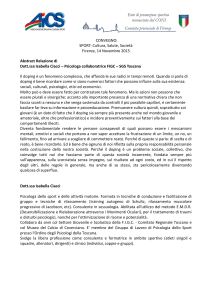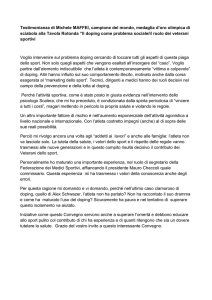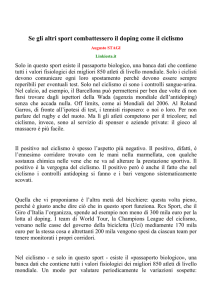sabato 16 gennaio 2016
L’intervista
6
Per amore dello sport
Martial Saugy
Dal 1990 al Laboratorio antidoping
di Losanna, del quale dal 2003 è il direttore,
Martial Saugy nel 2016 lascerà l’istituto
per passare al nuovo Centro di
competenza sui problemi del doping,
affiliato all’Università vodese.
Abbiamo ripercorso alcuni dei capitoli
più significativi di 25 anni trascorsi
a dare la caccia ai bari dello sport.
Con uno sguardo proiettato al futuro.
Non si è mai lasciato prendere dalla frustrazione, dall’idea di essere un nuovo Don
Chisciotte in lotta contro i mulini a vento?
Lavoro in questo campo da 25 anni e ammetto
che a volte mi è capitato di pensare “non vinceremo mai”. Ma la vera frustrazione non la si percepisce in laboratorio, bensì nei tribunali, dove
spesso veniamo trattati alla stregua di criminali. Mi ricordo quando ero stato negli Stati Uniti
per testimoniare nel caso di Tyler Hamilton: gli
avvocati mi avevano di fatto messo alla sbarra,
accusato di voler rovinare con prove non attendibili la carriera di uno sportivo esemplare e
corretto. E ciò, nonostante vi fossero evidenze
scientifiche inconfutabili. È da qui che nasce
un certo senso di frustrazione, dal fatto di dover sempre lottare con i denti per fare accettare
la realtà dei fatti.
di Sebastiano Storelli
Martial Saugy, dalla biologia all’antidoping...
Ho studiato biologia vegetale e il mio lavoro di
dottorato verteva sulla ricerca degli ormoni
della crescita nelle piante. Nel 1990 mi trovavo
in Canada per un periodo di post-dottorato
quando mi è stato riferito che il laboratorio antidoping di Macolin avrebbe chiuso i battenti e
che se ne stava aprendo uno nuovo a Losanna.
In quanto biologo e amante dello sport mi è stato offerto un posto e sono rientrato immediatamente in Svizzera.
Cosa rappresenta per lei il suo lavoro?
Non vorrei essere frainteso, ma questo lavoro è
estremamente eccitante, una sfida continua. Si
tratta di una sorta di caccia al ladro, ma priva di
giudizi morali. Credo nelle regole senza le quali,
sono convinto, lo sport non potrebbe esistere.
Nei 100 metri tutti devono partire dopo lo sparo
dello starter, nel calcio un’infrazione in area è
sanzionata con un rigore, nel ciclismo il percorso da compiere è uguale per tutti: sono regole,
esattamente come lo sono quelle del codice antidoping e vanno rispettate senza se e senza
ma. Chi si dopa bara. Certo, il tema della pericolosità del doping per la salute degli atleti non
mi è indifferente, ma il mio impegno personale
in questa lotta è soprattutto a favore del rispetto dello spirito sportivo e dei valori dello sport.
E allora, quando le analisi provano la positività di un campione di sangue o di urina
qual è la sua reazione?
In primo luogo occorre ricordare che i nostri
test sono effettuati su provette contrassegnate
con un numero e non con un nome, per cui
sono anonime. Il nome, o per lo meno la disciplina, la conosciamo solo al momento delle
controanalisi. La prima reazione è rappresentata da una certa soddisfazione per il successo
ottenuto dall’indagine. E questo, se si vuole, è
l’aspetto scientifico. Ma vi è anche un secondo
piano di lettura, quello sociologico: dal profilo
etico giudico in modo diverso il caso di un atleta a fine carriera che spera, grazie a un doping
sistematico e volontario, di rimpolpare ulteriormente le sue finanze personali, da quello di
una ragazzina diciottenne del Kazakistan costretta a far uso di sostanze proibite da persone
che stanno al di sopra di lei, stritolata da un sistema all’interno del quale semplicemente non
le è permesso dire di no. E vi è poi una terza reazione, quella di dire: “Speriamo che l’atleta non
abbia a disposizione avvocati troppo bravi”,
perché spesso proprio quegli sportivi per i quali il doping è stato un processo volontario vengono scagionati grazie all’intervento di un legale in grado di aggrapparsi a un cavillo del regolamento.
Alla luce di quanto venuto a galla negli
ultimi decenni, il tifoso medio può ancora
esaltarsi per una performance sportiva?
Una doverosa premessa: il doping non è pratica
comune a tutti gli atleti. Inoltre, dall’introduzione nel 2008 del passaporto biologico, le federazioni sono obbligate a predisporre una serie
di controlli a sorpresa che definirei “pertinenti”
(l’atleta giusto, al momento giusto, in vista della giusta competizione). Tutti sono consapevoli
di come sia diventato molto difficile truccare
un controllo ematico tramite il quale è addirittura possibile isolare il Dna. Sono convinto che
l’effetto deterrente del passaporto biologico e la
possibilità di una teorica sorveglianza perma-
Il biologo ritratto durante la conferenza tenuta giovedì al Centro sportivo di Tenero
nente sugli atleti sospetti rappresentino un
ostacolo difficilmente sormontabile per chi rimane intenzionato a doparsi in modo sistematico. Quanto successo di recente in Russia è il
frutto della corruzione, non dei mancati controlli. Il passaporto biologico e i test effettuati
avevano evidenziato la necessità di fermare e
squalificare un certo numero di atleti, ma l’applicazione delle regole e la somministrazione
delle sanzioni sono state spazzate via dalla corruzione. Certo, chi vuole barare è alla ricerca
costante di sostanze nuove. Ve ne sono molte e
sempre più specifiche, prodotte da varie case
farmaceutiche, e noi stiamo già dando loro la
caccia. Va però detto che grazie alle tecniche di
indagine e all’introduzione del passaporto biologico, il margine di miglioramento ottenibile
per una prestazione è considerevolmente inferiore rispetto vent’anni fa. Al giorno d’oggi i
Bjarne Riis al 60% di ematocrito non possono
più esistere.
Rimane da trovare un’uniformità per quel
che riguarda le sanzioni. Fin tanto che la
decisione su una squalifica viene demandata alle singole federazioni nazionali il sistema non progredisce...
È un procedimento che va assolutamente rivisto perché tutt’ora rappresenta un grande ostacolo nella lotta al doping, nell’atletica come in
altre discipline. Si sta lavorando nella direzione
giusta, seguendo le raccomandazioni espresse
dalla Wada (l’agenzia mondiale antidoping) e
da tutte le persone di buon senso che ritengono
necessaria una maggiore indipendenza della
lotta antidoping rispetto al potere sportivo. È
da questo aspetto che deve partire la svolta.
Nel corso degli anni il Laboratorio di Losanna ha ottenuto importanti successi.
In particolare, sul finire degli anni Novanta
TI-PRESS
con la messa a punto del test di depistaggio
dell’Epo...
Negli anni Novanta esisteva il mercato libero
dell’eritropoietina, con quantità astronomiche
iniettate senza alcun timore, in barba ai controlli dell’ematocrito introdotti dall’Uci per cercare di arginare il fenomeno. Eravamo consci
del fatto che la nostra scoperta avrebbe messo
la parola fine al mercato libero, ma sapevamo
altrettanto bene che la rincorsa non sarebbe finita lì. Gli atleti, grazie all’ausilio di preparatori
e medici compiacenti e ben informati, avrebbero cambiato strategia e, nel caso dell’Epo, sarebbero passati alle microdosi. Ciò che è puntualmente successo. Un’ulteriore dimostrazione di come gli atleti, in particolare in alcune discipline, siano dotati di un alto grado di adattabilità. Questo cambiamento di abitudine ha
portato da parte nostra alla creazione del passaporto biologico, uno strumento che, però, se
preso singolarmente è già superato dagli eventi, in quanto gli atleti si sono adattati alla novità
e hanno adottato le necessarie contromisure.
La ricerca di un test di depistaggio per l’Epo
era stata lunga e faticosa...
Assolutamente sì, per cui al raggiungimento
dell’obiettivo ci fu grande soddisfazione. Mitigata però dalla consapevolezza che chi intendeva continuare a doparsi avrebbe immediatamente cambiato regime, seguendo le indicazioni dei preparatori. I quali, vale la pena ricordarlo, a differenza nostra non erano e non sono tenuti a seguire alcun protocollo etico, ma utilizzavano gli atleti come cavie, potendo così avanzare nelle loro ricerche in maniera molto più
spedita. Uno come Michele Ferrari, ad esempio,
era in grado di procedere senza controllo, mentre noi per effettuare gli stessi test dovevamo
attendere anni prima di avere tutti i permessi
etici e scientifici.
Per gli addetti all’antidoping l’aria iniziò a
diventare pesante nel 1998, quando scoppiò
il caso Festina...
Noi eravamo consci di quanto stava succedendo nel ciclismo, ma la domanda era: “Come dimostrarlo e come fermarlo?”. Mi ricordo che
all’epoca avevo preso coscienza della necessità
di smetterla di lavorare a compartimenti stagni. La lotta al doping andava portata avanti
con tutti i mezzi possibili, non soltanto tramite
analisi di laboratorio, il più delle volte attaccate
e messe in dubbio nei tribunali da esperti di vario genere. Le inchieste di polizia rappresentavano un modo per rafforzare i dati scaturiti dai
laboratori e quindi andavano pienamente appoggiate. In quegli anni, quando al Tour de
France ci presentavamo per i nostri controlli,
eravamo soprannominati “vampiri”. Venivamo
letteralmente insultati dai direttori sportivi, ad
esempio da Bruno Roussel, manager della Festina, il quale ci accusava di trattare i nostri
connazionali – in squadra c’erano Zülle, Dufaux e Meier – come dei cani. Sparate che producevano il loro effetto sull’opinione pubblica,
ma noi sapevamo, grazie ai risultati dei controlli ematici, che i medici delle squadre truccavano il sangue dei corridori, riuscendo a calibrare al limite del 50% il livello di ematocrito,
mantenendolo però al si sotto della soglia oltre
la quale scattava la sospensione per motivi di
salute. Il caso Festina lo vissi come lo scoppio di
un detonatore, conscio del fatto che la squadra
francese rappresentasse solo la punta dell’iceberg.
Su alcune discipline (atletica, ciclismo, sci
di fondo...) continua ad aleggiare il fantasma del doping, mentre altre non vengono
nemmeno sfiorate dai sospetti...
Gli sport di squadra seguono una dinamica diversa, a partire da una sorta di autoregolamentazione che ogni giocatore ha nei confronti dei
compagni e della società. Conosco bene i controlli effettuati nel calcio inglese e devo dire che
sono estremamente seri e ben organizzati. Per
quanto riguarda le discipline individuali, ciclismo e atletica sono state le prime ad aver messo le mani nel barattolo della marmellata, ma
sono pure state le prime a reagire. Negli anni
Ottanta era molto difficile depistare gli steroidi
anabolizzanti e a farsi carico del problema, soprattutto dopo il caso Ben Johnson, era stata
proprio l’atletica. Nel ciclismo, sport nel quale
la cultura del doping è endemica, si è fatto largo
uso di anfetamine, si è passati più lentamente
agli anabolizzanti, ma poi ci si è buttati a capofitto nell’Epo. Altri sport meno mediatizzati, ad
esempio il fondo o il biathlon, hanno vissuto
esattamente la medesima traiettoria, lavorando negli ultimi anni per rifarsi una reputazione.
Sono però convinto che sarebbe bene dare una
grattatina ad altre discipline individuali per capire cosa si nasconde sotto la superficie.
E qual è la situazione dello sport svizzero?
Non so quale sia la cultura del doping in Svizzera. Lavoro molto su scala internazionale e molto poco con la Svizzera. Antidoping Svizzera ci
utilizza quali prestatori di servizi, ma preferisce non condividere le rispettive esperienze, ciò
che consentirebbe di arrivare a un concetto nazionale di lotta al doping. Dal mio punto di vista ritengo si tratti di un’occasione mancata.