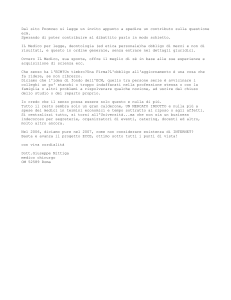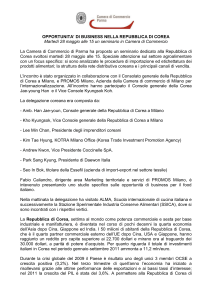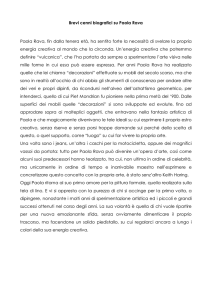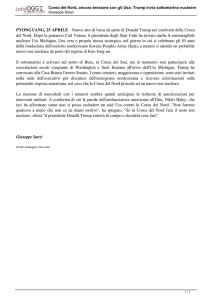William Schuman: The Symphonies (and
selected orchestral works). Seattle
Symphony; Gerard Schwarz director.
Naxos American Classics.
William Schuman: The Symphonies (and selected orchestral works). Seattle
Symphony; Gerard Schwarz director. Naxos American Classics.
I lavori di William Schuman sono una sorta di tesoro nascosto: rappresentano
una parte importante, se non fondamentale, del linguaggio sonoro del
Novecento. Ed è un tesoro che la Naxos racchiude in cinque cd dove
all’integrale delle sinfonie si affiancano altri brani che al compositore
hanno dato particolare fama e successo:
“New England Triptych”, “Judith”, Circus
Overture”, “Night Journey” e le
Variazioni su “America” di Charles Ives.
Una “raccolta” che si fa apprezzare per
la grande macchina sinfonica che erge di
fronte all’ascoltatore: ipnotica,
drammatica, suadente, ironica, plastica,
imprevedibile. Difficilmente
catalogabile, se non per il fatto che
Schumann è riuscito – nella sua carriera
– ad organizzare una sintesi compositiva
che fosse sì americana ma anche
universale. Poliritmica, soprattutto, ma
anche essenziale nel fine di esprimere i
mordenti di un mondo in cambiamento.
Attraversato dalla Seconda Guerra
Mondiale, dalle tragedie e dalle rinunce. Dalla sofferenza e dalla ricerca di
uno spirito Alto che facesse da tramite tra l’umanità e la scoperta di un
significato che si ritrova, come ebbe a dire il compositore, nella musica
stessa. Scura e sensoriale, percettiva e perspicace. Rarefatta, aleatoria,
squisitamente cangiante: Schuman dipinge scenari apocalittici e pastorali con
una forza che nasce dal particolare strumentale. Ogni singola famiglia è
trattata con meticolosa cura nell’estensione timbrica al fine di trasformare
il suono in una curva espressiva. E che richiede a chi ascolta un vissuto
emozionale senza riserve. Nella lettura di Schwarz, le sinfonie di Schuman si
presentano come un unico, immenso impianto di una musica senza confini.
Letteralmente travolte da un desiderio di raccontare, incidere, marcare. I
lavori di Schuman, dunque, non debbono essere considerati semplici episodi
compositivi, ma placche di un affresco che si costruisce nota dopo nota.
Schwarz , in questo caso, si offre come interlocutore privilegiato tra il
pubblico e il musicista. Non cerca di ottenere l’effetto ma l’affetto. Non la
provocazione, ma la purezza dello stile. Non l’eccezione – nei tempi e nel
fraseggio – ma la regola di una conduzione pulita e chirurgicamente devota al
segno originale. Il risultato è ottimo se si decide di ascoltare la raccolta
senza concedersi pause: un cd dietro l’altro per ricostruire la storia di un
artista che ha sempre puntato alla coerenza e all’eleganza. Alla temerarietà
senza eccessi. E alla logica senza compromessi.
Davide Ielmini
Marlene Kuntz: “Canzoni per un
figlio”. Emi Music.
Marlene Kuntz: “Canzoni per un figlio”. Emi Music.
Poesia liquida: non c’è nulla, oggi nella musica italiana, che somigli ai
Marlene Kuntz. Nulla che segua la sua scia. Nulla che possa essere, nello
stesso punto e con la stessa regolarità così piacevole. Diretta. Spogliata da
esosità e tradimenti artistici. “Canzoni per un figlio” è un concept-album,
non una raccolta. Arrangiamenti nuovi,
spostati al centro del suono, interessati
anche all’acustico ma mai troppo morbidi o
levigati. E’ il cambiamento – in meglio –
verso una direzione dove il battito si
trasforma in palpito, l’elettrico sfuma
nell’intimità, il testo è recitazione. Non
sempre urlata. Anzi, spesso la voce trasuda di
una debolezza voluta ma formidabile
nell’arredare la scena di un mondo nuovo. Più
adatto ad un figlio. Forse, meno cinico. Ci
vuole qualcuno che spieghi e che guidi: è
sufficiente un libretto per introdurre
all’ascolto. Per avvicinare i giovani. Per
dire ciò che non hanno e che, probabilmente, potrebbero perdere. Però, <la
felicità non è impossibile / La stupidità la rende facile…Se sai bene ciò che
fai / La felicità sarà sempre raggiungibile…Se non sai quello che vuoi /
L’infelicità sarà spesso incomprensibile>. Così questo disco nasce da un
principio che il gruppo ha fatto suo negli anni: “Assecondiamo la curiosità
piuttosto che il calcolo”. E allora ecco un elenco di episodi di vita sparsa,
che ricordano ancora i Sonic Youth, imbarazzati a volte da questa veste
cangiante. Non solo gli inediti “Canzone in prigione” (scritta per una
colonna sonora) e “Un piacere speciale”, ma anche “A fiori di pelle” (con la
delicatezza degli archi) e “Canzone ecologica” (con le gocce sonore del
piano). Non solo “Pensa” ma anche il sobbalzare lirico tex-mex di
“Trasudamerica” con gli ottoni di Roy Paci. E la tromba che svetta. Non solo
“Io e Me” (di una forza scatenante) ma anche “Ti giro intorno”. Una
radiografia che rivela un corpo non ancora conosciuto: quello dei Marlene
Kuntz post-Sanremo. Ancor più decisi a ribaltare il loro repertorio nelle
luci della scuola d’autore, senza rinunciare però ai grumi del noise rock. Ed
è così che li vogliamo.
Davide Ielmini
Chick Corea / Stefano Bollani:
“Orvieto Concert”. ECM 2222
(Distribuzione Ducale Dischi).
Chick Corea / Stefano Bollani: “Orvieto Concert”. ECM 2222 (Distribuzione
Ducale Dischi).
“Orvieto Concert” é da ascoltare rigorosamente in cuffia: Chick Corea e
Stefano Bollani hanno uno stile che ben li caratterizza, ma quando l’incontro
pianistico gioca sul contrappunto, sulle tessiture più increspate, sugli
intrecci poliritmici, è consigliabile affidarsi alla
tecnologia. I due si incontrano per la prima volta
sul palco, ed è – come facile intuire – un capirsi a
prima vista. Perché Bollani adora la musica latina e
Corea quel jazz lirico che entra senza troppi
complimenti anche nell’alveo europeo
dell’improvvisazione e della musica colta. Le
personalità sono simili: incisivo il pianismo di
Corea (che alla linfa spagnoleggiante non rinuncia,
rilasciata sui tasti come note sulla carta),
strutturato, senza dubbio – non sempre però –
criptico. Spensierato quello di Bollani. Ma anche elastico, sornione,
disciplinato quando si decide di passare al setaccio le melodie di “Jitterbug
Waltz” di Fats Waller, “Nardis” di Miles Davis, “Retrato Em Branco E Preto”
di Antonio Carlos Jobim. Timbrica poi più “brunata” quella di Corea e più
“limpida” quella di Bollani. Tocco, infine, da virtuosi della tastiera: senza
temere confronti con chi, le ottave, le allena sugli Studi di Chopin.
Atmosfera di gran classe: ispirata, divertita, che mette il pepe dove non si
può dire. Cavalcata musicale, dunque, che rispolvera lo spleen di due artisti
allergici alle prove ma sempre più ispirati dal confronto e dall’idea di
improvvisare. Con fraseggi articolati, rapidi, sontuosi. Bollani dice di
ispirarsi a Corea, e Corea a Bollani: insomma, tanti i complimenti fra i due.
Ricambiati anche dal pubblico, che si avverte ipnotizzato di fronte alla
bellissima rivisitazione di “Armando’s Rhumba” di Corea o di “If I Should
Loose You”. Così, tra standard della grande tradizione jazzistica, brani
devoti alla scuola della bossa-nova e original a firma di Corea e Bollani, il
concerto si trasforma in un baldanzoso scoppiettio di atmosfere. Tutte
diverse e tutte selezionate dalla sensibilità di questi pianisti che dell’Ecm
sono punte di diamante.
Davide Ielmini
Enrico Rava Quintet: “Tribe”.
Enrico Rava Quintet: “Tribe”. ECM 2218 (Distribuzione Ducale Dischi).
Non c’é molto da aggiungere, a ciò che già é stato scritto in passato,
sull’attività di Enrico Rava per la Ecm. Prima di tutto, musica stimolante.
Curiosa, in seconda battuta. Avvolgente, come se fosse nebbia nella
metropoli. E poi, epidermica, nascosta, tenebrosa.
Non facile: perché il jazz di Rava, negli anni, ha
assorbito la riflessione, la strategia strumentale e
timbrica, la flessuosità del pensiero e dei solo.
Così, “Tribe” somiglia tanto all’ennesimo capitolo
di un racconto sonoro nel quale la composizione –
più che altro, lo stile, il segno, il carattere – è
la regina saggia di un jazz che si trasforma
lentamente. E che, lentamente, fluisce. Senza
rinunciare al gusto di comunicare con chiarezza il
passaggio da una ballad ad un post-bop più
articolato e dal passo deciso. Dopo Easy Living, Tati, The Words and the
Days, The Third Man e New York Days, il trombettista genovese si concentra
ancora sull’esplorazione della musica più lirica ma meno esposta. Certo,
ammaliante ma senza accecare. E’, insomma, l’ideale compagna di viaggio per
chi vuole ferire di malinconia concedendosi però il lusso di qualche piccolo
colpo di testa. Con un quintetto nel quale le giovani promesse – e i giovani
che le promesse le hanno ormai mantenute – svettano per bravura, entusiasmo,
capacità di dirigersi tutte insieme verso la meta decisa dal Maestro Rava.
Gianluca Petrella al trombone, per esempio, è ancora un ragazzotto che ha
fatto incetta di premi e affascina gli americani (e nel gruppo di Rava
richiama forse la stessa affinità del trombettista con Roswell Rudd, ai tempi
della New Thing), mentre Gabriele Evangelista è nato nel 1988, si diploma in
contrabbasso al conservatorio “P. Mascagni” di Livorno (sua città natale),
studia jazz con Salvatore Bonafede. Nel 2010, dopo i corsi Siena Jazz, entra
a far parte del quintetto di Rava. Su Giovanni Guidi, classe 1985, dice lo
stesso trombettista: “Uno dei pianisti italiani più interessanti e originali.
E io che lo conosco bene ed ho il piacere di suonare con lui con una certa
frequenza, posso affermare con certezza assoluta che non è che l’inizio di
una storia che prevedo straordinaria”. Il senso di “Tribe” è tutto qui:
voglia di fare, mettersi alla prova, dimostrare che il jazz si può inventare
giorno dopo giorno. Come il quintetto fa con alcuni vecchi brani scritti da
Rava negli anni ed ora affidati alle “unghiate” di chi, per età, è
meravigliosamente incosciente.
Davide Ielmini
Giovanna Pessi / Susanna Wallumrod:
“If Grief Could Wait”.
Giovanna Pessi / Susanna Wallumrod: “If Grief Could Wait”. ECM 2226.
E’ ormai un dato di fatto, riconosciuto e accettato: la musica antica
rappresenta lo specchio di un bisogno contemporaneo che non sempre si riesce
a soddisfare. E allora lo stile seicentesco, in questo caso di Henry Purcell,
si ritrova a dover condividere lo spazio con le liriche di Leonard Cohen e
Nick Drake. Come dire: i poeti restano tali con il passare dei secoli, delle
mode, dei capricci del pubblico. Questo
disco della coppia Pessi (all’arpa
barocca) e Wallumrod (alla voce) non è
semplice: perché il gusto musicale è
quello che lascia in ereditàla
ScholaCantorumBasiliensis dove la prima
ha studiato per cinque anni. In poche
parole, un’immersione totale nella
conoscenza dell’antichità e dei suoi
stilemi. E’ così, in effetti, che la
vivono le due protagoniste: musica che
è commento, accompagnamento,
arricchimento, disfacimento (in senso
del tutto positivo) del testo
originale. Si vedano Cohen e Drake per
capire come e dove il tessuto armonico
di una canzone può essere disfatto – come si disfa un lavoro a telaio – per
poi ritrovare un senso nuovo del tempo: allungato nel timbro riflettente
della Wallumrod, con le “code” sulle vocali e le strofe estese sugli accenti.
Lavoro di scienza interpretativa, rielaborato nel pensiero, scandito nella
trasparenza degli arrangiamenti musicali. Brani che si nascondono in loro
stessi per lasciare il campo alla grandezza di chi li ha composti. Il
quartetto, che si completa con Jane Achtman alla viola da gamba e Marco
Ambrosini alla nychelharpa, non induge e si avvalora di una riservatezza che
offre al suono una maggiore profondità. Nulla che faccia pensare, ovvio, alla
prassi filologica nell’esecuzione. Piuttosto, una sperimentazione gradevole
di ciò che può essere il pensiero musicale oggi in due giovani menti
formatesi – è il caso della Pessi – al fianco di Rolf Liesveland e sotto la
direzione di Philippe Pierlot, Harry Bicket, Nikolaus Harnoncourt e Marc
Minkowski. Accade, così, che per capire meglio i nostri tempi – e i loro
suoni- ci si debba rivolgere al passato lontano. Quando l’armonia era,
forse, ancora un arcano votato alla difesa della vera bellezza.
Davide Ielmini
Paolo Fresu / A Filetta Corsican
Voices / Daniele di Bonaventura:
Mistico Mediterraneo.
Paolo Fresu / A Filetta Corsican Voices / Daniele di Bonaventura: Mistico
Mediterraneo. ECM 2203.
Definita “Isola della Bellezza”,la Corsicaè una regione-nazione: affascinata
dal separatismo, culla una sua identità che sfocia in conservatorismo e
divulgazione. “Mistico Mediterraneo” ne è un buon esempio. Innanzitutto
perché fa incontrare un trombettista sardo di fama come Paolo Fresu con un
ensemblevocaleacappellacorsodialtrettantosuccesso:“AFiletta”(in
italiano, felce). Poi, perché in questa
incisione è la mistica – in quanto ricerca della
estetica – a tracciare il cammino tra arcaico e
moderno. Non la contemporaneità come la si
intende, ma le sue estensioni di suono nella
tradizione che rivive senza perdersi in se
stessa. L’ensemble “A Filetta” nasce trent’anni
fa, fondato da Jean-Claude Acquaviva, allora
tredicenne, in Balagna. Si tratta di una storia
di fascino, di conquista, di orgoglio. Ma,
soprattutto, di musicalità: attraente, a volte
meravigliosamente in sordina, evocativa. Sacra
seppur profana. Perché dei vecchi riti, e delle superstizioni (“La folie di
Cardinal” è costruita sulla strofa di un esorcismo), mantiene la forza
sotterranea. E’ qui che la collaborazione con Fresu e Daniele di Bonaventura
– al bandoneon – si fa preziosa: senza scalfiture, acrobatismi, tentazioni
barocche. Trionfa, invece, la sintesi (il testo di “Le Lac” è quello di un
mantra tibetano) e la primitività immediata, ribelle e rispettosa nello
stesso tempo, di questi testi (anche del poeta corso Petru Santucci) cantati
e recitati in latino, francese e corso. La lucentezza e il contrappunto delle
voci stagliate sulla rappresentazione quasi teatrale del bandoneon – che non
rinuncia ai soundscapes – si vaporizza lentamente nel tempo. Senza rinunciare
alla tentazione – e questo vale soprattutto per Fresu – di riportare alla
memoria ciò che Jan Garbarek ha fatto in “Officium” al fianco dell’Hilliard
Ensemble. Emozioni forti (“Liberata” è dedicata alla Resistenza della Seconda
Guerra Mondiale), dalle tinte in trasparenza con timbriche eccezionalmente
levigate. Il “Dies Irae”, il “Gloria” (con il breve crescendo tremendo e
febbrile), il “Gradualis” e il “Sanctus” sono vette di assoluta precisione.
Allora, ci si accorge di quanto l’intero disco assuma la forma di una
filigrana, di fronte alla quale il miglior commento è solo un sentito e
religioso silenzio.
Davide Ielmini
Coldplay: MMylo Xyloto
Coldplay: MMylo Xyloto. Emi Records 097 5532.
I Coldplay hanno venduto 50 milioni di dischi. “Mylo Xyloto” è già un
successo planetario: con la data a Dubai, poco tempo fa, hanno fatto sold out
e raggiunto la somma di un milione di euro. La loro musica, composta come un
cocktail nel quale variano le dosi degli ingredienti ma non i colori,
saltella allegramente – con un’aurea falsamente riflessiva in testi e
arrangiamenti – tra il brit-pop, un certo
glamour anni Ottanta, richiami armonici e
ritmici agli U2 e ventate di immediatezza
melodica stile A-Ha. Dove, se non ci si
riusciva con le note, la musica trovava
una rapida soluzione nell’ammiccamento
giovanilistico,
nel
romanticismo
spietato, nella “riserva” di spontaneità
e voce morbida. I Coldplay, purtroppo,
sono uno di quei gruppi sui quali ci si
dovrebbe interrogare: non sono forniti di
un’originalità particolarmente spiccata,
sono un misto di Beatles (nelle
intenzioni)
e
rock
alleggerito.
Rappresentano un’icona contemporanea che
di icona ha ben poco, se non la capacità
di accendere i cuori dell’adolescenza ormonica pronta ad infiammarsi di
fronte all’ennesimo riff riprodotto ad oltranza. Sono, i Coldplay, un gruppo
che come tanti – oggi – non sono adatti a confezionare una colonna sonora
adeguata ai nostri tempi di crisi. O, forse, chi scrive è così vecchio da
pretendere che anche in questi nostri giorni nasca il Neil Young di turno o
appaia miracolosamente, chissà da dove, un quartetto che non ci faccia
rimpiangere i Led Zeppelin. La musica dei Coldplay è a tal punto costruita da
pensare ad un organismo geneticamente modificato: troppo attenta, precisa,
pulita. Con giri di accordi che rischiano di somigliarsi l’uno con l’altro e
un risuonare continuo di punti di riferimento riadattati al momento. E’
questo che fa dei Coldplay l’ennesima realtà contemporanea di una musica che
non ha molto da dire. O, se lo dice, non pone gli accenti al posto giusto.
Parla al cuore, ma raccontando una storia già ascoltata da altre chitarre e
in altre ballad strappalacrime. Sono dunque lontani i temi di “A rush of
blood to the head”: il lavoro che fece attendere la svolta e la maturazione.
Da parte sua ha ragione Chris Martin quando afferma che “avrebbe voluto
recensire Ok Computer” dei Radiohead: quelli erano dischi!
Davide Ielmini
Pink Floyd: “A foot in the door – The
best of Pink Floyd”.
Pink Floyd: “A foot in the door – The best of Pink Floyd”. Emi Records.
Non se ne avvertiva la necessità, perché non se ne sente la mancanza. I Pink
Floyd ritornano nei negozi di dischi con il meglio prodotto in più di
quarant’anni di musica. Ci sono brani cult che almeno tre generazioni
conoscono a memoria: Hey You, See Emily Play, Another Brick in the Wall (part
2), Wish you were here e via di seguito sino a Learning to Fly e Confortably
Numb. Un cd singolo di circa ottanta minuti per ripassare la storia non solo
del rock psichedelico. “A foot in the door” non avanza sfide e non
chiede rivalse: il mondo in cui viviamo è questo.
E se a resistere, a incuriosire, a interessare e
a far crescere – come ascoltatori – è ancora un
gruppo nato sul finire degli anni Sessanta, è
presumibile ci sia un vuoto che gli artisti
contemporanei (e i talent-scout delle major
discografiche) non riescono a colmare. Nulla di
particolare, in tutto questo: sono i Pink Floyd
di sempre, con un collage di cover storiche in
copertina e una pulizia di suono che aiuta ad
abbandonarsi al sogno. Un viaggio libero in una
ricerca che se, anni fa, intimoriva qualcuno e
rivoltava le certezze del sistema, ora appartiene al dna di una società
stretta tra la sfiducia e l’incertezza del vivere. E, come spesso accade con
le espressioni artistiche più lungimiranti e coraggiose, questi brani
acquisiscono ancora spessore nel trattare problemi sociali mai del tutto
risolti. Inutile filosofeggiare sull’importanza dei PF: questa raccolta ce li
presenta nei migliori anni della loro vita. Con un solo rammarico: la
scaletta non considera alcun brano da “Animals”. Conoscendo il gruppo, non si
tratta certo di una dimenticanza.
Davide Ielmini