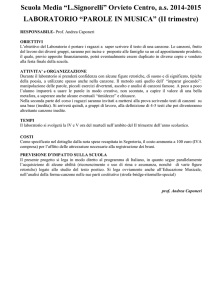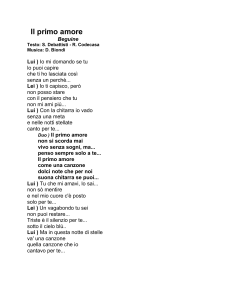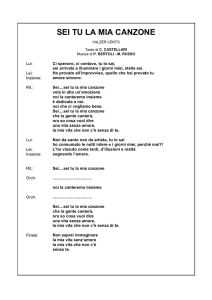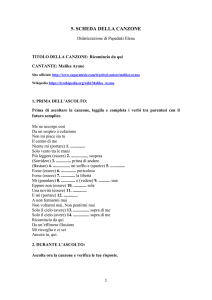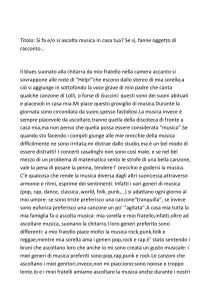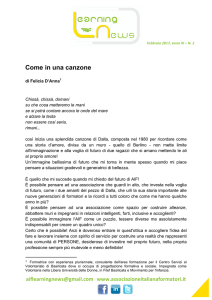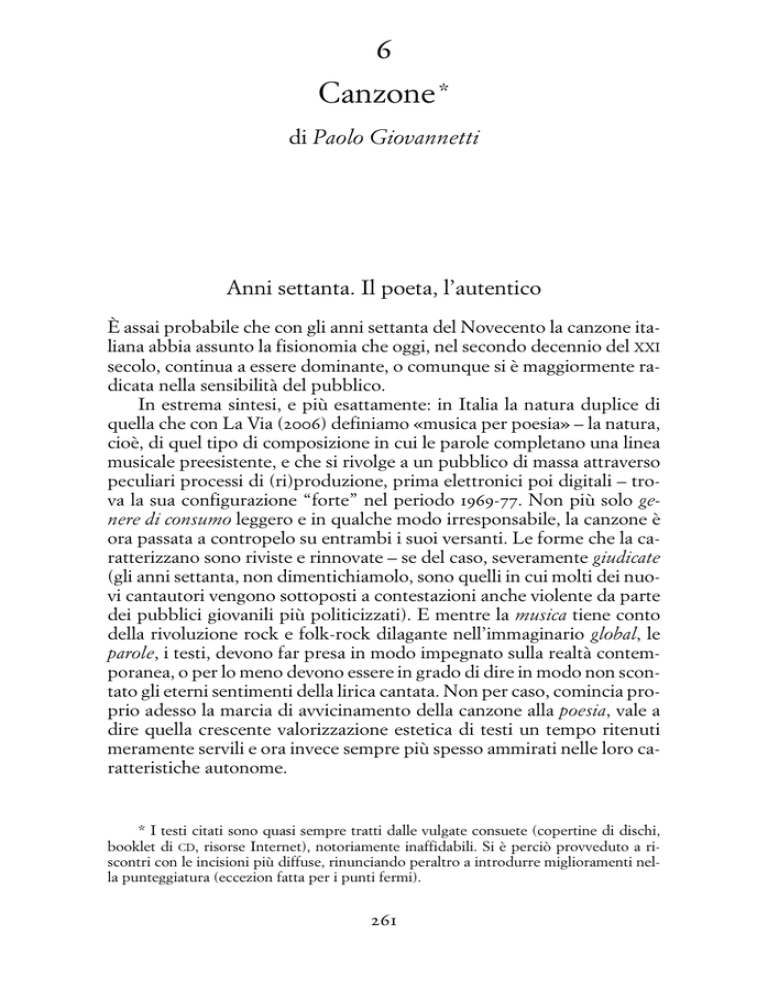
6
Canzone *
di Paolo Giovannetti
Anni settanta. Il poeta, l’autentico
È assai probabile che con gli anni settanta del Novecento la canzone italiana abbia assunto la fisionomia che oggi, nel secondo decennio del XXI
secolo, continua a essere dominante, o comunque si è maggiormente radicata nella sensibilità del pubblico.
In estrema sintesi, e più esattamente: in Italia la natura duplice di
quella che con La Via (2006) definiamo «musica per poesia» – la natura,
cioè, di quel tipo di composizione in cui le parole completano una linea
musicale preesistente, e che si rivolge a un pubblico di massa attraverso
peculiari processi di (ri)produzione, prima elettronici poi digitali – trova la sua configurazione “forte” nel periodo 1969-77. Non più solo genere di consumo leggero e in qualche modo irresponsabile, la canzone è
ora passata a contropelo su entrambi i suoi versanti. Le forme che la caratterizzano sono riviste e rinnovate – se del caso, severamente giudicate
(gli anni settanta, non dimentichiamolo, sono quelli in cui molti dei nuovi cantautori vengono sottoposti a contestazioni anche violente da parte
dei pubblici giovanili più politicizzati). E mentre la musica tiene conto
della rivoluzione rock e folk-rock dilagante nell’immaginario global, le
parole, i testi, devono far presa in modo impegnato sulla realtà contemporanea, o per lo meno devono essere in grado di dire in modo non scontato gli eterni sentimenti della lirica cantata. Non per caso, comincia proprio adesso la marcia di avvicinamento della canzone alla poesia, vale a
dire quella crescente valorizzazione estetica di testi un tempo ritenuti
meramente servili e ora invece sempre più spesso ammirati nelle loro caratteristiche autonome.
* I testi citati sono quasi sempre tratti dalle vulgate consuete (copertine di dischi,
booklet di CD, risorse Internet), notoriamente inaffidabili. Si è perciò provveduto a riscontri con le incisioni più diffuse, rinunciando peraltro a introdurre miglioramenti nella punteggiatura (eccezion fatta per i punti fermi).
261
MODERNITÀ ITALIANA
Fatta la tara alle mode e alle etichette (rock e folk-rock nel 2010 sono parole sostanzialmente vuote; e in letteratura chi scrive «impegno»
oggi lo fa con virgolette di rossore), questa duplice responsabilizzazione
della canzone è tuttora in vigore.
Ma che cosa avviene di così importante negli anni settanta, in particolare nella loro prima metà, e in che senso questa trasformazione (e poi
stabilizzazione) delle forme si differenzia dall’insieme dei fatti che aveva
contraddistinto la canzone, italiana e non, dalla seconda metà degli anni cinquanta in poi? È infatti un luogo comune molto consolidato (cfr.
almeno Borgna, 1985, Jachia, 1998) quello che colloca il grande cambiamento un decennio abbondante più indietro, quando avevano mosso i
primi passi i moderni «rocker» e «cantautori» (poniamo: Celentano e
Gaber da un lato, Paoli e Tenco dall’altro), dopo che nel 1958 Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno aveva vinto il festival di Sanremo
mostrando che un tipo leggermente diverso di canzone era possibile.
Appunto: perché gli anni settanta, e non prima?
Per dare una risposta, bisogna prendere in considerazione per lo
meno tre fattori: 1. il generalizzarsi di procedimenti compositivi diversi
da quelli, ereditati, basati sulla struttura “melodrammatica” strofa-ritornello (intorno alla forma della canzone, cfr. soprattutto Fabbri, 1996,
pp. 53-79; ma cfr. anche Cruciani, 2005 e Bandini, 1976); 2. la diffusione
di massa di un nuovo medium quale il disco a 33 giri e la parallela nascita del cosiddetto concept album (De Luigi, 1982); 3. la già ricordata
tensione all’impegno, soprattutto politico ma anche genericamente letterario, la ricerca vale a dire di testi qualitativamente validi (Carrera,
1980, Coveri, 1996, Antonelli, 2010).
1. Che alla fine degli anni sessanta un processo di rinnovamento fosse
ormai maturo, lo argomenta un documento di facile reperibilità. Oggi,
avvalendosi di una risorsa come YouTube è possibile rivivere la performance di Enzo Jannacci nel corso di Canzonissima 1968 (il programma
TV del sabato sera che, come tutti forse sanno, si rivolgeva soprattutto alle famiglie), quando interpretò una canzone intitolata Gli zingari. Niente di particolare, a uno sguardo-ascolto d’assieme, anche perché Jannacci assecondava fin troppo bene i movimenti di una telecamera che lo
costringeva a spostarsi circolarmente; solo che quella canzone è in buona parte recitata, la melodia si limita a sostenere poche parole, e nel parlato fa capolino un italiano basso, dell’uso medio, con evidenti connotazioni regionali lombarde (vedi il costrutto «star lì a...»; tra l’altro, Jannacci storpia il “letterario” e leggermente incongruo ristettero: pronunciando restettero: «e [gli zingari] restettero muti perché subito intesero
che lì non c’era niente, niente da dover capire, niente da stare a parlare,
262
6. CANZONE
niente da stare a parlare»). Sullo sfondo delle canzoni strofa-ritornello,
la teatralizzazione di Jannacci ha qualcosa di scandaloso, certo: ma è anche chiaro che a quest’altezza e in quel contesto di consumo popolare ci
si poteva lecitamente attendere di ottenere un minimo di successo persino con una simile piccola provocazione. Dieci anni di nuove esperienze non erano trascorsi invano.
E, per fare un secondo esempio concreto, nel corso del festival di
Sanremo del 1971 è probabile che il vero vincitore morale sia stato Lucio
Dalla, con 4 marzo 1943, una canzone che – oltre a esemplificare un tema
ritenuto trasgressivo: la “santità” di una ragazza-madre, la purezza del
suo amore unicamente fisico per uno sconosciuto – si fonda su una struttura non lontana da quella della ballata (AA), dove l’eventuale uncino
(hook) melodico è costituito da un pugno di note intonate non dal cantante ma da un violino, che “agisce” sul palco insieme a Dalla.
E così via. Non c’è dubbio che anche la canzone più commerciale
comincia, fra anni sessanta e settanta, a risentire dell’onda lunga dell’innovazione e a fissarla in forme tutto sommato condivise, al di là magari
di singoli exploit festivalieri. La stabilizzazione in un modulo destinato
a durare per molti anni e anzi ad arrivare fino ai giorni nostri si affida soprattutto alla coppia Mogol-Battisti. Intanto, è stato con efficacia argomentato (da Salvatore, 1997) che la struttura dominante nella maggior
parte delle canzoni da loro firmate risponde alla dialettica chorus-bridge (appunto, non strofa-ritornello). In questo modo, si verifica un fenomeno blandamente parodico: episodi testuali ed episodi melodici non
hanno una relazione reciproca del tutto trasparente, e si alternano secondo un processo poco scontato, poco prevedibile. Insieme, quasi in
parallelo, la voce di Battisti evoca l’immagine di un uomo (persino di un
maschio) tanto in crisi quanto aggressivo, tanto impaurito di fronte a un
diverso tipo di donna, quanto misogino e desideroso di rivincite.
Conosciuta pressoché a memoria da più generazioni di italiani, la – a
modo suo – perfetta Canzone del sole (1971) è un buon esempio di tutto
ciò. Basti fare due considerazioni: a) uno dei punti più cantabili (e memorabili) della canzone culmina su un’ardita apocope sillabica, che addirittura sfigura il corpo fonico di una parola: «O mare nero, mare nero,
mare ne». Tanto più che «mare nero» ha un significato metaforico non
subito evidente (anche dopo più ascolti), essendo di fatto un’allegoria
dello sconforto in cui piomba chiunque scopra l’“abiezione” della donna (un tempo) amata. E comunque la sua pregnanza è con ogni evidenza indebolita da una vera e propria, asemantica, glossolalia; b) lo statuto
enunciativo di alcune parti della canzone, vale a dire l’identità esatta della voce che parla, è assai difficile da individuare. Si pensi in particolare
(riascoltando l’esecuzione più diffusa) a come Battisti intona «Ferma ti
263
MODERNITÀ ITALIANA
prego la mano». Senza scendere nei dettagli, è chiaro che la voce sforzata verso il falsetto ha qui la funzione sia di femminilizzare il protagonista
maschile (se a parlare è lui, che si sente aggredito da chi è «donna ormai»), sia di costringere il locutore maschile (nel caso in cui fosse lei a
pronunciare quelle parole: che quindi sarebbero “citate”) ad assumere
il punto di vista di una giovane che ha subito un’aggressione sessuale. In
entrambi i casi, comunque, l’autore implicito della canzone evoca ed
esorcizza allo stesso tempo, in modo inquietante (e blandamente lubrico, certo), un’insopprimibile, quasi insostenibile paura della donna, culminante nel desiderio di degradarla.
2. La canzone del sole, lo abbiamo visto, adotta convenzioni di tipo narrativo. Mogol e Battisti spesso raccontano storie d’amore, certo tutt’altro che lineari (anche se prevedibili: l’analessi avendo come oggetto, non
di rado, un recente tradimento, che lei, cioè l’interlocutrice dell’io cantante, in un futuro immediato dovrà perdonare), ma in qualche modo
perfettamente chiuse su sé stesse. Nel concept album, questa logica «unipuntuale» viene messa in discussione, e la canzone comincia a uscire fuori di sé. Nell’intento di costruire un percorso unitario, sono accostate alcune (una decina o poco più) composizioni, per un totale di una quarantina di minuti. Il capostipite del “genere” è, com’è noto, Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles, uscito nel 1967. Le caratteristiche della nuova tradizione sono evidenti anche dal punto di visto paratestuale. Ogni 33 giri definibile come concept album denuncia fin dalla
copertina la propria unitarietà d’ispirazione – le proprie ambizioni artistiche –, per la qualità della grafica e delle immagini e perché spesso vi
sono riprodotti i testi, alla stregua di autentici prodotti letterari. E di
fronte al concept album il critico di canzonette deve risolvere gli stessi
problemi che lo studioso di poesia affronta quando cerca di restituire la
complessità di una raccolta di componimenti in versi, del cosiddetto libro di poesia. Gli elementi di coesione e coerenza, i legami narrativi e isotopici che caratterizzano un insieme di testi poetici o di canzoni chiedono all’ascoltatore-lettore di compiere alcune scelte, di capire a quale tipo di “concezione” complessiva, a quale “progetto”, si attiene l’opera.
Da questo punto di vista, i più antichi concept album italiani suggeriscono un quadro eterogeneo. Prendiamo la trilogia di cui è autore Fabrizio De André, La buona novella (1970), Non al denaro, non all’amore,
né al cielo (1971), Storia di un impiegato (1973), dischi ispirati rispettivamente ai Vangeli, all’Antologia di Spoon River e al Sessantotto. Tutti e tre
presentano una solidità evidentissima, e culminano in un’opera dalle intenzioni – sin dal titolo: Storia di – evidentemente narrative. Se però badiamo ad altre realizzazioni dei primi anni settanta, l’impressione può es264
6. CANZONE
sere a volte assai diversa: da L’isola non trovata (1970) di Francesco Guccini ad Anidride solforosa (1975) di Lucio Dalla, dall’Orso bruno (1973) di
Antonello Venditti a Rimmel (1975) di Francesco De Gregori. Non sempre queste raccolte presentano una tenuta davvero in grado di valorizzare sia le molte suggestioni paratestuali che le incorniciano sia la ricerca di
un’omogeneità di sound realizzata in sala d’incisione grazie al lavoro di
abili produttori e «arrangiatori». In certi casi (tipicamente in De Gregori) ci si trova di fronte a canzoni stilisticamente molto simili fra loro, ma
non necessariamente legate da un filo tematico (tanto meno narrativo) altrettanto forte. Il concept album di molti cantautori finisce per essere o
un fatto estrinseco o la conseguenza di un’autorialità accentuata, della
personalità affascinante dell’esecutore. La centralità della singola canzone costituirebbe insomma un dato in qualche modo irrinunciabile.
Interna a questa logica, ma certo quasi del tutto indipendente dalle
dinamiche dell’industria discografica (che in questi anni sembra cercare
di “costruire” il cantautore, di imporlo; cfr. per un caso particolare, Fabbri, 2009), è l’esperienza meno concettuale che teatrale di Giorgio Gaber. A partire dal 1969, dopo avere abbandonato la carriera televisiva, il
cantante realizza spettacoli (firmati insieme con l’amico artista Sandro
Luporini) in cui brevi recitativi integrano un “discorso” musicale eticopolitico-narrativo. Canzoni, anche molto tradizionali, si alternano cioè a
monologhi teatrali in un gioco dinamico, chiaroscurato, la cui unità è garantita dalla presenza scenica dell’esecutore. Lo si è chiamato «teatro
canzone», e le sue caratteristiche segneranno l’attività di Gaber sino alla fine della sua carriera. La sua intelligenza musicale ed esperienza gli
permettono di comprendere che la moderna canzone può recuperare
certi aspetti originari e quasi costitutivi del genere: in particolare la sua
essenza performativa, la possibilità di rappresentare un corpo-voce che
dia vita a una sintesi espressiva di ampio respiro. Qualcosa del genere
era avvenuto nella tradizione del café chantant e persino nell’avanspettacolo: in questi ambiti, Gennaro Pasquariello, Ettore Petrolini, Rodolfo
De Angelis (fra inizio del secolo e anni quaranta – molte informazioni
sul tema si leggono in De Angelis, 1940) erano riusciti a imporre le proprie identità di «canzonettisti»-attori, capaci di legare fra loro anche con
la recitazione composizioni musicali autonome, inizialmente indipendenti. Su un piano assai diverso, lo stesso avveniva e continua ancor oggi ad avvenire al teatro Ariston di Sanremo, dove – come peraltro tutti
sanno – le canzoni passano in secondo piano rispetto a una cornice inizialmente solo teatrale e radiofonica, poi divenuta televisiva, e ora trans(o cross-)mediale.
Non solo, e soprattutto. Negli stessi anni settanta, in perfetta coincidenza e sintonia con la rivoluzione del concept album, si sviluppa in
265
MODERNITÀ ITALIANA
Italia il genere musicale – grosso modo definibile come rock, anche sulla scorta di Frith (1978) e Fabbri (1996) – che maggiormente, si direbbe
persino intrinsecamente, valorizza la funzione teatrale della canzone, la
sua capacità di culminare in una performance in cui corpo e voce dettano legge, determinando gli a priori della comunicazione (decisivo su
tutti questi temi è Fiori, 2003, al quale il presente discorso deve molto).
Tra l’altro, i legami fra canzonetta “rinnovata” e rock italiano sono evidentissimi ed espliciti. Il primo importante prodotto del rock made in
Italy uscito su 33 giri, vale a dire Storia di un minuto (il tropo, quasi l’ossimoro del titolo, tra narrazione e antinarrazione, è piuttosto significativo) della Premiata Forneria Marconi, anno 1972, comincia con la canzone Impressioni di settembre, che si avvale delle parole “idilliche” ed
“esistenziali” – quintessenzialmente liriche, in definitiva – del navigatissimo Mogol:
Quante gocce di rugiada intorno a me
cerco il sole, ma non c’è.
Dorme ancora la campagna, forse no,
è sveglia, mi guarda, non so.
Già l’odore della terra, odor di grano
sale adagio verso me,
e la vita nel mio petto batte piano,
respiro la nebbia, penso a te.
[...]
No, cosa sono adesso non lo so,
sono solo, solo il suono del mio passo.
E intanto il sole tra la nebbia filtra già
il giorno come sempre sarà.
E tuttavia sembra inevitabile, almeno all’inizio dell’avventura rock, che
le strade debbano biforcarsi: e che il rock italiano sia destinato a seguire un percorso differente da quello della mera canzone, essendo il più
recente genere capace anche di valorizzare la realtà “collettiva” e per certi versi “industriale” di una nuova maniera di comporre. Lontani dall’idea del cantante-menestrello-trovatore che in modo autentico intona la
propria storia, i gruppi rock restituiscono un’immagine tecnologica e soprattutto non personalistica della musica (cfr. Fabbri, 2005, in particolare pp. 161-9; 2009). A fianco della Premiata Forneria Marconi, i New
Trolls (che peraltro erano stati precursori non fortunatissimi di tutte
queste tendenze, con il precoce concept album Senza orario, senza bandiera, battezzato già nel 1968 da De André), il Banco del Mutuo Soccorso, Le Orme, gli Osanna, sfornano nei primi anni settanta opere importanti che cercano di italianizzare il sound progressive del contemporaneo
266
6. CANZONE
rock soprattutto inglese (King Crimson, Genesis, Gentle Giant ecc.).
Del resto, a dimostrare appunto il possibile radicalizzarsi del fenomeno,
a fianco dei più innocui rocker “istituzionali” (ben accetti dalla stampa
e dall’industria discografica) si collocano gli alternativi, o “indipendenti”, come si direbbe oggi, Stormy Six e Area (fra i molti, peraltro), che
seguono percorsi più liberi, più politicizzati e persino intermediali (gli
Area, grazie al loro geniale produttore Gianni Sassi, sono contigui alla
musica d’avanguardia novecentesca, al mondo delle performance artistiche, dell’arte concettuale).
In definitiva, tutto parrebbe mettere in discussione la forma-canzone, che infatti nel rock almeno in parte scompare (e non tutto il rock è
peraltro cantato, com’è noto) e viene rielaborata in forme originalissime.
Fra i molti esempi possibili, si può prendere una composizione (oggi, anno 2011, quasi inascoltabile presso le giovani generazioni) come L’orchestra dei fischietti (1977) degli Stormy Six. Diviso, dal punto di vista testuale, in tre parti nettamente distinte, il pezzo è introdotto da una sorta di riff sospeso nel vuoto, contornato da lunghi silenzi. I contenuti
grezzamente intesi sono inizialmente politici: la prima parte («l’orchestra dei fischietti» che «dà la sveglia alla città») si riferisce infatti a un
corteo operaio, mentre la seconda («la semplicità del bisogno») dice di
un “desiderio” tutto sommato universale, e la terza («Niente resta uguale a se stesso / la contraddizione muove tutto») con il suo esplicito hegelismo dovrebbe marcare la sintesi degli opposti. Come si vede, il gioco è molto intellettualistico e voluto (anche se indubbiamente suggestivo); e infatti nei concerti degli Stormy Six un pezzo a tal punto concettuale abbisognava di un’esplicita spiegazione prima di essere eseguito.
3. Il punto è che, come si vede, la canzone anni settanta, per lo meno
fino al tornante del 1977-78, è investita di una molteplicità di compiti e
doveri, che finiscono per metterla in crisi. Decisivo senza dubbio è il reagente politico: l’impegno chiesto a gran voce soprattutto dal pubblico
giovanile, ma nient’affatto disdegnato anche dalle agenzie istituzionali e
dai produttori (gli spettacoli “politici” di Gaber si svolgono spesso in
spazi finanziati dalle pubbliche amministrazioni; negli anni settanta,
Nanni Ricordi, rampollo della notissima famiglia di editori musicali,
non solo continua a promuovere una canzone alternativa, ma fonda
un’etichetta politicizzata come l’“Ultima Spiaggia”), probabilmente sottopone il medium, il genere, a tensioni che non è in grado di sostenere.
La formula in effetti molto letteraria della rinnovata canzone, la sua ricerca di un messaggio, di una testualità innanzi tutto poetiche, anzi addirittura liriche, non hanno moltissimo a che fare con quanto si chiede
dall’esterno ai nuovi cantanti. Al di là delle loro personali convinzioni,
267
MODERNITÀ ITALIANA
le canzoni che scrivono ambiscono in modo sin troppo sfacciato a una
dimensione di “qualità” e “arte”, astrattamente disinteressate, rivolta
però a un pubblico di massa. Quello stesso pubblico che da allora – e
con gli anni il fenomeno non ha fatto che crescere – ha riconosciuto l’artisticità, la poeticità di Fabrizio De André, Francesco Guccini, Francesco De Gregori ecc.
Anni ottanta. La maschera, l’ibrido
In effetti, a partire dalla seconda metà degli anni settanta, il quadro registra una serie di trasformazioni, destinate poi a esplodere nel decennio
successivo (per un inquadramento generale, cfr. Accademia degli Scrausi, 1996). Nell’ambito della canzone d’autore strettamente intesa, il fenomeno più “lungimirante” è forse offerto dalla produzione di Rino Gaetano: che sceglie una strada di semplificazione persino eccessiva delle forme – le sue composizioni più note sono vere e proprie litanie o salmodie
di immagini, cui corrisponde una costruzione musicale poco gerarchizzata –, ma che grazie a una notevole personalità esecutiva sa drammatizzare il crescendo surreale inscritto nella sua opera. Tipicamente, si veda l’attacco di uno dei suoi successi più noti, Berta filava (1976):
E Berta filava e filava la lana,
la lana e l’amianto
del vestito del santo che andava sul rogo
e mentre bruciava
urlava e piangeva e la gente diceva:
“Anvedi che santo vestito d’amianto”.
E Berta filava e filava con Mario
e filava con Gino
e nasceva il bambino che non era di Mario
che non era di Gino.
E Berta filava, filava a dritto
e filava di lato
e filava filava e filava la lana.
Gaetano muore trentenne nel 1981, e il suo “mito” da allora è andato
consolidandosi: fino a restituire l’immagine di una canzone ironica, citazionista (poi ampiamente ripresa e “coverizzata”), capace di liberarsi
degli incubi dell’engagement pensoso, e semmai in grado di raccontare
la fisicità, il libero piacere. Uno strano mix insomma di intellettualismo
e primitivismo.
268
6. CANZONE
Su questo secondo versante, il passaggio tra i due decenni deve registrare l’esplosione, a partire dal 1979, di Gianna Nannini (finalmente
una donna-autrice e per giunta rocker!) che con America elogia esplicitamente il piacere femminile – più esattamente l’orgasmo –, peraltro argomentando il tema con un’energia corporea ed espressiva tanto debordante da rendere convincente tutta l’operazione. Anche perché il fenomeno Nannini integra il ritorno al successo, proprio alla fine degli anni
settanta, di Patty Pravo, in particolare con quel Pensiero stupendo (1978)
che rende esplicita la pulsione omoerotica di una donna, all’insegna di
ciò che in retorica è detta aposiopesi: la sospensione del discorso cioè che
non dice e allude, in questo caso determinando una sorta di tensione metalinguistica e persino fàtica, quasi che chi canta dovesse tenere sotto
controllo la liceità e l’efficacia stessa del messaggio («Le mani questa volta sei tu e lei / E lei a poco a poco di più, di più / Vicini per questioni di
cuore / Se così si può dire – dirò»).
Appunto. Con gli anni ottanta la canzone italiana non ha più remore a mettere in luce la sua natura commerciale, facile, oggetto di un culto intenso ma effimero. Gaber, sopravvissuto all’“impegno”, per registrare lo scandaloso Io se fossi Dio (un’invettiva apocalittica che osa dir
male anche della memoria di Aldo Moro) nel 1980 deve rivolgersi a una
minuscola casa discografica. Un vecchio maestro degli anni settanta,
Edoardo Bennato, lo dichiara nello stesso anno: Sono solo canzonette. E
un onesto mestierante come Toto Cutugno può diventare emblema di
un «canto all’italiana», che molti credevano morto, con l’hit internazionale L’italiano (1983). Ma, soprattutto, nel 1985, un poco più che ventenne Eros Ramazzotti, con Una storia importante, inaugura la carriera
trionfale di un cantante italiano per un pubblico global, contribuendo
così a innescare una nuova tradizione oggi fiorentissima (e dovremo appunto ritornarci).
Ma il “disimpegno” può anche andare più in là, e mettere in crisi
due capisaldi della recentissima storia: le sonorità del rock più coraggioso da un lato e il concept album dall’altro. Quanto al primo punto,
è indubbio che le forme del rock progressive vengono precocemente
abbandonate (il caso della ruspante Nannini è esemplare), e che suoni più commerciali irrompono. In particolare dilagano gli stili della
nuova musica da ballo, della dance elettronica. Negli anni settanta aveva per un attimo scandalizzato la conversione a un consumo facile di
un cantante ritenuto sperimentale come Alan Sorrenti (Figli delle stelle, 1977; Tu sei l’unica donna per me, 1979); ma nel decennio successivo un certo sound diverrà quasi la sigla di un ben definito immaginario. Il riferimento a tutt’oggi più noto è al tormentone Vamos a la playa
del duo Righeira (1983): musicisti con un passato di ricerca alla manie269
MODERNITÀ ITALIANA
ra dei tedeschi Kraftwerk, azzeccano il proverbiale ritmo-motivetto
che però nasconde un testo apocalittico da postesplosione nucleare
(«Vamos a la playa, / la bomba estalló, / las radiaciones tuestan / y matizan de azul»); non diversamente da quello che fa nella stessa estate il
Gruppo Italiano con una composizione altrettanto cinica e altrettanto
cantabile come Tropicana, che scandalizza un po’ il poeta e autore di
canzoni Roberto Roversi (cfr. Borgna, 1985, pp. 219-21), anche perché
– vi si dice – davanti alla catastrofe nucleare ci si sente come al cinema.
E si tratta – appunto – di exploit effimeri, estivi, di canzoni singole
estranee alle costruzioni complesse del concept album (di modo che
l’approccio alla canzone italiana dell’utile Salvadori, 2006, che si occupa solo dei singoli pezzi sino a farne un’enciclopedia, appare tutto
sommato plausibile).
Insomma, mentre imperversa la discussione intorno al postmoderno
(l’avvio del dibattito italiano, guarda caso, è proprio il 1979), molta canzone italiana diviene postmoderna, e in modo peraltro spesso consapevole. Il principale artefice di questa svolta è un musicista-cantante che
da molti anni pratica la composizione elettronica e sperimentale, Franco Battiato. In particolare con l’album La voce del padrone (1981), Battiato s’inventa uno stile destinato a durare molto a lungo: 1. un testo che
assembla citazioni tratte da un immaginario eclettico ma in fondo condiviso, in cui senza soluzione di continuità – e secondo un montaggio vagamente surreale – si alternano riferimenti colti e riferimenti pop; 2. una
costruzione musicale dance, arricchita da arrangiamenti classicheggianti (straordinari i cori maschili alla maniera di Carl Orff) ed elettronici, vicini ai modi della minimal music; 3. un’intenzionalità, implicita in tutta
l’operazione, che è di natura “gnostica”, intesa cioè a cifrare un po’ misteriosamente significati profondi (Battiato dichiara da molti anni la propria appartenenza al sufismo).
Basterebbe riascoltare, e provare a leggere, il centone di citazioni e
aforismi contenuto in una canzone come Bandiera bianca (dallo stesso album), quasi lo stupidario di un certo intellettualismo italiano, fra Bob
Dylan e il Risorgimento, Adorno e la pubblicità, passando attraverso
boutades ostentatamente demenziali («A Beethoven e Sinatra preferisco
l’insalata / a Vivaldi l’uva passa che mi dà più calorie»). È in gioco, evidentemente, il double coding, che tanto appassiona in questo periodo i
teorici del postmoderno, e in Italia i lettori del Nome della rosa. Battiato lo si può tranquillamente ballare come molti altri prodotti commerciali, eppure la trama di citazioni che sostanziano le sue scelte compositive dà piena soddisfazione a chi abbia della musica e dei testi una visione leggermente più complessa, e insomma abbia fatto le giuste letture e
i giusti ascolti.
270
6. CANZONE
Si potrebbe persino dichiarare che un effetto-Battiato diffusosi a
raggiera contraddistingua l’inizio degli anni ottanta, esattamente come
un effetto-Mogol-Battisti aveva attraversato la canzone di dieci anni prima. Già nel 1979 Giorgio Gaber aveva realizzato il suo nuovo spettacolo, Polli d’allevamento, con arrangiamenti di Battiato; che poi nel 1981
aiuterà Alice a vincere il festival di Sanremo (dopo un decennio di crisi
dell’istituzione festivaliera) con un pezzo, Per Elisa, composto insieme
con il violinista Giusto Pio; sempre Battiato contribuirà al lancio della
talentuosa Giuni Russo, offrendo inoltre i suoi servigi musicali alla “vecchia” Milva desiderosa di tornare alla ribalta. Questo intelligentissimo
bricoleur, dotato di un fiuto musicale quasi infallibile, crea un mix di antico e di nuovissimo, di sapienziale e di bassamente commerciale, che solo una maschera impassibile, come è quella da lui indossata, gli consente di gestire con sicurezza. Elevata da altri, la stessa impalcatura artistica crollerebbe subito, rivelando l’insopportabile opzione kitsch che le è
connaturata.
È da credere che questa della maschera, che tale capacità di mettere in scena non più il malinconico poeta autentico, bensì un esecutore che «dice di dire», sia una delle scoperte più interessanti di questo periodo. La canzone di Paolo Conte deve essere letta in questa chiave. Autore sin dagli anni sessanta di canzoni di successo e pianista jazz
mancato, all’inizio del decennio Conte ha superato i quaranta e la sua
carriera solistica è solo agli inizi. Tuttavia, e anzi proprio per questo, il
suo stile è tanto ben definito che per decenni sarà capace di garantire
una perfetta continuità e coerenza di sviluppo. Anche quando dice
«io», Conte comunica all’ascoltatore la netta separazione dell’io enunciato dall’io enunciatore, l’impossibilità di confondere biografia e arte. Certo, inizialmente, erano decisivi temi e contenuti volutamente démodé: certi ricordi degli anni quaranta; una provincialissima provincia
italiana tra Asti, Alessandria e Genova; certe vecchie balere, rese ancora più arcaiche dall’incombere di un jazz italicamente artigianale; insieme, un immaginario salgariano, fatto di nomi esotici che nemmeno
per un attimo cercano di nascondere le proprie origini cartacee o di
celluloide. Divenuti in seguito più astratti e impalpabili, i contenuti
della sua canzone non hanno per questo modificato il patto che il cantante instaura con il suo ascoltatore. Il fatto è che, con gli anni, il grandissimo performer che Conte è fa sempre meglio capire agli ascoltatori-spettatori che la sua opera, in fondo, sceneggia la propria relazione
con noi, con il pubblico. Il qui e ora in cui opera il contenuto, il tema,
è un ancoraggio per il nostro investimento affettivo; e infatti Conte è
maestro della deissi spaziale e temporale, collocando sé stesso sempre
in un setting per lo meno virtuale (cfr. su questo punto Zublena, 2007).
271
MODERNITÀ ITALIANA
Un esempio fra i moltissimi possibili, Via con me, dall’album Paris Milonga (1981):
Via, via, vieni via di qui,
niente più ti lega a questi luoghi
neanche questi fiori azzurri...
via, via, neanche questo tempo grigio
pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti
[...]
Via, via, vieni via con me
entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo...
via, via, non perderti per niente al mondo.
Paradossalmente, una canzone di Conte deve essere vista prima che ascoltata; deve essere situata in uno spazio-tempo vago sì ma rassicurante, indefinibile sì ma plausibile, generico (persino banale) sì ma convincente.
Sembrerà curioso, ma forse non lo è troppo: il terzo nome che benissimo rappresenta gli anni ottanta, si colloca agli antipodi dei primi
due. Alla maschera del compositore alchimista o del teatrante-musicista
performing si contrappone la nuda vita reale, l’esperienza maledetta reale, la voce di giovane uomo reale – caratteristiche di Vasco Rossi. Nessuno schermo o filtro fra lui e il pubblico; anzi perfetto riconoscimento
e identificazione empatica: Siamo solo noi, uno dei primi suoi grandi successi nel 1982, è esplicita fin dal titolo, quando allude a una dimensione
individuale che diventa quasi automaticamente collettiva. Certo, per lo
meno alle origini del suo successo, Vasco lancia anche espliciti segnali di
finzione e di falsetto: il suo Bollicine del 1983 in cui recita parole ironiche
a elogio della Coca-Cola e a mimesi di slogan pubblicitari allora in voga
(«Coca-Cola... / e sei protagonista / Coca-Cola... / per l’uomo che non
deve chiedere mai!!!»), un po’ è una critica al cosiddetto consumismo,
un po’ è un vero elogio del tipo umano, della moltitudine globalizzata
che della Coca-Cola non può più fare a meno.
A sfruttare il residuo margine di autenticità rimasto a disposizione
di chi fa canzone ci pensano alcuni nuovi gruppi rock che si affermano
in questo decennio. Per capire in che strana contraddizione agiscono, è
forse utile leggere due passi tratti da altrettante canzoni dei CCCP, la band
anni ottanta che probabilmente ha maggiormente inciso sullo sviluppo
della canzone rock nel successivo quarto di secolo:
Spara Jurij spara
spara Jurij spara
spara Jurij spara
Jurij spara
272
6. CANZONE
Spera Jurij spera
spera Jurij spera
spera Jurij spera
Jurij spera.
Felicitazioni
felicitazioni
felicitazioni.
Un freddo più pungente
accordi secchi e tesi
segnalano il tuo ingresso
nella mia memoria.
Consumami distruggimi
è un po’ che non mi annoio.
Aspetto un’emozione
sempre più indefinibile.
Teatri vuoti e inutili potrebbero affollarsi
se tu ti proponessi di recitare te.
Emilia Paranoica.
Brucia Tiro e Sidone, il roipnol fa un casino
se mescolato all’alcool.
Bombardieri su Beirut.
Da un lato dunque (Spara Jurij, 1984) un riff verbale, pura emissione
amelodica di un gesto conativo, omologo al primitivismo tipico del
punk; dall’altro (Emilia paranoica, 1985) addirittura una forma di introspezione, che certo è quella caratteristica dello “sballo” cara a una retorica beat e postbeat, ma che qui si arricchisce di una forza epica e mitopoietica e di una meta-riflessione («Teatri [...] se tu ti proponessi di
recitare te»), che in effetti giustifica la congiunzione sopra la storia di
Tiro, Sidone e Beirut.
La nuova parola rock, a differenza di quella ancora condizionata dalle canzonette del decennio precedente (persino gli Area usavano certi
troncamenti quando nel 1974 con Settembre nero cantavano: «Gente colorata quasi tutta uguale / la mia rabbia legge sopra i quotidiani. / Legge nella storia tutto il mio dolore / canta la mia gente che non vuol morir»), in questo modo forza gli estremi della glossolalia asintattica e della discorsività affabulante. E proprio il secondo aspetto, praticato dal
leader dei CCCP (poi CSI), Giovanni Lindo Ferretti, sarà destinato a influenzare la testualità del rock anni novanta. Lo vedremo. Anche i CCCP,
comunque, sanno di esprimersi in un contesto falso, così come falsa,
quasi farsesca, è l’iconografia “stalinista” che esibiscono; però è altrettanto chiaro che la loro maschera è funzionale ad altri temi; e che questo altro è tutto meno che ironico e leggero.
273
MODERNITÀ ITALIANA
Parola-gesto, parola-grido insieme a parola sinuosa, non priva di ricadute sapienziali. In gruppi come i Litfiba le due tensioni possono
confondersi, e comunque il testo di certe loro canzoni storiche “comunica” solo se affidato alla corporeità vocale di Piero Pelù («Cerco / in
una mano chiusa / la causa della morte di / uomini neri! / GUERRA / Aria
vuota nelle strade / si muovono le ombre di / uomini neri! / GUERRA» –
Guerra, 1982). Quasi all’opposto, le composizioni molto efficaci anche
sul piano delle parole (Siberia, del 1984, è ancora oggi attuale, magari per
versi come «I nostri occhi impauriti / nelle stanze gelate / al chiarore del
petrolio bruciato / e oltre il muro il silenzio / oltre il muro solo ghiaccio
e silenzio»), scritte da Federico Fiumani dei Diaframma, hanno una certa autonomia dal loro autore, e infatti furono inizialmente interpretate
da una voce diversa dalla sua.
Del resto, proprio su questo versante della qualità, gli anni ottanta,
traguardati dall’inizio del secondo decennio duemillesco sono soprattutto quelli del De André cantante anche in genovese, che con un album
come Creuza de mä (1984: opera nient’affatto cantautorale, e anzi frutto
di un’officina rock, se non addirittura di un’intenzione world music, in
cui un ruolo decisivo è svolto dalle sonorità progettate da Mauro Pagani), propone una straordinaria sintesi “artistica”. E forse De André in
questo suo percorso esagera un po’, proprio per un tentativo fin troppo
esibito di giungere a una sorta di musica totale, tanto autorevole e prestigiosa quanto suscettibile di un’ammirazione un po’ fredda, esterna,
passiva (cfr. Fabbri, 2005, pp. 148-69; 2009).
Anni novanta. La voce, le lingue
Fortunatamente, la seconda metà degli anni ottanta e l’inizio del decennio successivo hanno avuto la forza di modificare un quadro sin troppo
propenso a impreziosire l’oggetto-canzone, a farne un feticcio serioso, a
incrementarne in modo preterintenzionale l’aura kitsch. Tra i principali
e benemeriti fautori di tale – diciamo – abbassamento rabelaisiano, un
ruolo fondamentale è stato svolto da Elio e le Storie Tese. Basti dire che
il loro primo successo per lo meno di nicchia è, intorno al 1988, John Holmes, elogio delle iperboliche virtù dimensionali («trentatré centimetri di
dimensione artistica») di un noto pornoattore allora da poco scomparso; tale monologo del “superdotato estinto”, che una decina d’anni prima si sarebbe detto demenziale, ora però è sostenuto da una band tutt’altro che primitiva e rozza musicalmente, anzi capace di plasmare suoni
molto smaliziati. Elio e compagni sono inizialmente soprattutto un fenomeno da concerto, per la loro bravura anche tecnica. Nel 1989 esce il
274
6. CANZONE
loro primo album, con titolo in lingua tamil, Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu, il cui contenuto dice di flatulenze ed eiaculazioni da realizzare in compagnia di Elio (!). Tre anni dopo il secondo (dal titolo non
meno ostico: Italyan, Rum Casusu Çikti, che in turco significa «Si è scoperto che l’italiano era una spia greca») contiene la geniale Pipppero©,
in cui si realizza in modo goliardico ed esilarante qualcosa in fondo di
molto serio, vale a dire l’assemblaggio delle meravigliose voci di un notissimo coro femminile bulgaro, di una parodia dei balli “a comando” e
di riferimenti a noti (e sempre “bulgari”) complotti internazionali:
Evviva l’Italia, evviva la Bulgaria
che ci ha fatto dono del PIPPPERO.
Ruotiamo le dita e uniamo le falangi,
questo è il ballo del PIPPPERO.
Amici servizi segreti bulgari, non sparate più al papa
ma dedicatevi al PIPPPERO.
Popolo bulgaro – iù –.
Popolo italiano.
Servizi segreti bulgari e italiani, via.
Sentite come pompa il PIPPPERO.
Ma ben più radicale è un’altra novità degli anni novanta, ben più eversivo è un fenomeno che nello scenario globale è stato addirittura in grado
di trasformare alla radice la percezione del rapporto parole/musica, l’idea e la pratica della canzone. Mi riferisco prevedibilmente a quanto oggi viene di solito chiamato rap, e costituisce il corrispettivo musicale di
una serie di pratiche (danza, pittura e scrittura murale, comportamenti,
abbigliamento ecc.) riconducibili alla galassia hip-hop. Sin dagli inizi degli anni ottanta, disc-jockey neri statunitensi avevano cominciato a ritmare su basi di musica da ballo testi di contenuto per lo più autobiografico (ma precocemente virato al sociale), non di rado molto violento
o osceno. La prassi maggiormente in voga prevede che siano manipolati meccanicamente pezzi musicali registrati su vinile, e che la voce del
cantante (MC, master of ceremonies, maestro di cerimonie) non intoni una
vera linea melodica, ma si limiti a un recitativo ossessivamente ritmico
(spesso giambico), con frequentissime rime, in certi casi ribadite sino al
virtuosismo. Quanto ai contenuti, ben presto il rap acquisisce connotazioni di protesta assai esplicite, pur non perdendo mai una caratterizzazione tematica che noi definiremmo “machista” o “bullista”, priva di
ogni forma di mediazione o attenuazione, e anzi mostrandosi sempre
pronto a esasperare le proprie provocazioni.
L’insieme delle pratiche musicali hip-hop ancora oggi conserva qualcosa di estremo, di inquietante e scandaloso. Il meraviglioso narratore
275
MODERNITÀ ITALIANA
americano David Foster Wallace, fra l’altro interpretando il punto di vista dell’ascoltatore white, l’ha icasticamente definito «l’unico tipo di
avanguardia di cui ormai Noi abbiamo ancora paura», proprio per la sua
«posizione di estraneità all’interno della cultura bianca tradizionale»,
per la «sua schietta strafottenza verso qualunque forza tenda a omogeneizzare o centralizzare l’universo musicale» (Wallace, Costello, 1990,
pp. 55-6).
In Italia (De Paoli, 1998; Pacoda, 2000; Scholz, 2002, 2004; Borroni,
2004) è appunto con gli anni novanta che il fenomeno comincia ad attecchire, con particolare forza al Sud, anche per la precocissima tendenza a “rappare” in dialetto. Sin troppo facile, ma certo molto suggestivo, è cogliere nel fenomeno un vero e proprio ritorno all’oralità. La
cultura altra dei neri americani (i cui legami con l’oralità “primaria” non
si sono mai interrotti, e semmai nel Novecento si erano sublimati in forme artistiche mutanti, come, tipicamente, il jazz – cfr. Caporaletti, 2005)
attraverso la mediazione dell’elettronica e poi del digitale eccita la ripresa del medium vocale e della lingua “materna” che meglio lo incarna.
Giovani e meno giovani protagonisti del movimento (che presenta complesse diramazioni: sul versante del suono reggae si ha per esempio il cosiddetto raggamuffin) sono concordi nel dichiarare la loro riscoperta,
non tradizionalistica comunque, di un retaggio popolare la cui consapevolezza è cresciuta in loro grazie ai modelli nordamericani. L’enunciazione mistilingue dei salentini Sud Sound System in un pezzo come Soul
Train (1996) dichiara in effetti un radicale e benefico eclettismo (in mezzo al quale rime o assonanze imperfette quasi sconosciute alla tradizione colta, come le “ipermetre” atone classe: Schaffausen e fugge: origine,
incuriosiscono l’orecchio):
Pallidu politicu nun ci ha statu maiu in seconda classe
sullu trenu che va da Lecce a Schaffausen
chinu de gente sì ma gente ca sta fugge
lontano dalla loro terra d’origine
amara e resa pesante come il piombo
mandata allo sbaraglio lasciata affondare
tradita depredata sbranata e violentata
e me chiedi se cussì se pò campa’
ieu lu sacciu peccé lu portu lu paccu de cartune.
Almeno agli inizi, il neonato genere si contraddistingue, in Italia, per la
sua natura collettiva, frutto di aggregazioni, dette posse (parola dell’American English di origine trasparentemente latina, che dapprima sta a
indicare il gruppo di volontari guidati da uno sceriffo i quali si organizza276
6. CANZONE
no per dare la caccia a un malvivente), dove i singoli agiscono sempre
con pseudonimi e non hanno alcuno spicco divistico.
Frankie HI-NRG MC, siciliano di origine e vissuto a Caserta, è comunque uno dei primi importanti talenti “individuali”. E il suo pionieristico successo, Fight da faida (1992, che tra l’altro riprende l’iperpoliticizzato Fight the Power degli americani Public Enemy, presente
anche nel film di Spike Lee Fa’ la cosa giusta, del 1989), suggerisce i possibili risvolti civili del fenomeno rap, secondo una sorta di tradizione
“impegnata” perfettamente italiana. E, tuttavia, in particolare lo studioso del ritmo ha modo di cogliere la natura ancipite del testo: la sua
ricchezza di rime, la sua scansione in membri versali percepibilissimi,
il suo profilo insomma metrico, tuttavia convive con qualcosa di eliminabilmente prosastico, si nutre di una humus che è discorsiva e anzi
espositivo-argomentativa. Si dice che il rap sia la CNN dei poveri; e ciò
sta in effetti a suggerire che i suoi contenuti, pur formalizzati con tecniche in senso lato “poetiche”, negano ogni appartenenza di natura
seppur vagamente lirica. L’MC, a ben vedere, pur con tutto il suo individualismo muscolare e conflittuale, non esprime tanto sé stesso quanto una comunità. Il suo esserne almeno idealmente leader lo costringe
a rendere ancora più affilata e rappresentativa la parola. Il testo prosastico – appunto di Fight da faida – è qui stato diviso nei segmenti metrici ritenuti pertinenti.
Padre contro figlio, | fratello su fratello, | partoriti in un avello | come carne da
macello, | uomini con anime | sottili come lamine, | taglienti come il crimine, |
rabbiosi oltre ogni limite, | eroi senza una terra | che combattono una guerra |
tra la mafia e la camorra, | Sodoma e Gomorra, | Napoli e Palermo | succursali
dell’inferno, | divorate dall’interno | in eterno, | da un tessuto tumorale | di natura criminale | mentre il mondo sta a guardare | muto senza intervenire. | Basta
alla guerra fra famiglie | fomentata dalle voglie | di una moglie colle doglie | che
oggi dà la vita ai figli | e domani gliela toglie, | rami spogli dalle foglie | che lei taglia come paglia | e nessuno se la piglia: | è la vigilia di una rivoluzione | alla voce del Padrino, | ma don Vito Corleone | oggi è molto più vicino: | sta seduto in
Parlamento. | È il momento di sferrare | un’offensiva terminale, | decisiva, radicale, distruttiva, | oggi uniti più di prima alle cosche, | fosche attitudini losche, |
mantenute dalle tasse, | alimentate dalle tasche: | basta una busta | nella tasca giusta | in quest’Italia così laida...
In effetti, la situazione della canzone negli anni novanta è ricchissima di
motivi evolutivi, anche perché il mondo hip-hop era stato preceduto, in
alcune sue innovazioni, dallo sviluppo del reggae dialettale (già alla fine degli anni ottanta i Pitura Freska, che cantano in veneziano, avevano raggiunto un ampio successo); ma in seguito le contaminazioni si
277
MODERNITÀ ITALIANA
moltiplicano in modo quasi incontrollabile, all’insegna di una continua
ibridazione dal basso. Fautori sin dal 1992 di uno strampalatissimo incontro fra dialetto torinese e sonorità africane e sudamericane, i Mau
Mau diverranno assertori di una “poetica” della patchanka (la definizione in realtà si deve a Manu Chao, un artista di cui, non a caso, è quasi impossibile definire l’identità nazionale e che canta in un numero impressionante di lingue diverse...): finita l’epoca delle musiche d’arte
contrapposte a quelle commerciali, oggi il musicista si sente legittimato
a pescare disordinatamente dalle tradizioni che più gli aggradano onde
giungere alla propria personalissima sintesi. In questo Marasma General (titolo di un doppio album appunto dei Mau Mau, del 2001, che documenta aspetti dell’attività dal vivo del decennio precedente) da un lato i generi si moltiplicano a dismisura diramandosi in continue sottospecificazioni, dall’altro la prassi della patchanka li relativizza e rende
impraticabili.
Un simile atteggiamento, si noterà, quasi rovescia il postmoderno
anni ottanta: ora, non si tratta di degradare materiali nobili (di inserire
il Risorgimento o Adorno in un contesto dance – alla maniera di Battiato), ma davvero di giocare orizzontalmente con quanto il cantante ha a
disposizione, e ritiene appartenere alla sua cultura. In questo senso,
dobbiamo segnalare per lo meno due tendenze ormai chiare intorno alla metà degli anni novanta e arrivate felicemente sino alla fine degli “anni Zero”. 1. Una nuova generazione di cantautori che, eredi soprattutto
di Paolo Conte e Rino Gaetano (di una tradizione, voglio dire, anch’essa non lirica) e in parte di certi modi compositivi del Battiato “canzonettiere”, lavorano su pattern musicali massimamente eclettici, al limite del commerciale, ma sanno anche mantenere una spiccata indipendenza “artistica”. 2. La terza ondata del rock italiano che per la prima
volta nella storia del genere sembra in grado di definire un rapporto non
squilibrato fra parole e musica, e anzi (anche grazie alla lezione di un
vecchio maestro come Giovanni Lindo Ferretti) propone le forme di
una nuova testualità.
Nel 1997 il trentenne Max Gazzè incide un singolo, Cara Valentina,
il cui testo suona più o meno così:
Cara Valentina il tempo non fa il suo dovere
e a volte peggiora le cose.
Credimi pensavo davvero di avere superato il momento difficile
ed ancora adesso non mi è chiaro lo sbaglio che ho fatto
se il vero sbaglio è stato il mio
perché dai miei trent’anni ti aspettavi un uomo col senso del dovere
perché chi s’innamora non deve dirlo a nessuno
278
6. CANZONE
oppure è un’impudente enfatica demenza
nel farti le carezze girata dall’altra parte.
Ho la strana sensazione di un amore acceso
esploso troppo presto fra le mani
e cara Valentina che fatica innaturale perdonare a me stesso
di essere io di essere fatto così male.
Cara Valentina il tempo non fa il suo dovere
e a volte peggiora le cose...
E tu sarai il pretesto per approfondire
un piccolo problema personale di filosofia
su come trarre giovamento dal non piacere agli altri
come in fondo ci si aspetta che sia.
Per esempio non è vero
che poi mi dilungo spesso su un solo argomento...
Naturalmente, la storia della canzone italiana è tessuta di testi in forma
di lettera (la generazione anni settanta avrà nell’orecchio L’anno che
verrà di Lucio Dalla, del 1978; e già nel 1912 Cara piccina di Lama-Bovio
aveva realizzato “epistolarmente” uno dei primi modelli di lirismo canzonettistico nazionale); ma qui c’è qualcosa d’altro. E non è solo per il
finale, forse noto, in cui l’enunciatore chiede di non essere accusato di
apparire troppo ripetitivo, ma lo fa ripetendo ossessivamente la stessa
frase, cioè gli ultimi due versi... A me sembra invece che qui per la prima volta, almeno nella canzone italiana, sia in primo piano il fluente e
leggermente sconclusionato italiano dell’e-mail, dello scrivere e scriversi per posta elettronica; una dimensione proverbialmente orizzontale e scarsamente strutturata, che tuttavia in questo caso – nella geniale
sintesi di Gazzè – viene costretta a chiudersi su sé stessa per l’iniziativa latamente metrica della musica. È un modulo, questo, che troverà
fortuna nel decennio successivo (ci ritorneremo). Ogni conato lirico,
ogni serietà, con tutta evidenza, implodono. Il gioco di Gazzè è volutamente surreale; basti pensare alla malizia anche ritmica con cui scrive nel Timido ubriaco (2000) versi che quasi sembrano rifarsi a forme
metriche, a base bisillabica, presenti nella poesia francese (per esempio
in Hugo):
Sposa
domani ti regalerò una rosa
Gelosa d’un compagno non voluto
temuto
Stesa
caldissima per quell’estate accesa
279
MODERNITÀ ITALIANA
Fanatica per duri seni al vento
io tento
Tanto
quell’orso che ti alita accanto
Sudato che farebbe schifo a un piede
non vede
Dorme
tapino non le tocca le tue forme
Eppure è ardimentosa la sua mano
villano.
E se Daniele Silvestri ha estremizzato certi virtuosismi testuali utilizzando anche suggestioni rap (ma puntando su temi leggermente più
scontati), è Vinicio Capossela che negli anni novanta va nella direzione
d’una canzone d’autore per certi aspetti “alta” ma anche fortemente
contaminata. Anzi, la teatralizzazione, che Capossela ha imparato dal
suo maestro Paolo Conte, lo induce a lavorare spesso à la manière de,
citando non solo dai suoi autori preferiti (Fante, Kerouac, Bukowski,
Céline, Fellini), ma scrivendo – per esempio – una specie di parafrasi
della Pioggia nel pineto, ambientandola a Milano (cfr. Pioggia di novembre, 1996), o riprendendo il Codice di Perelà di Palazzeschi (cfr. Marajà, 2000). Del resto, pur progettando i suoi album in modo concettuale, è vero che Capossela soprattutto verticalizza le canzoni, e le concepisce come entità comunicative autonome in cui una “storia” giunga
a pieno compimento. L’intento, meritorio, è proprio quello di distruggere ogni residuo di poeticità, di spiegare a chiare lettere che chi canta
non è Vinicio Capossela. Prendiamo Body guard, contenuta in Il ballo
di San Vito (1996). Su un ritmo in levare, di fatto un reggae, ascoltiamo
il rovesciamento di Vita spericolata di Vasco Rossi: un io non meno propenso alla trasgressione (fino all’iperbole e allo zeugma: «qui in un attimo sei fritto / coca pillole e vinazza / aspirati in quantità») chiede per
sé non il piacere del rischio ma la certezza della difesa dai pericoli, vale a dire una serie sempre più numerosa di body guard, che tutelino la
sua ipocondria:
Sì, io la voglio la body guard
che mi protegga dalla volgarità
sì io chiedo una body guard
perché adesso vivo nell’oscurità.
Da questo punto di vista, i rocker italiani anni novanta denunciano, in
prima battuta, una fisionomia quasi opposta, dal momento che in loro la
rabbia, lo sfogo individuale sembrano imporsi sopra tutto il resto, al280
6. CANZONE
l’insegna di una vitalità che violenta le parole dall’esterno, e in modo abbastanza grezzo. L’a priori musicale e strumentale è in effetti una loro –
peraltro ovvia – caratteristica. Ma a guardare le cose più da vicino tale
impressione va parecchio ridimensionata. Intanto, un elemento di interesse è costituito da una certa oltranza verbale, per esempio negli Afterhours («So che lei sa / strategie dell’apnea / che sono sue amiche, che
sono ferite / novità il vero che muore / succhiandomi il cazzo svanisce /
il risveglio dal sogno / forse uccide, mai tradisce»; Strategie, 1995); e poi
colpisce che nei Massimo Volume il testo possa trasformarsi in una mera prosa narrativa, di impianto noir, che riduce al minimo ogni sviluppo
melodico e dà luogo a un semplice recitativo. Basta leggere l’incipit di
Ronald, Tomas e io (1993) – in cui tra l’altro colpiscono al terzo verso certi congiuntivi ipercorretti:
Roffe ha un buco sulla testa
una cicatrice dieci centimetri sopra l’occhio destro.
Sembra che se cada e batta in quel punto muoia sul colpo.
Così mi disse Tomas, e così è andata.
Ma questo è successo tempo dopo.
Io ormai non abitavo più lì, e nemmeno Tomas.
Ma lo ricordo bene, Roffe.
Altri gruppi come i Bluvertigo e i Marlene Kuntz mettono a partito la lezione di Giovanni Lindo Ferretti, vale a dire la costruzione di testi intonati sì, ma dallo sviluppo orizzontale, monotono, quasi da litania, entro
il quale un ritmo dattilico tende a farsi dominante:
Orso si sposta goffamente con passo irregolare
nel flusso irregolare della gente che scontra;
le mani dentro a un buco, tasche sfinite
vociare di monete obsolete
Orso ci vede nebulosamente, nebulosamente: già.
Ne discende una diversa percezione del rapporto fra testo e musica: le
parole riempiono una vera e propria mascherina metrica, frutto del ritmo musicale, che sempre più torce la lingua italiana e la strania costringendone il polisillabismo “nativo” a interruzioni e spezzature interne innaturali. In questo senso, rock e rap convergono. Cristiano Godano, la voce dei Marlene Kuntz, nella canzone appena citata (Sonica,
1994) scandisce «nebulòsa-ménte», rietimologizzandola come se fosse
composta di due parole separate; e in una più recente incisione del
gruppo (Uno, 2007) si odono esecuzioni di questo genere: «la tua presenzà / rassicurante e ipnoticà / mi affascinà / e gioca col mio sennò / e
281
MODERNITÀ ITALIANA
né lascia [...]», che nella canzone anche di livello medio-basso d’oggi sono divenute assolutamente normali.
“Anni Zero”. I ritmi, il testo infinito
Il fatto è che negli ultimi vent’anni, anche al di là (o al di qua) delle sperimentazioni più coraggiose e indipendenti e della couche cantautorale,
il modo stesso di concepire la canzone è andato incontro a una modernizzazione che ha imposto nuovi stili e nuove maniere (cfr. in generale
Antonelli, 2005). Persino interpreti di cassetta come Luca Carboni, Samuele Bersani, Gianluca Grignani ma anche come il “vecchio” Eros Ramazzotti o come il giovane e oggi fortunatissimo Tiziano Ferro, e poi le
voci femminili di Giorgia, Irene Grandi, Carmen Consoli, nonché, e certo soprattutto, di Laura Pausini, configurano l’esistenza di una canzone
italiana mainstream di portata internazionale che presenta caratteristiche
almeno in parte da scoprire. Certo, talune strutture di fondo – come l’annosa alternanza strofa-ritornello – sono grosso modo rispettate; ma è vero che anche nei più emotivi ed emozionati Pausini e Ferro sono presenti
interessanti teatralizzazioni dinamiche.
Ad esempio, in un hit davvero mondiale come Il regalo più grande di
Tiziano Ferro (2008: il video che lo accompagna è stato girato a New
York, in perfetto stile Muccino) può succedere che il ritornello, pur sottolineato in modo enfatico (anche attraverso una salita di tonalità
conforme a una procedura del tutto canonica), in realtà non abbia affatto una struttura melodica molto articolata, gerarchizzata, anzi appaia
piuttosto ripetitivo; e sia possibile che la conclusione non venga affidata all’acme del ritornello ma a una coda con testo sussurrato e poco intonato, che ha il ruolo di smorzare il sound e di aumentare la drammaticità dell’esecuzione. Ma, soprattutto, le parole sono una specie di gesticolazione testualmente ipercoesa (su questo fenomeno nella canzone
sanremese cfr. Arcangeli, 1999), non senza qualche goffaggine. L’elocutore segnala la perfetta chiusura su sé stesso del proprio sentimento con
una fitta trama di connettivi (uno dei quali approssimativo, come si noterà: «che / anche che» corrisponde a “anche se”):
Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché
di notte chi la guarda possa pensare a te
per ricordarti che il mio amore è importante
che non importa ciò che dice la gente perché
tu mi hai protetto con la tua gelosia che anche
che molto stanco il tuo sorriso non andava via
282
6. CANZONE
devo partire però se ho nel cuore
la tua presenza è sempre arrivo
e mai partenza.
La canzone sentimentale, dunque, non presenta melodie intrinsecamente troppo patetiche , e punta piuttosto sulla presenza “scenica” e vocale
dell’interprete, quasi sulla sua attorialità, sulla capacità di porgere innanzi tutto con la grana della voce, con il nesso inscindibile, “auratico”
per certi versi, voce-corpo. E anche la sintassi, ripeto, si sta (melo)drammatizzando.
Va ribadito con forza: una forma nuova di testualità sta prendendo
corpo, e la capacità di affabulazione infinita di un certo tipo di nuova
canzone è un dato inequivocabile. Se negli anni novanta era stato possibile un fenomeno come quello degli 883, capaci di concentrare storie ricchissime ed espressive in pochi azzeccati (e sghembi) versi, alla fine del
decennio e poi nel 2000 una certa canzone di qualità è quella che riesce
a intonare parole di questo genere:
Ma come posso dare l’anima
e riuscire a credere
che tutto sia più o meno facile
quando è impossibile
volevo essere più forte di
ogni tua perplessità
ma io non posso accontentarmi se
tutto quello che
sai darmi
è un amore di plastica.
Certo, chi ha nell’orecchio la voce di Carmen Consoli sa benissimo che
Amore di plastica (1996) è una canzone che funziona alla perfezione perché c’è quella impetuosa e particolarissima voce che “imburra” il testo
(Parole di burro è il titolo di un suo pezzo del 2000) e lo fa scorrere senza alcuna difficoltà sino allo scioglimento, slalomando tra sdrucciole rese tronche o atone accentate (animà, facilé, ché) e soprattutto tra i continui enjambements. Di nuovo, infatti, a colpire è l’allure da scrittura dell’io poco raffinata – di nuovo l’e-mail, si potrebbe dire –, che tuttavia non
è lasciata del tutto a sé stessa, a una vaga soggettività desiderante, perché chi parla, qui, non si limita a esprimere passioni e sentimenti, ma
proprio si spiega, argomenta, ragiona.
In parallelo, si può inoltre parlare di una letteraturizzazione della
canzone degli ultimi dieci-quindici anni, anche in virtù di fenomeni di
ibridazione “esterna” un tempo impensabili. Fin dal 1997, Garbo ave283
MODERNITÀ ITALIANA
va pubblicato un album (Up the line) contenente pezzi che musicavano parole, tra gli altri, di Aldo Nove e Tiziano Scarpa. Gli stessi due autori insieme a Raul Montanari danno vita nel 2001 a un’operazione assai discussa come il progetto Nelle galassie oggi come oggi. Covers, un
libro di poesia pubblicato presso la classica collana “bianca” di Einaudi, che tratteggia il paradosso di coverizzare, cioè reinterpretare, canzoni (originariamente in inglese, peraltro) con l’ausilio però solo della
poesia del verso. Ovviamente si tratta di un confronto intermediale del
tutto impossibile, ma efficace sul piano della provocazione, nel momento in cui costringe a riflettere sulle modalità enunciative radicalmente diverse della poesia e della canzone (su tutto ciò, cfr. Giovannetti, 2008). E poi ci sono i ResiDante (Il fronte interno, 2003) che hanno musicato poesie del poeta Gabriele Frasca, il quale tra l’altro ha
spesso eseguito pubblicamente certi suoi testi cantandoli. E la registrazione del 2007 dei Marlene Kuntz, sopra ricordata, si accompagna ai
cammei testuali commissionati a scrittori, diciamo, ufficiali (Carlo Lucarelli, Stefano Benni, Enrico Brizzi, tra gli altri). E così via. Non sempre fortunatissime né di qualità necessariamente eccelsa (colpisce per
esempio l’esito deludente della collaborazione Gianna Nannini-Isabella Santacroce, con l’album Aria del 2002), simili ricerche confermano
proprio il bisogno di implementare la testualità infinita della canzone,
la sua vera e propria fame di parole.
Molta di detta letterarietà si configura, nei testi più diffusi, come un
flusso poco gerarchizzato. Lo confermano molti fattori. Poniamo: dalla
persistente produttività del rap, che continua a sfornare giovanissimi
nuovi talenti capaci di incastri metrici spesso originali e complessi, all’emergere di figure eclettiche come quella di Simone Cristicchi, che vince
a Sanremo nel 2007 con una canzone di «impegno sociale» (così è stata
definita la sua Ti regalerò una rosa) e che è dotato di una capacità affabulatoria tecnicamente notevole, non lontana dalle tecniche hip-hop. E
ancora: da un uso nuovo (quasi descrittivo, se non proprio narrativo)
delle canzoni all’interno di film di successo, come per esempio è capitato a Carmen Consoli nell’Ultimo bacio di Gabriele Muccino (2001) oppure con l’inserimento di pezzi dei Negramaro nel film La febbre (2005)
di Alessandro D’Alatri, al successo per lo meno di critica del gruppo reggiano degli Offlaga Disco Pax, che non presenta canzoni ma pezzi recitati dal contenuto un po’ demenziale (ma il modello vero sembra essere
il Woobinda di Aldo Nove), un po’ esplicitamente politico. Da un estremo all’altro, si dispiega un campo di invenzioni discorsive, estemporanee
forse, ma non di rado convincenti. Certo, può capitare che in queste corse attraverso le parole si verifichino i curiosi fenomeni di deformazione
più volte ricordati; e che per esempio nella brillantissima Lo scrutatore
284
6. CANZONE
non votante di Samuele Bersani (una variazione, anno 2006, sulla struttura tropica dell’ossimoro)
Lo scrutatore non votante
[...]
si è comperato un mangia-carte
per sbarazzarsi della verità.
Lo scrutatore non votante
è sempre stato un uomo fragile
poteva essere farfalla
ed è rimasto una crisalide
telefonate al cartomante
che non contatta neanche l’aldiquà,
il cantante sia costretto a pronunciare vèrita e (!) àldiqua per restar
dentro alla gabbia metrica prescelta. Se trent’anni fa Pier Marco Bertinetto (1981) riteneva solo sporadici e occasionali i fenomeni di forzatura della prosodia italiana ereditata nella direzione dell’inglese, vale
a dire nella direzione di una lingua a isocronia accentuale (laddove l’italiano sarebbe una lingua a isocronia sillabica), ciò oggi appare meno
certo; e anzi sono molti i segnali di un intacco strutturale della lingua
italiana di canzone da parte di una metrica accentuativa di origine appunto inglese.
Che nuovi ritmi e una diversa qualità della prosodia dell’italiano
stiano facendo capolino, è forse una buona notizia. Il lungo lavoro extraistituzionale – ai margini del sistema letterario e di quello musicale
colto – svolto dalla canzone italiana rinnovata dà frutti inattesi, e la
sua vitalità è indubbia. In questo senso, persino un evento massificato come il talent show intitolato X Factor può essere letto quale sintomo di un protagonismo dal basso, irruzione nell’ormai senile televisione di una sensibilità giovanile attenta al nesso corpo-voce così importante per il mondo della canzone. In fondo, il talento commerciale di Giusy Ferreri – classificatasi seconda nella prima serie della trasmissione (2008), ma di fatto una specie di sua “vincitrice morale” –
passa attraverso una voce bella e originale; e la struttura scontata della composizione che più l’ha resa famosa, Non ti scordar mai di me, riesce a rileggere il topos più che mézzo del “non ti scordar di me” con
parole prosastiche e disincantate, che non temono di confrontarsi con
lo «stare insieme» (= “essere fidanzati”) e l’attenuazione ragionativa
dell’«un po’» (per giunta ripetuto); appunto per restituire al tutto parvenze quotidiane. Le solite contraddizioni della canzone – verrebbe
da dire.
285
MODERNITÀ ITALIANA
Non ti scordar mai di me,
di ogni mia abitudine,
in fondo siamo stati insieme
e non è un piccolo particolare.
[...]
Forse è anche stata un po’ colpa mia
credere fosse per l’eternità.
A volte tutto un po’ si consuma,
senza preavviso se ne va.
Sul versante diametralmente opposto proprio tale disinibita discorsività
consente al giovane ferrarese Vasco Brondi, che si firma Le Luci della
Centrale Elettrica (quasi si trattasse di un gruppo), di concepire testi di
cupa violenza politica, eseguiti con una voce urlata e monotona, espressionistica, che racconta l’angoscia dei precari “anni Zero”. E il fatto notevole – certo – è che molti testi di questo autore nascono dalla trasposizione in versi di pagine originariamente prosastiche, “postate” in un sito web. Sempre più lontana dalla poesia, ma sempre più sociale, insomma, la nuova canzone italiana un po’ invera un po’ tradisce le sue radici
anni settanta. Ecco nella sua interezza il testo di Nei garage a Milano nord
(2008) che non indegnamente – forse – ambisce a essere sintesi del disagio (ma anche dell’energia) giovanile; e che negli ultimi versi campiona
spettralmente Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano:
I semafori cominciavano a lampeggiare
centimetri tra le nostre bocche con un contratto andato a male
le istruzioni per abbracciarsi
e per ballare negli scompartimenti delle metropolitane
sarà l’effetto serra il nostro carcere speciale
le fotocopie del cielo milanese.
Che Milano era veleno, che Milano era veleno.
Era un deserto al contrario
un cielo notturno illuminato a giorno
da stelle cianotiche da stelle col tuo nome
le insegne luminose e i tifosi violenti
arruoliamo brigatisti
arruoliamo brigatisti
arruoliamo brigatisti.
Nei bar deserti sui navigli
la curiosità ci divorava
e staremo ad abbaiare a questo cielo da rottamare
abiteremo in un centro sociale affacciato sulle discariche e sul mare
ma lavoreremo ancora in nero.
286
6. CANZONE
Milano era veleno, Milano era veleno.
Era un deserto al contrario
un cielo notturno illuminato a giorno
da stelle militanti da stelle deficienti
dalle p38 caricate a sale
Milano da bere Milano da pere
amori interinali e poliziotti di quartiere.
Nei bar deserti i navigli
per ammazzare il tempo ci siamo sconvolti, per ammazzare il tempo ci siamo sconvolti
per ammazzare il tempo ci siamo sconvolti, per ammazzare il tempo ci siamo sconvolti.
Nei garage a Milano nord
nei garage a Milano nord
nei garage a Milano nord
nei garage a Milano nord.
Chi odia i terroni
Chi ha crisi interiori
Chi scava nei cuori
Chi legge la mano
Chi regna sovrano
Chi suda e chi lotta
Chi mangia una volta
Chi gli manca una casa
Chi vive da solo
Chi prende assai poco
Chi gioca col fuoco
Chi vive in Calabria
Chi vive d’amore
Chi prende i sessanta
Chi arriva all’ottanta
Chi muore a lavoro
Chi muore a lavoro
Chi muore a lavoro
Chi muore a lavoro
Chi muore a lavoro
Chi muore a lavoro.
287
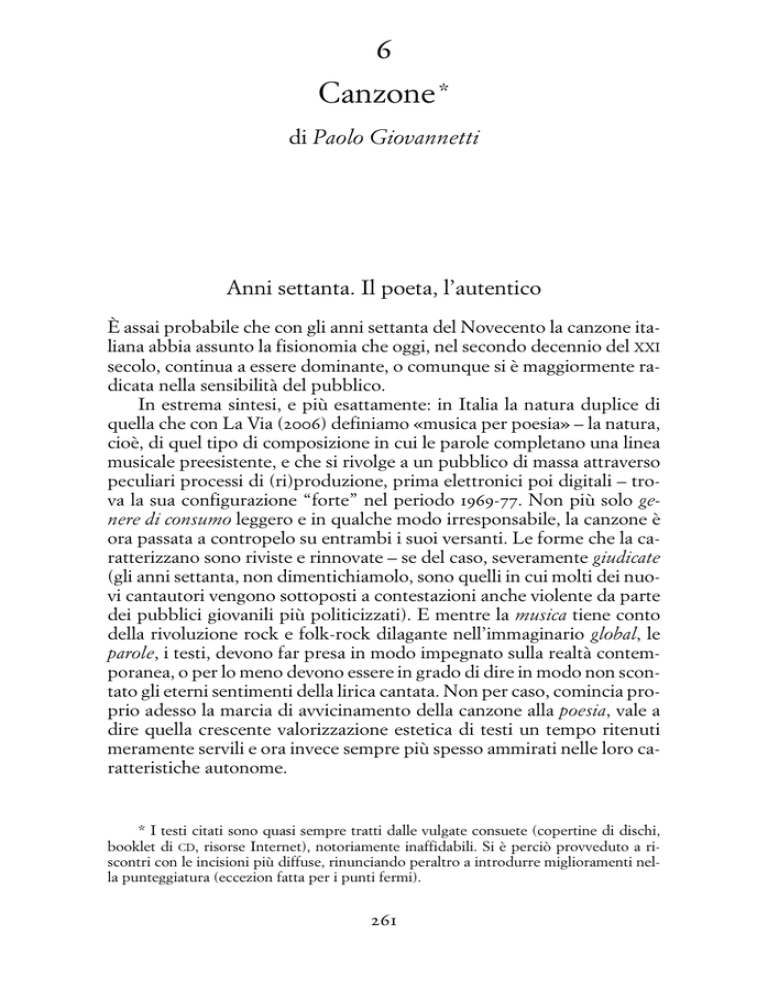
![Musica_e_immagine.pps [modalità compatibilità]](http://s1.studylibit.com/store/data/007525709_1-5cde61487a57acc65bf762230b059028-300x300.png)