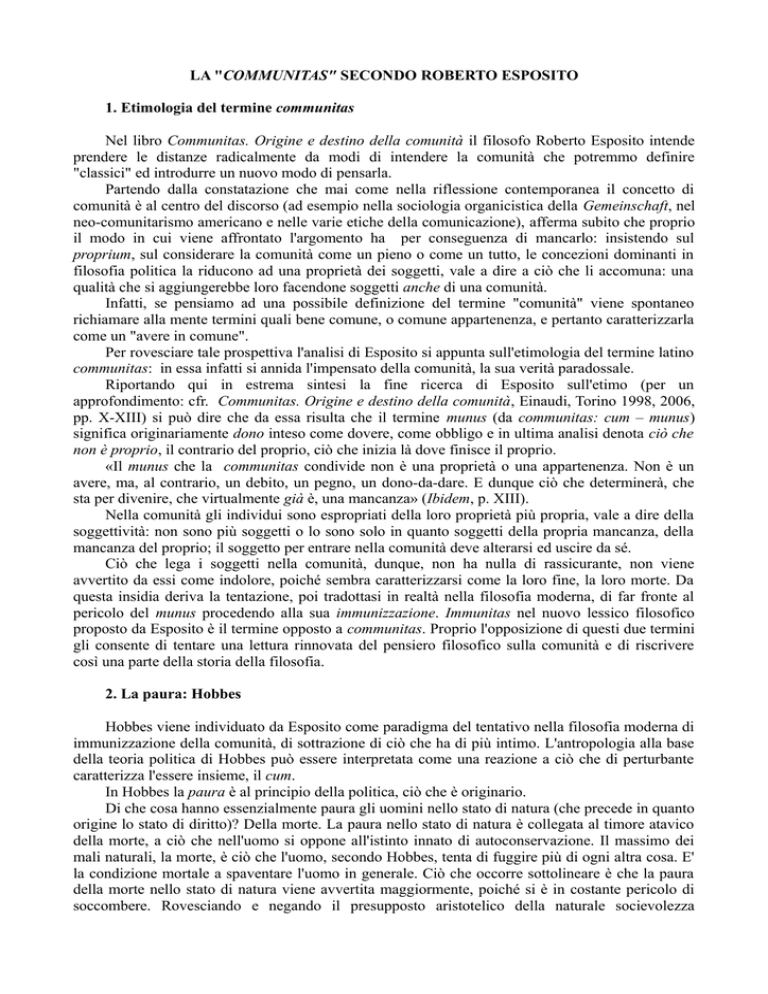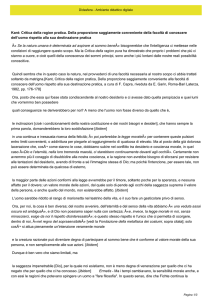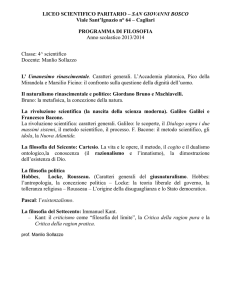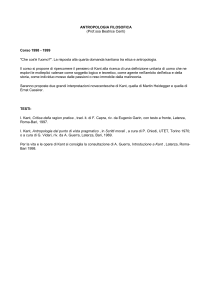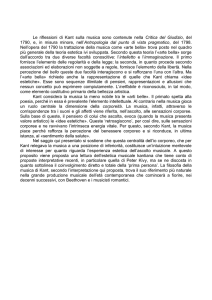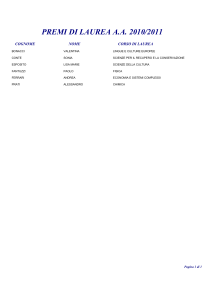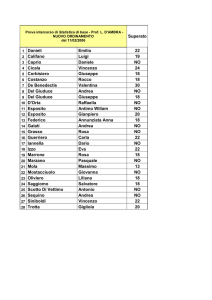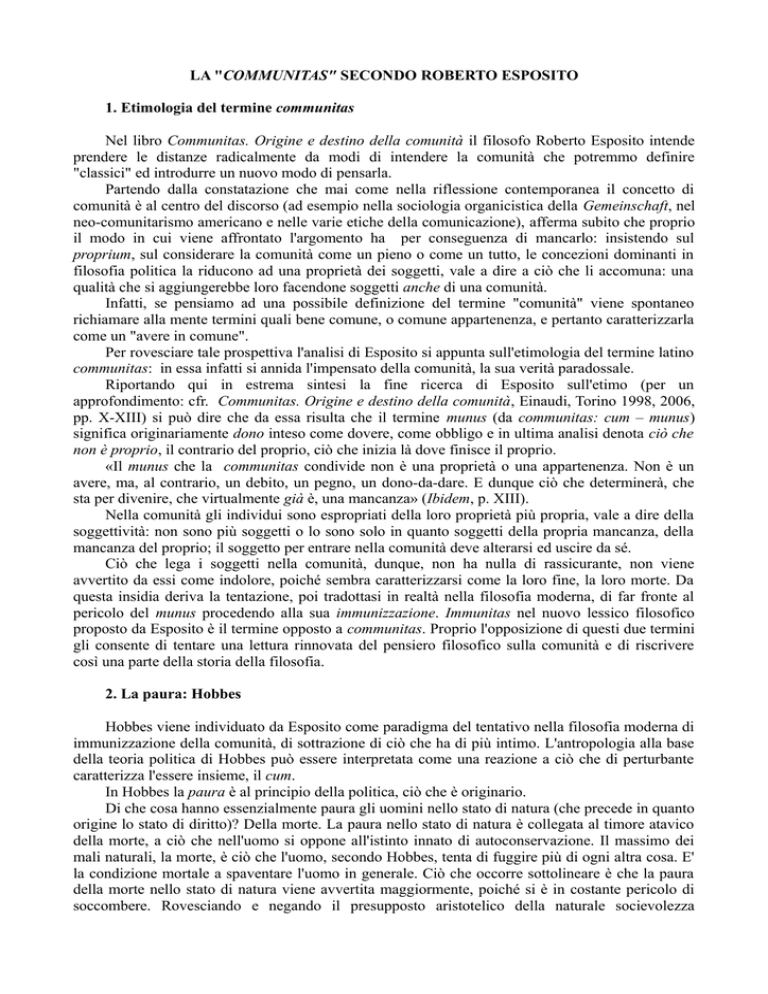
LA "COMMUNITAS" SECONDO ROBERTO ESPOSITO
1. Etimologia del termine communitas
Nel libro Communitas. Origine e destino della comunità il filosofo Roberto Esposito intende
prendere le distanze radicalmente da modi di intendere la comunità che potremmo definire
"classici" ed introdurre un nuovo modo di pensarla.
Partendo dalla constatazione che mai come nella riflessione contemporanea il concetto di
comunità è al centro del discorso (ad esempio nella sociologia organicistica della Gemeinschaft, nel
neo-comunitarismo americano e nelle varie etiche della comunicazione), afferma subito che proprio
il modo in cui viene affrontato l'argomento ha per conseguenza di mancarlo: insistendo sul
proprium, sul considerare la comunità come un pieno o come un tutto, le concezioni dominanti in
filosofia politica la riducono ad una proprietà dei soggetti, vale a dire a ciò che li accomuna: una
qualità che si aggiungerebbe loro facendone soggetti anche di una comunità.
Infatti, se pensiamo ad una possibile definizione del termine "comunità" viene spontaneo
richiamare alla mente termini quali bene comune, o comune appartenenza, e pertanto caratterizzarla
come un "avere in comune".
Per rovesciare tale prospettiva l'analisi di Esposito si appunta sull'etimologia del termine latino
communitas: in essa infatti si annida l'impensato della comunità, la sua verità paradossale.
Riportando qui in estrema sintesi la fine ricerca di Esposito sull'etimo (per un
approfondimento: cfr. Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino 1998, 2006,
pp. X-XIII) si può dire che da essa risulta che il termine munus (da communitas: cum – munus)
significa originariamente dono inteso come dovere, come obbligo e in ultima analisi denota ciò che
non è proprio, il contrario del proprio, ciò che inizia là dove finisce il proprio.
«Il munus che la communitas condivide non è una proprietà o una appartenenza. Non è un
avere, ma, al contrario, un debito, un pegno, un dono-da-dare. E dunque ciò che determinerà, che
sta per divenire, che virtualmente già è, una mancanza» (Ibidem, p. XIII).
Nella comunità gli individui sono espropriati della loro proprietà più propria, vale a dire della
soggettività: non sono più soggetti o lo sono solo in quanto soggetti della propria mancanza, della
mancanza del proprio; il soggetto per entrare nella comunità deve alterarsi ed uscire da sé.
Ciò che lega i soggetti nella comunità, dunque, non ha nulla di rassicurante, non viene
avvertito da essi come indolore, poiché sembra caratterizzarsi come la loro fine, la loro morte. Da
questa insidia deriva la tentazione, poi tradottasi in realtà nella filosofia moderna, di far fronte al
pericolo del munus procedendo alla sua immunizzazione. Immunitas nel nuovo lessico filosofico
proposto da Esposito è il termine opposto a communitas. Proprio l'opposizione di questi due termini
gli consente di tentare una lettura rinnovata del pensiero filosofico sulla comunità e di riscrivere
così una parte della storia della filosofia.
2. La paura: Hobbes
Hobbes viene individuato da Esposito come paradigma del tentativo nella filosofia moderna di
immunizzazione della comunità, di sottrazione di ciò che ha di più intimo. L'antropologia alla base
della teoria politica di Hobbes può essere interpretata come una reazione a ciò che di perturbante
caratterizza l'essere insieme, il cum.
In Hobbes la paura è al principio della politica, ciò che è originario.
Di che cosa hanno essenzialmente paura gli uomini nello stato di natura (che precede in quanto
origine lo stato di diritto)? Della morte. La paura nello stato di natura è collegata al timore atavico
della morte, a ciò che nell'uomo si oppone all'istinto innato di autoconservazione. Il massimo dei
mali naturali, la morte, è ciò che l'uomo, secondo Hobbes, tenta di fuggire più di ogni altra cosa. E'
la condizione mortale a spaventare l'uomo in generale. Ciò che occorre sottolineare è che la paura
della morte nello stato di natura viene avvertita maggiormente, poiché si è in costante pericolo di
soccombere. Rovesciando e negando il presupposto aristotelico della naturale socievolezza
dell'uomo, Hobbes per spiegare tale pericolo teorizza uno stato di natura con individui caratterizzati
dalla volontà di nuocere all'altro (oltre che dal già menzionato istinto di autoconservazione); ciò si
traduce in ultima istanza in uno stato di guerra tra tutti, erga omnes. Infatti, alla volontà di nuocere
all'altro e conservare sé non è correlata altrettanta differenza di forza che possa permettere all'uno di
prevalere sull'altro.
Nello stato di natura gli uomini sono uguali tra di loro e tale uguaglianza si concretizza nella
medesima capacità di uccidere e nella possibilità di essere uccisi. Da qui si genera dunque una
situazione insostenibile di continua paura e guerra, nella quale il rapporto tra individui non può che
essere distruttivo.
Per Esposito è di particolare interesse la soluzione adottata da Hobbes per uscire da questo
stato: nel passaggio dallo stato di natura allo stato di diritto viene significativamente eliminato ogni
legame sociale. Se la relazione comunitaria lasciata a sé è causa di delitto e guerra, allora è
necessario unire gli uomini mediante un patto, un contratto, che li renda immuni dal contatto gli uni
con gli altri, è necessario unire mediante la "dissociazione", eliminare del tutto il cum, il legame che
tiene uniti gli individui.
«Gli uomini vanno adesso associati nella modalità della reciproca dissociazione, unificati nella
eliminazione di ogni interesse che non sia quello puramente individuale. Artificialmente accomunati
nella sottrazione della comunità» (Ibidem, p. 12).
Esposito sottolinea, inoltre, come le caratteristiche dispotiche dello Stato tratteggiato da
Hobbes siano una conseguenza delle sue premesse e come pertanto siano causate da quella che
Esposito denomina, con felice espressione, l'arcaicità del moderno: l'origine, che si pensava
rimossa per sempre, sopravvive nel tempo del suo congedo. La violenza originaria caratterizzante lo
stato di natura permane nella violenza dello stato assoluto, nel Leviatano. Infatti, di fronte al patto
di dissociazione tra individui, che determina la loro unione mediante la sottrazione della comunità,
sorgono inevitabili obiezioni: «Come derivare un potere positivo dalla somma di tante negazioni? E'
pensabile che da un insieme di passività scaturisca un potere positivo? E poi – da parte dei sudditi –
perché mai dovrebbero rinunciare a ciò che già hanno a favore di un'entità ad essi esterna?»
(Ibidem, p. 15).
Hobbes per ovviare a tali difficoltà adotta la soluzione della teoria della autorizzazione. Per
questa teoria non solo gli individui con il patto depongono un diritto, ma autorizzano una persona
rappresentativa (i.e. il sovrano) ad agire al loro posto, conservando così il ruolo di soggetti per
ciascuna delle sue azioni. Ciò, tuttavia, ha per conseguenza l'effetto di sciogliere il sovrano da ogni
controllo, poiché rimane l'unico soggetto a conservare il diritto naturale in un contesto in cui tutti lo
hanno deposto. La teoria dell'autorizzazione, che aveva come scopo quello di ridurre la
trascendenza del potere del sovrano sui contraenti il patto, ha come effetto paradossale quello di
accentuarla al massimo grado.
«Essere identici al sovrano significa consegnargli interamente la propria soggettività (...). Da
questo punto di vista, allora, non è – come si sarebbe portati a supporre – la distanza, la
trascendenza, ma l'identità del sovrano rispetto ai sudditi a mettere in moto quel dispositivo
sacrificale che l'autorizzazione avrebbe dovuto bloccare e che invece finisce per potenziare al
massimo livello» (Ibidem, pp. 16-17).
3. La colpa: Rousseau
Rousseau si pone come l'avversario filosofico di Hobbes, come l'anti-Hobbes, per quanto
concerne il pensiero sulla comunità.
La critica principale che rivolge al filosofo inglese è di aver confuso lo stato di natura con lo
stato civile, di averlo descritto con tratti storici derivati dalla società del tempo. Per Rousseau,
invece, lo stato di natura è una dimensione che sfugge affatto alla storia, un cominciamento
astorico. Ecco perché secondo il suo punto di vista non è né una situazione conflittuale né pacifica,
bensì un puro negativo, la mancanza di ogni rapporto tra gli uomini, un'origine logica.
«L'origine – paradossalmente – è nominabile solo dal punto di vista della storia che la nega;
così come la natura dal lato della sua necessaria denaturazione. (...) L'innocenza non è tematizzabile
che a partire dall'angolo di visuale aperto dalla sua perdita: dalla colpa che la perverte e la deforma»
(Ibidem, p. 34).
Rousseau, tuttavia, non rimane fedele alla logica interna al suo discorso, secondo Esposito,
poiché tenta una definizione positiva dell'origine e ciò non può che portare all'aporia di cercare la
comunità positiva in uno stato alternativo alla società di fatto, con individui isolati tra di loro.
Il suo discorso dunque slitta verso una contrapposizione tra un prima (lo stato di natura) ed un
dopo (lo stato di diritto) legati dalla caduta, dalla degenerazione. La storia, la società, la tecnica, il
tempo e la morte, troverebbero la loro spiegazione nella caduta a partire da quello stato puro ed
innocente che verrebbe prima.
Se, da un lato, Rousseau parte da una critica giusta ad Hobbes, sottolineando come nella sua
concezione sia assente l'idea di comunità e come gli individui siano uniti solo dalla comune
schiavitù, dall'altro, giunge ad una caratterizzazione dello stato di natura modellata proprio sul
medesimo paradigma, quello di un individuo chiuso nella sua perfetta compiutezza.
«Egli spezza il nesso consequenziale tra individualismo e assolutismo stabilito da Hobbes: ma
lo fa attraverso una ridefinizione dello stato naturale connotata in chiave ancora più assolutamente
individualistica» (Ibidem, p. 40).
Se per Hobbes come per Rousseau la felicità dell'uomo consiste nella identificazione con sé,
con la propria più intima essenza, allora la comunità intesa come relazione non è più possibile.
Come può infatti questa unità originaria rapportarsi con l'altro da sé?
Così si spiega la deriva totalitaria del modello di Rousseau: mediante la compenetrazione
reciproca del modello comunitario e di quello individuale, mediante il tentativo di disegnare la
comunità sul profilo dell'individuo isolato ed autosufficiente.
Il racconto di Rousseau sulla comunità si traduce in un mito che può essere inteso attraverso il
passaggio dall'uno individuale all'uno collettivo.
«Nel mito, precisamente, di una comunità trasparente a se stessa in cui ciascuno comunica
all'altro la propria essenza comunitaria. Il proprio sogno di autoimmanenza. Senza nessuna
mediazione, filtro, segno che interrompa la fusione reciproca delle coscienze; senza nessuna
distanza, discontinuità, differenza nei confronti di un altro che non è più tale perché fa parte
integrante dell'uno; che è, anzi, già l'uno che si perde – e si ritrova – nella propria alterità» (Ibidem,
p. 43).
4. La legge: Kant
Kant vuole superare le contraddizioni in cui cade Rousseau; desidera evitare ogni deriva mitica
della comunità immettendo una differenza all'interno della sfera della volontà; la volontà in Kant, a
differenza che in Rousseau, non è più assoluta, ha al suo interno uno scarto, che è introdotto dalla
legge.
Le legge è ciò che per Kant viene prima rispetto alla volontà e fonda la comunità. Per Kant lo
stato originario di natura è caratterizzato dalla possibilità del male, altrimenti la legge non sarebbe
necessaria. A differenza del filosofo francese che parla di una caduta da una condizione di
innocenza allo stato di colpa e che tratteggia perciò lo stato di natura come privo del male, per Kant
la libertà originaria contiene già in sé il germe contrario rispetto alla legge, il male.
E' interessante a questo punto vedere come Kant riesca a conciliare la libertà con il male: non
vi è infatti alcuna predeterminazione nella precedenza del male rispetto alla libertà.
Infatti, «se siamo necessariamente portati al male, che ne è, della libertà stessa? In che senso
possiamo continuare a chiamarci liberi? Come si concilia questa libertà con la naturalità del male?»
(Ibidem, p. 60).
Kant distingue tra una origine razionale ed una naturale; il male per Kant non è riducibile ad
un impulso naturale, ma è una massima che il libero arbitrio dà a sé.
«Tale duplicazione differenziale serve a Kant per rendere compatibile il principio della
naturalità del male con quello dell'assoluta libertà. Essi sono compossibili perché sono cooriginari.
E' vero che il male, essendo innato, sta prima dell'atto che lo pone in essere. Però tale preesistenza
va interpretata secondo un criterio razionale ma non anche temporale. Per non entrare in
contraddizione col principio di libertà – con la libertà in quanto origine – è necessario pensare anche
il principio del male, anziché come un impulso naturale determinante, come una massima, in
questo caso cattiva, che il libero arbitrio dà a se stesso» (Ivi).
Esposito mostra come, tuttavia, il discorso di Kant, a mano mano che procede, moltiplichi le
antinomie interne.
«Il male è ciò nonostante imputabile alla nostra libera scelta. E' liberamente innato e
necessariamente libero. Nessuno dei due punti di vista può essere sacrificato all'esclusività
dell'altro» (Ibidem, p. 61).
Mentre nella Fondazione della metafisica dei costumi Kant intende ancora dedurre in modo
trascendentale il principio morale dalla libertà della volontà, nella Critica della ragione pratica
rovescia il procedimento posponendo la libera volontà al "fatto" della legge. La legge morale nella
Critica è un Faktum teoreticamente indeducibile, che precedere il bene, il male e la libertà. Tuttavia,
la legge non impone alla libertà i suoi comandi. Si profila perciò un circolo vizioso tra legge e
libertà, che può essere, se non spezzato, quanto meno inteso considerando la circostanza per cui
l'uomo appartiene a due ordini, due piani: quello intellegibile dei fini e quello sensibile delle cause
efficienti. Mentre sul piano intellegibile c'è coincidenza tra libertà e legge in base al comune
principio di ragione, sul piano sensibile divergono tra di loro, il concetto di libertà entra in
contraddizione con quello di legge.
Questo discorso riportato sul piano della comunità conduce Kant alla distinzione tra la
comunità etica, che va intesa come idea della ragione, e la realtà concreta della comunità politica.
La comunità etica appare come qualcosa di meramente possibile, la cui realizzazione sembra remota
tanto che in ogni caso non potrà mai coincidere con la comunità esistente.
«La frase etica non può essere collegata a quella politica che dal fragile ponte del come se. Ma
sotto il ponte passa un abisso invalicabile. Il rapporto resta puramente analogico: può esprimersi
attraverso segni, simboli, emblemi – come l'entusiasmo per la rivoluzione – ma non per prove ed
esempi storici. Che, anzi, regolarmente, lo sconfermano» (Ibidem, p. 65).
L'abisso che separa la comunità etica da quella politica è incolmabile tanto che a prima vista
sembra essere impossibile realizzare davvero la comunità.
Esposito, tuttavia, pensa che in Kant sia presente una via alla comunità: il pensiero
comunitario del filosofo di Königsberg va ricercato là dove il soggetto sfugge a sé, là dove si
verifica una desoggettivazione dell'Io. Questo accade proprio per il carattere non soggettivo della
legge, per lo scarto aperto tra la forma della legge ed il contenuto del soggetto. Di fronte al fatto
della legge, al suo dovere, il soggetto appare passivo; la legge non prescrive alcun contenuto, ma
solo l'obbligo formale di obbedirle: non dice cosa il soggetto deve fare, ma semplicemente gli
impone di agire in modo da poter costituire la sua volontà a principio di legislazione universale. La
legge sembra corrodere il soggetto, venire da fuori e portarlo fuori, diventando sostanzialmente
inadempibile. La finitezza del soggetto sancisce l'impossibilità della comunità prescritta dalla legge
kantiana.
«Quella finitezza – si è detto – esprime l'impossibilità della comunità: è proprio riguardo alla
sua realizzazione che risultiamo irrimediabilmente finiti. Ma essa, insieme, è anche ciò che apre la
possibilità di pensarla per la prima volta (...) Non bisogna evitare la contraddizione – e neanche il
paradosso che ne deriva – perché è essa a costituire lo strappo decisivo che Kant segna rispetto a
tutta la tradizione filosofica precedente (...) che la comunità sia impossibile vuol dire che
quell'impossibile è la comunità» (Ibidem, p. 71).
5. L'estasi: Heidegger
Secondo Esposito, Heidegger è l'unico che ha saputo riprendere il discorso di Kant sulla
comunità. Kant era giunto di fronte all'abisso della soggettività che si apre alla sua costitutiva
alterità, al punto di rottura del soggetto metafisico ed era dovuto indietreggiare.
Questo punto di rottura è il tempo, la sua struttura temporale che sottrae il soggetto all'indentità
sospendendolo alla contingenza o alla finitezza.
«Questo è ciò che Heidegger intende (...) per "esistenza" o "estasi" del, anzi come, Dasein:
intanto il fatto che a trascendere è il soggetto, e non le cose rispetto ad esso; e poi, soprattutto, che si
tratta di una trascendenza non contrapposta, ma interna e coincidente con l'immanenza. Il suo
eccesso. Ovvero non un semplice fuoriuscire da sé, ma uno 'stare in sé' nella forma eccentrica del
suo 'fuori'» (Ibidem, p. 84).
A differenza di Kant, dunque, in cui la legge viene per prima, in Heidegger la legge deve
essere a sua volta preceduta da un altro, da un'altra legge che è precisamente un fuori-la-legge nella
misura in cui la pone in essere. Lo spazio che si apre prima della legge è l'ontologia. L'alterità,
infatti, non può essere né trascendente, né trascendentale.
Ciò che sfugge a Kant perciò è che l'essere della comunità, il suo cum, è l'essere costitutivo
dell'Esserci in quanto essere-nel-mondo. La comunità non è una potenzialità a venire o una legge
anteposta al nostro esserci, ma quell'Esserci nella sua costituzione «singolarmente plurale» (Ibidem,
p. 90).
Vale la pena riportare un passo chiarificatore del libro di Esposito che rivela qual è la grande
intuizione di Heidegger a proposito della comunità:
« [La comunità] Non appartiene né al nostro passato, né al nostro futuro – ma a ciò che adesso
siamo. La nostra estasi. Noi in quanto estatici. Da questo punto di vista qualsiasi sforzo di
raggiungere un fine non è meno inutile di quello di riappropriarsi di un'origine a un certo momento
perduta. La comunità non sta né prima né dopo la società» (Ivi).
Bisogna sottolineare, tuttavia, che il senso della comunità così intesa è e rimane
l'incompiutezza. Gli individui non sono uniti da un pieno, ma da una mancanza, da un vuoto, che già
sono. Lo scopo ultimo della comunità, ammesso che si possa parlare di "scopo", è quello di avere
piena consapevolezza dell'improprietà che accomuna i suoi membri. L'essere autentico, infatti, non
consiste nel disfarsi dell'inautentico, ma nel prendersene cura.
A questo punto è evidente che in Heidegger la comunità è qualche cosa di impolitico e non una
comunità storica, di fatto, nel senso che «possiamo corrispondere al nostro essere in comune solo
nella misura in cui lo tratteniamo al di qua di ogni pretesa di effettuazione storico-empirica»
(Ibidem, p. 96).
Questa precisazione è importante perché permette a Esposito di mostrare in che misura lo
stesso Heidegger fraintenda sé stesso ed il proprio pensiero negli anni Trenta, aderendo al nazismo.
Ciò che è interessante per lui comprendere è come sia potuto avvenire tale auto-fraintendimento da
un punto di vista concettuale.
In primo luogo, ciò si spiega perché il tema della comunità, grazie al concetto essenziale di
Mit-sein, essere-con (per cui il Dasein è già sempre Mit-sein), è introdotto in modo tardivo da parte
del filosofo tedesco (nel venticinquesimo paragrafo di Essere e Tempo) dopo che aveva già trattato
il Dasein nella sua autonomia.
In secondo luogo, Heidegger non rimane fedele alla sua concezione di "proprio" e
"improprio", per la quale «improprio (...) non è altro dal proprio, ma il Dasein stesso conosciuto
nella sua più impropria proprietà» (Ibidem, p. 98), ma separando e contrapponendo proprio e
improprio, va alla ricerca di un recupero dell'origine ricandendo nella dialettica di presupposizione
e destinazione. Ecco allora che egli ricade nel tradizionale mitologema politico-filosofico: vuole
parlare affermativamente della origine e ciò comporta la necessità di dare alla comunità originaria
un destino che si concretizza nel futuro di una comunità specifica, con una terra e con una storia.
6. L'esperienza: Bataille
Nonostante l'abisso lessicale, stilistico e categoriale che divide Bataille da Heidegger, il loro
pensiero non è estraneo, infatti parte da un interesse comune; c'è una prossimità tra i due pensatori
per cui Bataille, secondo Esposito, espliciterebbe il non-detto nel pensiero sulla comunità di
Heidegger.
Il loro minimo comun denominatore è il concetto di fine della filosofia. Tuttavia, mentre in
Heidegger questa fine è un compimento che comporta un nuovo inizio, un nuovo orizzonte e
dunque anche un rinnovato compito per il pensiero, in Bataille non c'è nulla di tutto ciò. Bataille
spezza la dialettica di origine e compimento.
Bataille si ispira a Nietzsche e rovescia l'interpretazione e il giudizio che Heidegger dà della
filosofia di Nietzsche: per Bataille non è Nietzsche a rimanere all'interno della tradizione filosofica
occidentale a cui metterebbe fine, bensì lo stesso Heidegger nella misura in cui pensa la fine come
compimento che apre lo spazio a nuove possibilità di sapere.
Per Bataille la fine della filosofia non rappresenta affatto il suo compimento, ma il non-sapere,
la definitiva incompiutezza (inachèvement). Il non-sapere non è da intendersi come limite o nonconosciuto (ignoto) rispetto al sapere, poiché in tal caso sarebbe ancora una alterità esterna rispetto
al limite del sapere, ancora potenzialmente conoscibile; il non-sapere è l'assoluto inconoscibile. Il
non-sapere, infatti, non è separato dal sapere (altrimenti entrerebbe in gioco ancora la dialettica), ma
coincide con esso, con il suo culmine.
Esiste a questo punto la possibilità di parlare del non-sapere in maniera affermativa? Nella
filosofia di Bataille questa possibilità è espressa dal concetto di esperienza interiore.
L'esperienza interiore è il punto in cui la vita si ritrae, spinge la vita sul suo "fuori", una specie
di esperienza della non-esperienza; essa è, infatti, un viaggio senza meta e senza ritorno che mette il
soggetto fuori di sé, è una destituzione della soggettività e come tale impossibile.
L'epicentro di questa dissoluzione del soggetto, del non-sapere, è la comunità nella quale il
soggetto fa dono (munus) di sé.
«Il non sapere consiste nel tenere aperta l'apertura che già siamo. A non occultare, ma ad
esibire, la ferita nella e della nostra esistenza (...). Abbiamo visto come l'esperienza, per Bataille,
coincida con la comunità in quanto impresentabilità del soggetto a se stesso. Il soggetto non può
presentarsi. Si manca» (Ibidem, p. 123).
Per Esposito, Bataille rappresenta il più radicale anti-Hobbes.
«Se Hobbes è stato fin dall'inizio indicato come il più conseguente sostenitore di una
immunizzazione volta a garantire la sopravvivenza individuale; se a questo fine – in nome della
paura della morte – egli non ha esitato a teorizzare la distruzione non solo di ogni comunità
esistente non coincidente con lo Stato, ma dell'idea stessa di comunità umana; ebbene Bataille ne
costituisce il più drammatico oppositore: contro l'ossessione di una conservatio vitae spinta al punto
di sacrificare ogni altro bene al proprio conseguimento, egli riconosce il culmine della vita in un
eccesso che la conduce continuamente a ridosso della linea della morte» (Ibidem, pp. 128-129).
Bataille consente a Esposito di giungere a conclusione del suo discorso ricostruttivo, poiché
rappresenta la massima espressione della verità paradossale della comunità, il culmine e l'antitesi
rispetto al punto dal quale si era partiti, e gli permette di effettuare una breve ricapitolazione della
sua interpretazione della storia della filosofia fondata sulla originale opposizione tra communitas ed
immunitas.
Daniele Baron
http://filosofiaenuovisentieri.it/2013/05/29/la-communitas-secondo-roberto-esposito
© Filosofia e nuovi sentieri 2013. Tutti i diritti riservati