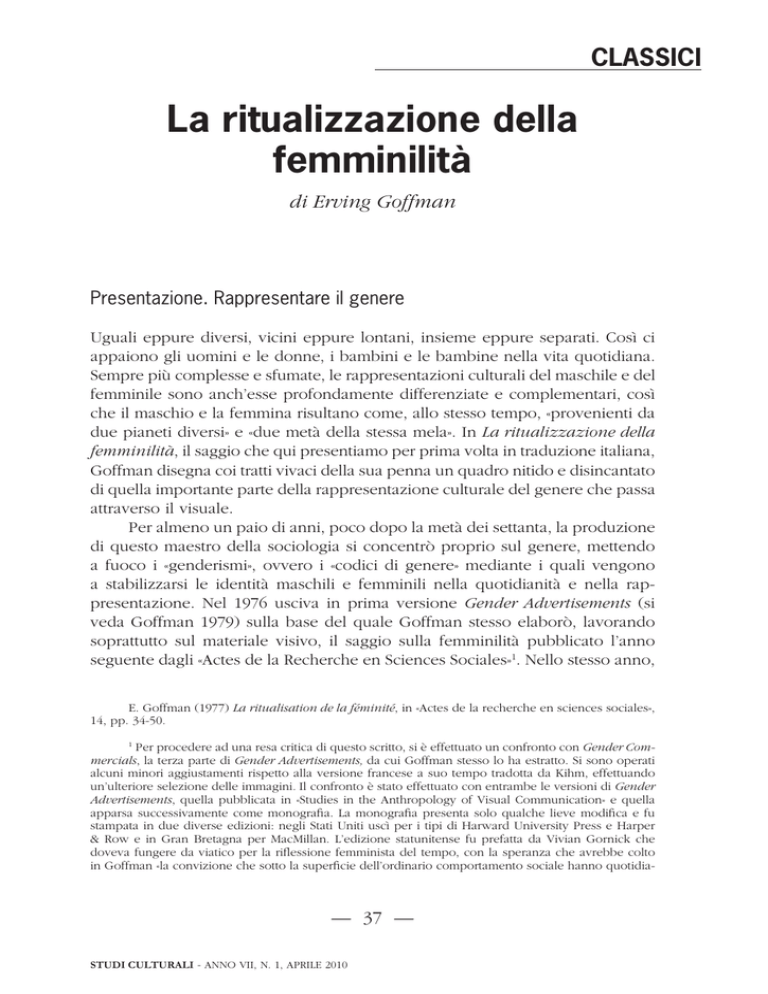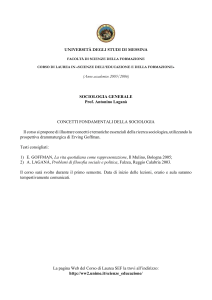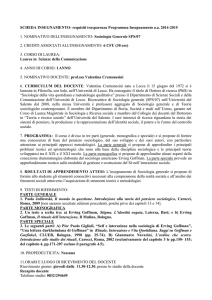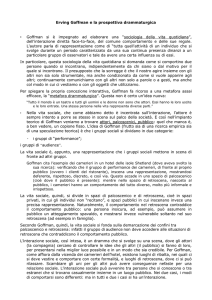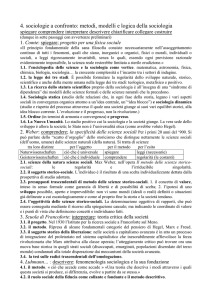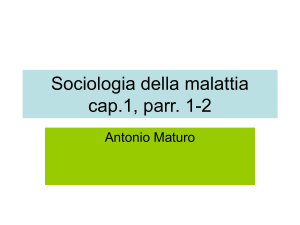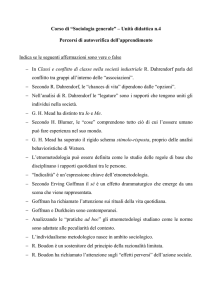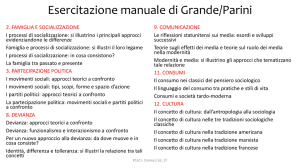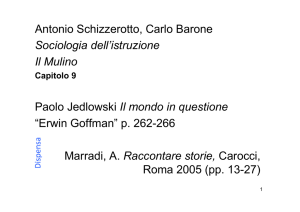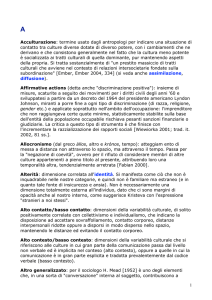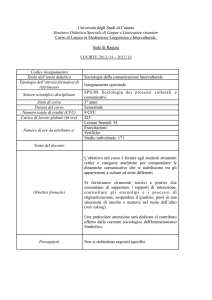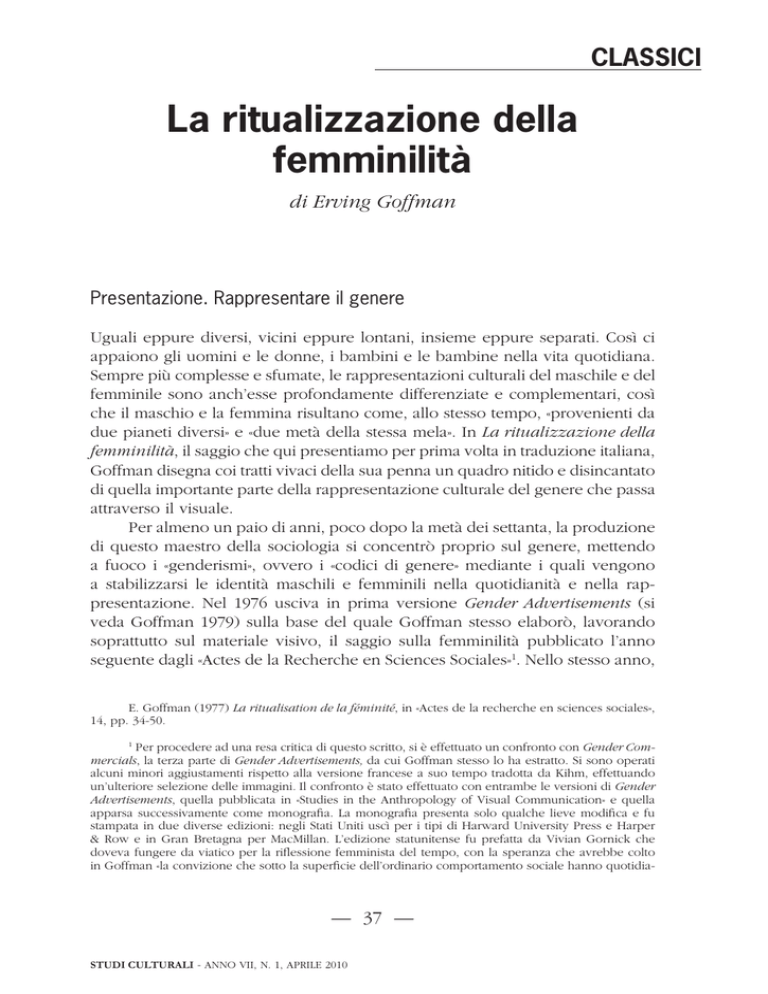
classici
La ritualizzazione della
femminilità
di Erving Goffman
Presentazione. Rappresentare il genere
Uguali eppure diversi, vicini eppure lontani, insieme eppure separati. Così ci
appaiono gli uomini e le donne, i bambini e le bambine nella vita quotidiana.
Sempre più complesse e sfumate, le rappresentazioni culturali del maschile e del
femminile sono anch’esse profondamente differenziate e complementari, così
che il maschio e la femmina risultano come, allo stesso tempo, «provenienti da
due pianeti diversi» e «due metà della stessa mela». In La ritualizzazione della
femminilità, il saggio che qui presentiamo per prima volta in traduzione italiana,
Goffman disegna coi tratti vivaci della sua penna un quadro nitido e disincantato
di quella importante parte della rappresentazione culturale del genere che passa
attraverso il visuale.
Per almeno un paio di anni, poco dopo la metà dei settanta, la produzione
di questo maestro della sociologia si concentrò proprio sul genere, mettendo
a fuoco i «genderismi», ovvero i «codici di genere» mediante i quali vengono
a stabilizzarsi le identità maschili e femminili nella quotidianità e nella rappresentazione. Nel 1976 usciva in prima versione Gender Advertisements (si
veda Goffman 1979) sulla base del quale Goffman stesso elaborò, lavorando
soprattutto sul materiale visivo, il saggio sulla femminilità pubblicato l’anno
seguente dagli «Actes de la Recherche en Sciences Sociales»1. Nello stesso anno,
E. Goffman (1977) La ritualisation de la féminité, in «Actes de la recherche en sciences sociales»,
14, pp. 34-50.
1
Per procedere ad una resa critica di questo scritto, si è effettuato un confronto con Gender Commercials, la terza parte di Gender Advertisements, da cui Goffman stesso lo ha estratto. Si sono operati
alcuni minori aggiustamenti rispetto alla versione francese a suo tempo tradotta da Kihm, effettuando
un’ulteriore selezione delle immagini. Il confronto è stato effettuato con entrambe le versioni di Gender
Advertisements, quella pubblicata in «Studies in the Anthropology of Visual Communication» e quella
apparsa successivamente come monografia. La monografia presenta solo qualche lieve modifica e fu
stampata in due diverse edizioni: negli Stati Uniti uscì per i tipi di Harward University Press e Harper
& Row e in Gran Bretagna per MacMillan. L’edizione statunitense fu prefatta da Vivian Gornick che
doveva fungere da viatico per la riflessione femminista del tempo, con la speranza che avrebbe colto
in Goffman «la convizione che sotto la superficie dell’ordinario comportamento sociale hanno quotidia-
— 37 —
STUDI CULTURALI - ANNO VII, N. 1, APRILE 2010
erving goffman
sulla rivista americana «Theory and Society» usciva The Arrangement between
the Sexes, probabilmente la più completa riflessione goffmaniana sul genere
(Goffman 1977). In questi lavori Goffman ci dice che le differenze di genere
vengono costruite quotidianamente, mediante la struttura del mercato del lavoro,
la divaricazione negli orientamenti scolastici, la divisione dei compiti all’interno
della famiglia, ma anche – ed è soprattutto questo il cuore del suo interesse –
attraverso una continua e permeante ritualizzazione cerimoniale che le rende
allo stesso tempo scontate e immediatamente riconoscibili. L’analisi del sessismo
non può fermarsi alla discriminazione contro le donne perché gli «stereotipi di
genere si articolano in ogni direzione», così le gentilezze rivolte dagli uomini
alle donne, l’attenzione nei loro confronti può facilmente vestirsi di paternalismo
(Goffman 1979, 8). Le maniere di rivolgersi all’altro in quando soggetto codificato in base al genere, i modi di gestire il proprio corpo come corpo sessuato,
il gioco degli sguardi e delle posizioni nelle diverse scene della quotidianità,
e ancora il gioco della seduzione tra i sessi, sono altrettante forme ritualizzate
che rinsaldano le differenze di genere, fissandone culturalmente la naturalità.
Goffman è incuriosito dai modi in cui queste differenze cerimoniali vengono
messe in scena, ed anzi, distillate dai media. Con la sua analisi delle fotografie
pubblicitarie Goffman ci invita a leggere i messaggi mediatici con la consapevolezza che «essi sfruttano lo stesso corpus di rappresentazioni, lo stesso idioma
rituale che usiamo tutti noi mentre partecipiamo alle situazioni sociali, e con lo
stesso scopo: rendere leggibile un’azione intravista» (ivi, 84), e nella fattispecie
rendere visibili le differenze di genere. Le differenze di genere vengono però
rappresentate nelle pubblicità in un modo particolare, come un concentrato di
atteggiamenti e fogge, seguendo spesso forme iperboliche ed estremizzate: si
tratta, così la definisce Goffman nelle pagine che seguono, di una «iper-ritualizzazione». L’iper-ritualizzazione risulta fondata su un’esagerazione scoperta, a
volte ironica e a volte terribilmente seria, delle forme cerimoniali della differenza che tutti riconosciamo in quanto parte della nostra esperienza quotidiana.
Goffman ritaglia per sé una posizione eccentrica, o se preferiamo originale,
rispetto alla sociologia dei media del tempo, agli studi visuali e alla riflessione sul
genere. Le forme mediatiche iper-ritualizzate sono forse un riflesso idealizzato
che magnifica le differenze della realtà sociale, ma non uno «specchio distorto»
come voleva Polley (1986). Goffman si rifiuta così di concepire il nesso tra
rappresentazione mediatica e realtà sociale in termini prettamente ideologici,
namente luogo innumerevoli assassini della mente e dello spirito (Gornick 1979, ix); mentre l’edizione
inglese fu prefatta da uno degli autori di riferimento degli studi culturali britannici, Richard Hoggart,
che definì il libro «brillante e suggestivo» (Hoggart 1979, viii). Le prefazioni riflettono sia l’importanza di
Goffman negli anni settanta sia il carattere controverso delle incursioni di un affermato sociologo nel
dominio degli studi di genere. Gender Advertisements fu un successo editoriale: ebbe tra l’altro almeno
tredici recensioni tra il 1979 e il 1982, quasi quanto Frame Analysis, e fu recensito in luoghi prestigiosi,
dal «New York Time Book Review» alle principali riviste accademiche generalistiche.
— 38 —
La ritualizzazione della femminilità
lasciando piuttosto inesplorata la questione degli effetti che gli stereotipi di
genere nei media hanno sulla vita ordinaria. Il lavoro di Goffman sulle rappresentazioni del genere occupa uno spazio particolare anche negli studi visuali,
tanto che quello che è a oggi il testo introduttivo più importante in questo
campo interdisciplinare non riesce a collocarlo nella sua classificazione (si veda
Rose 2007). Goffman infatti non effettua né un’analisi del contenuto tradizionale
(quanto meno perché le sue categorie non sono mutuamente esclusive), né
un’analisi prettamente formale o semiotica. E certo non si ispira a forti paradigmi
critici come la psicoanalisi. E tuttavia, come sottolineò Sol Worth (1976, 65), al
materiale iconografico è data importanza centrale per analizzare il cerimoniale
sociale, sviluppando un approccio che affonda le proprie radici nella tradizione
antropologica, e in particolare nel lavoro di Bateson e Mead (1942) ben noto
a Goffman. Infine, a differenza di molti lavori sul genere a lui contemporanei,
Goffman sottolinea che la ritualizzazione delle differenze di genere avviene
in modo incidentale, e cioè mentre i soggetti fanno altro. La sottolineatura del
carattere incidentale del genere oppone la visione di Goffman soprattutto a
quella parte del pensiero femminista, spesso di derivazione marxista, che non
rinuncia a una qualche forma di teoria della cospirazione, ma non implica, come
vedremo, la mancanza di attenzione per meccanismi di potere.
1. Per quanto possano apparire eccentrici rispetto allo sviluppo della riflessione
femminista sul genere, i saggi di Goffman sono stati riscoperti proprio in una
chiave di teoria di genere (McGregor 1995; Smith 1996; West 1996; Winkin 1990;
Zaidman 2002). I saggi di Goffman sul genere del resto, considerati spesso e
ingiustamente come minori nella vasta produzione goffmaniana o persino colpevolmente anacronistici nella loro descrizione dei rapporti tra i sessi (Wedel
1978), hanno continuato a sollecitare nel corso degli anni attenzione e interesse
e offrono spunti teorici ricchi e attuali. In effetti, per la sua attenzione alla costruzione performativa delle differenze di genere come lavoro incidentale, portato a
termine dai soggetti nel loro tentativo esplicito di realizzare una molteplicità di
ruoli sociali, Goffman anticipa alcune delle osservazioni che, con un linguaggio
diverso, sono oggi proprie degli studi di genere post-strutturalisti siano essi di
matrice propriamente sociologica (ad esempio Barrie Thorne) o filosofica (ad
esempio Judith Butler). Peraltro, sebbene incidentale, e anzi forse proprio per
questo, l’espressione rituale del genere è carica di significati politici:
Si può dire che lo stile comportamentale delle donne «esprime» la femminilità nel senso di fornire un ritratto incidentale e gratuito. Ma Durkheim
ci ricorda che una simile espressione è una cerimonia politica, e in questo
caso afferma il posto che una persona ascritta alla classe sessuale femminile
ha nella struttura sociale, vincolandola in altre parole a questa posizione
(Goffman 1979, 8).
— 39 —
erving goffman
Se l’incidentalità dei genderismi è perfettamente compatibile con una visione
attenta ai rapporti di potere, l’interesse di Goffman per il genere non può dirsi
accidentale.
Anche se, come scrive Javier Trevino (2003, 10), «è difficile dire con precisione cosa accese l’interesse di Goffman per il genere», tale interesse non va
liquidato come opportunistico o estemporaneo, e neppure come meramente
episodico. È probabile che Goffman fu spinto a concentrarsi sul tema, come
sostiene Carol Brooks Gardner (cit. ivi, 10), sua brillante allieva, dal «generale
interesse per il genere allora di moda insieme a un numero innegabilmente vasto
di suoi studenti che erano donne, molte delle quali, me compresa, influenzate
dal pensiero femminista». Tuttavia, rileggendo l’intera opera goffmaniana saltano agli occhi numerosissimi riferimenti ai rapporti tra i sessi, alla galanteria
e alle maniere cortesi, alla gestione delle relazioni amorose eterosessuali, alla
femminilità e alla maschilità, e così via. A dispetto di un linguaggio poco «politicamente corretto» in cui il maschile viene utilizzato indifferentemente per
indicare in generale l’essere umano, molti dei suoi saggi si prestano dunque
a essere riletti in chiave di genere. Del resto, il maestro dell’analisi dell’interazione non poteva non tematizzare i rapporti tra uomini e donne visto che, per
sua stessa ammissione, i maschi e le femmine si differenziano, come vedremo,
essenzialmente mediante forme cerimoniali.
Se ripercorriamo la produzione goffmaniana a caccia di genere, riportiamo
un ricco bottino. E questo sin dai suoi primi lavori. Già in Presentation of the
Self in Everyday Life Goffman (1959) utilizza i codici di genere come esempio
per mostrare l’ambiguità della distinzione tra realtà e finzione nella costruzione
dell’identità personale. Egli suggerisce che ciò che noi consideriamo «autentico»
è in effetti una costruzione, o meglio, una «rappresentazione», frutto di cerimonie
elaborate, ma tipicamente non strumentali. Così, scrive Goffman (ivi, 86):
(Q)uando osserviamo una giovane americana del ceto medio che si fa passare per stupida con il suo corteggiatore, siamo pronti a trovare elementi
di astuzia ed artificio nel suo comportamento. Ma come lei e come il suo
amico, anche noi accettiamo come un dato di fatto che quest’attore è una
ragazza del ceto medio americano. Indubbiamente, però, nel far questo,
trascuriamo la parte più importante della rappresentazione.
E questa parte trascurata è, ovviamente, la rappresentazione dell’identità
sessuale. Sono i codici di genere a sostenere l’appartenenza a una particolare
categoria sessuale mentre specificano gli spazi delle strategie del corteggiamento.
L’essere donna può apparire come un dato essenziale e scontato, situato prima o
alla base di quelli che, di conseguenza, appaiono come artifici superficiali legati
alla seduzione. «È un luogo comune – prosegue Goffman (ivi, 86-7) – dire che
i diversi gruppi sociali esprimono diversamente attributi come l’età, il sesso, la
— 40 —
La ritualizzazione della femminilità
provenienza da una determinata regione e lo status di classe», ma ognuno di questi
attributi «non è qualcosa di materiale da possedere e poi mettere in mostra» quanto
«un modello di comportamento appropriato, coerente, abbellito e ben articolato.
Rappresentato con disinvoltura o con impaccio, consapevolmente o meno, con
astuzia o sincerità, è nondimeno qualcosa che deve essere inscenato e illustrato,
insomma che deve essere realizzato». La messa in scena di attributi «essenziali»
come il sesso o l’età è una cruciale forma di costruzione delle identità personali
che rimane così tanto sullo sfondo da eludere, nella maggior parte dei casi, ogni
messa in discussione, questo almeno finché gli attori si attengono alle norme che
prescrivono chi può legittimamente fare alcune cose in certi luoghi.
Del resto, i codici di genere non sono solo agiti dai soggetti, ma anche
subiti, e lasciano spazio a molte contraddizioni, perché si trovano, nella realtà
quotidiana, mescolati ad altri attributi identitari e a una infinità di ruoli. Nel celebre
saggio sui rituali che circondano il sé nelle società moderne, Goffman (1967) usa
proprio l’esempio del genere per mostrare l’intrecciarsi a volte contraddittorio di
prescrizioni sul contegno e la deferenza. Le norme di genere e le prescrizioni di
ruolo possono trovarsi a configgere lasciando margini di manovra ai soggetti ma
costringendoli anche a difficili scelte:
L’immagine di se stesso che l’individuo, per dovere verso gli altri, mantiene
con la sua condotta è una specie di giustificazione e di compensazione per
l’immagine che gli altri sono obbligati ad esprimere mediante la loro deferenza nei suoi confronti. Infatti ognuna delle due immagini può fungere da
garanzia e controllo sull’altra […]. Quando un uomo fa l’atto di alzarsi per
lasciare il posto ad una signora mostrando il proprio rispetto per il gentil
sesso, essa lo può interrompere mostrando di non voler approfittare dei
suoi privilegi di donna e di essere pronta a definire la situazione su un piano
di parità […]. Mediante questa differenziazione nella funzione simbolizzatrice, il mondo tende ad essere pervaso da una serie di immagini migliori
di quelle che ognuno di noi merita; infatti è comodo mostrare un grande
apprezzamento per gli altri, offrendo loro privilegi di deferenza, sapendo
che alcuni di questi privilegi verranno rifiutati, per poter dimostrare un
buon contegno.
Con ironia, forse quasi senza volerlo, Goffman mostra con questo esempio
quanto ambivalenti siano le gentilezze riservate alle donne, e quindi l’ambivalenza che esse devono gestire per poter al contempo dimostrare femminilità e
partecipare attivamente alla vita sociale. Qui Goffman anticipa quanto renderà
poi chiaro nei lavori espressamente dedicati al genere: anche negli ambienti di
lavoro, dove possono essere fatti valere principi universalistici, i soggetti possono sempre essere chiamati a rispondere in base alle proprie identità sessuali e,
malgrado numerose sovversioni localizzate, nel portare a termine il loro essere
sessuati gli uomini di preferenza portano anche a termine forme ritualistiche di
dominio e le donne, specularmente, di sottomissione. A differenza di altri grup-
— 41 —
erving goffman
pi sfavoriti queste ultime sono tenute in alta considerazione, ma si tratta di una
considerazione ambigua, che nega loro un pieno riconoscimento della propria
autonomia. Così, «ogni benevolenza che la società dimostra nei confronti delle
donne può essere vista come una benedizione a metà [mixed blessing]» che «sembra sempre avere la funzione di mascherare ciò che potrebbe essere ritenuto uno
svantaggio» (Goffman 1979, 9).
Le asimmetrie internazionali e comunicative correlate al genere sono evidenti nel caso delle licenze comunicative che è possibile prendersi nei confronti
dei soggetti ascritti al sesso femminile. Nel suo ultimo libro, Goffman (1981) si
concentra sulle forme del parlare e i modi in cui queste partecipano al gioco
dell’identità facendo numerosi riferimenti alle distinzioni tra uomini e donne.
Goffman, per esempio, apre la discussione sui mutamenti di footing, ovvero sui
cambiamenti «nella posizione che assumiamo nei nostri confronti e in quello degli
altri presenti espresso nel modo in cui affrontiamo la produzione e ricezione di
un enunciato» (ivi, 180), con un esempio legato al genere. Goffman ci riporta un
aneddoto della vita politica americana: il presidente Nixon, nella stanza ovale
insieme a numerosi funzionari governativi e giornalisti dopo la firma di un importante documento, «scherza» con un’affermata giornalista presente, portando
la discussione sul di lei aspetto, chiedendole addirittura di piroettare per arrivare
a farle un complimento. In questo scherzare del presidente c’è un cambiar di
piano – dalla serietà della politica alla micro-politica dei sessi – che fa slittare il
ruolo professionale della giornalista, inesorabilmente, verso un ruolo decorativo
ancorato alla sua identità di genere. Così scrive Goffman (ivi, 215 e 176):
Quando Helen Thomas ha piroettato per il presidente, stava parentesizzando
all’interno della sua posizione di giornalista un’altra posizione, quella di
una donna che riceve dei commenti sul proprio aspetto. […] Senza dubbio
le forze in gioco che questo incidente pone in rilievo sono il potere del
presidente di forzare una donna a passare da un ruolo professionale a un
ruolo sessuale, domestico in una occasione in cui essa […] potrebbe avere
il massimo interesse a che le sia riconosciuto ciò che le è professionalmente
dovuto e null’altro. […] Ma in questo fatto c’è qualcosa di più significativo:
la definizione sociale che le donne devono essere sempre pronte a ricevere
commenti sul loro «aspetto» purché siano favorevoli, vengano espressi da
persone conosciute e non possano essere interpretati sarcasticamente. Dal
punto di vista strutturale ciò implica che una donna deve essere sempre
pronta a cambiare la propria posizione, o piuttosto, al fatto che qualcuno
la cambi per lei, in virtù del suo essere soggetta a diventare momentaneamente un oggetto di valutazione, e non, o non solo, una partecipante ad
un incontro sociale.
Certamente, insiste Goffman, questo esempio ci dice qualcosa di generale
sulla comunicazione, le proprietà formali dei cambiamenti di footing e le situazioni
che li rendono possibili. Ci mostra cioè la struttura a incastro dei nostri modi di
parlare, il loro continuo rimescolare forme e contenuti presi da contesti diversi, e
— 42 —
La ritualizzazione della femminilità
la nostra «capacità di incassare la rapida rappresentazione di un ruolo nell’ambito
di una più estesa esecuzione di un altro» impiegando forme espressive prese da
situazioni sociali diverse, lontane, e ri-tradotte o re-incorniciate all’occorrenza
nella situazione in cui ci troviamo. Eppure, l’esempio ci dice anche qualcosa di
molto importante sul posto delle donne nel mondo. È significativo che Nixon,
per segnare la fine dell’evento serio e mostrarsi alla mano, si possa agevolmente
servire proprio di una donna, giocando con il di lei pubblico contegno. Così,
Goffman ci dice implicitamente, è più facile chiedere alle donne di rendere conto
della propria femminilità di quanto sia possibile fare con gli uomini. E questo in
ultima analisi tende a ridurre ogni loro attributo all’identità sessuale. L’esempio
proposto ci rimanda inoltre all’intreccio inestricabile tra maschilità e femminilità:
è apprezzando con fare scherzosamente censorio la femminilità della giornalista
che il presidente dimostra la propria maschilità.
2. Goffman arriva a tematizzare specificatamente i rapporti tra uomini e donne,
e lo fa in una duplice chiave: empirica, con gli studi sui codici visuali della femminilità e della maschilità, e teorica, a partire dall’idea che i rapporti tra i sessi si
articolino in base a «codici» attraverso i quali «si esprimono anche le concezioni
che gli stessi individui sviluppano della propria più profonda natura umana»
(Goffman 1977, 301). Nei suoi lavori sul genere il sociologo canadese concede
poco al pensiero femminista, e rimprovera piuttosto agli scienziati sociali di non
aver prestato attenzione al tema: «Ancor più che nel caso della nozione di classe
sociale, gli scienziati sociali si sono semplicemente comportati come tutti gli altri,
supportando ciecamente con il loro comportamento personale proprio quello che
almeno qualcuno di loro avrebbe dovuto studiare» (ibidem)2. I lavori sul genere
arrivano in una fase della produzione di Goffman che è marcatamente caratterizzata da una svolta cognitivista, segnata dalla sua opera monumentale Frame
Analysis (1974). I saggi sul genere segnalano uno spostamento dell’attenzione
dalle forme mediante le quali i soggetti partecipano alle diverse attività sociali ai
modi in cui i soggetti riescono a distinguere tra queste attività. Il genere, in effetti,
viene presentato come una sorta di frame, un insieme di codici – organizzativi,
cognitivi e affettivi – in base ai quali le istituzioni elaborano e magnificano differenze biologiche altrimenti insignificanti. La ritualizzazione della femminità
può essere letto come un’applicazione al linguaggio non verbale della nozione
2
Sempre attento al cerimoniale, qui Goffman avrebbe potuto anticipare le reazioni al genere
dell’autore, considerando che sollevare la questione dell’assenza del genere e delle donne in particolare
non basta a rendere queste ultime presenti, laddove è comunque un uomo che parla delle donne, e quindi
un dominante che parla dei dominati (si vedano Stacey e Thorne 1985; Zaidman 2002). E avrebbe potuto
farlo, dando forza alla legittimità della propria impresa, tenendo in giusta considerazione lo sviluppo e
l’influenza della riflessione femminista per le analisi del genere, femminismo che soprattutto allora voleva
e doveva parlare a partire dall’esperienza femminile non solo delle donne ma anche per loro.
— 43 —
erving goffman
di cornice, laddove le immagini che corredano i messaggi pubblicitari sono usate
per illustrare i «genderismi» che sostengono e danno forma alla femminilità.
Nei contesti interazionali, sostiene Goffman, gli individui presuppongono
che l’altro possieda una «natura essenziale». La mascolinità e la femminilità sono
prototipi di tale espressione essenziale – «qualcosa che può essere veicolato in
modo effimero in qualsiasi situazione sociale, eppure, allo stesso tempo, qualcosa
che mira alla caratterizzazione più elementare dell’individuo» (1979, 10). Goffman
(ivi, 1) chiarisce che una rappresentazione «fornisce prova del posizionamento
dell’attore all’interno della situazione, la posizione che egli sembra preparato ad
assumere in ciò che sta per accadere nella situazione sociale» e fornisce quindi
i «termini del contatto» che sembra disposto ad avere con gli altri presenti. Le
rappresentazioni del genere (gender displays) vengono tipicamente concepite
come forme di espressione di una realtà sottostante e pre-sociale («il sesso»).
Il genere può quindi apparire come una drammatizzazione di idealizzazioni
culturali della natura maschile e femminile, nella quale attori e pubblico si confondono e si dividono, condividendo la capacità di leggere un idioma rituale
la cui competenza performativa risulta smistata in modo ineguale tra soggetti
ascritti a classi sessuali diverse. Il genere si realizza attraverso una varietà di
«risorse culturali». Queste risorse non hanno molto a che fare con la «vera» natura
dei maschi e delle femmine: ciò che sembra naturale, sia negli uni che nelle
altre, è piuttosto la «capacità di imparare a fornire e a leggere raffigurazioni della
maschilità e della femminilità» unita a un «desiderio di aderire ad un programma
ben preciso per realizzare simili raffigurazioni» (Goffman 1977, 8 ss.). Goffman
ribadisce che i gender displays non vanno considerati né come residui dello
sviluppo evolutivo della specie umana né come «espressioni naturali». Quali attori
connotati in base al genere (gendered), le persone realizzano il proprio genere
mediante un «canovaccio di espressioni appropriate» (Goffman 1979, 8).
Ciò che la natura umana dei maschi e delle femmine davvero consiste allora
è la capacità di imparare a produrre e a leggere immagini della maschilità
e della femminilità e il desiderio di aderire ad un canovaccio per questa
rappresentazione, e questa capacità ce l’hanno poiché sono persone e non
maschi o femmine. Si può perfino arrivare a dire che non vi è un’identità
di genere, ma solo un canovaccio per la sua rappresentazione [così come]
vi è solo evidenza della pratica tra i sessi di coreografare mediante i comportamenti un ritratto della loro relazione.
Le rappresentazioni di genere non vanno però trattate come parte superficiale della vita ordinaria, come fronts che gli attori riservano per i palcoscenici
dell’esistenza: se le relazioni gerarchiche tra i sessi sono «l’ombra e la sostanza»
della vita sociale, le rappresentazioni di genere sono «tutt’altro che un mero show»,
e nel nostro raccontarci in relazione al genere non vi è «nulla di superficiale».
— 44 —
La ritualizzazione della femminilità
Il fine gioco di incastri del pensiero goffmaniano sul genere non è però
sempre stato apprezzato. Persino West e Zimmerman (1987, 127) nel loro celebre saggio Doing Gender sostengono che la nozione di gender display relega il
genere nella «periferia dell’interazione». La visione di Goffman sarebbe limitata,
spiegano i due etnometodologi, perché «il genere non è semplicemente qualcosa
che avviene nelle pieghe e nelle crepe dell’interazione, che spunta qua e là e
non interferisce con le questioni serie della vita. Mentre è possibile sostenere
che le rappresentazioni di genere, costruite come espressioni convenzionalizzate,
sono opzionali, non sembra plausibile dire che abbiamo l’opzione di esser visti
dagli altri come femmine o maschi» (ivi, 130). In realtà, per Goffman il genere
non è un ruolo – inteso come identità situata che può essere messa e dismessa
a piacere e che ha suoi specifici contesti organizzativi – quanto quella che uno
dei suoi ispiratori di Chicago, Everett Huges chiamava master identity, ovvero
un’identità che taglia trasversalmente le situazioni3. E in effetti «ogni scena può
essere, così sembra, definita come un’occasione per la rappresentazione della
differenza di genere, e in ogni scena si può trovare una risorsa per portare a
termine questa rappresentazione» (Goffman 1979, 9). La differenza di genere
risulta essere, nella visione di Goffman, molto più importante della classe o
dell’etnia – le dimensioni della stratificazione sociale tipicamente considerate
dalla sociologia critica:
Il più profondo senso di ciò che si è – la propria identità di genere – è
qualcosa i cui caratteri iniziali vengono dati a partire da fattori che non
contemplano stratificazioni etniche o socio-economiche; e questo in qualche modo fornisce uno scudo rispetto alle alterne vicende della nostra
vita in relazione alla nostra posizione nella gerarchia sociale complessiva
(Goffman 1977, 315).
Certamente la rappresentazione del genere si fonda su uno scambio rituale
di tipo affermazione-replica, ma il termine display va compreso non come tratto
di superficie, quanto come elemento dell’inevitabile presenza di un destinatario,
magari anche solo immaginato, nelle espressioni umane (si veda Bakhtin 1986). In
particolare, Goffman (1979, 3) scrive che le rappresentazioni del genere possono
«apparire opzionali» riferendosi ai numerosi «equivalenti funzionali» che maschi e
femmine hanno a disposizione per rimarcare la propria maschilità o femminilità:
opzionale non è quindi tanto l’espressione dell’appartenenza a una classe sessuale,
3
Tanto è vero che moltissimi ruoli, professionali ma non solo, sono intimamente connotati in base
al genere. In un saggio del primissimo secondo dopoguerra Hughes (1945, 356) fa riferimento ai compromessi che le donne professioniste dovevano saper gestire, tra la dimostrazione di una professionalità
(tipicamente maschile) e il mantenere una propria identità femminile (in opposizione alla maschilità). Un
modo di far fronte alle contraddizioni tra richieste di ruolo professionale e identità sessuale è quello di
mantenere i rapporti e le interazioni su un piano più formale possibile, tuttavia anche in questo caso il
genere rimane qualcosa di cui possiamo in alcuni casi essere chiamati a rispondere.
— 45 —
erving goffman
quanto i modi in cui maschilità e femminilità si realizzano e i codici così utilizzati.
Riferendosi ai genderismi Goffman evita di considerare il genere come una entità
unitaria e coerente, illuminandone la continua negoziazione in distinti domini di
esperienza sociale (Stacey e Thorne 1985). Tra le righe leggiamo comunque che,
per quanto si possa in alcuni casi giocare con la propria femminilità e maschilità,
abbracciare maschilità e femminilità più o meno ideali e «normali», risulta assai
più difficile giocare con la propria classificazione di maschio o di femmina.
Qui si aprono due questioni intrecciate: la normatività e la normalità. Le
espressioni di genere, «attività programmate in punti adeguati dell’interazione e
totalmente riconoscibili dall’audience», sono una diretta conseguenza di ciò che gli
individui sentono di dover veicolare sulla propria natura sessuata secondo codici
convenzionali, perciò si possono caratterizzare come «una sorta di “drammatizzazione” degli ideali che una cultura elabora sulle nature maschile e femminile»
(1979, 10). Goffman però non intende affatto sostenere che o si rappresenta una
femminilità «ideale» o non si rappresenta nulla, o si riesce a mettere in scena una
maschilità «perfetta» oppure si cade in una inevitabile stigmatizzazione: possiamo
immaginare che come in Stigma (Goffman 1967) egli avesse ben presente che i
confini tra normale e patologico sono instabili, sfumati, mutevoli e che la piena
normalità è una perfezione mai pienamente realizzata che in quanto tale funge
da ideale, termine di paragone, utopia etc. Rispetto alle idealizzazioni di genere
Goffman indica però anche il principale gradiente o strumento di categorizzazione: si tratta del rapporto tra categoria o meglio «classe sessuale» e «genere» (1977,
302)4. Per Goffman, come era stato per Garfinkel (1967, si veda anche Sassatelli
2006a) nella sua celebre riflessione sul transessualismo, l’assegnazione a una
classe sessuale precede il genere:
L’assegnazione è accompagnata dall’ispezione del corpo nudo del neonato,
in particolare dei suoi genitali, che sono visibilmente dimorfi; una pratica
di assegnazione non troppo diversa da quella che si usa fare con gli animali domestici. Questa assegnazione a partire dalla configurazione fisica,
consente l’attribuzione di un’etichetta linguistica di identificazione correlata
al sesso – per esempio, uomo-donna, maschio-femmina, ragazzo-ragazza,
lui-lei. La selezione è confermata in vari stadi della crescita dell’individuo da
altri segni biologici, alcuni riconosciuti dalle competenze di senso comune,
altri (perlomeno nelle società moderne), frutto di un’elaborazione scientifica, essendo descritti ad esempio come prove cromosomiche, ormonali, o
medico-anatomiche (Goffman 1977, 302).
4
Goffman può così porre il problema delle differenze di genere scardinando quella essenzialità
del sesso che ancora informa il senso comune e che, a metà degli anni settanta, era cruciale anche per il
pensiero femminista – basti pensare ad Ann Oakley (1972) che nel suo Sex, Gender and Society fonda il
concetto di genere proprio sulla distinzione tra sesso (come dato biologico sottostante) e genere (come
costrutto simbolico).
— 46 —
La ritualizzazione della femminilità
E tuttavia, anche laddove sembrerebbero affiorare differenze biologiche fra
i due sessi (nella forza corporea o nelle dimensioni fisiche) si può dimostrare,
insiste Goffman, che la loro effettività viene assicurata dall’organizzazione sociale,
la quale prevede meccanismi di educazione e selezione attraverso cui uomini e
donne possono manifestarsi differenti – ad esempio forme di «accoppiamento
selettivo» volte ad assicurare che in una coppia l’uomo abbia maggiore età e/o
dimensioni della donna. Introducendo la nozione di «riflessività istituzionale»,
Goffman (1977, 302 ss.) indica tutti quei caratteri dell’organizzazione sociale che
hanno l’effetto di confermare i nostri stereotipi di genere e convalidare l’orientamento prevalente nelle relazioni fra i sessi. È dunque l’ambiente sociale stesso
– dalle norme architettoniche alle regole del vivere civile – a esser plasmato così
da evocare e fare da palcoscenico ai genderismi che alludono al nostro essere
essenzialmente maschi o femmine. Non bisogna allora «spiegare le conseguenze sociali delle differenze innate tra i sessi, ma piuttosto il modo in cui queste
differenze sono state e sono poste a garanzia dei nostri accordi sociali e, ancor
più importante, il modo in cui l’attività istituzionale della società ha assicurato
che questa spiegazione abbia potuto sembrare solida» (ivi, 301). Indubbiamente
anche nei lavori sul genere Goffman inquadra i genderismi all’interno di proprietà
«più generali» della comunicazione e dell’esperienza, ma di converso il genere
risulta un elemento pervasivo del sociale che «garantisce» l’ordine. Anche se come
scrive Greg Smith (1996), «la teoria della riflessività istituzionale è primariamente
interessata alla differenziazione di genere e non alla stratificazione», Goffman è
conscio del peso del genere per le donne. Dal genere non ci si libera neppure tra
le mura domestiche: «Mentre altri gruppi sociali possono allontanarsi dal mondo
nella sfera domestica in cui l’autodeterminazione e il sollievo dall’ineguaglianza
sono possibili, lo svantaggio che persone che appartengono al sesso femminile
soffrono rende questo impossibile; i posti identificati nella nostra società come
luoghi in cui ci si può rilassare e realizzare sono ciò non di meno assolutamente
organizzati secondo regole svantaggiose per le donne» (Goffman 1979, 9).
Se il genere non è assimilabile a un ruolo, è dunque perché si esprime
attraverso l’incorporamento: mediante segnali e simboli che sono direttamente
ancorati ai nostri corpi. E i nostri corpi codificati in base al genere parlano di noi
senza che noi possiamo facilmente opporvi resistenza, e persino attraverso la
nostra resistenza. Si apre qui la grande questione del linguaggio non verbale e
della sua potenza (si veda Henley 1977). Le rappresentazioni visuali nelle fotografie, soprattutto nelle forme iperitualizzate dei messaggi commerciali, colgono
(e sfruttano) proprio questo linguaggio. Sono registrazioni istantanee, non tanto
della vita reale, ma di un idioma rituale.
La ricchezza dei codici di genere nelle rappresentazioni fotografiche commerciali è ben delineata da Goffman nel suo breve saggio sulla rappresentazione
della femminilità. Molti di questi codici si ispirano a quello che egli definisce il
— 47 —
erving goffman
«complesso genitori-figli» (1977, 3-4): si tratta di una cornice che accomuna le
relazioni tra maschi e femmine a quelle tra genitori e figli, per cui tanto i figli
quanto le femmine vengono posti sotto tutela «paternalistica» da genitori e maschi. Il risultato è che le donne ottengono protezione e cura in cambio di una
violazione della propria sfera del privato, della propria autonomia e persino del
proprio diritto a essere trattate come soggetti a pieno titolo, proprio come accade ai bambini. I gender displays affermano una struttura sociale fondamentale
tenendo le donne «al loro posto». Si tratta di rappresentazioni ritualistiche che si
avvalgono in modo asimmetrico di stratagemmi comunicativi come «il trattamento come non-persona», il «controllo benigno», «la licenza di orientamento», che
vengono estesi dai bambini alle donne. Quindi, «parlando ritualisticamente, le
donne sono equivalenti a maschi subordinati, ed entrambi sono equivalenti ai
bambini» (Goffman 1979, 5).
Le molte sfumature della femminilità possono allora essere riportate alla
dicotomia attivo/passivo. Gli uomini sono attivi, le donne passive. Nelle rappresentazioni ritualistiche, ad esempio, i maschi tendono a portare a termine il ruolo
attivo e principale e le donne quello passivo, decorativo o comunque sussidiario in
una «gerarchia di funzioni» (ivi, 36 ss.) che si applica non solo nei domini maschili
ma anche in quelli tradizionalmente femminili (per esempio in cucina, dove quando ci sono coppie, lui spesso assume un ruolo attivo, e finisce per cambiare un
pannolino o pulire, non senza ironia, un salotto). Goffman quindi riprende un’idea
che circolava già ampiamente negli studi sul visuale dell’epoca. Nel suo noto Ways
of Seeing, John Berger (1972) aveva ripercorso la storia dell’arte occidentale, e
in particolare la rappresentazione del nudo femminile, per mostrare proprio che
laddove «gli uomini agiscono, le donne appaiono. Gli uomini guardano le donne. Le donne osservano se stesse essere guardate» (ivi, 49). Laura Mulvey (1975,
11) articolava il paradosso della castrazione simbolica femminile analizzando la
rappresentazione delle donne nel cinema classico hollywoodiano, in cui l’eroe
maschile agisce mentre «le donne sono allo stesso tempo osservate e mostrate, e
la loro apparenza è codificata per un forte impatto visivo ed erotico tanto che si
può dire che esse connotino l’essenza stessa dell’essere guardati».
Ma Goffman mostra anche che le immagini pubblicitarie contengono importanti sovversioni dei genderismi dominanti. Certamente le sovversioni nel
campionario di Goffman occupano quantitativamente uno spazio ridotto (si
veda Chadwick 1988, 65-69). E tuttavia sono fondamentali. I displays di genere,
come altri rituali, possono ironicamente riflettere le fondamentali caratteristiche
della struttura sociale, ma possono anche contrapporsi a queste caratteristiche,
rovesciarle, controbilanciarle o compensarle. Così «i displays sono sintomi e non
ritratti. Perché, in effetti, quali che siano le circostanze fondamentali di coloro che
sono nella stessa situazione sociale, i loro stili comportamentali possono affermare
una immagine contraria» (Goffman 1979, 8). La rappresentazione pubblicitaria
— 48 —
La ritualizzazione della femminilità
mostra la propria doppiezza: le immagini promozionali possono infatti non solo
proporre visioni dell’identità, della famiglia, del genere, della razza etc. funzionali alla riproduzione delle gerarchie e delle differenze sociali consolidate, ma
anche ospitare visioni minoritarie e persino sovversive, soprattutto man mano
che si sviluppano mercati di nicchia sempre più diversificati. D’altro canto, se la
pubblicità ha sempre ospitato anche immagini sovversive del genere (Wernick
1991), è soprattutto a partire dagli anni settanta che essa ha cavalcato l’onda di
movimenti progressisti o di protesta, come quello femminista (Goldman 1992).
Il saggio sulla ritualizzazione della femminilità, e con esso Gender Advertisments, non si occupa tuttavia specificatamente della pubblicità come genere,
né del genere in pubblicità (si vedano Emmison e Smith 2000; Sassatelli 2006b)5.
Usa le fotografie pubblicitarie come una fonte da cui trarre elementi per l’analisi
di rituali di genere spesso taciti e opachi. Le osservazioni proposte non sono
volte a comprendere il messaggio pubblicitario come particolare processo comunicativo, né tanto meno i meccanismi tipici dell’industria pubblicitaria o, più in
generale, della cultura promozionale. L’obiettivo di Goffman è quello di utilizzare
un campionario di immagini fortemente tipizzate, come le foto pubblicitarie, per
mettere in luce le micro-configurazioni spaziali ed espressive che consentono agli
attori sociali di esprimere e costruire le differenze tra i sessi facendole apparire
«naturali». L’analisi del messaggio pubblicitario iper-ritualizzato è volta, così suggerisce Goffman, a osservare con lividezza e precisione i meccanismi attraverso
i quali gli attori sociali fissano il genere sui propri corpi nella vita quotidiana.
Il suo lavoro si colloca allora a una certa distanza da un altro influente saggio
a esso contemporaneo, Decoding Advertisements di Judith Williamson (1978)
dove, traendo ispirazione da Barthes, è lo specifico del messaggio pubblicitario
in quanto gioco di associazioni simboliche, traslazione e trasfigurazione mitica
di significati a essere al centro dell’attenzione6. Nel lavoro di Williamson sembra
aprirsi lo spazio per considerare l’intertestualità del genere, aspetto chiaramente
importante anche per Goffman. I pubblicitari, ci suggerisce, vogliono «decantare»
i prodotti, e per questo devono «sottomettersi alle costrizioni del supporto» che
utilizzano. Di queste costrizioni però Goffman ci parla poco. O meglio, Goffman
tende a considerare rappresentazione fotografica e rappresentazione fotografica
5
Forse anche dalla pubblicazione di un breve estratto da Gender Advertisings intitolato Genderisms: An Admittedly Malicious Look at How Advertising Reinforces Sexual Role Stereotypes su «Psychology
Today» nel 1977 discende tuttavia il grande successo del lavoro di Goffman tra le ricerche sugli stereotipi
di genere in pubblicità, successo testimoniato dalle numerose discussioni e repliche empiriche sino ai
giorni nostri, si vedano Belknap e Leonard (1991); Bell e Milic (2002); King (1997); Milburn et al. (2001);
Rutledge Shields (1997).
6
È questa la stagione in cui si sviluppa anche l’analisi semiotica del genere nel nostro paese: tra
le prime ricerche su questi temi, si veda Pignotti e Mucci (1978), un lavoro che riprende le funzioni del
linguaggio proposte da Jakobson, individua alcuni temi nella rappresentazione commerciale della donna
(una femminilità archetipica, la coppia, la famiglia, il lavoro, e l’eros) e li illustra con un vario ed eterogeneo materiale fotografico.
— 49 —
erving goffman
specificatamente pubblicitaria in diretta continuità identificando una serie di caratteristiche eterogenee: dall’utilizzo di scene che per la loro fondatività sequenziale
possono prendere il posto di un «intero corso di azione», all’uso di «tipi positivi,
approvati da tutti», alla rappresentazione di «scene e personaggi stereotipati che
la grande maggioranza degli spettatori ha da un pezzo identificato con questa o
quella attività, assicurando la comprensione immediata». Considerando il punto di
vista della fotografia pubblicitaria, Goffman ci dice qualcosa dell’obiettivo (che allo
stesso tempo tradisce ciò che gli sta davanti e non consente agli attori di tradire la
macchina fotografica), ma non molto della specificità della comunicazione pubblicitaria. Per quanto sembri sposare l’idea che la pubblicità sia rivolta al minimo
comune denominatore, ed estremizzi, con fini strumentali, la rappresentazione
del sociale (Nava et al. 1997; Wernick 1991), facendo eco a un celebre saggio
di Howard Becker (1974) su fotografia e sociologia apparso solo qualche anno
prima, Goffman tende a dare rilievo alla continuità tra forme del rappresentare.
E così scrive: «il lavoro del pubblicitario che deve mettere in scena il valore del
suo prodotto non è così distante dal lavoro di una società che riempie le proprie
situazioni sociali di cerimoniali e di segni rituali destinati a facilitare l’orientamento
reciproco dei partecipanti». E tuttavia, proprio nella sua attenzione per le sovversioni di genere scorgiamo un Goffman che, forse a suo dispetto, ha intravisto un
tratto specifico della cultura promozionale e delle immagini pubblicitarie: non
intendendo socializzare i valori o riprodurre le categorie sociali, la rappresentazione
pubblicitaria gioca con il genere, distillando raffigurazioni nitide, capaci di colpire,
aprendosi a forme diverse che irritano le coscienze dei moralisti, rafforzano le
convinzioni dei dominanti e strizzano l’occhio alle aspirazioni dei dominati.
Roberta Sassatelli
***
La ritualizzazione della femminilità
di Erving Goffman
Questo contributo discute e analizza alcune fotografie commerciali, ovvero pubblicità, che raffigurano soggetti umani. Queste fotografie sono state estratte con
un preciso disegno analitico da quotidiani e riviste a grande tiratura e, almeno per
me, facilmente accessibili. Si tratta infatti di immagini selezionate con lo scopo di
essere raccolte e arrangiate non senza malizia in alcune serie in grado ciascuna di
illustrare, delineare e riprodurre un tema preciso relativo al genere e, in particolare,
alla femminilità. Ogni serie è accompagnata da un semplice commento.
Iniziamo da qualche considerazione sul modo in cui le fotografie possono
o non possono essere utilizzare nell’analisi sociale. È mia opinione che i temi
— 50 —
La ritualizzazione della femminilità
che possono essere articolati mediante le fotografie possiedano uno statuto
ontologico molto variegato, e che ogni tentativo di fissare leggi sull’ordine di
realtà così rappresentato rischi fortemente di vedersi deluso.
Per chi vuole studiare le fotografie pubblicitarie esiste un metodo che consiste nell’estrarre un campione casuale di uno o più numeri di una o più riviste,
precisando i titoli e i periodi e rifiutando d’interessarsi a tutto ciò che esula dal
campione: la rappresentatività specificabile è dunque una delle condizioni che
ogni collezione di fotografie dovrebbe soddisfare7 – e che quelle che stiamo
per analizzare non soddisfano (tra parentesi, i risultati ottenuti a partire da un
campionamento sistematico molto spesso traggono la propria forza dal fatto
che ci si può aspettare che il lettore li generalizzi oltre il loro universo specifico,
operazione la cui garanzia statistica richiederebbe uno studio ulteriore che, a sua
volta, porterebbe a una sovrageneralizzazione ancora più estesa, e così via. Ma
questo è un altro problema). È importante sottolineare tuttavia che questo tipo di
rappresentatività appartiene alle immagini in quanto tali e non ci rivela niente di
ciò che molto spesso desideriamo conoscere, cioè di quali aspetti della vita reale
le fotografie diano un’immagine realistica, e quale effetto sociale esse esercitino
sulla realtà presumibilmente ritratta – un limite di cui, del resto, soffre anche il
campione a scelta ragionata da me analizzato.
Poiché sono pochi i limiti di ciò che posso scegliere di definire come tematica, o del genere di fotografie che posso raccogliere per esporre quanto ho
prima identificato, o delle possibili modalità di disposizione all’interno delle
serie, si potrebbe credere che niente mi vieti di dimostrare ciò che mi aggrada,
a partire da alcuni punti apparentemente comuni. In questo ambito il successo
non richiederebbe che un po’ di perversità e di astuzia, e una certa quantità di
fotografie. Perché, più è vasta la collezione di cui dispone il ricercatore, più grande è la sua certezza di trovare conferma di ciò che pensa d’aver scoperto in un
certo esemplare, persino di quanto vorrebbe dimostrare in ogni caso – prova che
talvolta più la rappresentatività diminuisce più i dati si moltiplicano. Ne consegue
che l’illustrazione efficace di un tema di per sé non dimostra nulla riguardo a ciò
che si può scoprire nelle immagini o, ancora meno, nel mondo. Il fatto è che è
un metodo abbastanza simile al mio quello utilizzato dai compilatori di album
umoristici e dai fotografi burloni che accoppiano l’immagine di questa o quella
celebrità, impegnata a gesticolare, con quella di un animale immortalato in una
posa apparentemente simile, o che vi appongono fumetti il cui contenuto modifica
radicalmente la situazione e attribuisce ai protagonisti reazioni sconvenienti.
Gli oggetti che mi propongo di esaminare sollevano tre questioni di metodologia generale che conviene non confondere: la scoperta, l’esposizione e la prova.
7
Per un esempio recente, si veda Robinson (1976).
— 51 —
erving goffman
Qui m’interessano solo le prime due, poiché si prestano a illustrare come sfruttare
– senza grande sforzo di ricerca – i vantaggi molto particolari che offre la fotografia.
Esiste una classe di pratiche comportamentali – che potrebbero chiamarsi
«piccoli comportamenti» – la cui forma materiale è codificata abbastanza bene,
anche se le implicazioni sociali o il significato delle azioni in causa possono essere in parte vaghi. Tali pratiche si compiono interamente, dall’inizio alla fine, in
un tempo molto breve e in uno spazio ristretto. Esse costituiscono degli eventi
comportamentali, registrabili e riproducibili per mezzo di cassette audio e video
e telecamere. (La banda magnetica e la pellicola, a differenza della fotografia,
forniscono non una sola immagine di una realizzazione effettiva dell’attività considerata, ma tutta una collezione di analoghe registrazioni. Meglio ancora, l’uso
di registrazioni audio e video per l’esame dei comportamenti minuti facilita lo
studio microfunzionale, cioè quello del ruolo di tale elemento comportamentale
nel flusso di quanto lo precede, accade contemporaneamente a esso e lo segue).
C’è un incontro tra un oggetto di studio e una tecnologia che pone il ricercatore
in una relazione totalmente nuova con i suoi dati e costituisce il fondamento
pratico della microanalisi.
Le fotografie, qualunque sia la loro provenienza, sono ormai a buon mercato
e facilmente riproducibili sotto forma di diapositive. Avendone così costituita una
collezione, niente è più facile che sceglierle, disporle e ridisporle, in breve dedicarsi con loro a un gioco per tentativi ed errori che contribuisce meravigliosamente
a rivelare schemi e ad apportare esempi, siano essi mere illustrazioni o casi reali.
La competenza sociale dell’occhio è enorme e impressionante è il consenso
tra coloro che guardano, due fattori che il ricercatore può sfruttare. Grazie a essi,
in effetti, gli è offerta la possibilità di esaminare chiaramente figure comportamentali che un insufficiente talento letterario non gli permetterebbe di evocare con
le sole parole. Non dovendo più restituire il fenomeno nella sua totalità, le sue
parole possono allora limitarsi a dirigere lo sguardo verso ciò che bisogna vedere.
Analogamente, la nozione di «reazione puramente soggettiva» diviene suscettibile
di una promozione accademica, poiché è ben chiaro che almeno una parte di
ciò che si evita di studiare per paura di cadere in chiacchiere possiede una realtà
specifica e si lascia percepire con precisione, essendo la tendenza a divagare
dovuta all’incapacità letteraria del ricercatore e non alla natura dei dati8.
8
L’orecchio possiede quanto l’occhio una competenza impressionante, e in questo campo i fonetisti
(seguiti ultimamente da tutti gli interessati all’analisi del discorso) hanno fatto uno sforzo esemplare per
elaborare sistemi di notazioni che, potendo essere stampati, evitassero le limitazioni dell’ortografia corrente
e tendessero così un ponte tra il dominio dei suoni e quello dello scritto. Rimane tuttavia un problema:
sebbene dei ricercatori allenati siano perfettamente capaci di produrre tutti una trascrizione identica per una
sequenza sonora data, la loro formulazione scritta può ugualmente applicarsi correttamente a espressioni
da essi intese per motivi differenti come significativamente diverse. Detto altrimenti, se si dispone di una
registrazione da ascoltare, la trascrizione del linguista può rivelarsi molto utile per orientare l’attenzione
uditiva verso un certo suono e sfruttare così tutta la competenza dell’orecchio per fini accademici. Ma,
— 52 —
La ritualizzazione della femminilità
Una collezione di esempi per immagini (si tratti di illustrazioni o di rappresentazioni di casi reali) su un tema comune offre qualcosa di più che un
semplice espediente per assicurarsi che il fenomeno studiato appaia chiaramente
alla vista dello spettatore. Per questo, basterebbero perlopiù uno o due esempi.
Diversamente dalle considerazioni tradizionali in materia di campionamento,
la dimensione della collezione non è assolutamente finalizzata a dimostrare la
prevalenza di questi o quei casi entro il campione e, per estensione, entro l’universo da cui è tratto, ha a che fare con tutt’altra cosa. L’interesse di avere diverse
immagini esemplificative di un unico tema è infatti dato dalla loro possibilità di
illustrare un ventaglio di sfondi contestuali differenti, capaci di chiarire disparità
ancora inedite anche se manifestate in un identico disegno. È, in certo modo, la
profondità e l’estensione di queste differenze contestuali a farci percepire il senso
di una struttura, di un’unica organizzazione soggiacente agli scarti superficiali.
Laddove per i metodi tradizionali le differenze tra casi da conteggiare in qualità
di rappresentazioni di una stessa cosa sono una fonte di disturbo in proporzione
al grado di differenza, per l’analisi tramite immagini, che consiste precisamente
nel fondere degli scarti apparenti in un unico insieme, è vero il contrario. E in
effetti possiamo imparare qualcosa anche quando un pubblicitario lavora a ritroso
e, partendo da un certo modello e un preciso argomento di vendita, si mette a
cercare diverse possibili scene dove farli figurare insieme, sperando di rilanciare
il prodotto tramite una commistione di ripetizione e novità. Perché, quale che
sia il suo desiderio di riempire di cambiamenti un tema dato, non di meno deve
soddisfare le esigenze dell’invenzione scenica – adeguatezza, intelligibilità, e così
via – che mostrano così necessariamente che è possibile e come è possibile coreografare e orchestrare diversi ingredienti per far loro «esprimere» la stessa cosa.
Il fatto che un insieme di pubblicità possa manifestare una struttura soggiacente
comune è dunque un artefatto interamente prodotto dalla concezione pubblicitaria
stessa, e il ricercatore non fa che scoprire quanto è stato di primo acchito disposto
deliberatamente. Ma il modo in cui il pubblicitario riesce a trovare diverse maschere per i suoi stereotipi ci istruisce sui modi in cui il materiale tratto da scene
reali può essere scelto e modellato per provocare l’interpretazione desiderata.
Le fotografie che raffigurano comportamenti rilevanti dal punto di vista del
genere e da me raccolte in modo non casuale possono rivelarsi utili per rinfrescarci le idee su tre punti: gli stili del comportamento legati al genere, il modo
in cui la pubblicità ne presenta una visione obliqua e le regole di produzione
scenica tipiche della forma fotografica. Sebbene il mio interesse primario si
focalizzi soprattutto sul primo punto, i testi che accompagnano le mie fotografie toccano tutte le questioni che esse possono sollevare. Preciso tuttavia che
senza la registrazione, una trascrizione non risolve niente. Quanto alla trascrizione scritta delle analisi
delle registrazioni video, essa pone problemi ancora più gravi.
— 53 —
erving goffman
l’obiettivo principale della mia analisi è illustrare quali siano i modi in cui pubblicitari ritengano profittevole rappresentare le donne. Le mie generalizzazioni
hanno quindi almeno la minima scusa di riferirsi al modo in cui il genere viene
rappresentato, non al modo in cui viene a realizzarsi concretamente.
In generale, non ho riportato le fotografie raffiguranti quanto è a mio parere
comune ai due sessi, solo sul piano dell’immagine o parimenti nella realtà, né quelle
relative alle differenze che ho assunto come ampiamente conosciute da tutti. Ne
consegue che quanto è banale – o almeno mi sembra tale – in pubblicità risulta
qui decisamente sottorappresentato. (Mancanza che del resto si ritrova ovunque
in etnografia: sono le differenze e le somiglianze inaspettate col proprio mondo a
essere registrate). Inoltre, per quanto la professione pubblicitaria (negli Stati Uniti)
sia concentrata a New York e i modelli e i fotografi costituiscano una popolazione
molto particolare, ciò che essi producono non ha niente di straordinario agli occhi
di chi lo guarda, è qualcosa di «completamente naturale». In altri termini, anche
se i documenti qui presentati non possono essere considerati rappresentativi del
comportamento rilevante per la stabilizzazione delle differenze di genere nella
realtà, né della pubblicità in generale né di una tale pubblicazione in particolare,
si può nondimeno, così mi sembra, emettere al loro riguardo un giudizio negativo
di una certa rilevanza, cioè che in qualità di immagini non sono percepite come
qualcosa di innaturale o di anormale. Stando così le cose, per prendere subito
coscienza dello stereotipo basta immaginare per ciascuna fotografia il risultato di
un eventuale scambio dei sessi. Con questa possibilità in mente, il lettore sarà in
grado di effettuare i suoi commenti personali e potrà farsi un’idea dei miei eventuali meriti.
Un ultimo avvertimento: nella stragrande maggioranza, le pubblicità presentano innocentemente scene fittizie i cui soggetti, i personaggi, non hanno
niente in comune con i modelli professionisti che posano per l’occasione. In
modo molto evidente, è una scorciatoia dire, per esempio, che le infermiere sono
presentate in questa o quella maniera dalla pubblicità: l’immagine data è infatti
quella di modelle vestite da infermiere e in posa in una riproduzione di un ambiente medico. (Senza dubbio basterebbe un’onesta retribuzione per convincere
una vera infermiera a posare o a lasciarsi fotografare al lavoro; ma il fatto è che
le agenzie di pubblicità pensano abitualmente che le vere infermiere dentro i
veri ospedali non hanno un’aria abbastanza «tipica»). Mi capiterà di utilizzare una
tale semplificazione e parlare dei soggetti di una fotografia come se si trattasse di
esempi, di immagini registrate dalla realtà. Ma la complicazione viene dal fatto
che posare per una pubblicità implica quasi invariabilmente un’esagerazione dei
caratteri sessuali, nell’aspetto delle modelle femminili come personaggi femminili e dei modelli maschili come personaggi maschili. (La stessa esagerazione si
osserva per le fasce d’età). Ne consegue che ogni discussione sul modo in cui il
genere viene trattato in pubblicità finisce per imbattersi nel punto in cui, in certo
— 54 —
La ritualizzazione della femminilità
senso, modello e personaggio coincidono. Ecco giustificata in modo particolare
la semplificazione di cui parliamo. Perché, se è vero che il pubblicitario che
mette in scena una «infermiera» non ci presenta la registrazione fotografica di un
tale personaggio o, detto altrimenti, non ci mostra l’immagine autentica di una
vera infermiera, resta il fatto che ci fa vedere una donna vera, almeno nel senso
corrente del termine «vera»9. Uscita dallo studio fotografico, la modella cessa di
essere una «infermiera» ma continua a essere una «donna».
Qualche parola finale a proposito del modo in cui ho organizzato le fotografie stesse. Va sottolineato innanzi tutto che in esse figurano donne in atteggiamenti
«femminili» non solo di fronte a uomini ma anche di fronte a un’altra donna,
cosa che ci spinge fortemente a pensare che gli stereotipi di genere – almeno in
fotografia – facciano riferimento a uno spazio suddiviso in due compartimenti,
per cui l’importante è il riempimento di ciascun compartimento tramite soggetti
differenziati in termini di ruolo, ma non necessariamente di opposta identità
sessuale10.
Ora che è abbastanza chiaro che la mia collezione di fotografie pubblicitarie
non è necessariamente da prendere sul serio, mi piacerebbe spiegare rapidamente perché tali immagini dovrebbero comunque essere degne di attenzione.
Il compito del pubblicitario è di disporre favorevolmente lo spettatore rispetto
al prodotto che decanta, mostrando pressappoco un esemplare smagliante del
prodotto in una cornice favolosa, suggerendo implicitamente che, se comprate
l’uno, sarete sulla buona strada per ritrovarvi nell’altra, e che questa è proprio
quella che desiderate. Del resto è interessante notare che l’elemento incantatore
è in generale assicurato dalla presenza nella scena di un’elegante giovane donna
venuta a elargire al prodotto la sua approvazione e lo splendore della sua persona,
che il suddetto prodotto sia una scopa, un insetticida, una sedia ortopedica, del
materiale edile per il tetto, una carta di credito o una pompa a pressione. Ma tutto
ciò certamente non è altro che pubblicità e ha ben poco a che fare con la vita
reale. Così dicono i critici di quest’arte dello sfruttamento. Critici, bisogna dirlo,
naifs, incapaci di comprendere davvero cosa succede in questa vita reale.
Il pubblicitario, sebbene voglia decantare il suo prodotto, deve sottomettersi alle costrizioni del supporto che usa. Essendo tenuto a presentare qualcosa
di sensato e facilmente comprensibile, per farlo non dispone che dei caratteri
di stampa e di una o due fotografie i cui personaggi, anche se hanno l’aria di
9
Si troveranno delle precisazioni riguardo all’espressione «donna vera» in Goffman (1974, 284-285).
[Qui Goffman aveva criticato Sartre e la sua affermazione, in riferimento a un’opera teatrale di Genet,
che una donna non potrà che «essere» una donna quando recita un ruolo femminile, lo sarà «veramente»
oltre e al di là del proprio ruolo teatrale, limitando quindi gli effetti del frame teatrale, NdC].
10
[In Gender Advertisements, Goffman (1979) specifica anche che ha organizzato la presentazione
delle fotografie in modo da mostrare prima le immagini di bambini e poi via via di adulti, e prima le
immagini più naturalistiche e poi quelle più apertamente manipolate dal discorso pubblicitario, concludendo con le immagini che rovesciano i ruoli di genere (gender reversals), NdC].
— 55 —
erving goffman
parlare, nondimeno sono muti. Sottolineiamo d’altronde che il testo, che spiega
più o meno «cosa sta accadendo», è perlopiù un po’ ridondante dal momento che
l’immagine è costruita per raccontare da sola la sua piccola storia.
Come dunque delle semplici fotografie possono rappresentare il mondo,
un mondo nel quale dei personaggi (in movimento e mai fissi in una posizione)
sono impegnati a portare a termine il corso dell’azione, mediante attività protratte
nel tempo in cui il suono conta quasi quanto la vista, senza parlare degli odori
e del tatto? Nel mondo inoltre ci accade spesso di conoscere personalmente gli
individui che incontriamo, caso molto improbabile se si tratta di personaggi delle
pubblicità.
Alcune delle risposte a questo problema sono ovvie. È certo possibile costruire una scena dove i personaggi sono stati catturati nel bel mezzo di azioni
capaci di riassumere in modo stereotipico l’intera sequenza da cui sono tratte e
questo perché non le si considera possibili se non nel corso di un corso d’azione
complessiva di cui sono parte e che lo spettatore è portato a ricostituire11. Una
seconda soluzione consiste nell’utilizzare scene già silenziose e statiche nella
realtà: dormire, riflettere, guardare le vetrine e, soprattutto, guardare di traverso,
che ci serve a comunicare il nostro generale allineamento con quello che un’altra persona – che non ci guarda direttamente – dice o fa. O ancora, è possibile
disporre i personaggi secondo una microconfigurazione spaziale al cui interno
ogni singola posizione nello spazio indichi una specifica posizione sociale. E, beninteso, c’è la soluzione consistente nell’utilizzare scene e personaggi stereotipati
che la grande maggioranza degli spettatori ha da un pezzo identificato con questa
o quella attività, assicurando la comprensione immediata. A questo proposito,
notiamo brevemente che i pubblicitari scelgono quasi sempre dei tipi positivi,
approvati da tutti (forse perché preferiscono vedere i propri prodotti associati a
quanto è buono piuttosto che dissociati da quanto è cattivo) cosicché quel che
vediamo sono personaggi idealizzati che si avvalgono di strumenti ideali per
scopi non meno ideali – e naturalmente uniti da relazioni esse stesse ideali, come
indicato micro-ecologicamente dalla loro disposizione spaziale. Infine, rimane
l’espediente di far posare delle celebrità, personaggi che certo non si conoscono
personalmente ma di cui si sa sempre qualcosa.
È interessante notare che i pubblicitari non sono i soli a ricorrere a questo
genere di metodi figurativi. Anche i governi e gli organismi senza scopo di lucro
utilizzano espedienti simili per far passare i propri messaggi mediante la stampa
o l’affissione; e così fanno pure sia i gruppi di estrema sinistra sia i privati che
hanno l’hobby o la vocazione della fotografia. (Infatti è abbastanza scorretto,
ahimè, pretendere che solo i pubblicitari facciano pubblicità. Anche chi si oppone alla commercializzazione del mondo si vede costretto a visualizzare i propri
11
Punto che mi è stato suggerito qualche anno fa da David Sudnow (si veda Sudnow 1972, 259-279).
— 56 —
La ritualizzazione della femminilità
argomenti per mezzo di immagini scelte secondo criteri alla fine molto simili a
quelli del nemico).
Ma il punto essenziale cui voglio arrivare è che, a conti fatti, il lavoro
del pubblicitario che deve mettere in scena il valore del suo prodotto non è
così distante dal lavoro di una società che riempie le proprie situazioni sociali
di cerimoniali e di segni rituali destinati a facilitare l’orientamento reciproco
dei partecipanti. L’uno e l’altra devono raccontare una storia tramite limitate
risorse «visuali» offerte dalle situazioni sociali. Devono entrambi tradurre accadimenti opachi in una forma facilmente interpretabile; ed entrambi per farlo
usano gli stessi processi fondamentali: ostentazione (display) delle intenzioni,
organizzazione micro-ecologica della struttura sociale, tipizzazioni approvate,
esteriorizzazione gestuale di ciò che può sembrare una reazione intima. (Come
una pubblicità per Coca-Cola può mostrarci una famiglia dall’aria felice, ben
vestita, in una stazione balneare chic, così si possono vedere famiglie modeste,
stavolta reali e vestite in modo ordinario, permettersi una piccola follia nel passare dieci giorni delle loro vacanze in un simile posto, e avere ben cura, dopo
essersi cambiati, di fotografarsi nel loro nuovo ruolo, come per confermarci,
se ce ne fosse bisogno, il loro abbandono a uno sfoggio di autopromozione).
Detto questo, certamente non c’è ragione di negare che le esibizioni che si realizzano nelle fotografie pubblicitarie costituiscono un sottoinsieme particolare
delle esibizioni in generale. In linea generale, il pubblicitario deve accontentarsi di presentare nella foto delle apparenze mute e inodori, limitazione non
conosciuta dai riti della vita reale.
Ecco il problema delle «situazioni sociali», definite come gli assetti in cui
le persone sono materialmente in presenza le une delle altre. Accade, e anche
frequentemente, che le fotografie pubblicitarie ci presentino personaggi solitari,
chiaramente al di fuori di ogni situazione sociale. Nondimeno, per l’interpretabilità della scena è necessario che il soggetto esibisca delle apparenze e si dedichi
ad azioni dotate di valore informativo, processo che è precisamente quello che
impieghiamo nelle situazioni sociali reali per costruire le nostre storie personali e
informarci su quelle degli altri. Dunque, solitari o meno, i personaggi delle pubblicità si rivolgono implicitamente a noi, gli spettatori, che ci ritroviamo presso di
loro per il permesso che ci è dato di vederne ciò che possiamo, ottenendone come
effetto la produzione di una situazione che si può dire sociale. Ancora meglio, è
frequente che il fotografo tolga in precedenza ogni ambiguità chiedendo al suo
soggetto di simulare una risposta gestuale a qualche fantasma che si aggira vicino
all’apparecchio, e cioè nello spazio che si considera abitato da noi spettatori. E
sottolineiamo inoltre che il personaggio solitario, non contento di «esteriorizzare»
l’informazione destinata a darci un’idea di ciò che ci si vuole mostrare, si astiene in
modo totalmente sistematico dall’abbandonarsi a comportamenti proibiti o poco
lusinghieri, che sono nondimeno quelli che ci si può aspettare da una persona
— 57 —
erving goffman
certa di essere sola. (Chissà se uno dei sottoprodotti del realismo commerciale
non sarà un rafforzamento della censura sui comportamenti solitari?)12.
Quando, dunque, si prende in considerazione la presentazione dei sessi
nella pubblicità l’attenzione non dovrebbe essere unicamente diretta a svelare gli
stereotipi dei pubblicitari riguardo alle differenze tra i sessi, per quanto significativi
essi possano essere, né, d’altronde, unicamente a rinvenire in questi stereotipi
quanto possono rivelarci dei modelli dominanti, soggiacenti alla distribuzione
dei ruoli sessuali nella nostra società. Bisognerebbe anche esaminare in che
modo quelli che compongono (e posano per) le pubblicità assemblano i diversi
materiali che hanno a disposizione nelle situazioni sociali per raggiungere i loro
fini, cioè la presentazione di una scena significativa e leggibile con un colpo d’occhio. In questo modo riusciremo forse a mettere in luce, dietro agli sforzi artistici,
il modo in cui, a partire dai corpi in presenza gli uni degli altri e circondati da
artefatti non umani, si può modellare l’espressione. E, avendo visto quello che i
fabbricanti di immagini sanno fare dei materiali situazionali, potremo iniziare a
vedere ciò che noi stessi siamo impegnati a fare quotidianamente. Allora, dietro
a un’infinita varietà di configurazioni sceniche, giungeremo forse a distinguere
un unico idioma rituale e, dietro a una moltitudine di differenze superficiali, un
piccolo numero di forme strutturali.
Ora, ammetto volentieri che con tutto ciò posso dare l’impressione di voler
sfruttare materiali pubblicitari facilmente accessibili con opportunismo e oltre
le loro possibilità per parlare dei comportamenti e delle differenze di genere.
Tuttavia, ciò che qui m’interessa non è il comportamento in generale, ma solo
le esibizioni che gli individui riescono a infilare nelle situazioni sociali, e questo
è certamente parte di ciò che i pubblicitari stessi si sforzano di mettere nelle
scene che costruiscono attorno ai loro prodotti per fotografarle. Certo, per la
maggior parte, le fotografie commerciali non sono che «mere immagini», tutt’al
più «realistiche», ma va da sé che la realtà che si considera che esse riflettano in
maniera distorta è essa stessa artificiale, per diversi aspetti non trascurabili. Ma
la questione oggetto di questo studio è come le situazioni sociali ci servono da
risorse sceniche per elaborare una serie di ritratti visualmente e istantaneamente
accessibili della natura umana che rivendichiamo. Le fotografie di composizione
si riveleranno dunque più ricche di sostanza di quanto non si potesse pensare,
connotandosi, per chi studia l’idioma rituale di una comunità, come l’analogo di
un testo scritto per chi ne studia la lingua13.
12
[Goffman riprenderà la questione del «parlare da soli» nel suo saggio sui «gridi di reazione» (si
veda Goffman 1981), NdC].
13
[I temi qui toccati sono stati maggiormente sviluppati in Goffman (1979), NdC].
— 58 —
La ritualizzazione della femminilità
Maschile/femminile
La maggior parte delle pubblicità che mettono in scena uomini e donne evocano
più o meno apertamente la divisione e la gerarchia tradizionali tra i sessi. Così, la
donna appare più spesso nella posizione di subalterna o di assistita. Inversamente
l’uomo, la cui statura più elevata simboleggia lo status superiore, è rappresentato
in una postura protettiva che cambia secondo il legame sociale – familiare, professionale, amoroso – che intrattiene con le sue partner14.
14
[Discutendo delle «diverse dimensioni» dei partner di sesso opposto in Gender Advertisements,
Goffman (1979) riprende una questione già sollevata nel saggio sull’organizzazione delle differenze tra
i sessi (Goffman 1977), e cioè che «l’accoppiamento selettivo» è socialmente organizzato in modo tale da
rendere più certa la tendenza statistica per cui gli uomini risultano più grandi delle donne. Goffman inoltre
nota che le donne posso usare il corpo di un uomo come se fosse un semplice punto di appoggio molto
più di quanto non possa avvenire il contrario, e che questo può sembrare introdurre dei rovesciamenti di
gerarchia quando in effetti è più semplicemente un caso di estensione dell’appoggio che gli adulti danno
ai bambini, NdC].
— 59 —
erving goffman
Il tocco femminile
Le donne, più spesso degli uomini, ci vengono mostrate mentre sfiorano col
dito o con la mano i contorni di un oggetto che stringono al seno o di cui accarezzano la superficie (talvolta col pretesto di dirigerne l’azione). Ancora, le
si vede sfiorarlo appena, come per timore che da lui a loro passi una scarica
elettrica. C’è qui un tocco ritualizzato che conviene distinguere dalla varietà
strumentale, quella che afferra, manipola e trattiene. Quando al contrario la
donna tocca se stessa, sembra che il suo scopo sia far sentire il suo corpo
come una cosa delicata e preziosa.
La donna nascosta
Si può osservare una situazione sociale da lontano o dietro una linea di separazione – uno «schermo alla partecipazione» – così da poter essere visti poco o
niente, caso in cui diventa possibile prendere effettivamente parte agli eventi
— 60 —
La ritualizzazione della femminilità
senza esporsi alla vigilanza o alla disapprovazione altrui. Ne risulta una scissione
tra determinati vantaggi e determinati inconvenienti delle interazioni faccia a
faccia. Inoltre la presenza di tale schermo permette di impegnarsi simultaneamente in numerose interazioni secondarie dissociate le une dalle altre senza
sembrare indisponibile ad alcun partecipante.
Esiste una versione ritualizzata di questo comportamento che consiste nel
presentarsi in qualche modo all’estremità della situazione o al riparo di una qualunque protezione quando in realtà si è del tutto accessibili ai partecipanti. [La donna
può essere] nascosta dietro un oggetto [o] dietro una persona (con la possibilità
allora di esprimere qualcosa in più della semplice presa di distanza, potendo
andare fino al tradimento collusivo della persona dietro cui ci si ripara).
La donna lontana
Parlare al telefono implica necessariamente una certa distrazione in rapporto
all’ambiente immediato, e di conseguenza un’impreparazione agli eventi che
potrebbero accadervi. A ciò generalmente si rimedia limitando la durata della
chiamata e non impegnandosi troppo nella conversazione. Le pubblicità, al
contrario, ci mostrano donne sognanti, deliziosamente immerse in telefonate
presumibilmente molto lunghe.
Più in generale, si può considerare che distogliere lo sguardo equivalga a
ritirarsi dal corso della comunicazione al fine di recuperare, al riparo dall’osservazione diretta, la padronanza delle proprie emozioni. Poiché in tale atteggiamento
non viene messa in scena una fuga, esso sembra implicare un certo sottomettersi
e affidarsi alla persona da cui partono gli stimoli all’azione15.
15
Si veda Chance (1962).
— 61 —
erving goffman
La donna delle pubblicità sembra spesso staccata da ciò che la circonda («lo
spirito altrove») qualora sia vicina a un uomo, come se la vigilanza di lui, pronto
ad affrontare qualunque cosa succeda, bastasse per due. (Talvolta d’altronde
l’uomo sembra all’erta). Questa è una «deriva» dunque, ma «ancorata», che può
realizzarsi fissando lo sguardo a media distanza nel vuoto, su una varietà di
piccoli oggetti diversi o su una parte dell’abbigliamento dell’uomo che la donna
attorciglia distrattamente. Le mani costituiscono un oggetto interessante su cui
fissare lo sguardo dopo averlo distolto perché questa posa, oltre a suggerire
una certa chiusura, richiede perlopiù di abbassare la testa, da cui la possibilità
di vedervi un’attitudine di sottomissione.
La donna sottomessa
Letti e pavimenti forniscono in una situazione sociale luoghi in cui chi vi si stende
si trova più in basso delle persone sedute o in piedi. Il pavimento corrisponde
anche alla parte meno pulita, meno pura, meno nobile di un stanza: è lo spazio
che si riserva al cane, dove si mettono le ceste della biancheria sporca, le scarpe
per uscire etc. D’altra parte, la posizione distesa è quella da cui si riesce meno a
difendersi e che dunque ci rende più dipendenti dalla benevolenza dell’ambiente
circostante. (E va da sé che essere distesi sul pavimento, su un divano o su un
letto costituisce anche, così sembra, un modo convenzionale di esprimere una
disponibilità sessuale). Ora ciò che c’interessa qui è il fatto che i bambini e le
donne ci vengono mostrati distesi più spesso degli uomini.
Le donne frequentemente, gli uomini molto raramente tengono «il ginocchio timidamente piegato». Sebbene possa essere altrimenti, questo piegamento
del ginocchio potrebbe essere interpretato come la posizione di chi rinuncia
a prepararsi pienamente ai rischi della situazione sociale, perché non può che
ritardare leggermente ogni movimento per lottare o fuggire. È dunque ancora
— 62 —
La ritualizzazione della femminilità
un’attitudine che sembra presupporre la benevolenza di chiunque potrebbe rivelarsi pericoloso nell’ambiente. Ma sottolineiamo che qui si tratta più di imbastire
una scena che di caratterizzare sessualmente un soggetto. Così, l’immagine può
benissimo rappresentare due donne di cui l’una piega il ginocchio, mentre l’altra
le serve da supporto scenico. In altri termini i due ruoli, che non corrispondono
necessariamente ai due sessi, vengono ripartiti. Una distribuzione pressoché
identica a questa è la posizione inclinata. Sebbene si possa distinguere tra
inclinare il corpo e inclinare la testa, le conseguenze non sono molto diverse.
Nei due casi, il livello della testa si trova abbassato rispetto agli altri, compreso
indirettamente lo spettatore dell’immagine. Ne consegue un’attitudine leggibile
come l’accettazione di una subordinazione, come un’espressione insinuante,
sottomessa e compiacente.
Si può supporre che il sorriso abbia spesso la funzione rituale di addolcire,
di segnalare che non è temuta alcuna ostilità, voluta o provocata, che il significato
delle azioni altrui è stato compreso e accettato, che la persona stessa è stata giudicata degna di approvazione. E mentre la persona che segue con occhio sospettoso
un potenziale aggressore può trovarsi a sorridere automaticamente quando il suo
sguardo viene sorpreso da colui che ne è il bersaglio, l’altro, da parte sua, non
è sempre portato a sorridere di rimando. D’altra parte, rispondere subito con un
sorriso (o meglio ancora, con una risata d’approvazione) a una battuta può voler
dire che si appartiene, almeno per conoscenza, allo stesso ambiente di chi l’ha
fatta. Tutte queste varietà di sorrisi sembrano dunque costituire l’offerta di un
inferiore a un superiore, piuttosto che il contrario. In ogni caso si nota che nella
società americana, in occasione di incontri tra persone di sesso diverso, le donne
sorridono di più e più espansivamente degli uomini, situazione che la pubblicità
riproduce forse senza esserne pienamente cosciente16.
16
Si vedano i commenti di Naomi Weisstein (1973).
— 63 —
erving goffman
Gioco di mano
Più degli uomini, le donne ci vengono mostrate in disposizioni che le allontanano
mentalmente dalla situazione sociale ambientale, le lasciano disorientate in e verso
di essa e dunque, apparentemente, in balia della protezione e della benevolenza
eventualmente attuate dagli altri partecipanti (presenti o possibili).
D’altra parte, quando una persona perde il controllo della sua espressione
facciale, quando la sua emozione (riso o timidezza) «straripa», essa ha, per dissimulare in parte il suo cedimento, la risorsa di girarsi rispetto agli altri o di coprirsi
il viso, in particolare la bocca, con le mani. Qui si tratta della ritualizzazione di un
gesto associato all’infanzia: un tale atto non saprebbe dissimulare la dissimulazione
e apporta inoltre una cecità momentanea verso l’ambiente, cosa che ne fa una
reazione particolarmente vana e inadatta di fronte a una minaccia reale.
Come coprirsi la bocca può essere un modo attenuato di nascondersi il
viso, si può supporre che portarsi un dito alle labbra costituisca a sua volta una
versione debole della prima azione. Tuttavia, sembra che più comunemente si
abbia a che fare con un altro tipo di ritualizzazione: un modo attenuato di succhiarsi o mordersi il dito. Questo gesto dà in effetti l’impressione che una certa
corrente di tensione, o un certo impegno nel rimuginare, o qualcosa del genere
si sia visto staccare dal campo dell’attenzione e si mantenga a parte, dissociato
e più o meno incosciente. Una cosa è certa: il volto è in parte coperto, e tutto
accade come se, potendo vedere senza essere visti, si fosse liberi di sottrarre il
viso e una mano all’impegno nato dall’interazione faccia a faccia. Quanto alle
dita giunte, sembra che esse esprimano lo stesso dissociato ritorno su di sé del
gesto precedente, ma sotto una forma ancora più attenuata. Si può d’altronde
immaginare un movimento a partire dalla bocca.
— 64 —
La ritualizzazione della femminilità
La donna docile
Tutte le attività d’insegnamento sembrano implicare una certa subordinazione
dell’allievo che si dimostra deferente verso l’istruttore. Questi tratti espressivi
adatti alla situazione d’apprendimento vengono ulteriormente rafforzati dal
legame che, per la maggior parte delle persone in ogni fase del ciclo di vita,
unisce questo apprendimento alla gerarchia dell’età. Nella nostra società esiste
inoltre una forma d’apprendimento tipicamente associata, pare, alla condizione
infantile: l’apprendimento cinestesico dove si tratta per
l’allievo di modellare la sua azione su quella dell’istruttore
che lo guida fisicamente17. Ora, è più frequente vedere un
uomo istruire una donna in questo modo piuttosto che
il contrario. Qualora, per necessità o cortesia, un adulto
riceva l’aiuto di altri per compiere un’azione corporale,
ciò ha raramente luogo senza collaborazione da parte
sua: lui guida l’esecuzione e/o riprende l’iniziativa per
gli ultimi movimenti. (Due esempi di questa situazione:
passare il sale; aiutare qualcuno a mettersi il cappotto).
In questo modo, il beneficiario può mantenere e dare la
sensazione della propria autonomia. E può farlo ancor
meglio, naturalmente, riacquistando l’abilità che gli permetterà di occuparsi personalmente ed efficacemente delle proprie necessità.
I bambini piccoli invece devono sopportare di vedere la loro collaborazione
disdegnata dall’adulto impegnato a prendersi cura di loro18. Si capisce dunque
che una fotografia che ci mostra, ad esempio, un adulto che viene imboccato
si sforza di dare alla scena un tono caricaturale, senza dubbio per evitare che
il sé delineato dal fatto di essere così imboccato non sia preso per un riflesso
del sé reale. Ma bisogna notare che le donne, che ci sono mostrate più spesso
degli uomini in un tal frangente, non sono altresì raffigurate nell’atto di dare
alla loro azione un tono particolarmente umoristico.
17
La nozione di apprendimento cinestesico è tratta da The Balinese Character di Gregory Bateson
e Margaret Mead (1942, 85-86). Il loro lavoro ha brillantemente inaugurato l’uso delle fotografie per lo
studio di ciò di cui si può riportare chiaramente in un’immagine e ha incoraggiato un’intera generazione di
antropologi a prendere fotografie. Eppure si è ottenuto – e forse si poteva ottenere – molto poco dall’analisi dei documenti così raccolti. Questo perché, in un certo senso, c’è stata una confusione tra l’interesse
umanistico e l’interesse analitico. Sono stati raccolti filmati e fotografie che mostrano gente meravigliosa
ed eventi affascinanti, ma senza grande profitto: molto rispetto e affetto è stato riservato agli autoctoni,
ma davvero poco per l’uso analitico che si può fare delle immagini.
18
Conviene inoltre tenere conto dell’idea generalmente accettata per cui i membri di classi sociali
aristocratiche assumessero per tradizione servitori cui chiedere servizi intimi che i borghesi hanno sempre
preferito compiere personalmente, tanto che il pudore finisce per essere un supporto alla democrazia.
Naturalmente, legato a questi servizi intimi era lo status di non-persona di chi li svolgeva. [A questo proposito è disponibile lo studio di Judith Rolling (1985), che sviluppa alcune osservazioni goffmaniane sulla
gestione della deferenza e del contegno, NdC].
— 65 —
erving goffman
La donna bambina
Data la posizione subordinata dei bambini, sottomessa alla mera
indulgenza degli adulti, appare evidente che «fare il bambino
piccolo» consista nel richiamare su di sé un trattamento simile al
loro. In che misura s’incontra realmente nella vita un tale atteggiamento? È lecito chiederselo. Ciò che è sicuro è che lo s’incontra
nelle pubblicità.
La donna giocattolo
«Aspetta che ti prendo» è un gioco comunemente praticato tra adulti e bambini. Questi
ultimi sono scherzosamente trattati come prede assalite da un predatore. Nel corso
del gioco, certi oggetti (cuscini, getti d’acqua, palloni da spiaggia)
fungono da proiettili che colpiscono ma non feriscono mai. Degli altri
(letti, banchi di neve, pozze d’acqua, braccia) costituiscono altrettanti
rifugi dove gettare senza rischi il corpo del piccolo prigioniero. Ora,
si verifica che gli uomini fanno giochi simili con le donne, che vi
collaborano mostrando di fuggire, fingendo grida d’allarme, di paura
o di pacificazione. (Il ballo è un’occasione istituzionalizzata dove il
partner sollevato da terra non è mai l’uomo). È ben possibile inoltre che sotto la
superficie l’uomo si dedichi a una dimostrazione più profonda, tesa a suggerire
cosa sarebbe capace di fare semmai diventasse serio.
La donna giocosa
La nota buffa provocata dalle attitudini infantili può essere causata ancora da un’altra maschera del sé, limitata forse al dominio
pubblicitario, che consiste nel rendere tutto il corpo strumento di
gestualità divertente, una sorta di marionetta-clown.
Felicità di donna
Abbiamo già sottolineato che le donne delle pubblicità tendono
più degli uomini a ritirarsi dalla situazione sociale che le circonda,
comprese le loro reazioni emozionali. Tra esse, ci sono quelle che
traducono il piacere, la meraviglia, la gioia, l’allegria, altrettanti modi
di essere trasportati dalla felicità. Il loro senso è forse che la donna
— 66 —
La ritualizzazione della femminilità
– come un bambino che mangia un gelato – è capace di trovare una sorta di
soddisfazione ultima e definitiva nell’ambito degli obiettivi totalmente realizzabili
nell’istante presente19. Si tratta, in un certo senso, di un’euforia che consuma.
Rituale e sovraritualizzazione
Abbiamo dunque appena messo in luce alcune espressioni «naturali» della femminilità e della maschilità, per quanto si lascino rappresentare nelle immagini
pubblicitarie attraverso l’interpretazione di stili di comportamento visualmente
percepibili. Esaminandole nell’insieme mi pare che tali espressioni appaiano
come altrettante illustrazioni di unità comportamentali di tipo rituale, ritratti di una
concezione ideale dei due sessi e delle loro relazioni strutturali in parte realizzati
grazie all’indicazione, ancora ideale, dell’atteggiamento degli attori all’interno
della situazione sociale.
Certo le fotografie pubblicitarie vengono costruite mediante pose accuratamente studiate per apparire «del tutto naturali». Ma io sostengo che le espressioni
reali della femminilità e della maschilità procedano anch’esse attraverso pose
artificiali, nel senso etimologico del termine.
Qual è dunque, dal punto di vista della ritualità, la differenza tra le scene che ci dipingono le pubblicità e quelle della realtà? La nozione di «iperritualizzazione» costituisce una prima risposta. In effetti la standardizzazione,
l’esagerazione e la semplificazione che caratterizzano le forme rituali in generale si ritrovano nelle pose pubblicitarie, ma elevate a un grado superiore
e spesso messe allo stesso livello dell’infantilismo, della derisione etc. D’altra
parte, ci sono i processi di montaggio. Una fotografia pubblicitaria costituisce
una ritualizzazione degli ideali sociali tale per cui tutto ciò che ostacola la
19
Komisar sviluppa un’idea analoga (Komisar 1972, 306-307). Credendo
��������������������������������������
alle pubblicità della televisione, la maggior parte delle americane cade in estasi incontrollabili nel vedere o sentire l’odore di tavole
o credenze che hanno amorosamente impregnato della carezza di cere vaporizzabili, persistenti, lucidanti
e al profumo di limone. Sono rapite dall’estasi di fronte al candore abbagliante della loro biancheria – e
l’invidia nera delle loro vicine. La casalinga che ci mostra la pubblicità per la cera Johnson abbraccia la
tavola della sala da pranzo che brilla così meravigliosamente; poi dà la cera al pavimento finché, dopo
essersi imprigionata nell’ultimo angolo, deve saltare sui mobili per uscire. E un certo detersivo ci fa vedere una donna profondamente depressa perché la sua biancheria non brilla quanto quella della vicina.
Sottolineiamo inoltre che certe pubblicità, invece di mostrarci la meraviglia di una donna che riceve un
regalo da parte di un uomo, ci fanno vedere talvolta la scena precedente, cioè quella dell’«Indovina!»,
dove l’uomo possiede qualcosa che la donna (che a volte è obbligata a chiudere gli occhi) non può
vedere, e la tormenta perché lei indovini l’oggetto che sta per arricchirne l’esistenza e che la sprofonda
in un tale stato di gioioso supplizio. In un’altra versione, il donatore fa saltar fuori il suo regalo senza
avvertimenti, con la conseguenza che la beneficiaria perde provvisoriamente ogni controllo di sé e va in
visibilio dal piacere. Questa dispettosa generosità è del resto praticata comunemente dai genitori verso
i loro bambini, e conviene accostarla a quell’equilibrio precario che è l’aggressione scherzosa di cui
abbiamo parlato. [Goffman riporta questa configurazione all’estensione del «complesso genitori-figli» al
rapporto tra uomini e donne, si veda Goffman (1977 e soprattutto 1979, cap. 1), NdC].
— 67 —
erving goffman
manifestazione dell’ideale è stato rimosso e soppresso. Nella vita ordinaria,
in compenso, abbiamo un bel lavorare incessantemente per produrre delle
simili espressioni «naturali», senza arrivarci che per mezzo di certi stili di comportamento, o in certi particolari istanti delle nostre attività: brevi cerimonie,
espressioni di simpatia, riunioni amichevoli e così via, distribuiti nel nostro
giro quotidiano secondo un piano che conosciamo ancora poco. In breve, sia
nelle pubblicità sia nella vita noi vogliamo pose brillanti, vogliamo la nostra
esteriorizzazione. Nella vita, però, buona parte della pellicola è senza interesse. Ciò nonostante, sia che posiamo per una fotografia o che eseguiamo una
reale azione rituale, ciò che mettiamo in scena ha un carattere commerciale,
nel senso che si tratta di una rappresentazione ideale prodotta con l’auspicio
che possa essere giudicata una descrizione della realtà delle cose. Ogni volta
che un uomo reale accende la sigaretta di una donna reale, il suo gesto presuppone che le donne siano oggetti di valore, in qualche modo fisicamente
limitate e cui è bene prestare costante aiuto. Ma questa espressione «naturale»
della relazione tra i sessi forse, questo piccolo rito interpersonale, potrebbe
non essere il riflesso reale di questa relazione più di quanto la coppia di una
pubblicità di sigarette non sia una coppia rappresentativa. Le espressioni naturali non sono altro che scene commerciali, portate a termine al fine di vendere
una certa versione del mondo in condizioni non meno discutibili e insidiose
di quelle che affrontano i pubblicitari.
In generale dunque i pubblicitari non creano le espressioni ritualizzate
che usano. Essi al contrario sfruttano lo stesso corpus di esibizioni, lo stesso
idioma rituale che funge da risorsa per tutti noi che partecipiamo alle situazioni
sociali, e lo fanno con lo stesso scopo: rendere leggibile un’azione altrimenti
ambigua. Il compito specifico dei pubblicitari sta nel rendere convenzionali le
nostre convenzioni, stilizzare quanto è già stilizzato, fare un uso frivolo di immagini già ampiamente decontestualizzate. In breve le loro iperboli sono una
forma di «iper-ritualizzazione».
(Traduzione di Roberta Sassatelli)
Bibliografia
Bakhtin, M. (1986) Speech, Genres and Other Late Essays, Austin, University of Texas Press.
Bateson, G. e Mead, M. (1942) The Balinese Character, New York, New York Academy of
Science.
Becker, H.S. (1974) Photography and Sociology, in «Studies in the Anthropology of Visual
Communication», 1, pp. 3-26.
Belknap, P. e Leonard, W.M. (1991) A Conceptual Replication and Extension of Erving Goffman’s Study of Gender Advertisements, in «Sex Roles», 25 (314), pp. 103-118.
— 68 —
La ritualizzazione della femminilità
Bell, P. e Milic, M. (2002) Goffman’s Gender Advertisements Revisited: Combining Content
Analysis with Semiotic Analysis, in «Visual Communication», 1 (2), pp. 203-222.
Berger, J. (1972) Questione di sguardi, trad. it. Milano, Il Saggiatore, 2002.
Chadwick, M. (1988) Gender and Symbol in Advertising Imagery: A Comparison of Goffman
and Williamson, Salford, University of Salford.
Chance, M.R.A. (1962) An Interpretation of Some Agonistic Postures: The Role of «Cut-Off» Acts
and Postures, in «Symposium of the Zoological Society of London», 8, pp. 71-89.
Emmison, M. e Smith, P. (2000) Researching the Visual, London, Sage.
Garfinkel, H. (1967) Agnese, trad. it. Roma, Armando, 2000.
Goffman, E. (1959) La vita quotidiana come rappresentazione, trad. it. Bologna, Il Mulino,
1969.
Goffman, E. (1967) Il rituale dell’interazione, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1988.
Goffman, E. (1974) Frame Analysis. L’organizzazione dell’esperienza, trad. it. Roma, Armando, 2001.
Goffman, E. (1977) The Arrangement Between the Sexes, in «Theory and Society», 4, pp.
301-332.
Goffman, E. (1979) Gender Advertisements, Cambridge, Harvard University Press; New York,
Harper and Row; prima edizione in «Studies in the Anthropology of Visual Communication», 3, 1976, pp. 69-l54.
Goffman, E. (1981) Forms of Talk, Philadelphia, University of Pennsylvania Press; Oxford,
Basil Blackwell.
Goldman, R. (1992) Reading Ads Socially, London, Routledge.
Henley, N.M. (1977) Body Politics: Power, Sex and Non Verbal Communication, Englewood
Cliffs, Prentice Hall.
Hoggart, R. (1979) Introduction, in Goffman (1979).
Hughes, E. (1945) Dilemmas and Contradictions of Status, in «American Journal of Sociology»,
50, pp. 353-359.
Hunt, P. (1980) Review of Gender Advertisements, in «The Sociological Review», 28, pp.
442-444.
King, M.E. (1997) The Portrayal of Women’s Images in Magazine Advertisements: Goffman’s
Gender Analysis Revisited, in «Sex Roles», 37 (11/12), pp. 979-96.
Klassen, M.L., Jasper, C.R. e Schwartz, A.M. (1993) Men and Women: Images of Their Relationship in Magazine Advertisements, in «Journal of Advertising Research», 33 (2),
pp. 30-39.
Komisar, L. (1972) The Image of Woman in Advertising, in V. Gornick e B.K. Moran (a cura
di), Woman in Sexist Society: Studies in Power and Powerlessness, New York, New
American Library.
Kuhn, A. (1980) Review of Gender Advertisements, in «Sociology», 14, pp. 315-316.
McGregor, G. (1995) Gender Advertisements Then and Now: Goffman, Symbolic Interactionism
and the Problem of History, in «Studies in Symbolic Interaction», 17, pp. 3-42.
Milburn, S.S., Carney, D.R. e Ramires, D.M. (2001) Even in Modern Media, the Picture is Still
the Same, in «Sex Roles», 44 (5/6), pp. 277-294.
Mulvey, L. (1975) Visual Pleasure and Narrative Cinema, in «Screen», 16 (3), pp. 6-18.
Nava, M., Blake, A., MacRury, I. e Richards, B. (a cura di) (1997) Buy this Book: Contemporary
Issues in Advertising and Consumption, London, Routledge.
Pignotti, L. e Mucci, E. (1978) Marchio & femmina. La donna inventata dalla pubblicità,
Firenze, Vallecchi.
Polley, R.W. (1986) The Distorted Mirror: Reflections on the Unintended Consequences of
Advertising, in «Journal of Marketing», 50, pp. 18-36.
— 69 —
erving goffman
Robinson, D.E. (1976) Fashions in Shaving and Trimming of the Beard: The Men of the Illustrated London News, 1842-1972, in «American Journal of Sociology», 81 (5), pp.
1133-1141.
Rolling, J. (1985) Between Women: Dometics and Their Employers, Philadelphia, Temple
University Press.
Rose, G. (2007) Visual Methodologies, seconda edizione, London, Sage.
Rutledge Shields, V. (1997) Selling the Sex that Sells: Mapping the Evolution of Gender Advertising Research Across Three Decades, in B.R. Burleson e A.W. Kundel (a cura di),
Communication Yearbook 20, Thousands Oaks, Sage.
Sassatelli, R. (2006a) La ritualizzazione dei codici visuali di genere. Goffman e la femminilità in pubblicità, in L. Bovone e L. Ruggerone (a cura di), Che genere di moda?,
Milano, Angeli.
Sassatelli, R. (2006b) Corpi Ibridi. Sesso, genere, sessualità, in «Aut Aut», 330 (2), pp. 29-57.
Smith, G.W.H. (1996) Gender Advertisements Revisited: A Visual Sociology Classic?, in «Electronic Journal of Sociology», disponibile sul sito: www.sociology.org/content/vol002.001/
smith.html (marzo 2010).
Stacey, J. e Thorne, B. (1985) The Missing Feminist Revolution in Sociology, in «Social Problems», 31, pp. 301-316.
Sudnow, D. (1972) Temporal Parameters of Interpersonal Observation, in Id. (a cura di),
Studies in Social Interaction, New York, The Free Press.
Trevino, A.J. (2003) Goffman’s Legacy, Oxford, Rowman & Littlefield.
Wedel, J.M. (1978) Ladies, We’ve Been Framed! Observations on Erving Goffman’s The Arrangement between the Sexes, in «Theory and Society», 5, pp. 113-125.
Weisstein, N. (1973) Why We Aren’t Laughing Any More, in «Ms Magazine», 2, pp. 49-90.
Wernick, A. (1991) Promotional Culture: Advertising, Ideology and Symbolic Expression,
London, Sage.
West, C. e Zimmerman, D.H. (1987) Doing Gender, in «Gender and Society», 1 (2), pp. 125151.
West, C. (1996) Goffman in Feminist Perspective, in «Sociological Perspectives», 39 (3), pp.
353-369.
Williams, R. (1988) Understanding Goffman’s Methods, in P. Drew e A. Wootton (a cura di),
Erving Goffman: Exploring the Interaction Order, Boston, Northeastern University
Press.
Williamson, J. (1978) Decoding Advertisements, London, Marion Boyars.
Winkin, Y. (1990) Goffman et les femmes, in «Actes de la Recherche en Sciences Sociales», 83,
pp. 57-61.
Worth, S. (1976) Introduction to Gender Advertisements, in «Studies in the Anthropology of
Visual Communication», 3 (2), pp. 65-68.
Zaidman, C. (2002) Ensemble et séparés, in E. Goffman, L’arrangement des sexes, Paris, La
Dispute.
— 70 —