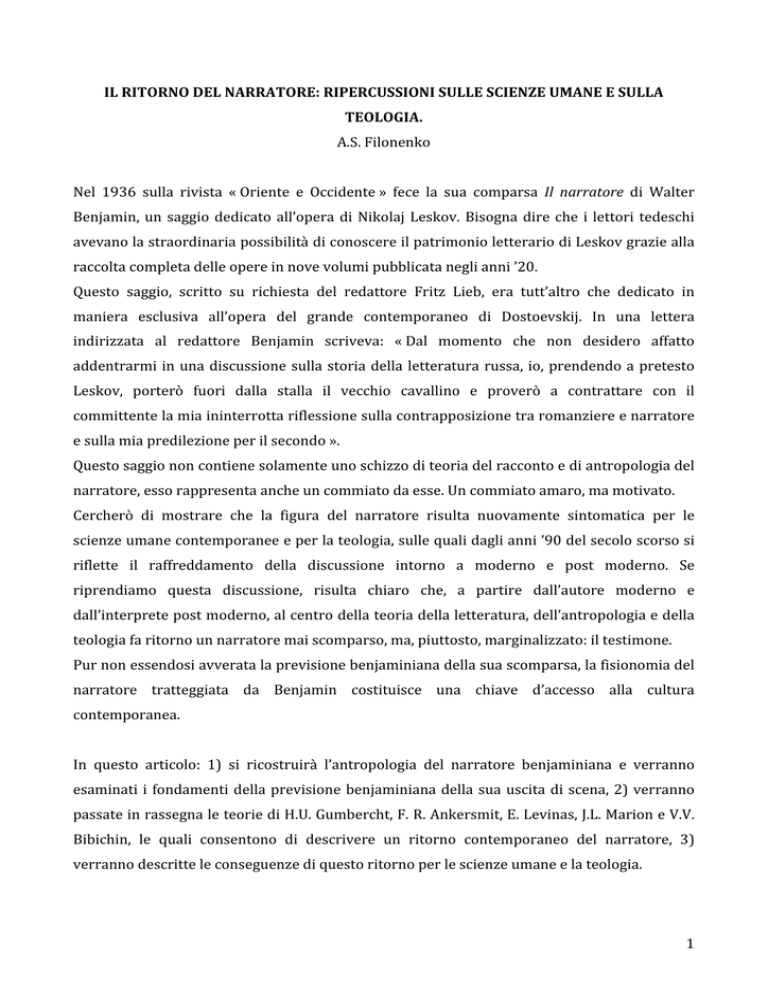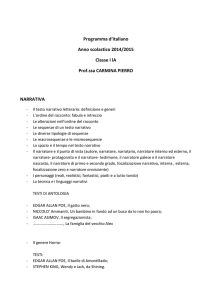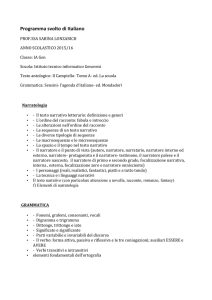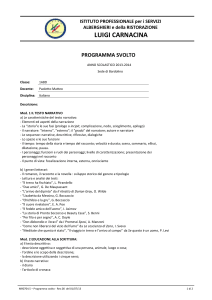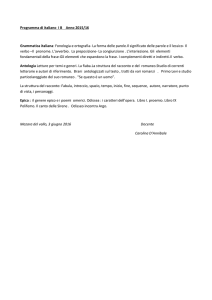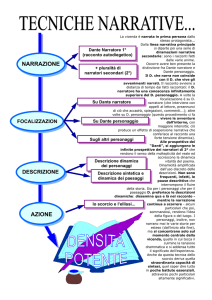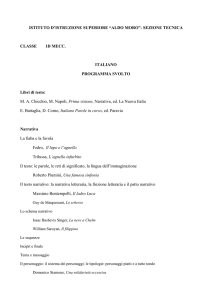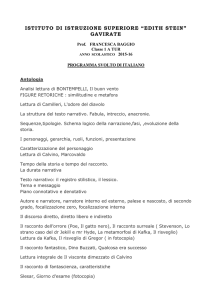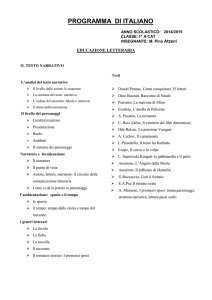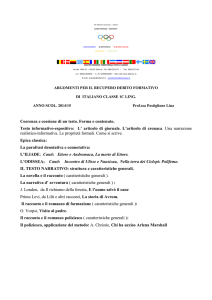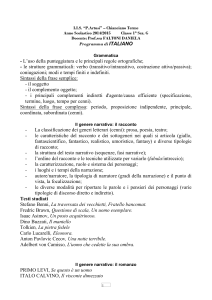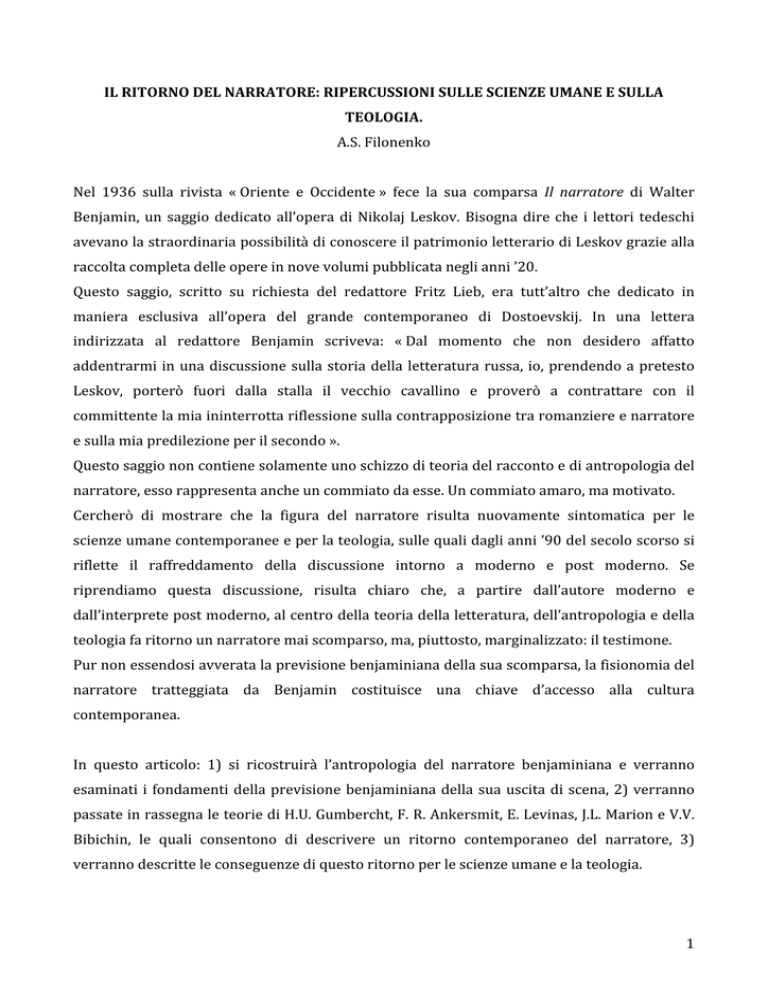
IL
RITORNO
DEL
NARRATORE:
RIPERCUSSIONI
SULLE
SCIENZE
UMANE
E
SULLA
TEOLOGIA.
A.S.
Filonenko
Nel
1936
sulla
rivista
«
Oriente
e
Occidente
»
fece
la
sua
comparsa
Il
narratore
di
Walter
Benjamin,
un
saggio
dedicato
all’opera
di
Nikolaj
Leskov.
Bisogna
dire
che
i
lettori
tedeschi
avevano
la
straordinaria
possibilità
di
conoscere
il
patrimonio
letterario
di
Leskov
grazie
alla
raccolta
completa
delle
opere
in
nove
volumi
pubblicata
negli
anni
’20.
Questo
saggio,
scritto
su
richiesta
del
redattore
Fritz
Lieb,
era
tutt’altro
che
dedicato
in
maniera
esclusiva
all’opera
del
grande
contemporaneo
di
Dostoevskij.
In
una
lettera
indirizzata
al
redattore
Benjamin
scriveva:
«
Dal
momento
che
non
desidero
affatto
addentrarmi
in
una
discussione
sulla
storia
della
letteratura
russa,
io,
prendendo
a
pretesto
Leskov,
porterò
fuori
dalla
stalla
il
vecchio
cavallino
e
proverò
a
contrattare
con
il
committente
la
mia
ininterrotta
riflessione
sulla
contrapposizione
tra
romanziere
e
narratore
e
sulla
mia
predilezione
per
il
secondo
».
Questo
saggio
non
contiene
solamente
uno
schizzo
di
teoria
del
racconto
e
di
antropologia
del
narratore,
esso
rappresenta
anche
un
commiato
da
esse.
Un
commiato
amaro,
ma
motivato.
Cercherò
di
mostrare
che
la
figura
del
narratore
risulta
nuovamente
sintomatica
per
le
scienze
umane
contemporanee
e
per
la
teologia,
sulle
quali
dagli
anni
’90
del
secolo
scorso
si
riflette
il
raffreddamento
della
discussione
intorno
a
moderno
e
post
moderno.
Se
riprendiamo
questa
discussione,
risulta
chiaro
che,
a
partire
dall’autore
moderno
e
dall’interprete
post
moderno,
al
centro
della
teoria
della
letteratura,
dell’antropologia
e
della
teologia
fa
ritorno
un
narratore
mai
scomparso,
ma,
piuttosto,
marginalizzato:
il
testimone.
Pur
non
essendosi
avverata
la
previsione
benjaminiana
della
sua
scomparsa,
la
fisionomia
del
narratore
tratteggiata
da
Benjamin
costituisce
una
chiave
d’accesso
alla
cultura
contemporanea.
In
questo
articolo:
1)
si
ricostruirà
l’antropologia
del
narratore
benjaminiana
e
verranno
esaminati
i
fondamenti
della
previsione
benjaminiana
della
sua
uscita
di
scena,
2)
verranno
passate
in
rassegna
le
teorie
di
H.U.
Gumbercht,
F.
R.
Ankersmit,
E.
Levinas,
J.L.
Marion
e
V.V.
Bibichin,
le
quali
consentono
di
descrivere
un
ritorno
contemporaneo
del
narratore,
3)
verranno
descritte
le
conseguenze
di
questo
ritorno
per
le
scienze
umane
e
la
teologia.
1
Benjamin:
il
commiato
dal
narratore.
Benjamin
dà
l’avvio
alla
sua
analisi
muovendo
dalla
descrizione
della
condizione
antropologica,
e
lo
fa
alla
lontana,
a
prima
vista,
a
partire
dalla
problematica
imprescindibile
e
minacciosa
della
cultura
europea
a
cavallo
delle
due
Guerre
mondiali.
Questa
situazione
consiste
nel
fatto
che
l’esperienza
quotidiana
«
ci
dice
che
l’arte
di
narrare
si
avvia
al
tramonto.
E’
sempre
più
raro
incontrare
persone
che
sappiano
raccontare
qualcosa
come
si
deve:
e
sempre
più
spesso
si
diffonde
l’imbarazzo
quando,
in
una
compagnia,
qualcuno
esprime
il
desiderio
di
sentir
raccontare
una
storia.
E’
come
se
fossimo
privati
di
una
facoltà
che
sembrava
inalienabile,
la
più
certa
e
sicura
di
tutte:
la
capacità
di
scambiare
esperienze
»1.
Nel
1971,
a
trentacinque
anni
dalla
pubblicazione
de
Il
narratore,
H.G.
Gadamer
scrisse
il
saggio
L’incapacità
del
comunicare
nel
quale
si
pose
un
problema
affine
a
quello
che
emerge
dalla
diagnosi
benjaminiana:
«
Sta
davvero
scomparendo
l’arte
del
colloquio?
Non
osserviamo
forse
nella
vita
sociale
del
nostro
tempo
un
crescente
monologare
del
comportamento
umano?
»2.
Constatando
un
«
calo
della
capacità
del
dialogo
»
nel
XX
secolo,
Gadamer
ne
individuò
la
causa
sia
nell’invenzione
del
telefono,
dal
momento
che
«
una
certa
brutalità
del
disturbare
resta
al
fondo
di
ogni
chiamata
telefonica,
anche
quando
il
partner
assicura
di
rallegrarsi
per
la
chiamata
»3,
sia
nella
sostituzione
dello
scambio
epistolare
con
la
videoscrittura;
estrapolando,
ricondusse
la
crisi
del
racconto
al
fatto
che
«
il
linguaggio,
quale
comune
medio
tra
gli
uomini,
decade
sempre
di
più,
nella
misura
in
cui
ci
siamo
sempre
più
adattati
alla
situazione
monologica
della
civiltà
scientifica
dei
nostri
giorni,
e
alla
tecnica
dell’informazione
anonima
alla
quale
siamo
assoggettati
»4.
Gadamer
mette
in
evidenza
la
straordinaria
importanza
del
colloquio:
«
Il
divenire
sempre
più
capaci
di
comunicare,
cioè
divenire
capaci
di
ascoltare
l’altro,
mi
sembra
essere
la
vera
e
propria
elevazione
dell’uomo
verso
la
vera
umanità
»5.
Al
di
fuori
del
colloquio
non
è
possibile
né
formazione
né
scambio,
né
soprattutto
«
un
discorso
che
sia
in
grado
di
trasfigurare
l’uomo
»,
dal
momento
che
«
non
il
fatto
che
siamo
venuti
a
sapere
qualcosa
di
nuovo
ha
fatto
di
qualcosa
un
colloquio,
piuttosto
il
fatto
che
nell’altro
ci
è
venuto
incontro
qualcosa,
che
nella
nostra
propria
esperienza
del
mondo
non
ci
era
ancora
capitato
di
incontrare
»6.
Per
l’autore
la
dissoluzione
del
colloquio
è
un
pericolo
evidente,
e,
pur
attribuendone
la
causa
oggettiva
al
monologismo
1
W.
Benjamin,
Il
narratore,
Einaudi,
Torino
2011,
p.
3.
2
H.G.
Gadamer,
L’incapacità
del
comunicare,
in
Verità
e
metodo
2,
Bompiani,
Milano
2010,
p.
175.
3
Ibi,
p.
176.
4
Ibi,
p.
182.
5
Ibidem.
6
Ibi,
p.
179.
2
tecnicista,
la
causa
soggettiva
di
una
crisi
di
questo
genere
risiede
nel
fatto
che
«
“incapacità
del
colloquio”
non
sembra
più
essere
il
rimprovero
che
uno
fa
a
colui
che
non
vuol
seguire
il
suo
proprio
pensiero,
quanto
piuttosto
la
mancanza
che
l’altro
realmente
possiede
»7.
E
sebbene
tale
causa
soggettiva
abbia
dato
un
input
alla
nascita
della
filosofia
dell’Altro,
rimane
tuttavia
incomprensibile
il
motivo
per
cui
tale
riluttanza
ad
ascoltare
l’altro
si
sia
manifestata
in
modo
così
sistematico
e
distruttivo
proprio
nel
XX
secolo.
Gadamer
fa
un
passo
indietro
di
fronte
alla
domanda
da
cui
Benjamin
comincia.
A
suo
avviso,
la
ragione
della
scomparsa
di
persone
che
siano
in
grado
di
sostenere
un
discorso
e
di
raccontare
una
storia
in
ogni
frangente
è
la
seguente:
«
Le
quotazioni
dell’esperienza
sono
crollate
»8.
Perché
ci
sia
racconto,
è
necessario
che
l’ascoltatore
abbia
stima
dell’esperienza
personale.
Noi
interroghiamo
e
ascoltiamo
perché
riteniamo
che
l’esperienza
personale
di
qualcun
altro
sia
rilevante
per
la
nostra
vita.
Questo
crollo
di
quotazioni
dell’esperienza
personale
è
diretta
conseguenza
della
Prima
guerra
mondiale:
«
Non
si
era
notato
che,
dopo
la
fine
della
guerra,
la
gente
tornava
dal
fronte
ammutolita,
non
più
ricca,
ma
più
povera
di
esperienza
comunicabile?
»9.
In
luogo
del
racconto,
un
duplice
ammutolimento.
Prima
di
tutto,
la
guerra
come
frattura
catastrofica
nella
vita
di
una
generazione
che
significò
uno
svuotamento
dell’esperienza
del
periodo
precedente
alla
frattura:
«
Una
generazione
che
era
ancora
andata
a
scuola
col
tram
a
cavalli,
si
trovava,
sotto
il
cielo
aperto,
in
un
paesaggio
in
cui
nulla
era
rimasto
immutato
fuorchè
le
nuvole,
e
sotto
di
esse,
in
un
campo
di
forze
attraversato
da
micidiali
correnti
ed
esplosioni,
il
minuto
e
fragile
corpo
dell’uomo
»10.
In
secondo
luogo,
la
stessa
esperienza
di
guerra
si
rivelò
falsa,
dal
momento
che,
al
fine
di
comprenderla
in
quanto
evento,
si
diffusero
tipi
di
analisi
statistica,
sociologica,
economica,
storica
e,
insomma,
qualunque
tipo
di
analisi
anonima,
tutto
fuorchè
«
esperienza
passata
di
bocca
in
bocca.
E
ciò
non
stupisce.
Poiché
mai
esperienze
furono
più
radicalmente
smentite
di
quelle
strategiche
dalla
guerra
di
posizione,
di
quelle
economiche
dall’inflazione,
di
quelle
fisiche
dalle
battaglie
caratterizzate
da
grande
dispiego
di
mezzi
e
materiali,
di
quelle
morali
dai
detentori
del
potere
»11.
7
Ibi,
p.
173.
8
W.
Benjamin,
cit.,
pp.
3‐4.
9
Ibi,
p.
4.
10
Ibidem
.
11
Ibidem.
3
Benjamin
scriveva
questo
nel
1936,
mentre
l’Europa
era
dinanzi
alla
ripetizione
del
medesimo
ammutolimento.
Giorgio
Agamben,
prendendo
in
esame
la
letteratura
dell’Olocausto,
rileva
che,
tra
coloro
che
erano
tornati
dal
lager,
si
erano
diffusi
due
tipi
di
reazioni:
«
Alcuni
dei
sopravvissuti
poi
preferiscono
tacere.
[...]
E
tuttavia,
per
altri,
non
far
morire
il
testimone
è
l’unica
ragione
di
vita
»12.
Anche
Benjamin
descrive
la
prima
reazione,
considerandola
un’uscita
di
scena
definitiva
del
racconto
dalla
letteratura
e
dalla
cultura.
Ma
la
seconda,
di
gran
lunga
meno
diffusa,
risulta
determinante
per
il
ritorno
del
narratore
in
chiave
contemporanea,
tramite
la
figura
del
testimone‐sopravvissuto
e
il
superamento
del
mutismo.
Scrive
Agamben
a
proposito
delle
fonti
del
secondo
tipo
di
reazione:
«
Nel
campo
una
delle
ragioni
che
possono
spingere
un
deportato
a
sopravvivere,
è
diventare
testimone
»13.
E’
significativa
la
notazione
di
Agamben
che,
dal
piano
giuridico,
muove
verso
una
dimensione
antropologica:
«
In
latino
ci
sono
due
parole
per
dire
il
testimone.
La
prima,
testis,
da
cui
deriva
il
nostro
termine
testimone,
significa
etimologicamente
colui
che
si
pone
come
terzo
(*terstis)
in
un
processo
o
in
una
lite
tra
due
contendenti.
La
seconda,
superstes,
indica
colui
che
ha
attraversato
qualcosa,
ha
attraversato
fino
alla
fine
un
evento,
e
può
dunque
renderne
testimonianza
»14.
Ma
per
Benjamin
è
però
fondamentale
un’altra
questione:
la
catastrofe
del
XX
secolo
ha
messo
in
dubbio
la
possibilità
di
un’esposizione
della
propria
vita,
possibilità
che
deriverebbe
da
un
colloquio
confidenziale
sull’esperienza
personale
dell’altro
uomo.
L’opinione
di
Benjamin
è
che
una
società
di
narratori
sia
andata
irrimediabilmente
perduta,
e
di
questo
si
debba
cercare
la
ragione.
Ne
Il
narratore,
egli
intende
mostrare
che
la
scomparsa
del
narratore,
di
cui
la
Prima
guerra
mondiale
non
è
altro
che
un
poderoso
evento
finale,
è
tutt’altro
che
un
fenomeno
recente:
l’intera
storia
della
modernità
è
uno
spostamento
progressivo
dal
racconto
al
romanzo15.
Così
Benjamin,
per
spiegare
in
modo
compiuto
l’antropologia
del
narratore,
e
per
descrivere
il
racconto,
opera
una
distinzione
tipologica
tra
racconto
e
romanzo,
individuando
la
loro
radice
comune
nell’epos16.
Egli
dispiega
un
insieme
di
opposizioni:
1)
Il
racconto
–
originato
dall’ascolto,
e
il
romanzo
–
originato
dall’individuo
nel
suo
isolamento.
«
Il
narratore
prende
ciò
che
narra
dall’esperienza
–
dalla
propria
o
da
quella
che
12
G.
Agamben,
Il
testimone,
in
Quel
che
resta
di
Auschwitz.
L’archivio
e
il
testimone,
Bollati
Boringhieri,
Torino
1998,
pp.
13‐14.
13
Ibi,
p.
13.
14
Ibi,
p.
15.
15
Cfr.
W.
Benjamin,
cit.,
p.
16
e
p.
18.
16
Cfr.
ibi,
p.
19,
p.
23,
e
pp.
56‐57.
4
gli
è
stata
riferita
–;
e
lo
trasforma
in
esperienza
di
quelli
che
ascoltano
la
sua
storia.
Il
romanziere
si
è
tirato
in
disparte
»17.
E
così,
l’uno
ha
a
che
fare
con
qualcuno
che
ascolta,
l’altro
con
un
lettore:
«
Chi
ascolta
una
storia
è
in
compagnia
del
narratore
[...]
mentre
il
lettore
di
un
romanzo
è
solo
»18.
Il
racconto
è
un
evento
comunitario,
mentre
il
romanzo
è
un
prodotto
dell’individualizzazione
ed
è
legato
alla
circolazione
del
libro,
leggibile
in
solitudine.
2)
Il
racconto
si
costituisce
sulla
base
di
un
interesse
verso
l’altro,
la
cui
autorità
porta
in
sé
qualcosa
di
lontano
e
di
meraviglioso.
La
forma
di
comunicazione
imparentata
con
il
romanzo,
l’informazione
su
ciò
che
è
più
prossimo
e
proprio,
tende
invece
alla
verosimiglianza19.
Il
libro
si
avvicina
progressivamente
alla
stampa.
Due
figure
tipiche
di
narratore
‐
l’agricoltore
sedentario
e
il
mercante
navigatore
–
che
si
trasformano
all’interno
della
bottega
artigianale
in
artigiano
sedentario
e
in
garzone
errante.
Nell’artigianato
medievale
«
la
conoscenza
dei
paesi
lontani
acquisita
da
chi
ha
molto
viaggiato
si
fondeva
con
quella
del
passato,
caratteristica
invece
dei
sedentari
»20.
3)
Il
racconto
si
costituisce
intorno
ad
avvenimenti,
evitando
spiegazioni
che
li
riducano
a
una
mera
fattualità:
«
E’
infatti
già
la
metà
dell’atto
di
narrare
lasciare
libera
la
storia,
nell’atto
di
riprodurla,
da
ogni
sorta
di
spiegazioni
»21.
Il
romanzo,
al
contrario,
nasce
da
fatti‐notizie
«
infarcite
di
spiegazioni
»22.
E
se
l’informazione
«
si
consuma
nell’istante
della
sua
novità
»23
e
«
vive
solo
in
quest’attimo
»24,
il
racconto
invece
«
non
si
esaurisce.
Esso
conserva
la
propria
forza
raccolta
e
sa
dispiegarsi
anche
dopo
lungo
tempo»25
scatenando
«
in
noi
meraviglia
e
riflessioni
»26.
4)
La
possibilità
del
racconto
si
dà
soltanto
all’interno
di
una
comunità
di
ascoltatori
riunita
da
quegli
aspetti
dell’attività
artigianale
che
sono
legati
alla
noia.
«
La
noia
è
l’uccello
incantato
che
cova
l’uovo
dell’esperienza
»27.
I
suoi
nidi
vengono
distrutti
perché
«
non
si
17
Ibi,
p.
19.
18
Ibi,
p.
66.
19
Cfr.
ibi,
pp.
23‐24.
20
Ibi,
p.
10.
21
Ibi,
p.
24.
22
Ibidem.
23
Ibi,
p.
27.
24
Ibidem.
25
Ibi,
p.
28.
26
Ibidem.
27
Ibi,
p.
34.
5
tesse
e
non
si
fila
più
ascoltando
le
storie
»28.
Il
dono
di
ascoltare,
legato
alla
possibilità
di
ascoltare
dimentichi
di
sé,
forma
«
una
rete
su
cui
si
fonda
l’arte
del
narrare
»29.
Il
romanzo
fiorisce
in
una
società
atomizzata,
che
non
ha
tempo
per
la
noia.
Il
ritmo
lento
del
racconto
scade
nella
«
short
story
»30.
5)
Il
racconto
è
legato
ad
una
società
in
cui
l’esperienza
della
morte
è
pubblica,
e
attraversa
la
vita
intera.
E,
soprattutto,
«
la
vita
vissuta
–
che
è
la
materia
da
cui
nascono
le
storie,
assume
forma
tramandabile
solo
nel
morente
»31.
La
rilevanza
della
morte
di
ogni
uomo
determina
l’autorità
di
ciò
che
ha
raccontato
ai
vivi
che
«
circondano
[il
suo
letto
di
morte]»32.
«
La
morte
è
la
sanzione
di
tutto
ciò
che
il
narratore
può
raccontare.
Dalla
morte
egli
attinge
la
sua
autorità
»33.
Il
racconto
muore
nella
società
borghese
che
tende
a
«
evitare
agli
uomini
la
vista
dei
morenti
»34
e
che
spinge/confina
la
morte
stessa
in
ospedali
e
sanatori,
lontano
«
dal
mondo
percettivo
dei
viventi
»35.
La
privatizzazione
della
morte
nell’Epoca
moderna
distrugge
il
racconto,
ma
allo
stesso
tempo
alimenta
il
romanzo,
scritto
per
un
uomo
che
non
sa
della
propria
morte.
6)
Il
senso
di
un
racconto
sta
nell’iniziativa,
che
si
stabilisce
a
partire
dall’ascolto
di
un
altro
narratore.
Il
narratore
non
è
né
un
autore
né
un
interprete,
bensì
sempre
un
testimone.
Nel
romanzo,
al
contrario,
la
produzione
di
senso
si
realizza
attraverso
la
sua
fine.
Il
commentatore‐interprete
arriva
dopo
la
fine.
Per
spiegarlo,
Benjamin
costruisce
un
ragionamento
di
questo
genere:
per
conoscere
«
il
significato
della
vita
»
di
un
uomo
di
cui
parliamo,
è
importante
sapere
quanti
anni
ha
vissuto.
E
così
se
ha
vissuto,
per
esempio,
trentacinque
anni,
allora
significa
che
ogni
giorno
della
sua
vita
è
il
giorno
della
vita
di
un
uomo
che
è
vissuto
fino
a
trentacinque
anni.
Se
lo
stesso
uomo
fosse
vissuto
fino
a
settant’anni,
allora
avremmo
valutato
i
suoi
primi
giorni
in
modo
completamente
diverso:
giorni
della
vita
di
un
uomo
di
settant’anni.
Il
problema
nel
quale
vive
l’individuo
moderno
è
il
seguente:
gli
risulta
impossibile
capire
il
senso
dell’oggi
perché
non
sa
quanto
a
lungo
vivrà.
Se
sapesse
con
precisione
che
la
sua
vita
sarà
quella
di
uomo
di
novant’anni,
allora
un
singolo
giorno
avrebbe
questo
carattere,
di
essere
in
relazione
con
una
vita
di
novant’anni,
nel
caso
28
Ibidem.
29
Ibi,
p.
35.
30
Ibi,
p.
39.
31
Ibi,
p.
44.
32
Ibidem.
33
Ibi,
p.
47.
34
Ibi,
p.
43.
35
Ibi,
p.
44.
6
invece
sapesse
che
la
sua
vita
sarà
quella
di
un
uomo
di
quaranta,
allora
un
singolo
giorno
avrebbe
quest’altro
carattere.
Ma
siccome
noi
non
sapremo
mai
quanto
vivremo,
ne
consegue,
secondo
Benjamin,
il
sorgere
della
forma
romanzesca,
grazie
alla
quale
possiamo
vivere
la
vita
di
un
altro
uomo,
l’eroe
del
romanzo,
una
vita
conchiusa
e
delimitata
entro
un
arco
di
tempo
dato:
“Quel
destino
altrui,
grazie
alla
fiamma
da
cui
è
consumato,
genera
in
noi
il
calore
che
non
possiamo
mai
ricavare
dal
nostro.
Ciò
che
attira
il
lettore
verso
il
romanzo,
è
la
speranza
di
riscaldare
la
sua
vita
infreddolita
alla
morte
di
cui
legge
»36.
Benjamin
lega
la
privatizzazione
della
morte
al
fatto
che
il
romanzo
ha
sempre
una
fine,
la
morte
dell’eroe,
oppure
la
fine
del
libro
in
senso
letterale.
Anche
per
questo,
il
romanzo
è
essenzialmente
legato
al
libro.
La
presenza
pubblica
della
morte,
legata
al
racconto,
offre
una
struttura
inversa
della
domanda.
Se
leggiamo
i
romanzi
per
arrivare
alla
fine,
domandandoci
“Come
si
conclude
tutto
questo?”,
il
racconto,
invece
(prendiamo
come
modello
la
narrazione
di
Sherazade),
offre
la
possibilità
di
chiedere
“E
dopo
cos’è
successo?”.
7)
Il
romanzo
e
il
racconto
sono
connessi,
ciascuno
a
suo
modo,
alle
fonti
storiografiche.
Per
Benjamin
la
storiografia
rappresenta
«
il
punto
di
indifferenza
creativa
di
tutte
le
forme
dell’epica
»37
e
sta
ad
esse
«
come
la
luce
bianca
ai
colori
dell’iride
»38.
E
se
il
racconto
è
legato
alle
cronache
e
ai
cronisti,
che
descrivono
i
fatti,
rifuggendo
dalle
interpretazioni,
che
appartengono
al
cielo,
il
romanzo
è
invece
legato
agli
storici
che
tentano
di
dare
una
dimostrazione
esplicativa
dell’avvenimento.
8)
La
memoria
del
romanziere
è
legata
«
all’eternità
rispetto
a
quella
dilettevole39
del
narratore
»40,
che
si
apre
all’interesse
dell’ascoltatore
«
di
conservare
ciò
che
è
narrato
»41
in
vista
della
«
possibilità
della
riproduzione
»42.
«
Quanto
più
dimentico
di
sé
l’ascoltatore,
quanto
più
a
fondo
si
imprime
in
lui
ciò
che
ascolta
»43.
E
se
la
memoria
è
il
dono
epico
per
eccellenza
–
perciò
Mnemosine
è
la
musa
della
poesia
epica
–
questo
principio
“musico”
compare
sotto
forme
differenti
nel
romanzo
e
nel
racconto.
Nel
racconto
esso
agisce
come
ricordo,
volto
a
«
creare
la
rete
che
tutte
le
storie
finiscono
per
formare
tra
loro
»44.
Nel
36
Ibi,
p.
67.
37
Ibi,
p.
51.
38
Ibidem.
39
Nel
testo
dell’articolo
si
legge
«
korotkij
»
cioè
«
breve
»
(N.d.T.)
40
Ibi,
p.
57.
41
Ibi,
p.
56.
42
Ibidem.
43
Ibi,
pp.
34‐35.
44
Ibi,
p.
57.
7
romanzo
interviene
come
rammemorazione
del
romanziere
che
mantiene
l’unità
della
storia,
caduta
fuori
dalla
rete
dell’epos.
9)
Il
racconto
rappresenta
una
«
forma
di
comunicazione
artigianale
»
immersa
nella
vita
del
narratore.
«
Il
racconto
reca
il
segno
del
narratore
come
una
tazza
quello
del
vasaio
»45.
Se
nel
romanzo
la
voce
è
autonoma,
nel
racconto
il
mondo
si
rivela
come
moltitudine
di
voci
tese
alla
ricerca
di
un
accordo:
un
aspetto
di
questo
accordo
consiste
nella
consonanza
di
anima,
occhi
e
mani
del
narratore,
come
unione
di
aspetto,
voce
e
gesti.
Il
narratore,
per
usare
il
lessico
dell’artigiano,
ha
«
il
compito
di
lavorare
la
materia
prima
delle
esperienze
–
altrui
e
proprie
–
in
modo
solido,
unico
e
irripetibile
»46.
10)
Se
il
romanziere
parte
dalla
verosimiglianza
dell’esperienza
individuale,
il
narratore
invece
spalanca
la
scala
dell’esperienza
collettiva
«
per
cui
anche
la
scossa
più
profonda
di
ogni
esperienza
individuale
–
la
morte
–
non
rappresenta
affatto
uno
scandalo
o
un
limite
»47.
Questa
scala
«
sprofonda
nell’abisso
dell’inanimato
»48
ma
si
innalza
verso
la
testimonianza
del
giusto
e
si
regge
sull’autorità
della
venerazione,
che
è
andata
perduta
nel
romanzo.
«
Il
narratore
entra
fra
i
maestri
e
i
saggi.
[...]
Il
narratore
è
la
figura
in
cui
il
giusto
incontra
se
stesso
»49.
E
così
tutti
i
tratti
distintivi
del
racconto
e
del
romanzo
fungono,
in
Benjamin,
da
argomentazioni
per
un’unica
tesi
forte:
la
cultura
europea,
da
un
lato
si
è
ritirata
dalle
arti,
andando
verso
l’industria
borghese,
dall’altro
si
è
trovata
davanti
alla
Catastrofe
del
XX
secolo,
momento
in
cui
l’esperienza
personale
cessa
di
essere
significativa
per
l’altro,
e
non
aiuta
più
ad
affrontare
l’esperienza
di
una
catastrofe
di
tali
dimensioni.
E
così
il
narratore
è
scomparso.
Che
cos’è
comparso
al
suo
posto?
A
questa
domanda
risponde
indirettamente
J.F.
Lyotard,
quando
nel
1979
ne
La
condizione
postmoderna,
distingue
i
racconti
tradizionali,
l’analisi
dei
quali
si
avvicina
a
quella
di
Benjamin,
dai
grandi
racconti,
che
svolgono
la
funzione
di
legittimazione
moderna
della
conoscenza
e
della
scienza.
La
modernità,
secondo
Lyotard,
conduce
ad
una
legittimazione
della
conoscenza
e
della
scienza
attraverso
due
tipi
di
grandi
racconti:
il
discorso
speculativo
sulla
dialettica
dello
Spirito
e
il
45
Ibi,
p.
37.
46
Ibi,
p.
85.
47
Ibi,
p.
71.
48
Ibi,
p.
78.
49
Ibi,
p.
86.
8
discorso
sulla
liberazione.
Il
soggetto
di
questi
racconti
è
sempre
uno,
sia
esso
il
popolo
oppure
lo
Spirito,
in
lui
confluiscono
i
ruoli
di
narratore,
ascoltatore
e
relatore,
ed
è
questo
a
distinguere
i
grandi
racconti
moderni
dai
tradizionali,
che
la
modernità
ha
rigettato:
«
I
rappresentanti
della
nuova
legittimazione
“popolare”
sono
anche
gli
affossatori
dei
saperi
popolari
tradizionali,
concepiti
ormai
come
minoranze
o
potenziali
separatismi
necessariamente
votati
all’oscurantismo
»50.
La
modernità
distrugge
la
cultura
dei
racconti
tradizionali,
la
cui
forma
narrativa
si
contrappone
alla
lingua
nozionale
della
scienza,
ma
per
legittimare
la
scienza
stessa
costruisce
la
sua
grande
narrativa.
Per
Benjamin,
a
questo
corrisponde
la
relazione
tra
romanzo
e
racconto.
I
grandi
racconti
della
modernità,
espungendo
il
narratore,
hanno
di
fatto
legittimato
generi
narrativi
basati
su
una
autodeterminazione
dello
Spirito.
Dopo
la
seconda
guerra
mondiale,
la
loro
distruzione
definisce
a
sua
volta
la
condizione
postmoderna,
nella
quale
«
la
grande
narrazione
ha
perso
credibilità,
indipendentemente
dalle
modalità
di
unificazione
che
le
vengono
attribuite,
sia
che
si
tratti
di
racconto
speculativo,
sia
di
racconto
emancipativo
»51.
Per
Lyotard,
è
evidente
che
«
il
ricorso
alle
grandi
narrazioni
è
escluso;
non
si
sarebbe
più
in
grado
di
ricorrere
né
alla
dialettica
dello
Spirito,
né
all’emancipazione
dell’umanità
per
la
validazione
del
discorso
scientifico
postmoderno.
Ma
[...]
la
“piccola
narrazione”
resta
la
forma
per
eccellenza
dell’invenzione
immaginativa,
innanzitutto
nella
scienza
»52.
E’
curioso
che
solo
in
alcune
note
egli
tratti
il
tema
del
ritorno
benjaminiano
del
narratore
come
nuova
possibilità
di
legittimazione.
Tendendo
«
ad
una
idea
e
ad
una
pratica
di
giustizia
che
non
siano
legate
a
quelle
del
consenso
»53,
che
non
si
appoggino
sull’autonomia
degli
interlocutori
come
frammento
del
racconto
dell’emancipazione,
e
rivolgendosi
alla
politica
«
in
cui
saranno
ugualmente
rispettati
il
desiderio
di
giustizia
e
quello
di
ignoto
»54,
Lyotard
invita
a
pensare
il
paralogismo
come
forma
del
ritorno
del
racconto
nel
discorso
della
legittimazione,
i
cui
elementi
caratterizzanti
sono
il
metodo
dei
sistemi
aperti,
il
localismo,
l’antimetodo,
la
performatività
e
così
via.
Dopo
l’esilio
del
narratore,
si
impongono
i
grandi
racconti
della
modernità
a
partire
dalla
loro
tensione
all’utopia,
ma
ad
essi,
in
compenso,
appartiene
l’ironia
postmoderna,
sbocciata
nel
50
J.F.
Lyotard,
La
condizione
postmoderna,
Feltrinelli,
Milano
1989,
p.
57.
51
Ibi,
p.
69.
52
Ibi,
p.
110.
53
Ibi,
p.
120.
54
Ibi,
p.
122.
9
momento
in
cui
«
la
nostalgia
della
narrazione
perduta
è
anch’essa
perduta
per
la
maggior
parte
della
gente
»55.
Il
postmoderno
sposta
nella
qualità
del
soggetto
della
cultura
la
figura
dell’interprete,
caratterizzata
dall’ironia
della
libertà
interiore,
ma
incapace
di
legittimare
un
nuovo
tipo
di
conoscenza.
Al
posto
dell’interprete,
fa
ritorno
un
narratore
che
realizza
il
paralogismo
lyotardiano
attraverso
la
testimonianza.
E
questa
differenza
tra
testimone
e
interprete
è
molto
rilevante
per
la
comprensione
della
figura
del
narratore.
Il
narratore
è
sempre
un
testimone.
Egli
è
un
interprete
solo
in
seconda
battuta,
e,
di
norma
l’interpretazione
è
un
fallimento
del
racconto.
Il
narratore
non
ricopre
il
ruolo
di
interprete
della
storia
che
racconta.
Benjamin
suggerisce
un
bell’esempio
in
proposito:
la
storia
che
racconta
Erodoto
a
proposito
del
faraone
d’Egitto
Psammenito,
fatto
prigioniero.
I
persiani,
nel
tentativo
di
umiliarlo,
condussero
davanti
a
lui
la
figlia
e
il
figlio,
ma
egli
non
pianse;
poco
dopo
condussero
un
servo,
ed
egli
scoppiò
a
piangere.
Erodoto
conclude
qui,
ma
Montaigne
riprende
la
storia
e
dà
un’interpretazione,
beninteso
non
unica,
sul
motivo
del
pianto
del
faraone.
Egli
può
aver
pianto
per
una
decina
di
motivi.
E
ognuno
può
trovare
da
sé
almeno
due
cause.
Benjamin
sottolinea
che
il
carattere
di
racconto
dipende
proprio
dal
fatto
che
Erodoto
non
ci
dice
il
motivo
esatto
per
cui
il
faraone
scoppia
in
pianto,
e
la
storia
resta
continuamente
meravigliosa
e
nuova.
Ogni
nuova
generazione,
attraverso
questa
storia,
scopre
qualcosa
sulla
propria
vita.
Perciò
l’interpretazione
per
il
narratore
è
uno
sbaglio,
un
depotenziamento
del
racconto56.
Presenza,
epifania,
gratitudine:
il
ritorno
del
narratore
nelle
scienze
umane.
Il
ritorno
del
narratore
è
legato
ad
un
generale
rinnovamento
delle
scienze
umane
cominciato
negli
anni
novanta.
Per
argomentare
questa
affermazione,
faccio
riferimento
ad
un’opera
programmatica
pubblicata
nel
2004,
Production
of
presence:
what
meaning
cannot
convey
di
Hans
Urlich
Gumbrecht,
critico
letterario
e
teorico
della
cultura
tedesco,
che
lavora
all’Università
di
Standford.
La
mossa
teoretica
di
questo
libro
muove
verso
il
superamento
della
crisi
nelle
scienze
umane
contemporanee,
le
quali,
secondo
Gumbrecht,
sono
chiuse
in
una
assolutizzazione
della
procedura
interpretativa.
Egli
si
muove
in
questa
direzione
per
«
prendere
fermamente
posizione
contro
l’abitudine
di
deviare
in
modo
sistematico
dalla
presenza
e
contro
la
posizione
assolutamente
incontrastata
che
occupa
l’interpretazione
55
Ibi,
p.
76.
56
Cfr.
W.
Benjamin,
cit.,
p.
28.
10
all’interno
di
quelle
discipline
accademiche,
che
si
chiamano
“scienze
umane
e
artistiche”
»57.
Siamo
in
una
situazione
in
cui
ogni
umanista
è
in
grado
di
fornire
decine
di
interpretazioni
per
ogni
testo,
e
tale
sovrapproduzione
è
condizionata
da
una
riduzione
della
conoscenza
umanistica
a
istituzione
al
servizio
della
macchina
interpretativa.
Gumbercht
mostra
che
questa
crisi
denota
una
caduta
al
di
fuori
dal
campo
interpretativo
dell’esperienza
della
presenza,
esperienza
produttiva
di
testi.
L’uscita
dalla
crisi
è
legata
ad
un
ritorno
dell’interrogativo
su
ciò
che
genera
la
testualità
della
presenza.
A
quel
punto
il
nucleo
delle
scienze
umane
si
sposta
dalla
domanda
sugli
effetti
del
significato,
al
problema
della
relazione
tra
gli
effetti
della
presenza
e
gli
effetti
del
significato.
L’analisi
della
presenza
che
viene
proposta,
rompe
«
con
la
tradizione
“postmoderna”
appassita
secondo
la
quale
sono
ammissibili
soltanto
i
concetti
e
le
argomentazioni
antisostanzialistiche
»58.
Lo
stesso
Gumbrecht
analizza
questo
cambiamento
epistemologico
nella
filologia,
nella
filosofia,
nell’estetica,
nella
storia
e
nella
pedagogia,
ma
il
suo
discorso
verte
non
soltanto
sull’ambiente
accademico,
ma
anche
sulla
nuova
sensibilità
culturale.
Descrivendo
le
fonti
della
crisi
contemporanea
delle
scienze
umane,
egli
sviluppa
uno
schema
tipologico
della
cultura
europea,
e
mette
in
evidenza,
all’interno
di
essa,
una
cultura
della
presenza,
prossima
all’epoca
medievale,
e
una
cultura
del
significato,
che
è
andata
diffondendosi
nell’Età
moderna,
e
che
ha
avuto
un
ruolo
centrale
nel
corso
del
XX
secolo.
Questa
schematizzazione
è
molto
simile
a
quella
di
Benjamin.
Il
confronto
tra
esse
autorizza
a
mettere
a
paragone
il
racconto
con
la
cultura
della
presenza,
e
il
romanzo
con
la
cultura
del
significato.
La
schematizzazione
si
struttura
anche
attraverso
l’accentuazione
di
significative
caratteristiche
tipologiche
oppositive:
1)
La
cultura
della
presenza
è
la
cultura
del
corpo,
la
cultura
del
significato,
con
il
dominio
del
paradigma
soggettivo/oggettivo,
è
la
cultura
dello
spirito,
o
della
coscienza.
2)
Il
corpo
è
incluso
nel
mondo
e
possiede
un
significato
intrinseco,
lo
spirito
come
soggetto
è
eccentrico
rispetto
al
mondo.
3)
Nella
cultura
della
presenza
la
conoscenza
è
manifesta
e
si
dà
come
effetto
dello
stesso
auto­schiudersi
del
mondo
(come
dono,
e
non
per
uno
sforzo
dell’uomo);
nella
cultura
del
significato
la
conoscenza
è
un
risultato
dell’attività
interpretativa
del
soggetto.
57
H.U.
Gumbrecht,
Proizvodstvo
prisutstvija:
čego
ne
možet
peredat
značenie,
Moskva,
Novoe
literaturnoe
obozrenie
2006,
p.
12
(Le
traduzioni
del
testo
di
Gumbrecht
che
seguono
sono
state
qui
tradotte
sulla
base
delle
citazioni
della
traduzione
russa
riportata
da
A.
Filonenko).
Cfr.
la
versione
inglese:
Production
of
presence:
what
meaning
cannot
convey,
Stanford
University
Press
2004.
58
H.U.
Gumbrecht,
cit.,
p.
30.
11
4)
La
cultura
della
presenza
si
dispiega
intorno
alle
cose
come
unità
di
sostanza
e
forma,
la
cultura
del
significato
intorno
ai
segni
come
unità
di
significante
e
significato.
5)
La
cultura
della
presenza
lega
l’uomo
al
cosmo
e
alla
sua
trasfigurazione,
della
quale
l’uomo
non
è
autore
ma
collaboratore;
per
la
cultura
del
significato
è
fondamentale
l’attività
umana
autonoma
e
la
trasformazione
del
mondo
è
il
compito
più
importante.
6)
La
«
produzione
della
presenza
»
si
dispiega
in
uno
spazio
configurato
come
insieme
di
luoghi
occupati
da
corpi,
mentre
gli
effetti
del
significato
presuppongono
un
dominio
del
tempo
come
attributo
della
coscienza.
7)
La
violenza
come
occupazione
dello
spazio
mediante
corpi
nella
cultura
della
presenza
e
il
potere
come
traccia
della
violenza
attuale
nella
cultura
del
significato.
8)
Nella
cultura
della
presenza
l’avvenimento
è
una
rottura
meravigliosa
della
continuità,
nella
cultura
del
significato
l’avvenimento
è
sorprendente
come
effetto
imprevisto
che
eleva
al
valore
dell’innovazione.
9)
Il
carnevale
della
corporeità
e
il
gioco/invenzione
come
lavoro
di
motivi
e
significati.
10)
L’Eucarestia,
nella
quale
«
è
generata
la
reale
presenza
di
Dio
»,
e
il
parlamento
nel
quale
vengono
prese
le
decisioni
non
tanto
sulla
base
della
presenza
fisica
dei
parlamentari,
quanto
sulla
base
della
dignità
intellettuale
di
concezioni
e
di
argomenti
in
competizione
fra
loro.
11)
L’opposizione,
legata
alla
differenza
tra
Eucarestia
e
parlamento,
tra
l’intensività
quantificabile
della
presenza
nel
realismo
platonico,
nella
cultura
della
presenza,
e
la
non
quantificabilità
logica
del
reale
nella
cultura
del
significato.
Gumbrecht
individua
la
possibilità
di
uscire
dalla
crisi
contemporanea
in
una
attualizzazione
della
sensibilità
della
cultura
della
presenza,
che
comporta
anche
il
ritorno
del
narratore.
Nel
nuovo
«
ambiente
intellettuale
»,
che
non
è
in
cerca
di
una
predominanza
paradigmatica
tra
gli
interpreti,
ma
di
una
«
produzione
della
presenza
»
nei
racconti
dei
testimoni,
si
apre
di
nuovo
la
cultura
della
presenza.
E’
curioso
che,
non
essendo
un
teologo,
Gumbrecht
sottolinei
l’eucaristicità
della
cultura
della
presenza,
e
che,
descrivendo
gli
effetti
della
presenza,
faccia
ricorso
alla
nozione
di
epifania.
Nella
sua
analisi
della
presenza,
egli
intende
mostrare
che
la
cultura
del
significato
è
stata
determinata
dall’ipotesi,
secondo
cui
la
realtà
stessa
è
oggettiva
e
passiva,
e
che
l’attività
del
soggetto
è
separata
dalla
realtà,
mentre
la
cultura
della
presenza
non
è
nata
da
un’attività
autonoma
del
soggetto,
bensì
come
risposta
all’attività
della
realtà.
La
produzione
della
presenza
è
essa
stessa
un’attività
della
realtà,
che
Gumbrecht
definisce
anche
epifania.
12
La
partizione
classica
propria
della
cultura
del
significato
legava
la
storia
all’estetica
e
alla
pedagogia,
così
che
la
storia
determinava
la
comprensione
del
valore
estetico
degli
oggetti
della
cultura,
che
a
sua
volta
conteneva
un
messaggio
etico,
il
quale
fungeva
da
fondamento
per
la
pedagogia59.
Nella
cultura
della
presenza
il
rapporto
tra
queste
discipline
è
rivelato
da
un’epifania
estetica
incommensurabile
rispetto
alle
norme
etiche,
ma
legata
alla
storia,
la
quale
si
occupa
non
di
un’interpretazione
storica,
bensì
della
«
presentificazione
dei
mondi
passati
»
e
delle
organizzazioni
degli
effetti
della
presenza
legati
a
tali
mondi.
L’estetica
e
la
storia
insieme
forniscono
gesti
deittici,
che
conducono
«
gli
studenti
a
momenti
di
complessità
intellettuale
»
realizzando
allo
stesso
tempo
una
pedagogia
universitaria
che
sorga
dall’attenzione
per
l’avvenimento
della
presenza
e
l’estetizzazione
della
storia60.
L’esperienza
estetica
come
tale
è
caratterizzata
da
otto
aspetti:
1)
esperienza
estetica
come
momento
di
intensità61;
2)
attrattiva
di
quei
momenti
legata
all’eccezionalità
rispetto
alla
sfera
della
quotidianità62;
3)
distanza
dell’esperienza
estetica
rispetto
al
mondo
della
quotidianità,
in
quanto
legata
alla
repentinità
e
alla
separazione;
la
posizione
“insulare”
dell’esperienza
estetica
porta
verso
una
incommensurabilità
di
essa
rispetto
all’impianto
istituzionale
delle
norme
etiche63;
4)
lo
stato
d’animo
corrispondente
all’esperienza
estetica
è
«
apertura
e
concentrazione
»,
«
smarrimento
dentro
una
intensità
concentrata
»64;
5)
esperienza
estetica
come
«
oscillazione
tra
gli
effetti
della
presenza
e
gli
effetti
del
significato
»65;
6)
l’esperienza
estetica
è
un’epifania
come
avvenimento
che
nasce
da
nulla
e
da
un
quando
ignoto,
che
si
dispiega
nello
spazio
attraverso
un
avvicinamento/allontanamento,
che
«
si
autoannienta
nel
processo
della
sua
origine
»66;
7)
l’esperienza
estetica
è
un
avvenimento
nel
corso
del
quale
«
una
sostanza
occupa
uno
spazio
»,
ma
questa
occupazione
è
violenza
come
«
attualizzazione
di
un
potere
»67;
59
Cfr.
H.U.
Gumbrecht,
cit.,
p.
98.
60
Cfr.
ibi,
p.
100.
61
Cfr.
ibi,
p.
101‐103.
62
Cfr.
ibi,
p.103.
63
Cfr.
ibi,
p.
105‐106.
64
Ibi,
p.
107‐108.
65
Ibi,
p.
110.
66
Ibi,
p.
114‐116.
67
Ibi,
p.
117.
13
8)
l’esperienza
estetica
preserva
«
dalla
perdita
completa
della
sensazione
e
della
memoria
della
fisicità
della
nostra
vita
»68,
e
conduce
verso
il
grado
estremo
di
imperturbabilità
serenità
e
quiete,
che
è
legato
«
all’autoschiudersi
dell’Essere
»69.
Non
è
difficile
accorgersi
della
somiglianza
tra
la
descrizione
del
soggetto
dell’esperienza
estetica
gumbrechtiana
e
l’ascoltatore
del
racconto
benjaminiano:
resta
però
oscuro
come
questo
ascoltatore
possa
trasformarsi
in
narratore.
Per
avvicinarsi
alla
risposta
a
questa
domanda,
bisogna
rilevare
i
fondamenti
della
costruzione
della
presenza.
Lo
stesso
Gumbrecht,
richiamandosi
nell’analisi
dell’esperienza
estetica
alla
violenza,
intesa
troppo
astrattamente
come
«
occupazione
e
ostruzione
dello
spazio
da
parte
dei
corpi
»70,
si
limita
ad
un’unica
forma
di
attività
della
realtà:
la
forma
della
violenza.
Questa
presenza
è
una
sfida
della
realtà,
sulla
quale
noi
non
abbiamo
nessun
potere,
ma
alla
quale
non
possiamo
non
rispondere.
Per
molti
teorici,
gli
avvenimenti
dell’undici
settembre
hanno
messo
fine
all’epoca
postmoderna,
dei
lenti
e
ironici
giochi
dell’interpretazione
dal
momento
che
la
realtà
si
è
disvelata
in
modo
catastrofico.
Ci
siamo
trovati
«
nel
deserto
della
realtà
».
La
presenza
come
violenza
predetermina
una
comprensione
della
cultura
come
sistema
di
difesa
dalla
realtà.
Questa
comprensione
della
cultura
pone
anche
un
rapporto
con
la
lingua
come
mezzo
di
difesa,
a
proposito
della
quale
lo
storico
olandese
Franklin
Rudolf
Ankersmit
scrive:
«
Noi
siamo
in
possesso
della
lingua
per
non
avere
esperienza,
per
evitare
pericoli
e
ansie
che
solitamente
sono
generati
dall’esperienza.
La
lingua
è
uno
scudo
che
ci
difende
da
quel
contatto
diretto
con
il
mondo
che
accade
nell’esperienza
»71.
Ciononostante,
la
mia
analisi
dell’epifania
non
si
colloca
in
questo
letto
di
Procuste
della
comprensione
della
presenza
come
violenza.
Gumbrecht
parla
di
sfuggita
di
due
modalità
dell’epifania
che
non
portano
verso
una
forma
di
violenza:
«
L’apertura
dell’Essere
può
compiersi
sia
nella
modalità
del
bello,
sia
nella
modalità
del
sublime:
[...]
essa
può
condurci
nello
stato
della
chiarezza
apollinea,
oppure
della
frenesia
dionisiaca
»72.
Bisogna
cominciare
l’analisi
dalla
perdita
del
dono
del
discorso
e
del
silenzio
dinanzi
alla
forma
sublime
della
presenza,
quando
il
reale
si
apre
attraverso
il
superamento
dell’orizzonte
esistenziale
tracciato
dalla
lingua.
Cercando
la
presenza
oltre
i
confini
del
significato,
noi
68
Ibi,
p.
119.
69
Ibi,
p.
120.
70
Ibi,
p.
117.
71
F.R.
Ankersmit,
Vozvyšennyj
istoričeskij
opyt,
Moskva,
Izdatel’stvo
“Evropa”,
2007,
p.
33.
Cfr.
la
versione
inglese:
F.R.
Ankersmit,
Sublime
historical
experience,
Stanford
University
press,
2005.
72
H.U.,
Gumbrecht,
cit.,
p.
120.
14
scopriamo
che
la
realtà
è
ciò
che,
secondo
Ankersmit,
«
anticipa
e
supera
il
mondo,
dato
a
noi
nella
lingua
e
attraverso
la
lingua.
E
per
quanto
possa
apparire
ridicolo,
accade
che
la
realtà
come
tale
e,
dunque,
il
passato
come
tale,
evochino
in
noi
il
terrore
».
Bisogna
ricordare
l’acuta
osservazione
di
Ankersmit
a
proposito
dell’appello
di
Nietzsche
a
lasciare
«
la
prigione
della
lingua
»:
«
Nietzsche
ha
dimenticato
di
aggiungere
che
la
prigione
della
lingua,
è
una
prigione
molto
confortevole,
dove
ci
sono
sempre
gas,
luce,
acqua
calda
e
fredda,
dove
sono
disposte
dappertutto
comode
poltrone,
e
letti
tiepidi
pronti.
D’altronde,
da
tempi
immemorabili
l’umanità
ha
fatto
sforzi
di
ogni
genere
per
rendere
la
prigione
della
lingua
il
più
confortevole
possibile
»73.
Presuntuosamente,
nello
spirito
dell’illuminismo,
tendendo
verso
la
realtà
oltre
i
confini
del
significato,
noi
scopriamo
il
sublime
attraverso
l’avvenimento
del
dolore,
della
perdita,
della
morte,
del
terrore,
della
sofferenza
e
della
tristezza,
che
aprono
il
«
mondo
del
trauma
»74.
L’epifania
del
sublime
ci
apre
alla
presenza
extra
linguistica.
Nella
lingua,
invece,
essa
si
manifesta
come
rottura,
che
si
esprime
nella
poetica
romantica
dell’infinito.
Da
questa
prospettiva
si
capisce
perché
il
superamento
del
radicalismo
linguistico
postmoderno
accada
mediante
il
ritorno
all’esperienza
e
alla
stessa
categoria
di
sublime,
che
era
nota
ben
prima
dell’undici
settembre.
Ma
esiste
un’altra
forma
di
presenza,
che
non
sia
riconducibile
alla
violenza
e
all’esperienza
sublime,
e,
rispettivamente,
una
cultura
che
non
conduca
soltanto
ad
una
difesa
dalle
sfide
della
realtà,
e
che
faccia
memoria
non
soltanto
delle
cicatrici
lasciate
dall’esperienza
del
sublime?
Bisogna
esaminare
questa
domanda
in
qualità
di
domanda
sul
bello
come
forma
della
presenza,
e
avvalersi
della
filosofia
dell’Altro,
all’interno
della
quale
la
cultura
può
essere
considerata
non
solo
come
difesa
dalla
sfida
della
realtà
‘altra’,
ma
anche
come
risposta
al
richiamo
dell’Altro.
La
presenza
dell’altro
può
manifestarsi
come
sfida
dell’Altro,
alla
quale
io
non
posso
non
rispondere,
oppure
come
richiamo
al
quale
io
posso
non
dare
risposta,
e
allora
la
risposta
è
libera
e
apre
la
mia
umanità.
La
cultura,
intesa
come
difesa
dalla
sfida,
non
è
‘piena’,
e
questo
è
del
tutto
evidente
nelle
concettualizzazioni
postmoderne
della
cultura.
E’
indubbiamente
prezioso,
quando
un
uomo
è
capace
di
difendere
se
stesso
e
la
propria
identità
dalle
sfide
catastrofiche
che
gli
stanno
di
fronte,
ma
il
problema
è
che,
difendendosi
dalle
sfide,
l’uomo
può
diventare
incapace
di
accorgersi
del
richiamo.
Una
società
di
persone
che
sono
73
F.R.
Ankersmit,
Vozvyšennyj
istoričeskij
opyt,
cit.,
p.
5.
74
Ibi,
p.
6.
15
perfettamente
in
grado
di
difendersi
dagli
appelli,
che
non
si
sentono
l’un
l’altro
e
che
non
sentono
Dio,
è
una
società
postmoderna.
La
crisi
della
relazioni
nella
società
individualizzata,
mette
in
questione
la
cultura
come
ascolto,
obbedienza
e
attenzione
al
richiamo
dell’Altro.
Cosa
rende
possibile
una
tale
cultura?
La
domanda
su
questa
cultura
–
una
domanda
sulla
possibilità
del
superamento
della
totalità
della
violenza,
è
posta
da
Emmanuel
Levinas
nella
prefazione
a
Totalità
e
infinito,
come
prima
questione
della
filosofia
dell’Altro.
Per
Levinas,
l’avvenimento
catastrofico
della
guerra
mette
a
nudo
la
realtà
della
violenza
che
«
non
consiste
tanto
nel
ferire
e
nell’annientare,
quanto
nell’interrompere
la
continuità
delle
persone,
nel
far
loro
recitare
delle
parti
nelle
quali
non
si
ritrovano
più,
nel
far
loro
mancare
non
solo
a
degli
impegni,
ma
alla
loro
stessa
sostanza
»75.
«
La
guerra
instaura
un
ordine
che
assorbe
la
totalità
della
persona
umana
»76,
e
«
in
essa
gli
individui
sono
ridotti
ad
essere
i
portatori
di
forze
che
li
comandano
a
loro
insaputa
»77.
La
guerra
sopprime
la
morale
ingenua
e
per
questo
il
tentativo
di
prevedere
la
minaccia
della
guerra
conduce
sovente
ad
una
contrapposizione
tra
una
morale
ingenua
e
una
politica
fredda:
«
La
politica
si
oppone
alla
morale,
come
la
filosofia
all’ingenuità
»78.
Ma
la
soluzione
politica
al
problema
della
guerra
è
illusoria,
dal
momento
che
lo
stesso
freddo
ordine
politico
è
nato
da
guerre.
«
La
pace
degli
imperi
prodotti
dalla
guerra
si
fonda
sulla
guerra.
Essa
non
restituisce
agli
esseri
alienati
la
loro
identità
perduta.
E’
necessaria
una
relazione
originaria
ed
originale
con
l’essere
»79.
Effettivamente,
il
tentativo
di
prevenire
la
catastrofe
della
violenza
mediante
una
neutralizzazione
dell’Altro,
ottenuta
situandolo
in
un
mondo
che
sia
sotto
il
nostro
controllo,
e
la
pace,
pensata
come
tregua
nella
guerra
globale,
sono
gravidi
del
trionfo
dell’anonimità
totale.
La
freddezza
della
politica,
che
tenta
di
porre
freno
alla
violenza
con
l’aiuto
di
una
forza
legittima,
determina
la
filosofia
della
guerra.
Ad
essa,
Levinas
contrappone
l’escatologia
della
pace,
che
procede
oltre
“ragionevolezza”
della
tregua
postbellica.
La
relazione
autentica
con
l’essere
è
escatologica,
poiché
si
colloca
al
di
là
della
totalità80.
Essa
«
sottrae
gli
esseri
alla
giurisdizione
della
storia
e
del
futuro
»
e
li
esorta,
li
sprona
«
verso
la
loro
piena
responsabilità
».
«
L’idea
dell’essere
che
va
oltre
i
confini
della
storia
rende
possibili
degli
ent’i
(étant’s)
impegnati
nell’essere
e,
nello
stesso
tempo,
personali,
chiamati
a
rispondere
al
loro
75
E.
Levinas,
Totalità
e
infinito,
Jaca
Book,
Milano
1996,
p.
20.
76
Il
testo
nella
traduzione
italiana
legge:
«
Essa
instaura
un
ordine
[...]
che
distrugge
l’identità
dello
stesso
».
Ibidem.
77
Ibidem.
78
Ibi,
p.
19.
79
Ibi,
p.
20.
80
Ibi,
p.
20‐21.
16
processo
e,
quindi,
già
adulti
ma,
per
ciò
stesso,
degli
ent’i
che
possono
parlare,
invece
di
offrire
le
labbra
ad
una
parola
anonima
della
storia.
La
pace
si
produce
in
questa
capacità
di
parola.
La
visione
escatologica
rompe
la
totalità
delle
guerre
e
degli
imperi
nella
quale
non
si
parla
»81.
La
cultura
che
poggia
sull’ascolto
dell’Altro,
presuppone
una
risposta
al
richiamo
dell’Altro,
e
un
discorso
che
vinca
le
divisioni
ma
si
prenda
cura
delle
differenze.
La
soggettività
ad
essa
corrispondente
si
configura
come
«
accoglienza
dell’Altro,
come
ospitalità
»82.
L’incontro
con
il
volto
dell’Altro,
ingiunge
il
“non
uccidere”:
quel
volto
implora
appunto
l’ospitalità,
dando
vita
alla
parola.
All’interno
di
una
parola
siffatta,
si
dispiega
una
successione
di
forme
corrispondenti
alla
cultura
dell’ascolto
del
richiamo:
una
tra
queste
è
la
forma
del
racconto.
La
prima
tra
queste
parole
è
la
parola
di
ringraziamento:
per
scoprirla
dobbiamo
rivolgerci
alla
fenomenologia
della
donazione
di
Jean‐Luc
Marion.
La
fenomenologia
del
ringraziamento
non
trae
origine
dalla
risposta
al
dono
dell’Altro,
bensì
dalla
scoperta
del
dono
stesso
al
centro
della
datità.
Se
la
fenomenologia
classica
ha
a
che
fare
non
con
i
doni,
ma
con
i
fenomeni‐dati,
nei
quali
il
dono
è
indistinguibile,
la
fenomenologia
di
Marion
aiuta
a
identificare
nel
fenomeno
la
donazione,
che
si
apre
nel
suo
darsi
irriducibile:
«
La
fenomenologia
non
comincia
con
l’apparire
o
con
l’evidenza
(altrimenti
rimarrebbe
identica
alla
metafisica),
ma
con
la
scoperta,
tanto
difficile
quanto
stupefacente,
che
l’evidenza
in
se
stessa
cieca,
può
diventare
lo
schermo
dell’apparire
–
il
luogo
della
donazione
»83.
Il
lavoro
del
ringraziamento
è
la
scoperta
del
dono
in
questo
mondo.
Ogni
giorno
abbiamo
a
che
fare
con
la
datità
di
questo
mondo,
ma
quando
oltre
la
datità
noi
riconosciamo
il
dono,
allora
questo
è
segno
del
lavoro
del
ringraziamento.
Il
Metropolita
Antonij
di
Surož
presenta
così
l’inizio
di
questo
lavoro:
«
Non
appena
noi
ci
rendiamo
conto
che
nulla
di
ciò
che
chiamiamo
‘nostro’
ci
appartiene,
e
allo
stesso
tempo
capiamo
che
è
DATO
a
noi
da
Dio
e
dagli
uomini,
intorno
a
noi
comincia
a
stabilirsi
il
Regno
di
Dio...
Se
fossimo
veramente
attenti
a
ciò
che
accade
nella
vita,
noi
potremmo
raccogliere
gratitudine
a
partire
da
tutto,
come
un’ape
raccoglie
il
miele.
Gratitudine
da
ogni
movimento,
dal
respiro
libero,
dal
cielo
aperto,
da
tutti
i
rapporti
umani...
E
allora
la
vita
diventerebbe
sempre
più
ricca,
man
mano
che
diventassimo
sempre
più
poveri.
Perché
quando
un
uomo
non
ha
più
nulla,
e
si
rende
conto
che
tutto
nella
vita
è
carità
e
amore
–
egli
è
già
entrato
nel
81
Ibi,
p.
21.
82
Ibi,
p.
25.
83
J.L.
Marion,
Dato
che.
Saggio
per
una
fenomenologia
della
donazione,
SEI,
Torino
2005,
p.
21.
17
regno
di
Dio
»84.
La
nostra
capacità
di
percepire
il
richiamo
è
la
capacità
di
scorgere
un
dono
meraviglioso
oltre
la
datità,
la
quotidianità,
il
grigiore
e
la
banalità
della
vita.
Meraviglioso
non
nel
senso
sentimentale,
ma
nel
preciso
senso
fenomenologico
della
parola,
come
ciò
che
conduce
fuori
dalla
mente
verso
l’incontro
infinito
con
l’Altro.
Il
lavoro
del
ringraziamento
indica
un’introduzione
alla
cultura
dell’ascolto
del
richiamo.
Il
mio
rapporto
con
l’esperienza
non
può
essere
descritto
dalla
fenomenologia
classica.
Non
si
tratta
di
mettersi
davanti
all’esperienza
del
reale;
tutto
sta
invece
nel
fatto
che
questa
esperienza
passi
attraverso
il
lavoro
del
ringraziamento
quale
incontro
con
la
donazione
come
dono.
E
allora
risulta
evidente
che
ad
ogni
sforzo
di
comprensione
prelude
l’operazione
della
grazia
che
si
manifesta
come
universale
e
primaria.
Dunque
possiamo
parlare,
se
seguiamo
Marion,
del
fatto
che
le
scienze
umane
contemporanee,
andando
in
cerca
della
produzione
della
presenza,
devono
aprire
nel
loro
fulcro
una
ermeneutica
eucaristica85.
Non
possiamo
più
parlare
di
ermeneutica
universale,
ad
esempio,
nello
spirito
di
Gadamer,
dal
momento
che
tale
ermeneutica
assolutizza
la
procedura
interpretativa.
Possiamo
però
parlare
di
un’ermeneutica
che
fa
memoria
della
sua
nascita
dall’esperienza,
e
questa
rammemorazione
–
è
il
lavoro
del
ringraziamento.
L’ermeneutica
eucaristica
indica
che
il
lavoro
del
ringraziamento,
che
precede
lo
sforzo
della
comprensione,
rende
evidente
questa
formula
di
relazione
tra
esperienza
e
narrazione.
L’ermeneutica
eucaristica
è
una
proposta
alternativa,
rispetto
alla
tesi
postmoderna
secondo
cui
noi
abbiamo
a
che
fare
con
testi,
testi
e
nient’altro
che
testi.
Per
l’ermeneutica
eucaristica
è
importante
osservare
come
la
parola
e
il
testo
nascano
dal
lavoro
del
ringraziamento.
Essa
è
anche
uno
spazio
teoretico,
all’interno
del
quale
è
possibile
pensare
un
racconto
che
nasca
da
ciò
che
è
stato
udito
nell’avvenimento
dell’incontro:
un
racconto
tale
che
unisca
l’esperienza
e
la
narrazione
all’interno
di
una
comunità
di
ascoltatori.
Forme
distinte
di
presenza
–
la
violenza,
la
sfida
del
sublime
e
il
richiamo
del
bello
–
e
le
forme
a
loro
corrispondenti
della
cultura
e
della
lingua,
permettono
di
fare
ritorno
alla
domanda
benjaminiana
sul
legame
tra
racconto
e
storiografia,
e
di
esaminare
il
ritorno
della
narrazione
nel
contesto
della
storiografia
postbellica.
Seguendo
Ankersmit
si
possono
distinguere
tre
forme
di
filosofia
della
storia:
una
filosofia
della
storia
epistemologica,
una
filosofia
della
84
Antonij,
mitropolit
Surožkij,
O
blagodarnost’,
in
Antonij,
mitropolit
Surožkij.
Ljubov’
vsepobeždajuščaja:
propovedi,
proiznesennye
v
Rossii,
SPb,
Satis
1994,
pp.
149‐156.
85
Cfr.
J.L.
Marion,
Dio
senza
essere,
Jaca
Book,
Milano
1987.
18
storia
narrativa86,
e
una
filosofia
dell’esperienza
storica
sublime.
La
filosofia
della
storia
epistemologica
è
moderna,
descrittiva
e
critica.
Essa
distingue
quale
unità
interpretativa
la
dichiarazione
dal
fatto
storico,
ed
è
tesa
a
rispondere
alla
domanda
sulla
veridicità
di
queste
dichiarazioni87.
Da
questa
prospettiva,
è
evidente
la
sua
contiguità
con
la
tradizione
analitica.
La
filosofia
della
storia
narrativa
è
postmoderna,
interpretativa
e
linguistica.
Essa
distingue
quale
unità
interpretativa
il
narrativo,
non
scomponibile
nelle
distinzioni
della
dichiarazione,
ed
è
tesa
a
non
uscire
dai
confini
della
lingua
dello
storico88,
distingue
tipi
possibili
di
interpretazione
e
si
preoccupa
della
loro
proliferazione89.
Dalla
narrativa
storica
non
è
possibile
separare
lo
storico
stesso,
e
perciò
la
domanda
sulla
veridicità
della
interpretazione
è
messa
tra
parentesi.
L’approccio
narrativo
è
legato
ad
una
svolta
linguistica
nella
storiografia,
e,
oltre
ai
lavori
dello
stesso
Ankersmit,
distintosi
negli
anni
ottanta
come
apologeta
dell’approccio
narrativo90,
bisogna
citare
lo
studio
fondamentale
di
Paul
Ricoeur
Tempo
e
racconto91,
e
la
Metastoria92
di
Hayden
White.
Il
terzo
approccio,
presentato
da
Ankersmit
come
filosofia
dell’esperienza
storica
sublime,
si
delinea
durante
gli
anni
novanta
ed
è
legato
alla
svolta
che
la
teoria
storica
compie
dalla
lingua
all’esperienza,
«
dai
sistemi
universali
del
significato
al
significato,
circoscritto
a
situazioni
e
avvenimenti
concreti
»93.
La
seguente
constatazione
di
Ankersmit
è
vicina
all’analisi
gumbrechtiana:
«
La
“teoria”
e
il
significato
non
vanno
più
mano
nella
mano;
il
significato
ha
trovato
un
nuovo
e
più
sicuro
compagno
di
viaggio
nell’esperienza
»94.
Dal
mondo
post‐strutturalista
«
nel
quale
“la
lingua
parla
l’uomo”
e
il
soggetto,
o
l’autore,
sono
–
nel
migliore
dei
casi
–
attributi
della
lingua
»
ci
spostiamo
verso
un
paradigma
nel
quale
«
scoperta
reiterata
dell’esperienza
è
una
scoperta
reiterata
del
soggetto
»95.
Dopo
la
svolta
linguistica,
compiamo
una
svolta
antropologica.
Al
centro
di
questa
filosofia
della
storia
non
c’è
il
narrativo
storico,
ma
il
narratore
con
le
sue
storie
orali.
In
inglese
history
e
story
(due
cose
diverse
in
russo),
ovvero
la
storia
come
occupazione
propria
dello
86
Cfr.
F.R.
Ankersmit,
Narrativnaja
logika.
Semantičeskij
analiz
jazyka
istorikov,
Moskva,
Ideja‐Press,
2003
e
Istorija
i
tropologija:
vzlet
i
nadenie
metafory,
Moskva,
Kanon+,
2009.
(Le
traduzioni
del
testo
di
Ankersmit
che
seguono
sono
state
qui
tradotte
sulla
base
delle
citazioni
della
traduzione
russa
riportata
da
A.
Filonenko).
Cfr.
la
versione
inglese:
Narrative
logic.
A
semantic
analysis
of
the
historian’s
language,
Martinus
Nijhoff
Publishers,
1983
e
History
and
Tropology:
The
Rise
and
Fall
of
Metaphore,
University
of
California
press,
1994.
87
Cfr.
F.R.
Ankersmit,
Istorija
i
tropologija:
vzlet
i
nadenie
metafory,
cit.,
pp.
83‐84.
88
Ibi,
p.
84.
89
Ibi,
p.
129.
90
Cfr.
F.R.
Ankersmit,
Narrativnaja
logika.
Semantičeskij
analiz
jazyka
istorikov,
cit.
91
P.
Ricoeur,
Tempo
e
racconto
(3
voll.),
Jaca
Book,
Milano
1986‐1988.
92
H.
White,
Metahistory:
the
historical
imagination
in
XIXth­century
Europe,
Baltimore,
The
John’s
Hopkins
University
Press,
1973.
93
F.R.
Ankersmit,
Vozvyšennyj
istoričeskij
opyt
,
cit.,
p.
19.
94
Ibi,
p.
20.
95
Ibi,
p.
21.
19
storico,
e
la
storia
come
occupazione
del
narratore,
convergono,
e
questa
convergenza
risulta
pregnante
all’interno
del
terzo
paradigma,
e
prospetta
il
ritorno
del
narratore
come
nuovo
cronista
e
annalista
nella
storiografia
dell’avvenimento
contemporanea.
Un
esempio
di
nuova
storiografia
è
la
storia
dell’Olocausto,
i
cui
testimoni
sono,
o
persone
ammutolite
nella
Catastrofe,
che
non
parlano
di
questa
esperienza,
ma
vivono
a
partire
da
essa,
oppure
testimoni‐narratori:
la
ricezione
dei
loro
racconti
orali
si
scontra
con
le
difficoltà
che
stanno
al
centro
del
metodo
della
nuova
storiografia.
Queste
difficoltà
possono
essere
rappresentate
con
la
metafora
della
vita
sulla
cascata,
presentata
da
Jonatan
Sofran
Foer,
autore
ventenne
del
romanzo
d’esordio
Ogni
cosa
è
illuminata96
(Everything
is
illuminated,
2002).
L’autore
narra
del
suo
viaggio
in
Ucraina
in
cerca
di
testimonianze
sulla
patria
dei
suoi
antenati,
il
piccolo
paese
ebraico
di
Trachimbrod,
raso
al
suolo
dai
nazisti.
Il
romanzo‐
testimonianza
–
che
fa
ridere
fino
alle
lacrime
e
che
fa
piangere
ai
limiti
del
pianto,
disperatamente
lucido
e
commovente
oltre
ogni
speranza,
una
confessione
sincera
ed
esaltante,
che
lega
insieme
i
racconti
e
scioglie
il
dolore,
che
si
risolve
ad
un
passo
verso
l’Altro
e
diviene
esso
stesso
tale
passo
–
è
uno
splendido
esempio
di
ricerca
di
una
lingua
che
corrisponda
«
all’esperienza
storica
sublime
».
In
questo
romanzo
viene
presentata
una
metafora
a
proposito
della
vita
su
una
cascata,
una
vita
che
unisce
più
generazioni
che,
con
essa,
hanno
risposto
agli
indomabili
impulsi
tettonici
di
una
forza
sovraumana,
e
a
proposito
di
una
famiglia
che
si
è
stabilita
in
una
casa
nei
pressi
del
rombo
della
cascata.
Dapprima
essi
diventano
sordi
e
gridano
l’uno
all’altro,
per
superare
il
rumore
della
cascata,
tormentati
dall’insonnia
corrono
fuori
casa,
ma
dopo
un
paio
di
mesi
si
abituano
al
suo
fragore
e
cominciano
ad
ascoltarsi
l’un
l’altro.
«
E
questo
è
vivere
vicino
a
una
cascata,
Safran.
Ogni
vedova
si
sveglia
di
mattina,
forse
dopo
anni
di
lutto
puro
e
inossidabile,
per
rendersi
conto
di
aver
trascorso
una
bella
nottata
di
sonno,
e
di
poter
fare
colazione,
e
di
non
sentire
il
fantasma
del
marito
ininterrottamente,
ma
solo
a
tratti.
Al
suo
dolore
subentra
un’utile
tristezza
»97.
Ma
la
cascata
costringe
a
far
memoria
di
sé,
quando
essi
decidono
di
prendere
a
parlare
sottovoce
con
coloro
che
vivono
lontano
dalla
loro
casa:
«
L’ho
capito
la
prima
volta
che
ho
tentato
di
bisbigliare
un
segreto
senza
riuscirvi,
o
fischiettare
una
canzone
senza
insinuare
la
paura
nei
cuori
di
chi
era
nel
raggio
di
cento
metri,
quando
i
miei
colleghi
nella
conceria
mi
hanno
supplicato
di
abbassare
la
voce
perché
“Chi
riesce
a
pensare
se
gridi
in
quel
modo”?
Al
che
io
ho
domandato:
“STO
DAVVERO
GRIDANDO?”
»98.
96
J.
S.
Foer,
Ogni
cosa
è
illuminata,
Guanda,
2004.
97
Ibi,
pp.
314‐315.
98
Ibi,
p.
315.
20
Gli
uomini
possono
dire
le
cose
più
profonde
e
più
preziose
soltanto
sussurrando,
e
la
vita
presso
la
cascata
ha
insegnato,
con
il
tempo,
a
parlarsi
l’un
l’altro
di
ciò
che
è
importante.
Ma
ogni
nuova
generazione,
nata
lontano
da
questo
roboante
e
disumano
silenzio
della
Catastrofe,
non
presta
ascolto
alle
testimonianze,
perché
esse
gridano,
benchè
sussurrino
di
una
ferita.
In
ogni
caso,
noi
ci
troviamo
ora
in
una
situazione
in
cui
è
necessario
impadronirsi
dell’arte
di
parlare
sottovoce,
e
di
mettersi
in
ascolto
attraverso
il
grido
e
il
mutismo.
Senza
quest’arte
il
narratore
non
verrà
udito.
Essa
mostra
la
chiave
metodologica
delle
nuove
scienze
umane.
Il
testimone:
il
ritorno
del
narratore
nella
teologia.
Se
al
centro
delle
nuove
scienze
umane
troviamo
la
relazione
fra
gli
effetti
della
presenza
e
gli
effetti
del
significato,
il
loro
interrogativo
riguarda
soprattutto
la
poetica
della
presenza
e
la
lingua
del
ringraziamento,
in
relazione
al
racconto
e
alle
altre
forme
linguistiche.
Questa
intenzione
metodologica
determina
una
svolta
teologica
nell’ambito
delle
scienze
umane,
sensibili
all’esperienza
e
alla
lingua
dell’epifania
e
dell’eucarestia.
Ma
è
anche
la
teologia
stessa
a
volgersi
verso
la
questione
del
dono,
del
ringraziamento
e
delle
loro
forme
linguistiche,
rivelandosi
come
teologia
eucaristica
della
comunione.
Una
siffatta
teologia,
in
quanto
pratica
generativa
volta
all’Eucarestia,
si
definisce
appunto
come
opera
di
ringraziamento.
Se
la
lingua
della
teologia
ortodossa
nel
XX
secolo
è
stata
o
una
lingua
speculativa,
orientata
verso
la
corrente
filosofica
del
tempo
(sofiologia),
oppure
la
lingua
pratica
dell’ascesi,
che
subordina
l’elemento
catafatico
del
pensiero
speculativo
a
quello
apofatico
della
teologia
mistica
esistenziale
(sintesi
neopatristica),
la
prima
lingua
della
teologia
eucaristica
non
può
essere,
invece,
né
apofatica
né
catafatica.
L’epifania,
che
si
spalanca
come
un
richiamo,
esce
dai
confini
delle
lingue
teologiche,
tanto
da
quello
apofatico,
quanto
da
quello
catafatico,
e,
allo
stesso
tempo,
si
rivela
come
fonte
di
entrambe
le
pratiche
lingustiche.
Il
richiamo,
infatti,
genera
una
forza
apofatica,
dal
momento
che
appare
come
un
dono
che
fa
cadere
in
un
silenzio
carico
di
adorazione,
e
che
priva
del
dono
della
parola.
Il
richiamo,
percepito
all’interno
di
situazioni
concrete
legate
alle
diverse
pratiche
linguistiche,
blocca
queste
stesse
pratiche,
aprendo
una
sorta
di
frattura.
Ma
in
questa
frattura
nasce
una
relazione
vitale
mediante
il
richiamo,
e,
come
risposta,
il
ringraziamento.
L’avvenimento
del
richiamo‐dono
si
manifesta
nel
mondo
come
gratitudine,
in
essa
si
realizza
e
permane.
Il
ringraziamento
costituisce
anche
la
fonte
della
forza
catafatica.
21
La
stessa
divisione
tradizionale
delle
lingue
predicative
in
apofatico
e
catafatico,
risalente
alla
teologia
di
Dionigi
Aeropagita,
si
ritrova
inserita,
come
ha
mostrato
bene
J.L.
Marion,
nella
lingua
della
lode,
o
dell’inno:
«
Dionigi
tende
a
sostituire
al
dire
del
linguaggio
predicativo,
un
altro
verbo,
hymnein,
lodare.
Che
cosa
significa
questa
sostituzione?
Essa
indica
certamente
il
passaggio
dal
discorso
alla
preghiera,
perché
“la
preghiera
è
un
logos,
ma
né
vero
né
falso”
(Aristotele)
»99.
Marion
insiste
sul
fatto
che
«
bisogna
oltrepassare
l’alternativa
categorica,
per
accedere
ad
un
diverso
modello
del
discorso
»100,
che
definisce
discorso
di
lode.
Volendo
innanzitutto
metterne
in
evidenza
i
segni
distintivi,
Marion
precisa:
«
Dal
punto
di
vista
del
Postulato,
l’anonimato,
e
la
polionimia
si
incontrano
come
i
due
bordi
della
stessa
distanza.
E’
compito
dei
postulanti
parlare
un
linguaggio
che
si
rende
conto,
per
rispettarla,
di
questa
equivalenza
di
fondo
»101.
Nel
ruolo
del
linguaggio
«
appropriato
alla
distanza
che
comprende
iconicamente
il
linguaggio
stesso
»102
si
rivela
l’inno,
o
lode.
L’operazione
del
“come”
prende
per
Dionigi
la
forma
logica
della
lode,
in
luogo
delle
operazioni
di
affermazione
e
negazione:
«
donde
una
proposizione
del
tipo
“x
loda
il
Postulato
come
y”,
nella
quale
“come”
non
equivale
affatto
a
“come
se,
als
ob”
ma
a
“in
quanto”
»103.
«
E’
certo
pronunciato
un
enunciato
[di
lode],
il
quale
però
è
sempre
compreso
in
un
meta
linguaggio
che
implica
il
locutore
nella
determinazione
stessa
dell’enunciato
»
o
«
riprende
la
soggettività
del
locutore
nell’insuperabile
intenzione
al
Postulato
»104.
Andando
in
cerca
del
fondamento
della
teoria
del
discorso
di
lode
nelle
Ricerche
filosofiche
di
Wittgenstein,
e
mettendo
a
confronto
lode
e
performativo,
Marion
sottolinea
la
peculiarità
del
performativo
innografico:
se
ogni
«
performativo
presuppone
che
l’enunciatore
sia
minimamente
qualificato
sì
da
autorizzare
la
performazione
corrispondente
all’enunciato
»,
qui,
invece,
«
ogni
postulante
»
deve
pronunciare
la
lode,
e
per
di
più
«
la
postulazione,
per
performarsi,
dipende
qui
dal
Postulato
più
ancora
che
dal
postulante,
che
può
e
deve
postulare
solo
in
chi
lo
guida
e
lo
precede
nella
distanza
anteriore:
il
Postulato
»105.
«
Il
postulante,
lungi
dal
potere
di
performare
il
proprio
enunciato,
in
virtù
della
propria
qualificazione,
riceve
quest’ultima
originariamente
da
quello
che
il
suo
enunciato
intenziona
senza
predicarne
nulla
»106.
La
lode
trova
il
proprio
fondamento
non
nel
soggetto
che
la
compie,
bensì
in
Colui
verso
il
quale
è
diretta.
Essa
«
lavora
certamente
come
un
performativo
99
J.L.
Marion,
L’idolo
e
la
distanza,
Jaca
Book,
Milano
1979,
p.
183.
100
Ibidem.
101
Ibi,
p.
184.
102
Ibi,
p.
185.
103
Ibidem.
104
Ibi,
p.
186.
105
Ibi,
p.
187.
106
Ibidem.
22
(“Ti
lodo...”),
ma
come
performativo
che,
invece
di
fare
delle
cose
con
delle
parole,
elabora
con
delle
parole
dei
doni
»107.
E
così
l’inno,
o
discorso
di
lode,
è
la
prima
lingua
dell’ermeneutica
eucaristica,
la
quale
lega
la
Presenza
e
l’Eucarestia,
la
Parola
di
Dio
e
la
lode,
il
dono
e
il
ringraziamento,
l’esperienza
e
la
lingua.
Se
non
prestiamo
attenzione
all’inno
come
prima
lingua
teologica,
giungiamo
inesorabilmente
alla
frattura
tra
l’esperienza
della
teologia
esicasta
e
mistico‐apofatica
da
un
parte,
e
la
teologia
dogmatica
dall’altra.
La
crisi
della
teologia
accademica
contemporanea
consiste
nella
frattura
tra
l’esperienza
eucaristica
della
presenza
di
Dio
e
le
nostre
speculazioni:
è
stato
perso
l’anello
di
congiunzione
tra
la
teoria
e
le
pratiche
interpretative
–
e
questo
anello
di
congiunzione
è
l’inno.
La
teologia
contemporanea
necessita
di
una
comprensione
dettagliata
dell’inno.
Vladimir
Veniaminovič
Bibichin
l’aveva
sentito
acutamente,
muovendo,
in
parallelo
a
Marion,
i
primi
passi
nella
direzione
di
una
chiarificazione
dei
tratti
peculiari
dell’inno:
Bibichin
tenne
un
ciclo
di
lezioni,
intitolato
“Filosofia
grammatica
della
poesia”,
nel
secondo
semestre
del
2000
alla
Facoltà
di
filosofia
dell’Università
Statale
di
Mosca
(MGU).
Durante
il
corso,
partendo
dalle
sue
traduzioni
degli
inni
del
Rgveda,
realizzate
a
cavallo
degli
anni
sessanta
e
anni
settanta,
presentò
uno
schizzo
della
teoria
dell’inno:
«
Nella
teoria
della
letteratura
contemporanea,
l’inno
non
si
distingue
per
la
poetica
accanto
all’epica,
alla
lirica,
al
dramma,
e
viene
spesso
incluso
nella
lirica.
Io
lo
considero
talmente
a
sé
stante,
che
ritengo
piccola
la
distinzione
tra
i
generi
enumerati
dalla
teoria
della
letteratura,
e
grande
la
differenza
dell’inno
rispetto
alla
loro
totalità
»108.
Inscrivendo
l’inno
in
un
genere
autonomo,
Bibichin
comincia
da
una
descrizione
della
posizione
particolare
dell’autore.
Se
nell’epos
e
nel
dramma
«
l’atto
dell’autore
è
già
escluso,
perché
in
quei
casi
l’autore
non
compare
in
scena
»,
invece
«
nella
lirica
l’io
si
desta,
diventa
un
altro,
vede
con
sorpresa
se
stesso
e
questa
condizione
di
amekania,
egli
esclude
completamente
l’atto»,
mentre
nell’inno
«
il
poeta
stesso
partecipa
all’azione
esatta,
estrema
e
roboante
della
chiamata,
della
partecipazione,
precisamente
nel
compito
finale
del
dono
di
sé,
ossia
della
professione
di
fede
»109.
Bibichin
osserva
che
nella
filologia
dell’antica
Grecia,
il
primo
inno
è
stato
dimenticato,
ma
è
stata
conservata
la
denominazione
innografica
della
poesia
come
il
fare
»110.
Esaminando,
come
fa
Marion,
la
natura
performativa
dell’inno,
Bibichin
constata:
«
L’inno
è
un
atto
limite,
uno
slancio
107
Ibi,
p.
188.
Il
testo
termina,
nella
traduzione
italiana
con
l’esplicazione:
«
“Ti
lodo
come
‘y’,
‘y’,
‘y’”,
ecc.
»
(N.d.t.).
108
V.V.
Bibichin,
Grammatika
poezii.
Novoe
russkoe
slovo,
Izdatel’stvo
Ivana
Limbacha,
SPb
2009,
p.
133.
109
Ibi,
p.
136.
110
Ibi,
p.
132.
23
estremo,
un
momento
trionfale
della
storia,
che
si
accompagna
alla
certezza
nella
liminarità
di
questo
stesso
avvenimento.
La
trasformazione‐dilatazione
è
accolta
con
gioia
...,
colui
che
canta
entra
in
contatto
con
un
sé
che
prima,
probabilmente,
non
aveva
mai
conosciuto,
e
riconosce
questo
nuovo
sé
come
autentico
».
Inoltre,
la
scoperta
dell’autentico
io
che
canta
si
disvela
nell’inno
e
nella
società
parcellizzata
del
noi:
«
E’
chiaro
che,
sul
confine
verso
il
quale
tende
l’inno,
l’io
diventa
noi,
perché
è
pronto
ad
abbracciare
tutti,
e
questo,
a
sua
volta,
accade
perché
esso
si
lega
alla
vita,
all’essere.
Quando
un
canto
realizza
questi
due
passaggi,
verso
tutti
e
verso
tutto,
partecipando
di
tutto
e
di
tutti,
il
termine
lirica
è
ancora
meno
adeguato
per
denominare
questo
genere
di
poesia;
esso
costituisce
le
fondamenta,
semmai,
per
parlare
in
modo
specifico
dell’inno
»111.
Nell’inno
c’è
«
una
via
d’apertura
verso
ciò
che
è
unico,
verso
un
livello
di
affermazione
della
vita
(dell’essere).
L’unicità
qui
è
l’uscita
dalla
metrica.
Non
si
salva
nulla
dei
parametri
del
progresso,
oltre
alla
felicità
folle,
all’estasi
»112.
Nella
descrizione
dell’esperienza
innografica
di
Bibichin,
sono
presenti
tutti
i
caratteri
dell’epifania
che
sono
messi
in
evidenza
da
Gumbrecht,
ma
ad
essi
si
aggiungono
la
distinzione
linguistica
dell’epifania
nella
comunità
di
coloro
che
cantano
e
esultano,
e
l’aspetto
performativo
della
lingua
innografica:
«
Nell’inno
se
non
c’è
parola
non
c’è
un
fatto,
così
che
non
c’è
il
silenzio
efficace,
efficiente
»113.
Nella
parola
dell’innografia
«
non
esiste
differenza
tra
religione,
poesia
e
filosofia
né,
ancora,
differenza
tra
le
diverse
arti,
né
tanto
meno
tra
pensiero
e
parola,
e
men
che
meno
tra
vita
e
essere.
Questo
insieme
di
acquisizioni
non
è
preso
dalla
teoria,
ma
dalla
forza
»114.
La
lingua
dell’inno,
la
lingua
del
ringraziamento,
somiglia
«
alla
fisica
contemporanea,
che
conosce
soltanto
una
datità
affidabile,
e
precisamente
questa
stessa
datità,
che
la
datità
è
data,
e
dà
in
risposta
ad
essa
una
figura
»,
ma
gli
autori
di
inni
«
distinguono,
creano
un
volto,
la
cui
immagine
viene
dall’essere
».
Se
per
Benjamin
è
importante
il
rapporto
genetico
del
racconto
con
l’epos,
l’ermeneutica
eucaristica
invece
si
apre
per
mezzo
della
relazione
del
racconto
con
l’inno.
L’inno
«
che
crea
doni
con
le
parole
»,
che
è
teso
alla
condivisione
del
ringraziamento,
si
apre
come
un
discorso‐
azione,
diretto
agli
ascoltatori,
che
genera
in
questa
tensione
il
racconto‐testimonianza.
Il
passaggio
dall’inno
di
ringraziamento
alla
testimonianza
è
stato
esplicitato
in
modo
magnifico
dal
metropolita
Antonij
di
Surož:
«
Il
frutto
della
vita
è
la
gratitudine,
ma
la
stessa
gratitudine
deve
portare
frutto...
La
gratitudine
–
e
solo
essa
–
può
spingerci
all’impresa
111
Ibi,
p.
142.
112
Ibi,
p.
148.
113
Ibi,
p.
124.
114
Ibi,
p.
122.
24
estrema
dell’amore
verso
Dio
e
verso
gli
uomini.
Il
senso
del
dovere,
degli
impegni,
probabilmente
non
troverà
in
sé
la
forza
di
compiere
il
gesto
ultimo
della
vita,
del
sacrificio,
dell’amore.
Ma
la
gratitudine
la
troverà
»115.
Proprio
in
questo
passaggio
si
può
rilevare,
inoltre,
una
pluralità
di
forme:
ci
soffermiamo
qui
sulla
forma
del
pianto,
e
su
quella
della
predicazione.
Nel
1926,
il
suo
ultimo
anno
di
vita,
Rilke,
nell’elegia
dedicata
a
Marina
Cvetaeva‐Efron,
portando
a
compimento
la
svolta
verso
la
forma
dell’inno,
ne
ravvisa
la
affinità
con
il
pianto:
«
Che
tutto
sia
un
gioco,
uguale
che
muta,
rinvio,
mai
un
nome,
né
mai
forse
un
segreto
frutto?
Onde,
Marina,
noi
mare!
Abissi,
Marina,
noi
cielo.
Terra,
Marina,
noi
terra,
noi
mille
primavere
che,
come
allodole,
il
sorgere
di
un
canto
lancia
nell’invisibile.
S’inizia
qual
giubilo
e
già
completamente
ci
soverchia;
d’un
tratto
il
peso
nostro
piega
in
lamento
il
canto.
E
pure:
lamento?
Non
forse
–
più
nuovo
giubilo,
che
volge
in
basso?
»116
Il
pianto
è
in
grado
di
condurci
fuori
dal
mutismo
in
cui
siamo
finiti
dopo
le
catastrofi
del
XX
secolo.
Il
pianto
è
quella
forma
del
discorso
di
lode,
la
cui
acquisizione
costituisce
l’arte
di
parlare
sottovoce
e
di
porgere
l’orecchio
per
distinguere
il
sussurro
nel
grido.
E’
importante
aver
acquisito
nel
XX
secolo,
grazie
a
Bachtin,
una
teoria
articolata
della
cultura
comica;
posto
questo
però,
sappiamo
incommensurabilmente
poco
della
cultura
del
pianto,
e
del
rapporto
di
quest’ultima
con
la
cultura
della
commemorazione.
Anche
l’inno,
che
era
commemorazione
di
sé,
nella
poesia
di
Chlebnikov
e
di
Rilke,
e
il
pianto,
a
cui
l’Achmatova
dava
voce
nel
Requiem,
devono
entrare
a
far
parte
del
centro
dell’ermeneutica
eucaristica,
e,
nel
legame
con
essa,
delle
scienze
umane
che
si
volgono
alla
«
produzione
della
presenza
».
Per
la
teologia,
la
comprensione
di
queste
forme
determina
una
svolta
verso
il
liturgico
come
teologia
prima,
dalla
quale
nascono
l’estetica
e
la
dogmatica.
Dopo
il
pianto,
la
seconda
forma
che
deriva
dall’inno
è
la
predicazione,
la
cui
crisi
contemporanea,
secondo
quanto
osservato
da
Ol’ga
Sedakova,
è
dovuta
al
fatto
che,
una
volta
115
Antonij,
mitropolit
Surožkij,
O
blagodarnosti,
cit.,
p.
120.
116
Marina
Cvetaev,
Reiner
Maria
Rilke.
Lettere,
SE,
Milano
2010.
25
‘uscita’
dalla
culla
dell’inno117,
essa
ha
perduto
il
legame
con
l’inno
e
si
è
trasformata,
per
usare
la
definizione
di
Averincev,
«
in
un
prodotto
didattico
di
tipo
oratorio,
contenente
prescrizioni
etiche
»118.
Lo
sviluppo
della
teologia
eucaristica
è
legato
senza
dubbio
ad
un
rinnovamento
dell’omiletica,
della
quale
hanno
lasciato
esempi
impressionanti
Antonij,
metropolita
di
Surož,
padre
Aleksandr
Šmeman,
Sergej
Sergeevič
Averincev,
padre
Aleksandr
Men’,
padre
Georgij
Čistjakov.
Fin
dalle
origini,
la
predica
come
testimonianza
è
il
vero
e
primo
frutto
dell’inno.
La
predica,
come
genere
che
porta
l’inno
fuori
dalla
chiesa
verso
il
mondo,
è
la
seconda
forma
di
pratica
discorsiva
che
riveste
un
interesse
particolare
per
l’ermeneutica
eucaristica.
E
infine,
dalla
predica
nasce
la
terza
pratica
discorsiva,
che
conduce
verso
la
cultura
contemporanea
e
verso
le
scienze
umane
rinate
che
le
sono
legate,
è
cioè
proprio
il
racconto,
che
commisura
l’inno
alla
vita
attraverso
la
testimonianza.
Per
Leskov
era
chiaro
che
l’autorità
del
racconto
si
fonda
sui
giusti,
la
cui
testimonianza
vivente
costituisce
la
trama
della
tradizione
ecclesiastica,
che
trova
la
sua
realizzazione
proprio
nel
racconto.
Il
narratore
ritorna
in
quella
cultura
che
concepisce
se
stessa
come
risposta
ad
un
richiamo
secondo
tre
ipostasi:
quella
dell’innografo,
quella
del
predicatore
e
quella
del
testimone.
(Trad.
it.
di
Vera
Pozzi)
BIBLIOGRAFIA:
Agamben
G.,
Il
testimone,
in
Quel
che
resta
di
Auschwitz.
L’archivio
e
il
testimone,
Bollati
Boringhieri,
Torino
1998.
Ankersmit
F.R.,
Istorija
i
tropologija:
vzlet
i
nadenie
metafory,
Moskva,
Kanon+,
2009
(History
and
Tropology:
The
Rise
and
Fall
of
Metaphore,
University
of
California
press,
1994).
Id.,
Narrativnaja
logika.
Semantičeskij
analiz
jazyka
istorikov,
Moskva,
Ideja‐Press,
2003
(Narrative
logic.
A
semantic
analysis
of
the
historian’s
language,
Martinus
Nijhoff
Publishers
1983).
117
O.
Sedakova,
Jazyk
propovedi,
jazyk
propovednika
(Lingua
della
predica,
lingua
del
predicatore),
in
Duchovnoe
nasledie
mitropolita
Antonija
Surožkogo,
Moskva,
Fond
“Russkoe
Zarubež’e”,
2008,
p.
335.
118
S.S.
Averincev,
Sofija
–
Logos.
Slovar’
(Sofia­logos.
Dizionario),
Kiev,
Duch
i
litera,
2006,
p.
363.
26
Id.,
Vozvyšennyj
istoričeskij
opyt,
Moskva,
Izdatel’stvo
“Evropa”,
2007
(Sublime
historical
experience,
Stanford
University
press
2005).
Antonij,
mitropolit
Surožkij,
O
blagodarnost’,
in
Antonij,
mitropolit
Surožkij.
Ljubov’
vsepobeždajuščaja:
propovedi,
proiznesennye
v
Rossii,
SPb,
Satis
1994.
Averincev
S.S.,
Sofija
–
Logos.
Slovar’
(Sofia­logos.
Dizionario),
Kiev,
Duch
i
litera,
2006
Benjamin
W.,
Il
narratore,
Einaudi,
Torino
2011.
Bibichin
V.V.,
Grammatika
poezii.
Novoe
russkoe
slovo,
Izdatel’stvo
Ivana
Limbacha,
SPb
2009.
Cvetaeva
M.,
Rilke
R.M.,
Lettere,
SE,
Milano
2010.
Foer
J.
S.,
Ogni
cosa
è
illuminata,
Guanda,
2004.
Gadamer
H.G.,
L’incapacità
del
comunicare,
in
Verità
e
metodo
2,
Bompiani,
Milano
2010.
Gumbrecht
H.U.,
Proizvodstvo
prisutstvija:
čego
ne
možet
peredat
značenie,
Moskva,
Novoe
literaturnoe
obozrenie,
2006
(Production
of
presence:
what
meaning
cannot
convey,
Stanford
University
Press
2004).
Lyotard
J.F.,
La
condizione
postmoderna,
Feltrinelli,
Milano
1989.
Levinas
E.,
Totalità
e
infinito,
Jaca
Book,
Milano
1996.
Marion
J.L.,
Dato
che.
Saggio
per
una
fenomenologia
della
donazione,
SEI,
Torino
2005.
Id.,
Dio
senza
essere,
Jaca
book,
Milano
1987.
Id.,
L’idolo
e
la
distanza,
Jaca
Book,
Milano
1979.
Ricoeur
P.,
Tempo
e
racconto
(3
voll.),
Jaca
Book,
Milano
1986‐1988.
27
Sedakova
O.,
Jazyk
propovedi,
jazyk
propovednika
(Lingua
della
predica,
lingua
del
predicatore),
in
Duchovnoe
nasledie
mitropolita
Antonija
Surožkogo,
Moskva,
Fond
“Russkoe
Zarubež’e”,
2008.
White
H.,
Metahistory:
the
historical
imagination
in
XIXth­century
Europe,
Baltimore,
The
John’s
Hopkins
University
Press,
1973.
Prof.
Aleksandr
Semenovič
Filonenko,
docente
di
teoria
della
cultura
e
filosofia
della
scienza
presso
la
Facoltà
di
filosofia
dell’Università
nazionale
V.N.
Karazin
(Charkov).
www.risu.org.ua
28