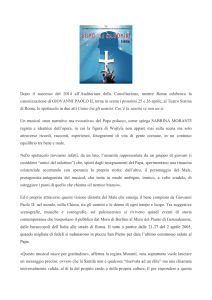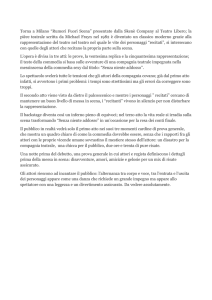18 — all’opera
Verso
«Die tote Stadt»
U
all’opera
n’opinione vulgata,
di Quirino Principe
di rado soggetta a verifica,
vuole che in Korngold esistano diversi compositori, in ragione di modi diversi di pensare la musica, di
proporle un fine e una funzione pubblica. Ci si appella, per
giustificare il giudizio e per trasformare in commiserazione la sua iniziale severità, agli accidenti della vita e alla forza tentatrice di facili occasioni di successo. Uno schema approssimativo distingue un primo Korngold, enfant prodige e
precoce autore di piccoli gioielli pianistici e cameristici, ammirato con una punta di stizza e persino invidiato da musicisti anziani ed esperti nel mestiere che accoglievano con
oscuro disagio l’astro nascente; un secondo Korngold, poco
più che ventenne ma già affermatissimo, direttore d’orchestra e didatta alla Wiener
Akademie für
Musik sino al
1934, nel ferv ido cl i ma
viennese del
primo dopoguerra, ed è
in quegli anni che nasce
Die tote Stadt,
op. 12 (1920):
un terzo e ultimo Korngold, emigrato in America, che scrivendo – con
straordinarie
gratificazioni in notorietà e in denaro – colonne sonore di film divenne un famulus
di Hollywood e della sua routine, perdendo, in compenso,
la fama che un tempo gli aveva arriso in Europa. Questa
immagine di un compositore in frammenti si è formata in
due fasi. Quarant’anni fa, quando l’ex enfant prodige morì appena sessantenne, anche chi possedeva vaghissime nozioni della musica di Korngold era più o meno al corrente di
una dicotomia, nella quale erano distinguibili grossolanamente due Korngold, quello europeo e attivo fra i protagonisti della grande musica austriaca del primo Novecento, e
quello americano, professionista corrivo e versatile al servizio dell’industria cinematografica. Di tale dicotomia, molti
hanno dato una lettura tendenziosa, dominante negli anni
cinquanta, anni di purismo censorio (una sorta di maccartismo applicato all’arte in nome dell’antiedonismo) durante
i quali fu reato apprezzare la musica per film, così come fu
reato amare Cajkovskij o Rachmaninov: la musica di questi
ultimi era guardata dai docenti istituzionali con superciliosa alterigia, poiché si diceva, appunto, che spesso Rachmaninov o Cajkovskij «degradavano» nel cue sheet e nella colonna sonora: prova irrefutabile di volgarità.
Ogni artista, come ogni uomo, è frammentato dal tempo, e
senza avvedersene diviene un altro uomo, ma lo diviene con
l’impercettibile gradualità con cui diminuiscono i granelli
del soreites nel paradosso di Eubulide. Tuttavia, avvengono
emergenze in forza delle quali il divenire è rapido, tranchant,
a scatti: non la natura, ma la storia facit saltus. L’unità dell’essenza individuale (non ci piace l’aggettivo «personale», che
ha una connotazione cristiana a noi sgradita) ha la meglio
sulla frammentazione del divenire se l’individuo possiede
forza e intelletto: in una parola, se la sua statura è alta. Alla
fine della vita, egli si trova alius et idem (ancora Orazio, Carmen saeculare, 10), ma è più idem che alius se intelletto e forza non gli sono mancati. Certo, un trauma può accentuare
la mutazione. Quando Erich Wolfgang Korngold nacque a
Brünn (oggi Brno) sabato 29 maggio 1897, l’anno in cui Gustav Mahler divenne direttore alla Hofoper di Vienna, esisteva l’Austria-Ungheria, patria di molte nazioni in difficile e miracoloso equilibrio, ed è notevole che moltissimi fra
i grandi «viennesi» di quell’epoca aurea, da Mahler a Freud,
da Schönberg a Hanslick, da Hofmannsthal a Zemlinsky,
fossero di origine cèca o galiziana o ebraica o magiara o mista; e Korngold era moravo. Quando Mahler, nel novembre
1908 e poco prima di ripartire per l’America (ah, i presagi!)
incontrò l’undicenne Erich Wolfgang e suo padre Julius, e
del ragazzo lodò la cantata Gold profetizzando all’esordiente
luminosi destini, il mondo esterno non era mutato di molto.
Quando Korngold morì a Hollywood venerdì 29 novembre 1957, la trasformazione rispetto alla fin-de-siècle era, nel
mondo, vistosissima. Sessant’anni non sono una vita lunga,
ma collocati dalla fine del secolo XIX a poco oltre la metà
del XX, sì da scavalcare le due guerre mondiali, la fine dei
tre grandi imperi (Austria, Germania, Russia) che nel cuore d’Europa lasciarono un gran vuoto lasciando pullulare
Stati effimeri o vitali ma travolti da sventure, il fascismo e
il nazionalsocialismo, quei sessant’anni furono tanto pieni
di eventi da sconvolgere l’essenza a tutto favore del divenire. Nel caso di Korngold e di altri artisti con simili connotati (lo ripetiamo: l’ebraismo, la Mitteleuropa d’origine), alla
frammentazione dovuta al tempo e controllabile con l’energia individuale si aggiunse la lacerazione dello spazio: emigrazione e diaspora entrarono nel codice genetico di molta
musica del Novecento, da Bartók a Zemlinsky, da Schönberg a Berthold Goldschmidt, da Kurt Weill a Ernst Krenck, da Bruno Walter a Igor Stravinskij: diversi e diversamente accaniti i persecutori, diverso il grado di sradicamento e di
malessere, simile la sceneggiatura dell’esilio. Una vita stabilmente ambientata e radicata è definibile mediante due coordinate: il fluire del tempo, le opere dell’uomo. La dislocazione dello spazio, oltre a produrre disagi nell’anima, complica
la definizione: introduce una terza coordinata, anzi, molte
altre, occasionali e ausiliarie. Nel primo caso, una biografia
è una pagina liscia e distesa; nel secondo, grazie all’intrico
di assi cartesiani, essa diventa un difficile problema topologico, come il foglio accartocciato che John Gribbin, nel
suo In Search of the Edge of Time, assume a similitudine di un
destino perturbato e instabile. Perciò a Korngold il tempo
e lo spazio sottrassero molto, ma meno di quanto egli offrì
in dono all’ascolto, e l’ascolto è la felicità che chiediamo alla musica. Non è importante domandarci se la sua musica
abbia guardato avanti o a ritroso nello stile, se essa sia stata remunerata dalla nobile povertà o dalla facile agiatezza.
La domanda sarebbe pura ideologia. Se la musica non andasse oltre ogni cosa, come ha scritto Rilke, che cosa sarebbe? Più giusto è domandarsi se l’arte di Korngold sia stata
grande o mediocre, o, più esattamente, bella o brutta, poiché questo e non altro conta veramente. Quell’uomo, che
nei ritratti appare sempre sorridente e felice, subì forse l’in-
felicità del sentirsi incompiuto. Sarebbe ingiusto vedere in
lui i frammenti di un musicista, e negargli la continuità del
suo intento: trasmettere generosamente, attraverso la musica, l’energia di ciò che è semplicemente bello.
La drammaturgia musicale in «Die tote Stadt»
Siamo d’accordo con un giudizio vulgato: Korngold ha dato il meglio di sé nel teatro. Diremmo meglio: nello spettacolo, poiché anche le colonne sonore che egli scrisse a Hollywood sono fra gli esiti migliori della musica per film, almeno per quanto riguarda il rapporto semantico ed espressivo tra musica e sceneggiatura cinematografica. Del resto, converge in questa direzione la palese teatralità delle
sue composizioni orchestrali, compresi i concerti per strumento solista. Siamo d’accordo anche nell’indicare in Die
tote Stadt il più felice fra gli esiti teatrali di Korngold, anche
se Das Wunder der Heliane, lavoro eccentrico e condannato a
morte dal nazismo, forma a nostro avviso una costellazione binaria con il precedente. Certo, proprio l’eccentricità
della più tarda fra le due opere fa sì che in Die tote Stadt s’intraveda il nucleo tipico di una drammaturgia per musica in
ciò che essa ha d’individuale e di originale. Una rapida e doverosa ricognizione del teatro di Korngold valga come una
sorta di accerchiamento della questione, lungo linee irradianti e convergenti.
Il lascito teatrale di Korngold comprende alcuni lavori
iscritti in vari generi, dal balletto al musical alla Bühnenmusik, e
quattro opere vere e proprie. Il primo gruppo comprende:
a) La pantomima Der Schneemann («L’uomo di neve»), composta nel 1908, orchestrata da Alexander von Zemlinsky e
andata in scena alla Hofoper di Vienna nel 1910 con la memorabile coreografia di Karl Godlewski. Fu la rivelazione
del Wunderkind (dell’astro nascente, dell’enfant prodige) e fece
del tredicenne Erich Wolfgang «l’uomo del giorno».
b) Musiche di scena op. 11 per la commedia Much Ado
about Nothing di William Shakespeare (1918).
c) Kathrin (1939) una «Volksoper» che nasce da una curiosa contaminazione di opera e operetta ed è, come ha scritto Brendan G. Carroll (presidente della Erich Wolfgang
Korngold Society), «more like a lyrical Singspiel than a dramatic opera».
d) La commedia musicale The Silent Serenade (Dortmund,
1954).
e) A partire dal 1929, una serie di adattamenti di operette, fra cui Die Fledermaus di Johann Strauss jr. data a Berlino nella versione registica di Max Reinhardt e, sempre in
versione di Reinhardt, La belle Hélène di Jacques Offenbach, per la quale Korngold scrisse un’ouverture ancora talvolta eseguita.
Il secondo gruppo comprende:
1) Der Ring des Polykrates, opera giocosa («heitere Oper»)
in 1 atto. Libretto di Leo Feld (pseudonimo di Leo Hirschfeld) e di Julius Leopold Korngold (padre del compositore), tratto dall’omonima commedia Der Ring des Polykrates («L’anello di Policrate», 1888) di Heinrich Teweles. Prima esecuzione: Monaco di Baviera, Hoftheater, martedì 28
marzo 1916, direttore Bruno Walter, interpreti Maria Ivogün (Laura) e Karl Erb (Wilhelm), il 10 aprile di quell’anno vi fu la première viennese, con Selma Kurz e Alfred Piccaver nei due ruoli principali. Fu un grande successo di critica: fece eccezione Karl Kraus, che sin dal 1910, sulle colonne della sua rivista «Die Fackel», aveva espresso riserve sul talento di Korngold, e questa volta usò giudizi aspri
senza mezzi termini.
2) Violanta, opera in 1 atto. Libretto del poeta moravo
Hans Müller (1882-1950), noto anche con il nome arricchi-
to da un’aggiunta di sua invenzione, Hans Müller-Einigen.
Prima esecuzione (insieme con Der Ring des Polykrates): Monaco di Baviera, Hoftheater, martedì 28 marzo 1916, direttore Bruno Walter, interpreti Emmy Krüger (Violanta),
Friedrich Brodersen (Simone), Franz Gruber (Alfonso), regia di Anton von Fuchs.
3) Die tote Stadt («La città morta»), opera in 3 atti: «atti» è
termine corrente, ma l’indicazione originale è «in drei Bildern», in tre quadri. Libretto di Paul Schott (pseudonimo
di Julius Leopold Korngold) con la collaborazione di Erich
Wolfgang Korngold, tratto dal dramma Le mirage (1897) dello scrittore franco-belga Georges Raymond Constantin Rodenbach nella traduzione tedesca (edita nel 1902) di Siegfried
Trebitsch intitolata Die stille Stadt («La città silenziosa»). A
sua volta, Rodenbach trasse il dramma Le mirage dal proprio
romanzo Bruges-la-Morte (1892). Prima esecuzione: simultaneamente, nella stessa serata di sabato 4 dicembre 1920, allo
StadtTheater di Amburgo e all’Opernhaus di Colonia. Interpreti: ad Amburgo, Anny Münchow (Marietta), Richard
Schubert (Paul), Maria Olszewska (Brigitta), Josef Degler
(Franck), direttore Egon Pollak; a Colonia, nello stesso ordine di personaggi, Johanna K lemperer, Karl
Schröder, Katharina Rohr,
Karl Renner,
direttore Otto
Klemperer.
4) Das Wunder der Heliane («Il miracolo di Eliana»),
opera in 3 atti. Libretto di
Hans Müller,
tratto da Die
Heilige, una
sorta di sacra
rappresentazione (Mysterienspiel ) del
poeta espressionista romeno Hans Kaltneker (o Kaltnecker, 1895-1919). Prima esecuzione: Amburgo, Stadt-Theater, venerdì 7 ottobre 1927, interpreti Maria Hussa (Heliane), Sabine Kalter (Messaggera), Carl Günther (straniero).
I soggetti delle quattro opere di Korngold si accampano
in diversissimi ambiti poetici: versatilità, curiositas, tendenza
«alessandrina» (barocco asiana, apulciana, da romanzo ellenistico), molto affine alle scelte drammaturgiche di Richard
Strauss e lontanissima dalla monocorde fedeltà a un’aura e
a uno stato d’animo, ravvisabile nelle due opere di Berg o
nel teatro di Weill. Per non chiamare in causa Strauss, troppo imponente come termine di riferimento, suggeriamo
un rapporto di analogia tra il teatro musicale di Korngold
e quello di un altro enfant prodige, Eugen d’Albert. In Violanta è l’Italia del Rinascimento, mondo poetico-drammatico
assai caro all’opera austro-tedesca della sfera Jugendstil e di
zone confinanti: qui è la Venezia del XV secolo, in Eine florentinische Tragödie di Zemlinsky è Firenze, in Die Gezeichneten di Schreker è Genova. In Der Ring des Polikrates è la Sassonia del 1797. In Das Wunder der Heliane affiora un mondo
senza tempo, vagamente medioevale e leggendario, in cui
all’opera
all’opera — 19
all’opera
20 — all’opera
dominano fiaba e magia. Tutto ciò sembra una sperimentazione di vari terreni lontani dal presente, separati e visti attraverso un filtro di simbologia realizzata nel diverso,
nell’altrove e nell’autrefois, quasi a sgombrare il campo degli esperimenti e a preparare l’ambito spazio-temporale in
cui si colloca Die tote Stadt, la grande letteratura contemporanea (contemporanea a Korngold, o precedente di pochi
decenni), con un’ambientazione «ai nostri giorni», ossia alla fine del secolo XIX.
Non sarà mai apprezzata a sufficienza, nella storia del teatro musicale, la funzione mediatrice dei librettisti, eroi oscuri e sempre sottovalutati. Fra quelli che collaborarono con il
compositore di cui ci occupiamo e che furono tre in tutto,
ossia suo padre Julius, Leo Feld e Hans Müller, quest’ultimo
fu la personalità più estrosa. Müller, che in origine abbozzò
anche il testo per Die tote Stadt ufficialmente ascritto a Julius
Korngold (alias Paul Schott) e allo stesso Erich Wolfgang,
era nato anch’egli a Brünn/Brno. Di ventidue anni più giovane di Julius, di quindici più anziano di Erich Wolfgang,
rappresentava una generazione intermedia tra i due, e di padre e figlio fu,
oltre che concittadino per
nascita, intimo amico da
sempre. I più
lo ricordano
come uno dei
librettisti della celeberrima operetta
Im weißen Rößl
di Ralph Benatzky (1930).
Interessa poco sapere
che egli fosse
omosessuale e
di natura ipocondriaca, e il
fatto che egli
portasse una
grossa sciarpa di lana anche in piena estate è irrilevante. Ci
interessa di più, e ci convince poco, il giudizio noiosamente ripetuto sull’incompetenza poetica di Müller, sui suoi eccessi verbali e sul suo cattivo gusto. Bruttissimo è giudicato,
abitualmente, il suo libretto per Das Wunder der Heliane, il suo
più impegnativo contributo al teatro di Korngold. Proprio
quel testo, a nostro parere, spicca per proprietà e senso della
misura, e si attaglia perfettamente al carattere magico della
musica ideata dal compositore in una fase di geniale ispirazione e in possesso di un magnifico mestiere.
Si diceva: la grande letteratura contemporanea agli anni
d’esordio di Erich Wolfgang. La fonte originaria da cui nacque Die tote Stadt è illustre, e scrittore di alto rango è il suo autore. Georges Raymond Constantin Rodenbach (Tournai,
16 luglio 1855 – Parigi, 25 dicembre 1898), rappresentò, insieme con Maeterlinck, Verhacren e Van Lerberghe la rinascita della letteratura belga di lingua francese dopo il 1880,
e il suo stile si sviluppò partendo dall’esperienza del Parnasse e procedendo, sotto l’influenza del Verlaine più maturo,
verso il simbolismo. La maturazione era compiuta nel 1892,
quando uscì il romanzo Bruges-la-Morte. Hugues Viane si trasferisce a Bruges per vivere nel ricordo della moglie morta,
Ophélie, e nella città gli sembra di riconoscere la sembian-
za dell’amata. Una sera, nell’intrico delle vie di Bruges, vede
una donna, Jane, il cui volto somiglia perfettamente a quello di Ophélie. Ne fa la propria amante, ma Jane è una ballerina petulante e volgare. Un giorno, in casa di Hugues, Jane
va di stanza in stanza osservando beffarda i ritratti e le memorie della defunta. Vede la treccia ambrata di Ophélie, tenuta gelosamente da Hugues come sacra reliquia. Per scherno, la afferra e se la avvolge al collo. Hugues ordina di posarla, ma al rifiuto della donna, impazzito d’ira e di dolore, strangola Jane con la treccia. Molto apprezzato da Maeterlinck, il romanzo di Rodenbach influì, pochi anni dopo,
su Henry James e su un suo lungo racconto, The Altar of the
Dead (1896). Giova rammentare che dal racconto di Henry
James, mediante una contaminazione con due altri più brevi testi narrativi dello scrittore americano (The Friends of the
Friends e The Beast in the Jungle), François Truffaut trasse nel
1978, interpretandone il ruolo di protagonista, il macabro
e raffinato film La chambre vert. Da Bruges-la-Morte emana un
flusso acre e sottile che filtra in linguaggi artistici di varia
natura: poesia, musica, teatro, cinema. Nel libretto abbozzato da Müller e rielaborato dai due Korngold sono quasi
immutate le funzioni narrative del romanzo e del dramma
derivato, Le mirage: mutano però i nomi dei personaggi. Hugues, Ophélie e Jane diventano rispettivamente Paul, Marie
e Marietta. C’è però, nel libretto, una differenza fondamentale, che si fa determinante nel rapporto con la drammaturgia musicale: Marietta non è frivola, vacua e volgare, non è
un «assoluto naturale» né pura e animale sensualità come
la Jane di Rodenbach. È invece consapevole della profanazione che compie toccando la treccia e deridendo Paul e il
suo culto delle reliquie. È, propriamente, una figura demoniaca, così come è infernale il Signore in Heliane. Lo stesso
Korngold insistette nel porre in rilievo questo aspetto – del
tutto nuovo rispetto a Rodenbach – quando scrisse nel 1921
una limpidissima sintesi della trama per un numero speciale della rivista viennese «Blätter des Operntheaters», in occasione della première di Die tote Stadt a Vienna.
Korngold cominciò a lavorare a Die tote Stadt nel 1917. Il
soggetto gli era stato fornito dal traduttore e drammaturgo
Siegfried Trebitsch, e si trattava della versione tedesca (intitolata, come sappiamo, Die stille Stadt, 1902) del dramma Le
mirage, che lo stesso Rodenbach aveva scritto rielaborando
in forma teatrale il romanzo Bruges-la-Morte. La traduzione
di Trebitsch era andata in scena nel 1903 al Deutsches Theater di Berlino, ma con un titolo diverso, Das Trugbild, che traduce letteralmente Le mirage e si riferisce all’apparizione del
fantasma di Ophélie (poi Marie in Die tote Stadt). Il dramma
mantenne quel titolo anche nell’edizione tedesca dei drammi di Rodenbach curata da Trebitsch (München, 1913), e
ciò è importante, poiché sottolinea l’intenzionale spostamento del centro poetico irradiante e del nucleo fantastico-drammatico rispetto al romanzo. Importante, in particolare, nell’ispirazione musicale di Korngold. Il ventenne
compositore tracciò subito una sceneggiatura in 1 atto, entusiasmandosi per il soggetto. Intervenne Hans Müller, che
ampliò il progetto facendone un’opera in 3 atti, cui avrebbe
voluto dare un titolo quasi dannunziano per antifrasi, Der
Triumph des Lebens («Il trionfo della vita»). Presto, però, l’irrequieto Müller rinunciò alla collaborazione, e lo sostituì il
cinquantottenne Julius Korngold, in strettissima intesa con
il figlio. Erano i tempi in cui Erich Wolfgang ubbidiva ancora ai gusti e alle posizioni teoriche del genitore in materia
di teatro e di musica, e taluni hanno asserito che il giovane
musicista fu spesso plagiato dall’anziano critico. Alcuni sospettavano addirittura, stizziti dalla precoce genialità del-
l’enfant prodige, che Julius scrivesse la musica per cui il figlio
era ammirato: una falsa accusa, respinta da Julius drasticamente: «Se io sapessi scrivere musica come questa, non farei il critico!» («Wenn ich Musik wie diese schreiben könnte,
wäre ich nicht Kritikor!»). Korngold padre, tuttavia, si celò
dietro lo pseudonimo di Paul Schott. Il prenome fittizio alludeva al nome del protagonista dell’opera, Paul, sostitutivo di Hugues Viane. Il fittizio cognome era allusivo alla casa editrice Schott di Mainz, destinata a pubblicare Die tote
Stadt. Al principale socio proprietario della Schott, Ludwig
Strecker (Dieburg in Assia, 26 marzo 1853 – Mainz, 19 dicembre 1943), fu dedicata dall’autore Die tote Stadt. Il 15 agosto 1920, Korngold ultimò la composizione della partitura. Nell’ottobre 1920, Giacomo Puccini fu a Vienna, ed ebbe l’occasione d’incontrare il ventitreenne Korngold. Strano destino: fra i progetti operistici presi in esame da Puccini tra il 1903 e il 1910 e mai realizzati, c’erano anche A Florentine Tragedy di Oscar Wilde (messa in musica da Zemlinsky nel 1916-1917) e, appunto, Bruges-la-Morte di Rodenbach. Korngold, al pianoforte, suonò e cantò per intero Die tote Stadt in presenza di Puccini, il quale ne fu tanto impressionato da definire in pubblico Korngold come «la più grande
speranza della nuova musica tedesca».
Se esaminiamo la già ricordata Handlung der Oper scritta da
Korngold nel 1921, vediamo come l’azione in sintesi dia rilievo a una serie di eventi musicali, non puramente espansivi o decorativi rispetto alla sceneggiatura, ma nuclei essenziali della drammaturgia. Fin dalle prime righe, l’immagine di Bruges, città morta, si apre con l’evocazione di un
suono mesto e lugubre: «… le sue campane, le vecchie case
in rovina, l’acqua stagnante nei canali, le chiese malinconiche e i chiostri…». Quando in casa di Paul giunge Marietta, ella «canta una canzone, accompagnandosi con il liuto,
un canto di un “amore fedele votato alla morte”, che assume per Paul un grande significato. Marietta danza, eccitando i sensi del giovane. Cedendo alla seduzione, Paul tenta
di abbracciare la donna. Respingendolo e allontanandosi
da lui, ella resta impigliata nella tenda che cela il ritratto di
Marie; tentando di districarsi, scopre il ritratto. Non è forse
lei medesima, quella donna? Lo stesso scialle, lo stesso liuto? Ora però Marietta deve andare alla sua prova teatrale:
è Hélène in Robert le Diable di Meyerbeer». Quando Marietta lo lascia, Paul è combattuto tra la fedeltà alla memoria di
Marie e il nuovo incalzante desiderio. Percorso da una tensione che gli turba i sensi e l’anima, il giovane ha una visione. Gli sembra che Marie esca dal ritratto: è un’immagine
uscita dalla dolorosa e nostalgica fantasia o dai rimorsi della
coscienza. Paul giura a Marie di esserle rimasto fedele, ma il
fantasma lo esorta ad uscire, poiché un’altra lo chiama alla
vita. All’improvviso, in luogo di Marie il giovane vede Marietta che danza sfrenatamente.
Nel II atto, gli eventi musicali si avvicendano in modo addirittura clamoroso, e sono ancor più essenziali all’azione
scenica: anzi, tutt’uno con essa. Sulla sponda di un canale,
Paul rivela alle campane di Bruges, «ferrei confessori», le
ferite della sua coscienza. Quando la compagnia teatrale di
cui fa parte Marietta si avvicina in barca, cantando allegre
canzoni, la ragazza suggerisce di provare all’aperto la scena di Hélène da Robert le Diable. Victorin, direttore di scena,
fischietta il motivo della Risurrezione dall’opera di Meyerbeer. Dalla cattedrale viene il suono di un organo, mentre
le beghine appaiono spettrali alle finestre. Il cielo si copre di
nubi violacee e minacciose, e le campane suonano a morto.
La sceneggiatura è già in sé, nel suo gioco d’incastri sonori, una straordinaria drammaturgia musicale. Così, nel III
atto, la scena della processione sacra associa il coro dei fanciulli a un misterioso ritmo di marcia. L’invenzione musicale di Korngold procede tutta secondo la tecnica del montaggio e dell’ibridazione.
L’autore trae forza drammatica da due procedimenti inventivi. Il primo è l’elaborazione di brevi motivi fondati su
intervalli di quarta e di quinta, caratterizzanti i diversi momenti dell’azione con lievi sfumature di linea melodica. Il
secondo è l’improvviso turgore lirico che dilata l’espressione musicale e sembra immobilizzarla in una sorta di estasi
allucinatoria. Una spettrale e tragica sembianza nasce così,
a tratti, da semplici e graziosi elementi di musica «già data»:
la canzone popolare intonata da Victorin, «Ja, bei fest und
Tanz», la romanza da salotto «Mein Sehnen, mein Wähnen»
cantata da Fritz, il Pierrot della compagnia; l’aria di Marietta, «Glück das mir verlieb» nello stile della giovane scuola italiana detta impropriamente «veristica». La scena del II
atto in cui Marietta, spiata da un Paul geloso e tormentato,
civetta con il ballerino Gaston, ci ricorda molto da vicino
Il tabarro pucciniano. A volte, con efficace logica espressiva fondata sul rovesciamento di situazione mediante inversione dei procedimenti musicali, il
repentino inturgidirsi della melodia è
sostituito dal
suo contrario:
l’invenzione
melodica si fa
esile, diventa
l’ombra di se
stessa, si frantuma. Il motivo che emerge
dall’orchestra
nella scena in
cui il fantasma di Marie
esce dal ritratto (una scena
che ci ricorda
un’opera amatissima da Korngold, Les contes d’Hoffmann di
Hoffenbach) assume la funzione di idée fixe nella coscienza
di Paul. Quando la larva di Marie, rientrando lentamente
nel ritratto in un alone di nebbia, pronuncia le terribili parole «Unsere Liebe war, ist und wird sein» («il nostro amore
fu, è e sarà»), quel motivo si spezza in frammenti. Ma quando, alla fine dell’opera, il motivo suona per l’ultima volta,
dilatato, nelle parole di Paul:
Leben trennt vorn Tod –
grausam Machtgebot.
Harre mein in lichten Höh’n –
hier gibt es kein Auferstehn.
La vita si separa per sempre dalla morte –
crudele volontà d’implacabile sorte.
Tu nella luce arrendimi, lassù –
risurrezione qui non c’è, mai più.
esso è di nuovo ricomposto, e la sua originaria unità è la
memoria di un passato irrecuperabile. ◼
all’opera
all’opera — 21
Venezia - Calle Minelli
S. Marco 1887-1888
30124 - Venezia (Italy)
Tel. +39-041-5203329
Fax +39-041-2415940
www.duodopalacehotel.com
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
«La città morta»
di Korngold
secondo
Pier Luigi Pizzi
Pier Luigi Pizzi firma regia, scene e costumi della Città morta di
Erich Wolfgang Korngold, di scena alla Fenice dal 23 al 31 gennaio.
In questo intervento illustra le linee generali del suo allestimento.
T
utto nasce da Bruges-La-Morte di Georges Rodenbach, un
romanzo
breve che racconta la storia di autoann ientamento del protagonista: costui, perduta la moglie, si trova a vivere una inqu ietante esperienza, credendo
di riconoscere in
una donna che incontra per la strada una sosia della
morta. Pensa in tal
modo di poter ricostruire il passato, cosa che si rivela falsa e impossibile, per quanto la
somiglianza tra le
due donne sia perfetta. Nonostante
l’incredibile conformità esteriore si
rende progressivamente conto che la
spiritualità, la sensibilità e i sentimenti della donna
che aveva amato
per dieci anni non
possono essere gli
stessi. Nel testo di
Rodenbach la città che fa da teatro
a questa vicenda è
caratterizzata dalle
sue atmosfere grigie e nebbiose, intrise di mistero. La sposa perduta si identifica continuamente con la città, anch’essa morta, che attraverso la sua
impalpabilità riflette lo stato d’animo del protagonista, le
sue angosce, i suoi smarrimenti e la sua inesausta ricerca
di un amore perfetto che non si può più ritrovare. Inseguendo questa utopia lui, come la città, affonda nelle acque morte.
Quest’ambientazione, così poetica e coinvolgente, ha
suggestionato Erich Wolfgang Korngold, che ha com-
«
posto un’opera densa di atmosfere romantiche e liriche,
che mettono in evidenza il senso di disfacimento vissuto dal protagonista, descrivendo con la musica il suo stato d’animo altilenante, che oscilla perennemente tra slanci e ripiegamenti.
Questa è l’opera che mi trovo a dover allestire, senza tradirla e cercando una analogia tra la città e la storia narrata.
In questo senso fondamentale è l’idea che questa città sia
costruita sull’acqua, perché oltre a corrispondere allo stato emotivo dei personaggi fa nascere immediata una forte similitudine con Venezia. Alla Fenice, è naturale prendere a modello proprio Venezia, tanto più che questa mia
nuova esperienza segue in modo diretto quella dell’anno
passato, quando diressi Death in Venice di Benjamin Britten. Per molte ragioni questa è in qualche modo la continuazione di quello spettacolo, quasi formassero un
discorso unitario.
Come allora avevo posto l’accento su un’atmosfera
lagunare fatta di
nebbie, di smarrimenti, di angosce
e l’annientamento
del personaggio
era messo a confronto con questa
città proprio così adesso in Korngold ripropongo il
clima inquietante di un percorso verso la morte
e verso l’impossibile realizzazione
dei propri ideali.
Per quanto riguarda la traduzione in immagini di queste sensazioni, ho dato
un ruolo da protagonista all’acqua, che sarà sempre presente sulla
scena. Ma funzione non secondaria avrà la nebbia,
che simboleggia il
comporsi e subito
dopo il disperdersi, del percorso intimo del protagonista. Sono stati
d’animo di grande speranza che si alternano ad altri di cupa disperazione, quando si fa strada la consapevolezza che
questo ritrovamento non ha riscontro nella realtà. Questa dicotomia sentimentale attraverso la musica raggiunge momenti di grande emozione, nei quali è facile riconoscersi, perché ognuno di noi coltiva sogni impossibili. Venezia, come accadeva in Death in Venice, è evocata attraverso immagini della memoria, accenni ad una realtà onirica
e riproposta in una dimensione mentale e poetica.» (l.m.) ◼
all’opera
all’opera — 23
24 — all’opera
Le voci di
«Norma»
S
di Marco Beghelli
del peso strettamente drammatico-musicale si suol dire che Norma è di fatto un’opera a un
solo personaggio: la protagonista. La giovane Adalgisa, infatti, è una deuteragonista destinata a venire pian
piano fagocitata dalla personalità della Gran Sacerdotessa Norma, fino a scomparire del tutto nel momento in cui
all’opera
ul piano
al virtuosismo leggero di «Ah! bello a me ritorna». Siamo
insomma di fronte a un personaggio vocalmente caleidoscopico, di quelli fatti apposta per mettere in vetrina tutte le doti canore e interpretative delle grandi primedonne
che hanno avuto la forza d’affrontarlo, una parte che non
richiede cioè soltanto perfezione tecnica sul piano musicale, né forse una pasta vocale di particolare pregio timbrico,
ma soprattutto un’interprete a tutto tondo, una grande attrice capace di cantare in modo superbo.
Non per nulla Bellini scelse l’argomento dell’opera e costruì la partitura su misura per Giuditta Pasta (1797-1865),
colei che l’autore stesso ebbe a chiamare «l’Angiolo Enciclopedico» (lettera del 28 aprile 1832): come dire, la voce
Giulia Grisi
il dramma raggiunge il suo culmine; Pollione è né più né
meno quello che Guido Pannain ebbe a definire «un grullo di tenore», tutto muscoli e poco cervello; Oroveso infine non porta a compimento quella parte di monumentale imponenza che la sua prima apparizione sembrerebbe prometterci, rimanendo un personaggio sfuocato destinato allo sfondo della vicenda principale. A dispetto di
tutto ciò, cantanti di prima sfera si sono alternati in quasi due secoli nei quattro ruoli principali dell’opera, attirati evidentemente dalle peculiarità vocali messe in campo
da Bellini.
Nella parte di Norma si susseguono uno dopo l’altro tutti i tratti canori del belcantismo primo-ottocentesco: c’è il
canto estatico di «Casta diva» così come il canto vibrato di
«Già mi pasco ne’ tuoi sguardi», l’effusione patetica di «Teneri figli» come lo scatto d’ira di «Oh non tremare, o perfido», la declamazione austera di «Sediziose voci» accanto
Giuditta Pasta
sovrumana capace di esprimere tutte le passioni della natura umana. Sul piano dell’estensione, la sua non doveva
essere una voce propriamente sopranile, ma più centrale, condividendo in ciò la natura canora di altri due grandi cantanti dell’epoca: Isabella Colbran e Maria Malibran,
emblemi per noi, oggi, del canto sopranile primo ottocentesco e nondimeno caratterizzate da una vocalità che diremmo piuttosto mezzosopranile (per il fratello Manuel
García jr., il più grande didatta del canto ottocentesco, la
Malibran era da considerarsi senza meno un contralto).
Ciò non impedì alla Pasta come alla Malibran di eccellere
anche in parti che siamo abituati a etichettare da soprano
leggero, Sonnambula innanzitutto, che l’una tenne a battesimo e di cui l’altra fece un cavallo di battaglia.
Secondo Stendhal, che le dedicò un intero capitolo nella
sua Vita di Rossini, «La voce della signora Pasta ha una considerevole estensione. Essa rende in modo ancora sonoro
il La sotto il rigo, e si alza fino al Do diesis e al Re acuto. La
signora Pasta possiede il raro vantaggio di poter cantare la
musica di contralto come quella di soprano. Oserei dire,
malgrado la mia poca dottrina, che la sua voce è di mezzosoprano. Il maestro che scrivesse per lei dovrebbe porre la
tessitura ordinaria dei suoi canti nella voce di mezzosoprano e servirsi poi, di passata, di tutte le altre note di un organo così ricco. Molte di esse sono non soltanto belle, ma
producono una vibrazione sonora e magnetica la quale, io
credo, per una miscela d’effetti fisici non ancora spiegati,
s’impadronisce con la rapidità del fulmine dell’anima degli spettatori. Ed eccoci così a considerare una particolarità molto singolare della voce della signora Pasta: essa non è
di un solo timbro, e questa
differenza nei suoni di una
stessa voce è uno dei più
potenti mezzi d’espressione di cui sa valersi tale ottima cantatrice».
Questa era dunque Giuditta Pasta; e questa, a ben
guardare, è di fatto anche
Norma, con la sua estensione ampia e impervia,
con la necessità di modificare il colore della voce
al variare delle situazioni drammatiche e delle rispettive intonazioni canore, difficoltà che solo una
grande cantante riesce a
superare, grazie a un severo e incessante studio,
come quello cui la Pasta
si sottopose quotidianamente per dominare un
organo vocale tutt’altro
che duttile e omogeneo in
natura.
Suo contraltare in quel
26 dicembre 1831 alla Scala – serata che rappresentò
il debutto non solo di Norma ma anche della stessa
Pasta nel maggiore teatro
Maria Callas
milanese – fu Giulia Grisi
(1811-1869), vero soprano
al contrario della collega,
che le cronache ci dicono per converso dotata di una voce limpida e fluente, agile e omogenea in tutta la sua gamma, disposta a sacrificare sin l’articolazione verbale e la varietà espressiva pur di non intaccare la bellezza del suono:
una dose di «superficialità» caratteriale che ben si sposava
con il personaggio più giovane e per certi versi ingenuo di
Adalgisa, come con quello di Elvira nei Puritani e di Norina nel Don Pasquale che più tardi Bellini e Donizetti scriveranno per lei: «Dagli la Sonnambula, i Puritani, la Gazza ladra, e mille opere di genere semplice ed innocente, ti posso giurare che non sarà seconda a persona, ma nei caratteri elevati, non li capisce, non li sente, perché non ha né
tale istinto, né istruzione per sostenerli con quella nobiltà ed alto stile che richiedono; dunque sarà mio sentimento che nella Norma sarà nulla, e la parte d’Agaldisa è la sola che s’adatta al suo carattere», commentava lo stesso Bellini (1 luglio 1835) alla notizia che in Londra la Grisi si era
cimentata con il ruolo della protagonista, sortendone «un
solenne fiasco».
Eppure la tradizione interpretativa dell’opera nei centocinquanta e più anni che seguirono tolse ad Adalgisa proprio quel manto di giovanile innocenza con cui l’aveva rivestita Bellini, man mano che la strada del teatro romantico procedeva sul sentiero della contrapposizione canora fra le due rivali di un melodramma, etichettando in via
automatica come soprano la protagonista, come mezzosoprano la sua controparte amorosa: Elisabetta ed Eboli, Aida e Amneris, Gioconda e Laura. Ed ecco allora che anche
Norma divenne presto appannaggio di soprani propriamente detti (la stessa Grisi, come s’è visto) mentre Adalgisa
per contrapposizione timbrica fu affidata ai mezzosoprani, non senza interventi sulla scrittura belliniana per adattare le vecchie parti alle nuove interpreti a suon di trasporti tonali e scambio delle linee vocali nei pezzi d’assieme. Solo a partire dagli anni settanta del secolo
scorso una nuova consapevolezza filologica ha indotto alcuni spiriti illuminati a ripristinare gli equilibri originali, a partire almeno da quella produzione di per sé storica voluta
da Rodolfo Celletti al Festival di Martina Franca
(era il 1977), che affiancava
per la prima volta in epoca
moderna una Norma con
voce brunita di mezzosoprano acuto (Grace Bumbry) a un’Adalgisa sopranile quanto mai chiara e
delicata (Lella Cuberli).
Quella che avrebbe dovuto imporsi come l’occasione d’avvio per un nuovo corso esecutivo rimase
tuttavia lettera morta per
molti anni ancora, al punto che tutt’oggi suona come eccezione e non come regola un’Adalgisa in voce di soprano, tale e quale la previde Bellini.
Alla Scala, nel 1831, Pollione fu il tenore Domenico
Donzelli (1790-1873), sul quale molte sciocchezze sono
state scritte negli ultimi tempi: ad esempio, che si trattasse di un «tenore centrale», praticamente un baritono, che
saliva con voce robusta fino al Sol, oltre il quale emetteva gli acuti con la tecnica del falsettone. E tutto ciò in forza d’una lettera scritta a Bellini mentre questi s’accingeva
a comporgli la parte, in cui dichiarava: «L’estensione, dunque, della mia voce è quasi di due ottave, cioè dal Re basso
[Re2] al Do acuto [Do4]. Di petto, poi, sino al Sol [Sol3]; ed
è in questa estensione che posso declamare con egual vigore e sostenere tutta la forza della declamazione. Dal Sol
alto al Do acuto posso usare di un falsetto che, impiegato
con arte e forza, dà una risorsa come ornamento» (3 maggio 1831). Ora, non è questa la sede per ripercorrere anco-
all’opera
all’opera — 25
all’opera
26 — all’opera
ra una volta la storia sull’equivoco nato attorno al fraintendimento moderno del termine falsetto, che all’epoca non significava per gli italiani lo sbiancamento caricaturale della voce virile, ma né più né meno che la gamma superiore della voce, raggiungibile con il cosiddetto «passaggio di
registro», cioè il cambiamento della modalità di emissione, dal registro con risonanze «di petto» al registro con risonanze «di testa»: un passaggio che qualunque tenore ha
sempre dovuto attivare e sempre attiverà per raggiungere
gli estremi acuti, con buona pace di coloro che si ostinano
a parlare di «Do di petto» ed espressioni simili, del tutto
insostenibili sul piano della fisiologia umana.
Con quella lettera, Donzelli comunicava semmai a Bellini di essere un tenore in piena regola, e non un baritono,
come del resto dimostra ampiamente il repertorio ch’era
uso a cantare, da opere rossiniane come L’inganno felice e La Cenerentola (e Rossini scrisse espressamente
per lui la parte del protagonista in Torvaldo e Dorliska, nonché il Cavalier Belfiore del Viaggio a Reims) a ruoli affatto tenorili come quelli del Pirata e
della Straniera belliniani, della Parisina e della
Lucia di Lammermoor donizettiane, della Muta
di Portici di Auber. Certo, Bellini affermava
che «Donzelli non potrà cantare il Pirata,
perché gli si dovrebbe trasportare tre toni sotto» (2 agosto 1828), e sappiamo di
fatto quanto gli interpreti
dell’epoca fossero scaltri
nell’adattare le parti vocali alla propria specifica tessitura; ma è anche vero che quella del
Pirata è una parte iperacuta, pensata a misura di Giambattista Rubini, mentre Donzelli parrebbe essere stato un tenore «normale». Sennonché proprio nel corso di quegli anni trenta il buon
Donzelli – al pari d’altri
suoi colleghi, Gilbert
Duprez in primis – stava procedendo verso
una profonda modificazione timbrica dell’emissione, ottenuta sfruttando
al massimo la cassa di risonanza offerta dal cavo orale, alzando esageratamente l’arco del
palato e arretrando il più possibile la radice della lingua per
raggiungere quella posizione, detta «dello sbadiglio», che
amplia notevolmente gli spazi vuoti all’interno della bocca. L’effetto ottenuto era una voce più potente e più scura (voix sombrée) da cui l’apparente effetto di una emissione tutta di petto fino agli estremi acuti (il sedicente «Do
di petto», spacciato come presunta invenzione di Duprez):
un’emissione che, abbandonate le esagerazioni della prima
ora, è stata poi ereditata da tutte le generazioni successive,
fino ai giorni nostri.
Tale ricerca spasmodica di un volume sonoro sempre
più ampio e potente si ritorceva naturalmente contro altre
componenti che il belcantismo d’inizio Ottocento aveva
pur accarezzato: quello della pronuncia chiara e nitida, ad
esempio, che l’abbassamento forzato della radice della lin-
gua inficiava invece notevolmente. Così scriveva nel 1842
Alberto Mazzucato sulla «Gazzetta Musicale di Milano»:
«Qualunque artifizio di pronunzia, sia in raddolcimento di
consonanti sia in ristringimento di vocali, sia persino nell’introduzione di alcune consonanti o vocali pienamente
estranee alle parole sottoposte alla musica, tutto era adoperato allo scopo del maggior volume vocale, al quale unicamente sembravasi aspirare. E vogliamo lusingarci che
non ci si griderà alla bestemmia se asseriamo – cosa in fatto da noi scrupolosamente osservata – che Donzelli, a modo d’esempio, nella sua sortita del Bravo [di Mercadante,
alla Scala nel 1839], dove si presenta colle seguenti parole “Trascorso è un giorno eterno, ecc.”, non altrimenti interpretava che così: “Troscuorso è un giuoreno etereno”.
E più sotto: “Par che un nemico Iddio m’abbia sul petto /
nell’ira sua questo pugnal cacciato”, che egli precisamente verteva: “Por che un nemico Iddiho m’obbio sul
pettmuo | nell’iro suo questo pugniol cocciotmuo”.
Dall’osservazione delle quali poche parole ognuno
può inferire qual novella forma dovessero prendere i concetti del poeta».
Pollione si trovò dunque a costituire una
delle tappe che condussero, con Donzelli ed altri, a tali esagerazioni espressive,
incontrando terreno fertile in un personaggio fiero e vibrante, come dev’esserlo un vero proconsole romano. È del resto lo stesso Bellini a invitare l’interprete a
un’emissione forte e maschia, quando prescrive «Canto vibrato» nella cabaletta «Me protegge, me difende», mentre in numerosi altri
luoghi della partitura
sembra prendere alla
lettera le richieste del
primo interprete che
si diceva capace, in
zona centrale, di «declamare con egual vigore e sostenere tutta la forza della deDomenico Donzelli
clamazione». Persino
l’occasionale Do acuto che in quella lettera Donzelli mette a disposizione del compositore quale «falsetto che, impiegato con arte e forza, dà una risorsa come ornamento» viene prescritto da Bellini nel tempo lento della cavatina «Meco all’altar di Venere»: e proprio quale «ornamento», vale a dire come variante melodica della frase «eran rapiti i sensi» testé intonata, che in
quanto variante può benissimo essere tralasciata (come
capita nella maggioranza dei casi in sede esecutiva), ovvero sostituita a sua volta con qualcosa d’altro. Questa è
la vera filologia applicata al «belcanto» sette-ottocentesco,
non già l’esecuzione supina del segno scritto, a dispetto
del «malcanto» che potrebbe eventualmente derivarne! ◼
Per gentile concessione dell’editore Bongiovanni – Bologna
Il capolavoro di Bellini
al Verdi di Trieste
Dal 20 febbraio al 3 marzo al Teatro Verdi di Trieste va in scena
Norma di Vincenzo Bellini, con la direzione d’orchestra di Julian
Kovatchev e la regia di Federico Tiezzi. All’artista toscano chiediamo di raccontare la sua interpretazione dell’opera.
I
l mio allestimento di Norma risale al ‘91, quando mi ven-
che credo piuttosto inedito, anche se si tratta di un nesso palese, che sta davanti agli occhi di tutti, a cominciare dalle coincidenze cronologiche. Tutta l’opera – per quanto avvenga in costumi neoclassici, per quanto i bimbi giochino con un trenino,
un cerchio e un pallone, per quanto tutta l’imagerie sia fortemente tardoneoclassica e premoromantica, come se tutto fosse illuminato da Friedrich – deriva il suo senso primario dalle notazioni che Leopardi ci ha lasciato a proposito della luna, o più precisamente dalle riflessioni che la potenza energetica della luna
ha suscitato in un poeta come lui. Partendo da questa “tavola di
orientamento”, ho cominciato a lavorare sull’allestimento, nel
quale, attraverso degli enormi screen blu, viene ricostruito uno
spazio emotivo in cui la scenografia nei suoi movimenti dinamici possa diventare espressiva della musica, ricongegnare cioè
scenograficamente, spazialmente, e quindi nel movimento degli attori, l’espressività della partitura. Non mi interessa affatto
che si illustri quello che dicono le parole: mi interessano invece i conflitti che caratterizzano la musica, in modo particolare
quella di Bellini e di Verdi.
Come riferimenti principali ovviamente mi sono rivolto alla
Medea di Euripide e alla Velléda dei Martyrs di Chateaubriand.
Ma questo sta sullo sfondo, la mia Norma è una maga, e per co-
ne commissionato dal Petruzzelli di Bari poco prima del
drammatico incendio. Fu la mia prima collaborazione con
Mario Schifano, e anche l’unica andata ad effetto, perché purtroppo lui venne a mancare prima di completare il nostro progetto per Madama Butterfly. In realtà fu anche il
mio primo lavoro di teatro musicale: allora avevo portato a Bari la mia versione della Divina Commedia, alla
quale avevo lavorato con poeti come Edoardo Sanguineti, Mario Luzi e Giovanni Giudici. Quello spettacolo aveva un impianto di tipo “operistico”, con una spasmodica attenzione alla musica, e probabilmente fu per
questo che in quell’occasione mi fu chiesto di provarmi
nella regia lirica. Accettai con entusiasmo, proponendo di lavorare insieme a Schifano, che era da tempo un
mio desiderio, e così nacque l’esperienza di Norma. Lo
spettacolo andato in scena a Bologna questa primavera – che passerà per Trieste per poi infine approdare di
nuovo a Bari, festeggiando anche simbolicamente la
riapertura del Teatro – nelle sue diversità, conserva il
disegno originario: si tratta cioè di una Norma al contempo neoclassica e ossianica. A Schifano avevo chiesto di concentrare il suo lavoro su due elementi nordici: una quercia, simbolo che richiama direttamente un
certo tipo di natura, e la luna, elemento allo stesso tempo naturale e rituale che presiede alla malinconia. Questo era per me molto importante, perché volevo legare
Norma a quella lunacy che Shakespeare riferisce ad Amleto, uno dei personaggi più amati dalla letteratura che
sta a cavallo tra tardo Neoclassicismo e prime avvisaglie del Romanticismo. La lunacy è una specie di lanNorma nella versione di Federico Tiezzi
guore malinconico, una follia della mente, un’astenia
che normalmente viene attribuita o ai pazzi oppure ai
veggenti, un sentimento quindi assolutamente calzante per il personaggio di Norma.
Più di quindici anni dopo, insieme a Pier Paolo Bisleri, che anstruire la sua figura sono tornato con la memoria ai meraviglioche nel ‘91 aveva collaborato alla concezione delle scene, abbiasi gesti di Maria Callas: di questa incredibile gestualità nei primo riconcepito tutta la scenografia – mentre i costumi, che erami anni ottanta avevo discusso con Jerzy Grotowski, e ci erano di Ruggero Vitrani, ora sono di Giovanna Buzzi – e ci siavamo trovati d’accordo nel definirla una prova di grandissimo
mo orientati su un’opera che ha qualche differenza rispetto alteatro interiore.
la precedente, anche se molti restano i tratti coIn questa nuova versione – oltre a utilizzare un
muni. Abbiamo reimmerso di nuovo tutta Normucchio di scene di Schifano – ho potuto anche
– Teatro Verdi
ma dentro un blu profondo, il blu della notte, al- 20,Trieste
24, 26 febbraio, ore 20.30 ricostruire alcuni bellissimi fondali firmati da
l’interno del quale si svolge per gran parte la vilui, che però non avevamo potuto utilizzare per21 febbraio, ore 16.00
cenda. C’è una presenza ossessiva della luna e
ché erano arrivati fuori tempo massimo. E in
28 febbraio, ore 17.00
della luce lunare, che collegano la Norma di Belquesto modo ho potuto riandare con il pensie1 marzo, ore 16.00
3 marzo, ore 20.30
lini direttamente a Leopardi, un accostamento
ro a tutte le nostre discussioni di allora… (l.m.) ◼
all’opera
La «Norma»
lunare e
leopardiana di
Federico Tiezzi
all’opera — 27
28 — all’opera
la Biennale del Mediterraneo
La musica di Rota
per l’«Impresario
delle Smirne»
Luca De Fusco allestisce
alla Biennale il testo
goldoniano
V
a in scena al Teatro Malibran, al-
all’opera
l’interno della programmazione della Biennale di Maurizio Scaparro, L’impresario delle
Smirne di Carlo Goldoni, con la
regia di Luca De Fusco e le musiche che Nino Rota aveva composto cinquant’anni prima per l’allestimento della Fenice firmato
da Luchino Visconti. Francesco
Lombardi, curatore dell’Archivio
«Nino Rota» presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, ci parla
di queste partiture.
«Rota era un uomo disordinatissimo, ma conservava tutto, il che
rende abbastanza scontato che quello che
Festival
Internazionale
del Teatro
diretto da Maurizio Scaparro
Venezia
20 Febbraio–8 Marzo 2009
non è stato perduto dopo la sua morte, o regalato in vita, pian
piano riemerga. Per quel che riguarda le musiche teatrali è rimasto davvero molto, contrariamente a ciò che a volte accade per
altri autori, avendo questo tipo di repertorio una vita generalmente limitata alla produzione dello spettacolo. L’impresario delle Smirne – allestimento molto ricco, come altrimenti non sarebbe potuto essere uno spettacolo di Visconti – debuttò alla Fenice l’1 agosto del 1957 per la direzione di Bruno Nicolai, maestro
spesso coinvolto nell’ambito della musica da film. Se si considera il catalogo di Rota, tutto è connesso, quindi la musica per il cinema ha spesso dei riferimenti tematici che si sono travasati nelle composizioni concertistiche. L’impresario delle Smirne ha al suo
interno uno dei temi del Padrino, così come – seppure declinato
in modo completamente diverso – Il padrino si ritrova anche in
Fortunella di Eduardo De Filippo.
Negli ultimi anni di attività Rota era un musicista non solo
molto affermato, ma anche oberato da impegni. Decidere di
fare ancora musiche di scena, quindi, era una scelta certamente non dettata da motivi di interesse ma dal piacere di creare della musica d’uso, “dedicata”, basata su un testo. E
questo contribuisce a tratteggiare la figura di un compositore che ha comunque sempre considerato l’aspetto
artigianale un elemento molto importante del proprio lavoro: una risposta personale e originale in un’epoca
in cui sul creatore di musiche si accalcavano responsabilità totalizzanti legate
alla crisi dei linguaggi e alla necessità di inventare una
musica nuova. La risposta di
ota
Rota
è dunque quella di aderiR
Nino
re alla maggior fonte di commissione commerciale del suo secolo: il
cinematografo, limitando quindi di molto la propria libertà creativa. Se infatti la musica nel cinema è senz’altro importante, tuttavia
l’autore della colonna sonora rimane sempre alla stregua di un collaboratore, a volte sicuramente indispensabile come nel caso del connubio Rota-Fellini, ma comunque mai nell’occhio di bue
che invece sosta sul regista. E nel teatro il ruolo è ancora più “di servizio”. Poi è ovvio che ci siano spettacoli teatrali dove la musica ha certamente un ruolo determinante. Ed è proprio questo il caso dell’Impresario delle Smirne. Altre
volte ancora è accaduto che le musiche siano state spunto diretto di trasposizioni cinematografiche: è il caso per esempio
di Romeo e Giulietta di Zeffirelli che prima è stato rappresentato in teatro a Londra e che successivamente lo stesso regista ha
trasformato in film utilizzando le medesime musiche». (i.p.) ◼
Musiche per le scene di Nino Rota
1. Suite per pianoforte a quattro mani di
accompagnamento alla lettura della favola di
Nino Rota Storia del mago Doppio e della fata Giglia
1919
2. Musiche di scena per l’azione teatrale di
Pietro Metastasio L’isola disabitata 1931
3. Musiche di scena per lo spettacolo di Sergio
Tofano L’isola dei pappagalli con Bonaventura
prigioniero degli antropofagi 1936
4. Musiche di scena per la rivista di Giovanni
Mosca Nuvolinaria, liberamente tratta da
Aristofane 1941
5. Musiche di scena per la commedia di Eugène
Labiche Si jamais je te pince!.… 1941
6. Musiche di scena per la commedia di William
Shakespeare La dodicesima notte... o quel che volete
1944
7. Musiche di scena per la rivista teatrale Il suo
cavallo di Steno, Renato Castellani, Aurel M.
Milloss 1944
8. Musiche di scena per il dramma di Ugo Betti
Spiritismo nell’antica casa 1950
9. Musiche di scena per Liliom Leggenda in 7
quadri di Ferénc Molnar 1950
10. Suite musicale per piccolo ensemble di
accompagnamento alla lettura radiofonica
della novella Cristallo di Rocca di Adalbert Stifter
1950
11. Musiche di scena per la commedia Il mondo
della noia di Édouard Pailleron 1954
12. Musiche di scena per la commedia
L’Impresario delle Smirne di Carlo Goldoni 1957
13. Musiche di scena per la commedia in tre atti
di Katy Frings Veglia la mia casa, Angelo 1958
14. Musiche per il radiodramma La contadina
furba di Cesare Vico Lodovici 1958
15. Musiche di scena per la tragedia Romeo e
Giulietta di William Shakespeare 1960
16. Musiche di scena per L’Arialda di Giovanni
Testori 1960
17. Musiche di scena per la commedia Dommage
qu’elle soit un p… di John Ford 1961
18. Musiche di scena per la commedia Much Ado
About Nothing di William Shakespeare 1965
19. Musiche di scena per la commedia Il Contratto di
Eduardo de Filippo 1967
20. Musiche di scena per la commedia Il Monumento
di Eduardo De Filippo 1970
21.Musiche di scena per la commedia Napoli
Milionaria di Eduardo De Filippo 1971
22. Musiche di scena per la cicalata del tempo
e del luogo Ogni anno punto e da capo di Eduardo
De Filippo 1971
23. Musiche di scena per la commedia in tre atti
di Eduardo Scarpetta Lu curaggio de nu pompiere
napulitano 1975
24. Musiche di scena per la commedia in tre
atti di Eduardo Scarpetta Li nepute de lu sinneco
1975
25. Musiche di scena per l’atto unico di Eduardo de
Filippo Gennareniello 1978
26. Musiche di scena per l’atto unico di Eduardo De
Filippo Quei figuri di tanti anni fa 1978
27. Musiche di scena per la commedia in 5 atti
di William Shakespeare La dodicesima notte... o
quel che volete 1979
all’opera — 29
A Bassano un allestimento
contemporaneo
e sperimentale
di Arianna Silvestrini
Venerdì 12 dicembre il Bassano Operafestival ha presentato La Traviata nella versione di Denis Krief, che ha firmato anche le scene e i
costumi. Con l’occasione chiediamo al regista di raccontarci gli elementi della sua interpretazione in chiave contemporanea.
D
evo fare innanzitutto una premessa: non
penso che l’innovazione sia legata necessariamente all’epoca o alla rappresentazione storica della vicenda. La regia non è un trasloco d’epoca. Spesso si vedono degli allestimenti cosiddetti “contemporanei” costruiti con l’ambizione
di essere innovativi e che sono, in realtà, molto vecchi e senza senso; allo stesso modo si vedono, spesso, delle realizzazioni di impostazione più tradizionale che riescono a trasmettere una grande forza di
sperimentazione. Dipende poi molto anche dal pubblico; a mio avviso, il pubblico del teatro lirico non ha
ancora raggiunto una vera maturità, né intellettuale né critica, come invece è accaduto per il pubblico
della danza o della prosa. La mia Traviata non è altro
che una proposta, certo non definitiva, ma circostanziata rispetto al contesto e alle condizioni di regia, in
particolare rispetto al budget che avevo a disposizione. Ritengo che il pubblico sia interessato a questo, ad
accogliere cioè proposte nuove, e ritengo al contrario
che la morte del teatro stia invece nella routine. Il mio
allestimento è frutto di una scelta molto mirata che
ho compiuto rispetto al Veneto e alla lirica in Veneto. Nella storia del teatro italiano c’è una sorta di ombra malefica che incombe a ogni nuova interpretazione di quest’opera: è l’ombra della Traviata di Visconti, di cui peraltro non è rimasta alcuna incisione audiovisiva. Si tratta quindi di una memoria di qualcosa che nessuno, o pochissimi, hanno visto, ma che ha
dato adito a un certo “ciarpame” postviscontiano. Io
stesso mi sono confrontato con questa memoria ingombrante e per l’allestimento verdiano di Catania
ho voluto seguire quella tradizione. Ma non ero soddisfatto, perciò a Bassano ho intrapreso un’altra strada. Spero di essere riuscito a formulare una proposta
differente proprio in virtù del fatto di essermi liberato dell’antica Traviata. A Bassano ho dovuto fare i conti con un budget piuttosto ridotto, ma credo sia necessario tenere conto delle circostanze e trovare un modo adatto alle medesime e allo stesso tempo soddisfacente. Spesso a causa delle scarse risorse vengono
messi in scena degli spettacoli ridicoli, senza rigore e
senza criteri di qualità. Il risultato è pessimo. Ho preferito tenere conto di queste condizioni e su questa base inventare un
allestimento contemporaneo. Del resto la storia della Traviata
è assolutamente moderna: è la vicenda di una donna che con il
suo charme riesce a sedurre uomini potenti. Nella nostra epoca
ci sono moltissimi casi di donne che potrebbero assomigliare
«
alla protagonista. Una Violetta contemporanea potrebbe ad
esempio essere una modella famosa che, in un mondo in cui
regna la superficialità, riesce a ottenere i favori di uomini potenti. Questa storia è assolutamente attuale, perciò quello che
mi interessava era restituire precisamente l’atmosfera raccontata da Verdi. La mia, in fondo, è una proposta di new economy
del teatro d’opera, che ha un riferimento culturale molto forte nel gesto innovatore della Nouvelle Vague francese. Ritengo
che in questo periodo storico sia indispensabile creare un altro tipo di teatro, in cui non ci si occupi solo di gestire la tradizione ma di innovare e inventare allestimenti sinceri e onesti. È indispensabile un modo diverso di gestione dei teatri:
in Italia si cerca ancora di scimmiottare un teatro d’opera che
non c’è più. Sarebbe davvero importante ci fossero dei politici in grado di accogliere le novità. La politica è fondamentale
per il cambiamento, mentre spesso quello che interessa è solo
all’opera
La «Traviata»
secondo Denis Krief
Traviata, nella versione di Denis Krief
l’aspetto di mondanità. In Italia ci sono tanti artisti giovani di
talento, ma con un futuro professionale molto difficile. I cantanti selezionati in questa versione sono tutti giovani davvero
bravi e intelligenti, che mi hanno permesso di fare una vera regia di attori e di raggiungere un’enorme soddisfazione: nonostante tutto, l’Italia è ancora un grande serbatoio di talenti». ◼

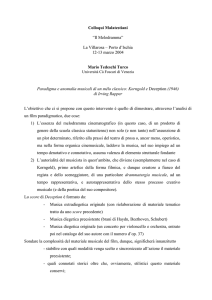

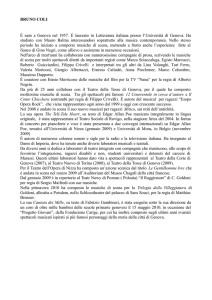

![Musica_e_immagine.pps [modalità compatibilità]](http://s1.studylibit.com/store/data/007566322_1-58d70b56b536a079f8882415348ab4fa-300x300.png)