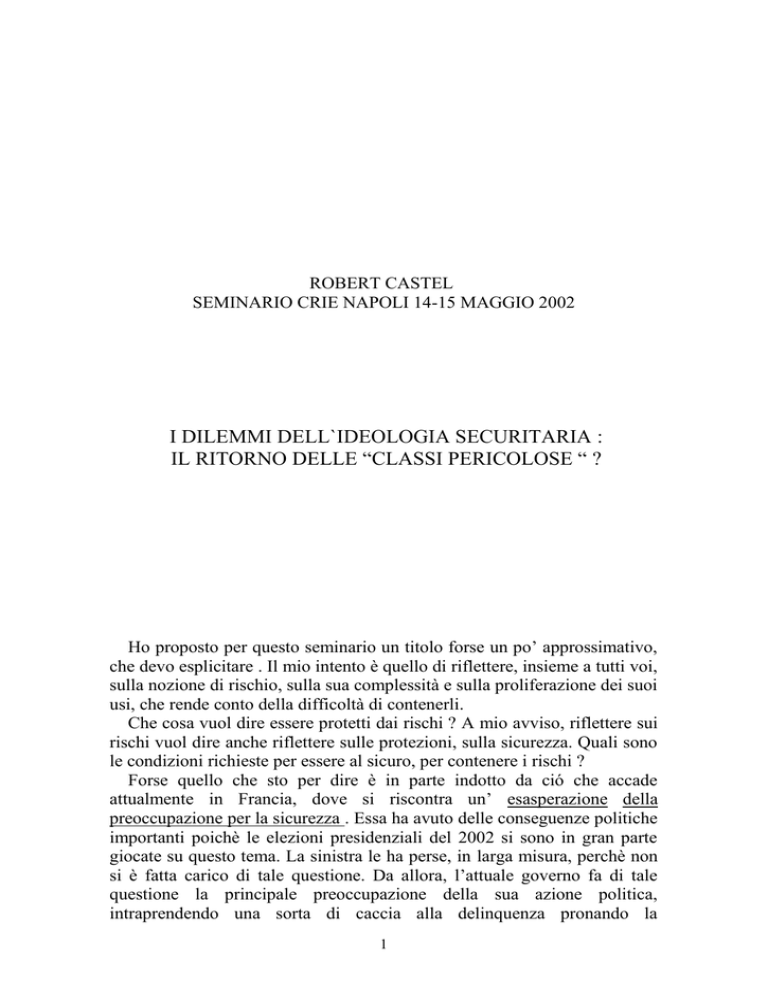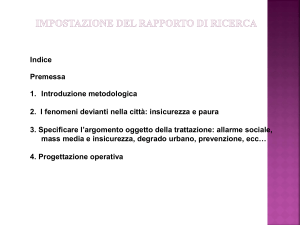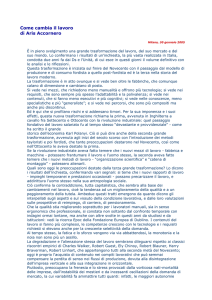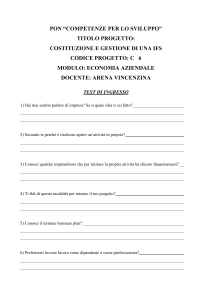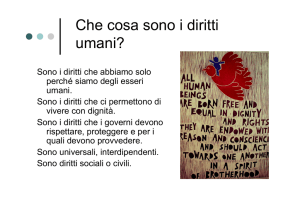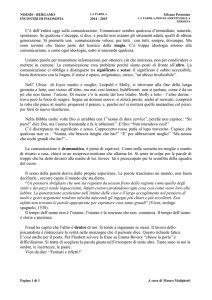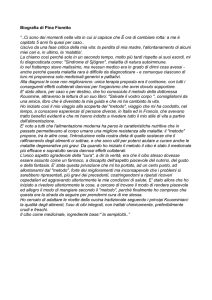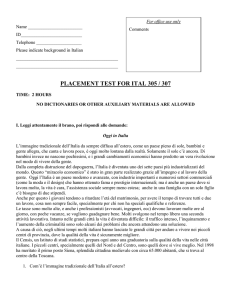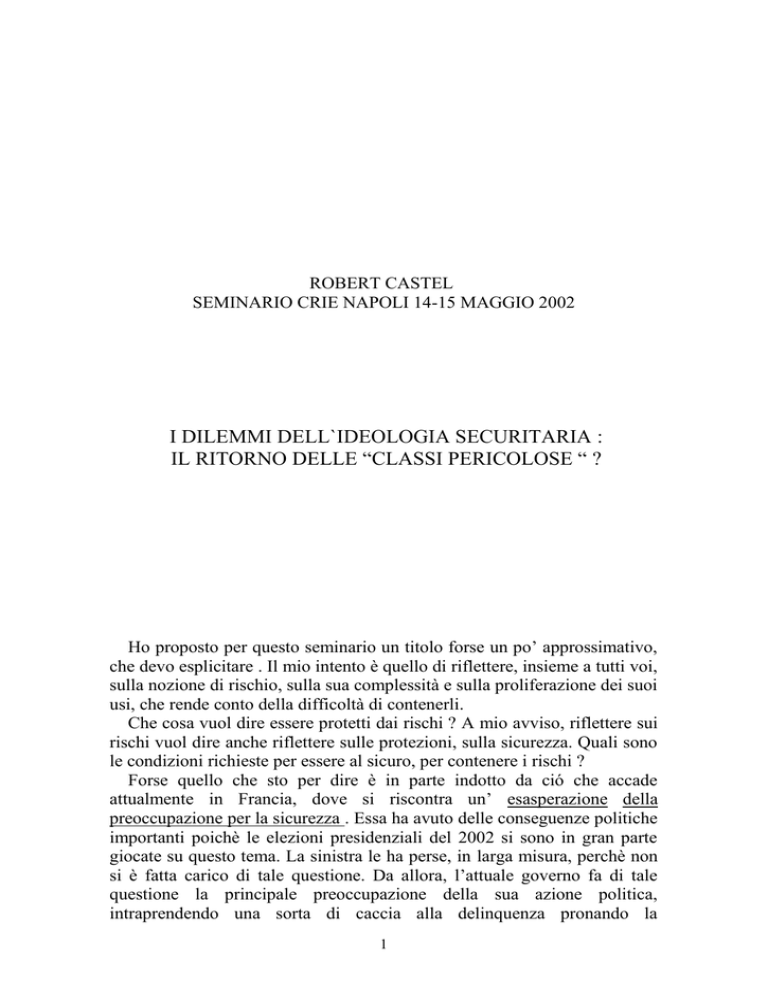
ROBERT CASTEL
SEMINARIO CRIE NAPOLI 14-15 MAGGIO 2002
I DILEMMI DELL`IDEOLOGIA SECURITARIA :
IL RITORNO DELLE “CLASSI PERICOLOSE “ ?
Ho proposto per questo seminario un titolo forse un po’ approssimativo,
che devo esplicitare . Il mio intento è quello di riflettere, insieme a tutti voi,
sulla nozione di rischio, sulla sua complessità e sulla proliferazione dei suoi
usi, che rende conto della difficoltà di contenerli.
Che cosa vuol dire essere protetti dai rischi ? A mio avviso, riflettere sui
rischi vuol dire anche riflettere sulle protezioni, sulla sicurezza. Quali sono
le condizioni richieste per essere al sicuro, per contenere i rischi ?
Forse quello che sto per dire è in parte indotto da ció che accade
attualmente in Francia, dove si riscontra un’ esasperazione della
preoccupazione per la sicurezza . Essa ha avuto delle conseguenze politiche
importanti poichè le elezioni presidenziali del 2002 si sono in gran parte
giocate su questo tema. La sinistra le ha perse, in larga misura, perchè non
si è fatta carico di tale questione. Da allora, l’attuale governo fa di tale
questione la principale preoccupazione della sua azione politica,
intraprendendo una sorta di caccia alla delinquenza pronando la
1
« tolleranza zero » : essere spietati verso i fattori d’insicurezza. E il
principale bersaglio di tali campagne sicuritarie sono soprattutto i giovani
che abitano quelle che in Francia si chiamano « le banlieues » : le periferie,
i quartieri deprivati che circondano le grandi città.
Questi giovani, spesso di origine immigrata, sono appena qualche
centinaio di migliaia, ma sono stigmatizzati e trattati come se costituissero
una classe pericolosa.
Una « classe pericolosa » : cosa vuol dire ? L’espressione rinvia al modo
in cui è stata qualificata una parte della classe operaia del XIX secolo. Vi
sono innumerevoli descrizioni di ció che allora veniva chiamato « il
pauperismo » : uno stato di miseria, ma anche di immoralità, delle
popolazioni ammassate alle periferie delle città industriali nella
promiscuità, nella sporcizia, nel vizio e nella delinquenza. « Classi
laboriose, classi pericolose », per riprendere il titolo del libro ben noto di
uno storico, Luis Chevalier, che esamina tali descrizioni (si puó anche
pensare ai Miserabili di Victor Hugo).
Simili descrizioni sono senz’altro esagerate, ma hanno trovato largo
consenso. Esse sono come la cristallizzazione, su una particolare frangia
della popolazione, di tutti i pericoli e tutte le minacce in cui una società si
possa imbattere. Mi pare che vi sia in questo uno schema ben delineato, che
aiuta a comprendere la sicurezza e l’insicurezza. Esso ha funzionato in
contesti storici e sociali molto diversi. Nelle società pre-industriali, si
potrebbe mostrare come i vagabondi abbiano giocato tale ruolo di gruppo
stigmatizzato su cui si cristallizzavano le paure della società dell’epoca. E
mi sembra che « la questione delle periferie » e dei giovani marginalizzati
oggi rinvii a questo stesso schema.
Torneró più diffusamene su questo tema, ma mi sembra illuminante per
comprendere in che modo si ponga la questione dell’insicurezza e più
precisamente la congiunzione, o l’addizione, di due tipi di insicurezza. Vi è
ció che si puó chiamare l’insicurezza civile, costituita da rischi che
riguardano l’integrità delle persone e dei beni : violenza, delinquenza, furti,
criminalità… Ma vi è anche l’insicurezza sociale , costituita dalle situazioni
nelle quali le persone non dispongono neppure delle risorse minime che
assicurino loro l’indipendenza e sono alla mercè del più piccolo incidente
di percorso che possa gettarli nell’incertezza del domani. Oppure vi sono
delle zone della vita sociale, come oggi le periferie urbane, in cui questi
due tipi di insicurezza si sovrappongono. A mio parere questo è un punto
strategico per cogliere i difficili problemi posti dal controllo dei rischi e vi
ritorneró più avanti.
La questione delle « classi pericolose » non è il mio solo proposito. E’
piuttosto un’illustrazione esemplare di una riflessione più generale che
vorrei proporre sulla nozione di rischio in rapporto alla questione della
sicurezza, che include anche la prevenzione dei rischi e la questione del
ruolo che lo Stato puó giocare in tali operazioni. In effetti è intorno alla
2
questione del controllo dei rischi che lo Stato ha trovato le sue
giustificazioi essenziali, che si tratti dello Stato di diritto, per lottare contro
l’insicurezza civile, o dello Stato sociale, per lottare contro l’insicurezza
sociale. Ma questo è un campo vasto e complesso, che non pretendo di
esaurire in questa sede. Desidero soltanto tracciare alcune linee di
discussione che mi sembrano importanti.
-La prima tenta di precisare in cosa consista la logica del rischio : che
cosa vuol dire iniziare a parlare in termini di rischi e di prevenzione dei
rischi ? Per non restare troppo in astratto, mi rifarò ad un ambito preciso :
quello della medicina mentale, della quale mi sono un tempo occupato.
Cosa implica parlare di rischi in tale contesto ? Di qui un primo enunciato
che potrebbe intitolarsi « dalla pericolosità al rischio » : delineare il nuovo
regime di pensiero e le nuove forme di azione che implica la volontà di
spingere la percezione del pericolo in direzione di una prevenzione dei
rischi in questo campo.
- In secondo luogo, ritengo si debba essere sensibili al fatto che vi sono
« diversi tipi di rischi » e diverse maniere di affrontare i rischi. Non ho la
pretesa di essere esaustivo, ma insisterò su due punti che mi sembrano
particolarmente importanti : il primo ruota attorno alla nozione di rischio
civile, che ho evocato a proposito della sicurezza dei beni e delle persone,
con alcuni dei problemi relativi alla volontà di sradicare e contenere i
rischi ; il secondo attorno al rischio sociale (cos’è un rischio sociale, come
controllarlo, in altri termini cos’è la sicurezza sociale nel senso forte del
termine. Questo è il punto sul quale insisterò maggiormente, perchè
costituisce anche il nucleo del Welfare State ;
- Infine, abborderò più rapidamente alcune questioni che ruotano attorno
a quella che possiamo chiamare una « nuova generazione di rischi »,
ecologici e tecnologici, che rende ancor più complessa la problematica dei
rischi .
Indico sommariamente quale sarà la linea guida del mio intervento.
Credo si debba prendere sul serio il tema dei rischi, ma sono altrettanto
convinto che si debba diffidare di una certa inflazione contemporanea del
riferimento al rischio, contropartita del bisogno disperato di sicurezza che
dissolve al limite la possibilità stessa di essere protetti. Riflettere sul rischio
forse vuol dire anche interrogare le ideologie della prevenzione totale e del
controllo assoluto di tutti i flagelli dell’esistenza, che sono irrealistiche e
persino politicamente pericolose.
Ma tali propositi sono evidentemente fatti per essere discussi e spero che
potremo avere degli scambi aperti su tali questioni. Aggiungo che se vi
sono altri punti per voi interessanti che non rientrino nella linea da me
tracciata siete invitati a dirlo alfine di inserirli nella discussione.
3
I DALLA PERICOLOSITÀ AI FATTORI DI RISCHIO
Nella prima parte del mio intervento, vorrei cercare di caratterizzare il
regime di pensiero del rischio, o piuttosto di illustrarlo attraverso un
esempio. La medicina mentale mi sembra illustrare abbastanza bene il
cambiamento ad un tempo teorico e pratico che induce la promozione
sistematica della nozione di rischio e di « fattori di rischio ».
Si potrebbe dire che la prima medicina mentale - « l’animismo » - si sia
costruita attorno alla nozione di pericolosità. In effetti il « pazzo », o
l’ « alienato » dell’epoca, agli inizi del diciannovesimo
secolo, è
essenzialmente percepito come pericoloso. Va detto che all’epoca si
trattava di gravi patologie, rappresentate da qualche decina di migliaia di
persone. Cionondimeno, tali individui pongono un problema assai grave :
che siano pericolosi, o semplicemente percepiti come tali, essi devono
essere neutralizzati ; ma in quanto alienati essi sono irresponsabili e dunque
non possono essere condannati. Essi pongono un problema essenziale al
momento dell’instaurazione di un regime che si vuole liberale, in rottura
con l’assolutismo regio e con l’arbitrio delle lettres de cachet.
Come neutralizzare l’alienato senza condannarlo ? L’isolamento
terapeutico, inventato dai primi alienisti, é la soluzione a tale problema :
l’alienato deve essere rinchiuso, ma é per il suo bene, perché é la sua sola
possibilità di guarigione. Egli non sarà punito, ma curato. C’è come
un’armonia prestabilita fra l’interesse della società e quello dell’ammalato.
Tutta la psichiatria classica si costruisce intorno al modello dell’asilo,
che diviene nel diciannovesimo secolo l’ospedale psichiatrico. Colgo
l’occasione di questa mia venuta in Italia per rendere omaggio a Franco
Basaglia, che ho avuto l’onore di conoscere molto bene e con il quale ho
lavorato. Non si tratta di un proposito anneddotico, la sua opera
fondamentale condotta negli anni sessanta, e sfociata nella chiusura di
questo tipo di internamento dei malati mentali in Italia, illustra al contrario
la lunga e tenace persistenza di un simile modello.
Questa prima risposta sistematica alla pericolosità del malato mentale ha
dato dunque prova di una grande consistenza, ma progressivamente ha
rivelato i suoi limiti, che sono di due ordini:
-Innanzitutto, essa è debolmente preventiva. Certo, l’ammalato cessa di
essere pericoloso, allorchè è rinchiuso, ma bisogna attendere che manifesti
dei sintomi gravi per intervenire .
4
-In secondo luogo, tale risposta si rivela sempre più insoddisfacente, a
mano a mano che il campo d’indaggine della psichiatria si amplia. Accanto
ai « grandi matti » e ai « grandi deliranti », il cui numero non ha mai
superato il centinaio di migliaia per un paese come la Francia, si assiste al
moltiplicarsi delle patologie leggere, o i cui sintomi sono meno visibili.
L’internamento appare così sempre più inadeguato per trattare questi
diversi tipi di anomalie, disturbi del comportamento, disfunzioni psichiche
di ogni sorta, poichè bisognerebbe internare migliaia di persone. Inoltre, la
pericolosità che esse possono presentare è molto più difficile da anticipare.
La presa di coscienza dei limiti dell’internamento si è avuta nella metà
del diciannovesimo secolo.
Cito una lettera che uno psichiatra francese, Morel, indirizza nel 1860 al
Prefetto della Senna Inferiore (i medici alienisti dipendono
amministrativamente dal prefetto e Morel è medico direttore dell’ospedale
psichiatrico del dipartimento).
Signor Senatore-Prefetto,
L’aumento sempre crescente degli alienati negli asili della Senna
Inferiore, gli inconvenienti che ne risultano mi spingono a studiare, come
ho fatto per altri dipartimenti, le cause di tale aumento.
Credo, innanzitutto, che per rendersi conto del progressivo aumento dei
nostri alienati sia importante entrare nel cuore delle cause di ordine
intellettuale, fisico e morale che scatenano questa triste malattia. Lo studio
delle cause non può effettuarsi prescindendo dagli strumenti forniti dalla
statistica.
Per operare su una zona vasta come il dipartimento della Senna
inferiore, è necessario procedere con ordine e metodo. Penso che se il
metodo vuole fornire all’amministrazione delle indicazioni utili, deve
studiare successivamente, nei diversi arrondissements della Senna
inferiore, le cause che agiscono in maniera funesta sullo stato intellettuale,
fisico e morale delle popolazioni.
La più legittima conclusione alla quale si giunge, partendo da simili
principi, è che la più o meno grande frequenza dell’alienazione, e delle
diverse degenerazioni della specie umana, in questo o quel paese, è sempre
in rapporto con la frequenza più o meno significativa delle cause
perturbatrici della salute fisica e morale degli abitanti di quel paese. Il
5
programma da seguire per studiare efficacemente le conseguenze di tali
cause può riassumersi nelle seguenti questioni :
1 Qual è la moralità degli abitanti di un determinato ambiente ? Per
rendersi conto di ciò, occorre conoscere il numero dei bambini illegittimi,
quello degli attentati contro le persone e le proprietà. Bisogna conteggiare
i suicidi, valutare l’estensione della prostituzione, il numero delle morti
naturali ed accidentali, ecc.
2 Quali sono le condizioni di nutrizione e di igiene degli abitanti ? Quali
le malattie predominanti in questo o quell’ambiente ? Quali influenze
esercitano l’industria e le condizioni di vita, la natura del suolo ed il suo
tipo di coltura sulle abitudini, il temperamento, la moralità e la salute
fisica degli individui ?
3 Qual è il livello di istruzione primaria in ciascuno dei nostri comuni ?
Quali sono, in un determinato dipartimento, le cause più frequenti di
eccitabilità intellettuale e di emozioni morali ?
4 E soprattutto, qual è la proporzione dell’ubbriachezza ed in che
quantità si consumano bevande alcoliche ? Quale azione esercita questa
funesta abitudine sulla sterilità delle donne, la breve durata della vita dei
bambini, il vagabondaggio, la precocità criminale, l’imbecillità e l’idiozia
congenite ?
Questa lunga citazione non è forse inutile, perchè esprime una
trasformazione decisiva della problematica della malattia mentale. Invece
di restare rinchiusa negli asili, la psichiatria deve precedere la follia,
esplorare il tessuto sociale prima che la malattia si manifesti. Morel
propone quindi un’esplorazione sistematica di quelle che possiamo definire
« popolazioni a rischio » ante litteram, in particolar modo quei gruppi
sociali il cui stile di vita predispone, a suo parere, a divenire dei malati
mentali. Si può in tal senso considerarlo come il precursore di una politica
psichiatrica di prevenzione dei rischi.
Tuttavia, Morel non può andare molto lontano in tale direzione, poichè
non dispone di una tecnologia sofisticata per realizzare il suo progetto. Egli
non può che proporre delle indagini poliziesche pesanti ed inaccettabili
(non conosciamo la risposta del Prefetto, ma è verosimile che egli non
abbia dato seguito a tale richiesta). A dispetto della sua moderna intuizione,
Morel è rimasto un medico d’asilo, vale a dire egli stesso legato ad una
concezione che possiamo definire « chiusa » della prevenzione : occorre
internare gli ammalati che si sospettano essere pericolosi, ma per poterlo
fare bisogna attendere che abbiano manifestato tale pericolosità.
Dopo Morel, molto dopo, si assiste allo sviluppo di due tecniche
innovative.
6
La prima é quella genica, che si sviluppa a partire dagli inizi del
ventesimo secolo. Per evitare che i portatori di un rischio di degenerazione
della razza si riproducano, si sterelizzano i deficienti, i ritardati e diverse
categorie di malati mentali. Cito un altro testo del Presidente dell’American
Psychiatric Association, che nel 1914 dichiarava :
« Una guarigione radicale dei mali che comporta l’esistenza di una
classe di deficienti a carico sarebbe realizzata se tutti i deboli di spirito,
tutti gli alienati incurabili e tutti gli epilettici, tutti gli imbecilli, tutti i
criminali recidivi, tutti coloro che soffrono manifestamente di una carenza
della volontà e tutti gli ubbriachi inveterati fossero sterilizzati ; è questa
una proposta che si evidenzia da sé. Con tali mezzi, potremmo sanare due
generazioni di deficienti, con la stessa efficacia con la quale si potrebbe
sconfiggere il vaiolo nel mondo, se tutti fossero vaccinati con successo ».
Vi è un’altra via di depistaggio sistematico del rischio. Essa consiste
nell’autonomizzarlo completamente dal pericolo. Un rischio non è portato
da un individuo particolare. Esso è prodotto dall’associazione di fattori di
rischio che rendono più o meno probabile l’avvento di un comportamento
indesiderato. Il che suppone un certo numero di condizioni che non erano
presenti all’epoca di Morel, come delle statistiche solide, una struttura
amministrativa efficace per la gestione di tali dati, ecc. Tuttavia, vi è
un’importante mutazione. Non si tratta più di farsi direttamente carico di
una situazione pericolosa o indesiderata, ma di intercettarla
indipendentemente dalla presenza delle persone.
Prendo l’esempio di un sistema che aveva iniziato a prendere piede in
Francia a partire dal 1976 e che è stato chiamato il sistema GAMIN
(gestione automatizzata materna ed infantile). Esso non è stato mai messo a
punto completamente poichè nel 1981 un parere negativo della
Commissione Informatica e Libertà lo ha giudicato incompatibile con il
rispetto della riservatezza e della libertà delle persone. Lo prendo
comunque ad esempio, perchè incarna l’ideale tipico del modo di pensare
che si ritrova nelle diverse forme attuali di gestione delle « popolazioni a
rischio », non solo in Francia ma pure in Italia.
Il sistema GAMIN si fondava sull’esame sistematico di tutti i bambini
che nascevano in Francia. In effetti c’erano tre esami : alcuni giorni dopo la
nascita, alcuni mesi dopo e all’età di due anni. Questo esame aveva
l’obiettivo di intercettare tutte le possibili anomalie psichiche, fisiche o
sociali che possono colpire il bambino o la madre. Ad esempio, una
gravidanza difficile della madre, la sua età troppo avanzata o troppo
giovane, il fatto di non essere sposata, o immigrata ecc ... Tali particolarità
costituiscono dei fattori di rischio che, come si nota, sono completamente
7
eterogenei. Ad esempio, qual è la relazione fra l’essere madre nubile, avere
una gravidanza difficile, essere studentessa ? Si tratta di fattori
estremamente indipendenti, bisognerebbe stabilire una relazione. Perchè
allevare da sola il proprio figlio costituirebbe un fattore di rischio ? In
ragione di una struttura psichica più fragile, o di redditi il più delle volte
insufficienti in assenza di un « capo famiglia » che lavori ? Questo non si
sa e soprattutto non bisogna saperlo. Poichè quello che i fattori di rischio
definiscono non sono degli individui, sono delle popolazioni statistiche le
quali, potremmo dire, sono state costruite attraverso la de-costruzione degli
individui.
Si tratta di un cambiamento considerevole nella maniera di farsi carico
non solo della malattia mentale, ma di un certo numero di popolazioni
« con problemi », o che vengono percepite come tali, come le popolazioni
portatrici di rischi di delinquenza. La grande differenza rispetto alla
situazione anteriore è innanzitutto la dissoluzione del soggetto
dell’intervento. Non si è più in presenza di un individuo, il che permette
una sorveglianza a distanza, una detenzione a distanza. Michel Foucault ha
descritto, attraverso il modello del panopticon, un paradigma di
sorveglianza proprio delle istituzioni disciplinari. Ma, perchè il panopticon
sia efficace, bisogna che il soggetto sia lì, che sia già rinchiuso e posto
sotto lo sguardo del sorvegliante. Qui, attraverso l’intercettazione dei fattori
di rischio, si può essere intercettati senza essere mai stati visti, è insomma il
computer che svolge il lavoro associando dei fattori eterogenei di rischio.
Questo determina un considerevole incremento delle possibilità di
sorveglianza rispetto alle situazioni diciamo classiche nelle quali gli
indiviui pericolosi, o potenzialmente tali, dovevano essere tenuti sotto
osservazione. Questa moltiplicazione delle possibilità di sorveglianza è resa
possiblile dall’utilizzo di nuove tecnologie statistiche ed informatiche.
Un altro punto merita di essere sottolineato : tale passaggio
all’intercettazione a distanza ricompone profondamente la relazione fra i
professionisti del territorio e gli amministratori delle politiche sanitarie,
sociali o penali. Si potrebbe, ad esempio, mostrare come le politiche
psichiatriche classiche, quale quella attuata in Francia con la legge del
1838, o più tardi attraverso la « politica di settore », siano state il risultato
del compromesso fra gli operatori del territorio, gli psichiatri e gli
amministratori del Ministero della Salute . Con l’intercettazione dei rischi,
si determina uno squilibrio a favore degli amministratori e dei politici.
Sono questi ultimi a scegliere i fattori di rischio, a determinare gli obiettivi
da perseguire, ed i professionisti del territorio intervengono come degli
ausiliari che applicano le opzioni di coloro che « decidono », come si dice
oggi. Il professionista è chiamato come un esperto per fornire delle
informazioni e chiarire le opzioni di coloro che prendono le decisioni; ci si
potrebbe interrogare sull'attuale proliferazione di questa funzione di
8
consulente, delle commissioni di ogni sorta in seno alle quali gli specialisti
non intervengono più come degli esperti.
Non voglio piangere sulla perdita di potere degli esperti, che potrebbe
avere delle conseguenze quantomeno ambigue. Tuttavia, queste nuove
possibilità mi sembrano inaugurare una nuova modalità di ciò che
potremmo chiamare il lavoro sull'altro.
Il lavoro sull'altro nella sua forma classica mette a confronto due
persone, o due gruppi concreti, diciamo un professionista o dei
professionisti, oppure dei clienti, nel quadro di ciò che si definisce una
relazione di servizio - ad esempio un terapeuta ed un malato, o persino,
estendendo un po' il quadro di questa relazione di servizio, un professore ed
i suoi allievi, oppure un poliziotto ed i delinquenti dei quali si occupa.
Questa forma di lavoro sull'altro pone evidentemente dei problemi, perchè
possono esserci dei fallimenti e persino delle depravazioni di questa
relazione di servizio, e vi è d'altra parte tutta una letteratura su questo,
riguardo alla sociologia delle professioni.
Ma con il depistaggio dei rischi si ha a che fare con una maniera
completamente diversa di lavorare sull'altro, di intervenire a distanza, che
si potrebbe forse definire come una costruzione di profili di popolazioni per
destinare loro un trattamento speciale. Si vogliono evitare i pericoli,
prevenire i rischi intercettando in anticipo delle popolazioni potenzialmente
pericolose. Va colta, in questo mutamento di prospettive, una differenza
essenziale sia nel regime di pensiero che nella strategia di intervento. Si
passa da un'esperienza concreta, che si ritaglia su un intervento altrettanto
concreto (un malato che si cura o un delinquente che si imprigiona), alla
presa in conto di una popolazione a partire dalla quale si stabiliscono delle
correlazioni fra dei fattori di rischio. Tuttavia, bisogna insistere sul fatto
che un rischio così costruito rappresenta una possibilità aleatoria, è la
probabilità di un evento indesiderato e non una caratteristica direttamente
assegnabile a tale o talaltro individuo concreto. Si può allora immaginare
che in una determinata popolazione delle violenze, degli attacchi alle
persone ed ai beni saranno commessi, ma non si possono ad esempio
rinchiudere preventivamente tutti gli abitanti di un quartiere definito
difficile. Certo è vero, come sempre si dice, che
« prevenire » è meglio
che curare, ma questa evidenza su cui quasi tutti concordano pone una
questione molto difficile, quella della natura dell’applicazione e degli
eventuali effetti perversi delle tecnologie di prevenzione. Una vera e
propria politica preventiva esigerebbe idealmente: 1) La conoscenza esatta
delle cause del pericolo da prevenire; 2) Il possesso di tecniche efficaci per
combattere tali cause. Vuol dire puntare molto in alto. Ciò ad esempio è
possibile in certi settori della medicina, nei quali una malattia come il
vaiolo può essere efficacemente combattuta, e persino debellata, grazie al
vaccino: il virus è la causa del vaiolo e si è messo a punto un vaccino per
immunizzare la popolazione. Ma, nella stessa medicina, ciò non vale per
9
tutte le epidemie conocsiute. Ad esempio, sebbene si conosca la causa
dell'aids non si è ancora trovato un vaccino per l'HIV. A maggior ragione,
questo discorso vale per la delinquenza e per la malattia mentale, delle
quali non si conoscono certamente tutte le cause. C'è bisogno di ipotesi o di
teorie, le quali d'altro canto non fanno che combattersi fra loro. E, in ogni
modo, non vi sono vaccini contro la schizofrenia, oppure contro la
criminalità. Allora, dinanzi ad una popolazione a considerata così a rischio,
cosa si può fare di realmente preventivo? Non pongo tali questioni per
negare qualsiasi utilità alle politiche di depistaggio dei rischi, ma esse
devono invitarci alla vigilanza nella consapevolezza di due problemi.
Il primo è quello di aver coscienza del fatto che intercettare il rischio non
significa controllarlo. Il depistaggio non possiede, o almeno non possiede
in se stesso, un valore assoluto. Esso può costituire una prima tappa per
combattere il rischio, ma lascia aperta l'immensa questione della
conoscenza di tecniche efficaci di prevenzione. Sarei portato a dire che
l'affermazione dei benefici della prevenzione non sia che una dichiarazione
ideologica, quasi priva di un reale contenuto se non associata alla
conoscenza di strumenti effettivi per combattere i pericoli che si sono
intravisti.
In secondo luogo, una politica di depistaggio dei rischi può in se stessa
presentare dei pericoli, nella misura in cui vi sia una potenzialità di arbitrio
nella definizione di ciò che si intende per fattore di rischio. L'ho appena
evocata a proposito del programma GAMIN: essere madre nubile, essere
immigrata, appartenere ad un ambiente sfavorito ecc sono forse dei fattori
di rischio, ma che vuol dire? Al limite, qualunque cosa può portare dei
rischi, cioè ogni deviazione in rapporto ad una norma o ad una normalità
socialmente costruita. Il che può conferire un potere che possiamo definire
come esorbitante agli amministratori di queste politiche preventive, come a
quei tecnocrati che popolano i ministeri e a quegli esperti incaricati di
decidere cosa è bene e cosa è male. Essi istituiscono la norma ed il margine
di variazione legittima in rapporto alla norma. Il fatto che siano
generalmente ben intenzionati non è del tutto rassicurante. Non si tratta
tanto di attribuire loro intenzioni machiavelliche, quanto di temere che la
caccia al rischio apra una sorta di vaso di Pandora: in nome della
preoccupazione, che può essere legittima, di combattere i pericoli, si
instaura un sospetto generalizzato che può volgersi su tutto e tutti.
Perchè di rischi, oggi, se ne vedono ovunque e se ne scoprono ogni
giorno: rischi sanitari, alimentari, tecnologici, ambientali ecc. Di qui la
ricerca di una prevenzione totale, o di una sicurezza assoluta che rischia di
essere il sogno ad occhi aperti di controllare tutte le catastrofi della vita
individuale e sociale, che comporta necessariamente una dose di
imprevedibilità - sogno che può tramutarsi in incubo spingendo a scorgere
il pericolo dappertutto. Bisognerebbe allora istituire degli strumenti di
controllo e di sorveglianza di tutti i settori della vita individuale e sociale, il
10
che potrebbe fornire una definizione abbastanza efficace del totalitarismo.
Si tornerà su questa referenza generalizzata al rischio, che diviene oggi
sempre più invadente, e che mi sembra il rovescio della medaglia di un
intento di prevenzione generale. In ogni caso, è un tema che vorrei
sottoporre alla discussione. Il depistaggio dei rischi può forse giustificarsi
attraverso la preoccupazione di prevenire degli eventi indesiderabili. Ma
cosa occorre prevenire, realmente? E in che modo? Spero che le riflessioni
che seguiranno sui rischi civili e i rischi sociali apporteranno degli
elementi, se non delle risposte definitive, per approfondire i termini di
questo dibattito, analizzandolo oggi. Ma vorrei iniziare da quelle
osservazioni che ancora oggi restano generali su cosa significa pensare in
termini di rischi, ma che invitano a non pensare a priori che il passaggio dal
fronteggiare il pericolo al prevenire i rischi si imponga senza problemi
come un progresso assoluto del sapere e della pratica. Tale passaggio, del
quale ho riassunto il modo in cui si è effettuato nel campo della medicina
mentale intesa in senso ampio, è certamente importante. Ma passa esso
stesso attraverso numerosi problemi che bisogna cercare di approfondire.
II LA LOTTA CONTRO I RISCHI CIVILI E LO STATO
DI DIRITTO
Vorrei affrontare, in successione, i tre ambiti principali della
problematica dei rischi oggi:
- la questione di quelli che possiamo chiamare i rischi civili, vale a dire
la questione della salvaguardia dei beni e delle persone in uno Stato di
diritto e della lotta alla delinquenza.
- la questione della lotta contro i rischi sociali, la necessità di assicurare
la sicurezza sociale, con il ruolo preponderante dello Stato sociale o del
Welfare State. Sarà d'altronde il punto sul quale insisterò maggiormente,
non fosse che perchè mi sento maggiormente a mio agio discutendo i
problemi che toccano i diritti sociali e la protezione sociale rispetto a quelli
che interessano le questioni della sicurezza civile e della delinquenza.
Cionondimeno, la problematica della sicurezza civile è importante ed è
11
oggi una preoccupazione estremamente diffusa, e devo almeno cercare di
inquadrarla nella problematica di insieme dei rischi.
- e aggiungerò i problemi che pone la recente scoperta dei « nuovi rischi
», che contribuiscono ad estendere e complessizzare, oggi, questa tematica
del rischio.
Trattandosi della sicurezza civile, il pericolo da affrontare qui
(
poichè noi ci interessiamo alle relazioni pericoli-rischi ) è la violenza fatta
ai beni ed alle persone, e la risposta si trova ad essere l'affermazione delle
prerogative dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto è uno Stato liberale che
è completamente diverso dallo Stato sociale inteso come risposta
all'insicurezza sociale che si presenterà in seguito. Storicamente, il
problema dell'insicurezza civile e dello Stato di diritto si è posto agli inizi
della modernità, verso i secoli XVII e XVIII. Non che la questione della
violenza sui beni e sulle persone non si sia posta in precedenza, essendo
essa stessa tanto vecchia quanto il genere umano. Ma essa si pone sotto la
forma che noi oggi le riconosciamo a partire dal momento in cui la società
inizia a pensarsi come una società di individui, cioè all'epoca in cui delle
costrizioni collettive che ricacciano gli individui in dei sistemi di
appartenenze, ma anche di protezioni, tradizionali cominciano a disfarsi, ed
in cui l'individuo si ritrova al contempo valorizzato (vedi la Dichiarazione
dei diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789, che è un magnifico manifesto
del valore eminente dell'individuo) e fragilizzato.
Per illustrare questa promozione ambivalente della nozione di individuo,
mi riferisco alla posizione di Thomas Hobbes alla fine del diciassettesimo
secolo - non per il piacere di fare un po' di storia della filosofia, ma perchè
Hobbes mi sembra essere stato un testimone particolarmente lucido di
questo momento storico, allorchè la problematica della modernità si mette
in moto. Hobbes è stato, fra le altre cose, testimone della guerra civile in
Inghilterra, che abolisce provvisoriamente la regalità. Egli assiste anche
alle guerre di religione in Francia, dove lo scontro selvaggio fra cattolici e
protestanti fa vacillare l'ordine religioso tradizionale (egli è fra l’altro
presente al momento della presa di La Rochelle, l'ultima cittadella
protestante in Francia). È anche il testimone, in Inghilterra, dell'esplosione
del capitalismo commerciale, che instaura una concorrenza generalizzata
degli scambi e fa scricchiolare il vecchio sistema delle corporazioni:
Hobbes constata in tal modo la fragilizzazione di tutti i sistemi di
regolazione tradizionali, che inserivano gli individui in dei circuiti forti, ad
un tempo di costrizioni e protezioni.
Hobbes spinge al limite tali constatazioni, anticipa il trionfo completo di
tali dinamiche nuove per pensare a come sarebbe davvero una società di
individui. Una società di individui non sarebbe più una società
propriamente detta. Sarebbe un conglomerato di persone senza diritti, senza
leggi, lasciate a loro stesse ed in preda ad una concorrenza sfrenata, alla
guerra di tutti contro tutti: « l'uomo è un lupo per l'uomo », dice Hobbes.
12
Altrimenti detto, una società di individui lasciati a se stessi sarebbe una
società di insicurezza totale, che vivrebbe sotto una minaccia permanente,
nell'onnipresenza del pericolo. Persino la legge del più forte non basta a
stabilizzare la situazione, perchè un forte rischierà sempre di trovare
qualcuno che è più forte di lui, a meno che qualcuno più debole di lui non
abbia la forza di assassinarlo nel sonno. Neppure la legge del più forte
costituisce una società.
Da questa sorta di tipo ideale di una società di individui, che certamente
è spinto al limite, Hobbes ha tratto una conslusione radicale, che lo ha reso
impopolare, ma sulla quale credo si debba riflettere seriamente: solo uno
Stato che abbia pieni poteri può assicurare una sicurezza totale. Esso è il
solo garante possibile, se posso dirlo, contro la violenza civile. E per
assumere pienamente tale funzione, lo Stato deve avere tutti i poteri. Cito
Hobbes nel Leviatano: “ Il potere se è estremo è buono, perchè è utile alla
protezione ”. E Hobbes aggiunge: « È nella protezione che risiede la
sicurezza ». Solo uno Stato forte, molto forte, può uscire dal pericolo
permanente degli individui abbandonati alla concorrenza, alla ricerca del
loro interesse, all'affermazione del loro potere.
Evidentemente, io non difendo il Leviatano, che ritengo essere una
rappresentazione assai spaventosa del totalitarismo. Tuttavia, penso anche
che Hobbes abbia avuto un'intuizione molto profonda: lo Stato opera,
innanzitutto, come un riduttore di rischio e la sicurezza civile, il fatto di
vivere in una società pacificata, non è un fatto scontato. Soprattutto in una
società moderna, che Hobbes osserva con puntualità diventare una società
capitalista, gli individui sono in competizione gli uni con gli altri, vi sono
vincitori e vinti. In questa società, la sicurezza non può che essere il
risultato di un’attenta costruzione politica. Essa deve essere imposta,
poichè non risulta dalla maniera in cui gli individui vivono spontaneamente
fra loro in una società moderna. È questo il motivo per il quale essi
formano uno Stato che combatte il pericolo rappresentato dalla coesistenza
di individui votati alla sola ricerca del loro interesse personale. Si può certo
pensare che Hobbes abbia dato alla sua argomentazione una forma
provocatoria, o estremista, che può scioccare. Ma ciò non deve farci
dimenticare che la costruzione politica della sicurezza ha sempre un costo,
che solo uno Stato dotato di mezzi possenti può assicurare. Fortunatamente,
la forma sotto la quale si è imposto lo Stato moderno a partire dalla fine del
diciottesimo secolo non è stato l'assolutismo del Leviatano. Esso ha
elaborato una costruzione più complessa e sottile, con in particolare
un'esigenza di separazione dei poteri fra l'esecutivo, il legislativo ed il
giudiziario che fa si che nessuna istanza, almeno in linea di principio, sia
dotata di un potere assoluto. Questa separazione dei poteri, nonchè
l'esigenza per lo stesso potere politico di rispettare la Costituzione e di
obbedire alla legge, è al cuore di ciò che si chiama lo Stato di diritto.
Ciononostante questo Stato di diritto, che si imporrà sotto la forma dello
13
Stato liberale a partire dal diciannovesimo secolo, riterrà qualcosa di
essenziale della lezione di Hobbes. Così per John Locke, che è stato il
grande teorico dello Stato liberale e che scrive una trentina di anni dopo
Hobbes, è la proprietà a poter dare sicurezza all'individuo. Allorchè
l'individuo non è più preso nei sistemi delle dipendenze-protezioni
tradizionali, delle quali Locke, come Hobbes, osserva l'indebolimento,
soltanto la proprietà può conferirgli un minimo di indipendenza sociale. La
proprietà costituisce quella specie di solco a partire dal quale l'individuo
può mobilizzare le proprie risorse ed esistere per se stesso. È la proprietà
che assicura contro i rischi della miseria, delle malattie, delle disgrazie. È la
proprietà che protegge e che può offrire l'assicurazione di non ricadere
nell'altrui dipendenza. Un proprietario non andrà a morire miseramente
all'ospizio, non avrà nemmeno bisogno di diventare cliente di un uomo
politico e di vendere il suo voto. Egli può essere socialmente indipendente.
Questo pone d'altronde l'enorme problema degli individui non proprietari- i
lavoratori che non hanno che la forza delle proprie braccia per vivere o per
sopravvivere- sul quale si ritornerà fra poco.
Intanto, bisogna ben comprendere che all'inizio della modernità la
proprietà appariva necessaria per conferire uno statuto all'individuo. Ecco
perchè il diritto alla proprietà figura nella Dichiarazione dei diritti
dell'Uomo e del Cittadino. Ecco anche perchè, durante l'epoca
rivoluzionaria, la difesa della proprietà non è prerogativa esclusiva dei
gruppi conservatori o politicamente moderati ( oggi si direbbe "borghesi" ).
Dei rivoluzionari radicali come Robespierre, Saint-Juste, i Sanculotti
parigini difendono una concezione del cittadino-proprietario, artigiano o
piccolo contadino, la cui indipendenza è assicurata dalla proprietà. Non vi
sono stati che dei gruppi ultr-minoritari, come Gracco Babeuf e i suoi
compagni, che abbiano rivendicato un ordine politico nuovo che non fosse
fondato sulla proprietà privata.
Ma occorre anche ben comprendere che, se è la società che assicura
l'individuo contro i rischi sociali, è lo Stato che assicura la proprietà. La
principale funzione dello Stato moderno che si costruisce è quella di
garantire la proprietà, perchè la proprietà è la condizione della sicurezza e
dell'indipendenza sociale. John Locke lo dice esplicitamente nel suo
Secondo Trattato del Governo:
« Il fine essenziale che perseguono gli uomini che si uniscono per
formare una Repubblica e sottomettersi ad un governo è la preservazione
delle loro proprietà ». Per Locke la proprietà non è solo il possesso dei
beni, è anche la proprietà della loro persona, la qual cosa Locke precisa: «
...la preservazione della loro proprietà, cioè della loro vita, della loro libertà
e dei loro beni, che chiamo con il nome generico di proprietà ». E lo Stato è
necessario perchè, come in Hobbes, solo lo Stato può garantire l'integrità
dei beni e delle persone.
14
Mi pare che sia questo il compito essenziale dello Stato moderno, che si
va affermando a partire dalla fine del diciannovesimo secolo. È lo Stato
liberale, che spesso si qualifica come “ Stato minimo ”, poichè, almeno in
principio, non deve intervenire nell'ambito sociale o in quello economico.
Ma non bisogna fare confusione. Questo Stato minimo non è uno Stato
debole. Lo si è anche chiamato Stato di Polizia, il cui mandato è quello di
garantire l'ordine pubblico, cioè di assicurare la sicurezza dei beni e delle
persone. E per fare questo, potrà all'occasione essere spietato. È questo
Stato di ispirazione liberale che nella Francia del diciannovesimo secolo ha
soffocato la rivolta degli operai parigini nel 1848 o la Comune di Parigi nel
1871. Ma è, nello stesso tempo, uno Stato di diritto, poichè il suo mandato
è effettivamente quello di far rispettare il diritto, il quale comprende il
diritto alla proprietà ed alla sicurezza delle persone.
Mi sembra sia effettivamente il nucleo di ciò che fino ad oggi chiamiamo
lo Stato di diritto: scongiurare i rischi di violenze contro le persone e contro
i beni, impiegando dei mezzi legali. Poichè questo Stato si è dotato di
un'armatura estremamente complessa di leggi e principi giuridici - a
differenza di uno Stato totalitario come il Leviatano di Hobbes - per
esercitare questo potere nel quadro legale. Questi dispotismi sono
consegnati in quei grandi monumenti giuridici che sono, in Francia, il
codice civile ed il codice penale. Tale mi sembra essere il quadro politicogiuridico della lotta contro i rischi civili e contro gli attacchi alla sicurezza
dei beni e delle persone. Se si vuole essere giusti, bisogna riconoscere che
tale quadro si sforza accuratamente di evitare l'arbitrio, di combattere le
tendenze assolutistiche di uno Stato di tipo leviatano. Così questo Stato di
diritto si è dotato di istituzioni specifiche, in particolare la giustizia e la
polizia, che hanno il monopolio dell'esercizio legittimo della violenza di
Stato.
Si chiama in generale delinquenza l'insieme di atti che trasgrediscono la
legge sotto il duplice aspetto della sicurezza dei beni e della sicurezza delle
persone. In uno Stato di diritto, la delinquenza deve essere sanzionata e la
polizia e la giustizia sono gli organismi specializzati che hanno il mandato
di esercitare tale repressione in un quadro legale. In rapporto alla legge, si
potrebbe dire che la delinquenza rappresenti una sorta di residuo: essa è
l'insieme dei comportamenti che resistono alle regole dello Stato di diritto,
il cui obiettivo è quello di eliminare i rischi che attentano alla sicurezza dei
beni e delle persone. In tal senso, la repressione della delinquenza è
legittima, a condizione che essa stessa si eserciti in un quadro legale.
In linea di principio, non penso che si possano sollevare delle serie
obiezioni a questa costruzione. In altre parole, la lotta contro la violenza
civile mi sembra legittima in una società, e particolarmente in una società
democratica. Non si può veramente “ fare società ” con i propri simili senza
la pace civile, se si vive sotto la minaccia permanente della violenza, del
furto, dello stupro o dell'aggressione. La sicurezza civile è un bene e si
15
potrebbe persino dire che essa debba essere un diritto, in una democrazia.
Tale è, in ogni caso, la posizione che difenderei, e della quale bisognerà
evidentemente discutere.
Tuttavia, nei fatti le cose sono più complesse, ed anche se ci si attiene a
tale eposizione bisogna constatare che essa pone, oggi, un problema. In
effetti, come dicevo all'inizio del mio intervento, attualmente assistiamo, in
Francia - è lo stesso anche in Italia? - ad una richiesta disperata di
sicurezza, che ha recentemente avuto conseguenze politiche molto gravi.
Così, l'elezione presidenziale dell'Aprile 2002 in Francia si è largamente
giocata intorno alla questione dell'insicurezza, ed il sentimento di
insicurezza ha molto influito sulla popolarità del Fronte Nazionale di JeanMarie Le Pen.
La preoccupazione per la sicurezza, che si tramuta a volte in ossessione
securitaria, appare d'altronde paradossale, poichè noi viviamo attualmente
in Francia - come in Italia, o, più in generale, nell'Europa Occidentale - in
una delle società più sicure che siano mai esistite. Ciò appare evidente se ci
guardiamo intorno: in più della metà del pianeta l'insicurezza è
onnipresente (basta paragonare la vita quotidiana in una città come Parigi o
Napoli a quella di una città dell'America Latina, o della striscia di Gaza, o a
Gerusalemme). Ma ciò è altrettanto evidente se ci si guarda un po' indietro
nella storia, la quale insegna come tutta la storia dell'umanità sia stata
attraversata da una violenza permanete. Dunque, è paradossalmente proprio
nelle società della sicurezza, che potremmo dire circondate ed attraversate
da protezioni, che il sentimento di insicurezza è onnipresente.
Per rendere conto di questo paradosso, credo si debba comprendere che
il sentimento di insicurezza non corrisponde necessariamente ad un'assenza
di protezione. Può determinarsi un rapporto complicato con le protezioni,
come accade quando si ha la sensazione di essere protetti, ma che le
protezioni delle quali si fruisce siano fragili e minacciate e che noi
rischiamo di perderle, ed è un sentimento oggi estremamente diffuso.
Oppure ancora, si può avere la sensazione di essere protetti contro taluni
rischi, ma questo relativo conforto accresce la nostra sensibilità al rischio e
fa emergere nuovi pericoli alla nostra coscienza. Prenderò uno o due
esempi, poichè tali questioni sono abbastanza complicate, ma nello stesso
tempo sono importanti per cercare di comprendere la congiuntura
paradossale nella quale si sviluppa oggi il sentimento di insicurezza. Queste
statistiche sembrano mostrare un certo aumento della delinquenza negli
ultimi venti anni: il numero dei delitti, dei furti, di quelle che chiamiamo
"le inciviltà" (degradazione di beni, spinte, aggressioni fisiche e verbali,
ingiurie ecc...) sembra in aumento. Tuttavia, occorre notare che questo
aumento della delinquenza, che non è trascurabile, concerne
essenzialmente i beni ed i comportamenti che vengono qualificati come
asociali. I delitti contro la proprietà sono dieci volte più numerosi degli
attacchi alle persone. Non si tratta di una progressione della grande
16
criminalità, degli assassinii, benchè continuino a verificarsi eventi tragici
ed uccisioni seriali fortemente mediatizzate, ma che non costituiscono una
novità assoluta, si pensi a Jack lo Squartatore e a Gilles de Ray. Altrimenti
detto, le persone fanno esperienza dell'insicurezza soprattutto attraverso
l'esperienza della paura del furto, della degradazione dei beni, di vaire
forme di depredazione, di comportamenti asociali. Non dico questo per
sottovalutare il peso di simili esperienze, che possono minare gravemente
la vita quotidiana delle persone, in particolar modo in talune zone urbane
come le periferie o i quartieri popolari, dove esse sono particolarmente
frequenti ( e si tornerà domani su questa questione). Ma sottolineo che il
sentimento di insicurezza può svilupparsi sul fondo di una società
fortemente securizzata - vale a dire nella quale è stata scongiurata
un'insicurezza di massa che è stata una costante storica nelle società
attraversate da lotte intestine, da scontri permanenti e sanguinolenti.
Si potrebbe così ipotizzare che il sentimento di insicurezza si sposti
come su di un cursore: allorchè alcuni rischi sono controllati, i rischi che
sussistono appaiono con particolare visibilità, sospinti da un bisogno di
sicurezza che resta esigente anche quando si potrebbe credere che abbia
delle buone ragioni di cui essere soddisfatto. Il che, a mio avviso, mostra
come non si debba pensare l'insicurezza come il contrario della sicurezza,
cioè come una sorta di stato di natura alla Hobbes in cui il pericolo sarebbe
onnipresente. In altre parole, nel nostro tipo di società il sentimento di
insicurezza consisterebbe soprattutto in un rapporto con le protezioni. E, al
punto in cui siamo, in Francia come in Italia, in uno Stato di diritto, questo
Stato di diritto promette in qualche modo la sicurezza dei beni e delle
persone: che lo Stato ci protegga, è lì per questo. Dunque che in tale
contesto permanga l'insicurezza, un'insicurezza residuale che è la
delinquenza comune, sembra inaccettabile e quasi scandaloso. Si
rimprovera allora allo Stato di non svolgere il suo lavoro, si critica la sua
impotenza nell'assicurare una sicurezza totale. Si accusano così, ed è oggi
un discorso molto frequente, i giudici di essere troppo lassisti nei confronti
dei delinquenti, o i poliziotti di essere inefficaci.
E' un'ipotesi che si può avanzare per poter così comprendere anche la
sensibilità verso altri rischi rispetto a quelli che concernono la delinquenza,
e che spesso si chiamano " nuovi rischi " e che sono emersi di recente, non
essendo prima oggetto di preoccupazione. Voglio prendere un esempio che
è senza dubbio un po' forte, ma che ben illustra ciò che cerco di dire.
Da sempre, per l'umanità in generale, e sfortunatamente ancora oggi in
numerose zone, il principale rischio alimentare è la fame: il fatto di non
avere da mangiare, semplicemente. Ma nelle nostre società cosidette
sviluppate questo rischio è stato scongiurato ed in Francia come in Italia,
fortunatamente, forse nessuno muore più di fame. Tuttavia il rischio
alimentare, per molti nostri contemporanei, si è spostato, e si potrebbe dire
che è ormai nel piatto: la paura di mangiare la carne della mucca pazza o
17
uno di quei prodotti cancerogeni che si scoprono quasi ogni giorno.
Insomma per alcuni la paura di mangiare ha sostituito quella di non avere
da mangiare.
Dicevo che questo esempio è forse un po' forte, ma esemplifica questo
assunto che credo importante: non esiste rischio in sé. Esiste, piuttosto, una
costruzione di rischi che si fa, almeno in parte, in riferimenro alle
protezioni delle quali già si beneficia. È anche perchè si gode di protezioni
che si può avere la sensazione di correre dei rischi. Il che vuol dire che la
sicurezza non è mai data, e senza dubbio mai potrà essere data una
sicurezza totale in via assoluta, poichè allorchè un certo livello di sicurezza
è raggiunto, l'esigenza di sicurezza cresce. In ogni caso, è l'ipotesi che
propongo per rendere conto della pregnanza del sentimento di insicurezza
in delle società come la nostra e suppongo tale ipotesi possa valere anche
per l'Italia. La questione dell'insicurezza si sposta perchè si sposta la
questione dei rischi da combattere e l'esigenza di sicurezza si fa sempre più
imperiosa. Si tratta di un punto che evidentemente è da discutere, ma prima
discuterò un'implicazione più politica di una simile ipotesi.
Credo che in questo desiderio di sicurezza, che diviene sempre più
imperioso, la concezione stessa dello Stato di diritto possa essere
minacciata dalla difficoltà, e forse dall'impossibilità, di realizzare
quest'esigenza rispettando le forme legali. Si constata in effetti che questo
Stato è sospettato di lassismo, di mancanza di efficacia nella lotta contro
l'insicurezza civile. Di qui la forza del modello proposto da Hobbes nel
Leviatano: l'idea che solo uno Stato assoluto possa essere assolutamente
efficace. Al contrario, il rispetto delle procedure giuridiche, ad esempio lo
stretto controllo della polizia da parte della giustizia, può nuocere
all'efficacia della repressione della delinquenza e il delinquete potrà trarre
profitto dallo stretto legalismo. La lotta contro questo tipo di rischi, che ho
chiamato civili, può essere assolutamente efficace senza che lo Stato
disponga di un'autorità assoluta?
Mi sembra che l'attuale situazione in Francia illustri questa difficoltà. Si
osserva in effetti una frustrazione securitaria che si è tradotta in
un'accresciuta domanda di autorità rivolta allo Stato, ed alla quale
d'altronde l'attuale governo si sforza di rispondere. Si tratta, ad esempio,
della concezione della "tolleranza zero" in materia di delinquenza: arrivare
insomma a zero rischi, a sradicare completamente la delinquenza. Ma tale
esigenza può essere integralmente assicurata nel rispetto delle regole
democratiche di uno Stato di diritto? Non dico questo per suggerire che la
preoccupazione di sicurezza sia secondaria - si può anche pensare che la
pace civile nel quotidiano sia essenziale per poter vivere in democrazia- ma
forse bisogna, allo stesso tempo, comprendere che questa esigenza è
essenziale, e che tuttavia essa non può essere perfettamente realizzata senza
correre il rischio di scivolare nel non-diritto.
18
In ogni caso, è ciò che sembra suggerire non solo l'esempio della
Francia, ma anche quello di altri Paesi come gli Stati Uniti d'America che
affermano il loro forte attaccamento ai diritti dell'uomo, al punto di volerli
imporre agli altri. Ma il modo in cui gli Stati Uniti conducono la "guerra al
terrorismo", come essi stessi dicono, mostra bene come questo Stato che si
prende a modello si conceda delle libertà rispetto al diritto. Al di là di
queste prospettive attuali, in Francia e negli Stati Uniti, non vi è in questo
una tentazione che minaccia tutti gli Stati di diritto? Per dirla in altre
parole, la domanda di sicurezza totale non è condannata ad essere disattesa,
a suscitare sempre una frustrazione, almeno nel quadro di una società
democratica? Questa è la ragione per la quale ho presentato il modello di
Hobbes, non perchè io nutra un'inclinazione per il despotismo, al contrario,
ma Hobbes ci consente di pensare le condizioni di una sicurezza totale che
sarebbe al limite uno Stato totalitario. E non si tratta di un modello
scolastico, perchè attraverso lo stalinismo ed il nazismo si possono vedere
delle forme attualizzate del Leviatano di Thomas Hobbes. Dopo essersi
imposte con la forza ed aver continuato a tenersi in piedi attraverso la
forza, la Germania nazista e lo Stato sovietico hanno senza dubbio
garantito una certa sicurezza interna e la delinquenza ordinaria non sembra
aver posto particolari problemi. Ma si può suggerire che il prezzo da pagare
sia stato esorbitante. Forse bisogna avere il coraggio di trarre la
conseguenza di tali osservazioni: che non si può giungere allo sradicamento
completo dei fattori di insicurezza civile nel quadro di uno Stato di diritto.
Vi è in ogni caso una forte tensione, se non una contraddizione, fra
l'esigenza di uno stretto rispetto delle forme legali e la ricerca della
sicurezza assoluta. Mi pare si tratti di un'implicazione dello stesso tipo di
quella scorta nel primo punto di riflessione da me proposto, a proposito del
depistaggio sistematico dei rischi e della preoccupazione di una
prevenzione totale contro i rischi. Non si rischia, per arrivare a rischio zero,
di adoperare mezzi lesivi delle libertà e contrari al diritto? Si potrebbe
discutere delle implicazioni politiche della caccia ai rischi. Vi sono
certamente delle ragioni e delle giustificazioni assai serie al fatto di
combattere i rischi - e se ne avrà fra poco la conferma a proposito
dell'indispensabile lotta che va condotta per scongiurare i rischi sociali- ma
dinanzi a questa urgenza di una caccia ai rischi, di una prevenzione
generalizzata contro tutti i rischi, lo Stato di diritto non si trova in una
posizione scomoda?
III LA LOTTA CONTRO I RISCHI SOCIALI E LO STATO SOCIALE
19
Nell'ambito di questa riflessione sui rapporti fra rischi e sicurezza, o
rischi e protezioni contro gli stessi, ho proposto in un primo tempo di
caratterizzare il pensiero sul rischio attraverso la sua differenza rispetto al
fronteggiare il pericolo: definizione di popolazioni a rischio che permettono
di attuare delle politiche preventive, con tutte le ambiguità che esse
presentano. In seguito, ho proposto di conferire una particolare importanza
a due grandi tipi di rischi, i rischi civili, che riguardano la sicurezza dei
beni e delle persone e dei quali abbiamo parlato ieri, ed i rischi sociali e la
lotta all'insicurezza sociale, che impegneranno la nostra attenzione oggi.
È a partire dall'esigenza di combattere i rischi sociali, che lo Stato
moderno si è costruito un ruolo nuovo ed essenziale, diverso dallo Stato di
diritto del quale si è parlato ieri: lo Stato sociale, o Welfare State.
Senza la pretesa di offrirne una definizione dotta, possiamo qualificare il
rischio come un evento che, sopraggiungendo, degrada lo Statuto sociale di
un individuo. Ad esempio un incidente, una malattia, la perdita di un lavoro
rischiano di far vacillare un individuo. Egli perde le risorse che gli erano
necessarie per vivere con un minimo di indipendenza e cade
nell'insicurezza sociale, nell'incertezza del domani, sotto la minacci della
decadenza sociale. L'insicurezza sociale è stata la condizione generale di
una gran parte di quello che veniva chiamato il popolo, in particolar modo
di coloro che non vivevano che della forza delle loro braccia per garantire il
proprio sostentamento, il che significa la stragrande maggioranza dei
lavoratori. L'insicurezza sociale è stata sempre una costante nella storia,
benchè le sue espressioni siano state spesso e volentieri discrete. Si tratta,
in effetti, di persone che spesso non hanno voce in capitolo, se non quando
la loro disgrazia esplode in rivolte o rivoluzioni. Ma si può affermare che
nelle società pre-industriali, cioè fino al diciottesimo secolo, una buona
metà della popolazione europea versasse in questa situazione di
vulnerabilità sociale, cioè minacciata di scivolare nel bisogno, infoltendo le
fila dei mendicanti e dei vagabondi, magari a causa di un cattivo raccolto o
di un inverno particolarmente rigido.
Questo problema è stato la grande questione sociale fino alla fine del
diciottesimo secolo almeno e su questo ci si potrebbe dilungare se avessimo
più tempo... Ma, in rapporto a ciò che dicevo ieri, ci si potrebbe
sorprendere dell'indifferenza della quale hanno dato prova i liberali nei
confronti di tale questione. Fondando lo Stato di diritto sulla proprietà,
facendo del cittadino un individuo proprietario, essi escludevano dal patto
sociale ciò che, molto prima di Marx, un autore del periodo rivoluzionario
chiamava “ la classe non proprietaria ”. Eppure, la situazione alquanto
spaventosa in cui versava questa
“ classe non proprietaria ” era una
realtà ben evidente al momento della formazione dello Stato moderno. Non
evocherò che una sola testimonianza, ma che non è scelta a caso e che cito
spesso perchè è dell'abate Seyiès. L'abate Seyiès è stato il principale
fautore della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino, cioè di
20
quel testo che afferma con clamore la libertà e l'indipendenza
dell'individuo. Ma, qualche anno prima di questa dischiarazione, nei suoi
appunti Seyiès parla « di quegli sfortunati votati ai lavori più penosi,
produttori dell'altrui godimento, che ricevono in cambio appena ciò di cui
sostentare il loro corpo sofferente e bisognoso di cure, quella folla di
strumenti bipedi che non posseggono che delle mani atte a guadagnare
poco ed un'anima affaticata ». E Seyiès aggiunge: « Sono questi, quelli che
voi chiamate uomini? ».
E bisogna ammettere che essi non sono degli uomini nel senso compiuto
del termine, individui sovrani della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e
del Cittadino. Ma, esprimendo un simile giudizio, Seyiès non esprime, o
non esprime soltanto, un pregiudizio di classe. Egli opera una constatazione
che si potrebbe qualificare come sociologica ante litteram. Questi individui
che « non posseggono che delle mani atte a guadagnare poco » sono i
numerosi lavoratori dell'epoca,
“ operai a giornata ” che, in città o in
campagna, sopravvivono giorno per giorno. È ciò che Marx chiamerà il
proletariato, o piuttosto, poichè il proletariato industriale non esiste ancora
alla fine del diciottesimo secolo, sono i piccoli salariati dell'epoca, “ genti
di pena e di braccia ”, la frangia inferiore dei lavoratori. Essi non solo sono
miserabili, sono anche disprezzati, persino da qualcuno come Seyiès, che
non è uno spirito particolarmente reazionario.
In questa fase, si assiste all'emergere della questione sociale moderna,
con la comparsa di nuove categorie di lavoratori, non solo poveri ma anche
privi di riconoscimento sociale e senza protezioni. Questa “ classe non
proprietaria ” è il nucleo del salariato moderno. E questa situazione si
aggrava progressivamente, fino ad estendersi, nel diciannovesimo secolo,
con lo sviluppo del proletariato. Con l'industrializzazione, il numero di
questi salariati miserabili si moltiplica e si rischia di vedere moltiplicarsi
anche il numero delle persone ridotte ad una condizione di “ quasistrumenti bipedi ”, per riprendere l'espressione dell'abate Seyiès, una
proliferazione di
“ nuovi barbari ”, secondo una qualifica che sarà
utilizzata nella prima metà del diciannovesimo secolo. È il tema « classi
laboriose-classi pericolose ».
Tale questione è stata analizzata, all'epoca, sotto il nome di “ questione
del pauperismo ”, ed ha costituito il centro della riflessione di tutti gli
osservatoeri sociali a partire dagli anni 1820-1830. Senza esagerare, si
potrebbero qui citare decine e decine di libri, di libelli, di saggi attorno alla
questione del pauperismo. Citerò soltanto uno di questo autori, Villeneuve
de Bargemont, il quale nel 1834 fornisce una definizione abbastanza
sintetica del fenomeno nel suo Trattato sull'economia politica cristiana.
"L'indigenza, sotto il nome nuovo e tristemente energico di pauperismo,
invade diverse classi sociali. Essa tende ad accrescersi progressivamente,
21
proprio in ragione della produzione industriale. Essa non è più un
incidente, bensì la condizione forzata di una parte dei membri della
società. Il pauperismo costituisce una minaccia all'ordine politico e
sociale".
Vi è all'epoca un ampio consenso su questo punto, che si tratti di autori
situati piuttosto a destra, come nel caso di Villenuve de Bargemont o
Tocqueville, il quale ha scritto un Saggio sul pauperismo, o a sinistra come
Engels, l'alter-ego di Marx, che fornisce un'allucinante descrizione di
Manchester, la città inglese che fu all'epoca al vertice del capitalismo
industriale.
In un certo senso, ci si potrebbe meravigliare di questa onnipresenza
della tematica del pauperismo nel diciannovesimo secolo. Degli storici
moderni hanno sottolineato che si trattava di una realtà relativamente
minoritaria in seno al mondo del lavoro. Infatti, si tratta degli operai della
prime concentrazioni industriali e delle loro famiglie, che si calcolano
essere state in Francia, nel 1840, circa mezzo milione, vale a dire circa un
decimo del mondo operaio, ancora ampiamente dominato dall'artigianato,
ivi compreso l'artigianato rurale, ancora assai fiorente fino alla fine del
diciannovesimo secolo. Ma è proprio questo che risulta essere interessante
per comprendere la costituzione di una classe pericolosa: la cristallizazione
su una minoranza dei pericoli che una società si rappresenta.
Perchè una simile cristallizzazione? Perchè queste persone che
compongono la popolazione del pauperismo sono concepite, ad un tempo,
come dentro e fuori la società. Dentro, poichè la maggioranza di questi
operai lavora, anche se spesso ciò avviene sotto forme estremamente
precarie, con compiti particolarmente devalorizzanti, ciò che oggi
chiameremmo i lavori sotto-qualificati. Ma, nello stesso tempo, essi sono
essenziali allo sviluppo dell'industrializzazione. Essi sono dunque nella
società, ma, contemporaneamente, sono lasciati parzialmenete fuori dalla
società stessa, perchè si tratta, generalmente, di immigrati che vengono
dalle campagne ad ammassarsi alle periferie delle città, i quali importano
alla città una cultura di origine rurale percepita dai cittadini e dai borghesi
come una non-cultura. Questi proletari, dice Auguste Comte con
un'espressione efficace, « fanno numero nella società moderna senza
esservi incasellati », cioè integrati. Essi non sono inseriti nei circuiti
dominanti degli scambi, non occupano una posizione stabile, né nel lavoro,
né nelle strutture familiari.
Di qui, lo sviluppo di un vero e proprio razzismo di classe, e la parola
non è troppo forte quando si viene a conoscenza delle descrizioni fornite di
questi “ nuovi barbari ”, che sono come degli aggressori che « dai
sobborghi delle città minacciano come dei barbari di trascinare tutto con sé
al loro passaggio ». Sono come dei selvaggi moderni, moderni perchè sono
22
il prodotto stesso dello sviluppo della modernità attraverso
l'industrializzazione - ed è questo paradosso che scuote profondamente gli
osservatori dell'epoca.
Ipotizzo che vi sia in ciò un movente profondo, che consente di
comprendere la relazione che una società intrattiene con i suoi margini. Per
una società vi sono dei nemici esterni, che all'occasione si combattono -è la
logica della guerra contro i “ veri stranieri ”, oserei dire. Ma vi sono anche
dei nemici interni, che sono nello stesso tempo parzialmente esterni perchè
importano nella società una cultura che sembra straniera, come i rurali per
la città, che vivono in condizioni assai precarie e sembrano atipici ed
immorali- e si può comprendere che tali condizioni assai precarie di
esistenza non predispongano a condurre una vita regolata: ubbriachezza e
violenza degli uomini, facilità di costumi e prostituzione delle donne sono
parte delle descrizioni del pauperismo, senza dubbio esagerate, ma non
completamente inventate.
Ciò che mi sembra confermare tale ipotesi è il fatto che lo stesso
meccanismo si produca in contesti assai diversificati. Si tornerà fra poco
sulla questione delle periferie, o dei quartieri difficili, così come essa è
attualmente percepita, perlomeno in Francia. Ma in principio questo ruolo
di classe pericolosa è stato ricoperto nella società pre-industriale dai
vagabondi, quegli individui completamente distaccati sia dal lavoro che da
qualsiasi iscrizione territoriale. Il vagabondo è un pigro ed un errante, un
esempio limite di ciò che mi sono riproposto di chiamare la desaffiliazione,
la completa rottura dei rapporti di lavoro e delle relazioni di sociabilità.
Come per il pauperismo, si potrebbero citare centinaia di testimonianze che
stigmatizzano i vagabondi, terrori delle campagne e principali responsabili
dell'insicurezza nelle città. E su questi sfortunati si sono abattute delle
misure repressive estremamente crudeli: le galere, l'impiccagione, la
bandizione, il marchiaggio a fuoco...
Così su questi vagabondi si sono cristalliazate gran parte delle paure
delle società pre-industriali, alle quali comunque non mancavano validi
motivi per sentirsi minacciate. Senza dubbio, i vagabondi erano numerosi,
all'epoca, e potevano essere talvolta pericolosi, soprattutto allorchè si
organizzavano in bande. Ma nella maggiorparte dei casi i vagabondi erano
dei poveri esseri che lasciavano una campagna che non poteva più nutrirli,
o una città nella quale non avevano lavoro perchè non inseriti
nell'organizzazione corporativa dei mestieri. I vagabondi rappresentano
questa frangia della popolazione che le strutture della società preindustriale non riescono ad integrare e che sono respinti ai margini. Si
potrebbe dire che questa politica nei riguardi dei vagabondi abbia costituito
una forma di politica sociale, e persino la prima politica sociale condotta
dai poteri politici dell'epoca- la regalità a livello nazionale, le municipalità
a livello delle città- per tentare di sradicare il male sociale rappresentato dal
vagabondaggio. Tali politiche sono d'altronde fallite perchè su più di un
23
quarto di secolo- dalla metà del quattordicesimo alla fine dell'Ancien
Régime- si susseguono gli stessi tipi di editti regali o municipali che
condannano il vagabondaggio senza riuscire a controllarlo.
Allora, non dico che la situazione dei proletari sia uguale a quella dei
vagabondi - i vagabondi non erano iscritti da nessuna parte, ed era questo il
loro dramma; mentre i proletari sono utili, e persino indispensabili alla
società industriale, i vagabondi sono degli “ inutili al mondo ”, per
riprendere la formula usata in un processo che si concluse con
l'impiccagione di un povero vagabondo nel quindicesimo secolo. Si è
potuto cercare, al limite, di sradicare la questione del vagabondaggio
sopprimendo i vagabondi, mentre non si potrebbe immaginare di
sopprimere i proletari, poichè essi sono inseriti nell'ordine industriale che si
sta man mano costruendo. Per questo occore moralizzarli, socializzarli,
integrarli. E per fare questo occorre far svolgere allo Stato una fuonzione
diversa da quella repressiva, prevalsa per il trattamento del
vagabomdaggio. È lo sviluppo di un'altra funzione dello Stato, lo Stato in
un ruolo sociale, lo Stato sociale, che che andrà ad operare essenzialmente
come un riduttore di rischi: ridurre i rischi combattendo l'insicurezza
sociale.
Dico questo in una forma talmente schematica da poter apparire
caricaturale. Ma cercherò di esplicitare questo processo. Se disponessi di
maggior tempo, potrei illustrare come nel diciannovesimo secolo questa
soluzione, che va ad imporsi, non fosse la sola possibile. Vi sono stati
tentativi rivolti in altre direzioni: lo sviluppo della filantropia per cercare di
moralizzare queste classi pericolose senza il ricorso allo Stato. La
filantropia è stata estremamente importante nel diciannovesimo secolo, in
particolare attraverso lo sviluppo di un paternalismo padronale nelle grandi
industrie dell'epoca che ha posto in essere delle vere e proprie istituzioni
sociali, ma in una forma totalmente privata. Vi sono anche, all'altra
estremità dello scettro politico, le diverse versioni del socialismo
rivoluzionario e del marxismo, che riguardano le rivendicazioni di una
classe operaia che si struttura nella sua opposizione al paternalismo
filantropico ed al capitalismo ed intende scuotere a fondo i rapporti di
produzione abolendo il salariato. Evidentemente, si potrebbe parlare per ore
di queste opzioni, che rappresentano anche delle risposte alla questione
sociale così come si pone nel diciannovesimo secolo, a partire dall'esistenza
del proletariato. Ma il mio proposito non è quello di fare la storia completa
di questo periodo. Mi limito a cercare di far comprendere la risposta che ha
prevalso, e che era lungi dall'essere evidente all'epoca.
La sintetizzerò dicendo che essa è sfociata nella costituzione di una
nuova forma di proprietà, la proprietà sociale, che determinerà delle
protezioni e delle sicurezze (la sicurezza sociale) per i non proprietari.
Questa sorta di invenzione di una proprietà sociale mi sembra costituire il
nucleo della risposta alla questione sociale che si elabora a partire dalla fine
24
del diciannovesimmo secolo, ed anche il nucleo di ciò che si chiama lo
Stato sociale, o Stato assistenziale.
In cosa consiste la proprietà sociale? Parto dalla citazione di Alfred
Fouillée, uno dei rappresentanti di quella corrente di pensiero vicina alla
Terza Repubblica (anche Durkheim appartiene a questa corrente) che cerca
una via di mezzo fra il laissez-faire dei liberalisti, indifferenti alla questione
sociale, e l'estremismo dei socialisti rivoluzionari, che vogliono risolverla
minando le fondamenta della società e collettivizzando al proprietà. Come
dicevo, mi soffermo su questa posizione non per scelta ideologica, ma
perchè questa è la scelta che, come si vedrà, si è finalmente imposta. Alfred
Fouillée dunque, in un libro scritto nel 1884 ed intitolato La proprietà
sociale e la democrazia, dice quanto segue:
"Lo Stato può, senza violare la giustizia ed in nome della giustizia
stessa, obbligare i lavoratori ad un minimo di previdenza e di garanzie per
l'avvenire. Giacchè queste garanzie di capitale umano sono come un
minimo di proprietà, essenziale a qualunque cittadino per essere libero ed
uguale agli altri, e sempre più necessaria per evitare la formazione di una
classe proletaria fatalmente condannata alla servitù o alla ribellione".
Questo testo è estremamente ricco e contiene l'essenziale di quella
formula che comincia timidamente ad attuarsi a partire dalla fine del
diciannovesimo secolo e soprattutto durante il ventesimo. Si vede in esso
come sono articolate le diverse componenti delle moderne politiche sociali:
- Un nuovo ruolo dello Stato: "Lo Stato può, senza violare la giustizia ed
in nome della giustizia stessa persino imporsi ... È il nucleo dello Stato
sociale- lo Stato può e deve intervenire nelle questioni sociali. È trasgredire
ciò che è sempre stato un tabù per il liberalismo, un divieto di Stato al di là
delle funzioni minime dello Stato di diritto del quale si è parlato ieri.
- In secondo luogo, lo Stato deve dunque intervenire esigendo dai
lavoratori "un minimo di previdenza e di garanzie per l'avvenire". Questo
Stato si dà per obiettivo quello di securizzare l'avvenire dei lavoratori,
assicurando una sicurezza sociale. E il modo privilegiato, o in ogni caso
uno dei modi privilegiati d'intervento dello Stato sarà quello di promuovere
l'assicurazione abbligatoria: obbligare i lavoratori ad assicurarsi contro i
rischi sociali, il che stabilizzerà il loro avvenire, invece di condannarli a
vivere alla giornata nell'insicurezza sociale. E l'assicurazione obbligatoria
sarà effettivamente la grande tecnologia in grado di controllare i principali
rischi sociali. Vi è una relazione privilegiata fra la tecnologia assicurativa e
l'intervento statale. L'assicurazione, come sappiamo, non è un'invenzione
del diciannovesimo secolo, né tantomeno un'invenzione statale. Essa esiste
già sotto forma privata ( si vedano le assicuraziohni marittime, a partire
almeno già dal quattordicesimo secolo ) e persino in campo sociale essa ha
25
importanti applicazioni con le mutuali, le società di previdenza ecc. Ma
queste mutuali, incoraggiate dal movimento filantropico che evocavo
pocanzi, restano delle iniziative private. Esse diventano un'obbligazione di
Stato e ciò va a modificare profondamente la loro natura. È ciò che
d'altronde spiega la ferma opposizione dei liberali e dei filantropi a questo
obbligo assicurativo, che si traduce nella legge sugli incidenti sul lavoro del
1898 e nella legge sulle pensioni operaie e contadine del 1910. Ma ogni
volta vi sono voluti anni di accanite controversie prima che esse si
imponessero.
- Il prodotto di questo obbligo assicurativo è, dice Fouillée, quello di
dare « come un minimo di proprietà essenziale ad ogni cittadino ». Si tratta
di un minimo di proprietà che fornirà al lavoratore un minimo di
indipendenza. Egli avrà delle risorse di base per non dipendere dagli altri e
potrà essere un "cittadino libero ed eguale agli altri"- vale a dire libero
come lo erano solo i proprietari, prima di queste garanzie di capitale
umano. Forse Fouillée qui esagera un po', dicendo che si giunge ad una
vera uguaglianza con l'insieme dei cittadini. Appare evidente come questo
minimo di proprietà non sopprima le ineguaglianze fra le condizioni
sociali. Ma essa fornisce almeno le condizioni di base che consentono di
essere un cittadino a pieno titolo, poichè l'indipendenza sociale è assicurata.
- Infine, Fouillé trae l’implicazione socio-politica di questa innovazione.
Essa è la risposta alla questione del pauperismo ed al duplice pericolo che
esso rappresenta: o il persistere di una situazione di totale decadenza dei
proletari nella dipendenza del bisogno, oppure che tali proletari, « che altro
non hanno da perdere, se non le loro catene », come aveva detto Marx poco
tempo prima, si rivoltino rovesciando l’ordine borghese. Si tratta di una via
di mezzo fra uno statu quo politico che mantiene una miseria di massa ed
un’opzione rivoluzionaria che farebbe tabula rasa del passato.
Non credo di aver sovrainterpretato questo testo. Esso presenta una sorta
di programma che andrà a costituire un’ asse portante, per non dire l’asse
portante, delle politiche sociali che attuerà la Terza Repubblica e, anche al
di là della stessa terza Repubblica, un’ asse portante dello sviluppo dello
Stato sociale. Qui risulta chiaro che, come dicevo, questo Stato nel suo
ruolo sociale interviene innanzitutto come un riduttore di rischi. Esso
garantisce un minimo di sicurezza a coloro che versavano in una
permanente insicurezza sociale.
Si potrebbe dire che questa proprietà sociale sia un analogon, un
equivalente della proprietà privata. Non si tratta di una proprietà nel senso
di un patrimonio che si possiede e che è possibile vendere sul mercato.
Essa dipende da regolamentazioni legali e giuridiche.
Ad esempio, il diritto alla pensione. Io non posso vendere il mio diritto
alla pensione così come venderei un oggetto che mi appartiene. Esso
dipende da una serie di obbligazioni legali: aver versato per un certo
numero di anni dei soldi, ecc. Ma una volta che tali obbligazioni siano state
26
soddisfatte, si dispone effettivamente di un diritto, si riceve come un diritto
questa pensione che assicura un minimo di proprietà. Ciò non vuol dire che
vi sia la possibilità di vivere nell’opulenza, ma perlomeno affranca da
quell’indegnità e da quella miseria che costituivano la condizione generale
del vecchio lavoratore che non fosse più in grado di lavorare. Senza voler
fare del melodramma, si può affermare che si trattasse spesso di una
condizione spaventosa. Questi rischiava di ammalarsi gravemente per poi
finire in suoi giorni in un ospizio. Oppure poteva talvolta essere preso a
carico dai suoi figli, che non erano molto più ricchi di lui, cadendo così in
un’ulteriore forma di dipendenza. La pensione esemplifica perfettamente la
funzione della poprietà sociale. Essa non consente di vivere nel lusso, ma
costituisce comunque una vittoria su ciò che di più drammatico vi era
nell’insicurezza sociale. Essa costituisce una proprietà per la sicurezza.
Bisogna sottolineare un’ulteriore specificità di questa proprietà sociale:
essa è in larga misura costruita a partire dal lavoro. Un salariato, per
definizione, lavora per qualcun altro. Il salariato, dunque, come dicevano i
giuristi, costituisce un rapporto di subordinazione, ed è la radice della
denuncia dello sfruttamento dei lavoratori. Tale dipendenza permane
sempre, altrimenti detto si è sempre in un sistema capitalista. Ma ormai il
lavoratore lavora anche, in parte, per se stesso. Una porzione del prodotto
del suo lavoro sfugge alle leggi del mercato. Egli finanzia anche la propria
sicurezza e quella della sua famiglia. Si tratta di ciò che viene chiamato il
salario indiretto. Una parte del salario fa in qualche modo ritorno al
lavoratore sotto forma di protezioni, fornendogli dei diritti sociali, come
quello alla pensione.
Tale mutamento non costituisce una rivoluzione nel senso di uno
sconvolgimento dei sistemi di produzione. In tal senso, si tratta di
un’opzione riformista e non rivoluzionaria. Ma, nello stesso tempo, si tratta
di una trasformazione abbastanza fondamentale rispetto alla condizione dei
proletari degli albori del processo di industrializzazione, che hanno
letteralmente « perso la propria vita guadagnandosi di che vivere », per i
quali il salario costituiva una relazione puramente commerciale che, nel
rapporto di forza con il datore di lavoro, dava luogo ad uno sfruttamento
totale. Dunque si può affermare che la proprietà sociale metta fine a questo
tipo di situazione e muti qualitativamente la condizione effettiva dei
lavoratori. Essa apporta una certa limitazione all’egemonia del mercato sul
lavoro. Le esigenze capitaliste di un profitto massimale non sono più in
grado di esercitare un dominio assoluto sul mondo del lavoro, perchè il
salario include ormai delle contropartite di natura sociale relative alla
protezione dei lavoratori. Nell’ambito di un regime il quale rimane
capitalista il mercato è quindi, in una certa misura, inquadrato dalla
proprietà sociale. Nello stesso tempo, lo Stato costituisce il garante
necessario di questa forma di equilibrio, poichè queste regolamentazioni
derivano dalla legge. Si stabilisce, dunque, un certo qual compromesso , ed
27
è proprio in ciò il nucleo di quello che viene chiamato “ il compromesso
sociale ” della società salariale, che toccherà il suo vertice verso gli anni
1970 - compromesso fra le esigenze di mercato di una produzione
massimale di ricchezze e l’esigenza di una sicurezza minima per quegli
uomini e quelle donne i quali producono tali ricchezze, cioè i lavoratori che
continuano, nella maggiorparte dei casi, ad appartenere alla “ classe non
proprietaria ”.
Ma ormai non si tratta più di quei proletari che « non avevano altro da
perdere all’infuori delle loro catene ». Il mutamento anche delle
implicazioni politiche, in direzione del riformismo, piuttosto che della
rivoluzione, costituisce la ragione per la quale le più radicali tendenze del
movimento operaio hanno, almeno in un primo momento, combattutto tali
misure, ad esempio opponendosi violentemente alla legge sulle pensioni
operaie e contadine, votata in Francia nel 1910.
Ecco, dunque, quello che mi sembra essere il nucleo della proprietà
sociale. In tutta evidenza, ho affermato tutte queste cose in una maniera
estremamente sintetica, e forse talvolta troppo schematica, ma tale brevità
era dettata dai limiti oggettivi del mio intervento; se avessi avuto maggior
tempo a disposizione, ne avrei approfittato per esplicitare le innumerevoli
peripezie attraverso le quali un simile sistema si sia progressivamente
costituito. In particolare, avrei sottolineato il modo in cui si sia passati dalle
prime realizzazioni, di portata piuttosto limitata, all’insieme sistematizzato
delle protezioni sociali. Ho pocanzi evocato la legge del 1910 relativa alle
pensioni operaie, la quale ha interessato un numero relativamente limitato
di salariati, vale a dire tutti coloro che all’epoca si trovavano al di sotto di
una determinata soglia salariale, in quanto l’idea dominante era ancora
quella che i salariati più “ agiati ” dovessero in un certo qual modo
assicurarsi da soli, nella logica della proprietà privata. Questa misura ha
dovuto interessare all’incirca un milione di persone, tanto più che la
maggiorparte dei beneficiari virtuali morivano assai prima dell’età della
pensione, cioè i sessantacinque anni. Dunque avrei sottolineato in che
modo si sia passati da queste prime realizzazioni, tutto sommato piuttosto
mediocri ( “ una pensione per i defunti ”, diceva la CGT dell’epoca, che vi
si opponeva con tenacia ), a quella che François Ewald ha chiamato, in un
altro periodo della sua vita,
“ la società assicurativa ” – una società in
grado di “ coprire ”, attraverso questi tipi di assicurazioni contro i rischi,
innanzitutto l’insieme dei salariati, e in un secondo tempo praticamente
persino l’insieme della popolazione, nel periodo che è succeduto alla
Seconda Guerra Mondiale. Inche modo tutto ciò è potuto accadere?
François Ewald, nel suo libro intitolato Lo Stato assistenziale ha avuto
ragione nel sottolineare la forza del modello assicurativo, poichè in larga
misura è proprio la mutualizzazione dei rischi sociali ad aver permesso di
28
vincere i rischi stessi. Tuttavia, la tecnologia assicurazionista non ha
giocato da sola. Vi è un contributo da aggiungere ad analisi come quella di
Ewald, ispirate d’altronde da Michel Foucault, e che ho presentato ne Le
Metamorfosi della questione sociale. Dietro simili trasformazioni si gioca
un processo sociologico di fondo che è quello della generalizzazione e
diversificazione del salariato . Allorchè la legge del 1910 sulle pensioni
viene applicata, il salariato è ancora, essenzialmente, il salariato operaio.
Esso rappresenta, in Francia, all’incirca i tre quarti dei salariato, fino alla
fine degli anni 1930. È su questo blocco centrale della società, che nello
stesso tempo è anche il più vulnerabile, che le assicurazioni puntano
nell’intento di stabilizzarlo, oppure di integrarlo nella società industriale:
far uscire questi salariati, per la maggiorparte miserabili, dalla situazione di
insicurezza sociale nella quale essi versano. Ma, progressivamente, si
operano contemporaneamente, come dicevo, una generalizzazione ed una
diversificazione del salariato. Verso il 1970, i salariati rappresentano quasi
l’ 80 % della popolazione attiva totale, a detrimento di altre categorie di
lavoratori, contadini, artigiani, piccoli imprenditori. Ma, nello stesso
tempo, il salariato si è diversificato. Gli operai rimangono i più numerosi,
certamente, ma, soprattutto al di sopra di loro, si sviluppano rapidamente
delle nuove categorie di salariati, impiegati, professioni intermediarie,
quadri medi e superiori.
Questa società è così diventata, dopo la Seconda Grande Guerra, quella
che possiamo chiamare una società salariale, e questo non soltanto in
Francia, bensì in tutta l’Europa occidentale. Sempre per motivi di tempo,
non mi è possibile in questa sede relazionare nei particolari tutto questo
processo, ma vorrei portarmi direttamente nel suo punto di sbocco, verso la
metà degli anni 1970, poco prima che la situazione cominci piano piano a
degradarsi.
Una sociatà salariale non è solamente una società nella quale la
maggiorparte della popolazione attiva è salariata – il che è comunque vero,
poichè in Francia, come senza dubbio in Italia, a quell’epoca all’incirca l’
80 % della popolazione attiva era salariata. Ma essa è anche, e soprattutto,
una società all’interno della quale la stragrande maggioranza dei membri è
assicurata, e gode di protezioni sociali forti. Queste protezioni, la
maggiorparte delle quali sono state costruite espressamente a partire dal
salariato stesso, assicurano dunque, quasi a tutti, una sicurezza. Certamente
restano, ai margini, degli individui o dei gruppi più o meno marginali che
non sono coinvolti nel processo di modernizzazione ( quello che in Francia
si è chiamato “ il quarto Stato ” ), ma si ritiene, in generale, che queste
siano delle categorie residuali, in via di riassorbimento nella dinamica del
progreso sociale. Si può dunque pensare che l’insieme della società sia
assicurato dai principali rischi sociali.
29
Questa società non è una società egualitaria. La società salariale, ivi
compreso nel suo periodo di massima crescita, ha lasciato sussistere delle
forti diseguaglianze. Le differenze fra le varie categorie della
stratificazione sociale – ad esempio quelle che sussistono fra gli operai ed i
quadri – non si sono molto attenuate. L’immagine che si dovrebbe
impiegare per descrivere gli anni di maggior accrescimento della società
salariale, quelli che hanno seguito la Seconda guerra mondiale, è forse
quella di una scala meccanica, di un escalator sul quale tutto si eleva,
mentre la distanza fra le categorie poste sui diversi gradini resta
pressappoco la stessa. Dunque, e contrariamente a quello che spesso si dice
allorchè si parla di “ Stato Assistenziale” , vi è relativamente poca
redistribuzione dei benefici del progreso economico e sociale, tranne forse
in direzione dei più poveri. Al contrario, si sono stabilizzate delle forti
protezioni.
Si potrebbe affermare che la società salariale consista in un continuum
differenziato di posizioni . La formula può forse apparire un po’ pedante,
ma è certamente precisa.
La differenziazione sociale fra le posizioni rimane determinante, ad
esempio fra quelle due categorie di salariati che sono gli operai
specializzati poco qualificati e gli ingegneri, e le differenze non attengono
semplicemente al reddito. Ma, nello stesso tempo, continuum, continuità di
posizioni, poichè queste diverse categorie godono del medesimo tipo di
protezioni, protezione sociale e diritto al lavoro, le quali hanno un potere,
appunto protettore, assai consistente.
Si tratta in ogni caso di un’idea che vi sottopongo e sulla quale insisto,
perchè credo che non sia stata sufficientemente sottolineata. D’altronde è la
ragione per la quale non mi piace l’espressione “StatoAssistenziale”, che
non adopero mai. Questa spinge a pensare che il Welfare State sia una sorta
di distributore di benefici, che sparga a destra e a manca sussidi di ogni
sorta – un po’ come la Provvidenza divina è ritenuta ricolmatrice di doni
dai cristiani. E spesso è anche a partire da tale rappresentazione che i
nemici dello Stato sociale condannano quest’ultimo come un dispositivo
dispendioso e rovinoso, che deresponsabilizza i suoi beneficiari
colmandoli, appunto, di benefici che non hanno ottenuto né meritato
attraverso i loro sforzi.
Senza stabilire un’opposizione assoluta fra il ruolo distributore ed il
ruolo protettore dello Stato sociale, penso che si debba insistere
principalmente sul ruolo protettore. “ Fare del sociale ” non significa
semplicemente ridistribuire. Si prenda l’esempio della pensione, del quale
ho già avuto modo di illustrare come essa fosse una realizzazione
particolarmente significativa della proprietà sociale. In Francia, ma credo
che tale situazione sia molto vicina a quella dell’Italia, ad un buon salario
corrisponde una buona pensione, mentre ad un piccolo salario corrisponde
una piccola pensione. Il ruolo ridistributore della pensione, se esso esiste, è
30
dunque stremamente debole. Al contrario il suo ruolo protettore è assai
forte. È evidente se paragonato alla situazione precedente come quella del
proletario degli inizi dell’industrializzazione. La pensione ha limitato
l’insicurezza sociale. Anche il piccolo pensionato dispone di quel minimo
di risorse e diritti che gli consente di non cadere in situazioni più o meno
degradanti di assistenza.
Per concludere con questo sviluppo della proprietà sociale nel dettaglio ,
nel merito del quale non posso entrare, a conclusione di tale processo,
negli anni 1970 , prenderò ad esempio il caso di uno dei suoi beneficiari.
Prendiamo un tecnico impiegato in una grande impresa. Egli non è
necessariamente proprietario, se non forse dei beni di consumo correnti, i
suoi mobili, i suoi vestiti, la sua macchina etc... . Al contrario, egli gode di
un salario relativamente confortevole. Ed anche e soprattutto ha delle
protezioni e dei diritti che sembrano garantirgli un’avvenire sicuro per sè e
per la sua famiglia, anche quando avrà superato l’età lavorativa ( pensione
). In termini di indipendenza sociale, egli può perfettamente rivaleggiare
con un proprietario, con quei piccoli reddirieri che descrive ad esempio
Balzac, tesi alla difesa del loro piccolo patrimonio. Questo tecnico non ha
effettivamente bisogno di rendite, non rischia di essere rovinato da una
cattiva congiuntura come hanno potuto esserlo numerosi redditieri, che
avevano ad esempio sovvenzionato dei crediti prima della rivoluzione
bolscevica. Questo salariato rappresenta uno dei modelli di individuo
moderno indipendente, così come illustrato nei giornali alla moda degli
anni sessanta: il giovane quadro dinamico, libero, affrancato dai pregiudizi
arcaici, curioso, relativamente colto, etc. A ben vedere, è questo un
modello di individuo moderno. Vi è così un modo di uscire dall’inscurezza
sociale dall’alto. Ma tale individuo è così perchè egli dispone di supporti
costruiti a partire da una condizione salariale solida.
Si può tradurre questo dicendo che vi è uno statuto dell’impiego al quale
sono riagganciate delle protezioni e dei diritti. La costituzione di uno
statuto dell’impiego è stata lunga, attraverso una moltitudine di conflitti e
di compromessi , ed ha permesso di vincere , per la maggioranza della
popolazione, i principali rischi sociali. Una funzione essenziale del Welfare
State è stata contribuire alla costituzione di questo statuto del’impiego. In
tutta evidenza, lo Sato non ha influito da solo su questo processo. Il
compromesso sociale che ho già evocato è il risultato di una negoziazione ,
spesso conflittuale, fra le diverse “parti sociali ”, come si suol dire –
sindacati dei salariati, patronato ...
Ma il ruolo dello Stato è stato non di meno essenziale nell’amito di
questa costruzione. Non solo è stato un partner nella negoziazione
collettiva, ma è proprio lui a conferire forza di legge agli equilibri nei quali
essa sfocia.
31
[PAUSA]
Ciò che ho cercato di presentare attraverso lo sviluppo della prorpietà
sociale è, schematicamente, la risposta che è prevalsa fino alla metà degli
anni settanta in Francia, ma anche, con delle varianti non trascurabili e
delle quali sarebbe interessante discutere, in Italia ed in diversi paesi
dell’Europa occidentale. Questo non vuol dire che simili trasformazioni
siano state totalmente egemoniche . Restavano comunque degli individui e
dei gruppi che non venivano iscritti in questi sistemi generali di protezione.
Così “ il quarto mondo ”, che ho già evocato e che rivelava da forme più
particolariste di protezioni. Ma si credeva anche in generale che si trattasse
di popolazioni in via di riassorbimento nella dinamica generale del
progresso sociale.
Ma questa dinamica si è infranta a partire da quella che è stata chiamata
“la crisi” degli inizi degli anni 1970 , e che si rivela essere molto più di
una crisi passeggera, corrispondente senza dubbio ad un mutamento di
regime del capitalismo, al tramonto del capitalismo industriale. Ma una
delle conseguenze più consistenti di questa
“ grande trasformazione”,
come direbbe Karl Polaniy, è stato il nuovo aumento del’insicurezza
sociale , che non rinvia – almeno non ancora – al pauperismo del
diciannovesimo secolo ma che destabilizza alquanto profondamente quei
dispositivi di protezione dai rischi sociali dei quali si è appena vista
l’attuazione. Vi sarebbe molto da dire sulla natura e l’ampiezza di tale
mutamento, ma uno dei modi di cogliere ciò che è accaduto è trarre le
conseguenze della destabilizzazione dal modello classico dell’impiego, che
è stato la chiave di volta della struttura della società salariale. Questo
modello dell’impiego corrisponde ad uno statuto stabile al quale erano
riagganciate delle protezioni e dei diritti altrettanto stabli, ma ciò che
bisogna comprendere, è che queste protezioni erano legate alla stessa
struttura dell’impiego. Si diceva che “un lavoratore occupava un impiego” ,
cioè è dall’impiego che egli traeva sia delle obbligazioni (lavorare in un
certo modo, per un certo tempo, etc..), che delle protezioni.
Se tale struttura ha funzionato bene per stabilizzare la codizione
salariale, ciò dipende innanzitutto dalla permanenza delle condizioni di
lavoro nella durata. Si tratta della presenza maggioritaria di ciò che si
chiama in Francia il contratto a tempo indeterminato, il C.D.I. , che in
principio assicura la permanenza dell’impiego sulla lunga durata. Ma anche
questo modello dell’impiego stabile riposa sulla permanenza dei compiti di
lavoro: omogeneità delle categorie professionali, stabilità dei posti di
32
lavoro, gestione in continuo delle carriere professionali... Questa
permanenza dello statuto dell’impiego sfuggiva largamente alle fluttuazioni
del mercato ed ai cambiamenti tecnologici che erano molto meno rapidi di
adesso.
È questa struttura che è rimessa in questione dalla frammentazione degli
impieghi e dalla flessibilizzazione dei compiti. Questo è un punto sul quale
bisogna insistere perchè è il nucleo della grande trasformazione attuale che
ha iniziato a manifestarsi con la crisi degli anni 1970. Allorchè si è iniziato
a parlare di questa “crisi” in un primo tempo si è stati particolarmente
sensibili ad alcune delle sue manifestazioni più spettacolari, come la
disoccupazione di massa , che è effettivamnete drammatica. Ma, facendo
un passo indietro, ci si rende conto che al di là di questa disoccupazione di
massa si cela un processo di decollettivizzazione, o di
reindividualizzazione del lavoro. E questo su diversi livelli. Riassumo:
- Nell’organizzazione del lavoro propriamente detta,vi è un’ esigenza di
mobilità, di disponibilita, di responsabilizzazione dei lavoratori o, come si
dice oggi, degli “ operatori ”. Per dirla in breve, i grandi collettivi
omogenei di lavoro non sono aboliti, ma si frammentano. L’individuo
lavoratore è allora sempre più in concorrenza con i suoi pari per far fronte a
cambiamenti incessanti. Si ha una frammentazione delle mansioni del
lavoro , anche con dei cambiamenti tecnologici, occorre essere
riconvertibili, adattabili, flessibili ecc...
- Ma anche a livello delle traiettorie professionali propriamente dette si
assiste alla stessa mobilizzazione. Si tratta di quello che il sociologo
tedesco Ulrick Beck chiama, nel suo libro La Società del rischio, la
preminenza di un modello biografico : tocca sempre più all’individuo
stesso il compito di farsi carico del proprio percorso professionale, egli
deve operare delle scelte, delle riconversioni, far fronte ai più repentini
cambiamenti, etc... Così, contemporaneamente alla parcellizzazione dei
compiti di lavoro, le traiettorie professionali divengono discontinue e sono
sempre più raramente iscritte nelle grandi regolamentazioni collettive
dell’impiego stabile. Di qui l’mportanza dei C.D.I., la moltiplicazione delle
cosidette “forme atipiche ” di impiego, il lavoro interinale, il lavoro
intermittente, il lavoro part-time, etc... Mi sembra tra l’altro che in Italia
questa evoluzione si sia risentita in una maniera ancora più drammatica che
in Francia.
Evidentemente, si tratta qui di un’evoluzione di tendenza.
Attualmente, in Francia i C.D.I. risultano ancora essere maggioritari.
Tuttavia, se si ragiona in termini di flusso, vale a dire in termini di entrate
sul mercato del lavoro, le più discontinue forme di impiego si moltiplicano
giorno dopo giorno. In termini concreti, questo significa che l’instabilità
dell’impiego sta oramai sostituendosi alla stabilità dell’impiego, divenendo
33
la forma dominante dell’attuale organizzazione del lavoro. Si tratta
indubbiamente di una tendenza estremamente forte. Certamente,
permangono delle forme ancora stabili di organizzazione del lavoro, ma
sicuramente questo processo di de-collettivizzazione e di reindividualizzazione dell’impiego attraversa oramai largamente la
maggiorparte delle attuali forme di organizzazione del lavoro, benchè sia
inegualmente impiantato a seconda dei settori. Ad esempio, al limite si
potrebbe avere, nel settore della “ nuova economia ”, la figura del creatore
di start up che è completamente individualizzato e de-collettivizzato. Ma,
anche nei bastioni della grande industria, come nella costruzione delle
automobili, si riscontrano le stesse tendenze con la costituzione di piccole
squadre che gestiscono la propria produzione in modo autonomo. Dunque
in linea di tendenza questa enorme trasformazione si impone quasi ovunque
nel mondo del lavoro; la si potrebbe forse riassumere dicendo che si assiste
ad una generale rimessa in mobilità. Allorchè il capitalismo industriale era
caratterizzato dalla preponderanza delle forme di organizzazione collettiva
e delle regolazioni collettive, l’attuale mutazione del capitalismo rompe, e
in ogni caso affetta gravemente, questa preminenza dei collettivi.
Queste trasformazioni comportano evidentemente delle implicazioni
importanti sul piano della produzione dei lavoratori e sulla protezione
sociale in generale. Come ho già detto, le protezioni riposavano su dei
sistemi generali di assicurazioni che “coprivano” delle grandi categorie
omogenee di salariati. Attualmente, si è assistito alla moltiplicazione di
quelli che si chiamano i minima sociali , cioè delle prestazioni che sono
attribuite senza condizione di risorse a degli individui e a dei gruppi che
incorrono in particolari difficoltà o che non sono ( o non più ) nel regime
generale dell’ impiego. In Francia, il più conosciuto di questi minima
sociali è il reddito di inserimento minimo ( R.M.I. ), istituito nel 1989, ma
vi sono attualmente otto minima sociali, nonchè una folla di misure
particolari di “lotta alla povertà”, o di “lotta contro l’esclusione”.
Non si tratta di criticare queste misure, che hanno un’utilità e
rappresentano senza dubbio un male minore per delle popolazioni che
versano in situazioni molto difficili proprio perchè private dell’impiego.
Ma bisogna chiedersi se non si stia assistendo ad una trasformazione del
regime stesso delle protezioni . Accanto ai sistemi generali di protezione
della società salariale, che conferiscono i più pieni diritti, si avranno
sempre più delle misure particolariste, di una qualità inferiore, rivolte ai più
deprivati. Si scivolerà così verso una sorta di regime a due velocità . Nello
stesso tempo, occorre costatare che anche le protezioni più generali sono
minacciate, come illustrano i dibattitti attualmente in corso relativamente
ai regimi delle pensioni e della sanità.
Parallelamente, si sviluppano queste protezioni che non solo sono
inferiori quanto alle risorse finanziarie, ma rischiano anche di assumere un
carattere stigmatizzante nella misura in cui sono attribuite sulla base di
34
qualcosa, cioè una deficienza, o in ogni caso sulla base dell’accertamento
di una mancanza rispetto al regime comune. È così che l’ R.M.I. , che
nasceva da un’intenzione piuttosto generosa, si è percepito nel corso degli
anni in maniera sempre più peggiorativa; usufruirne è come essere
sospettati di non essere abbastanza coraggiosi da lavorare.
Infine, ci si potrebbe chiedere se non sia la stessa concezione di
solidarità ad alterarsi. Esiste un forte senso della solidarietà che Durkheim
chiama “la solidarietà organica” , che significa che tutti i membri di una
società sono legati da relazioni di interdipendenza. Ciò non vuol dire che
essi siano uguali in senso stretto, ma che partecipano ad un medesimo
insieme sociale perchè ognuno di loro dispone di risorse e di diritti comuni
che gli permettono di essere in interrelazione con gli altri. Ma la solidarietà
così come la si intende oggi tende piuttosto a somigliare all’assistenza,
quando non alla carità. Ad esempio, viene chiamata “allocazione specifica
di solidarietà” un’allocazione accordata ai disoccupati arrivati “in fine di
diritto”, i quali non godono più dell’assicurazione sulla disoccupazione
alla quale essi avevano diritto in funzione del loro precedente lavoro. Si
concede loro dunque una “allocazione di solidarietà”. Certamente è meglio
di niente , ciò significa che si è solidali nel senso che non si lasciano
completamente a se stessi i membri meno fortunati della società. Tuttavia,
questa soluzione è molto inferiore all’assicurazione. Questi disoccupati non
sono protetti da un diritto che hanno acquisito in ragione del loro lavoro. La
comunità se ne fa carico, ma essi hanno davvero un’indipendenza sociale,
sono ancora dei cittadini sociali a pieno titolo? La questione di fondo che ci
si potrebbe porre è se oggi non si stia assistendo ad una sorta di riscatto
della prorpietà privata su quella sociale. Non si tratta di istituire una
opposizione assoluta fra queste due concezioni della proprietà. Si potrebbe
anche difendere la tesi che la costituzione della proprietà sociale nel senso
in cui io l’ho intesa abbia salvato la proprietà privata. Essa non ha reso
necessario un tipo di soppressione della proprietà privata, la sua
collettivizzazione quale la intendevano diverse correnti del socialismo
rivoluzionario e il marxismo ( si pensi alla rivoluzione bolscevica del 1917
in Russia ). Fra diverse altre ragioni lo statuto protetto del lavoro nella
società salariale ha certamente influito per economizzare questo tipo di
alternativa alla proprietà privata . Ma oggi le trasformazioni di matrice
liberale o neo liberale non portano forse di nuovo in primo piano la figura
del proprietario? Non si tratta del proprietario terriero che era la forza
dominante della proprietà nella società preindustriale, e neppure della
proprietà del redditiere nel diciannovesimo secolo. Nè è il capitano di
industria del periodo d’oro del capitalismo industriale. È soprattutto,
attraverso la mondializzazione, la figura del capitalismo finanziario a
dominare, cioè la ricerca del profitto per il profitto. Questo tipo di
proprietà, se avesse la meglio, schiaccerebbe la proprietà sociale e forse lo
stesso Stato sociale.
35
Poichè bisogna insistere sui rapporti che esistono fra l’assottigliamento
della proprietà sociale e la fragilizzazione dello Stato sociale, ovvero ciò
che si potrebbe chiamare la crisi dello Stato nazional Sociale. Questa è
un’espressione che Étienne Balibar impiega in un senso vicino a questo e
che bisogna presentare con una certa prudenza, poichè non ha niente a che
vedere con il nazional socialismo di matrice fascista. Tuttavia tale
espressione qualifica in modo alqualnto efficace il tipo di Stato che si è
affermato soprattutto nell’europa occidentale dopo la fine della seconda
guerra mondiale e che ha costruito questi sistemi di protezioni su una base
nazionale. Vi sono certamente delle varianti significative che distinguono
fra loro la Francia, l’Italia, la Gran Bretagna, la Germania, la Spagna, il
Portogallo, etc... ma vi sono anche delle forti analogie, perchè queste
differenti versioni dello Stato sociale avevano il potere di controllare i
principali parametri della loro economia attraverso delle politiche
economiche di ispirazione Keynessiana. Queste politiche sono state
possibili perchè ciascuno Stato disponeva allora di una certa autonomia per
impostare la propria politica economica, cosa che gli permetteva anche,
soprattutto in periodi di forte crescita, di sviluppare delle politiche sociali
molto estese. Tuttavia, con l’europeizzazione e la globalizzazione questo
margine d’azione degli Stati Nazionali si è ristretto . Se ne è avuta la
prova in Francia dopo l’insediamento dei socialisti nel 1981. Il tentativo di
rilancio al contempo economico e sociale del primo governo socialista è
fallito. La Francia si è poi avvicinata a certi imperativi dettati dalla
concorrrenza economica internazionale , con tutte le sue implicazioni
sull’organizzazione del lavoro (decollettivizazione e reindividualizzazione
) e sulle protezioni sociali in direzione di uno scivolamento di sistemi
omogenei di assicurazione verso una logica di minima sociali che trae
dall’assistenza la protezione sociale. Si nota che tale indebolimento è anche
un modo di rimettere in discussione lo Stato nazional sociale pensato
dall’ideologia neo liberale dominante come un qualcosa che ostacolava,
attraverso le sue regolamentazioni, la libera dinamica del mercato.
Evidentemente , si tratta qui di grandi tendenze, che sono obbligato a
presentare in modo stringato. Esse formano l’attuale contesto a partire dal
quale credo si sia in diritto di parlare di una nuova ascesa dell’insicurezza
sociale. Per un numero sempre crescente di persone l’incertezza
dell’avvenire ha rimpiazzato la certezza di poter controllare l’avvenire
lottando efficacemente contro i principali rischi sociali. Tuttavia questa
diagnosi non equivale ad una catastrofe. Siamo in Francia come in Italia in
società ancora largamente circondate e attraversate da protezioni. È
un’evidenza se paragoniamo la nostra situazione a quella che prevaleva
appena secolo fa. La diagnosi più oculata che si possa fare è quella
dell’assottigliamento, non del crollo dei sistemi di protezioni. Questo
significa che non siamo, o non ancora, in delle società interamente percorse
dalle esigenze del mercato. Il che può lascire dei margini di manovra
36
affinchè il crollo non sia ineluttabile e spero avremo un po’ di tempo per
discutere di questo.
Prima di tutto, poichè abbiamo parlato successivamente dell’insicurezza
civile e dell’insicurezza sociale, vorrei discutere una questione che illustra
in maniera esemplare il modo in cui questi due tipi di insicurezza si
sposano reciprocamente. Sarà anche l’occasione di ritornare un’ultima
volta, come avevo annunciato, sulla tematica delle classi pericolose, che
riunisce fra il reale e l’irreale la congiunzione fra queste due forme di
insicurezza.
I vagabondi delle società preindustriali, così come i proletari delgi inizi
dell’industrializaazione che ho giàò evocato, rappresentano dei gruppi
totalmente privi di mezzi rispetto ai rischi sociali e sono stati essi stessi
percepiti come rappresentanti un rischio capitale per la sicurezza civile. Per
attualizzare questo schema ( è questo il titolo che avevo proposto per
questo seminario: “ Il ritorno delle classi pericolose? ”, sottolineando il
punto interrogativo ), mi sembra che questo ruolo sia oggigiorno
interpretato dalle popolazioni delle periferie, e più precisamente dai giovani
delle periferie, i quali cristallizzano in maniera privilegiata per molte
persone i pericoli dell’insicurezza.
Innanzitutto, voglio precisare meglio il quadro di quello che si chiama “
il problema delle periferie “, o dei quartieri sensibili. Esso si situa in quei
vasti insiemi immobiliari che sono stati costruiti alla periferia delle grandi
città francesi. Questi immobili sono stati costruiti alla fine degli anni
cinquanta e sessanta per far fronte ad una gravissima crisi degli alloggi che
colpì la Francia del dopoguerra. In un primo momento, queste costruzioni
in periferia sono riuscite a combattere efficacemente il problema degli
alloggi insalubri, il sovraffollamento e la mancanza di alloggi etc... Queste
nuove forme di habitat, che erano generalmente costruite da architetti
modernisti, sono state soprattutto popolate da degli operai in via di ascesa
sociale ed anche da alcune categorie della classe media. Poi è sopraggiunta
la “ crisi ”, che non ha evidentemente origine nelle periferie, ma di cui uno
degli effetti è stato un cambiamento della popolazione di questo habitat e
del profilo sociologico dei suoi abitanti: la disoccupazione dovuta alla deindustrializzazione e l’aumento dei lavoratori immigrati hanno dato vita ad
una popolazione fortemente fragilizzata e precarizzata, con un numero
altissimo di maghrebini, i cui figli nati in Francia sono chiamati “ beurs” 1.
Nello stesso tempo, la qualità delle condizioni abitative si degrada e le
popolazioni più agiate lasciano questi spazi appena possibile. Per
riassumere, in questi spazi difficili da vivere si sono trovate riunite delle
1
Espressione offensiva, nata dall'approssimata inversione di "Arabe" N.D.T.
37
popolazioni fra le più precarizzate, che accumulano diversi handicap: forti
proporzioni di disoccupati o di lavoratori precari, di giovani spesso alla
ricerca di un impiego...
Prendiamo il caso dei giovani, poichè è su di essi che si cristallizzano le
reazioni più ostili. In linea generale, essi sono fuori dal regime dell’impiego
regolare. Spesso hanno ricevuto un’istruzione mediocre. Errano
freneticamente per strada, anche perchè il loro habitat non è per niente
attraente. Talvolta formano delle bande, all’occasione commettono dei
delitti, si dedicano ad un’economia informale ai margini della legalità.
Talvolta si scontrano con le forze dell’ordine. Soprattutto, sono molto
visibili, si raggruppano negli androni delle scale condominiali o nelle
piazze come ad ostentare davanti a tutti la loro inutilità sociale e la loro
disoccupazione.
Bisogna riconoscere che queste condizioni di vita, questa instabilità non
predispongono a vivere in modo particolarmente angelico. Vi sono
effettivamente dei tassi di delinquenza e di inciviltà più elevati che altrove,
in questi quartieri, e si è anche parlato di alcuni di loro come di zone di non
diritto in cui la polizia non osa neppure entrare. Dunque non contesto che
dei problemi reali di insicurezza si pongano e debbano essere presi sul
serio- tanto più che spesso coloro che subiscono delle violenze quotidiane,
o che le temono, sono spesso le persone del quartiere che non hanno i
mezzi per vivere altrove. Tuttavia, fare di questi giovani una vera e propria
classe pericolosa mi pare eccessivo. Piuttosto si tratta del processo di
slittamento della conflittualità sociale che ho già segnalato a proposito dei
vagabondi e dei proletari. Non possiamo applicare a questi giovani la
formula che Auguste Comte riservava ai proletari degli inizi del
diciannovesimo secolo? “ Essi vivono nella società moderna senza esservi
inseriti ”. Essi soffrono infatti di un deficit di integrazione, soprattutto se di
origine straniera, e si scontrano con l’ostilità dell’ambiente circostante e
della polizia.
Ma mi sembra che la relazione con il margine esprima nello stesso
tempo una relazione con il centro della società. Questi giovani non vivono
su un altro pianeta, essi esprimono in una forma limite una situazione
infondo generale, o in ogni caso molto comune, con la loro difficoltà nel
trovare un impiego e un alloggio decente, le cui cause sono a monte della
loro situazione particolare; ecco l’iopotesi che vi sottopongo: è il centro che
produce il margine. I proletari dei quali si è già parlato sono spinti al
margine, sono percepiti al margine, ma esprimono nei fatti una struttura
essenziale del capitalismo industriale, all’epoca dominato dal massimo
sfruttamento della forza lavoro. Allo stesso modo i vagabondi sono
percepiti come dei fuorigioco sociali,
“ inutili al mondo ”, secondo la
vecchia formula che ho già citato. Tuttavia, se si osserva più da vicino da
dove provengono i vagabondi, la qual cosa ho cercato di fare, si noterà che
nove volte su dieci essi provengono dal piccolo popolo delle città o delle
38
campagne, sottoqualificato, come si direbbe oggi, che non trova da
mangiare a sazietà nella fattoria a conduzione familiare. Essi partono alla
ricerca di un lavoro che nella maggiorparte dei casi non trovano e
diventano vagabondi criminalizzati.
Perchè mai non trovano lavoro? Perchè l’organizzazione dell’impiego
dell’epoca è dominata dal sistema delle corporazioni. Si tratta di un sistema
estremamente rigido e chiuso, occorre spesso fare un apprendistato di circa
dieci anni per diventare maestri. I vagabondi sono esclusi da questa
struttura e sono, se posso permettermi l’espressione, come dei salariati
virtuali: essi non hanno che la loro forza lavoro per vivere, ma questa
virtualità del lavoro non si realizza perchè non esiste un mercato del lavoro
aperto che possa impiegarli. Allo stesso modo, ed anche questo è un
rapporto del centro e del margine senza una modalità diversa, è una
struttura centrale dell’organizzazione della società industriale che
costituisce il proletariato come questa sorta di margine. Ed allo stesso
modo i giovani della periferia sono costituiti come un margine
stigmatizzato perchè la loro situazione fornisce una rappresentazione limite
di problemi che attraversano l’insieme della società nella situazione di “
crisi ” attuale.
Si potrebbe fare un’analisi ancora più precisa mostrando come questa
aggressività, che almeno in parte si rivolge contro i giovani, sia l’effetto di
un risentimento collettivo di gruppi sociali che sono lasciati da parte nella
dinamica della modernizzazione che si dispiega nel quadro della
mondializzazione, come una parte della classe operiaia un tempo integrata
nella società industriale. Questi gruppi vivono la loro attuale traiettoria
come un declino ed hanno una reazione collettiva di rigetto. Una reazione
che potremmo chiamare
“ da piccoli bianchi ” – come forse sapete,
quest’espressione ha designato in principio una parte della popolazione
bianca del Sud degli Stati Uniti, la quale viveva in condizioni assai modeste
alla fine della Guerra di Secessione, e si trovava palmo a palmo con i Neri
poveri quanto lei, ma che avevano guadagnato la propria indipendenza
sociale. Il razzismo anti-nero, nelle forme durevoli e cruente che ha
assunto, si ancorava in quel contesto, ma faccio l’ipotesi che anche un
meccanismo socio-antropologico abbia giocato un ruolo. Questo
risentimento collettivo è proprio di gruppi che vivono un declino sociale, e
si rivolge su altri gruppi ad un tempo vicini ma diversi. Non è sui nuovi
neri piantatori di cotone, che i piccoli bianchi hanno rivolto il loro
disprezzo, ma su altri “piccoli Neri ” la cui condizione non era troppo
diversa dalla loro. Il risentimento collettivo si rivolge a coloro con i quali si
è messi in concorrenza e che si accusa di prendre il proprio posto, di essere
dei parassiti.
Mi sembra vi sia insomma un risvolto del razzismo che prescinde dalle
situazioni particolari. Questo risentimento collettivo si rivolge oggi, in
Francia, sugli immigrati, soprattutto su quelli di origine maghrebina, che si
39
accusano di rubare impieghi ed usufruire di prestazioni sociali che
dovrebbero essere riservate agli “ autentici francesi ”, come si suol dire,
etc... Così si può comprendere, almeno in parte, ciò che per molti ha
costituito una sorpresa, cioè il voto per l’estrema destra alle elezioni
presidenziali dell’aprile 2002. Il nucleo centrale dell’ideologia del Fronte
Nazionale è una posizione violentemente anti-immigrata in nome della “
preferenza nazionale ”. Perchè, anche se non fa piacere, bisogna
riconoscere che Jean-Marie Le Pen è arrivato in testa grazie al voto dei
disoccupati, dei lavoratori più precari e di talune categorie operaie - dunque
una parte delle persone che un tempo votavano a sinistra. Si può
interpretare questo voto come una reazione di gruppi che hanno
l’impressione di essere lasciati da parte, e che ufficialmente lo sono, nelle
attuali trasformazioni in direzione dell’europeizzazione, della
globalizzazione e della modernizzazione. Questa reazione si rivolge su
gruppi effettivamente molto vicini ed in concorrenza sul piano del lavoro,
fomentando il razzismo, come ho detto, e l’esclusione, con tutte le
implicazioni delinquenziali ad essa connesse. Lo Stato di diritto ha il
dovere di arginare la delinquenza, ma l’errore in cui si può cadere in una
situazione così tesa è quello di confondere la lotta all’insicurezza civile con
la lotta contro l’insicurezza sociale, arrivando a credere che lo
sradicamento della delinquenza possa risolvere tutti i problemi di
insicurezza; problemi come la disoccupazione di massa non si risolvono
attraverso l’intervento delle forze armate. Ancorare la questione generale
dell’insicurezza su una nuova classe pericolosa vuol dire stigmatizzare un
gruppo di capri espiatori i quali, anche se non sono sempre innocenti, non
possono comunque essere ritenuti responsabili di tutta la miseria del
mondo.. Ma si vede anche il significato politico di tali operazioni.
Combattendo energicamente la delinquenza in nome della “ tolleranza zero
” si ostenta che lo Stato svolge il suo dovere di garante dell’ordine
pubblico. Ma nello stesso tempo, nell’ordine sociale si difende un’ideologia
liberale che indebolisce lo Stato sociale ed alimenta un’insicurezza sociale
che a sua volta alimenta l’insicurezza civile. Si tratta dello stesso spirito
che animava l’antica lotta al vagabondaggio. I poteri politici dell’epoca si
sono energicamente mobilitati, con dei successi d’altronde assai limitati,
per sradicare il pericolo rappresentato dai vagabondi. Ma queste misure non
toccavano l’ordine sociale, in particolare l’organizzazione corporativista
del mercato del lavoro, che alimentava il vagabondaggio.
I giovani delle periferie urbane non sono certamente dei vagabondi, né
sono paragonabili in tutto ai proletari del diciannovesimo secolo, ma mi
pare vi sia nella posizione di questi gruppi e nel tipo di trattamento che è
riservato loro una sorta di omologia strutturale che ci chiarisce i rapporti
che una società intrattiene con i suoi margini e che mi pare più ricca di una
qualifica in termini di “ esclusione ”. In ogni caso, questa è l’ipotesi che
volevo sottomettere alla discussione e spero potremo farlo fra poco. Ipotesi
40
che, naturalmente, non ha la pretesa di rendere conto dell’insieme delle
questioni che costituiscono oggi la problematica dell’insicurezza. Ecco
perchè vorrei, prima di concludere, sottolineare un’altra dimensione che mi
sembra importante per rendere conto del paradosso dal quale siamo partiti:
che nelle società come le nostre, le quali possono apparire come le società
più sicure che mai siano esistite, il senso di insicurezza è onnipresente.
Questo paradosso si chiarisce, almeno in parte, se si tiene conto
dell’apparizione di un nuovo tipo di rischi che si aggiungono a quelli civili
e sociali, i “ nuovi rischi ” .
Senza dubbio, non esiste una relazione diretta fra le due serie di
fenomeni, ma, a partire dagli anni 1980, si sviluppano delle preoccupazioni
nuove, accanto a quelle suscitate dai rischi civili e sociali: quelle suscitate
dai rischi industriali, tecnologici, ecologici, naturali. E come un effetto
boomerang dei processi di controllo della natura che si sono sviluppati con
la modernità – “ rendere l’uomo padrone e possessore della natura ”, diceva
Descartes. Ma tale lavoro sulla natura può avere delle contropartite
negative sull’uomo e sul suo ambiente. Ulrich Beck parla di “ società del
rischio ”, per qualificare la società contemporanea. Egli iscrive il rischio
nel cuore dell’esperienza sociale contemporanea: “ La terra è divenuta un
luogo spregevole ”, ha scritto, come se la catastrofe fosse il nostro solo
orizzonte temporale. Ma credo si debba conservare una distanza critica in
rapporto all’inflazione contemporanea del riferimento al rischio.
Innanzitutto perchè essa rappresenta un’estensione in rapporto a ciò che si
intendeva classicamente per rischio. Nel senso proprio del termine, un
rischio è un evento prevedibile, del quale si possono valutare la probabilità
di manifestazione e i danni che esso può comportare. I nuovi rischi, invece,
non sembrano poter essere controllati né previsti. Pensiamo a Tchernobil,
alla mucca pazza, all’effetto serra. Fino a che punto si possono chiamare
rischi?
Non credo si possa chiamare rischio ogni avvenimento nefasto, ogni
minaccia, ogni pericolo. La vita individuale e sociale è fitta di pericoli, non
fosse che per la dose di imprevedibilità che inevitabilmente essa comporta.
La morte è un rischio? Mi sembra che nessuna società possa prefissarsi
come obiettivo ultimo quello di securizzarsi completamente. Ci si può
chiedere se parlare con Ulrich Beck di
“ società del rischio ” o con
Giddens, di “ cultura del rischio ” non comporti, se posso dire, il rischio, di
fabbricare pericoli e paure. Vuol dire in ogni caso porre la minaccia al
cuore dell’avvenire, ma senza possedere i mezzi per controllarla,
contrariamente alla riflessione su alcuni rischi sociali che sono
naturalizzabili o ad alcuni rischi sanitari che sono controllabili attraverso
delle tecnologie preventive appropriate.
41
Un pensiero consapevole del rischio è, mi pare, un pensiero che fa del
rischio un riduttore di incertezza . Si è visto con le politiche sociali e lo si
potrebbe verificare attraverso l’esame delle politiche sanitarie. Ma ci si può
chiedere se la generalizzazione della nozione di rischio non faccia del
rischio un moltiplicatore di insicurezza , più che un riduttore. Al limite, si
potrebbe rinunciare a combattere i rischi, perchè non vi sono tecnologie
possibili di riduzione dei rischi. Ritroviamo qui una riflessione che
avevamo tentato ieri sulle ambiguità di una preoccupazione generalizzata di
prevenzione, che pone l’aspirazione alla sicurezza così in alto che si
condanna in partenza ad essere disattesa – si può parlare di frustrazione
securitaria .
Si può anche capire che la sensibilità verso i nuovi rischi alimenti
l’insicurezza. Essa si aggiunge alle inquietudini che riguardano i rischi
civili e sociali, senza che vi siano relazioni causali fra queste serie. Si tratta
piuttosto di una correlazione storica, ma che va in direzione
dell’aggravamento del sentimento di insicurezza. Non bisogna confondere
il sentimento di insicurezza con l’assenza di protezioni. Tutto avviene come
se un rafforzamento della sicurezza potesse anche avere l’effetto di
soddisfare una richiesta di sicurezza che si fa sempre più insaziabile
proprio perchè in parte è soddisfatta. Degli antenati non molto lontani si
sarebbero forse sentiti al sicuro se fossero stati protetti da rischi quali le
carestie, le razzie di guerra, le incursioni dei briganti... Con ciò non voglio
dire che le moderne forme del sentimento di insicurezza siano da
considerare come il capriccio di una popolazione garantita, ma bisogna
comprendere la specificità attuale del rapporto dell’uomo con la sicurezza,
che rischia di ritorcerglisi contro ponendo al cuore della vita sociale un
sentimento di insoddisfazione.
Per concludere, suggerirei una distinzione. Bisognerebbe diffidare del
confusionismo che alimenta all’infinito il riferimento al rischio e, nello
stesso tempo, prendere sul serio la ricerca della sicurezza. Il che sfocia in
due proposte: da un lato guardarsi dall’attuale inflazione della nozione di
rischio, che lo confonde con pericoli e minacce. La caccia ai rischi può
condurre a delle trappole. A cosa serve gridare al rischio senza avere i
mezzi per controllarlo? Non dico che non si debbano cercare tali mezzi, ma
che al riferimento ai rischi si debba associare una riflessione sui mezzi per
prevenirli e combatterli.
La realizzazione della sicurezza ci pone dinanzi a delle sfide difficili da
affrontare. Stiamo uscendo dal capitalismo industriale, caratterizzato da
un’organizzazione collettiva della produzione che aveva permesso
l’edificazione di protezioni sociali contro i rischi del lavoro. Il nuovo
capitalismo è caratterizzato dall’ipermobilità e dalla crescente
individualizzazione che si è presa in esame. Per cui non è possibile
conservare tutti i dispositivi di protezione validi per la società salariale: la
42
vera sfida sarebbe affiancare alla mobilità delle protezioni. Mi viene in
mente quello che Alain Supiot chiama uno statuto del lavoratore mobile:
affiancare dei diritti e delle protezioni che garantiscono la sicurezza sociale
non solo allo statuto dell’impiego, giacchè quest’ultimo ha perso molta
consistenza, ma alla persona stessa del lavoratore. Diritti che il lavoratore
poteva così esercitare in dei periodi di non impiego, o di impiego saltuario,
nei momenti di riconversione che saranno sempre più necessari per
affrontare positivamente i cambiamenti, etc...
Ciò che propongo è più facile a dirsi che a farsi, ma esistono già delle
proposte interessanti, ad esempio nell’opera di Supiot Al di là dell’impiego,
che è d’altronde un lavoro collettivo effettuato per conto della
Commissione europea di Bruxelles. Le proposte propongono numerosi
problemi di definizione, attuazione e finanziamento. Si tratta piuttosto di un
cantiere in piena attività, che indica la direzione nella quale muoversi per
securizzare le traiettorie del lavoro- è questo un punto strategico della lotta
all’insicurezza sociale, ma vi sono anche altri cantieri da esplorare, per
innestare nuove protezioni sociali nella nuova congiuntura che ha iniziato a
delinearsi dalla metà degli anni settanta.
Traduzione di Clelia Castellano
43