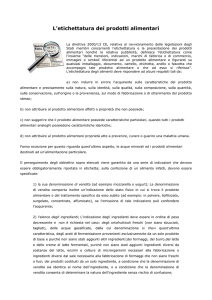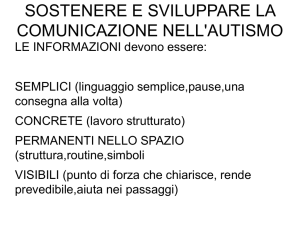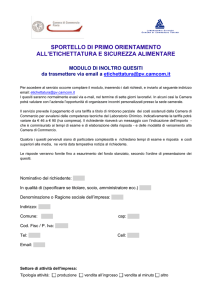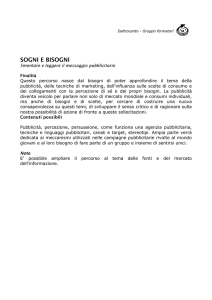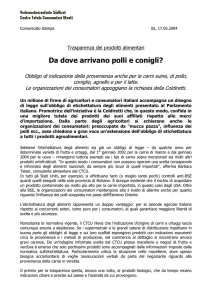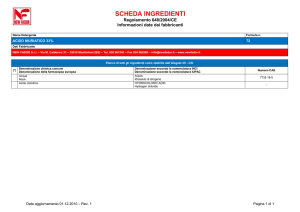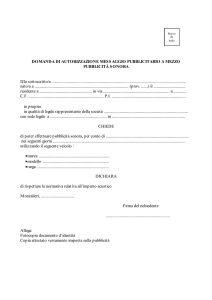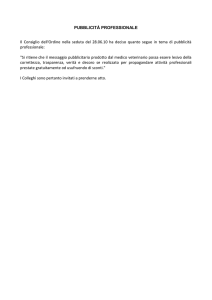Etichettatura, presentazione, pubblicità dei prodotti alimentari
nel decreto leg.vo 109/92
Il trinomio deve essere applicato in funzione univoca
Antonio Neri
1.- Introduzione
La materia oggi sbrigativamente compresa nel termine “etichettatura” assume in realtà
connotati più variegati se considerata, come deve essere, nel complesso terminologico di
cui all’enunciato del D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 109 e cioè corredata dei termini
“presentazione” e “pubblicità”. Trinomio che le Direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1989 hanno preconizzato inscindibile. Ciò in ossequio ai principi
ispiratori delle direttive stesse tendenti a rendere non equivocabili le dichiarazioni sulla
natura, identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine, provenienza,
modo di fabbricazione, modo di ottenimento del prodotto. Il tutto a privilegiare il
consumatore al quale massima é dovuta la completezza dell’informazione. Sebbene le
numerose modifiche e integrazioni, subite e apportate nel corso degli anni, non abbiano
inciso sull’efficacia giuridica dei principi, tuttavia è necessario registrare che questi sono
oggi interpretati da parte dei produttori in modo decisamente surrettizio. Da qui lo scopo
del presente lavoro il cui titolo è ispirato al filo logico-tecnico-giuridico che lega le norme
del D.L.vo 109/92, riconducendole ad un unicum coordinato, e quindi funzionale,
all’enunciato. Da qui il significato di “funzione univoca” che, in modo semantico,
attribuisco a tutto ciò che costituisce attuazione di studiato meccanismo psicologico atto
alla migliore “presentazione” del prodotto attraverso la confezione (dimensione, forma,
colore, grandezza dei caratteri, colori e posizione delle scritte) e di quanto, per il tramite
di scritte e indicazioni, si vuol comunicare sulle caratteristiche dello stesso. Insomma
affinché il tutto (etichettatura, presentazione e pubblicità), conduca a un senso solo e
definito, senza possibilità di equivoci.
Per “scritte” e “indicazioni” non intendo i claims (dei quali dirò in prosieguo riferendomi a
quelli salutistici e nutrizionali di cui al Reg. 1924/2006) ma tutte quelle espressioni
intonate più alla suggestione che all’informazione, quelle che la psicolinguistica indica
influenti sui processi comportamentali dell’uomo. Il che induce alla conclusione che non
tanto ha valore il significato delle parole quanto piuttosto il contesto in cui sono riportate.
Corollario di quel che ha lasciato scritto Marshall McLuhan (il maggior studioso delle
comunicazioni di massa) secondo il quale il modo con il quale le persone comunicano è
più importante di quel che esse vogliono comunicare. Dal che deriva il suo slogan il
“medium è messaggio”, che può sembrare superficiale e cinico, ma che contiene una
verità assai importante. Infatti, nel contesto che ci interessa, l’etichettatura è un “mezzo”.
1
A chiusura di questa introduzione dirò che nella stesura di queste note mi sono regolato
avendo a riguardo la professionalità dei lettori e perciò riducendo al minimo le citazioni
normative. Per cui la mancata citazione di quelle altre che un occhiuto censore dovesse
considerare una lacuna, si sappia che è voluta. Infatti ho ritenuto più utile e producente
dare spazio alle mie considerazioni sulla materia che titola l’articolo, nell’auspicio che
esse, passate attraverso il filtro di un esame critico, possano rappresentare occasione di
dibattito oggi più che mai necessario in un contesto ancora ben lontano da accettabili
soluzioni.
2.- L’etichettatura formale
Definirò così quella concentrata nelle norme di cui all’art. 3 del D.L.vo 109/92 (“Elenco
delle indicazioni dei prodotti preconfezionati”), nell’art. 4 (“Denominazione di vendita”) e
nell’art. 5 (“Ingredienti”).
Complessivamente considerate, le disposizioni appaiono chiare e facilmente applicabili.
Al punto che ad esse debbono la loro fama consulenti delle più diverse estrazioni
professionali, autoreferenziatisi in questa nuova branca del sapere, giocosamente
definita “etichettologia”. Tanto più facilitati quando si tratti di alimenti e bevande dotati di
autonoma disciplina sulla “denominazione di vendita”, distinta, ove ricorre il caso, per
tipologie. Ma in tanto maggior difficoltà, proprio a causa della “denominazione di vendita”,
quando pretendono di sostituirla con marchi di fabbrica o di commercio o con
denominazioni di fantasia oppure ricorrendo a perifrasi descrittive (si fa per dire) pur in
vigenza di disposizioni specifiche già previste in sede comunitaria o dall’ordinamento
italiano (anche con disposizioni amministrative).
Le difficoltà aumentano quando si tratti di coordinare la “denominazione di vendita” con
l’ingredientistica (additivi compresi ope legis) cui consegue un’ interessata renitenza alla
collocazione di certi ingredienti (in specie l’acqua, la “grande vitamina” dell’industria) al
giusto posto nell’ordine di quantità decrescente. Il che è causa di traumatizzanti brain
storming per la ricerca di lambiccate soluzioni quali, esemplificando, quelle per
l’individuazione dell’ingrediente caratterizzante o per l’ingrediente ancora presente in
forma modificata e ancora, quando ricorra il caso, della corretta indicazione del QUID. La
“designazione degli aromi” (art. 6 del D.L.vo 109/92) è tranquillamente osservata con la
generica dicitura “aromi” preferendo sottrarsi all’impegno di un’indicazione più specifica
sulla natura degli stessi secondo le previsioni del D.L.vo 25 febbraio 1992 n. 102. Lo
stesso dicasi per gli amidi modificati che passano tutti sotto la voce “amido” nella
sicurezza che nessuno andrà mai ad indagare se la modifica è realizzata per via chimica.
Sono queste, citazioni di casi scelti in modo sporadico ma rappresentativi di una più
vasta realtà quale ci è fornita dal tortuoso percorso fra gli affollati scaffali di un
supermercato. Rappresentativi altresì di una navigazione senza la bussola di un tecnico
che disponga almeno delle basi della scienza chimica. In difetto delle quali, ancora
esemplificando, l’addetto ai lavori, non conoscendo il meccanismo d’azione di un certo
2
additivo non sarà in grado di classificarlo in relazione al campo d’impiego e neppure
decidere se più utilmente considerarlo coadiuvante tecnologico (che lo esenterebbe dall’
indicazione). Oppure farà spicciativo ricorso all’allegato IX al D.M. 27 febbraio 1996 n.
209, (conosciuto come quello degli additivi “generalmente ammessi” per di più con il
criterio di utilizzo del “quanto basta”), senza porsi il problema delle eccezioni previste
dall’art. 15 comma 3 dello stesso D.M. 209/96.
Infine, ma non per ultima, la dimensione dei caratteri di stampa. Che non esaurisce certo
questo capitolo ma che è questione nient’affatto banale, dato che la Commissione Ce se
ne è fatta carico nella sua proposta di regolamento del 30 gennaio 2008 al Parlamento
europeo, avente ad oggetto proprio i provvedimenti sull’informazione dei consumatori. In
questa proposta si rileva che i consumatori chiedono ancora maggiori ragguagli
sull’etichetta il che può realizzarsi attraverso una chiara, semplice, comprensiva
informazione uniformata d’imperio. E qui cade acconcia la presa d’atto della
Commissione della quantità dei testi normativi così dispersi da incidere sulla chiarezza e
sulla coerenza delle leggi. Per cui, riportando nella lingua di prima stesura:
“The main changes with respect to general labelling issues are:
a) - To improve the legibility of the information provided on the labelling a minimum print
size for the mandatory information is introduced;
b)- The clarification of the responsibilities regarding food labelling for the different food
business operators along the supply chain;”.
Sul punto di cui alla lettera b) torneremo nel capitolo dedicato appunto alle
responsabilità.
3.- L’etichettatura nutrizionale
L’”etichettatura nutrizionale” (D.L.vo 16 febbraio 1993 n. 77, attuazione della direttiva
90/496/CEE) segue di un anno circa l’entrata in vigore del D. L.vo 27 gennaio 1992 n.
111 (attuazione della Direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad
una alimentazione particolare). In termini di tempi di formazione legislativa si può parlare
di contemporaneità, una circostanza epocale che segnò l’inizio dell’età dell’oro per
l’industria alimentare. Che colse l’occasione per ipervalutare i suoi prodotti ricorrendo alla
“informazione nutrizionale” e di conseguenza alla “tabella nutrizionale” tanto ricca di
simboli e numeri quanto povera di significato per il consumatore. Sicché oggi vediamo la
tabella nutrizionale persino sui funghi secchi, alimento di inesistente valore nutritivo. Si
diede così inizio ad una strana catena logico-sistematica, tuttora operante che, partendo
dal vanto di particolari caratteristiche (in piena contraddizione ai divieti contenuti nell’art.
2 comma 1. lettere a), b), c) e comma 2. del D.L.vo 109/92) conduce surrettiziamente
all’attribuzione di un valore aggiunto che non esiste perché si vantano caratteristiche che
sono in re ipsa e del tutto identiche ai prodotti analoghi.
Si interpretano le norme (o meglio l’intreccio di norme) contenute nei due decreti
ricorrendo ad una diabolica commistione concettuale. Partendo dal presupposto che l’art.
3
1 del D.L.vo 77/93 disciplina l’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari “comuni” e
quella dei prodotti “destinati ad una alimentazione particolare”, si forza la derivata che
qualunque enfatizzazione del prodotto in toto o di uno dei suoi ingredienti (sia o no
caratterizzante) sia ammessa avendo solo cura di gabellarla come informazione
nutrizionale. Si dimentica che le disposizioni sono comuni alle sole formalità
dell’etichettatura nutrizionale che l’art. 4 comma 1 dello stesso D.L.vo 77/93 limita
strettamente al valore energetico e ai nutrienti elencati nell’art. 3.
Cosicché avviene che i prodotti sono volta a volta fonte di proteine, ricchi di fibre vegetali,
di alta qualità, senza colesterolo, senza zuccheri, leggeri, con grassi omega 3, ricchi di
calcio, di vitamine, e via enfatizzando quanto più l’”arricchimento” è praticato con poca
spesa grazie alla “quantità significativa”, flebilmente identificata, ope legis, in quel 15%
delle R.D.A. (razioni giornaliere raccomandate) di cui all’allegato al D.L.vo 77/93.
Cosicché nei casi di contestazione di una o più delle infrazioni alle previsioni di cui all’art.
2 D.L.vo 109/92, si argomenta (negli scritti difensivi previsti dall’art. 18, Legge 24
novembre 1981 n. 689 – depenalizzazione – per i quali non è ancora certa né l’autorità
competente a riceverli né il destino anche dopo lustri di attesa) qualificando il prodotto
come destinato ad una alimentazione particolare. Lasciando tutti indifferenti di fronte alla
circostanza che l’art. 7 del D.L.vo 111/92 (commercializzazione dei prodotti) prevede
l’informazione al Ministero della salute mediante trasmissione di modello di etichetta.
L’approvazione esplicita della quale non costituisce conditio sine qua non in virtù della
formula del silenzio assenso (Decr. Minisalute 7 maggio 2004). L’approvazione è
pacifica per i prodotti provenienti da altro Stato membro (o da uno Stato terzo) dove
siano già posti in commercio. Unica condizione, la comunicazione al Ministero
dell’”autorità destinataria della prima comunicazione” che resta sempre sconosciuta
perché il produttore comunitario (tanto meno quello del Paese terzo) non ha a chi
rivolgersi per il semplice motivo che non esiste l’autorità preposta, malgrado la Direttiva
89/398/CEE espressamente la preveda in tutte le lingue della Comunità. Tutto ciò a
comprova che, in generalità, non è solo al nostro Paese che bisogna imputare la
mancanza di zelo nei recepimenti e/o l’inosservanza delle disposizioni comunitarie. Ben
altro è il campo di applicazione del D.L.vo 111/92 vista la materia complessivamente
disciplinata dall’art. 1 e differenziata nei tre commi che lo compongono.
In questo capitolo non può mancare un cenno a quella che si delinea come un nuovo
genere di etichettatura, questa su base volontaria. Mi riferisco all’etichettatura
nutrizionale che va sotto l’acronimo GDA (“Guideline Daily Amount”) che nella nostra
lingua suona “Quantità Giornaliere Indicative”. Per definizione le GDA rappresentano la
quantità approssimata di calorie e nutrienti per una persona adulta media, calcolate sulla
base di una dieta giornaliera di 2000 kcal. I fabbisogni individuali ovviamente variano in
funzione del sesso, dell’età, dell’attività fisica e di altri fattori, fra i quali bisogna
annoverare quelli genetici. Secondo le intenzioni, il consumatore potrà scegliere con
maggiore consapevolezza senza sacrificare le sue preferenze valutando i “rischi” per il
suo benessere sulla base delle quantità dell’alimento che intende introdurre nella sua
dieta. Aspettiamo con ansia.
4
4.- Il Reg. n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute
Come l’etichettatura nutrizionale segnò l’età dell’oro per gli alimenti dalle qualità più
vantate che dimostrate, cosi il Regolamento 1924/06 (“Indicazioni nutrizionali e sulla
salute fornite sui prodotti alimentari”) provocò l’assalto alla diligenza. Si trattava di
legittimare claims nutrizionali “non conformi” all’allegato al regolamento stesso (in pratica
al di fuori di qualsiasi contesto normativo in materia di etichettatura) approfittando della
possibilità offerta dall’art. 28 (recante le misure transitorie) di commercializzare i prodotti
così etichettati anteriormente al 1 luglio 2007 (data di applicazione del regolamento) fino
alla data di scadenza ma non oltre il 31 luglio 2009. Non solo ma vi fu anche chi pensò di
bruciare i tempi uscendo sul mercato, con grande battage pubblicitario, con una serie di
prodotti di comune consumo (pani, biscotti, snack, fiocchi e barrette di cereali, bevande a
base di frutta e vegetali) ma integrati di ingredienti avveniristici e caratterizzati da claims
salutistici e nutrizionali sebbene privi di specifica valutazione da parte dell’EFSA
(European Food Safety Autorithy). Il produttore evidentemente reputò sufficiente il ricorso
alla collaudata procedura di notifica di cui all’art .7 del D.L.vo 111/92 tenendo in non cale
gli avvertimenti del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sicurezza degli
Alimenti e della Nutrizione, versati nella sua circolare del 15 marzo 2008 per porre un
argine al dilagare di “abusi in termini di etichettatura e pubblicità” in assenza di
validazione dei claims. Concludeva la circolare che in caso di inottemperanza si sarebbe
proceduto alla segnalazione all’Autorità garante per la Concorrenza e del Mercato. Il che
puntualmente si materializzò in un provvedimento della stessa Autorità che giudicava
scorretta detta “pratica commerciale” ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice del
Consumo e ne vietava l’ulteriore diffusione.
Dunque, concludendo sul punto, l’EFSA, cui è demandato il compito di verificare se
l’indicazione sulla salute sia confortata da prove scientifiche, ha bocciate ad oggi il 90%
di quelle ricevute per essere validate. Vedremo quante ne resteranno al termine della
falcidia.
Ma assieme ai claims salutistici e nutrizionali non validati, occorre citare un caso che
rientra nel contesto delle sole indicazioni nutrizionali quali sono quelle normate
nell’allegato al regolamento 1924/2006 in esame. Riguarda un recente provvedimento
dell’Autorità Garante che giudica fattispecie di pubblicità ingannevole il claim “senza
zuccheri aggiunti” riferito ad omogeneizzati di diversi tipi di frutta contenenti una certa
quantità di mela, pur dichiarata fra gli ingredienti. Il focus dell’inganno, individuato
nell’ingrediente-mela (naturalmente caratterizzato da considerevole contenuto
zuccherino), non è stato condiviso dal TAR del Lazio che, accogliendo il ricorso del
produttore, ha annullato il Provvedimento dell’Autorità. A mio giudizio, da entrambi gli
elaborati, pur fondati su dotti anche se opposti pareri tecnici, non emerge una semplice
circostanza che, di per sé rende inoppugnabile la responsabilità del produttore. E cioè
che l’allegato al Regolamento 1924/2006 prevede il caso in questione. Infatti se
l’alimento contiene naturalmente zuccheri allora si rende obbligatoria l’indicazione
“contiene naturalmente zuccheri”. Ma questa, evidentemente non garbava al
5
responsabile del marketing. La discussione del caso potrebbe non esaurirsi qui a
seconda che si consideri la seconda indicazione (“contiene naturalmente zuccheri”)
aggiuntiva o non piuttosto sostitutiva della prima (“non contiene zuccheri aggiunti”). La
mia opinione è che debba considerarsi “aggiuntiva”, opinione dettata da ragioni d’ordine
logico-sistematico. Basti pensare che nell’allegato, costituito da un elenco di ben 24
indicazioni nutrizionali provviste ognuna di titolo specifico ad un testo che reca una
disposizione autonoma, solo quella di cui al titolo “non contiene zuccheri aggiunti” non è
autonoma in quanto condizionata dall’obbligo dell’indicazione della seconda, nel caso in
cui, l’alimento contenga appunto naturalmente zuccheri.
E’ un esempio di come il tema “etichettatura”, inscindibile dal tema la “pubblicità”, come
detto nell’introduzione di questo articolo, costituisca materia assai impegnativa sotto il
duplice profilo tecnico e culturale.
5.- Presentazione e pubblicità
Dire che la presentazione di un prodotto, a qualunque genere appartenga, gioca un ruolo
fondamentale nell’influenzare la scelta dell’acquirente, è dire cosa ovvia. Nel caso dei
prodotti alimentari il contributo di grafici e designer (i creativi in senso lato) a realizzare
forme e dimensioni della confezione, scegliere colori, studiare immagini, utilizzare
materiali (tutto quel che con brutto neologismo si definisce “abbigliaggio”), nonché a
“posizionare” indicazioni (denominazione di vendita, modalità d’uso, di conservazione, di
shelf life, di ingredienti) e inventare claims suggestivi, tutto questo concorre in modo
speciale per un prodotto alimentare a creare il bisogno (o il desiderio come si vuole) e
quindi decidere all’acquisto. Solo uno specialista conosce l’importanza di concentrare
sulla faccia principale della confezione, in fantasmagorica evidenza, tutti gli artifici grafici
e lessicali possibili ad illustrazione di qualità e caratteristiche che solo un attento e
smagato censore è in grado di dimostrare in netta contraddizione con quanto riportato in
ridottissima evidenza sul retro e/o sulle fasce laterali.
L’inganno così costruito è ancor più patito nel caso di prodotti composti, elaborati o
trasformati in cui la caratteristica vantata si basa sulla presenza fra gli ingredienti di un
prodotto DOP. Tali prodotti composti sono legittimati dal D. L.vo 19 novembre 2004 n.
297 purché in ottemperanza alla semplice disposizione che gli stessi risultino inseriti in
apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio che ha concesso l’utilizzo
della DOP. In assenza di apposita disposizione disciplinatrice della etichettatura di
prodotti siffatti, sembra chiaro che debbano essere osservate le norme di cui al D.Lvo
109/92. Ma così non é.
Vale il presente caso per annotare la straordinarietà rappresentata dai Consorzi di Tutela
di DOP e IGP che si considerano legibus soluti dalle disposizioni generali per il fatto di
ritenersi obbligati, in via esclusiva, al rispetto del disciplinare di cui si sono
autonomamente dotati. Rispetto tanto più agevole quanto più gli stessi disciplinari sono
soggetti a modifiche su richiesta degli stessi Consorzi, richieste puntualmente accolte e
6
modifiche acriticamente poste subito sotto protezione transitoria dal dicastero
competente (Mipaaf). Una sorta di limbo sul quale i Consorzi fanno conto perché agevola
modifiche a catena in coincidenza con le contingenti necessità di bottega. Niente di più
definitivo del transitorio dunque, grazie al patto non scritto fra produttori e
amministrazioni (comunitarie comprese). Ho aperto questo inciso perché illumina la
scena sulla quale sono esibiti taluni prodotti contenenti DOP anch’essi dimostrativi della
disinvoltura che regola il modo di condursi dei Consorzi anche in tema di etichettatura,
presentazione e pubblicità.
Due casi al proposito mi sembrano emblematici.
Il primo riguarda un formaggio fuso confezionato in vaschetta del quale viene taciuta la
qualità di “fuso”. L’appetibile consistenza cremosa non è ottenuta con una particolare
tecnologia (esempio omogeneizzazione) ma semplicemente con un sale di fusione
(ammesso fra gli additivi e del resto dichiarato fra gli ingredienti). Non solo. Ma con
vistosa grafica e colorita immagine riportate (secondo la collaudata prassi) sulla faccia
principale della vaschetta, gli si attribuisce la denominazione “crema di….” rafforzandone
la qualifica e identificandone la natura come originata da quella pregiatissima DOP. Ma
non in toto, come lasciano intendere denominazione e figura, bensì nella contenuta
proporzione (dichiarata fra gli ingredienti) del 50%, con ciò a un tempo consumando
l’inganno e contravvenendo alla disposizione dell’art. 7 della Convenzione di Stresa
(recepita con D.P.R. 18 novembre 1953, n.1099), che pretende l’impiego in fusione al
minimo del 75% del formaggio protetto da denominazione d’origine.
Il secondo caso riguarda marche diverse di formaggio fuso a spicchi, dove il formaggio
pregiato della DOP é contenuto in ragione del 25%. La circostanza è anch’essa
enfatizzata sulla faccia principale della scatola, con denominazione e raffigurazione
studiate, con la differenza che alcune marche collocano tale ingrediente (caratterizzante
quant’altri mai) al primo posto in ordine di quantità decrescente mentre altre lo collocano
al secondo. Sotto il profilo pubblicitario l’inganno è evidente, come è evidente il vantaggio
sul profitto che ne trae il produttore che mette al primo posto un altro ingrediente di minor
pregio e costo.
Stanti così le cose e dato che interviene apposita convenzione tra il produttore che
utilizza la DOP ed il Consorzio che la concede, tanto più che più i prodotti derivati devono
essere, come già richiamato, iscritti in apposito registro tenuto dal Consorzio, ne
consegue che questi avalla la relativa “etichettatura” con tutto quel si comprende in
questo termine. La domanda allora è: può il Consorzio ritenersi esente da responsabilità
per quanto attinente l’etichettatura? Domanda retorica cui consegue risposta retorica se
affermo che si, il Consorzio è responsabilmente coinvolto con il produttore utilizzatore.
6.- Responsabilità del produttore e del distributore. Artt. 13, 12 e 19 Legge 283/62. Art.
515 c.p.
Riprendiamo le mosse dal secondo obiettivo di cui alla proposta di regolamento della
7
Commissione Ce citato e cioè:
“b) the clarification of the responsabilities regarding food labelling for different food
business operators along the suppling chain”.
Pacifica la responsabilità in capo al produttore (o dei titolari del brand name o private
label che sia) non fu altrettanto pacifica l’individuazione delle norme punitive. Il focus del
dibattito consisteva nell’applicazione dell’art. 2 del D.L.vo 109/92 in luogo dell’art. 13
della Legge 30 aprile 1962 n. 283 (escluso dalla depenalizzazione, Legge 24 novembre
1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”) a ragione del fatto che entrambi riguardano
fattispecie sostanzialmente identiche. Il contrasto interpretativo trovò soluzione nel
criterio di cui all’art. 9 (“Principio di specialità”) della stessa Legge 689/81 che fece
prevalere la sanzione amministrativa a norma dell’art. 18 dello stesso D.L.vo 109/92. Da
qui l’ “ordinanza ingiunzione” di cui all’art. 18 della Legge 689/81 e la conseguente
facoltà per l’interessato di presentare i già criticati “scritti difensivi”.
Permane irrisolta - da qui ritengo la proposta della Commissione - l’individuazione delle
responsabilità dei soggetti operanti lungo la catena distributiva. Per questo, non a caso,
ho collocato vicini nel titolo di questo capitolo gli artt. 12 e 19 della Legge 283/62. Il primo
riguarda il divieto di introdurre nel territorio della Repubblica sostanze destinate
all’alimentazione non rispondenti ai requisiti della Legge (sanzione amministrativa
pecuniaria) e sanzione penale (art. 6 stessa legge) nel caso di sostanze destinate al
commercio. La seconda fattispecie è quella che interessa nel contesto “etichettatura” che
necessita di essere considerata coordinatamente all’art. 19, che vale il caso di riportare
testualmente: “Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al
commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo
prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge
stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne di
recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la
confezione originale non presenti segni di alterazione”.
Di questo dettato ci interessano la nozione di “commerciante” e la nozione di “requisiti
intrinseci” in contrapposto a quella di “requisiti estrinseci”.
Sulla nozione di “commerciante”. E’ da ritenere che il legislatore dell’ormai lontano 1962
si riferisse al commerciante al dettaglio, attribuendogli la sola responsabilità dell’offerta in
vendita di prodotti in confezioni originali che presentassero segni di alterazione (requisiti
estrinseci). Non si poteva infatti presumerlo dotato di una professionalità che lo mettesse
in condizione di valutare la corrispondenza degli stessi alle complesse norme regolatrici
l’etichettatura. Anche se l’etichettatura, di per se stessa, è da considerarsi fra i requisiti
estrinseci (anche qui nel senso di ciò che è “esterno”).
Ma da allora, sia pure con lenta progressione, si è consolidata una giurisprudenza che
configura la responsabilità anche in capo al distributore. Sia esso importatoredistributore, così definito per comodità lessicale il soggetto operante in ambito
comunitario sia il grossista-distributore che opera in ambito nazionale come la GDO
(Grande Distribuzione Organizzata). Ed ecco che quel che fino ad oggi ha riguardato, in
modo pressoché esclusivo, la responsabilità sulla rispondenza alle condizioni igienico-
8
sanitarie oltre che all’idoneità merceologica (sia delle derrate, sia dei prodotti finiti
confezionati) si deve estendere al complesso normativo compreso nel trinomio
etichettatura-presentazione-pubblicità. Per ora è solo un auspicio perché sussistono
dubbi interpretativi che generano resistenze applicative da parte degli organi
istituzionalmente incaricati della vigilanza. Sebbene appaia di tutta evidenza che la
nozione di “operatore del settore alimentare” compresa nell’art. 3 comma 1 del Reg. CE
178/2002 (“la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle
disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare sotto il suo controllo”)
coordinata con la nozione di “impresa alimentare” compresa nel comma 2 dello stesso
art. 3 (“ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una
qualsiasi attività connessa ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione
di alimenti”) conduca a concludere sul coinvolgimento del distributore-rivenditore specie
quando trovasi al livello imprenditoriale della Grande Distribuzione. La quale, proprio per
dimensione e complessità di attività deve ritenersi dotata di quella professionalità capace
di valutare anche l’idoneità legale del contesto normativo oggetto della presente
disanima.
Ma in questo contesto bisogna registrare con favore - almeno questa è la mia
convinzione - il ritorno dell’art. 515 c. p. (“Frode nell’esercizio del commercio”), che vedrei
corroborato dall’art. 517 c.p. (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”). E’ il
caso dei prodotti composti contenenti una DOP e coinvolgimento dei Consorzi di tutela.
Due recenti sentenze di Cassazione aprono il nuovo scenario che, a ben vedere, è un
ritorno al passato.
La prima riguarda il caso del sequestro di una partita di confezioni di prodotto
denominato “Cocktail reale” costituito da una miscela di miele, pappa reale, propoli, che
sulla confezione recava la dicitura “miscela di preziosi doni dell’alveare”, sequestro
confermato dal primo giudice. Il ricorso per Cassazione, tendente all’annullamento del
provvedimento di sequestro, è stato respinto disattendendo l’assunto difensivo secondo il
quale alla fattispecie andava applicata la disciplina di cui all’art. 2, comma 1 del D.L.vo
109/92 con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa ex art. 18 dello
stesso decreto legge. Al riguardo, si legge in sentenza, va ribadito che tra la previsione di
cui all’art. 2 D.L:vo 109/92 e l’art. 515 c.p., che tutela il corretto svolgimento dell’attività
commerciale, non sussiste alcun rapporto di specialità ex art. 9 Legge 689/81 stante il
diverso ambito di operatività delle due disposizioni.
La seconda sentenza riguarda il caso di carni inscatolate pubblicizzate a mezzo di
inserzioni su quotidiani come ottenute da bovini allevati in Italia e risultate invece carni
provenienti da Paese comunitario. Essa conclude per l’annullamento con rinvio sulla
base del presupposto che nell’art. 515 c.p. il termine “dichiarato” prevale, in tema di
prodotti confezionati la cui vendita al consumatore finale non è caratterizzata da un
momento contrattuale, sul termine “pattuito”. Tale interpretazione della fattispecie
criminosa dell’art. 515 c.p. – conclude la Corte - non appare in contrasto, per il principio
di specialità, con la normativa di pubblicità ingannevole dettata dal D.L.vo 25 gennaio
1992 n.74.
9
7.- Considerazioni finali
Il contenuto del presente lavoro è certamente da considerarsi limitato. Ciò nel senso che
la materia trattata, per quanto oggetto di attento esame critico, meriterebbe ben più
diffuse citazioni di casi che hanno trovato conclusione in una giurisprudenza a volte
condivisa a volte necessitante di ulteriori approfondimenti. A questi casi si aggiungono gli
altri che il mercato ci offre in tumultuosa apparizione a dimostrazione dell’intraprendenza
dell’industria in coincidenza con l’inadeguatezza dei controlli. Parlo di inadeguatezza
culturale di cui si deve fare addebito, è bene precisarlo, ai soli organi periferici ai quali,
tuttavia, non si può chiedere di entrare in competizione dialettica con i mostri sacri delle
agenzie di pubblicità. Il livello culturale del confronto è invece pareggiato nei casi
d’interventi d’autorità sia diretti sia per sollecitazioni della concorrenza. Fra le autorità
istituzionalizzate prevalenti sono i contributi della Direzione Generale della Sicurezza
degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero Salute, la collaborazione della quale è di
sovente richiesta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Quest’ultima
vanta un palmares di provvedimenti di alto valore tecnico e giuridico. In questo favorita
dal diritto, di cui gode per legge, di corrispondere con le pubbliche amministrazioni ed
enti di diritto pubblico per avere notizie, informazioni e assistenza per l’adempimento
delle sue funzioni.
E’ dunque su queste istituzioni che possiamo confidare quando si tratti della tutela di
interessi diffusi come di quelli soggettivi a salvaguardia della leale competizione
commerciale. Perché è in queste sedi che il confronto diventa aureo vedendo coinvolti i
diretti soggetti interessati: operatori economici e operatori pubblicitari.
Infine il “consumatore medio”. Allergizzante espressione che non trova un suo significato
neppure attraverso le contorsioni tautologiche riportate in giurisprudenza e in testi
normativi. Riprenderli tutti comporterebbe una ricognizione troppo minuziosa. Ci basti
sapere che il Codice del Consumo cita più volte questa figura ectoplasmatica senza
tuttavia (giudiziosamente) dettarne la nozione. L’ultima, che è anche la più articolata e
complessa, è contenuta nel 16° considerando del Reg. 1924/2006 che, riferendosi alle
sentenze della Corte di Giustizia Ce in materia di pubblicità ingannevole e comparativa,
avverte che “il presente regolamento prende come parametro il consumatore medio,
normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e tenuti presenti i fattori
sociali, culturali e linguistici” con la cautela che “il criterio del consumatore medio non è
un criterio statistico”. (E meno male!).
Un marketing research saprebbe offrire del consumatore modelli a decine (ma non
necessariamente utili al giurista) perché la scuola dell’economia dei consumi gli ha
insegnato a sezionare l’universo antropologico in fasce di individui distinti per età, sesso,
condizione socioeconomica, gusti, tradizioni. Il che gli consente di modulare “modelli”
applicabili di volta in volta alle collaudate tecniche di offerta del prodotto che gli viene
commissionato di promuovere.
10
La realtà è che si esige dai cittadini (utenti, consumatori) una universalità di conoscenze
che faticano a trovar posto nella nostra anima prima ancora che nella nostra mente. E’
questo il conto che ci presenta la civiltà dei consumi (o società del benessere come ad
alcuni piace chiamarla) che ci garantisce su tutto attraverso la pubblicità salvo poi
gratificarci di ignoranti se ne siamo ingannati.
Per cui è da concordare con la definizione di L. L. Levinson nel suo “The left handed
dictionary”: consumatore, uno che crede nella pubblicità.
Fonte normativa ALIMENTALEX – Raccolta su CD della legislazione alimentare
nazionale e comunitaria, consultabile on line su www.scienzaediritto.com.
ABSTRACT
The labelling of foods packaged for the final consumer is a very important medium for
advertising promotion. Therefore in the complex contest of labelling, the packaging (form,
dimension, colour) and the information written on the front of it (that are often in
contradiction with the information written on back or on lateral sides) are of great
importance. The author cites several cases of deceptive labelling with particular
reference to nutritional labelling and claims ruled by Reg. Ce n. 1924/06 that hasn't
practically found application. Referring to regulation proposal 30 January 2008 of
Commission, the author develops one of the most important aspects of this proposal, that
refers to clarification of the responsibilities regarding food labelling for the different food
business operators along the supply chain.
11