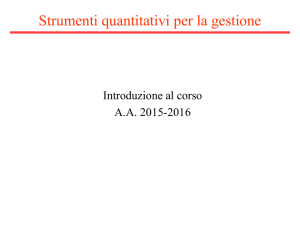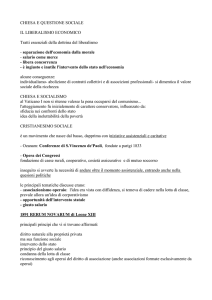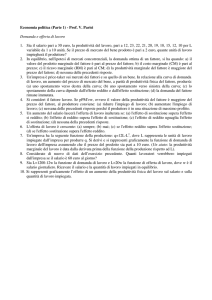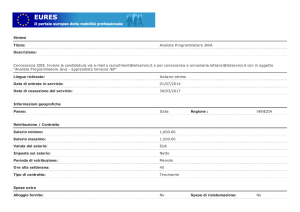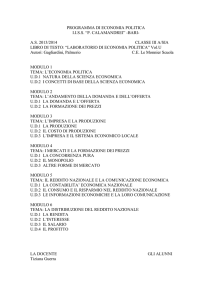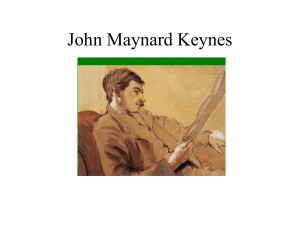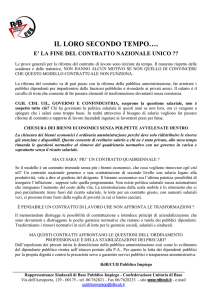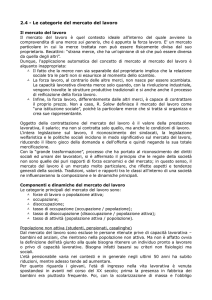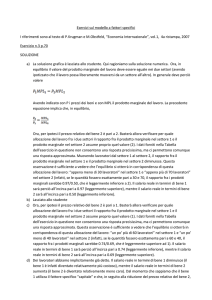ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
A.A. 2015/2016
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Prof. Guglielmo Forges
Davanzati
0
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
L’economia del lavoro ha come proprio campo d’indagine lo studio del funzionamento
del mercato del lavoro, con particolare riferimento all’individuazione delle cause della
disoccupazione e dei meccanismi che sono alla base della determinazione dei salari, sia
sul piano teorico, sia sul piano empirico. A tal fine, e per quanto riguarda la trattazione
che segue, si fa propria un’opzione metodologica che rinvia alla coesistenza di paradigmi
alternativi e competitivi, non riconducibili a un schema teorico unitario e unanimemente
condiviso. Questa opzione si basa sulla convinzione che ogni schema teorico si basa su
assiomi, ovvero su premesse non dimostrate né dimostrabili, che sono radicalmente in
contrapposizione con gli assiomi propri di altri schemi teorici e che, per questa ragione,
non si rende possibile giungere a una sintesi. In quanto segue, verranno descritti i
principali orientamenti teorici presenti nel dibattito contemporaneo: il modello
neoclassico, il modello keynesiano, il modello postkeynesiano nella sua variante della c.d.
teoria monetaria della produzione. Si propongono, a seguire, due appendici: la prima dà
conto del dibattito su diseguaglianze distributive e crescita economica; la seconda riporta
un breve importante saggio di M. Kalecki, rilevante per la comprensione dello studio del
funzionamento del mercato del lavoro in una prospettiva postkeynesiana e marxista. Alla
trattazione di queste teorie vengono qui aggiunte due sezioni dedicate, rispettivamente,
agli effetti delle politiche di deregolamentazione del mercato del lavoro sull’occupazione
e al dibattito sugli effetti dell’accumulazione di capitale umano sulla crescita economica e
dell’occupazione.
Alla stesura di questi appunti hanno contribuito Andrea Pacella (Università di Catania)
che ha scritto parte del cap.1 e Gabriella Paulì (Università del Salento), che ha scritto
parte del cap.4 e del cap. 5.
Lecce, marzo 2016
G.F.D.
1
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
INDICE
1 Principali definizioni e indicatori statistici nel mercato del lavoro
2 La teoria neoclassica del mercato del lavoro
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Il mercato del lavoro: caratteri generali
La domanda di lavoro in concorrenza perfetta
L’offerta di lavoro
L’equilibrio nel mercato del lavoro e processi di aggiustamento: i movimenti lungo le
curve
L’inefficienza dei ‘salari minimi’
L’equilibrio nel mercato del lavoro e processi di aggiustamento: gli spostamenti delle
curve
Sviluppi recenti del modello neoclassico
3 Il mercato del lavoro nella teoria keynesiana
4. La teoria postkeynesiana: caratteri generali
4.1 La teoria monetaria postkeynesiana*
4.2 La teoria postkeynesiana del mercato del lavoro
4.3 Deregolamentazione del mercato del lavoro e occupazione
4.3.1 La visione dominante
4.3.2 La precarietà come freno alla crescita: l’approccio postkeynesiano
Approfondimento I Il dibattito su disuguaglianze distributive e crescita economica
Approfondimento II Michael Kalecki e gli aspetti politici del pieno impiego
5 Il capitale umano
5.1
5.2
5.2.1
5.3
Che cosa è il capitale umano
Capitale umano e mercato del lavoro
Capitale umano e probabilità di assunzione : education o relazioni sociali?
Capitale umano e crescita economica: la teoria della crescita endogena, ovvero i
fattori dal lato dell’offerta della crescita economica
5.3.1 Il modello Ak ed il learning by doing nel modello di Romer
5.3.2 Modelli con capitale umano : il modello Uzawa-Lucas e Rebelo
5.4 L’eccesso di istruzione
Bibliografia
2
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
1. Principali definizioni e indicatori statistici nel mercato del lavoro
In ciascun paese gli istituti di statistica raccolgono ed elaborano i dati inerenti al lavoro.
In Italia, ad esempio, l’ISTAT pubblica periodicamente l’Indagine sulle forze di lavoro
che, oltre a misurare l’occupazione e la disoccupazione, approfondisce le modalità e i
gradi di partecipazione al mercato del lavoro. La maggior parte dei dati viene raccolta
tramite interviste a campioni di popolazione.
Il principale obiettivo della rilevazione consiste nella produzione di stime ufficiali degli
occupati e
delle persone in cerca di occupazione.
In base alle definizioni ispirate dall’International Labour Office e recepite dai Regolamenti
comunitari, la popolazione in età lavorativa (15 anni e oltre) è ripartita in tre gruppi
distinti: occupati, disoccupati, inattivi.
Nella condizione di occupato si classificano le persone (di età non inferiore ai 15 anni)
che, nella settimana che precede la settimana in cui viene condotta l’intervista, hanno svolto
almeno un’ora di lavoro retribuito in una qualsiasi attività. Nel caso l’attività sia svolta nella ditta
di un familiare nella quale si collabora abitualmente, il lavoro può anche non essere
retribuito. Le persone occupate inoltre sono anche coloro che sono temporaneamente
assenti dal lavoro (per ferie o per malattia). Qui di seguito si riporta uno schema che
indica il modo in cui i questionari dell’ISTAT distinguono tra persone occupate e non.
L’individuazione delle persone in cerca di occupazione si fonda invece sui seguenti
requisiti:
• risultare non occupato;
3
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
• essere disponibile a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane
successive il momento dell’intervista;
• avere fatto almeno un’azione di ricerca di lavoro […] nelle quattro settimane
precedenti l’intervista.
Le indagini campionarie consentono inoltre di distinguere tra le diverse tipologie di
lavoratori e di contratti. Si riesce così a calcolare il numero di lavoratori dipendenti e il
numero dei lavoratori indipendenti, cioè lavoratori autonomi a partita IVA,
professionisti, ecc. Tra i lavoratori dipendenti, si può distinguere tra coloro che hanno
stipulato un contratto di lavoro permanente oppure a termine, e tra coloro che
lavorano a tempo pieno o a tempo parziale, ecc. Tra coloro che cercano lavoro, si può
distinguere tra quelli che hanno già esperienze e quelli che non hanno precedenti
esperienze lavorative. Tra gli inattivi si può inoltre distinguere tra coloro che non sono
disponibili a lavorare, e coloro che invece non cercano attivamente un lavoro ma che
sarebbero disponibili a lavorare se trovassero un impiego (talvolta, riguardo a questi
soggetti, si parla di lavoratori scoraggiati). L’esistenza di effetti di scoraggiamento è
anche alla base del fenomeno c.d. dei NEET (Not in employment, education or training),
individui giovani inattivi, non occupati, che non studiano né frequentano corsi di
formazione. Il fenomeno esattamente opposto a quello del lavoratore scoraggiato, che
segnala anche in questo caso interdipendenza fra domanda e offerta di lavoro, riguarda il
c.d. effetto del lavoratore aggiunto: in casi di aumento del tasso di disoccupazione, e di
riduzione dei salari, l’offerta di lavoro aumenta per l’ingresso nel mercato del lavoro di
altre componenti dell’unità familiare. Occorre anche rilevare l’esistenza di fenomeni di
disoccupazione nascosta, per i quali esistono lavoratori occupati che erogano una
produttività nulla (il che accade soprattutto in imprese a gestione familiare).
Il seguente cartogramma riporta i dati relativi alla ripartizione delle forze lavoro in Italia
nel 2013:
4
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
5
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
6
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Si noti che le percentuali riportate nei riquadri sono calcolate in rapporto al totale della
popolazione residente. E’ possibile tuttavia calcolare anche altre percentuali. Per esempio,
sapendo che i lavoratori dipendenti con contratto a termine sono 1.650.000 a tempo
pieno e 617.000 a tempo parziale, e che il totale dei lavoratori dipendenti è 16.915.000,
allora si può verificare che i lavoratori dipendenti con contratto a termine rappresentano
il 13,40% del totale dei lavoratori dipendenti,
1.650.000 617.000 2.267.000
13, 40%
16.915.000
16.915.000
Dai dati riportati nel cartogramma è inoltre possibile ricavare altri indicatori. Si consideri
per esempio la forza lavoro, data dalla somma delle persone occupate e delle persone in
cerca di occupazione. Nel 2013, la forza lavoro era pari a 22.430.000+2.844.000 =
25.274.000 unità. E’ inoltre possibile calcolare il tasso di disoccupazione, dato dal
rapporto fra persone in cerca di occupazione e la forza lavoro: nel 2013 era pari a
2.844.000/25.274.000 = 11,25%. C’è poi il tasso di occupazione, dato dal rapporto fra
gli occupati e la popolazione in età lavorativa tra 15 e 64 anni (quest’ultima è data dalla
somma tra occupati, disoccupati – quindi forza lavoro – e gli inattivi in età lavorativa,
25.274.000+14.699.000 = 39.973.000). Nel 2013, quindi, il tasso di occupazione era pari
a 22.430.000/39.973.000 = 56,11%. E’ inoltre possibile calcolare il tasso di attività,
dato dal rapporto fra la forza lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento (nel
nostro caso 25.274.000/39.973.000 = 63,22%) e il tasso di inattività, dato dal rapporto
fra gli inattivi e la popolazione di riferimento (nel nostro caso 14.699.000/39.973.000 =
36,78%).
Il tasso di disoccupazione è forse l’indicatore più comune tra tutti quelli citati, ma non è
sufficiente per valutare la situazione occupazionale di un paese. Esso ha infatti vari limiti:
per esempio, dato che non contempla i lavoratori scoraggiati, rischia di condurre a
risultati fuorvianti. Pensiamo a una situazione in cui, a causa del protrarsi della crisi
economica, alcune persone smettono di cercare attivamente un lavoro. Guardando al
cartogramma precedente, possiamo supporre per esempio che 200.000 persone passino
dallo stato di persone in cerca di occupazione allo stato di persone inattive in età
lavorativa. Ebbene, in questa circostanza sia le persone in cerca di lavoro che la forza
lavoro si riducono di 200.000 unità, e il tasso di disoccupazione diminuisce:
2.644.000/25.074.000 = 10,53%.
Invece, i tassi di attività e di inattività riflettono correttamente il fenomeno degli
scoraggiati, ed è quindi ad essi che occorre guardare per valutarne l’entità. Una corretta
valutazione della situazione occupazionale di un paese dovrebbe dunque basarsi su più
indicatori.
Se tenessimo conto, oltre dei disoccupati propriamente detti, anche di una parte degli
inattivi in età lavorativa il dato della ‘disoccupazione’ in Italia sarebbe più significativo:
7
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Persone in cerca di
occupazione
Persone che cercano lavoro
non attivamente ma
disponibili a lavorare
Persone che cercano lavoro
ma non disponibili a
lavorare
Persone che non cercano
lavoro ma disponibili a
lavorare
Totale
2.844.000
1.943.000
334.000
1.370.000
6.491.000
Rapportando il totale ottenuto nella tabella per la popolazione di riferimento il tasso di
disoccupazione corretto diventa 6.491.000/39.973.000 = 16,23%>11,25%.
L’andamento dei principali indicatori relativi al mercato del lavoro in Italia e il confronto
con i Principali Paesi Europei è riportato nella sezione info grafica che segue, nel quale
vengono illustrati l’andamento dei tassi di occupazione, di disoccupazione, di
disoccupazione giovanile, di occupati per settore e confrontati alcuni dati e indicatori a
livello europeo. Vengono inoltre illustrate graficamente la condizione giovanile nel
mercato del lavoro, con riferimento alla condizione dei NEET ( acronimo inglese Not
(engaged) in Education, Employment or Training) e, brevemente, al mismathc tra domanda e
offerta di lavoro.
Sulla base degli indicatori EUROSTAT e OECD è possibile identificare le seguenti
tipologie di mismatch: 1. vertical mismatch (EUROSTAT) misurato dall’indicatore
education/occupation mismatch 2. under/over-qualification (OECD) misurato
dall’indicatore skill mismatch 3. vertical / horizontal mismatch (EUROSTAT) misurato
dall’indicatore qualification mismatch.
8
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Figura 1.1 Tassi di occupazione in Italia
2004-2013.
Fonte ISTAT
Figura 1.1 Tassi di disoccupazione in Italia
2004-2013.
Fonte ISTAT
Figura 1.4 Tassi di disoccupazione giovanile al
2004-2013.
Fonte ISTAT
Figura 1.3 Occupati per settore. Anno 2013.
Fonte ISTAT
9
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Figura 1.6 Tasso di disoccupazione in Italia
2013-2014 (dati mensili, percentuale). Fonte
ISTA
Figura 1.5 Occupati in Italia 2013-2014
(dati mensili, milioni di unità). Fonte ISTAT
10
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Figura 1.7 Tasso di occupazione, variazioni e confronti tra Paesi Europei.
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Figura 1.8 Tasso di disoccupazione tra Paesi Europei.
12
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Figura 1.9 La condizione occupazionale dei giovani in n Italia
13
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Figura 1.10 La condizione occupazionale in Italia
Figura 11.1 La condizione occupazionale in Italia
14
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Figura 1.11. La condizione occupazionale in Italia
Figura 1.12 La condizione occupazionale in Italia
15
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Figura 1.13 La condizione occupazionale in Italia: i NEET
16
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Figura 1.14 Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro
17
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
2. La teoria neoclassica del mercato del lavoro
2.1. Il mercato del lavoro: caratteri generali
E’ preliminarmente necessario chiarire che non vi è consenso unanime sulla definizione
stessa di mercato del lavoro, dal momento che quella che viene comunemente proposta
fa esclusivo riferimento al modello neoclassico e, dunque, è una delle possibili definizioni
derivante da una delle possibili teorie della determinazione di salari e occupazione.
In ambito neoclassico, il mercato del lavoro può essere definito come il “luogo” nel
quale si realizza lo scambio fra offerta di servizi lavorativi, espressa dai lavoratori, e loro
domanda, espressa dalle imprese. La retribuzione di servizi lavorativi viene definita
salario, corrisposto in termini monetari. Il salario in termini reali, ovvero il salario
monetario unitario diviso per il livello generale dei prezzi, costituisce il potere d’acquisto
dei lavoratori. Si definisce domanda di lavoro la relazione tra quantità di lavoro che le
imprese sono disposte ad impiegare e il salario al quale l’impiego della forza lavoro è
realizzabile. Si definisce offerta di lavoro la relazione tra quantità di lavoro che si è
disposti a fornire e il salario corrisposto per quel servizio. In un mercato perfettamente
concorrenziale in cui sussiste parità contrattuale tra imprese e lavoratori, flessibilità
salariale e assenza di interventi esterni (azione sindacale, fissazione di salari minimi da
parte dello Stato) il meccanismo di funzionamento del mercato stesso – basato su di un
processo di aggiustamento della domanda e dell’offerta – fa sì che il salario raggiunga un
livello tale da rendere compatibili le scelte delle imprese riguardanti il numero di
lavoratori da impiegare con le decisioni della forza lavoro sulla quantità di lavoro da
erogare. In altre parole il meccanismo del mercato stesso fa sì che il salario si stabilizzi ad
un livello (il salario di equilibrio o market clearing) per il quale la domanda di lavoro è
uguale all’offerta di lavoro. Si individua così un livello ottimo di salario a cui corrisponde
una quantità ottima di lavoro. L’aspetto importante di questo approccio è che il livello di
occupazione esistente in un determinato momento non è frutto di una decisione
unilaterale delle imprese ma è la risultante di un processo di convergenza degli interessi
delle controparti, laddove le imprese massimizzano i profitti e i singoli lavoratori
massimizzano la loro funzione individuale di utilità. La disoccupazione diviene così
fenomeno esclusivamente volontario (salvo interventi esterni) frutto di una libera e
consapevole scelta individuale nel non impiegare il proprio tempo in attività lavorative
ritenendo il salario di mercato più basso rispetto a quello per il quale si è disposti a
lavorare (salario di riserva). Per poter giungere all’individuazione del livello di
occupazione e di salario erogato occorre individuare il meccanismo di funzionamento
della domanda di lavoro e dell’offerta di lavoro.
In quanto segue si esporrà lo schema-base del modello neoclassico. E’ importante
osservare che l’introduzione di “imperfezioni” – p.e. i costi di ricerca del lavoro (la c.d.
job search theory) 1 - non ne altera le conclusioni fondamentali e soprattutto non altera il
fondamentale assunto che regge questo modello, ovvero che salari e occupazione sono
determinati all’interno del mercato del lavoro, concepito come mercato isolato dagli altri. E non
1
Si rinvia al Manuale di Economia del Lavoro più diffuso in Italia: BRUCCHI (2001)
18
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
altera la fondamentale conclusione del modello per la quale l’aumento del salario riduce
l’occupazione.
Il modello si costruisce sulle seguenti ipotesi.
a) Lavoratori e datori di lavoro sono perfettamente razionali e perfettamente informati.
Conoscendo il livello dei prezzi, negoziano il salario monetario come se contrattassero
direttamente il salario reale.
b) Il mercato è perfettamente concorrenziale. Dunque, le imprese sono wage-taker (non
hanno cioè potere di fissazione del salario) e hanno l’obiettivo di massimizzare il profitto.
I lavoratori hanno l’obiettivo di massimizzare l’utilità, assumendo il lavoro come solo
fonte di disutilità.
c) la produttività marginale del lavoro è decrescente. Si assume, cioè, che all’aumentare
del lavoro impiegato il valore marginale del prodotto del lavoro diminuisce e questo
accade perché – a parità di prezzo di vendita del prodotto – i rendimenti del lavoro
diminuiscono all’aumentare della sua quantità. Più lavoro si impiega meno rendimento si
ottiene. Si dice che all’aumentare del lavoro impiegato la produttività marginale dello
stesso diminuisce. Ciò è dovuto al fatto che quando l’impresa ha a disposizione una
quantità data di mezzi di produzione (il capitale fisso: K) all’aumentare del numero dei
lavoratori la quota di mezzi di produzione spettante a ciascun lavoratore (K/L) si riduce
comportando di conseguenza una riduzione anche della produttività del lavoro.
2.2. La domanda di lavoro in concorrenza perfetta
La domanda di lavoro per l’impresa è una domanda derivata poiché dipende dalla
domanda del prodotto o del servizio per la cui realizzazione il lavoro è tecnicamente
necessario. Diverse sono le considerazioni che l’impresa deve fare circa la quantità di
lavoro da impiegare posto che la stessa si serve di lavoro per produrre e vendere beni e
servizi:
1. L’impresa deve conoscere il prezzo al quale è possibile vendere il bene e/o servizio
che produce nonché il costo del lavoro da impiegare.
2. L’impresa deve poi individuare le quantità di lavoro tecnicamente necessarie per
produrre le diverse quantità di prodotto.
3. L’impresa deve valutare i ricavi ottenibili dalla vendita delle singole quantità così
come deve valutare i costi di produzione corrispondenti alla medesima quantità.
4. L’impresa, infine, deve valutare la quantità ottima del bene da produrre – e di
conseguenza la corrispondente quantità ottima di lavoro necessario alla sua
produzione – tenuto conto che il suo obiettivo è quello di massimizzare i profitti.
Consideriamo un’impresa produttrice di computers operante in un mercato concorrenziale.
Supponiamo che il prezzo di vendita di ogni computer sia di 500 euro e supponiamo che
il salario da corrispondere al lavoratore sia di 300 euro. Date le informazioni contenute
nella Tabella 2.1 è possibile dimostrare come il livello ottimo di lavoratori per l’impresa
sia di 7 unità. Questo livello di occupazione corrisponde alla condizione per la quale
valore del prodotto marginale del lavoro è uguale al salario:
19
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Tabella 2.1 Calcolo del livello ottimo di impiego del fattore lavoro
Lavorat Quan Prezz
ori
tità
o di
(L)
(Q) vendit
a
(p)
0
1
0
0,8
500
500
2
1,8
500
3
3,1
500
4
4,3
500
5
5,4
500
6
6,3
500
7
7,0
500
8
7,5
500
Valore Salari
Costo
Profit Valore marginale del
del
o
del
to=p prodotto del lavoro=
Q
prodott (w)
prodotto
*q*p
L
o del
del
L*w
lavoro
lavoro=L*
=p*Q
w
0
300
0
0
400
300
300
100
((0,8-0)/(10))*500=0,8*500=400
900
300
600
300
((1,8-0,8)/(21))*500=1*500=500
1.550
300
900
650
((3,1-1,8)/(32))*500=1,3*500=650
2.150
300
1.200
950
((4,3-3,1)/(43))*500=1,2*500=600
2.700
300
1.500
1.200 ((5,4-4,3)/(54))*500=1,1*500=550
3.150
300
1.800
1.350 ((6,3-5,4)/(65))*500=0,9*500=450
3.500
300
2.100
1.400 ((7,0-6,3)/(76))*500=0,7*500=350
3.750
300
2.400
1.350 ((7,5-7,0)/(87))*500=0,5*500=250
Figura 2.1 Domanda di lavoro corrispondente alla Tabella 1
La congiunzione di tutti i punti corrispondenti al valore marginale del prodotto del
lavoro (VMPL) individua la domanda di lavoro per l’impresa. Stando a questo schema,
infatti, la domanda di lavoro dipende esclusivamente dal rendimento dello stesso e il
rendimento del lavoro rinvia a questioni attinenti la domanda del bene e servizio
20
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
venduto – che si riflettono sul prezzo del bene e servizio venduto – e a questioni
attinenti la produttività del lavoro stesso (disponibilità di capitale, efficienza del lavoro,
efficienza del capitale, ecc). In corrispondenza, poi, del punto di incontro della domanda
di lavoro con il livello di salario erogato (W) si individua la quantità ottima del lavoro da
impiegare. La Figura 2.1 rappresenta la curva della domanda di lavoro (VMPL) e del
salario (W) come generalizzazione della Figura 1 al fine di individuare il livello ottimo di
lavoratori (L*) da impiegare:
W
VMPL
L*
L
Figura 2.2 Domanda di lavoro e livello ottimo di
impiego
L* (tale cioè da massimizzare i profitti) si determina in questo modo. I profitti sono dati
per definizione dalla differenza fra ricavi e costi e, in questo contesto teorico, ammessa la
w
L , la cui
p
w
w
derivata prima è: Q , che posta uguale a 0 à la condizione di equilibrio MP . Da
p
p
libera fluttuazione dei prezzi, i ricavi sono pari al prodotto. Da cui: P Q
cui, il livello di occupazione di equilibrio si ha nel punto in cui la produttività marginale del lavoro
eguaglia il salario reale.
La fondamentale conclusione che deriva da questo risultato è la seguente: può esistere
disoccupazione involontaria solo se il salario reale è rigido verso il basso, e la
rigidità del salario è da imputare a fattori esogeni, ovvero a interventi esterni
(segnatamente del sindacato e/o dello Stato) che fissano il salario al di sopra del suo
valore market-clearing. Da ciò segue che per raggiungere il pieno impiego occorre attuare
politiche di deregolamentazione del mercato del lavoro, che consentano al salario di
fluttuare liberamente (v. infra) e alle imprese di assumere e licenziare con i minimi vincoli
normativi.
2.3. L’offerta di lavoro
L’offerta di prestazioni lavorative dipende dal numero di persone disposte a lavorare e
dal numero di ore che queste persone sono disposte a dedicare al lavoro. Ciò dipende
essenzialmente dalle preferenze del singolo circa il tempo da dedicare al lavoro, e quindi
dalle sue preferenze circa il livello di consumo – dato che il dedicarsi al lavoro consente
21
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
di ottenere reddito da spendere in acquisti di beni e di servizi – e dalle preferenze circa il
tempo da dedicare al leisure, ossia al tempo libero. La possibilità di combinare in modo
ottimale le ore di lavoro con le ore di leisure è vincolata dalla disponibilità di reddito non
da lavoro (il c.d. salario di riserva). Ad aumenti ulteriori di salario reale le ore di lavoro
possono diminuire (v. Figura 2.3)
w
p
H
Figura 2.3 Offerta di lavoro
Un aumento del salario reale accresce la quantità di beni e servizi che l’individuo può
consumare grazie a un’ora addizionale di lavoro. Questo evento aumenta la desiderabilità
del lavoro e induce l’individuo a offrire più ore lavorative (effetto di sostituzione). Tuttavia,
l’aumento del salario reale ha un secondo effetto. L’individuo – lavorando un minor
numero di ore di lavoro – può acquisire il reddito reale che ritiene necessario per
conseguire un dato obiettivo di tenore di vita. In altri termini lavorando di meno
l’individuo può acquisire lo stesso reddito reale di prima e disporre di più tempo libero.
Un aumento del salario reale aumenta l’attrattività del lavoro relativamente a quella del
tempo libero e incentiva gli individui a sostituire ore di tempo libero con ore addizionali
di lavoro. Tuttavia l’aumento del salario reale aumenta altresì il reddito reale dei
lavoratori e provoca un effetto di reddito. Poiché il tempo libero è un bene di lusso, al
crescere del reddito reale i lavoratori tendono ad aumentare in modo ancora più evidente
la domanda di tempo libero e diminuire automaticamente il tempo del lavoro. L’effetto
di reddito incentiva quindi gli individui a lavorare di meno. L’effetto netto di un aumento
del salario reale dipende quindi dalla prevalenza dell’uno o dell’altro dei due effetti. In
conclusione, in un primo momento, al crescere del salario il consumo di tempo libero da
parte del lavoratore diminuisce in quanto lo stesso è sostituito dal lavoro grazie al quale è
possibile ricevere un reddito da spendere nell’acquisto di beni e servizi. E’ più
conveniente allora lavorare che dedicarsi al tempo libero. L’aumento del salario però
garantisce aumenti del reddito dello stesso lavoratore. Da un certo punto in poi il lavoro
diviene un bene inferiore (la sua domanda da parte del lavoratore diminuisce
all’aumentare del reddito) mentre il tempo libero diviene un bene normale (la sua
domanda da parte del singolo lavoratore aumenta all’aumentare del reddito).
22
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
2.4. L’equilibrio nel mercato del lavoro e processi di aggiustamento: i
movimenti lungo le curve
W
S
W*
DL
L*
L
Figura 2.4 L’equilibrio nel mercato del lavoro.
La Figura 2.4 rappresenta l’equilibrio nel mercato del lavoro relativo ad un particolare
settore produttivo. La curva di domanda di lavoro (DL) è negativamente inclinata
rispetto al salario e interseca la curva dell’offerta del lavoro (S) inclinata positivamente
rispetto al salario (W). La combinazione (L*,W*) individua l’equilibrio del mercato del
lavoro2. Come si nota al livello W* le scelte delle imprese sono compatibili con le scelte
dei lavoratori. Se il salario si fissasse al disopra di W* si creerebbe un eccesso di offerta
di lavoro rispetto alla domanda. Vi sarebbe cioè un numero di lavoratori che pur essendo
disposti a lavorare non trovano allocazione. Dall’altra parte essendo il salario troppo alto
poche imprese sarebbero disposte ad assumere. Poiché vi è ‘troppa’ quantità di lavoro
offerta sul mercato il suo valore scende e il salario tenderà così a diminuire. Al diminuire
del salario però alcuni lavoratori usciranno dal mercato perché riterranno troppo basso il
suo livello rispetto a ciò che desiderano ricevere. Allo stesso tempo poi il diminuire del
salario permetterà alle imprese di aumentare la domanda di lavoro. Questo processo
terminerà quando l’eccesso di offerta si sarà annullato. Se invece il salario di mercato
dovesse essere minore del salario di equilibrio W* ci sarebbe un eccesso di domanda di
lavoro. In questo caso vi sono molte imprese dispose ad impiegare lavoro ma pochi
lavoratori disposti a lavorare per un salario giudicato troppo basso. Essendoci poca
disponibilità di lavoro il suo valore tenderà ad aumentare ma se il salario aumenta le
imprese ridurranno la domanda di lavoro così come i lavoratori ne aumenteranno
l’offerta. Anche questo processo di aggiustamento terminerà quando l’eccesso di
domanda si sarà annullato.
2Si
noti che la curva di offerta di lavoro è costruita, in questo caso, assumendo implicitamente la prevalenza dell’effetto di
sostituzione sull’effetto reddito. Pertanto all’aumentare del salario il lavoro aumenta sempre.
23
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
2.5. L’inefficienza dei ‘salari minimi’
Perché gli economisti liberisti ritengono che la fissazione di un salario minimo da parte
delle autorità produca inefficienza per il sistema? La spiegazione sta nel fatto che
qualunque livello di salario fissato da un organismo esterno – sia che sia superiore o
inferiore a quello di mercato – non consente l’aggiustamento della domanda con l’offerta.
Se lo Stato fissasse un salario minimo superiore a quello di mercato la domanda si
manterrebbe sempre e comunque ad un livello inferiore a quella potenzialmente
realizzabile. Un salario molto alto, infatti, indurrebbe molte imprese ad uscire dal
mercato del lavoro e molte altre a non entrarvi. Non vi sarebbero così possibilità per
mettere in moto il processo di aggiustamento visto nel paragrafo precedente e pertanto
la disoccupazione da volontaria diverrebbe involontaria e quindi non imputabile al libero
arbitrio dei singoli circa la volontà di offrire il proprio servizio al salario di mercato. Le
imprese sono così indotte ad impiegare un numero di lavoratori inferiore a quanto
sarebbero disposte a fare se il salario fosse in grado di fluttuare liberamente. Lo stesso
problema si presenta nell’eventualità in cui lo Stato dovesse fissare un salario minimo al
di sotto di quello di equilibrio. In questo caso l’offerta sarebbe sempre e comunque
inferiore a quella potenzialmente realizzabile poiché un salario molto basso indurrebbe
molti lavoratori ad uscire dal mercato del lavoro e altri a non entrarvi. Le imprese quindi
sarebbero indotte ad impiegare una quantità di lavoro inferiore a quanto sarebbero in
grado di fare se il salario potesse fluttuare liberamente.
2.6. L’equilibrio nel mercato del lavoro e processi di aggiustamento: gli
spostamenti delle curve
a) Aumento della domanda dei beni venduti:
S
W**
W*
DL’
DL
L*
L**
Figura 2.5 Incremento della domanda dei beni, occupazione e
salari
b) Aumento della dotazione di capitale:
24
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
S
W**
W*
DL’
DL
L*
L**
Figura 2.6 Incremento di capitale, occupazione e salari
c) Avanzamento tecnico:
S
W**
W*
DL’
DL
L*
L**
Figura 2.7 Tecnologia, occupazione e salari
2.7 – Sviluppi recenti del modello neoclassico
Sviluppi recenti del modello neoclassico, inquadrabili anche nell’approccio c.d. della
sintesi neoclassica 3 , giungono alla conclusione secondo la quale la disoccupazione
involontaria dipende da rigidità endogena del salario, ovvero da rigidità derivanti dal
3
La sintesi neoclassica, o economia neokeynesiana, è un indirizzo di ricerca che si propone di
integrare la teoria keynesiana nel più generale modello neoclassico, facendo della prima un caso
particolare della teoria neoclassica, in particolare facendo risalire a Keynes una teoria della rigidità
dei prezzi.
25
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
comune interesse delle controparti (datori di lavoro e lavoratori) a non ridurre il salario.
Tre teorie motivano questa tesi.
1. La teoria dei salari di efficienza. Si assume che la produttività del lavoro aumenta
all’aumentare del salario e si motiva questa ipotesi con la considerazione per la quale se
aumenta il salario aumenta il costo-opportunità del licenziamento (il c.d. effetto di
disciplina), ovvero diventa più costoso per il lavoratore agire come shirker
(“scansafatiche”). In tal caso, infatti sarebbe alta la probabilità di essere licenziato e
costoso il licenziamento per effetto della perdita del (più alto) salario che seguirebbe. In
tali circostanze, l’impresa trova conveniente aumentare il salario fino al punto in cui è
massima la differenza fra salario e produttività (essendo questo il salario di efficienza,
ovvero il salario che massimizza i profitti) e il lavoratore trova conveniente erogare il
massimo rendimento (effort) ottenendo un salario più alto. Sul piano aggregato, la
fissazione di un salario superiore a quello di equilibrio genera disoccupazione
involontaria.
Questa teoria è suscettibile di una duplice critica. In primo luogo, si assume che la sola
determinante della produttività del lavoro sia il rendimento dei lavoratori (effort), a fronte
del fatto che, in altri contesti teorici, si considera tale l’accumulazione di capitale. Più in
generale, la produttività del lavoro è determinata dall’effort (che indica ciò che il
lavoratore vuole fare), K (che indica ciò che il lavoratore può fare) e il capitale umano (che
indica ciò che il lavoratore sa fare). La composizione anagrafica della forza-lavoro e
l’organizzazione dell’impresa sono altri fattori che co-determinano la produttività.
In secondo luogo, la teoria dei salari di efficienza può dar luogo a un esito
contraddittorio rispetto al modello neoclassico, per la seguente ragione.
In termini formali, questa teoria si basa sulla condizione per la quale al ridursi di w, / w
assume valori prima inferiori a 1, poi superiori a 1. Per determinare il salario di efficienza si
scrive la funzione del profitto come:
P ( w, N ) N wN
[2.1]
che, massimizzata rispetto a w, dà:
/ w 1
[2.2]
La 2.1 individua la condizione di equilibrio nella scelta di w – anche nota come
condizione di Solow (v. SOLOW, 1979). Si osservi che se / w 1 (ovvero se vi sono
“forti” effetti incentivo del salario sul rendimento), allora dP/dw>0; così che può
accadere che la curva di domanda di lavoro – per certi valori del salario – assuma
andamento crescente. Infine, se / w 1 (ovvero se vi sono “deboli” effetti incentivo del
salario sul rendimento), allora dP/dw<0; così che la curva di domanda di lavoro tende ad
assumere un’inclinazione negativa.
26
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Questa conclusione vale a mettere in evidenza che – date le ipotesi più diffusamente
accolte in letteratura – la teoria degli alti salari influisce significativamente sulle
implicazioni proprie della visione neoclassica del funzionamento del mercato del lavoro,
quantomeno nel senso che la contemporanea accettazione dell’ipotesi dell’esistenza di
effetti incentivo del salario sulla produttività del lavoro e dell’ipotesi di rendimenti
marginali decrescenti comporta la circostanza che la curva di domanda di lavoro –
almeno all’interno di un dato intervallo di valori del salario – assuma andamento
crescente e che, perciò, al crescere del salario cresce l’occupazione.
Figura 2.8 La teoria dei salari di efficienza
In Figura 2.8 è disegnata la curva di domanda di lavoro sotto le ipotesi qui accolte (la
curva ND(w)). L’offerta di lavoro – considerata, per semplicità, come un dato – è Ns. Al
ridursi del salario (partendo, ad esempio, da wo), aumenta, in un primo tempo, la
domanda di lavoro; successive riduzioni salariali determinano riduzioni della domanda di
lavoro. Le imprese sceglieranno il livello salariale w*, al quale corrisponde il livello di
occupazione N*, che consente loro di massimizzare i profitti. La curva ND è la curva di
domanda di lavoro tradizionale (in assenza di effetti incentivo del salario sulla
produttività del lavoro). Il confronto fra l’equilibrio determinato dalla ND(w) e quello
determinato dall’incrocio ND-NS consente di stabilire che, allorché il rendimento dei
lavoratori è legato al salario loro erogato, prevale un livello di occupazione inferiore e un
salario di equilibrio maggiore. A fronte di progressive riduzioni del salario, inoltre,
aumentando, per ipotesi, il valore di d/dw (per esempio, per il ridursi del costoopportunità del licenziamento), la ND(w) passa da un’inclinazione negativa a
un’inclinazione positiva, con la conseguenza che quanto prima d/dw assume valori
superiori a 1 (ovvero, quanto più “forte” è l’effetto incentivo), tanto minore è il livello di
occupazione di equilibrio.
2) La teoria degli insider/outsider. In questa teoria si pone l’accento sugli interessi divergenti
dei lavoratori occupati (gli insider) e dei disoccupati (gli outsider). Si pongono, a riguardo,
le seguenti ipotesi:
a. l’obiettivo degli outsider è essere assunti. L’obiettivo degli insider è conservare il proprio
posto di lavoro, con salario immutato;
b. al crescere dell’occupazione si riduce il salario reale unitario;
27
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
c. gli insider dispongono di un potere contrattuale nei confronti dell’impresa superiore a
quello di cui dispongono gli outsider, a ragione del possesso di skill (abilità) specifiche ai
processi produttivi dell’impresa stessa.
In base alle ipotesi a. e b., gli occupati non vogliono che l’impresa proceda a nuove
assunzioni (giacché, in tal modo, anche il loro salario verrebbe ridotto); in base all’ipotesi
c., essi possono di fatto impedire al datore di lavoro di assumere, minacciando di
dimettersi (nel qual caso, l’impresa perderebbe lavoratori altamente produttivi e
dovrebbe sostenere i costi di qualificazione dei nuovi assunti). Segue che – secondo
questo schema di contrattazioni – occupazione e salario tendono a rimanere stabili, non
avendo nessuna delle parti convenienza a modificare le variabili in gioco.
3) In base a questa teoria (cfr. ROSEN 1985), il contratto di lavoro è generalmente
strutturato sulla base di un duplice implicito impegno delle controparti 4 : l’impresa si
impegna a pagare un salario monetario stabile nel tempo, date le aspettative dei
lavoratori. Diversamente, il salario tenderebbe a crescere nelle fasi di espansione e a
ridursi nelle fasi di recessione. In cambio della stabilità del salario, l’impresa offre la
garanzia del non licenziamento ai propri dipendenti. Si ritiene che questa tipologia
contrattuale – ancorché implicita – sia conveniente per entrambi i contraenti, laddove
nessuno dei due sia in grado di prevedere la durata e l’intensità delle fluttuazioni cicliche.
La Figura 2.9 illustra la situazione qui descritta.
A
w
B
D
w
C
Figura 2.9 La teoria dei contratti impliciti
t
L’impegno è implicito perché non pubblicizzabile. Le clausole contrattuali potrebbero essere interpretate, infatti, come
discriminatorie, soprattutto quando introducono elementi di differenziazione nel trattamento di lavoratori formalmente
omogenei all’interno dell’impresa. Per una limpida e sintetica ricostruzione delle “teorie del mercato interno del lavoro”, si
rinvia a GRAZIANI (1993, pp.183 ss.).
28
4
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Posto il tempo (t) sulle ascisse e il salario monetario (w) sulle ordinate, è possibile
valutare la convenienza delle controparti alla stipula di un contratto implicito, data la
durata e l’intensità delle fluttuazioni cicliche. L’area compresa fra i punti wAB
rappresenta l’ammontare di moneta al quale il lavoratore rinuncia: in altri termini, se il
contratto non fissasse il salario indipendentemente dal ciclo economico, in una fase
espansiva w raggiungerebbe il massimo in A, così che l’area in oggetto è – per il
lavoratore – un’area di perdita, per l’impresa un’area di guadagno. Per converso, l’area
compresa fra i punti BCD è un’area di guadagno per il lavoratore e di perdita per
l’impresa. E’ chiaro che la stipula di un contratto implicito è tanto più conveniente per
l’impresa quanto più lunghe e intense sono le fasi espansive; ed è tanto più conveniente
per il lavoratore quanto più lunghe e intense sono le fasi recessive. Se – come è plausibile
– le parti non dispongono di informazioni sufficienti per prevedere gli andamenti ciclici
per l’intera durata del contratto, il contratto stesso costituirà la strategia più ragionevole,
anche se non necessariamente quella più conveniente ex-post per entrambe le parti.
3) La teoria del “decent wage”. Partendo dal presupposto in base al quale il lavoro non è una
merce come le altre, si argomenta (cfr. SOLOW, 1994) che – almeno in alcuni segmenti
del mercato del lavoro – la reputazione (e più in generale le norme morali e sociali)
rivestano un ruolo determinante nella determinazione del salario. Ciò accade sia per i
datori di lavoro, sia per i lavoratori. Per i primi: una volta impostasi storicamente una
norma informale che impone di non accordare ai propri dipendenti un salario reale
inferiore a quello che il comune sentire ritiene “dignitoso”, la violazione di tale norma,
da parte di un imprenditore, si traduce in ostracismo, nell’espulsione, cioè, dalla
comunità degli imprenditori “onesti”. Per i lavoratori: la gara al ribasso del salario, per
essere assunti, può semplicemente non essere conveniente per alcuni gruppi di lavoratori,
giacché il beneficio che essa comporta (l’assunzione per un posto di lavoro
particolarmente ambìto) può risultare inferiore al costo (la perdita di reputazione nei
confronti dei propri colleghi). In tali circostanze, si verifica un fenomeno noto come noundercutting: nessun agente trova, cioè, conveniente concorrere con gli altri, in quanto ciò
comporta perdita di reputazione.
In definitiva: le teorie esposte in questo paragrafo giungono alla conclusione in base alla
quale la rigidità salariale è un esito spontaneo del funzionamento della contrattazione nel
mercato del lavoro.
29
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
3. Il mercato del lavoro nella teoria keynesiana
La teoria keynesiana dell’occupazione si regge principalmente sul concetto di ‘domanda
effettiva’. La domanda effettiva è il punto di incontro di due curve: a) la curva
dell’offerta aggregata e b) la curva della domanda aggregata. La domanda aggregata (Y) è
data dalla somma della domanda di beni di consumo espressa dalle famiglie (C), la
domanda di beni di investimento espressa dalle imprese (I), la spesa pubblica al netto
della tassazione (G-T) e le esportazioni nette (NX), ovvero:
Y C I G T NX
[3.1]
Astraendo, per semplicità, da G, T e NX, il reddito “di equilibrio” si ottiene sostituendo
la funzione dei consumi e degli investimenti nella 2.1. La funzione dei consumi è:
[3.2]
C Co cY
dove Co è la quota autonoma dei consumi, c è la propensione al consumo (ovvero C/Y)
e Y il reddito.
La funzione degli investimenti è:
[3.3]
I f (i, e), f 'i 0, f 'e 0
dove i è il tasso di interesse ed e una variabile che cattura le aspettative imprenditoriali
(expectations), soggette a incertezza radicale.
da cui:
[3.4]
dove (1/1-c) è il moltiplicatore, un coefficiente che indica di quanto aumenta Y
all’aumentare di I. Si osservi che l’effetto moltiplicativo è tanto maggiore quanto
maggiore è la propensione al consumo. In più, poiché il reddito può essere destinato a
consumi e/o a risparmi, vale la condizione Y=C+S e, dividendo per Y, vale la
condizione c+s=1, dove s è la propensione al risparmio. Da cui: 1/(1-c)=1/s.
La funzione aggregata d’offerta collega N, il numero dei lavoratori occupati, alla variabile
AS, definita come offerta aggregata del prodotto ottenuto dall’impiego di N lavoratori,
mentre la funzione aggregata di domanda collega N alla variabile Z, definita come
domanda del prodotto che gli imprenditori si attendono dalla produzione alla cui
realizzazione concorrono gli N lavoratori impiegati. In altre parole AS – essendo curva
dell’offerta - individua la curva dei costi marginali che occorre sopportare nell’impiegare i
lavoratori mentre Z – essendo curva della domanda – individua la curva dei ricavi
marginali e attesi che gli imprenditori si attendono nel produrre e vendere i prodotti, e
quindi, in ultima analisi nell’impiegare i lavoratori. L’aspetto importante di
quest’approccio è che entrambe le curve esprimono unicamente il punto di vista
dell’imprenditore. Non vi è, infatti, nessuna curva di offerta da parte dei lavoratori. Si
Y * [1/(1 c)][Co I ]
30
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
noti che entrambe le curve sono positivamente inclinate anche se la domanda aggregata
cresce meno rapidamente rispetto all’offerta aggregata. Questo andamento può avere
diverse giustificazioni. Per quanto riguarda la domanda aggregata, occorre sottolineare
che, stando a Keynes, essa soggiace alla “legge psicologica” per la quale la propensione al
consumo tende a decrescere al crescere del reddito, data la ragionevole ipotesi per la
quale individui con reddito alto consumano relativamente meno di quanto consumano
individui con basso reddito.
Per quanto riguarda l’offerta aggregata è naturale supporre che all’aumentare del numero
dei lavoratori impiegati il costo marginale risulti crescente. Il punto di domanda effettiva
ci dice quale è il livello di equilibrio dell’occupazione e quindi della produzione date le
aspettative di breve periodo degli imprenditori sui costi e ricavi.
AS
AS,DL
Z
N
Figura 3.1 La determinazione del livello di occupazione nella teoria keynesiana
Uno dei pilastri portanti della teoria keynesiana dell’occupazione è il ruolo del salario. Il
salario ha natura duale: esso è costo di produzione ma anche elemento della domanda
aggregata per il tramite dei consumi. Ciò che si afferma è allora che le decisioni di
occupazione da parte delle imprese non sono prese sulla base (o soltanto sulla base) della
tecnica con la quale operano (come accade nel modello neoclassico) e dunque dei costi,
ma principalmente sulla base della domanda attesa per i beni da esse prodotti. Da ciò
segue che l’esistenza di disoccupazione involontaria è da imputare a carenza di
domanda aggregata. La carenza di domanda aggregata, a sua volta, considerando per
semplicità un’economia chiusa e senza intervento pubblico, dipende da bassi consumi
e/o bassi investimenti. Keynes ritiene che la variabile più rilevante per dar conto di una
bassa domanda aggregata siano gli investimenti, data la volatilità delle aspettative, e
suggerisce, nel capitolo conclusivo della Teoria Generale, programmi di socializzazione
degli investimenti. In linea più generale, un basso livello della domanda aggregata
deriva da bassi consumi e/o bassi investimenti: bassi consumi, a loro volta, dipendono
da bassi salari e/o da un’elevata propensione al risparmio; bassi livelli di investimento
dipendono da alti tassi di interesse e/o (e soprattutto) da aspettative pessimistiche. La
principale prescrizione di policy che deriva dalla Teoria Generale è il deficit spending, ovvero la
creazione di disavanzi primari del settore pubblico finalizzati ad accrescere l’occupazione.
Come mostrato nella figura in basso, la c.d. croce keynesiana, nella quale per semplicità
31
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
non compare una funzione di offerta, l’aumento di G sposta la curva della domanda
aggregata in alto generando aumenti di occupazione e di produzione.
Figura 3.2
32
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
4 La teoria postkeynesiana: caratteri generali
L’Economia postkeynesiana è stata elaborata da numerosi economisti a seguito della
pubblicazione della Teoria Generale, in contrapposizione a una interpretazione del
pensiero keynesiano che lo riconduce a un caso particolare del modello neoclassico, nella
versione dell’equilibrio economico generale (la c.d. sintesi neoclassica o Economia
neokeynesiana). Sebbene, a differenza dell’approccio neoclassico, l’Economia
postkeynesiana non può considerarsi un corpus unitario, alcuni elementi di analisi
condivisi possono essere rintracciabili e riconducibili ai seguenti punti.
1) Il livello di produzione e di occupazione è determinato, sia nel breve sia nel lungo
periodo, dalla domanda aggregata.
2) Il mercato del lavoro, per conseguenza, è un mercato ‘residuale’, nel senso che, a
differenza del modello neoclassico (nel quale occupazione e salari sono determinati
dall’incontro fra domanda e offerta di lavoro), occupazione e salari sono qui determinati
dall’andamento della domanda aggregata.
3) Le decisioni di investimento, da parte delle imprese, sono assunte in un contesto di
incertezza radicale (fundamental uncertainty), ovvero in un contesto nel quale non è
possibile assegnare un valore probabilistico al verificarsi di eventi futuri.
4) L’offerta di moneta è endogena: il settore bancario nel suo complesso può creare
moneta senza vincoli di scarsità (dove per moneta è qui da intendersi moneta-credito) e
la quantità di moneta effettivamente circolante dipende dalla domanda di credito che le
imprese (ed eventualmente le famiglie) esprimono nei confronti del settore bancario. In
tal senso, si stabilisce che l’offerta di credito è ‘trainata dalla domanda’ (demand-driven).
5) I mercati non sono perfettamente concorrenziali e le imprese fissano i prezzi sulla
base della regola del mark-up, ovvero aggiungendo un margine di profitto ‘normale’ o
‘desiderato’ ai costi di produzione. In termini formali, non considerando, per semplicità,
i costi degli altri input diversi dal lavoro, si ha: p
w
(1 r ) , dove p è il prezzo unitario, w
il salario monetario, π la produttività del lavoro e r il saggio del profitto.
6) La struttura economica è composta da gruppi (classi) sociali con interessi divergenti e
conflittuali. Con la massima schematizzazione, si assume che esistano tre macrooperatori: il settore bancario, il settore delle imprese (produttrici di beni di consumo e di
beni di investimento) e i lavoratori dipendenti. Una ipotesi diffusamente accolta in
questo ambito teorico riguarda la differente propensione al consumo fra gruppi sociali:
in particolare, si assume che la propensione al consumo dei lavoratori è maggiore della
propensione al consumo dei capitalisti.
Sul piano metodologico, gli economisti postkeynesiani ritengono che la formulazione di
teorie economiche non possa e non debba fondarsi su un approccio assiomatico (come
nell’Economia neoclassica) e che debba, per contro, basarsi su una selezione di ipotesi
che rifletta l’evidenza empirica (il c.d. realismo critico). In tal senso, si rifiuta l’assioma
neoclassico della razionalità strumentale, si ritiene che il problema economico non sia
riconducibile a un problema di allocazione di risorse scarse fra usi alternativi dati e, per
conseguenza, si considera che la scarsità di risorse non è mai esogena. In altri termini, le
33
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
risorse sono scarse solo in quanto endogenamente scarse, ovvero solo se sussistono vincoli
di natura extra-economica (e dunque di natura in ultima analisi politica) che le rendano
tali. A ciò si aggiunge la considerazione in base alla quale, per gli economisti
postkeynesiani, il comportamento dei singoli agenti non avviene, come nella modellistica
neoclassica, in un vuoto istituzionale: da qui, la proposta di superare l’individualismo
metodologico e di fornire macrofondazioni della microeconomia, ovvero considerare i
comportamenti dei singoli agenti come profondamente influenzati dalla loro
appartenenza a gruppi/classi sociali, da abitudini e consuetudini e da relazioni di potere
(cf. LAVOIE, 1992).
Nei paragrafi che seguono, ci si soffermerà, in particolare, su due aspetti dell’Economia
postkeynesiana: la teoria monetaria e l’analisi del funzionamento del mercato del lavoro.
Questa opzione è giustificata dal fatto che, in questo contesto teorico, il mercato del
lavoro interagisce con il mercato del credito, così che salari e occupazione sono
fondamentalmente determinati dalle decisioni del sistema bancario in ordine al
finanziamento della produzione.
4.1 – La teoria monetaria postkeynesiana*
Come evidenziato supra, la teoria monetaria postkeynesiana, nei suoi più recenti sviluppi,
si basa sull’ipotesi stando alla quale l’offerta di moneta è endogena e trainata dalla
domanda di credito espressa dalle imprese (ed eventualmente dalle famiglie). A seguire, si
considererà un indirizzo di ricerca, che ha riscosso e riscuote particolare interesse fra gli
economisti di orientamento “critico” e di ispirazione postkeynesiana: la teoria monetaria
della produzione o teoria del circuito monetario.
La teoria monetaria della produzione (TMP) si propone come una descrizione del
processo economico alternativa a quella neoclassica, almeno per due aspetti essenziali. In
primo luogo, si ritiene che la distribuzione del reddito non è soggetta alla regola
marginalista della produttività marginale, stando alla quale le retribuzioni sono
commisurate al contributo individuale alla produzione, e si considera che l’assetto
distributivo è il risultato della contrattazione fra macro-operatori e, in tal senso, riflette il
loro potere contrattuale. Vengono, conseguentemente, rifiutati i principali presupposti
della teoria neoclassica: l’individualismo metodologico, l’assioma della scarsità (esogena)
delle risorse e il principio della ‘sovranità del consumatore’, includendo nel discorso
economico variabili che la tradizione neoclassica ha, di norma, espunto dal piano
analitico, con particolare riferimento alla dimensione del potere, individuale e di gruppo,
ai conflitti distributivi, e alle relazioni di gerarchia e di dipendenza (cfr. GRAZIANI, 2003).
In secondo luogo, in questo schema teorico si pone l'accento sul ruolo della moneta
come primum movens della produzione di merci, nel senso che si ritiene impossibile l’avvio
del processo produttivo senza la preventiva creazione di mezzi di pagamento da parte
del sistema bancario. Questa impostazione – la cui genesi viene fatta risalire a Marx – ha
i suoi primi sviluppi intorno agli anni venti del Novecento grazie ai contributi di Knut
Wicksell e Joseph A. Schumpeter. Il suo consolidamento, sul piano analitico, si ha, in
*
Questa sezione è una rielaborazione di quanto contenuto in FORGES DAVANZATI, PATALANO 2014.
34
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
quegli anni, con il Treatise on Money di Keynes, ed è a partire dagli anni cinquanta del
Novecento che gli studi nell’ambito della TMP subiscono un ulteriore impulso
soprattutto per opera di economisti italiani e francesi. Nell’ambito della TMP, si ritiene
che la moneta svolge la sua funzione essenziale proprio nel momento del finanziamento
della produzione – il cosiddetto initial finance – così che la produzione di beni e servizi
presuppone la produzione di moneta. Lo schema-base di funzionamento del circuito
monetario si basa sull’esistenza di tre macro-operatori: le banche, le imprese, i lavoratori.
Lo schema prevede fasi sequenziali, articolate come segue. Le banche, nel loro
complesso, creano moneta-credito sulla base della domanda di finanziamento
proveniente dalle imprese (ipotesi di moneta endogena). Queste ultime quantificano
l’initial finance sulla base del monte salari contrattato con i lavoratori. Gli scambi interni al
macro-operatore imprese danno luogo a un saldo netto nullo, dal momento che non si
dà fuoruscita di moneta dal sistema delle imprese (v. GRAZIANI, 2003). Assumendo che
la propensione al consumo dei lavoratori sia unitaria, l’intero monte salari monetario
torna alle imprese sotto forma di ricavi di vendita, così che i costi monetari di
produzione (pari al monte salari monetario), per le imprese nel loro complesso, sono
identicamente uguali ai ricavi che esse sono in grado di ottenere vendendo i beni e
servizi prodotti, per qualunque livello dei prezzi. Questa raffigurazione del processo
economico dà luogo a ciò che è stato definito il ‘paradosso dei profitti’.
Si può osservare che, in questo schema, la manovra del tasso di interesse da parte del
sistema bancario non è un mero fatto tecnico (e non necessariamente attiene al controllo
del tasso di inflazione), ma coinvolge direttamente alla sfera distributiva. In tal senso, il
tasso di interesse è una variabile distributiva, le cui variazioni non rispondono al puro fatto
‘tecnico’ del controllo delle pressioni inflazionistiche, ma sono essenzialmente finalizzate
a modificare la distribuzione del reddito. In più, nello schema di base della TMP, si
assume che le imprese nel loro complesso sono libere di scegliere la scala e la
composizione merceologica della produzione, secondo il principio della ‘sovranità del
produttore’ che viene contrapposto a quello marginalista della ‘sovranità del
consumatore’. Più in dettaglio, si ritiene che le imprese scelgano la quantità prodotta di
beni di investimento e beni di consumo sulla base – nel primo caso – della loro
propensione all’accumulazione e – nel secondo caso – sulla base di eventuali pressioni
che i lavoratori possono esercitare per acquisire salari reali più alti. Ciò accade
evidentemente in un orizzonte di breve periodo con risorse date, così che l’aumento
della produzione di beni di investimento non può non implicare la riduzione della
produzione di beni di consumo. A ciò si aggiunge l’assunto secondo il quale le imprese
sono considerate come un sistema consolidato, così che all’attivo di un’impresa (vendita
di beni) corrisponde il passivo di un’altra (acquisto di beni). Questo significa che le
imprese non fanno altro che trasferirsi fra loro liquidità, e che questo ammontare di
moneta non ‘fuoriesce’ dal settore delle imprese.
In questo contesto teorico, si assume che i salari siano contrattati in termini monetari e
che il salario reale sia noto ex-post, una volta, cioè, che le imprese hanno fissato i prezzi
dei beni di consumo. Il numero di occupati e il salario reale dipende in modo cruciale dal
grado di accomodamento del sistema bancario, ovvero dalle decisioni di finanziamento
della produzione da parte del sistema bancario. In termini più generali, viene fatto
osservare che l’attuale configurazione delle economie capitalistiche è caratterizzata da
35
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
rilevanti processi di “finanziarizzazione” e che questi comportano un declino della quota
dei salari sul Pil (il c.d. finance-led-capitalism). HEIN e DETZER (2015), in particolare,
rilevano che, in una condizione di pressoché totale deregolamentazione dei mercati
finanziari, le imprese trovano conveniente ottenere profitti attraverso attività speculativa
(il marxiano D-D’). Il che comporta riduzione degli investimenti, dell’occupazione e dei
salari5.
4.2 - La teoria postkeynesiana del mercato del lavoro
E’ stato rilevato che, nella modellistica postkeynesiana, il mercato del lavoro è un
mercato “residuale”, nel senso che occupazione e salari sono in ultima analisi determinati
dall’andamento della domanda aggregata. Questa assunzione è derivata dalla
constatazione che il salario ha natura ‘duale’: sul piano microeconomico, e dunque per la
singola impresa, è esclusivamente un costo (come si verifica nel modello neoclassico),
mentre sul piano macroeconomico è una componente della domanda aggregata per il
tramite dei consumi. A ciò si aggiunge un’ulteriore ipotesi che fa riferimento al fatto che,
in un’economia monetaria dominata da incertezza radicale, la contrattazione nel mercato
del lavoro ha ad oggetto il salario monetario (o nominale), non, come nel modello
neoclassico, il salario reale.
Diversamente, quindi, dalla teoria neoclassica per la quale il salario di equilibrio (market
clearing) deriva dall’incontro fra una curva di domanda di lavoro con inclinazione negativa,
data l’ipotesi di produttività marginale decrescente, e una curva di offerta crescente, nella
modellistica postkeynesiana si considera una curva dei salari (v. Fig. 4.1) che risulta essere
crescente al crescere dell’occupazione. Ciò a ragione del fatto che la crescita
dell’occupazione comporta un aumento del potere contrattuale dei lavoratori e delle
organizzazioni sindacali e, per conseguenza, un aumento del salario unitario. In tal senso,
la curva è denominata bargaining real wage (BRW) e la sua equazione è: w b(U ), b' 0 ,
dove w è il salario, b un coefficiente che indica il potere contrattuale dei lavoratori e U il
tasso di disoccupazione6.
HEIN e DETZER (2015) osservano anche che la finanziarizzazione è anche associata alla crescente propensione, da parte
del management delle grandi imprese, a valutare la performance dell’impresa in un orizzonte di brevissimo termine (il c.d.
short-termism). In terzo luogo, la finanziarizzazione si manifesta anche con il crescente ricorso all’indebitamento privato,
soprattutto per le famiglie con più bassi redditi. Infine, la finanziarizzazione è anche associata a crescenti e ampi disequilibri
macroeconomici, con particolare riferimento alle dinamiche del commercio internazionale.
6
V. CARLIN e SOSKICE (1993, pp.148 ss.).
36
5
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
w
BRW
Ls
PRW
L
Figura 4.1 Salario contrattato e salario effettivo
Si osservi che, in questa impostazione teorica, si assume che i lavoratori abbiano un
salario- obiettivo (target), che deriva dalle loro abitudini di consumo, dalla memoria
individuale e di gruppo, dalla loro percezione di equità e da altri fattori istituzionali non
riconducibili a un criterio di pura razionalità strumentale. Il salario obiettivo può anche
essere considerato salario di sussistenza, ovvero quel salario che consente la
riproduzione della forza-lavoro, storicamente e socialmente determinato. In ambito
postkeynesiano, si ritiene, seguendo Keynes, che i lavoratori siano interessati a
mantenere inalterati i salari relativi, ovvero il salario che ottengono nel confronto con
quello ottenuto da altri gruppi di lavoratori.
Poiché, nel modello postkeynesiano, si assume che oggetto di contrattazione è il salario
monetario e che le imprese fissano il prezzo con la regola del mark-up (ovvero
aggiungendo un margine di profitto ‘normale’ o desiderato ai costi di produzione), può
accadere, come descritto in Fig.1.4, che il c.d. salario reale determinato dal prezzo (o
salario reale effettivo) – PRW – diverga dal salario contrattato, e che questo sia inferiore
37
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
a quello contrattato. La differenza è tanto maggiore quanto maggiore è il potere di
mercato delle imprese e, quindi, quanto maggiore è il mark-up. Il valore del mark-up
dipende dal grado di concentrazione industriale e dal grado di collusione e
coordinamento fra le imprese esistenti. L’esistenza di barriere all’entrata consente alle
imprese esistenti di applicare un margine di profitto maggiore, dal momento che si
riduce la possibilità, per i consumatori, di acquistare beni da altre imprese (v. CARLIN e
SOSKICE, 1993, pp.152 ss.). Stando a questo schema, molti economisti postkeynesiani
ritengono le lotte per l’aumenti dei salari totalmente inefficaci, per gli interessi stessi dei
lavoratori, dal momento che l’eventuale aumento dei salari monetari potrebbe essere
traslato dalle imprese nell’aumento dei prezzi, con conseguente riduzione (o non
aumento) dei salari reali, Si suggerisce, per contro, di agire sulla scala e sulla
composizione merceologica della produzione, inducendo le imprese (anche tramite
intervento pubblico diretto di produzione di beni e servizi) a produrre una quantità
maggiore di beni di consumo (cfr. GRAZIANI, 2003).
Si ribalta in tal modo il nesso causale teorizzato in ambito neoclassico: è al crescere
dell’occupazione che cresce il salario a fronte del nesso per il quale l’aumento del salario
riduce l’occupazione. Si tratta di un meccanismo simile a quello teorizzato da Marx – il
c.d. esercito industriale di riserva – in base al quale le fluttuazioni dei salari dipendono
dal potere contrattuale dei lavoratori, a sua volta dipendente dal tasso di disoccupazione.
L’aumento dell’occupazione, a sua volta, si rende possibile per l’aumento della domanda
aggregata. Si può quindi scrivere:
AD C I G T NX
L f (Y e ), f ' 0
[4.1]
[4.2]
dove Y è la domanda aggregata, come somma di domanda di beni di consumo (C), di
beni di investimento (I), a cui si aggiungono la spesa pubblica al netto della tassazione
(G-T) e le esportazioni nette (NX). La funzione 4.2] stabilisce che la domanda di lavoro
espressa dalla imprese è funzione diretta della domanda aggregata attesa.
Gli economisti postkeynesiani riconoscono che le dinamiche del mercato del credito
rivestono un ruolo rilevante nella formazione della domanda aggregata e, per
conseguenza, nella determinazione del livello di occupazione. In particolare, il settore
bancario influisce su Y mediante la fissazione del tasso di interesse e/o mediante
variazioni del grado di accomodamento bancario, intendendo, per questo, la propensione
delle banche ad assecondare in toto o in parte la domanda di moneta-credito espressa
dalle imprese (v. supra).
In tal senso, si può concludere che, in ambito postkeynesiano, il livello dell’occupazione
e dei salari dipende in modo cruciale dalle decisioni del settore bancario in ordine
all’erogazione di credito alle imprese (ed eventualmente alle famiglie). In questo ambito
teorico, dunque, il mercato del lavoro risulta ‘residuale’ rispetto al mercato del credito e, in tal senso,
risulta impossibile analizzarlo come mercato isolato dagli altri.
Coerentemente con questa impostazione, in Fig. 4.1 non compare una curva di domanda
di lavoro, essendo, quest’ultima, derivata dalla funzione della domanda aggregata, a sua
volta dipendente dal funzionamento del mercato del credito. La curva di offerta di
38
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
lavoro (Ls) è verticale dal momento che si assume che i) la forza-lavoro è omogenea; ii) i
lavoratori non hanno redditi non da lavoro, così che il loro salario di riserva è
strettamente maggiore di zero.
In radicale contrapposizione con l’approccio neoclassico, si ritiene, in questo contesto
teorico, che l’imposizione di minimi salariali sia un dispositivo efficace ai fini della
crescita. Ciò fondamentalmente per due ragioni. Innanzitutto, sul piano microeconomico,
si ritiene che maggiore rigidità del mercato e del rapporto di lavoro spinga le imprese a
competere innovando (essendo difficile competere riducendo i costi e, dunque, i salari).
Questo meccanismo viene denominato teoria degli alti salari, o effetto Webb (Lavoie,
1992): un aumento esogeno dei salari determina un aumento della produttività del
lavoro, attraverso l’introduzione di innovazioni- In secondo luogo, per l’operare del
meccanismo di accelerazione (v. KALDOR, 1957), si considera che l’aumento dei salari, in
quanto accresce la domanda, spinge le imprese ad aumentare la produzione, dunque gli
investimenti e l’occupazione. Ciò avviene sia per l’aumento delle dimensioni medie
aziendali, sia per la riduzione del grado di capacità produttiva inutilizzata.
Un effetto analogo si ottiene attraverso aumenti di spesa pubblica, data l’ipotesi di
complementarietà fra spesa pubblica e investimenti privati (PARGUEZ, 2011). In
altri termini, si ritiene che un aumento della spesa pubblica, in quanto accresce la
domanda interna, migliora le aspettative imprenditoriali, agendo come “àncora dei
profitti”, e, per conseguenza, accresce occupazione e salari.
4.3 – Deregolamentazione del mercato del lavoro e occupazione* nel
dibattito contemporaneo
Almeno a partire dagli anni novanta, è diventata convinzione diffusa che l’elevata
disoccupazione in Europa era (ed è) imputabile all’eccessiva rigidità del mercato del
lavoro e del contratto di lavoro. Del tutto coerentemente con questa diagnosi, si è
proceduto – con particolare accelerazione soprattutto in Italia – ad attuare politiche di
progressiva precarizzazione del lavoro. Convenzionalmente, il grado di “flessibilità del
lavoro” è misurato da un indicatore, elaborato dall’OCSE e denominato employment
protection legislation, che fa essenzialmente riferimento alla libertà accordata alle imprese di
licenziare con i minimi costi7.
Questa sezione è una stesura ridotta di FORGES DAVANZATI, PAULÌ (2015).
Protection Legislation (EPL) si riferisce all’insieme di regole e procedure che disciplinano la possibilità di
assumere e licenziare lavoratori nel settore privato. L’Ocse identifica alcuni indicatori sintetici che misurano il grado di EPL
in vari paesi, a partire dalla considerazione di 21 fattori, classificati in tre aree principali: la prima area considera un gruppo
di fattori (1-9) relativi alla normativa sui lavoratori a tempo indeterminato licenziati per motivi individuali o economici, ma
senza giusta causa; la seconda area considera i fattori (10-17) relativi ai contratti a termine standard e al lavoro interinale
(temporary-work-agency employment); nella terza area rientrano i fattori (18-21) che definiscono le regole specifiche da applicare
nel caso di licenziamenti collettivi. Gli indicatori sintetici di EPL sono ottenuti attribuendo alle regole vigenti nei vari paesi –
per ognuno dei 21 fattori – un punteggio su una scala che va da 0 a 6. Sulla base di questa metodologia di calcolo, l’Ocse
elabora due principali sotto-indicatori di EPL: l’EPRC misura il grado di protezione del lavoro a tempo indeterminato e
considera fattori come i vincoli procedurali e temporali al licenziamento, il livello degli indennizzi, le difficoltà a licenziare
(es. la definizione di licenziamento senza giusta causa, il periodo di prova, la disciplina del reintegro, ecc.) e la disciplina dei
contratti collettivi; l’EPT misura invece il grado di protezione per i contratti a termine. In entrambi i casi, quanto maggiore è la
flessibilità del mercato del lavoro, tanto minore è il valore dell’indice. Le misurazioni di questi indici sono cambiate nel tempo,
ne esistono oggi tre versioni che riflettono mutamenti circa l’ampiezza e la disponibilità delle informazioni prese in
39
*
7 L’Employment
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
L’opinione dominante si fonda sulla convinzione che le politiche di deregolamentazione
del mercato del lavoro siano necessarie per la crescita dell’occupazione8. Per contro, si
mostrerà che le politiche di precarizzazione del lavoro favoriscono, di fatto, processi di
moderazione salariale, funzionali alla crescita dei margini di profitto delle nostre imprese
attraverso la compressione dei prezzi dei prodotti esportati, senza nessun effetto di
segno positivo sull’occupazione (o addirittura accrescendo la disoccupazione). Sulla base
dell’evidenza empirica, verrà mostrato che i) questa strategia non è risultata efficace
almeno nel caso italiano; ii) le politiche di precarizzazione del lavoro hanno avuto il solo
effetto di ridurre la quota dei salari sul Pil e di disincentivare modalità di competizione
basate sulla crescita della produttività mediante introduzione di innovazioni.
Nelle sezioni che seguono si propone di fornire una ricostruzione critica del dibattito
teorico sui nessi esistenti fra politiche di precarizzazione del lavoro, occupazione e
crescita economica e successivamente ci si sofferma sulle critiche formulate in ambito
post-keynesiano.
4.3.1 – La visione dominante
L’impostazione teorica che accoglie l’idea che una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro9
possa costituire una condizione per una maggiore occupazione si richiama alla “scuola
neoclassica marginalista”10, secondo la quale il livello di occupazione si determina nel
considerazione. La prima versione è disponibile per molti paesi a partire dal 1985, mentre la terza versione – che comprende
una gamma più ampia di fattori rispetto alle versioni precedenti – è disponibile soltanto a partire dal 2008. In quanto segue, i
termini precarietà, flessibilità, deregolamentazione – per comodità espositiva – verranno considerati sinonimi.
8 Si veda, fra gli altri, BLANCHARD, GIAVAZZI (2003); BLANCHARD (2006).
9 Dal punto di vista strettamente terminologico, la flessibilità nel mercato del lavoro rimane un concetto polisemico, al
quale però si associa erroneamente e prevalentemente la facilità di assunzione e di licenziamento del lavoratore. L’OECD
distingue diverse forme di flessibilità: una distinzione è quella tra flessibilità del rapporto di lavoro e flessibilità salariale. Per
ciò che attiene alla prima forma, la letteratura economica distingue ulteriormente: la flessibilità esterna si riferisce alla capacità
da parte dell’impresa di variare il numero di lavoratori al suo interno, mentre la flessibilità numerica interna misura invece la
capacità dell’impresa di variare l’input lavoro (le ore di lavoro per unità di tempo) senza licenziare o assumere lavoratori,
come nel caso del lavoro straordinario; la f. funzionale misura la capacità dell’impresa di riorganizzare i propri lavoratori su
diverse mansioni, differenti luoghi e tipi di lavoro. La f. salariale si riferisce, nei termini più tradizionali, alla misura in cui i
salari, e specificamente quelli reali, sono reattivi rispetto a variazioni di domanda e offerta di lavoro. Consiste quindi nella
capacità dei datori di lavoro di alterare la retribuzione pagata ai propri lavoratori quando le condizioni del mercato lo
richiedano e in relazione all’andamento della produttività; essa è generalmente limitata dove la contrattazione salariale è
fortemente centralizzata, mentre può essere favorita dalla contrattazione decentrata. La f. di esternalizzazione, infine, consiste
nell’utilizzo, da parte delle imprese, di lavoratori esterni all’impresa instaurando rapporti di tipo commerciale anziché
lavorativo; non è molto diffusa in Italia e prende le forme, per es., del telelavoro oppure del lavoro a distanza. Per una
trattazione estesa di questi temi si veda FORGES DAVANZATI ( 2005).
10 Per un confronto tra le diverse teorie economiche si veda RONCAGLIA(2012); LUNGHINI (1999). Con la massima
schematizzazione, si può affermare che la teoria neoclassica-marginalista, a partire dai lavori fondativi di Menger, Jevons,
Walras elabora un metodo di indagine economica che, abbandonando la teoria del valore elaborata dagli economisti classici,
propone una teoria alternativa del valore di tipo soggettivista basata sul concetto cardine di utilità marginale quale misura del
valore dei beni, i quali pertanto hanno un valore in quanto sono utili, cioè servono a soddisfare un bisogno dell’uomo, e tale
valore è tanto più elevato quanto maggiore è la scarsità dei beni e più intenso il bisogno; tale approccio fa propria inoltre
l’assunzione del principio di scarsità per qualunque mercato (dei beni, del lavoro, della moneta) per il quale le risorse
disponibili in aggregato sono limitate; ne consegue la rilevanza delle forze del mercato e della concorrenza perfetta in primis,
in un contesto ipotetico in cui tutti gli attori economici sono perfettamente razionali (operando in condizioni di assenza di
incertezza) e pertanto perfettamente informati al fine di consentire l’allocazione efficiente di risorse ritenute scarse, nel
mercato dei beni così come nel mercato del lavoro, ritenuto al pari di un qualunque bene cedibile sul mercato; infine, dalla
validità della nota “legge di Say” logicamente segue che non siano ipotizzabili crisi di mercato, dato che i beni prodotti sono
totalmente venduti e i fattori produttivi completamente impiegati. Come osserva LUNGHINI (2012, p. 29) la teoria
neoclassica “ci descrive dunque il mondo in cui tutti noi vorremmo vivere, un mondo in cui l’homo oeconomicus dispone di
40
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
mercato del lavoro. In questo framework teorico, il mercato del lavoro è concepito in
modo del tutto analogo al mercato delle merci (un mercato tra i mercati). Nel caso del
mercato del lavoro, il “prezzo” è il salario in termini reali. La quantità è invece il numero
di occupati (come approssimazione delle ore lavorate). E’ importante rilevare che, in
condizioni di concorrenza perfetta, si assume che datori di lavoro e lavoratori abbiano il
medesimo potere contrattuale, dal momento che, seguendo SAMUELSON (1957, p.894)
“in a perfectly competitive market, it really doesn't matter who hires whom: so have labor hire capital
”11.
Le tesi a sostegno delle politiche di precarizzazione del lavoro sono fondamentalmente le
seguenti.
1) Nel modello neoclassico, in una condizione di concorrenza perfetta, il livello
dell’occupazione è determinato dall’incontro fra la domanda di lavoro espressa dalle
imprese e l’offerta di lavoro espressa dai lavoratori. Nel primo caso, si ritiene che il
numero di lavoratori domandati dalle imprese si riduca al crescere del salario. Ciò a
ragione dell’ipotesi stando alla quale le imprese operano con rendimenti marginali
decrescenti, così che – per uno stock dato di capitale fisso – al crescere del numero di
occupati, la loro produttività si riduce. L’offerta di lavoro viene considerata, in questo
modello, come funzione diretta del salario reale. Questa relazione viene motivata
considerando che al crescere del salario vi è maggiore incentivo a entrare nel mercato del
lavoro. Se il salario può liberamente fluttuare in relazione a variazioni della domanda e
dell’offerta di lavoro (ovvero, se il mercato del lavoro è perfettamente concorrenziale),
nel punto di incontro fra domanda e offerta di lavoro si determinerà il salario reale di
equilibrio e l’occupazione di equilibrio. In tale condizione, se esiste disoccupazione essa
ha natura esclusivamente volontaria, riguardando individui che – dato il loro salario di
riserva – non sono disposti a lavorare al salario corrente. Da ciò segue che ogni intervento
esterno di regolamentazione del mercato del lavoro (p.e. sotto forma di imposizione di minimi salariali)
non può che generare disoccupazione involontaria.
2) Una elevata flessibilità del lavoro può avere effetti positivi sui profitti e di
conseguenza sugli investimenti e infine sulla occupazione. Questa variante dell’approccio
neoclassico – che non ha necessità di poggiare sull’ipotesi di rendimenti marginali
decrescenti e di sostituibilità dei fattori – è riassunta in questa sequenza. Un aumento del
grado di flessibilità del mercato del lavoro accresce i profitti (in quanto comporta
“moderazione salariale”), generando conseguentemente un aumento degli investimenti e
dell’occupazione.
L’argomento ora presentato si presta a diverse obiezioni: i) non vi è alcuna ragione
logico-teorica per esser certi che l’aumento dei profitti si risolva in un aumento degli
investimenti. Proprio in quanto la possibilità di un accresciuto autofinanziamento è una
razionalità perfetta e conoscenza illimitata e in cui non ci sono né crisi, né conflitti distributivi” (corsivo aggiunto). L’autore
sottolinea che il fatto che la teoria neoclassica sia riuscita a conservare la sua egemonia culturale e politica in un mondo
come mai agitato dal conflitto, dalla crisi e dall’incertezza, possa configurarsi come una classica questione gramsciana. Per una
bibliografia essenziale che possa descrivere la contemporanea macroeconomia mainstream, si vedano: ROBBINS (1932, 1947) ;
SAMUELSON (1973); per una bibliografia sul mainstream contemporaneo che accoglie il c.d. approccio imperfezionista, si veda,
tra gli altri: BLANCHARD, AMIGHINI, GIAVAZZI (2011).
11 Si tratta di una tesi che ignora il fatto che i datori di lavoro dispongono, all’atto della stipula del contratto di lavoro, di
fondi per la propria sussistenza maggiori di quelli di cui dispongono i lavoratori. In tali condizioni, potendo aspettare più
tempo per la stipula del contratto, dispongono di maggior potere contrattuale (come rilevato, fin dal 1776, da Adam Smith).
41
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
precondizione per investimenti aggiuntivi, nulla implica che le imprese vogliano effettuarli.
Perché la relazione postulata tra maggiori profitti per le imprese, maggiori investimenti e
quindi maggiore occupazione sia certa, occorre porre ipotesi sulle aspettative
imprenditoriali, assumendo, in particolare, che l’aumento dei profitti attuali si rifletta in
un aumento dei profitti attesi, e che – inoltre – le aspettative siano unicamente (o
principalmente) influenzate dai profitti effettivamente realizzati. Vi è di più. Anche posto
che le aspettative migliorino a seguito dell’aumento dei profitti realizzati, occorre anche
che gli investimenti vengano effettuati nella stessa area geografica nella quale sono state
attuate politiche di flessibilità, e che dunque non vi siano delocalizzazioni e che i profitti
realizzati non vengano utilizzati per fini speculativi (o per consumi ostentativi); ii) Non vi
è alcuna ragione logico-teorica per stabilire che l’aumento degli investimenti si traduca in
un aumento dell’occupazione, potendo tradursi (ed è il caso della jobless-growth) in un
aumento della dotazione di capitale fisso. La possibile contro-obiezione è nell’ “effetto di
compensazione”, per il quale la disoccupazione (qui tecnologica) è un fenomeno di breve
termine, destinato a essere ridotto o annullato tramite il riassorbimento dei (temporanei)
disoccupati nei settori che producono beni capitale12. Come diffusamente riconosciuto in
ambito non-neoclassico13, tuttavia, questo meccanismo presuppone una perfetta capacità
di riconversione dei disoccupati, i quali – senza costi – dovrebbero esser pronti ad
acquisire conoscenze su processi tecnici adottati in settori industriali nei quali non sono
mai stati utilizzati.
3) Si ritiene anche che le politiche di deregolamentazione del mercato del lavoro, in
quanto associate a “moderazione salariale”,
sono funzionali alla crescita
dell’occupazione per il tramite di un aumento delle esportazioni reso possibile dalla
riduzione dei salari monetari e dei prezzi 14 . In altri termini, la riduzione del salario
derivante da una politica di flessibilità determina una riduzione dei prezzi dei beni
esportati, alla quale farebbe seguito un aumento dei profitti delle imprese esportatrici,
dunque degli investimenti, della domanda interna e dell’occupazione. La sequenza
aumento dei profitti, degli investimenti e dell’occupazione è suscettibile delle medesime
obiezioni poste con riferimento al caso discusso supra. Due ulteriori obiezioni possono
essere poste all’argomentazione che fonda la sequenza ora delineata: i) sul piano teorico,
non vi è evidentemente nessuna ragione stringente che induca a considerare come
effetto necessario l’aumento dei profitti a seguito della riduzione del prezzo, dal
momento che la competitività internazionale attiene anche alla qualità dei prodotti
esportati; ii) sul piano empirico, risulta ampiamente documentato che la maggiore flessibilità
non necessariamente produce maggiori esportazioni15.
Si osservi che l’ “effetto di compensazione” riguarda anche l’aumento della domanda, e dunque dell’occupazione,
conseguente alla riduzione dei prezzi che fa seguito all’aumento della produttività. Sul tema si rinvia a PINI (1992).
13 Si rimanda a P. PINI, op. cit.
14 La questione verrà ulteriormente approfondita infra. Per una critica a questa posizione si veda il contributo di STIRATI in
CESARATTO, REALFONZO ( 2006).
15 Il caso più noto, che contraddice questa relazione, è la Germania, per la quale il consolidarsi delle quote di mercato si
verifica in concomitanza di una dinamica salariale maggiore rispetto agli altri Paesi (pure a fronte di riduzioni dei salari
anche in Germania): si tratta di un risultato che ribalta sul piano fattuale e concreto l’aspettativa teorica del modello
neoclassico secondo cui l’aumento delle esportazioni e l’incremento delle quote di mercato sono determinate dalla riduzione
dei costi relativi e dei prezzi delle esportazioni. Nel caso concreto sembra ravvisarsi allora l’ipotesi, nota in letteratura come
“paradosso di Kaldor”, che nei rapporti di scambio internazionali, più del costo del lavoro pesino i fattori competitivi non
42
12
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Gli economisti che si riconoscono nella scuola neoclassico-marginalista ritengono che la
flessibilità del rapporto di lavoro (la flessibilità numerica) possa favorire una maggiore
occupazione. Si ritiene, infatti, che l’aumento del grado di discrezionalità delle imprese
con riferimento a scelte che riguardano le assunzioni (flessibilità in entrata) e i
licenziamenti (flessibilità in uscita) accresca l’occupazione, a ragione di questa circostanza.
La rimozione dei vincoli normativi sulla libertà di licenziamento – si argomenta –
avrebbe come effetto l’aumento della efficacia e della credibilità della “minaccia” del
licenziamento stesso. A ciò dovrebbe far seguito un aumento del rendimento dei
lavoratori, a ragione dell’operare di un “effetto di disciplina”16 dunque della produttività,
dei profitti, dell’occupazione. Si può sostenere che la flessibilità in uscita può al più
accrescere l’occupazione, ma non anche risultare efficace per il raggiungimento del pieno
impiego. La rimozione dei vincoli normativi su assunzioni e licenziamenti – viene ancora
osservato – potrebbe esercitare un effetto positivo sulle aspettative imprenditoriali,
inducendo le imprese ad assumere. Detto diversamente: in questa ipotesi, è solo sapendo di
poter licenziare che le imprese assumono.
Vi è di più. La flessibilità funzionale – anche intesa come demansionamento – viene
ritenuta necessaria al fine di garantire la maggiore occupazione: si ritiene che l’aumento
della discrezionalità attribuita all’imprenditore nella gestione dei movimenti interni
all’impresa, dunque nella modifica anche continua delle mansioni dei suoi dipendenti,
accresca la produttività totale dei fattori, dunque la produzione e i profitti, giacché –
conoscendo l’imprenditore la struttura del processo produttivo meglio del legislatore – è
in grado di allocare la forza-lavoro in modo efficiente all’interno dell’impresa. Questo
argomento, tuttavia, non si presta – se non in modo molto indiretto – a ipotizzare una
relazione positiva fra flessibilità funzionale e occupazione, giacché occorre assumere che
la maggiore efficienza derivante dall’utilizzo dello “ius variandi” si traduca in maggiori
profitti; che tali profitti vengano destinati a nuovi investimenti; che tali investimenti
generino incrementi di occupazione.
4.3.2 – La precarietà come freno alla crescita: l’approccio postkeynesiano
La teoria postkeynesiana17 descrive il funzionamento del sistema economico a partire da
assunti teorici molto diversi rispetto all’approccio di derivazione neoclassico-marginalista.
In particolare, e per quanto qui conta, si ritiene che occupazione e salari non sono
determinati all’interno del mercato del lavoro, attraverso fluttuazioni della domanda e
dell’offerta in una condizione di piena parità contrattuale fra datori di lavoro e lavoratori,
di prezzo, quali la composizione merceologica e qualitativa dei prodotti esportati. Si rimanda su questi temi ai lavori di .
GRAZIANI (1998, 2002).
16 Si rimanda a SHAPIRO, STIGLITZ (1984).
17 E’ possibile rilevare che tra gli elementi comuni e condivisi di questo approccio possono essere considerati i seguenti: a)
il riconoscimento della non neutralità della moneta e della c.d. teoria della moneta endogena (stando alla quale il sistema
bancario nel suo complesso può creare moneta-credito senza incontrare vincoli di scarsità); b) la convinzione che il livello di
occupazione sia determinato dalla domanda effettiva (dove la domanda effettiva è data dalla somma di consumi,
investimenti, spesa pubblica al netto della tassazione ed esportazioni al netto delle importazioni), in un assetto istituzionale
nel quale non vi è parità di poteri contrattuali nel mercato del lavoro e nel quale vige incertezza radicale (così che non
esistono agenti rappresentativi pienamente razionali). Una bibliografia minima consultabile per orientarsi rispetto alla
ricchezza di questo approccio teorico è la seguente: LAVOIE (1992); DAVIDSON ( 1994); PASINETTI (2010); FONTANA,
SETTERFIELD (eds) (2010).
43
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
ma dipendono dalla domanda di beni di consumo e di beni di investimento. In più, il
salario ha natura ‘duale’: è costo di produzione per le imprese (sul piano
microeconomico) e componente della domanda aggregata per il tramite dei consumi (sul
piano macroeconomico). Gli economisti postkeynesiani condividono la tesi
(radicalmente contrapposta a quella neoclassica) secondo la quale un’economia di
mercato deregolamentata tende spontaneamente a generare disoccupazione involontaria.
La quale dipende essenzialmente dall’attuazione di politiche di bassi salari che, riducendo
i consumi, riducono la domanda di beni e servizi e, conseguentemente, riducono la
domanda di lavoro espressa dalle imprese.
Se pertanto dal punto di vista delle argomentazioni teoriche è possibile individuare una
pluralità di obiezioni sul piano logico e sul piano teorico, l’eredità di Keynes18, raccolta
dagli economisti postkeynesiani che al suo lavoro e alle sue argomentazioni si richiamano,
consente di mettere in campo ulteriori argomenti teorici contrari a politiche di
precarizzazione del lavoro e di moderazione salariale.
Gli economisti di orientamento postkeynesiano ritengono che la flessibilità salariale
costituisca una strategia o inefficace o finanche controproducente ai fini della riduzione
della disoccupazione a partire dalle seguenti assunzioni generali: a) la contrattazione fra
datori di lavoro e lavoratori ha ad oggetto il salario monetario, non il salario reale; b) il
salario ha natura duale: è costo di produzione, ma anche elemento della domanda
aggregata per il tramite dei consumi.
Dalla seconda ipotesi discende immediatamente che le decisioni di occupazione da parte
delle imprese non sono prese sulla base (o soltanto sulla base) della tecnica con la quale
operano (come accade nel modello neoclassico), e dunque, dei costi; ma principalmente
sulla base della domanda attesa per i beni da esse prodotti. E’ così possibile stabilire la
relazione macroeconomica per la quale il livello di occupazione è funzione della
domanda aggregata attesa 19 . In ottica postkeynesiana, una possibile schematizzazione
degli effetti derivanti dall’introduzione di misure di flessibilità salariale è indicata in
questa sequenza. La riduzione dei salari, derivante da politiche di deregolamentazione del
mercato del lavoro, riduce i consumi e, a parità di investimenti, la domanda aggregata,
con effetti di segno negativo sull’occupazione. La sequenza ricostruisce, in modo
semplificato, il meccanismo keynesiano mediante il quale la riduzione del salario
monetario, connesso alla rimozione di rigidità nel mercato del lavoro in presenza di
disoccupazione, riduce la domanda per consumi, con effetti negativi sulla domanda
aggregata e, conseguentemente, con effetti sostanzialmente nulli sull’occupazione.
18In
particolare ci si riferisce (KEYNES1930; [1936] 1994).
Dove – si ricordi – le aspettative sono puramente erratiche, essendo impossibile – in ottica keynesiana – attribuire
probabilità al verificarsi di eventi futuri.
44
19
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
In definitiva, nel modello postkeynesiano:
- l’operare spontaneo dei meccanismi di mercato non garantisce necessariamente il
raggiungimento del pieno impiego20.
- la flessibilità salariale non accresce l’occupazione e può tradursi unicamente in una
riduzione della quota dei redditi da lavoro dipendente (il c.d. labour share);
Questi risultati sono generati dall’ipotesi-chiave secondo la quale il livello di occupazione
non è determinato nel mercato del lavoro (che è qui un “mercato residuale”), ma
dipende dall’ampiezza della domanda aggregata.
Alcuni sviluppi della ricerca in ambito postkeynesiano21 hanno posto in rilievo il fatto
che la flessibilità in uscita può ridurre l’occupazione. Il modello è fondato sulle seguenti
ipotesi:
a) La propensione al consumo si riduce al crescere della probabilità di licenziamento.
Questa ipotesi è giustificata dal fatto che, ragionevolmente, l’obiettivo degli occupati è
mantenere sostanzialmente stabile il proprio tenore di vita. La riduzione della
propensione al consumo (ovvero l’aumento dei propri risparmi) costituisce, perciò, una
risposta razionale all’introduzione di misure di flessibilità in uscita;
b) La produttività del lavoro cresce al crescere della probabilità di licenziamento, a
ragione dell’operare dell’effetto di disciplina, ovvero dell’incentivo a erogare maggior
rendimento (effort) in una condizione nella quale è più alto il rischio di perdita del posto
di lavoro22.
Dal punto di vista macroeconomico, si verificano, dunque, i seguenti effetti. Una maggiore
flessibilità in uscita riduce la propensione al consumo, dunque la domanda aggregata,
dunque l’occupazione. Parallelamente, sia a causa della riduzione della domanda, sia a
causa dell’aumento della produttività del lavoro, si rende necessario un numero minore
di occupati. D’altra parte, dal punto di vista microeconomico, vi è certamente convenienza
ad avvalersi di misure di flessibilità in uscita, giacché queste, contribuendo alla riduzione
dei costi di produzione (l’aumento della produttività a parità di salario), determinano una
riduzione dei prezzi e la conseguente sottrazione – da parte delle imprese che per prime se
ne avvalgono – di quote di mercato alle proprie concorrenti. E’ questo un caso nel quale:
- vi è vantaggio nel “partire per primi” (advantage of being first);
- vi è divergenza fra convenienza privata (avvalersi della flessibilità in uscita, in quanto
questa contribuisce alla crescita della produttività e dei profitti) e convenienza sociale
(non avvalersi della flessibilità in uscita in quanto questa riduce la domanda aggregata,
l’occupazione e non ha effetti positivi sui profitti aggregati).
20A
una conclusione più estrema si giunge con la c.d. shock theory. Viene fatto rilevare che la flessibilità salariale può rilevarsi
una strategia controproducente, per la seguente ragione. Si parte dalla constatazione che, per ottenere i massimi profitti, il
management di un’impresa deve erogare il massimo impegno e che l’erogazione di effort impone costi, in termini di disutilità del
lavoro. Se – come accade per le grandi imprese – la proprietà è distinta dal management, dove solo i proprietari-azionisti
hanno interesse alla massimizzazione dei profitti (cfr. Baumol,1962), è l’aumento, non la riduzione, dei salari dei lavoratori
ad incentivare il rendimento dei manager; i quali – per ottenere almeno il medesimo volume di profitti con costi di
produzione accresciuti – devono ora introdurre miglioramenti nei processi organizzativi e/o produttivi al fine di accrescere
la produzione e i ricavi. In tal caso, l’aumento dei salari esercita un effetto positivo di shock sulla produttività del management,
e la flessibilità salariale è controproducente in quanto riduce il volume di produzione (cfr. REES, 1973). Si rimanda inoltre a
BAUMOL (1962);
21 Cfr. FORGES DAVANZATI, REALFONZO (2003).
22 E’ opportuno sottolineare che questa ipotesi ha una radice fondamentalmente neoclassica, e che non è unanimemente
accettata in ambito postkeynesiano. Si fa rilevare, in questo contesto teorico, che la precarizzazione del lavoro può semmai
generare effetti di scoraggiamento, con conseguente riduzione della produttività del lavoro.
45
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
In conclusione, è opportuno porsi la seguente domanda: posto che esistono numerosi
rilievi critici di ordine teorico ed empirico riferiti ai presunti effetti positivi delle politiche
di precarizzazione del lavoro sull’occupazione, sulla base di quali considerazioni tali
politiche vengono reiteratamente attuate? In letteratura, sono state avanzate numerose
risposte23 e non è questa la sede per dar conto della complessità del dibattito. Occorre,
tuttavia, rilevare che la fase di attuazione di misure di politica del lavoro (e, più in
generale, di politica economica) coinvolge numerosi attori, segnatamente: il Governo (il
cui obiettivo si ritiene essere la massimizzazione del consenso), le imprese (alle quali
conviene operare in un mercato del lavoro “flessibile”), i lavoratori occupati (che
verosimilmente sono contrari alla flessibilità), i lavoratori disoccupati (che
verosimilmente sono favorevoli alla flessibilità). Una tesi, accreditata soprattutto fra gli
economisti di orientamento marxista 24 è che le politiche del lavoro sono, in ultima
analisi, orientate dalla minaccia che le imprese oppongono al Governo di disinvestire,
ovvero di dislocare i propri investimenti all’estero (il c.d. “sciopero del capitale” o Capital
Strike). Il disinvestimento costituisce una minaccia efficace per il Governo, poiché,
riducendo il reddito nazionale, e quindi i redditi individuali, riduce la probabilità che i
cittadini (ora impoveritisi) rinnovino il proprio consenso verso il Governo in carica. In
più, seguendo la c.d. power resources theory (KORPI, 1998), si può sostenere che gli
orientamenti di politica economica riflettono i poteri contrattuali nel mercato del lavoro,
così che quanto maggiore è il tasso di disoccupazione, tanto minore è il potere
contrattuale dei lavoratori anche nella sfera politica e tanto più agevole è l’attuazione di
misure di precarizzazione del lavoro che redistribuiscono risorse a vantaggio dei profitti.
In altri termini, l’esistenza di un ampio esercito di riserva è una precondizione per
l’attuazione di misure finalizzate a comprimere i salari.
In definitiva, si può rilevare che le politiche di precarizzazione del lavoro i) esercitano
effetti di segno negativo sulla domanda aggregata, dal momento che accrescono il grado
di incertezza in ordine al rinnovo del contratto, riducendo, per conseguenza, la
propensione al consumo; ii) agiscono come disincentivo alle innovazioni, dal momento
che pongono le imprese nella condizione di competere comprimendo i costi di
produzione (salari in primis); iii) non si associano a significativi incrementi delle
esportazioni, dal momento che la precarietà del lavoro è anche associata a una bassa
dinamica della produttività e, dunque, a un elevato costo del lavoro per unità di prodotto.
Sulla base di questi tre effetti, e considerando l’evidenza empirica, si conclude che le
politiche di deregolamentazione del mercato del lavoro hanno il solo effetto di ridurre la
quota dei salari sul Pil, accrescendo (o comunque non riducendo) il tasso di
disoccupazione e agendo come freno alla crescita economica.
23
Si rimanda a SAINT-PAUL (2000).
BOWLES, GINTIS (1983)
24
46
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Approfondimento I: Il dibattito su disuguaglianze distributive e
crescita economica
Le differenti analisi e proposte di politica economica che derivano da contrastanti analisi
del funzionamento del mercato del lavoro, in ambito neoclassico e postkeynesiano,
riflettono un dibattito di portata più generale, che attiene alla relazione fra equità
distributiva e crescita economica, In quanto segue, se ne forniscono le coordinate
essenziali.
a) L’approccio neoclassico. Le teorie dominanti fanno riferimento sostanzialmente a due tesi.
In primo luogo, come già rilevato da Kuznets nel 1955, si ritiene che la dinamica delle
diseguaglianze segua una curva a U rovesciata, ovvero che esse tendano a crescere nelle
prime fasi di industrializzazione per poi decrescere, in assenza di interventi esterni. E’
dunque la crescita economica a produrre spontaneamente riduzione delle diseguaglianze. In
secondo luogo, si ritiene che la diseguaglianze siano necessarie per la crescita, per
l’operare di effetti di “sgocciolamento” (trickle-down): misure di redistribuzione del
reddito a vantaggio dei più ricchi, considerati tali in quanto più produttivi, si suppone
generino maggiore crescita economica che, a sua volta, si suppone essere una precondizione per l’attuazione di politiche redistributive25. Per contro, politiche finalizzate a
generare maggiore equità distributiva disincentiverebbero l’impegno lavorativo,
riducendo il tasso di crescita a danno anche e soprattutto dei ceti meno abbienti. Si
osservi che, secondo questa impostazione, la redistribuzione del reddito è un problema
extra-economico, dal momento che le politiche redistributive si rendono opportune o
necessarie per motivazioni che attengono alla sfera morale, alla necessità di preservare la
coesione sociale compatibilmente con la prioritaria necessità di generare crescita economica26.
Sulla base di queste argomentazioni, quantomeno nel caso dell’Unione Monetaria
Europea, si sono stabiliti vincoli all’espansione dei deficit e dei debiti sovrani in relazione
al Pil, ovvero si sono imposte ‘scarsità artificiali’ (PARGUEZ 2011), rendendo necessaria
l’attuazione di politiche fiscali restrittive, con riduzioni di spesa pubblica e aumenti della
pressione fiscale.
Occorre preliminarmente chiarire che la ripartizione dell’onere fiscale, così come la
distribuzione dei tagli di spesa, risente del potere contrattuale dei lavoratori e delle
imprese nella sfera politica e, in tal senso, non risponde a criteri di efficienza di sistema
(v. KORPI, 1989). In una condizione di elevata disoccupazione, è dunque lecito aspettarsi
che il maggior peso della tassazione (e dei minori trasferimenti pubblici) venga fatto
gravare sul lavoro, accreditando la tesi di MARX (2006 [1869]) secondo la quale “la causa
La quali, in questa impostazione teorica e di politica economica, dovrebbero essere effettuate attraverso trasferimenti
monetari, che preservino la libertà di scelta dei beneficiari. Vi sono, per contro, argomenti rilevanti per motivare la superiore
efficacia di trasferimenti pubblici in forma di beni e servizi (dunque, nella forma del potenziamento del Welfare), dal
momento che, in questo caso, per effetto dell’accesso ai servizi sanitari e all’istruzione, le misure di ridistribuzione del
reddito hanno effetti di segno positivo sul tasso di crescita della produttività del lavoro.
26 Si può osservare che l’ipotesi della trickle down economics è di fatto connessa all’idea che la crescita economica sia trainata dal
reinvestimento dei profitti (profits-led-growth). Si tratta di una tesi che sembra radicalmente smentita sul piano empirico, a
ragione fondamentalmente del fatto che i profitti vengono utilizzati sempre più per attività speculative e/o per consumi di
lusso. Questi fenomeni, a loro volta, sembrano configurare uno scenario definito di “stagnazione secolare”.
47
25
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
del fatto che il patrimonio dello stato cade nelle mani dell’alta finanza [è] l’indebitamento
continuamente crescente dello stato”.
In questo scenario, le diseguaglianze distributive tendono ad autoalimentarsi. Le misure
di austerità, da un lato, accrescono il tasso di disoccupazione e, riducendo il potere
contrattuale dei lavoratori, riducono la quota dei salari sul Pil; l’aumento del debito
pubblico che ne consegue si traduce nella necessità di reperire risorse tramite tassazione,
prevalentemente a danno del lavoro dipendente.
Da cui una seconda conclusione: le politiche finalizzate a ridurre il debito (in quanto si
associano a un aumento della tassazione sui redditi più bassi e, dunque, a maggiore
diseguaglianza distributiva) determinano un trasferimento netto di ricchezza alla rendita finanziaria.
Come scriveva Marx: “L’indebitamento dello stato è l’interesse diretto dell’aristocrazia
finanziaria quando governa e legifera per mezzo delle Camere; il disavanzo dello stato è
infatti il vero e proprio oggetto della sua speculazione e la fonte principale del suo
arricchimento. Ogni anno un nuovo disavanzo. Dopo quattro o cinque anni un nuovo
prestito offre all’aristocrazia finanziaria una nuova occasione di truffare lo stato che,
mantenuto artificialmente sull’orlo della bancarotta, è costretto a contrattare coi
banchieri alle condizioni più sfavorevoli” (MARX, 2006 [1869]). In termini ancora più
chiari, viene rilevato che:
“I prestiti mettono i governi in grado di affrontare spese straordinarie senza che
il contribuente ne risenta immediatamente, ma che richiedono tuttavia un
aumento delle imposte in seguito. D’altra parte, l’aumento delle imposte
causato dall’accumularsi di debiti contratti l’uno dopo l’altro costringe il
governo a contrarre sempre nuovi prestiti quando si presentano nuove spese
straordinarie. Il fiscalismo moderno, il cui perno è costituito dalle imposte sui
mezzi di sussistenza di prima necessità (quindi dal rincaro di questi), porta
perciò in sé il germe della progressione automatica. Dunque, il sovraccarico di
imposte non è un incidente, ma anzi è il principio” (MARX, 1980 [1867], p.819)27.
Marx rileva che: “il debito pubblico diventa una delle leve più energiche dell’accumulazione originaria: come con un colpo
di bacchetta magica, esso conferisce al denaro, che è improduttivo, la facoltà di procreare, e così lo trasforma in capitale,
senza che il denaro abbia bisogno di assoggettarsi alla fatica e al rischio inseparabili dall’investimento industriale e anche da
quello usuraio” (MARX, 1980 [1867], p.817). In altri termini, per Marx, l’emissione di titoli del debito pubblico produce un
duplice effetto positivo per i capitalisti: 1) Essa crea “una classe di gente oziosa, vivente di rendita”, la c.d. “aristocrazia
finanziaria”, favorendo una modalità di accumulazione basata sullo scambio di denaro contro denaro (D-D’) senza
l’intermediazione del processo produttivo (D-M-D’). Essendo il salario fissato al livello di sussistenza, non si ammette che i
lavoratori possano acquistare titoli di Stato; 2) Al tempo stesso, i maggiori profitti derivanti dalla spesa pubblica mettono le
imprese nella condizione – per loro favorevole – di essere meno dipendenti dal sistema bancario, ovvero di poter effettuare
investimenti attingendo ai propri fondi interni. Inoltre, per Marx, escludendo l’eventualità che il debito possa essere
monetizzato, il rimborso non può che avvenire mediante tassazione: Si osservi che l’aumento della spesa pubblica (e del
debito pubblico) accresce i profitti monetari, in assenza di aumento del saggio di plusvalore. Se ciò non produce effetti
inflazionistici (che potrebbero derivare dall’aumento del saggio di profitto), il salario reale resta costante. Data la relazione
inversa saggio di profitto/saggio del salario, si può ritenere che la spesa pubblica aumenti quando il saggio del profitto è al di
sotto del suo valore medio, ovvero, per converso, quando il salario è superiore al suo livello di sussistenza. Non essendo
ammissibile, per Marx, che il salario sia permanentemente collocato al di sotto del livello di sussistenza, si può ricavare un
criterio di sostenibilità del debito, in Marx, che consideri il salario come unico vincolo, ovvero l’indebitamento di uno Stato
non può spingersi oltre la necessità di rimborsarlo tramite un livello di tassazione dei salari che li ponga permanentemente al
di sotto del livello di sussistenza.
48
27
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Peraltro, l’espansione del debito pubblico tende ad associarsi a una compressione degli
investimenti, non per l’effetto di spiazzamento sopra richiamato, ma per la maggiore
convenienza, soprattutto da parte delle grandi imprese, a ottenere profitti via
speculazione, secondo una modalità di riproduzione capitalistica basata sulla crescente
finanziarizzazione, dunque senza l’intermediazione della produzione, attraverso scambi
di moneta contro moneta: il marxiano D-D’. Si tratta di un fenomeno che è stato
definito di “divenire rendita del profitto”, ovvero di crescente destinazione dei profitti
per attività speculative e, dunque, di non utilizzo dei profitti accumulati per investimenti
produttivi (cfr. MILBANK, PAST, 2015).
b) L’approccio postkeynesiano. In ambito postkeynesiano, si rileva che un’economia di
mercato deregolamentata tende spontaneamente a produrre compressione dei salari e
crescita delle diseguaglianze distributive. Ciò fondamentalmente accade per il superiore
potere contrattuale delle imprese nel mercato del lavoro (che peraltro si traduce nel loro
superiore potere contrattuale nella sfera politica) e alla connessa tendenza, e convenienza,
a competere riducendo i costi.
Viene fatto osservare che l’aumento delle diseguaglianze distributive riduce il tasso di
crescita (e l’occupazione) fondamentalmente attraverso due canali, che operano
rispettivamente sulla domanda aggregata e dal lato dell’offerta.
a) Dal lato della domanda. La riduzione della quota dei salari sul Pil determina una
caduta dei consumi e, a parità di investimenti pubblici e privati, della domanda aggregata
e del tasso di crescita. L’effetto è amplificato dal fatto che, di norma, le famiglie con
più basso reddito esprimono una propensione al consumo maggiore di quelle
con redditi più elevati. Vi è poi un nesso fra dinamica dei consumi e dinamica degli
investimenti, dal momento che la compressione dei consumi, derivante dalla riduzione
dei salari, tende a disincentivare gli investimenti privati, con effetti, anche in questo caso,
di segno negativo sulla domanda aggregata28.
b) Dal lato dell’offerta. La riduzione dei salari (e del costo di tutela dei diritti dei
lavoratori da parte delle imprese) pone le imprese nella condizione di competere
comprimendo i costi e, per questa via, disincentiva l’introduzione di innovazioni, con
effetti di segno negativo sul tasso di crescita della produttività (v. DUTT, 2012). I seguenti
ulteriori meccanismi amplificano questa dinamica. Primo: la riduzione della domanda
interna (imputabile, in primis, alla caduta dei salari e, dunque, dei consumi), in quanto
riduce i mercati di sbocco, riduce i profitti monetari, a danno innanzitutto delle imprese
che operano sul mercato interno, con conseguente compressione degli investimenti e del
tasso di crescita della produttività del lavoro. Secondo: la riduzione dei profitti monetari
riduce le fonti di autofinanziamento delle imprese e ne accresce il grado di dipendenza
dal settore bancario. La compressione dei margini di profitto, in quanto accresce il
rischio di insolvenza, induce le banche a ridurre l’offerta di credito generando, anche per
questa via, riduzione degli investimenti e della produttività.
Ciò sia a ragione dell’operare di effetti di accelerazione, sia perché una bassa domanda peggiora le aspettative
imprenditoriali. V. KALDOR (1957). Occorre chiarire che l’effetto qui descritto configura una modalità di crescita trainata da
aumenti salariali (wages-led) che può non verificarsi se l’aumento dei salari riduce i margini di profitto e gli investimenti, come
nel caso di modelli di crescita trainati dai profitti (profits-led regime). La letteratura su questi argomenti è estremamente vasta:
qui si rinvia al pionieristico contributo di BHADURI AND MARGLIN (1990).
49
28
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Con ogni evidenza, la moderazione salariale in atto, mentre può generare crescita
attraverso un aumento delle esportazioni per un singolo Paese, non può generare questo
effetto su scala globale, essendo il commercio internazionale un gioco a somma zero (cfr.
ONARAN AND GALANIS, 2013).
50
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Approfondimento II: Michael Kalecki e gli aspetti politici del pieno
impiego
I.1
Una solida maggioranza degli economisti è oggi dell’opinione che, anche in un sistema capitalista, il pieno impiego possa
essere assicurato da un programma di spesa del Governo, purché siano disponibili impianti adeguati ad impiegare tutta la
forza lavoro esistente, e purché sia possibile ottenere in cambio delle esportazioni forniture adeguate delle necessarie materie
prime che devono essere importate dall’estero.
Se il Governo garantisce investimenti pubblici (ad esempio costruisce scuole, ospedali e autostrade) o sostiene con sussidi il
consumo di massa (con gli assegni familiari, la riduzione delle imposte indirette, o con sussidi diretti a mantenere bassi i
prezzi dei beni di prima necessità) e se, in più, queste spese sono finanziate con un maggiore indebitamento e non con la
tassazione (che potrebbe avere un effetto negativo sugli investimenti e sui consumi privati) allora la domanda effettiva per
beni e servizi può essere incrementata fino al punto che corrisponde al raggiungimento del pieno impiego.
Si noti che questa spesa del Governo incrementa l’occupazione non solo direttamente ma anche indirettamente, dal
momento che i redditi più elevati che essa genera provocano a loro volta incrementi secondari della domanda di beni di
consumo e di investimento.
I.2
Ci si potrebbe chiedere dove il pubblico prenderà il denaro da prestare al Governo se non riduce i suoi investimenti e i suoi
consumi.
Per comprendere questo processo la cosa migliore, penso, è immaginare per un momento che il Governo paghi i suoi
fornitori con titoli di Stato.
I fornitori, in generale, non tratterranno questi titoli ma li metteranno in circolazione acquistando altri beni o servizi, e la
circolazione dei titoli di Stato continuerà finché alla fine essi giungeranno a persone che li tratterranno in quanto attività che
generano un reddito sotto forma di interesse.
In ogni periodo l’incremento totale dei titoli di Stato posseduti (temporaneamente o stabilmente) dalle persone e dalle
imprese sarà pari ai beni e ai servizi venduti al Governo.
Così quello che l’economia presta al Governo sono i beni e i servizi la cui produzione è “finanziata” dai titoli di Stato.
Nella realtà il Governo non paga i suoi acquisti con titoli di Stato ma con denaro, ma nello stesso tempo emette titoli e così
raccoglie denaro; e questo è equivalente al processo immaginario descritto prima.
Che cosa succede, tuttavia, se il pubblico non vuole assorbire tutto l’incremento dei titoli di Stato? Il pubblico alla fine
offrirà i titoli di Stato alle banche per avere in cambio del denaro (in contanti o sotto forma di depositi). Se le banche
accetteranno queste offerte, il tasso di interesse non varierà, altrimenti il prezzo dei titoli di Stato diminuirà, il che significa
che ci sarà un incremento del tasso di interesse, e questo incoraggerà il pubblico a detenere più titoli di Stato in rapporto ai
depositi.
Ne segue che il tasso di interesse dipende dalla politica delle banche, e in particolare dalla politica della Banca Centrale.
Se questa politica mira a mantenere il tasso di interesse a un certo livello questo obiettivo può facilmente essere raggiunto,
qualunque sia l’ampiezza del nuovo indebitamento del Governo.
Questa era ed è la situazione nell’attuale guerra. Nonostante l’astronomico deficit di bilancio, il tasso di interesse non ha
mostrato alcun aumento sin dall’inizio del 1940.
I.3
Si può obiettare che la spesa del Governo finanziata con un maggiore indebitamento causerà inflazione. A questo si può
replicare che la domanda effettiva creata dal Governo agisce come ogni altro incremento della domanda. Se la forza lavoro,
gli impianti e le materie prime di provenienza estera sono disponibili in eccesso, l’incremento della domanda è soddisfatto da
un incremento della produzione.
51
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Ma se il punto di pieno impiego delle risorse è raggiunto e la domanda effettiva continua a crescere, allora i prezzi si
alzeranno per equilibrare la domanda e l’offerta di beni e servizi.
(In una condizione di sovraimpiego delle risorse come quella della quale siamo testimoni nell’attuale economia di guerra, un
rialzo dei prezzi che generi inflazione è stato evitato solo fin tanto che il razionamento e la imposizione fiscale diretta sono
riusciti a far diminuire la domanda effettiva per i beni di consumo).
Ne segue che se l’intervento del Governo mira a raggiungere il pieno impiego ma si ferma prima che la domanda effettiva
aumenti oltre il segno corrispondente al pieno impiego, allora non c’è alcuna necessità di preoccuparsi dell’inflazione 1.
II
[Problemi politici del pieno impiego]
II.1
Quello che ho scritto sopra è un riassunto molto rozzo e incompleto della dottrina economica del pieno impiego. Ma, penso,
è sufficiente per dare al lettore un’idea dell’essenza della dottrina e per consentirgli così di seguire la discussione che seguirà
dei problemi politici che comporta il raggiungimento del pieno impiego.
Bisogna innanzitutto affermare che sebbene la massima parte degli economisti concordi oggi sul fatto che il pieno impiego
possa essere ottenuto con la spesa del Governo, questo non avveniva affatto fino a solo poco tempo fa.
Tra gli oppositori a questa dottrina c’erano (e ci sono ancora) stimati cosiddetti “esperti di economia” strettamente legati ai
settori bancario ed industriale.
Questo suggerisce che ci sia uno sfondo politico nella opposizione alla dottrina del pieno impiego anche se gli argomenti
avanzati sono di tipo economico.
Il che però non vuole dire che le persone che avanzano queste obiezioni di carattere economico, per quanto povere possano
essere, non credano in esse.
Ma una ignoranza ostinata è generalmente una manifestazione di sottostanti motivazioni politiche.
Ci sono, comunque, anche indicazioni più dirette del fatto che in gioco ci sia una questione politica di prima grandezza.
Nella grande depressione degli anni Trenta, le grandi imprese [big business] si opposero nello stesso modo a esperimenti
diretti ad incrementare l’occupazione con la spesa del Governo in tutti i paesi, tranne che nella Germania nazista.
Questo si vide chiaramente negli Stati Uniti (opposizione al New Deal), in Francia (l’esperimento di Blum) e anche in
Germania prima di Hitler.
Questo atteggiamento non è facile da spiegare.
Chiaramente una produzione e una occupazione più elevate generano benefici non solo per i lavoratori ma anche per
gli imprenditori, perché i loro profitti aumentano. E la politica di pieno impiego delineata sopra non usurpa i profitti
perché non comporta alcuna tassazione aggiuntiva.
Gli imprenditori durante una crisi economica non vedono l’ora di un nuovo boom; perché non dovrebbero accettare con
gioia quella ripresa economica “artificiale” che il Governo è in grado di offrire loro?
E’ una questione difficile e affascinante che intendo affrontare in questo articolo.
Le ragioni della opposizione dei “leader dell’industria” al pieno impiego ottenuto con la spesa del Governo possono essere
suddivise in tre categorie:
i)
L’avversione contro l’interferenza, in quanto tale, del Governo nel problema dell’occupazione;
ii)
L’avversione contro la destinazione della spesa del Governo (investimenti pubblici e sussidi ai consumi);
iii) L’avversione contro i mutamenti sociali e politici provocati dal mantenimento del pieno impiego.
Esamineremo nel dettaglio ciascuna di queste tre categorie di obiezioni contro una politica espansiva condotta dal Governo.
II.2
52
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Affronteremo innanzitutto la riluttanza dei “capitani d’industria” ad accettare l’intervento del Governo nel campo
dell’occupazione.
Ogni ampliamento dell’attività dello Stato è vista dal “mondo degli affari” [business] con sospetto, ma la creazione di posti
di lavoro con la spesa pubblica presenta un aspetto speciale che rende l’opposizione contro di essa particolarmente intensa.
In un sistema di laisser-faire il livello dell’occupazione dipende grandemente dal cosiddetto stato della fiducia [state of
confidence].
Se questo si deteriora, gli investimenti privati diminuiscono, e questo provoca una caduta sia della produzione che
dell’occupazione (sia direttamente che attraverso l’effetto secondario della caduta dei redditi sui consumi e sugli investimenti)
Questo dà ai capitalisti un potente controllo indiretto sulla politica del Governo: tutto quello che può scuotere lo stato della
fiducia deve essere attentamente evitato perché causerebbe una crisi economica.
Ma una volta che il Governo apprende il trucco di incrementare l’occupazione con i suoi stessi acquisti, questo potente
strumento di controllo perde la sua efficacia.
Quindi i deficit di bilancio necessari per portare a termine l’intervento del Governo devono essere considerati pericolosi.
La funzione sociale della dottrina di una “finanza solida” [sound finance] è quella di rendere il livello dell’occupazione
dipendente dallo “stato della fiducia”.
II.3
L’avversione degli uomini d’affari [business leaders] contro una politica di spesa del Governo diventa ancora più acuta
quando giungono a considerare gli obiettivi per i quali il denaro dovrebbe essere speso: investimenti pubblici e sostegno al
consumo di massa.
I principi economici dell’intervento del Governo richiedono che gli investimenti pubblici siano confinati a oggetti che non
competono con i mezzi di produzione delle imprese private (ad esempio ospedali, scuole, autostrade, etc.).
Altrimenti la profittabilità degli investimenti privati potrebbe essere diminuita e l’effetto positivo degli investimenti pubblici
sull’occupazione controbilanciato dall’effetto negativo del declino degli investimenti privati.
Questa concezione si adatta molto bene alle richieste degli uomini d’affari.
Ma l’ambito degli investimenti pubblici di questo tipo è piuttosto ristretto, e c’è il pericolo che il Governo, nel perseguire
questa politica, possa alla fine essere tentato di nazionalizzare i trasporti o i servizi idrici ed elettrici [public utilities] così da
acquisire una nuova sfera di intervento nella quale poter investire. 2
Ci si potrebbe quindi aspettare che gli uomini d’affari e i loro esperti preferiscano un sostegno dei consumi di massa (per
mezzo di assegni familiari, sussidi per calmierare i prezzi dei beni di prima necessità, etc.) agli investimenti pubblici; dal
momento che sussidiando i consumi il Governo non si imbarcherebbe in nessun tipo di “impresa”.
In pratica, tuttavia, questo non accade.
Al contrario, sussidi ai consumi di massa sono avversati molto più violentemente da questi “esperti” che non gli investimenti
pubblici.
Perché qui è in gioco un principio “morale” della massima importanza.
I principi fondamentali dell’etica capitalista richiedono che “tu ti guadagnerai il tuo pane con il sudore” - a meno che non
capiti che tu sia ricco.
II.4
Abbiamo considerato le ragioni politiche dell’opposizione contro la politica di creare occupazione con la spesa del Governo.
Ma anche se questa opposizione fosse superata - come potrebbe benissimo essere superata sotto la pressione delle masse il mantenimento del pieno impiego causerebbe cambiamenti sociali e politici che darebbero un nuovo impulso
all’opposizione degli uomini d’affari.
Certamente, in un regime di permanente pieno impiego, il licenziamento cesserebbe di giocare il suo ruolo come strumento
di disciplina [disciplinary measure].
53
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
La posizione sociale del capo sarebbe minata e la fiducia in se stessa e la coscienza di classe della classe operaia
aumenterebbero.
Scioperi per ottenere incrementi salariali e miglioramenti delle condizioni di lavoro creerebbero tensioni politiche.
E’ vero che i profitti sarebbero più elevati in un regime di pieno impiego di quanto sono in media in una condizione
di laisser-faire; e anche l’incremento dei salari risultante da un più forte potere contrattuale dei lavoratori è più probabile che
incrementi i prezzi anziché ridurre i profitti, e danneggi così solo gli interessi dei rentier.
Ma la “disciplina nelle fabbriche” e la “stabilità politica” sono più apprezzate dagli uomini d’affari dei profitti.
Il loro istinto di classe gli dice che un durevole pieno impiego non è sano dal loro punto di vista e che la disoccupazione è
una parte integrante di un normale sistema capitalista.
III
[Fascismo e pieno impiego]
III.1
Una delle importanti funzioni del fascismo, come caratterizzato dal sistema nazista, è stata quella di rimuovere le obiezioni
dei capitalisti al pieno impiego.
L’avversione contro la spesa del Governo in quanto tale è superata sotto il fascismo dal fatto che la macchina dello Stato è
sotto il controllo diretto di una stretta alleanza tra le grandi imprese e i gerarchi fascisti.
La necessità del mito di una “finanza solida”, che serviva ad impedire al Governo di provocare una crisi di fiducia con la sua
spesa, viene meno.
In una democrazia non si sa come sarà il prossimo Governo. Sotto il fascismo non c’è un prossimo Governo..
L’avversione contro la spesa del Governo, sia per investimenti pubblici che per sostenere i consumi, è superata dal
concentrare la spesa del Governo sugli armamenti.
Infine, la “disciplina nelle fabbriche” e la “stabilità politica” in una condizione di pieno impiego sono mantenute dal “nuovo
ordine”, che spazia dalla soppressione dei sindacati ai campi di concentramento.
La pressione politica sostituisce la pressione economica della disoccupazione.
III.2
Il fatto che gli armamenti costituiscano la spina dorsale della politica di pieno impiego fascista ha una profonda influenza
sulle sue caratteristiche economiche.
Una politica di riarmo su grande scala è inseparabile dall’espansione delle forze armate e dalla predisposizione dei piani per
una guerra di conquista. Essa inoltre induce una politica di riarmo competitiva da parte degli altri paesi.
Questo fa sì che l’obiettivo principale della spesa si sposti gradualmente dal pieno impiego al raggiungimento della massima
efficacia del riarmo. Di conseguenza l’occupazione diviene “troppo piena”; non solo la disoccupazione è abolita ma prevale
un’acuta scarsità di forza lavoro.
Colli di bottiglia si manifestano dappertutto e devono essere affrontati con l’istituzione di tutto un insieme di strumenti di
controllo.
Un’economia di questo tipo ha molte delle caratteristiche di una “economia pianificata”, ed è talvolta paragonata,
dimostrando una certa ignoranza, al socialismo.
Comunque è necessario che questo tipo di “pianificazione” appaia ogni volta che un’economia si pone un certo elevato
obiettivo produttivo in un determinato settore, quando diventa una “economia con un obiettivo” [target economy] della
quale la “economia per l’armamento” [armament economy] è un caso particolare.
Una “economia per l’armamento” comporta in particolare la riduzione dei consumi, se confrontati con quelli che si
potrebbero avere in una condizione di pieno impiego.
54
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Il sistema fascista inizia con il superamento della disoccupazione, si sviluppa in una “economia per l’armamento” della
scarsità, e termina inevitabilmente nella guerra.
IV
[Democrazia capitalista e pieno impiego]
IV.1
Quale sarà il risultato pratico dell’opposizione al “pieno impiego ottenuto con la spesa del Governo” in una democrazia
capitalista?
Proveremo a rispondere a questa domanda sulla base delle ragioni di questa opposizione esposte nella sezione II.
Abbiamo argomentato che ci possiamo aspettare l’opposizione dei “leader dell’industria” su tre piani:
i)
L’opposizione di principio contro la spesa del Governo basata sul deficit di bilancio;
ii)
L’opposizione contro il fatto che questa spesa sia diretta o verso gli investimenti pubblici - che potrebbero prefigurare
l’intrusione dello Stato in nuovi campi dell’attività economica - o verso il sostegno ai consumi di massa;
iii)
L’opposizione contro il mantenimento della piena occupazione e non contro una semplice azione diretta a prevenire il
verificarsi di depressioni economiche profonde e prolungate.
Ora, deve essere riconosciuto il fatto che il tempo in cui gli “uomini d’affari” potevano opporsi a qualsiasi tipo di
intervento del Governo diretto ad alleviare una crisi economica è ormai passato.
Tre fattori hanno contribuito a questo:
a)
Proprio il pieno impiego durante questa guerra;
b)
Lo sviluppo della dottrina economica del pieno impiego;
c)
In parte come risultato dei precedenti due fattori, il fatto che lo slogan “mai più disoccupazione” [“Unemployment never
again”] è oggi profondamente radicato nella coscienza delle masse.
Questa condizione si è riflessa nelle dichiarazioni recenti dei “capitani d’industria” e dei loro esperti.
La necessità che “qualcosa deve essere fatto nella crisi” è condivisa; ma la battaglia continua, in primo luogo, su “ cosa deve
essere fatto nella crisi” (ad esempio su quale deve essere la direzione dell’intervento del Governo), e in secondo luogo, sul
fatto che “deve essere fatto solo nella crisi” (ad esempio semplicemente per alleviare la crisi piuttosto che non per assicurare
un permanente pieno impiego).
IV.2
Nelle discussioni correnti di questi problemi emerge continuamente l’idea di contrastare le fasi di recessione economica
stimolando gli investimenti privati.
Questo può essere fatto diminuendo il tasso di interesse, riducendo le imposte sui redditi, o sussidiando direttamente gli
investimenti privati in un modo o nell’altro.
Che questa idea debba essere attraente per il “mondo degli affari” non è sorprendente. L’ imprenditore rimane il mezzo
attraverso il quale l’intervento è condotto. Se egli non prova fiducia per la situazione politica non potrà essere comprato
affinché investa. E l’intervento non comporta né che il Governo “giochi” con gli investimenti (pubblici) né che “sprechi
denaro” sussidiando i consumi.
Si può mostrare, tuttavia, che lo stimolo degli investimenti privati non fornisce un metodo adeguato per prevenire il
verificarsi di una disoccupazione di massa.
Ci sono due alternative da considerare qui:
(a)
Il tasso di interesse o l’imposta sui redditi (o entrambi) vengono ridotti nettamente nella crisi e incrementati nel boom.
55
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
In questo caso sia il periodo che l’ampiezza del ciclo economico saranno ridotti, ma l’occupazione può essere lontana dal
pieno impiego non solo nelle fasi di recessione ma anche in quelle di espansione economica, ad esempio il tasso di
disoccupazione medio può essere considerevole, anche se le sue fluttuazioni saranno meno marcate;
(b)
Il tasso di interesse o l’imposta sui redditi vengono ridotti in una crisi ma non vengono incrementati nella successiva fase
di espansione economica.
In questo caso la fase espansiva dell’economia durerà più a lungo ma deve terminare in una nuova crisi: una diminuzione del
tasso di interesse o dell’imposta sui redditi non eliminano di certo le forze che causano fluttuazioni cicliche in una economia
capitalista.
Nella nuova fase recessiva sarà necessario ridurre di nuovo o il tasso di interesse o le imposte sui redditi, e cosi via.
Così, in un futuro non troppo remoto, il tasso di interesse dovrebbe diventare negativo e l’imposta sui redditi dovrebbe
essere sostituita con sussidi ai redditi.
Lo stesso risultato si otterrebbe se si tentasse di mantenere il pieno impiego stimolando gli investimenti privati: il tasso di
interesse e le imposte sui redditi dovrebbero essere ridotte continuamente.
In aggiunta rispetto a questa debolezza fondamentale del combattere la disoccupazione stimolando gli investimenti privati,
c’è una difficoltà pratica.
La reazione degli imprenditori alle misure descritte sopra è incerta.
Se la recessione è accentuata gli imprenditori possono assumere una visione estremamente pessimistica del futuro, e la
riduzione del tasso di interesse o delle imposte sui redditi può avere perciò per un lungo periodo di tempo un effetto piccolo
o nullo sugli investimenti, e così sul livello della produzione e dell’occupazione.
IV.3
Anche coloro che sono a favore di uno stimolo degli investimenti privati per contrastare una fase di recessione economica
spesso non fanno affidamento esclusivamente su di esso ma immaginano che debba essere associato ad investimenti
pubblici.
Al momento sembra che i “leader dell’economia” e i loro esperti (o almeno parte di essi) tendenzialmente
accetterebbero come estremo rimedio investimenti pubblici finanziati con un maggiore indebitamento, come strumento
per alleviare le fasi di recessione economica.
Essi appaiono comunque ancora fortemente contrari alla creazione di occupazione con sussidi ai consumi, e
al mantenimento della piena occupazione.
Questo stato delle cose è forse sintomatico del regime economico futuro delle democrazie capitaliste.
Nelle fasi di recessione economica, o sotto la pressione delle masse o anche senza di essa, investimenti pubblici finanziati
con un maggiore indebitamento saranno decisi per prevenire il verificarsi di una disoccupazione di massa.
Ma è probabile che eventuali tentativi di applicare questo metodo, compiuti per mantenere l’alto livello di occupazione
raggiunto nella fase successiva di espansione economica, incontrerebbero una forte opposizione da parte dei “leader
dell’economia”.
Come ho già detto, un durevole pieno impiego non è affatto di loro gradimento.
I lavoratori “sfuggirebbero di mano” e i “capitani d’industria” sarebbero ansiosi di “dargli una lezione”.
Inoltre, l’incremento dei prezzi in una fase di espansione economica avviene a svantaggio dei piccoli e grandi rentier e li rende
“stanchi del boom economico”.
In questa situazione è probabile che si formi un potente blocco sociale tra gli interessi delle grandi imprese e quelli dei rentier,
e che essi troverebbero più di un economista disposto a dichiarare che la situazione sia manifestamente non sostenibile.
La pressione di tutte queste forze, e in particolare delle grandi imprese [big business] - di norma influenti nei ministeri quasi sicuramente indurrebbe il Governo a ritornare alla politica ortodossa di riduzione del deficit di bilancio.
Seguirebbe quindi una recessione economica nella quale la politica di spesa del Governo tornerebbe in auge.
56
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Questo tipo di ciclo economico-politico [political business cycle] non è solo una congettura; qualcosa di molto simile è
accaduto negli Stati Uniti nel biennio 1937-1938 .
La fine della fase economica espansiva nella seconda metà del 1937 fu davvero dovuta alla drastica riduzione del deficit di
bilancio. D’altra parte, nella fase acuta di recessione economica che seguì, il Governo prontamente ritornò a una politica di
spesa.
Il regime del “ciclo economico-politico” sarebbe una restaurazione artificiale della condizione esistente nel capitalismo
dell’Ottocento.
Il pieno impiego sarebbe raggiunto solo all’acme della fase economica espansiva, ma le fasi di contrazione economica
sarebbero relativamente moderate e di breve durata.
V
[Compiti dei progressisti]
V.1
Un progressista dovrebbe essere soddisfatto di un regime del “ciclo economico-politico” come quello descritto nella sezione
precedente?
Penso che dovrebbe opporsi per due motivi:
i)
ii)
Perché non assicura un durevole pieno impiego;
Perché l’intervento del Governo è limitato agli investimenti pubblici e non si estende al sostegno ai consumi.
Quello che le masse oggi domandano non è la mitigazione delle fasi di recessione economica ma la loro totale abolizione.
Né il più pieno impiego delle risorse risultante dovrebbe essere diretto a investimenti pubblici non desiderati solo per fornire
lavoro.
Il programma di spesa del Governo dovrebbe essere diretto a investimenti pubblici solo nella misura in cui questi
investimenti sono realmente necessari.
Il resto della spesa del Governo necessaria per mantenere il pieno impiego dovrebbe essere diretta a sostenere i consumi
(attraverso gli assegni familiari, le pensioni di vecchiaia, la riduzione delle imposte indirette, i sussidi per ridurre i prezzi dei
beni di prima necessità).
Gli oppositori a questo tipo di spesa del Governo dicono che il Governo non avrà allora nulla da mostrargli in cambio dei
loro soldi. La risposta a questa obiezione è che la contropartita di questa spesa sarà un più elevato livello di vita delle masse.
Non è questo il fine di tutta l’attività economica?
V.2
Il “capitalismo del pieno impiego” [full employment capitalism] dovrà, naturalmente, sviluppare nuove istituzioni sociali e
politiche che rifletteranno l’accresciuto potere della classe operaia.
Se il capitalismo riuscirà ad adattarsi al pieno impiego allora in esso sarà stata incorporata una riforma radicale.
Altrimenti, si sarà dimostrato un sistema obsoleto che deve essere abbandonato.
Ma forse la battaglia per il pieno impiego condurrà al fascismo?
Forse il capitalismo si adeguerà al pieno impiego in questo modo?
Questo sembra estremamente improbabile.
Il fascismo è sorto in Germania in una condizione di tremenda disoccupazione e si è mantenuto al potere assicurando quel
pieno impiego che il capitalismo non era riuscito a garantire.
La battaglia delle forze progressiste per il pieno impiego è nello stesso tempo un modo per prevenire la rinascita del
fascismo
57
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Note: Questo articolo corrisponde approssimativamente a una conferenza tenuta presso la Marshall
Society a Cambridge nella primavera del 1942.
1
Un altro problema, di natura un po’ più tecnica, è quello del debito pubblico. Se il pieno impiego è mantenuto dalla spesa del Governo
finanziata con un maggiore indebitamento, il debito pubblico crescerà continuamente. Questo comunque non comporta alcun problema
per la produzione e l’occupazione, se gli interessi sul debito sono finanziati con una imposta patrimoniale annuale.
Il reddito corrente, dopo il pagamento dell’imposta patrimoniale, sarà minore per alcuni capitalisti e maggiore per altri rispetto a quello che
sarebbe stato se il debito pubblico non fosse stato incrementato, ma il loro reddito complessivo rimarrà uguale e il loro consumo
aggregato probabilmente non varierà significativamente.
Inoltre, l’incentivo ad investire in capitale fisso non è modificato da una imposta patrimoniale perché essa è applicata ad ogni tipo di
ricchezza. Sia che un capitale sia detenuto in contanti o in titoli di Stato o investito nella costruzione di una fabbrica, su di esso si applica la
stessa imposta patrimoniale e così il vantaggio comparato di un’alternativa rispetto all’altra rimane immutato.
E gli investimenti finanziati con debiti non sono chiaramente colpiti da un’imposta patrimoniale perché non costituiscono un incremento
della ricchezza dell’imprenditore che ha investito.
Così né i consumi né gli investimenti dei capitalisti sono influenzati da un incremento del debito pubblico, se gli interessi su di esso sono
finanziati con una imposta patrimoniale annuale.
2
Si deve notare qui che gli investimenti in un settore nazionalizzato possono contribuire alla soluzione del
problema della disoccupazione solo se sono affrontati con principi differenti da quelli adottati dalle imprese private.
Il Governo deve accontentarsi di un tasso di rendimento netto inferiore a quello delle imprese private, o deve deliberatamente pianificare i
suoi investimenti
in modo tale da realizzarli al momento giusto per mitigare gli effetti delle crisi economiche.
58
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
5. Il capitale umano
5.1 Che cosa è il capitale umano
Per capitale umano si intende l’insieme delle conoscenze generali e specifiche delle quali
un individuo e/o un sistema economico dispone. Esso può essere riguardato sotto il
duplice aspetto di investimento – nel senso che arreca (o può arrecare) benefici futuri (in
termini di salario e status) a fronte dei costi attuali per l’istruzione – e di consumo – nel
senso che, per alcune forme di istruzione, l’istruzione in quanto tale genera utilità.
Nella letteratura contemporanea sul capitale umano, vengono distinte le forme che esso
può assumere dalle sue modalità di acquisizione, secondo quanto segue (cfr.
PRAUSSELLO, MARENCO, 1996):
a) Le forme di capitale umano vengono ricondotte al capitale umano “generico”
(istruzione generale: il conoscere) e capitale umano “specifico” o “tecnico” (il saper fare).
b) Le principali modalità di acquisizione sono: il learning by schooling (l’istruzione scolastica) e
il learning by doing (l’imparare facendo)29.
La prima distinzione è particolarmente rilevante giacché ad essa è collegata l’ulteriore
distinzione fra capitale umano trasferibile e capitale umano non trasferibile. E’ trasferibile il
sapere generale (da un’impresa a un’altra, tramite il trasferimento di lavoratori), ed è non
trasferibile (o molto meno trasferibile) il sapere specifico. Sulla base di questa
constatazione – la trasferibilità implica la natura di bene pubblico da attribuirsi al capitale
umano generico - si giustifica la necessità dell’intervento pubblico per l’offerta di istruzione
generale (cfr. PRAUSSELLO, MARENCO, 1996). Le imprese private non avrebbero, infatti,
convenienza a fornire ai propri dipendenti conoscenze generali, che questi potrebbero
utilizzare, se licenziati e assunti da altre imprese, a beneficio di imprese concorrenti. Il
capitale umano specifico è non trasferibile, e lo è tanto più quanto più è specifico.
L’abilità acquisita nello svolgimento di una mansione specifica all’impresa accresce il
potere contrattuale del lavoratore, giacché il suo eventuale licenziamento (o le sue
dimissioni) obbligherebbero l’impresa a sostenere costi di qualificazione del nuovo
assunto, tanto maggiori quanto maggiore è la specificità delle conoscenze e abilità
richieste.
Sulla base di queste considerazioni, è opportuno soffermarsi su due aspetti in larga
misura distinti del tema trattato: il dibattito su capitale umano e mercato del lavoro e
quello su capitale umano e crescita economica.
5.2 Capitale umano e mercato del lavoro
In questa sezione svengono brevemente presentati i principali contributi teorici sul
ruolo del capitale umano nel mercato del lavoro. Le teorie economiche riconoscono
infatti l’importanza delle diverse forme di competenze e conoscenze che consentono di
accrescere il capitale umano: secondo BECKER (1964) la produttività del lavoro e
conseguentemente la sua retribuzione dipendono dalle caratteristiche del lavoratore
29
A ciò può aggiungersi il learning by interacting risultante dalla divisione del lavoro. Si veda ANTONELLI (2003, P.10).
59
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
intese come talento, istruzione ed esperienza (teoria del capitale umano); secondo
COLLINS (1979) 30 invece poiché l’istruzione ha lo scopo di fornire solo le “credenziali”
(teoria del c.d. credentialism) non sarebbero rilevanti lo sviluppo di particolari competenze
dentro un programma di istruzione, sebbene non possa escludersi che la stessa selezione
possa avvenire proprio sulla base dei livelli e dei tipi di competenze possedute; secondo
THUROW (1975) e la teoria del “job competition model” 31 invece le caratteristiche del
lavoratore avrebbero un qualche rilievo solo nel momento iniziale dell’assunzione, in
quanto un buon livello di istruzione iniziale riduce i costi della formazione successiva,
mentre sarebbero le caratteristiche del lavoro a pesare nella spiegazione della variabilità
dei salari; MINCER (1974) (32) rappresenta una sintesi rispetto alle posizioni precedenti
ed ipotizza che il salario possa essere spiegato sia attraverso il capitale umano acquisito
con istruzione e formazione, sia attraverso le caratteristiche del lavoro e del contesto
socio economico. Nelle analisi di SATTINGER (1993)(teoria dell’assignment) le caratteristiche
di un individuo, tra cui il capitale umano acquisito con istruzione e formazione, possono
o meno contare a seconda dello specifico contesto lavorativo, ipotizzando pertanto che
sia la corrispondenza tra quanto richiesto dall’ambiente lavorativo e quanto posseduto
dal lavoratore in termini di competenze e conoscenze a determinare il vantaggio o lo
svantaggio rispetto all’impiego in certi ambiti. Secondo questa impostazione l’incontro
tra domanda e offerta dipende dalle caratteristiche del lavoratore (come nella teoria del
capitale umano di Becker) e del lavoro (come dell’approccio c.d. del Job Competition
Model) con particolare riferimento alle competenze possedute rispetto a quelle richieste.
Complessivamente si è assistito ad una crescita degli studi tesi ad analizzare la relazione
tra capitale umano e mercato del lavoro: si tratta di studi che cercano di comprendere il
ruolo e l’effetto che le diverse tipologie di competenze e conoscenze possono avere sul
successo individuale in ambito lavorativo.
La diatriba in letteratura tra la necessità di equipaggiare il lavoratore di un capitale umano
in cui prevalgano competenze generiche o generali utili in ogni tipo di lavoro (NIJHOF,
STREUMAR 1998) o le competenze specifiche utili per certe professioni e non per altre
(THOMPSON E MURPHY, 1987; NORDHAUG 1993) non consente di giungere a una
qualche conclusione. Secondo BISHOP (1995,) per esempio l’istruzione superiore e
universitaria dovrebbe concentrarsi su competenze e conoscenze specifiche piuttosto
che accademiche, osservando che la produttività derivi più da “abilità sociali” (come
buone abitudini lavorative e attitudini individuali) e da competenze specifiche all’ambito
del proprio lavoro, che non da abilità di lettura, scrittura e matematica (conoscenze
accademiche)
Secondo invece altri autori, come NIJOHOF SREUMER, (1998); DUNCAN, (1968) BOWEN
(1977, pag. 89) invece sono più importanti competenze di tipo generale per saper
interagire con altri nel mondo del lavoro perché le competenze generali sono meno
suscettibili di obsolescenza (BARTEL E SICHERMAN 1998, pag.718). A questo riguardo
alcuni consigliano di investire di più nella formazione sul posto di lavoro e meno
nell’educazione formale precedente all’entrata nel mondo del lavoro, ma altri osservano
30
COLLINS (1979).
THUROW (1975).
32
MINCER (1974).
31
60
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
che proprio l’educazione formale è quella in grado di fornire le basi per far fronte più
efficacemente ai cambiamenti tecnologici.
Il dibattito economico si è concentrato largamente sulle qualità di capitale umano (sul
problema del tipo di competenze e conoscenze ovvero le caratteristiche del capitale
umano e sulle misure) in cui valga la pena investire per favorirei risultati a livello
individuale (reddito e occupazione) o aggregato (crescita e sviluppo economico) e anche
sulla dinamica del processo di acquisizione del capitale umano. In generale Heckman
afferma che la creazione del capitale umano è un processo dinamico per cui il suo livello
ad un determinato istante influisce sulle possibilità di successo nel mondo del lavoro, ma
anche sulla possibilità di acquisizione di ulteriore capitale umano (learning begets learning) 33.
HEIJKE et al. (2002) nell’ambito di una ricerca volta a verificare come le diverse tipologie
di competenze possono avere effetti sul successo individuale in ambito lavorativo
secondo l’impostazione generale dell’ assignment theory, sembrerebbero confermare da un
lato, l’importanza delle competenze accademiche in quanto propedeutiche
all’acquisizione delle competenze manageriali post laurea le quali sarebbero una delle
maggiori determinanti del livello salariale. 34 Questi risultati non solo sottolineano
l’importanza ed il ruolo delle diverse tipologie di competenze e conoscenze ma
ribadiscono anche la necessità di guardare alla creazione del capitale umano come ad un
processo dinamico in cui, attraverso momenti alterni di istruzione formale ed esperienza
lavorativa, le diverse tipologie di competenze e conoscenze entrano in gioco per favorire
l’acquisizione di livelli più elevati e/o di tipologie differenti di CC.
5.3 Capitale umano e probabilità di assunzione : education o
relazioni sociali?
La base teorica di riferimento è data dalla teoria delle informazioni asimmetriche, in base
alla quale – nel momento della stipula del contratto – il “principale” (il datore di lavoro)
non conosce né ciò che l’”agente” (il lavoratore) è in grado di fare (la c.d. selezione
avversa), né ciò che vuole fare (il c.d. rischio morale). In tali circostanze, il datore di
lavoro fronteggia il seguente problema di scelta: minimizzare le asimmetrie informative
attraverso procedure di selezione estremamente accurate, ma estremamente costose, e
tanto più costose quanto più accurate (SALOP and SALOP, 1976); “fidarsi” del segnale
costituito dal titolo di studio, se e in quanto questo è indicatore di affidabilità 35 ed
L’evidenza empirica è ottenuta analizzando la relazione tra tasso di scolarizzazione nella fascia 15-19 nel 2000 in alcuni
Paesi del mondo, il livello di conoscenze di matematica nell’8° grado (quindi a 12-13 anni) rilevato dell’indagine TIMSS nel
1999 ed il reddito pro-capite per l’anno 2002 in 21 Paesi. La relazione mostra che il tasso di scolarizzazione aumenta
all’aumentare del livello di conoscenza in matematica e del livello di reddito, che a loro volta appaiono molto correlati tra
loro come nelle funzioni di Coleman secondo cui il livello dell’apprendimento degli studenti dipende dal livello socioeconomico delle famiglie di provenienza; la dinamica del capitale umano risente ovviamente quindi di altri fattori fra cui le
condizioni di reddito(HECKMAN 2003)
34 Gli autori giungono a questa conclusione mettendo in relazione tre tipi di competenze rilevanti, quelle accademiche che si
apprenderebbero in ambito scolastico, quelle specifiche che si apprenderebbero parte in ambito scolastico e parte nel
mercato del lavoro; competenze manageriali che si apprenderebbero prevalentemente in ambito lavorativo con tre aspetti
fondamentali, il livello del salario, il livello di competenze manageriali possedute al momento dell’intervista ed il fatto di
lavorare in un settore coerente con gli studi svolti.
35 Intendendo per affidabilità essenzialmente il rispetto delle norme. La funzione moralizzatrice dell’istruzione è stata
ripetutamente teorizzata nella storia del pensiero economico. Sia qui sufficiente richiamare Alfred Marshall e particolarmente
Economics of industry, pubblicato nel 1879 con la moglie Mary Paley.
61
33
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
efficienza. Evidentemente, se il titolo di studio è ritenuto un segnale credibile, il problema
generato dall’esistenza di asimmetrie informative cessa di esistere nel momento della
stipula del contratto. In questo ambito teorico, si ritiene che il titolo di studio altro non
sia se non un “certificato” di affidabilità ed efficienza del potenziale assunto (v. SPENCE,
1973) e che, dunque, l’accumulazione di capitale umano – mentre, a livello individuale,
accresce la probabilità di trovare impiego – sul piano aggregato, non determinando
incrementi di produttività, risulta ininfluente ai fini della crescita economica (il c.d.
credenzialismo)36. Si osservi che, attenendosi a questa ipotesi, in un mercato del credito
imperfetto, poiché le credenziali vengono acquisite prevalentemente dagli individui con
reddito più alto, le mansioni che richiedono maggiori competenze vengono attribuite ai
lavoratori più ricchi e non necessariamente più abili. Altri autori37 – che si riconoscono
nella c.d. teoria della selezione - rilevano, per contro, che l’acquisizione di capitale umano
rende effettivamente i lavoratori più produttivi e li avvantaggia nella competizione per
l’acquisizione di posti di lavoro offerti maggiormente remunerativi e maggiormente
gratificanti (e/o maggiormente conformi rispetto alle abilità acquisite). In tal senso,
l’accumulazione di capitale umano è privatamente e socialmente conveniente: essa genera, da
un lato, incremento dei profitti e più elevati livelli salariali per coloro che effettuano tale
investimento; dall’altro, promuove la crescita economica, per il tramite dell’aumento
della produttività del lavoro. THUROW (1975) rileva che l’istruzione in quanto tale non
accresce in via diretta la produttività del lavoro, ma genera maggiore attitudine
all’apprendimento: in tal senso, tanto maggiore è il livello di conoscenze acquisite
attraverso il learning by schooling, tanto maggiore è l’efficienza nell’utilizzo del learning by
doing38.
Un indirizzo critico rispetto a quello ora descritto fa riferimento alla letteratura di
ispirazione “radicale”. Innanzitutto, viene posta in discussione l’idea che il capitale
umano – nel capitalismo – possa essere riguardato soltanto dal punto di vista degli effetti
quantitativi che la sua accumulazione genera (in termini di occupazione e produttività).
Ciò che, per contro, maggiormente conta è la qualità dell’istruzione offerta. Dal punto di
vista metodologico, questi economisti rilevano che, nell’analisi della teoria del capitale
umano di matrice neoclassica, vengono ignorati alcuni aspetti importanti circa il ruolo
che svolgono i fattori socio-ambientali nel determinare l’ammontare e la redditività
dell’istruzione, e vengono trascurati i vincoli che alcuni soggetti incontrano nell’accesso
all’istruzione e/o all’impiego. RENSHAW (1966), in particolare, individua i seguenti
ostacoli:
a) ostacoli di natura finanziaria (vincoli di bilancio eccessivamente stringenti per
sostenere, per esempio, le spese durante la fase di job-search);
b) ostacoli lagati all’“insufficienza” delle loro reti delle relazioni sociali39;
Si riconosce altresì che compito dell’istruzione è auto segnalare al singolo le proprie capacità.
Per una rassegna, si veda JOHNES (2000).
38 Tuttavia, a fronte di questo rilievo, si può osservare che – in settori produttivi caratterizzati da modesti investimenti in
ricerca e sviluppo e dove, quindi, le skill richieste sono basse – anche se lo svolgimento di date mansioni richiederebbe
l’utilizzo di lavoratori laureati, le imprese possono ricorrere a diplomati, i quali – se non altro per le minori spese sostenute
nella fase di istruzione – possono ottenere salari più bassi rispetto ai potenziali concorrenti laureati.
39
“Gli studenti universitari che incontrano maggiori difficoltà sono in genere quelli che mancano di conoscenze altolocate e
relazioni familiari e sociali su cui fare appello dopo la laurea (…i ricavi che un laureato può attendersi dall’istruzione sono
probabilmente anche funzione di fattori diversi dalle capacità personali e dal grado di formazione. L’agiatezza e la posizione
sociale della famiglia possono essere di grande aiuto nella ricerca di un buon impiego)”. RENSHAW (1966, p.58). In altri
62
36
37
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
c) ostacoli connessi all’accesso agli ordini professionali40;
d) scarsità delle informazioni, a sua volta, almeno parzialmente riconducibile alla carenza
di reti relazionali.
Nell’ambito di questo orientamento, è rilevante – e ampiamente discusso - il contributo
di Bowles e Gintis. Secondo questi autori (in particolare, BOWLES, GINTIS, 1976),
compito dell’istruzione è principalmente quello di selezionare gli individui aventi
caratteristiche comportamentali rispondenti alla necessità capitalistica di conservazione
del rapporto di subordinazione del lavoro al capitale. Il sistema scuola è fondato sulla
riproduzione di meccanismi di autorità e controllo tipici delle forme capitalistiche di
produzione. La “trasmissione del sapere” risponde, così, alla stessa logica che muove la
produzione capitalistica.
5.4 Capitale umano e crescita economica: la teoria della crescita
endogena, ovvero i fattori dal lato dell’offerta della crescita economica .
La teoria della crescita endogena (si vedano LUCAS, 1988; ROMER, 1989) pone l’accento
sul ruolo della conoscenza nel generare processi di crescita. L’aumento del sapere e del
saper fare – si ritiene – aumenta l’output, sostanzialmente per l’operare di due meccanismi:
in primo luogo, esso (in primis il saper fare) rende i lavoratori più specializzati e, quindi,
più produttivi; in secondo luogo, la conoscenza può favorire la produzione di
innovazioni. Inoltre, nel momento in cui le conoscenze acquisite su basi individuali
diventano patrimonio collettivo, l’accumulazione di capitale umano genera processi di
crescita anche per l’esistenza di fenomeni di esternalità.
La teoria della crescita endogena cerca di spiegare la crescita come effetto di fattori
endogeni al sistema economico: quelli rilevanti trovano ampia trattazione nella letteratura
e tracciano differenti indirizzi nella ricerca delle spiegazioni endogene della crescita
economica. (ossia l’accumulazione di conoscenza, l’accumulazione di capitale umano e l’investimento
in ricerca e sviluppo).
Nel modello di ROMER (1986, 1990) la conoscenza è un bene immateriale e la sua
accumulazione è regolata da dinamiche particolari ed in cui il tipo di progresso
tecnologico considerato è quello che incrementi il numero di beni intermedi impiegati
nella produzione Il modello di LUCAS (1988) analizza l’accumulazione di capitale umano, che
si può vedere come l’incorporazione della conoscenza nella forza lavoro.
L’accumulazione di capitale umano dipende in questa impostazione sia dal tempo che
dalle risorse che sono devolute a tale attività dagli individui. Comune a questi due filoni è
la possibile esistenza di esternalità nell’economia e quindi di un possibile ruolo dello Stato
(pianificatore) nella correzione dell’inefficienza nell’allocazione delle risorse.
termini, la probabilità di trovare lavoro non sembra essere associata al capitale umano acquisito, ma alla posizione sociale
della famiglia di appartenenza. Inoltre, come rilevano PAPAGNI, FILOSO (2003, p.121), il tasso soggettivo di preferenza
intertemporale è influenzato dal reddito, così che gli individui con minor reddito saranno propensi a scegliere guadagni
presenti certi a guadagni (maggiori) futuri incerti, con conseguente sottoinvestimento in capitale umano.
40 L’esistenza di quest’ultimi generano anche nel campo delle conoscenze “le rendite di monopolio” che sono un portato
della persistenza generazionale di alcune figure professionali.
63
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
5.4.1 Il modello Ak ed il learning by doing nel modello di Romer
Come si è rilevato nel paragrafo precedente il fatto che la crescita di lungo periodo
dipenda da fattori esogeni al modello, in particolare dall’avanzamento tecnico,
rappresenta un forte limite del modello base di crescita neoclassico (dipendente
dall’ipotesi neoclassica di rendimenti decrescenti del capitale). Il modello AK è uno dei
primi modelli, che ipotizzando la produttività marginale del capitale costante, è in grado di
spiegare la crescita economica di lungo periodo senza il bisogno di progresso tecnologico
esogeno 41, comunque restando all’interno di una cornice teorica di segno neoclassico.
La principale ipotesi del modello AK riguarda la considerazione del capitale non solo
come capitale fisico, ma anche come capitale umano: questo modello prende il nome di
“modello AK” in quanto utilizza una funzione di produzione del tipo Y AK ; come è
facilmente verificabile, tale funzione di produzione mostra rendimenti costanti del
capitale. Infatti Y / K A . Un limite di questa impostazione consiste nel fatto che non
si dà motivazione del perché la produttività del capitale è costante, invece che
decrescente.
Un’alternativa a questo tipo di approccio è data dai lavori di ROMER (1986) e ARROW
(1962), i quali sviluppano i loro modelli a partire dal superamento dei rendimenti
decrescenti del capitale introducendo il concetto di learning by doing. In pratica le imprese
durante il processo di accumulazione del capitale, apprendono come produrre più
efficientemente: questo effetto positivo dovuto all’esperienza aumenta la produttività del
capitale e consente di superare l’ostacolo dei rendimenti decrescenti del capitale.
Diventa pertanto fondamentale nel processo di crescita l’accumulazione della
conoscenza, bene non rivale e non escludibile, ossia con proprietà tipiche di un bene
pubblico: secondo ROMER (1986) tale conoscenza si accumula come sottoprodotto
dell’attività di produzione e non come risultato di un’esplicita scelta degli agenti. In
sintesi gli aspetti che caratterizzano il modello sono:
1.
la conoscenza è il fattore cruciale nello spiegare la crescita di un paese;
2.
la conoscenza è un bene cha ha le tipiche proprietà di un bene pubblico;
3.
la conoscenza incrementa la produttività del fattore lavoro;
4.
le caratteristiche della conoscenza si possono modellare come un’esternalità
nell’accumulazione di capitale, ossia l’accumulo di conoscenza è ottenuto dallo stesso
processo di produzione (learning by doing)42.
41BARRO-SALA
I MARTIN (1995)
Queste considerazioni possono essere modellizzate considerando una funzione di produzione neoclassica con tecnologia
labour augmenting (con i è indicata l’i-esima impresa), Yi F K i , Ai Li e introducendo due ipotesi:
42
1) Un aumento dello stock di capitale dell’impresa produce un aumento dello stock di conoscenza rappresentato da Ai .
Questo processo riflette l’idea di Arrow che la conoscenza e gli incrementi di produttività derivino direttamente dall’attività
di produzione e di investimento.
2) la conoscenza accumulata da ogni impresa è un bene pubblico al quale ogni impresa ha accesso con costo zero. In poche
parole, come un’impresa aumenta la propria conoscenza, tale incremento si trasmette istantaneamente a tutte le altre imprese.
Questa assunzione implica che il cambiamento nella tecnologia di ogni impresa, corrisponde al cambiamento della
tecnologia dell’intera economia ed è perciò proporzionale al cambiamento dello stock aggregato di capitale.
Date queste assunzioni possiamo riscrivere la funzione di produzione della singola impresa nel seguente modo (sostituiamo
ad Ai , il capitale aggregato K):
64
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
5.4.2 - Modelli con capitale umano : il modello Uzawa-Lucas e Rebelo
Nei modelli AK e nel modello a la Romer è possibile avere crescita di lungo periodo delle
grandezze pro-capite senza progresso tecnologico esogeno, se il capitale mostra
rendimenti costanti: l’ipotesi di assenza di rendimenti decrescenti del capitale può
giustificarsi col fatto che il capitale non è solo quello fisico, ma anche quello umano.
In questo paragrafo esamineremo esplicitamente modelli con capitale fisico e umano,
dove per capitale umano si intende un fattore produttivo accumulabile ottenuto come
risultato di un’attività di investimento da parte degli individui che dedicano il loro tempo
all’acquisizione di abilità professionali 43 (v. supra).
Prima di Lucas i primi studi che si occuparono del capitale umano si ebbero negli anni
sessanta e sono rappresentati dai lavori di BECKER (1964) e SCHULTZ (1963). Nell’ambito
della crescita a utilizzare il concetto è stato UZAWA (1965) e a rilanciare il concetto e
renderlo capace di generare crescita endogena (crescita che dipende dalle decisioni degli
individui) è stato Lucas (1988).
Uzawa formalizzò l’idea che il progresso tecnico (labour augmenting) non è una “manna
che cade dal cielo” ma è il risultato dell’azione intenzionale degli agenti economici che
impiegano risorse scarse per migliorare lo stato delle conoscenze tecnologiche: pertanto
il progresso tecnico è incorporato nel lavoro. L’idea di Uzawa è molto simile a quella
utilizzata da ROMER (1990) nei suoi modelli in cui l’interazione progresso tecnicocapitale umano è il motore fondamentale della crescita : non è possibile aumentare il
livello di conoscenza senza l’utilizzo di capitale umano.
L’accumulazione di capitale umano può essere il risultato di vari fattori, tra cui i più
importanti sono (i) il tempo dedicato all’istruzione, (ii) le risorse monetarie investite
Yi F K i , KLi .
Un esempio interessante è quello con una funzione di produzione del tipo Cobb-Douglas:
Yi A K i KLi
con 0 1.
1
Possiamo dimostrare che la produttività marginale del capitale è costante (e non decrescente come nel modello di Solow);
per verificarlo basta fare la derivata della funzione di produzione rispetto a
Questa derivata può essere riscritta nel seguente modo:
L
Yi / K i A K i
Ki
1
K i : Yi / K i A K i 1 KLi 1 .
.
A questo punto, ipotizzando che il rapporto lavoro/capitale sia uguale sia a livello aggregato che a livello di singola impresa,
possiamo riscrivere la derivata come Y / K A K L
i
i
K
1
, da cui otteniamo Yi / K i A L
1
. Come è facile
constatare, la produttività marginale del capitale è costante, e questa caratteristica consente al modello con learning by doing
di avere crescita endogena di lungo periodo.
43 Rientrano tra le componenti del capitale umano: a)Human capital skills (risultato dell’istruzione); b) entrepreneurship e
talento naturale; c)stock di conoscenze accumulate (esperienza).Pertanto il capitale umano è l’insieme delle capacità (skills)
delle conoscenze e delle abilità incorporate negli individui in grado di arrecare un vantaggio agli individui e alla società.
65
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
nell’educazione, (iii) le esternalità di cui può godere un individuo quando apprende e (iv)
le infrastrutture di cui può godere uno studente durante il processo di apprendimento.
Per considerare la variabile capitale umano è necessario modificare la funzione di
produzione come segue:
Y F K , H
dove con H è indicato lo stock di capitale umano. Potremmo pensare al capitale umano,
H, come al numero di lavoratori, L, moltiplicato per il capitale umano di un tipico
lavoratore, h. L’ipotesi che assumiamo è che la quantità di lavoratori, L, e la qualità degli
stessi, h, siano perfetti sostituti nel senso che solo il prodotto Lh conta per la produzione.
Quindi, fissare L non vuol dire ottenere dei rendimenti decrescenti, poiché il raddoppio
di K e h, per un dato L, porta a raddoppiare anche Y. Assumiamo solo per semplicità di
esposizione che la forza lavoro totale, L, sia fissa, e quindi che H cresca solo grazie ad
incrementi nella qualità media h. si noti inoltre che l’equazione sopra riportata non
ammette alcun tipo di progresso tecnologico.
Un esempio significativo è rappresentato dalla funzione di tipo Cobb-Douglas con
capitale umano Y AK H 1 . Ad essa sono affiancate le equazioni dinamiche del
capitale fisico e del capitale umano: K I K K e H I H H . Si assume che i due tipi
di capitale abbiano lo stesso tasso di deprezzamento, . Il deprezzamento del capitale
umano include le perdite dovute al deterioramento delle abilità e alla mortalità, al netto
dei benefici ottenuti grazie all’esperienza. I K e I H rappresentano rispettivamente
l’investimento lordo in capitale fisico e umano.
L’implicazione di un modello di questo tipo è che il tasso di crescita del prodotto Y / Y è
inversamente correlato al rapporto tra capitale fisico e capitale umano K / H se questo è
inferiore al proprio valore di stato stazionario /1 , mentre è correlato
positivamente a K / H se questo rapporto è inferiore a /1 .
Graficamente:
66
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Y / Y
Y / Y
min
/1
K/H
Figura 5.1 – Il tasso di crescita della produzione dipende da K/H
Nella figura 5.1, il tasso minimo di crescita si ha in corrispondenza di K / H 1 .
Un basso valore del rapporto K/H potrebbe essere stato causato da una guerra che ha
distrutto buona parte del capitale fisico ma ha lasciato intatto il capitale umano (è la
situazione della Germania e del Giappone alla fine della II^ Guerra mondiale). In queste
circostanze, si riprenderebbe a investire massicciamente in capitale fisico (e molto meno
in capitale umano), con conseguente aumento del rapporto K/H fino a che non sia
raggiunto il valore di stato stazionario /1 . Il caso contrario, cioè alti valori del
rapporto K/H, può invece essere stato causato da una estesa epidemia che ha ucciso
gran parte della popolazione di uno stato lasciando intatte le infrastrutture. In tale
circostanza si investirebbe massicciamente in capitale umano (e poco in capitale fisico)
con conseguente riduzione del rapporto K/H e sua convergenza verso il valore /1 .
Nel lungo periodo, comunque il prodotto cresce ad un tasso minimo Y / Y min
corrispondente ad un rapporto capitale fisico/capitale umano pari a /1 .
Abbiamo finora assunto che i beni fisici e l’istruzione fossero generati dalle stesse
funzioni di produzione. Così facendo però si ignora un aspetto fondamentale
dell’istruzione: il settore che produce capitale umano usa il capitale umano come input
molto più intensamente di quanto non faccia il settore che produce i beni. Dovremmo
perciò modificare il modello in modo che possa riflettere il fatto che la produzione del
capitale umano sia a sua volta relativamente più intensiva in capitale umano. Con tali
modifiche otteniamo conclusioni diverse circa gli effetti sulla crescita dello
sbilanciamento tra capitale umano e fisico.
67
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Seguendo REBELO (1991), ipotizzeremo due funzioni di produzione di tipo CobbDouglas:
Y A vK uH
1
H H B1 v K 1 u H
1
dove Y è la produzione di beni, A e B sono parametri tecnologici e v ed u sono
rispettivamente frazioni di capitale umano e fisico usate nella produzione di beni. Le
corrispondenti frazioni di capitale fisico e umano usate nella produzione di capitale
umano sono 1 v e 1 u . Se allora il capitale umano è generato da una
tecnologia differente da quella per i beni. Il fatto che significa che il settore che
produce capitale umano usa il capitale umano come input molto più intensamente di
quanto non faccia il settore che produce i beni. Le forme delle equazioni implicano che
le attività di produzione siano caratterizzate da rendimenti costanti di scala in entrambi i
fattori produttivi.
Una conclusione importante dei modelli di questo tipo è che una riduzione del capitale
umano crea maggiori problemi alla crescita di quanto non faccia una riduzione del
capitale fisico. Nei termini del modello precedente, la crescita risulterà meno rapida se
K / H 1 ; graficamente si dovrebbe avere una relazione tra Y / Y e K / H molto più
piatta verso destra.
Questi modelli predicono che l’economia dovrebbe fuoriuscire da una recessione più
velocemente a seguito di una guerra che ha distrutto principalmente il capitale fisico
piuttosto che di un’epidemia che ha ridotto lo stock di capitale umano. Il ragionamento
che sta alla base di questa conclusione è il seguente: se K / H 1 , allora il prodotto
marginale del capitale umano è alto, e la crescita del sistema sarà principalmente
condizionata dagli alti tassi di crescita del capitale umano stesso. Tuttavia, questo
comporterà alti salari nel settore dell’educazione, che utilizza intensamente il capitale
umano come fattore di produzione. Questo spingerà gli agenti economici ad allocare il
capitale umano nella produzione di beni, piuttosto che nella produzione di altro capitale
umano; la conseguenza sarà un rallentamento dei tassi di crescita dell’economia dovuto
al fatto che il capitale umano utilizzato nella produzione di beni fisici è molto meno
produttivo di quello usato nella produzione di altro capitale umano.
68
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Y / Y
Y / Y
min
/1
K/H
Figura 5.2 – Il tasso di crescita della produzione e capitale umano
Nella figura 5.2 il tasso di crescita della produzione, quando K / H 1 , cioè
quando il capitale umano è relativamente più scarso, è molto più basso che nel caso in
cui K / H 1 , cioè quando il capitale fisico è relativamente più scarso.
Le critiche al modello di Lucas derivano principalmente dal fatto che il capitale umano si
accumula non solo attraverso l’istruzione scolastica ma anche acquisendo abilità sul
posto di lavoro (learning by doing e training on the job).
Le prescrizioni di politica economica che discendono da questo corpus teorico che
abbiamo definito della crescita endogena riferimento alle c.d. politiche attive del lavoro. La
logica che muove questi interventi ribalta la logica che è stata alla base delle politiche del
lavoro in molti Paesi industrializzati soprattutto nel corso degli anni 1960-70: agli
obiettivi del sostegno del reddito e della protezione dell’occupazione, in larga misura riconducibili
a una matrice teorica keynesiana, si sostituisce l’obiettivo del sostegno all’accumulazione di
capitale umano per favorire innanzitutto la c.d. “occupabilità”. I canali sui quali si agisce –
e si intende ulteriormente agire – sono sostanzialmente due. Nella fase dell’istruzione
formale, rendere i processi di trasmissione delle conoscenze quanto più possibile
finalizzati ad accrescere la professionalità e a rendere possibile un aggiornamento
ricorrente. Nella fase lavorativa di ciascun individuo, intervenire per promuovere la c.d.
formazione permanente, al fine di evitare l’obsolescenza intellettuale e soprattutto di
aggiornare le conoscenze. La premessa implicita che è alla base di queste prescrizioni è
che la disoccupazione sia fondamentalmente imputabile a problemi di mismatch, ovvero
di non corrispondenza fra domanda di competenze espressa dalle imprese e offerta di
capitale umano espressa dai lavoratori.
5.4 – L’eccesso di istruzione
69
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
L’evidenza empirica mostra che, in molti contesti e fasi storiche, i tassi di istruzione sono
maggiori dove il tasso di disoccupazione è più alto. In quanto segue, ci si soffermerà
sull’individuazione delle possibili cause di questo fenomeno e sui suoi effetti.
E’ opportuno preliminarmente rilevare che, in prima approssimazione, il fenomeno in
oggetto configura un problema di overeducation (o sovrainvestimento in istruzione),
ovvero un problema che si genera laddove i benefici marginali dell’istruzione sono inferiori ai
costi marginali dell’istruzione ( cfr. JOHNES, 2000). I benefici includono il flusso dei redditi
attesi, e anche i benefici in termini di status (se quantificabili); i costi dell’istruzione
includono i costi monetari, di tempo e il costo-opportunità derivante dal non lavorare.
Prima di procedere alla presentazione di un’ipotesi interpretativa dell’overeducation, è
opportuno dar conto delle altre interpretazioni del fenomeno presenti in letteratura44.
I] Il sovrainvestimento in istruzione come scelta “non razionale”. Il fenomeno in oggetto può
essere visto come l’esito di una strategia individuale non puramente razionale, nel senso
che verrà ora specificato. Si pongono in evidenza motivazioni di ordine culturale che
spingerebbero – secondo questa visione – il singolo individuo a scegliere percorsi
formativi non “ottimali” (ovvero non in linea con quelli che sono i segnali provenienti
dal mercato del lavoro). Ciò a ragione delle seguenti circostanze:
a) L’istruzione può essere percepita innanzitutto come consumo, non come investimento.
La “non-razionalità” della scelta è, quindi, qui da intendersi come non ponderazione dei
suoi esiti di lungo periodo.
b) In più, e ciò varrebbe soprattutto nel Mezzogiorno, l’istruzione è percepita come un
fine in sè, tale da garantire a se stessi e/o alla propria famiglia un guadagno in termini di
status.
c) Un altro rilevante aspetto motivazionale viene riscontrato nell’obiettivo di allontanarsi
dalla famiglia di origine, scegliendo sedi universitarie lontane dalla propria residenza.
d) Per quanto riguarda la scelta dei percorsi universitari delle donne si evidenzia il ruolo
determinante della famiglia che predilige sedi universitarie prossime al luogo di residenza
indipendentemente dall’offerta formativa della stessa sede.
II] Il sovrainvestimento in istruzione come “strategia di attesa”. Il fenomeno in oggetto viene da
alcuni interpretato alla luce della “mancanza di cultura del lavoro” da parte dei giovani
meridionali. La visione dell’”Università-parcheggio”, in tal senso, costituirebbe la
migliore risposta al rinvio del proprio ingresso nel mercato del lavoro. E’ chiaro che la
famiglia riveste un ruolo determinante in tale processo, garantendo trasferimenti di
reddito che consentono la permanenza in condizioni di inoccupazione. Si possono,
inoltre, riscontrare casi di ritardo volontario nell’accesso al mercato del lavoro, in quanto
ciò comporta la presa in carico di decisioni importanti in un contesto di elevata
incertezza; fenomeno che Livi Bacci (1999) ha definito “sindrome da ritardo”.
In quanto segue, si procede a fornire una diversa interpretazione del fenomeno, fondata
sulla razionalità della scelta del singolo di accrescere la propria dotazione di capitale
umano in un contesto di interazione strategica45,46.
Nel caso italiano e ancor più meridionale, il fenomeno dell’overeducation non è un fenomeno recente. Si rinvia, a riguardo,
alla pionieristica indagine di FREY (1972).
45 Lo schema qui di seguito presentato ha molte affinità con gran parte della più recente letteratura della “job competition
“ secondo cui la funzione dell’istruzione è di acquisire un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro (CIRAVEGNA, 1995,
pp 282-287). Un modello per volti aspetti simile a quanto qui argomentato è stato recentemente proposto da FIASCHI,
70
44
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
Le cause. Si considerino due agenti (o due gruppi di agenti), A e B, il cui investimento in
istruzione è finalizzato a massimizzare la probabilità di trovare lavoro (0<<1). Si
pongono le seguenti ipotesi:
1) A e B fronteggiano il seguente problema di scelta: accrescere la propria dotazione di
capitale umano (p.e. passando dall’istruzione secondaria e quella terziaria: laurea, master,
dottorato di ricerca, seconda laurea, ecc.) o meno, in risposta alla probabilità che
ciascuno attribuisce alle “mosse” dell’altro.
2) A e B presumono che la probabilità di trovare lavoro sia funzione diretta del numero di
titoli acquisiti (H), escludendo, per semplicità espositiva, considerazioni relative alle
diverse possibili tipologie di capitale umano.
3) A e B hanno uguali vincoli di bilancio per incrementi di capitale umano, con costi dati
e certi ex-ante.
Sulla base dell’ipotesi 2), ciascun individuo ritiene razionale accrescere la propria
dotazione di capitale umano per acquisire un vantaggio posizionale nei confronti dei
concorrenti. In tal senso, l’accumulazione individuale di H è una strategia dominante, dal
momento che – per qualunque probabilità attribuita alle scelte di B – A ritiene che la
probabilità di trovare impiego sia necessariamente maggiore a seguito di questa scelta. Si
osservi che i costi dell’istruzione non influenzano la scelta, ma semmai influiscono
sull’ampiezza del fenomeno; nel senso che, all’aumentare dei costi, si riduce il numero di
individui con istruzione elevata e, tuttavia, ciò non genera di per sé un’allocazione
efficiente della forza lavoro (ovvero uno screening efficiente), dal momento che non può
darsi, in astratto, una correlazione diretta fra capacità di spesa e attitudine allo studio. Si
osservi anche che – almeno in questo schema semplificato - l’accumulazione di H è
comunque conveniente (stando all’ipotesi 2), indipendentemente dalle aspettative relative
all’aumento della domanda di lavoro e alla sua tipologia.
Sul piano macroeconomico, l’accumulazione di capitale umano si rivela, però, “eccessiva”,
determinando un’allocazione inefficiente delle risorse. La sequenza 1 descrive gli effetti
derivanti dalle considerazioni ora esposte, sotto l’ipotesi che la domanda di lavoro non
cresca.
- Se Ls Ld H 0 wr 0; e 0
- Se Ld / dt 0 conH 0 w 0; e 0
Sequenza 5.1. Effetti macroeconomici dell’overeducation
dove Ls è l’offerta di lavoro, Ld la domanda di lavoro, H la dotazione aggregata di
capitale umano, wr il salario di riserva, e lo status atteso (in termini di posizionamento nel
mercato del lavoro), t il tempo.
ORSINI (2001), i quali mettono in evidenza il fatto che l’investimento in istruzione può avere “caratteristiche posizionali”,
così che un individuo che aumenta la propria dotazione di capitale umano, coeteris paribus, accresce la propria probabilità di
successo a danno dei propri concorrenti, in un contesto di interazione strategica.
46 In quanto segue, non verranno trattati gli effetti dell’overeducation sulla mobilità dei lavoratori all’interno dell’impresa. Si
rinvia, a tal fine, a GROENVELD, HARTOG (2004).
71
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
In base alla sequenza 5.1, partendo da una condizione di disoccupazione, si genera una
crescita della dotazione aggregata di capitale umano, derivante dalle singole scelte
razionali di acquisizione di istruzione. A questa fa seguito un aumento delle aspettative
(dunque, un aumento del salario di riserva e dello status atteso), che si risolve
(temporaneamente) in disoccupazione volontaria. Al crescere del tempo di ricerca di
lavoro, le aspettative si ridimensionano, con i seguenti possibili esiti (con domanda di
lavoro stazionaria): per alcuni la disoccupazione involontaria, per altri l’assunzione con
livelli di reddito e mansioni inferiori alle aspettative o l’emigrazione 47 . A ciò si può
aggiungere un’ulteriore considerazione. La disoccupazione – o la sottoccupazione –
intellettuale può riguardare prevalentemente individui/famiglie con redditi medio-bassi,
in un contesto nel quale (i) le spese di istruzione non sono significativamente elevate; (ii)
non vi sono immediate opportunità di impiego. Le famiglie con redditi medio-alti –
soprattutto nei casi nei quali l’attività del capofamiglia è facilmente trasmissibile e
richiede un contenuto modesto di capitale umano generale (si considerino qui casi di
imprese con produzioni a basso contenuto di nuova conoscenza) – sperimentano, per
contro, un più elevato costo-opportunità dell’istruzione. Un effetto analogo può
generarsi se il mercato del credito è imperfetto: poiché sono prevalentemente gli
individui con redditi elevati a poter accedere a livelli elevati di scolarizzazione, le
mansioni che richiedono un più alto livello di conoscenze vengono attribuite a lavoratori
con redditi elevati e, non per questo, necessariamente più abili.
Si configura, in tal senso, una duplice possibile spirale viziosa. Nel primo caso, tanto meno
equa è la distribuzione del reddito, tanto maggiore è la dotazione di capitale umano degli individui con
redditi medio-bassi e tanto minore è il loro reddito. Nel secondo caso, tanto maggiore è la
diseguaglianza della distribuzione dei redditi, tanto maggiore è il capitale umano acquisito dagli
individui più ricchi e tanto maggiore è il loro reddito.
In sostanza: mentre sul piano microeconomico l’accumulazione di capitale umano è la migliore
risposta alla disoccupazione, sul piano macroeconomico risulta essere inefficace.
Da questa conclusione, possono farsi discendere due corollari.
a) Il tasso di disoccupazione intellettuale è positivamente correlato al tasso di
disoccupazione, ma è probabile che questo esito costituisca un esito di breve-medio
periodo, nel senso che – dopo aver sperimentato un periodo più o meno ampio di
inoccupazione – il singolo venga assunto per una mansione inferiore a quella attesa, per
poi riuscire a utilizzare pienamente i titoli acquisiti, accedendo a mansioni e a livelli di
reddito più elevati. Tuttavia, è anche probabile che questo effetto non sia valido, per
valori significativi, nel Mezzogiorno; ovvero che la carriera si sviluppi interamente nelle
aree più ricche del Paese, con rimesse pressoché inesistenti alle famiglie di origine.
b) L’accumulazione di capitale umano determina un “effetto di spiazzamento” a danno di coloro che
non scelgono (o non possono scegliere) questa strategia. In altri termini, coloro che hanno
acquisito più titoli vengono assunti per mansioni che richiedono skill proprie di chi ha
acquisito meno titoli; costoro rimarrebbero disoccupati (cfr. FREY, GHIGNONI, REGOLI,
1998).
In definitiva, l’accumulazione di capitale umano (quando assume la forma di overeducation)
(i) non contribuisce allo sviluppo economico dell’area considerata, anche in
47
Si osservi che il fenomeno può essere accentuato dall’insorgere di problemi di obsolescenza intellettuale.
72
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
considerazione di possibili fenomeni di brain-drain e della correlazione inversa fra
scolarizzazione e propensione alla creazione di impresa sopra richiamati; (ii) genera
effetti “distorsivi” nel mercato del lavoro, allocando i lavoratori per mansioni diverse da
quelle per le quali hanno acquisito istruzione, così determinando o disoccupazione o
“sottoccupazione” del lavoro intellettuale (CAPPARUCCI, 1989)48.
E’ opportuno rilevare che non si vuole qui negare l’idea che un’istruzione diffusa
rappresenti di per sè un obiettivo, dal momento che incide sulla crescita civile della
collettività. Viene diffusamente riconosciuto che individui con elevato livello di
scolarizzazione dispongono di maggiori capacità di selezionare il personale politico e, di
norma, sono meno propensi a effettuare transazioni illecite e più propensi al rispetto
delle norme. Si può inoltre rilevare che la partecipazione scolastica accresce la possibilità
di inserimento sociale, di esercizio dei diritti civili e, non da ultimo, riduce i tassi di
criminalità49. Tuttavia, come già messo in evidenza da SCHUMPETER (1964, pp. 146 ss.),
una massa ampia di individui disoccupati con alta dotazione di capitale umano può
costituire un fattore potenzialmente destabilizzante, potendo cioè minare alle radici
l’ordine sociale esistente. In tal senso, la disoccupazione intellettuale può ridurre lo stock
di capitale sociale, innescando fenomeni di micro e macro conflittualità50. E’ necessario
rilevare che il fenomeno dell’overeducation può essere contrastato o assecondando la
tipologia di domanda di lavoro espressa dalla imprese (e, dunque, dequalificando la
forza-lavoro, in contesti nei quali è elevata la domanda di lavoro poco qualificato) o
attraverso politiche industriali finalizzate innanzitutto a incentivare la crescita
dimensionale delle imprese. Imprese di grandi dimensioni possono sfruttare economie di
scala, ottenendo una più alta produttività del lavoro; sono, di norma, più innovative,
pagano salari più alti e sono meno dipendenti dal settore bancario. Un’economia
popolata da imprese con elevata propensione all’innovazione produce un’elevata
domanda di lavoro qualificato e di ricerca di base e applicata. A ciò si può aggiungere che,
come rilevato empiricamente, imprenditori con basso titolo di studio sono
maggiormente propensi ad assumere lavoratori con basso titolo di studio.
Riferimenti bibliografici
ANTONELLI G. [a cura di] (2003), Istruzione, economia e istituzioni, Il Mulino, Bologna.
ARROW K. J. (1962), The Economic Implications of Learning by Doing, in “ Review of Economic
Studies, 29(1), 155-173.
BARRO R.J., SALA-i-MARTIN X (1995), Economic Growth, Mac Graw- Hill.
BECKER G. S. (1964), Human Capital, Columbia University Press, New York.
La sottoutilizzazione del capitale umano genera, peraltro, deperimento dello stesso, a ragione del fatto che le competenze
acquisite non sono “tesaurizzabili” (cfr. BOLDIZZONI, a cura di, 2002, p.167).
49 Cfr. COSTABILE, GIANNOLA (1996).
50 “Tutti i disoccupati o insoddisfacentemente occupati o inimpiegabili affluiscono nei settori professionali in cui i criteri di
valutazione sono meno definiti o in cui si richiedono attitudini e competenze di ordine diverso; e gonfiano le file degli
intellettuali stricto sensu, il cui numero cresce perciò in modo eccessivo e che entrano a farne parte in uno stato d’animo
irritato e deluso. Lo scontento alimenta il rancore e, spesso, si razionalizza in quella forma di critica sociale che … è in ogni
caso l’atteggiamento tipico dello spettatore intellettuale verso uomini, classi ed istituti, specialmente in una civiltà
razionalistica e utilitaristica” (SCHUMPETER, 1964, p.148).
73
48
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
BHADURI A., MARGLIN S. (1990), Unemployment and the real wage: the economic
bases for contesting political ideologies, in “Cambridge Journal of Economics”, 14 (4),
pp. 375-93.
BARTELA. P., SICHERMAN N. (1998), Technology Change and the Skill Acquisition of
Young Workers, in “Journal of Labor Economics” 16(4), pp. 718–55.
BAUMAL W., On the Theory of Expansion of the Firm, in “The American Economic
Review”, 1962.
BISHOP J.H. (1995), Vocational education and at-risk youth in the United States, in
“Vocational Training European Journal”, 6, pp. 34-22.
BLANCHARD O., GIAVAZZI F. (2003), Macroeconomic Effects of Regulation and
Deregulation in Goods and Labour Markets, in “The Quarterly Journal of Economics”,
118, pp. 879-907.
BLANCHARD O. (2006), European Unemployment: The Evolution of Facts and Ideas, in
“Economic policy”, CEPR, CES, MSH, vol. 21, n. 45, pp. 5-9, 01.
BLANCHARD O., AMIGHINI A., GIAVAZZI F. (2011), Macroeconomia. Una prospettiva
europea, Il Mulino, Bologna.
BOWEN H.R. (1977), Investment in Learning, Jossey-Bass Inc., San Francisco.
BOWLES S., GINTIS H. (1976), Schooling in Capitalist America, Basic Books, New York.
BOWLES S., GINTIS H. (1983), The Power of Capital: On the Inadequacy of the Conception of the
Capitalist Economy as “Private”, in “The Philosophical Forum”, XIV.
BRUCCHI L. (2001), Manuale di Economica del Lavoro, Il Mulino, Bologna.
CAPPARUCCI M.( 1989), Il capitale umano come causa ed effetto dei livelli di sviluppo del
mezzogiorno, in “Quaderni di economia e lavoro”, n. 38.
CARLIN W., SOSKICE D. (1993), Macroeconomia, CLUEB, Bologna.
CESARATTO S.. REALFONZO R.(2006) (a cura di), Rive Gauche. Critica della politica
economica, 2006, Roma, Manifestolibri.
COLLINS R. (1979), The credential Society: an historical sociology of education and stratification,
Academic Press, New York.
COSTABILE L., GIANNOLA A. (1996), Norme sociali e distribuzione dei posti di lavoro. Una
parabola della corruzione nell’Italia meridionale, in COSTABILE L. (a cura di), Istituzioni e
sviluppo economico nel Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna.
DAVIDSON P. (1994), Post Keynesian Macroeconomic Theory, Edward Elgar, Aldershot.
DUNCAN B (1968), Trends in Output and Distribution of Schooling, in E.B. Sheldon & W.E.
Moore (eds.), Indicators of Social Change, Russell Sage Foundation, New York.
DUTT A.K. (2012), Distributional dynamics in Post-Keynesian growth models, in“Journal of
PostKeynesian Economics”, 34(3), Spring: 431-51.
FIASCHI D., ORSINI R. (2001), Investimento in istruzione e concorrenza posizionale, in “Rivista
di Politica Economica”, vol. 91, n.7/8, pp. 6-40.
FONTANA G., SETTERFIELD M. (eds) (2010), Macroeconomic Theory and Macroeconomic
Pedagogy, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
FREY L. (1972), Occupazione e disoccupazione giovanile in Italia, Isvet, Roma, n.37.
FREY L., GHINONI E., REGOLI A. (1998), Crescita dei livelli di istruzione e struttura
professionale in Italia, in “Quaderni di economia del Lavoro” 61, pp. 9-75.
FORGES DAVANZATI G. (2005), Distribuzione del reddito, istituzioni, moneta, Pensa, Lecce.
74
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
FORGES DAVANZATI G, REALFONZO R. (2003), Labour Market Deregulation and
Unemployment in a Monetary Economy, in R.Arena and N.Salvadori (eds.), Money, Credit and
the Role of the State, Asghate.
FORGES DAVANZATI G., PATALANO R. (2014), Il pensiero economico di Augusto
Graziani, in “Il pensiero economico italiano, XXII n. 1, pp. 184-195.
FORGES DAVANZATI G., PAULI’ G. (2015), Precarietà del lavoro, occupazione e crescita
economica: un ricostruzione critica del dibattito, in Costituzionalismo, Torniamo ai Fondamenti,
Fasciolo 1, 2015.
GRAZIANI A. (1992), Teoria economica. Macroeconomia, ESI, Napoli.
GRAZIANI A. (1993), Teoria economica prezzi e distribuzione, Napoli, Esi.
GRAZIANI A. (2003), The monetary theory of production, Cambridge University Press,
Cambridge.
GROENEVELD S. HARTOG G. (2004),Overeducation, wages and promotions within the
firm, in “Labour Economics”, 11, (6), pp. 701-714.
HEIN H., DETZER, D. (2015), Finance-dominated capitalism and income distribution: A
Kaleckian perspective on the case of Germany, “Italian Economic Journal”, 1 (2), July: 171-192.
JOHNES G. (2000), Economia dell’istruzione, Il Mulino, Bologna.
HEIJKE H., MENG, C., RAMAEKERS, G. (2002), An investigation into the role of human
capital competences and their pay-off’, ROA-RM-2002/3E.
KALECKI M. (1943), Political Aspects of Full Employment, in OSIATYNSKI J. (a cura di)
(1990), Collected Works of Michal Kalecki, Volume I. Capitalism: Business Cycles and Full
Employment, Clarendon Press, Oxford, pp. 347-56, 571-8.
KALDOR N. (1957), A model of economic growth, IN “The Economic Journal”, vol.67, n.
268, December: 591-624.
KEYNES J.M. (1930), A Treatise on Money, London, Macmillan Publishers.
KEYNES J.M. (1936), Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, 1994, Torino,
UTET.
KORPI W. (1998), Power resources approach vs action and conflict: On causal and intentional
explanations in the study of power. Power resources theory and the welfare state, in “Power resource
theory and the welfare state”, pp. 37-69.
LAVOIE M. (1992), Foundations of Post Keynesian Economics, Edward Elgar, Aldershot.
LUCAS R. (1988), On the mechanics of economic development, in “Journal of Monetary
Economics”, vol. 22, pp.3-42.
LUNGHINI G. (1999), Prefazione a: M. Dobb, Storia del pensiero economico: teorie del valore e della
distribuzione da Adam Smith ad oggi, Editori Riuniti, Roma.
LUNGHINI G. (2012), Conflitto, crisi, incertezza, Torino, Bollati Boringhieri.
MARX K. (1980, [1867]). Il capitale, Editori riuniti, Roma.
MINCER J. (1974), Schooling, Experience and Earning, Columbia University Press, New York.
NIJHOF W.J, STREUMER J.H. (eds.) (1998). Key Qualifications in Work and Education,
Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
NORDHAUG O. (1993), Human Capital in Organizations: Competence, Training and Learning.
Oslo/London: Scandinavian University Press/Oxford University Press.
ONARAN O., GALANIS G (2013), Income distribution and aggregate demand: A global PostKeynesian model, “PostKeynesian Economics Study Group”, working paper n.1304.
OECD (2004), Employment Outlook , Paris.
75
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
PARGUEZ A. (2011), Money creation, employment and economic stability: the monetary theory of
unemployment and inflation, in C. GNOS, L-P-ROCHON, Credit, money and macroeconomic policy.
A Post-Keynesian approach, Cheltenham: Elgar, pp.71-97.
PASINETTI L. (2010), Keynes e i Keynesiani di Cambridge, Laterza, Roma-Bari.
PINI P. (1992), Progresso tecnico e occupazione, Il Mulino, Bologna.
PINI P. (2013) Minori tutele del lavoro e contenimento salariale favoriscono la crescita della produttività?
Una critica alle ricette della BCE, in “Economia e Società Regionale”, FrancoAngeli Editore,
vol. 2013(1), pp. 150-181.
PINI P., Produttività e regimi di protezione del lavoro, “Keynesblog”, 20.5.2013
PRAUSSELLO F., MARENCO M. (1996), Economia dell’istruzione e del capitale umano,
Laterza, Bari.
REES A. (1973), The Economics of Work and Pay, Harper & Row, New York.
RENSHAW E.F. (1966), Stima dei ricavi ottenuti dall’istruzione, in CENSIS, L’istruzione come
investimento, Roma.
ROBBINS L. (1932), An Essay in the Nature and Significance of Economic Science, McMillan,
London, trad.it Saggio sulla natura e l’importanza della scienza economica, Utet, Torino, 1947.
RONCAGLIA A. (2012), La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico, Laterza RomaBari.
ROMER P. M.(1989), Capital Accumulation in the Theory of Long Run Growth, in Barro R. (ed.),
Modern Business Cycle Theory, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
ROMER P. M.(1986), Increasing Returns and Long-Run Growth in “ Journal of Political
Economy” 94, pp-1002-1037.
ROMER P.M. (1990), Endogenous Technological Change, in “ Journal of Political Economy” 98,
71-102.
ROSEN S. (1985), Implicit Contracts: A Survey, in “Journal of Economic Literature”, vol.
XXIII, pp. 1144-1175.
REBELO S. (1991), Long-Run Policy Analysis and Growth, in “Journal of Political Economy”
99, 500-521.
SALOP J., SALOP S. (1976), Self-Selection and Turnover in the Labour Market, in “Quarterly
Journal of Economics”.
SAINT-PAUL.G. (2000), The Political Economy of Labour Market Institutions, Oxford University
Press, Oxford.
SAMUELSON P. (1957), Wages and Interest: A Modern Dissection of Marxian Economic Models,
in “American Economic Review”, V. 47 (Dec.)
SAMUELSON P.(1973), Foundations of Economic Analyses, Harvard University Press,
Cambridge.
SCHUMPETER J.A. (1964 [1954]), Capitalismo, socialismo, democrazia, Edizioni di Comunità,
Milano.
Schultz T. (1963), Investment in human capital, in “American Economic Review”, 51.
SOLOW R.M. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, in “Quarterly Journal
of Economics”, vol.70, 1956, 65-94.
SOLOW R. M. (1994) , Perspectives on Growth Theory, in “Journal of Economic Perspectives”,
vol. 8 (Winter 1994), pp. 45–54.
SOLOW R. M. (1970), Growth Theory: An Exposition, Oxford, Clarendon Press, 1970.
SPENCE M. (1973), Job Market Signalling, in “Quarterly Journal of Economics”, 8.
76
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL LAVORO
THOMPSON P., MURPHYJ. (1987), Transferable skills in technical and further education, Tafe
National Centre for Research and Development, Adelaide.
THUROW L. C. (1975), Generating inequality, MacMillan, London.
SATTINGER M. (1993), Assignment Models of the Distribution of Earnings, in “Journal of
Economic Literature”, American Economic Association, vol. 31(2), pp. 831-80, June.
SHAPIRO C., STIGLITZ J.E. (1984), Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device,
in “American Economic Review”, 1984, 74.
STIRATI A. (2006), Distribuzione del reddito e vincolo esterno alla crescita dei salari, in Cesaratto S.
e Realfonzo R., (a cura di), Rive Gauche. Critica della politica economica, 2006, Roma,
Manifestolibri.
THUROW L.C. (1975), Generating inequality, Basic Books, New York.
UZAWA H. (1965), Optimum Technical Change in An Aggregative Model of Economic Growth, in
“International Economic Review” 6 (1): 18–31.
77