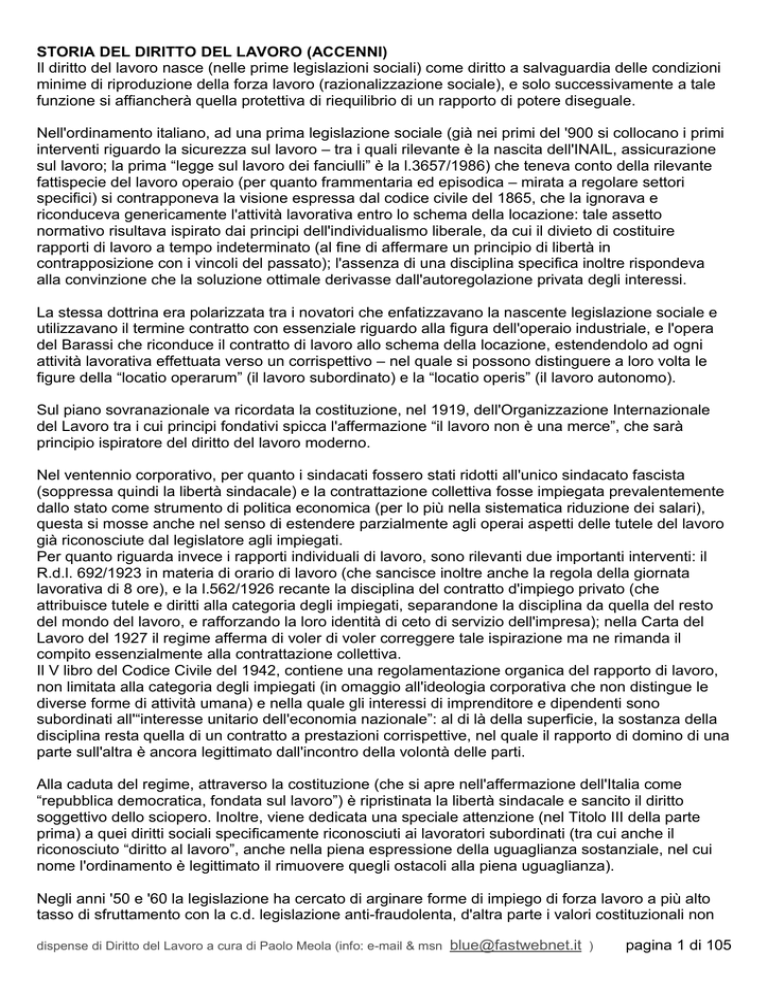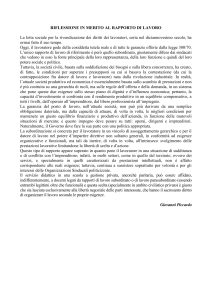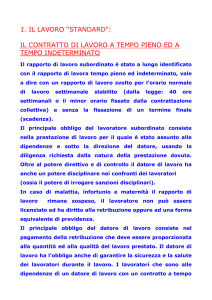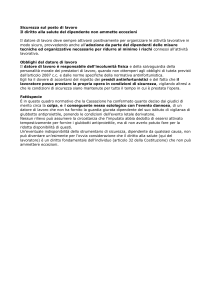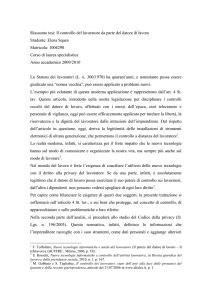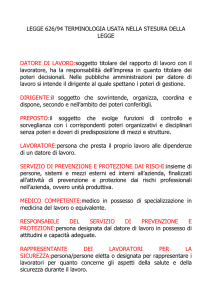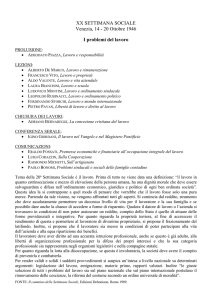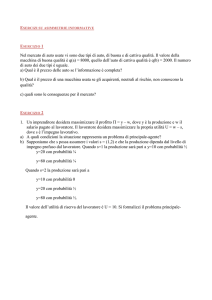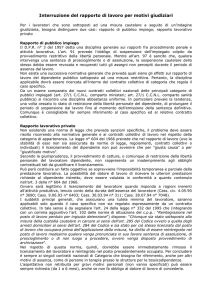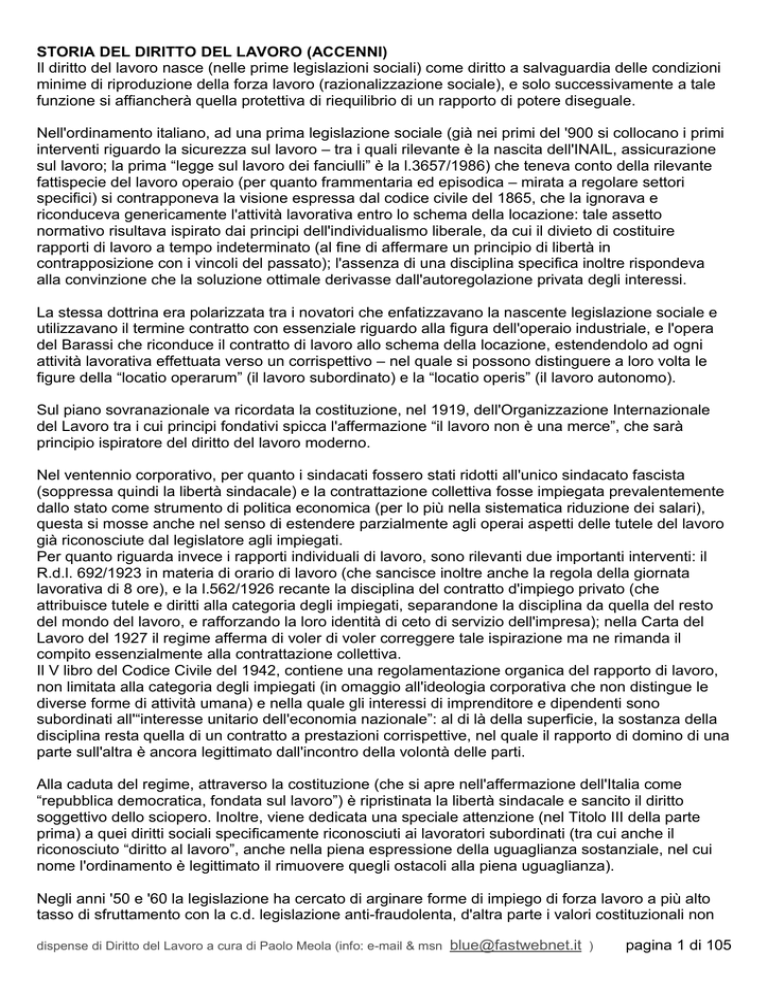
STORIA DEL DIRITTO DEL LAVORO (ACCENNI)
Il diritto del lavoro nasce (nelle prime legislazioni sociali) come diritto a salvaguardia delle condizioni
minime di riproduzione della forza lavoro (razionalizzazione sociale), e solo successivamente a tale
funzione si affiancherà quella protettiva di riequilibrio di un rapporto di potere diseguale.
Nell'ordinamento italiano, ad una prima legislazione sociale (già nei primi del '900 si collocano i primi
interventi riguardo la sicurezza sul lavoro – tra i quali rilevante è la nascita dell'INAIL, assicurazione
sul lavoro; la prima “legge sul lavoro dei fanciulli” è la l.3657/1986) che teneva conto della rilevante
fattispecie del lavoro operaio (per quanto frammentaria ed episodica – mirata a regolare settori
specifici) si contrapponeva la visione espressa dal codice civile del 1865, che la ignorava e
riconduceva genericamente l'attività lavorativa entro lo schema della locazione: tale assetto
normativo risultava ispirato dai principi dell'individualismo liberale, da cui il divieto di costituire
rapporti di lavoro a tempo indeterminato (al fine di affermare un principio di libertà in
contrapposizione con i vincoli del passato); l'assenza di una disciplina specifica inoltre rispondeva
alla convinzione che la soluzione ottimale derivasse dall'autoregolazione privata degli interessi.
La stessa dottrina era polarizzata tra i novatori che enfatizzavano la nascente legislazione sociale e
utilizzavano il termine contratto con essenziale riguardo alla figura dell'operaio industriale, e l'opera
del Barassi che riconduce il contratto di lavoro allo schema della locazione, estendendolo ad ogni
attività lavorativa effettuata verso un corrispettivo – nel quale si possono distinguere a loro volta le
figure della “locatio operarum” (il lavoro subordinato) e la “locatio operis” (il lavoro autonomo).
Sul piano sovranazionale va ricordata la costituzione, nel 1919, dell'Organizzazione Internazionale
del Lavoro tra i cui principi fondativi spicca l'affermazione “il lavoro non è una merce”, che sarà
principio ispiratore del diritto del lavoro moderno.
Nel ventennio corporativo, per quanto i sindacati fossero stati ridotti all'unico sindacato fascista
(soppressa quindi la libertà sindacale) e la contrattazione collettiva fosse impiegata prevalentemente
dallo stato come strumento di politica economica (per lo più nella sistematica riduzione dei salari),
questa si mosse anche nel senso di estendere parzialmente agli operai aspetti delle tutele del lavoro
già riconosciute dal legislatore agli impiegati.
Per quanto riguarda invece i rapporti individuali di lavoro, sono rilevanti due importanti interventi: il
R.d.l. 692/1923 in materia di orario di lavoro (che sancisce inoltre anche la regola della giornata
lavorativa di 8 ore), e la l.562/1926 recante la disciplina del contratto d'impiego privato (che
attribuisce tutele e diritti alla categoria degli impiegati, separandone la disciplina da quella del resto
del mondo del lavoro, e rafforzando la loro identità di ceto di servizio dell'impresa); nella Carta del
Lavoro del 1927 il regime afferma di voler di voler correggere tale ispirazione ma ne rimanda il
compito essenzialmente alla contrattazione collettiva.
Il V libro del Codice Civile del 1942, contiene una regolamentazione organica del rapporto di lavoro,
non limitata alla categoria degli impiegati (in omaggio all'ideologia corporativa che non distingue le
diverse forme di attività umana) e nella quale gli interessi di imprenditore e dipendenti sono
subordinati all'“interesse unitario dell'economia nazionale”: al di là della superficie, la sostanza della
disciplina resta quella di un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale il rapporto di domino di una
parte sull'altra è ancora legittimato dall'incontro della volontà delle parti.
Alla caduta del regime, attraverso la costituzione (che si apre nell'affermazione dell'Italia come
“repubblica democratica, fondata sul lavoro”) è ripristinata la libertà sindacale e sancito il diritto
soggettivo dello sciopero. Inoltre, viene dedicata una speciale attenzione (nel Titolo III della parte
prima) a quei diritti sociali specificamente riconosciuti ai lavoratori subordinati (tra cui anche il
riconosciuto “diritto al lavoro”, anche nella piena espressione della uguaglianza sostanziale, nel cui
nome l'ordinamento è legittimato il rimuovere quegli ostacoli alla piena uguaglianza).
Negli anni '50 e '60 la legislazione ha cercato di arginare forme di impiego di forza lavoro a più alto
tasso di sfruttamento con la c.d. legislazione anti-fraudolenta, d'altra parte i valori costituzionali non
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 1 di 105
iniziarono davvero a penetrare nella legislazione fino alla l.604/1966 che intaccò fortemente la libertà
di licenziamento, condizionandone la legittimità ad un giustificato motivo.
Lo “Statuto dei Lavoratori” (l.300/1970) si preoccupa di assicurare le condizioni normative funzionali
all'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, e d'altra permette che le fondamentali libertà
costituzionali possano essere esercitate dai lavoratori anche all'interno dei luoghi di lavoro.
Norma di fattiva importanza è quella contenuta nell'art. 18 della legge, che incrementa notevolmente
la tutela del lavoratore nei confronti del licenziamento illegittimo (rendendo infatti più agevolmente
esercitabili i diritti riconosciuti dallo statuto). Lo statuto ridimensiona l'autorità insita nel rapporto di
lavoro, con l'obbiettivo di realizzare un equilibrio socialmente più accettabile.
Gli obbiettivi prefigurati dallo statuto, sono infine agevolati dalla riforma del processo del lavoro
(attuata tramite la l.533/1973).
Negli anni '70 ed '80 l'intensa e prolungata crisi economica internazionale incise sul diritto del lavoro
(spesso con apporti che se all'inizio apparissero essere di carattere transitorio – dipendente dalla
particolarità della congiuntura economica – ma che si rivelarono di impatto duraturo): le pressanti
richieste delle imprese di maggiore elasticità nell'impiego della forza lavoro ed il tentativo di ridurre la
crescente disoccupazione portarono una moltiplicazione delle forme di lavoro subordinato, con
l'introduzione di numerose varianti rispetto al consolidato modello di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato. Sempre in questo periodo cominciano ad affermarsi quelle prassi concertative (che
danno vita ad una vera e propria legislazione contrattata) e quella tendenza del diritto del lavoro ad
essere anche “diritto del mercato di lavoro”.
La prassi della concertazione, già delineatasi nel precedente periodo, ebbe negli anni '90 un forte
impulso sia con l'Accordo di Luglio del '93 (con il quale si posero le basi di quella politica dei redditi
per l'adeguamento dell'Italia ai parametri richiesti dagli accordi Maastricht) e con il Patto per il Lavoro
del '96 (con il quale prese corpo la riforma del collocamento, e fu introdotto l'istituto del lavoro
interinale).
Sempre negli anni '90 sono stati apportati alcuni interventi con l'obbiettivo di superare tradizionali
squilibri del mercato del lavoro italiano (tra cui la privatizzazione del pubblico impiego, avviata nel
'93) ed altri volti a ricercare una sostanziale uguaglianza (come nel campo del lavoro femminile,
promossa con interventi positivi ai quali si affianca un forte ampliamento della tutela
antidiscriminatoria, e l'evoluzione di regole giuridiche che riequilibrassero il rapporto tra attività
lavorativa e responsabilità familiari – tradizionalmente svantaggiante le donne).
Nel nostro ordinamento nei primi anni del 2000, le politiche di de-regolazione del mercato del lavoro
hanno agito soprattutto moltiplicando le forme di accesso al lavoro, spingendosi verso un modello di
flessibilità sempre più incontrollato.
La globalizzazione è un fenomeno socio-economico che ha permesso una più libera circolazione di
capitali e merci, mentre quella di lavoratori resta più difficile (così da svantaggiare i lavoratori nel
rapporto con i propri datori di lavoro, ad esempio a causa di fenomeni come quello della c.d.
delocalizzazione della produzione, alla ricerca di minori costi).
Con il Trattato di Amsterdam vengono fortemente incrementate le competenze della Comunità
Europea, che è legittimata ad interventi nell'intera area della disciplina dei rapporti di lavoro: argini
alla delocalizzazione sono sicuramente gli elevati standard protettivi previsti dal diritto comunitario del
lavoro, estesi negli ordinamenti dei 27 stati membri.
LE ORIGINI DEL DIRITTO SINDACALE (ACCENNI)
La “storia” del diritto sindacale ha inizio con le prime forme di organizzazione del movimento operaio,
che storicamente risalgono all'affermarsi del lavoro di fabbrica, luogo nel quale venivano a trovarsi
grandi gruppi di lavoratori che, lavorando per lo stesso datore di lavoro nello stesso ambiente,
trovavano problemi comuni – ed avevano, quindi, necessità di garanzia degli stessi diritti.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 2 di 105
Nella seconda metà dell'800 nascevano le Società Operaie di Mutuo Soccorso (le c.d. SMS) con
scopi di assistenza sanitaria gratuita e di sussidio ai soci colpiti da infortunio sul lavoro: le SMS
hanno rappresentato la prima forma associativa diffusa su tutto il territorio nazionale in cui fosse
presente anche la classe operaia.
Negli ultimi anni del secolo le SMS furono travolte dalla “lotta” condotta dal Partito Operaio Italiano
(fondato nel 1885) le cui sezioni erano costituite da associazioni e leghe di operai tendenti alla
resistenza ed alla lotta per il miglioramento economico-sociale. Molte di queste società e leghe di
resistenza aderirono al Partito dei Lavoratori Italiani; quando il PLI assunse il nome di PSI (nel 1895)
modificò radicalmente la propria organizzazione, assumendo una carattere esclusivamente politico,
le lasciando dunque la funzione sindacale all'associazionismo operaio.
Le leghe di resistenza si proponevano l'obiettivo di promuovere la solidarietà di classe, di riunificare
gli operai di uno stesso settore, di introdurre un livello minimo di retribuzione, di ridurre l'orario: il
modello di organizzazione delle leghe si sviluppò “per ramo d'industria”, cioè non per mestieri ma in
base all'attività dell'impresa.
Già nei primi anni '90, con riferimento all'associazionismo operaio, nascevano le prime “Camere del
Lavoro”, una nuova istituzione con funzioni di collocamento dei lavoratori, di arbitrato nelle
controversie, di mediazione nelle lotte: in tali camere, alle quali aderivano le leghe di “lavoratori
salariati” organizzate per mestieri (ma anche SMS, cooperative ed associazioni varie), si riunivano gli
operai per trattare i loro problemi e difendere i propri interessi.
Nel 1883 venne istituita la Federazione nazionale delle Camere del Lavoro, con compiti di
coordinamento tra le Camere, che vennero però sciolte dal governo in concomitanza ai moti popolari
degli ultimi del secolo.
Quando ai primi del '900 iniziarono a ricostituirsi le Camere, queste avevano assunto un vero e
proprio carattere “sindacale”: potevano iscriversi solo i lavoratori salariati, e le sezioni venivano
invitate ad aderire alle rispettive “federazioni di mestiere”; in termini moderni le Camere
rappresentavano una struttura sindacale locale orizzontale pluri-categoriale, mentre le federazioni
nazionali rappresentavano organizzazioni verticali di categoria. Tali federazioni coordinavano l'azione
dei gruppi locali, elaboravano piattaforme rivendicative comuni, sostenevano scioperi locali e
nazionali, stabilivano condizioni contrattuali uniformi.
Nel 1906 viene costituita una nuova struttura organizzativa confederale, la CGdL (“Confederazione
Generale del Lavoro”), che riunisce tutti i soggetti lavoratori appartenenti ai diversi ambiti lavorativi
(con lo scopo di tutelarne gli interessi); parallelamente alla nascita di una confederazione dei datori di
lavoro.
L'avvento del fascismo segnò il passaggio da un sistema caratterizzato dall'astensione legislativa, ad
uno minutamente regolato dalla legge: legge repressiva che soppresse, insieme alla libertà
sindacale, anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
La legge sindacale fascista (l.563/1926 ) innanzitutto aboliva la libertà di organizzazione sindacale
dettando regole che consentivano di sopravvivere solo il sindacato fascista, l'unico riconosciuto – che
assumeva la personalità giuridica di diritto pubblico (ed era quindi, a tutti gli effetti, un organo dello
stato): tale sindacato aveva il compito di stipulare contratti collettivi (corporativi), di diritto pubblico
(almeno secondo la dottrina prevalente – in quanto posti infatti in essere da soggetti di diritto
pubblico, per finalità pubbliche, a tutela di interessi pubblici): la disciplina del contratto collettivo
corporativo si può leggere nelle disposizioni sul contratto collettivo tuttora contenute nel Codice
Civile. Sempre con la legge sindacale del '26 veniva creata una magistratura specifica del lavoro che
regolava il contenzioso individuale (con il potere di emanare ordinanze con efficacia erga omnes).
Contestuale al definitivo crollo del fascismo, nasceva (da una trattativa tra gli esponenti sindacali
legati ai tre partiti maggioritari: DC, PC e PS) la prima Confederazione Sindacale Unitaria (la CGIL),
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 3 di 105
sindacato unico articolato in federazioni nazionali di categoria, sindacati provinciali e Camere del
Lavoro: con l'unità sindacale, la CGIL si proponeva come forza autonoma rispetto ai partiti politici, ma
coinvolta nella soluzione dei problemi di sviluppo economico e sociale del paese, portatore di
interessi generali di tutti i lavoratori, chiamati alla solidarietà ed al sacrificio degli interessi particolari,
in nome di un'impegnata collaborazione alla ricostruzione del paese.
La CIGL si era data una struttura di massa, capace di accogliere e dirigere una base diversificata ed
in grandissima crescita. Nei primi anni di vita firmò importanti accordi, agendo in una prospettiva
essenzialmente politica di unità e solidarietà nazionale.
La scissione del 1948 (con l'uscita dei democristiani e dei socialisti autonomisti che costituirono altre
confederazioni, GISL e UIL), dovuta alla stretta correlazione tra partiti e sindacato, apriva una fase di
conflitto tra sindacati, il cui risultato fu un indebolimento dell'intero movimento sindacale.
L'EVOLUZIONE POST-COSTITUZIONALE DEL DIRITTO SINDACALE
Al vuoto legislativo in merito a quanto disposto dall'art. 39 Cost, si sostituì un meccanismo di
“privatizzazione del diritto sindacale” nel quale fondamentale rilievo è assunto dalle “organizzazioni di
autonomia collettiva” (garantite dalla libertà dell'organizzazione sindacale sancita dall'art. 39),
organizzazioni di diritto privato che mirano a tutelare “interessi collettivi” – sintesi degli interessi
individuali di una collettività costituita su basi volontarie: in quest'ottica gli interessi individuali dei
singoli appartenenti al gruppo vengono subordinati all'interesse collettivo.
Tali organizzazioni, che nella realtà italiana si presentano come associazioni sindacali, sono
associazioni di fatto – mancando della personalità giuridica che la Costituzione fa conseguire alla
registrazione regolata dalla legge (legge che nel nostro ordinamento non vi è mai stata).
Con lo Statuto dei Lavoratori del '70 viene a delinearsi il ruolo dello stato nei confronti del diritto
sindacale, da una parte quale garante dei diritti dei singoli lavoratori anche come protagonisti delle
vicende sindacali, e dall'altra quale “promotore” dell'azione sindacale nei luoghi di lavoro.
Se oggi si è persa l'idea dell'autonomia originaria dell'ordinamento sindacale, permane l'originaria
concezione dei rapporti tra ordinamenti che consente di giustificare la produzione normativa delle
organizzazioni sindacali, attribuendole il carattere di fonte extra-legislativa.
LA LIBERTA' SINDACALE NELL'ORDINAMENTO VIGENTE
La Costituzione nel primo comma dell'art. 39 afferma che << l'organizzazione sindacale è libera >> .
Con riferimento all'art. 18 Cost. , che sancisce il diritto dei cittadini ad associarsi liberamente, il primo
comma dell'art. 39 Cost. assume il significato di affermare la legittimità del fine sindacale.
Analizzato di per sé, il primo comma dell'art. 39 Cost va letto nel senso che la libertà di
organizzazione sindacale è da intendersi come libertà di organizzarsi liberamente, senza che sia
imposto un determinato modello organizzativo (quale quello dell'associazione).
In particolare, nell'esempio italiano, la forma di organizzazione sindacale generalmente adoperata è
l'associazione (generalmente non riconosciuta – ma anche occasionale).
D'altra parte l'art. 39 non definisce cosa debba intendersi con il termine “organizzazione sindacale”:
la dottrina si è orientata nel senso di definire “organizzazione sindacale”, l'attività diretta
all'autotutela degli interessi connessi allo svolgimento di un'attività di lavoro (non necessariamente
del solo lavoro subordinato) con riferimento ad un'aggregazione di soggetti (prevista quindi di una,
seppur minima, struttura di coordinamento degli interessi individuali).
Ed anzi secondo un'opinione largamente diffusa, oggetto della garanzia costituzionale è proprio
l'attività finalizzata all'organizzazione sindacale, che dev'essere libera da interferenze dei pubblici
poteri e dei soggetti privati.
Sicuramente la libertà sindacale affermata dalla Costituzione è da intendersi riferita anche alla libertà
di agire: sia per l'individuo, libero di coalizzarsi con altri per tutelare i propri interessi e di partecipare
all'attività dell'organizzazione a cui aderisce – sia collettiva, per cui l'organizzazione è libera di
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 4 di 105
svolgere attività di autotutela degli interessi dei lavoratori che ad essa aderiscono.
Infine (sempre sull'interpretazione del primo comma, tale libertà si configura anche come libertà (in
senso negativo) di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale (così come si desume dalla
lettura dello statuto dei lavoratori, che nell'art. 15 sancisce la nullità di ogni atto o patto diretto a
subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o meno ad un'associazione
sindacale, ovvero cessi di farne parte).
Per quanto riguarda i successivi commi dell'art. 39 Cost, si afferma che << ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le
norme di legge. >> : una volta registrati (e tale registrazione è subordinata all'accertamento della
presenza di uno statuto che sancisca <<un ordinamento interno a base democratica>>), i sindacati
assumono personalità giuridica e <<possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce>>.
Ad oggi, non esistono sindacati registrati e muniti di personalità giuridica, per cui il contratto collettivo
non ha efficacia erga omnes, e non è direttamente applicato ai non iscritto al sindacato.
A tutela sempre della libertà sindacale affermata dalla costituzione, onde garantire la “genuinità” delle
organizzazioni sindacali, l'art. 17 dello Statuto dei Lavoratori sancisce il <<divieto ai datori di lavoro
ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti,
associazioni sindacali di lavoratori>>.
Favorire illecitamente un sindacato costituisce condotta antisindacale (in quanto si configura come
comportamento diretto <<ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale>>, ex
art. 28 Statuto dei Lavoratori) ed il giudice dovrà condannare il datore di lavoro a cessare tale
comportamento, ed a rimuovere gli effetti pregiudizievoli che ne siano derivati agli altri sindacati ed
eventualmente ai singoli lavoratori danneggiati.
Libertà sindacale, almeno per la dottrina prevalente, è estesa nel nostro ordinamento anche ai datori
di lavoro, in quanto l'art. 39 Cost. non distingue tra le parti sociali contrapposte: naturalmente i datori
di lavoro non godono degli stessi diritti sindacali di cui godono i lavoratori, tutelati nelle loro libertà
sindacali dallo Statuto – e la giustificazione di tale sbilanciamento normativo è facilmente
giustificabile sulla base dell'“eguaglianza sostanziale” garantita dalla Costituzione (ex. art. 3, comma
2 Cost. ).
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE
All'inizio del '900 la maggior parte dei sindacati erano organizzati per “categoria” (cioè per ramo
d'industria). Durante il periodo corporativo, soppressa la libertà sindacale, venne imposta una
struttura articolata su due soli livelli: uno orizzontale (intercategoriale – la Confederazione) ed uno
verticale (di categoria: la Federazione Nazionale). Per ogni categoria (settore produttivo) erano
riconosciute una sola Federazione Nazionale dei Datori di Lavoro ed una sola Federazione
Nazionale dei Lavoratori occupati nel settore produttivo. Con il ritorno alla libertà sindacale, nel
dopoguerra rinacque il pluralismo.
Oggigiorno, la struttura organizzativa delle maggiori confederazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) è
complessa, e può essere schematizzata distinguendo la linea di organizzazione orizzontale
(intercategoriale) dalla linea di organizzazione verticale (di categoria). Nell'ambito di ciascuna di
queste linee occorre distinguere i diversi livelli territoriali:
– l'organizzazione orizzontale si articola su tre livelli:
– la struttura territoriale;
– la struttura regionale;
– la struttura nazionale.
– l'organizzazione verticale si articola su quattro livelli:
– la struttura al livello del luogo di lavoro;
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 5 di 105
la struttura territoriale di categoria;
la struttura regionale di categoria;
– la struttura nazionale di categoria (Federazione).
Tra la pluralità di sindacati “autonomi” (per distinguerli dai tre maggiori sindacati confederati) vi sono
strutture organizzative differenti legate alla definizione di un'area di rappresentanza ristretta ad
un'attività professionale, ovvero ad un settore specifico di attività – peraltro tali sindacati si sono
andati progressivamente riunendo in organizzazioni di tipo confederale.
–
–
Le organizzazioni dei datori di lavoro (a differenza dei sindacati di lavoratori) non presentano rilevanti
divisioni su basi ideologiche, ma più che altro per settori economici – in questi le strutture orizzontali
(territoriali e nazionali) assumono ampie funzioni e ruoli più importanti di quelli verticali di categoria
(almeno sul piano delle politiche sindacali).
IL RAPPORTO TRA SINDACATO ED ISCRITTI
Poiché nell'ordinamento italiano – non essendo stata mai emanata la legge alla quale l'art.39 riserva
l'attuazione dei suoi commi 2, 3 e 4 – i sindacati non possono chiedere la “registrazione” e
conseguire per questa via la personalità giuridica prevista dalla costituzione, la dottrina ha conferito a
tali soggetti (almeno qualora siano organizzati in forma associativa) la soggettività giuridica delle
associazioni non riconosciute (di cui agli artt. 36, 37 e 38 c.c. – che però hanno come primaria ratio la
tutela dei terzi creditori dell'associazione – mentre sul piano dei rapporti interni, secondo parte della
dottrina, potrebbero essere applicate analogicamente alcune disposizioni riferibili al fenomeno
associativo, ex artt. 14 – 35).
La natura giuridica di associazione non riconosciuta comporta una soggettività giuridica distinta da
quella dei singoli soggetti che vi aderiscono. Tradizionalmente, la dottrina ha ricondotto il rapporto tra
l'associazione ed i destinatari della sua attività negoziale al meccanismo della rappresentanza
volontaria (il singolo lavoratore nell'iscriversi ad un sindacato conferisce a questo il proprio mandato
di rappresentanza, volontaria in quanto l'iscrizione è libera e volontaria – non obbligatoria).
Nell'esercizio di tale rappresentanza, il sindacato si fa portatore dell'interesse collettivo, sintesi degli
interessi individuali dei singoli iscritti: la subordinazione dell'interesse del singolo a tale interesse
collettivo (e la conseguente subordinazione dell'autonomia individuale del singolo a quella collettiva)
è stata tradizionalmente ricondotta all'istituto del “, con cui l'iscritto legittima il sindacato ad agire per
proprio conto; altro ramo della dottrina aveva costruito la nozione di “rappresentanza associativa”,
per cui tale subordinazione dell'associato è effetto del contratto associativo (ed in tale direzione, più
recenti teorie che fanno discendere il potere negoziale del sindacato, non nel contratto, ma nel
metodo collegiale e nel principio di maggioranza che governano la formazione della volontà
collettiva). Nell'evoluzione dottrinale della giustificazione del potere negoziale del sindacato (anche
influenzata dalla nascita, negli anni '70, di forme non associativi di rappresentanza del lavoratori), si
sono fatte strada ricostruzioni che non fanno riferimento all'istituto del mandato e che considerano
tale potere come proprio del sindacato stesso – e, in tale ricostruzione l'interesse collettivo è da
intendersi come interesse proprio del sindacato, mediazione di interessi diversi, che non sono
necessariamente gli interessi dei suoi iscritti, per cui la rappresentanza è rappresentanza
tendenzialmente generale.
E' la stessa evoluzione normativa che – attribuendo funzioni normative ai sindacati maggiormente
rappresentativi – ha spinto la dottrina verso schemi di rappresentanza differenti da quella volontariaassociativa, privilegiando la dimensione collettiva rispetto a quella individualistica.
Il concetto di rappresentatività riguarda la “capacità” di dare effettiva tutela agli interessi collettivi
che si assume di rappresentare: nel momento in cui lo legge affida alla rappresentatività la funzione
di qualificare e selezionare i soggetti collettivi, questa assume il valore di concetto giuridico.
Collegamento tra maggiore rappresentatività e rappresentanza negoziale dei sindacati maggiormente
rappresentativi emerse nella stagione della c.d. “legislazione dell'emergenza” – nella quale ci si pose
l'obiettivo di dare ai contratti stipulati da tali sindacati efficacia erga omnes (subordinando quindi il
potere negoziale di alcuni sindacati – e dei loro iscritti – rispetto ad altri). La legislazione dell'epoca
identificò le s.m.r. nelle confederazioni maggiormente rappresentative (senza peraltro imporre verifica
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 6 di 105
della consistenza di un effettivo consenso maggioritario fra i lavoratori). Tale formula, per la sua
incapacità di esprimere adeguatamente l'ampio e frammentato universo degli interessi di lavoro,
conobbe un lento ma inesorabile declino.
Nell'odierno ordinamento la rappresentatività ha assunto il significato di “capacità” di rappresentare
una consistente quantità (e/o la maggioranza) dei potenziali interessati – subordinata a criteri di
valutazione dell'effettività di tale condizione.
Nella recente legislazione (con particolare riferimento alla l. 549/1995 ed al d.lgs 276/2003) il criterio
di selezione (ai fini di individuazione del contratto collettivo al quale la legge riconduce determinati
effetti legali) è quello dei “sindacati comparativamente più rappresentativi” – per cui, in presenza di
più contratti collettivi per la medesima categoria, la legge dà al contratto stipulato dai sindacati che
godono del maggior consenso dei lavoratori interessati l'autorizzazione ad introdurre integrazioni o
deroghe della disciplina legale. Per quanto riguarda la quantificazione di tale consenso, il solo
riferimento al numero dei lavoratori iscritti al sindacato (con riferimento all'art. 39 comma 4 Cost –
che conferisce ai sindacati registrati rappresentanza unitaria <<in proporzione dei loro iscritti>>)
segnerebbe il ritorno alle vecchie concezioni privatistiche di rappresentanza sindacale, né si potrebbe
apprezzare l'effettiva capacità del sindacato di aggregare il consenso dei lavoratori al di fuori della
cerchia degli iscritti.
LA RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE
Nel primo periodo post-corporativo, una prima forma di organo sindacale a livello aziendale era
rappresentata dalle Commissioni Interne, organo elettivo (rappresentativo quindi di tutti i lavoratori)
con funzioni propositive, consultive e conciliative, che era però escluso dalla competenza
contrattuale a livello aziendale, riservata alle organizzazioni sindacali (anche perché la CGIL unitaria
non era preparata ad affrontare un sistema di decentramento della contrattazione).
Ciò nonostante, le CI esercitavano “abusivamente” attività contrattuali – per quanto prive di alcuna
legittimazione – soprattutto con riguardo a contenuti di carattere essenzialmente economico: ciò
rappresentava dunque una prima forma di contrattazione aziendale (seppur non riconosciuta).
Dopo la scissione, CISL (seguita da CGIL) decise di dare costituzione ad un sistema di Sezioni
Sindacali Aziendali (SAS), che fungessero da “anello di congiunzione” tra movimento sindacale e vita
aziendale (pur restando il potere contrattuale in azienda affidato al sindacato provinciale di
categoria).
Nella mutata situazione storica post '68, nacquero nuove forme di rappresentanza dei lavoratori: i
delegati (rappresentanti dei lavoratori) riuniti nei consigli unitari dei delegati (i c.d. “consigli di
fabbrica”, CdF), con riconosciuti poteri di contrattazione nei luoghi di lavoro.
Lo Statuto dei Lavoratori garantisce e tutela i diritti sindacali nei luoghi di lavoro: l'art. 14 afferma che
<< il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a
tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.>>
L'art. 19 comma 1 dello Statuto prevede che le RSA possano essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori (anche non iscritti al sindacato nel cui ambito la RSA è costituita) in ogni unità produttiva,
nell'ambito (a seguito della modifica apportata con un referendum del 1995 in merito) di qualunque
associazione sindacale (anche meramente aziendale) – a patto che questa sia firmataria (cioè, come
ha affermato la Cassazione, abbia preso attivamente parte alla trattativa contrattuale) di un contratto
collettivo applicato nell'unità produttiva. Tale nuovo criterio di rappresentatività è effettivamente
desumibile ed accertabile dalla stipulazione del contratto collettivo – per cui è indice dell'effettiva
capacità del sindacato di imporsi come controparte contrattuale: a tal merito, la Cassazione ha
negato la possibilità di costituire una RSA ad un sindacato per la ragione che il datore di lavoro non
era iscritto ad alcuna organizzazione datoriale firmataria del contratto nazionale di categoria , e no
aveva dato adesione a tale contratto collettivo, limitandosi ad applicare ai propri dipendenti solo i
minimi retributivi previsti.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 7 di 105
Per quanto riguarda la struttura delle RSA, la legge non si pronuncia tassativamente, ma piuttosto
sembra individuare una “categoria” di organismi rappresentativi nella quale possono confluire una
molteplicità di strutture associative dei lavoratori che, in ogni caso (come ribadito dalla Cassazione),
rappresentano una struttura autonoma rispetto al sindacato dotata di propria soggettività giuridica –
distinta quindi da quella dell'associazione nel cui ambito è stata costituita.
La Cassazione ha affermato che la RSA necessita di una (pur informale) “recezione” da parte del
sindacato di riferimento, che potrebbe anche “sconfessare” l'iniziativa dei lavoratori – nel qual caso la
giurisprudenza di merito ha si è espressa nel senso che la revoca del riconoscimento della RSA ne
comporti anche il venir meno.
La struttura “aperta” delle RSA ha consentito, per lungo periodo, che nella realtà delle imprese diritti
e poteri che la legge riservava alle RSA fossero esercitati dai CdF – che in virtù del patto federativo
del 1972, CGIL, CISL e UIL avevano riconosciuto come propria struttura di base: i CdF da una parte
erano quindi legittimati dal sindacato, e dall'altra dal voto sia di iscritti che non iscritti al sindacato.
In ogni caso i CdF non si presentavano come esclusiva struttura di rappresentanza sindacale,
essendo comunque possibile per le minoranze dissenzienti costituire proprie RSA.
Negli anni '80 lo stato iniziò ad assumere un ruolo attivo nel negoziato tra le parti sociali, nella
cosiddetta prassi concertativa (che darà vita a più Protocolli) – promuovendo anche la contrattazione
collettiva con numerosi rinvii legislativi alla contrattazione collettiva (di carattere talvolta anche
derogatorio della legge).
Nel disegno del Protocollo del 1993 (quello che viene considerato il miglior esempio di concertazione
sociale nell'esperienza italiana delle relazioni industriali), viene disciplinata la RSU, una struttura
sindacale aziendale unitaria a composizione mista (in parte elettiva ed in parte associativa), canale
unico di rappresentanza dei lavoratori – con funzioni di rappresentanza dei lavoratori che lo eleggono
e, d'altra parte, di carattere sindacale (come la contrattazione aziendale).
La RSU si presenta come un organismo rappresentativo della generalità dei lavoratori, che trova nel
mandato elettorale (e dunque nel vincolo di rispettare la volontà della maggioranza) la fonte di
legittimazione del proprio potere di rappresentanza degli interessi dei lavoratori.
Le associazioni che non partecipano all'elezione della RSU (con la quale altrimenti si
impegnerebbero espressamente a non costituire RSA) potrebbero (qualora siano dotate dei requisiti
di cui all'art 19 dello Statuto) costituire proprie RSA. Qualora la RSU abbia stipulato un contratto
collettivo aziendale (nei limiti e cono le modalità previste dal contratto collettivo aziendale) si pone il
problema di stabilire quale efficacia abbia questo qualora sia presente nell'unità produttiva anche una
RSA diversa dalla RSU.
Se in linea teorica ogni sindacato che ne abbia i requisiti potrebbe costituire una RSA nel proprio
ambito, i sindacati firmatari del CCN hanno optato per la costituzione di una rappresentanza unitaria,
consentita dai datori di lavoro (che si sono obbligati in tal senso mediante la stipulazione dell'accordo
interconfederale).
Infine, la Cassazione ha affermato la natura di organo collegiale della RSU non esclude che i diritti
che lo Statuto attribuisce ai dirigenti della RSA restino prerogative proprie della “persona del
sindacalista”, e non della RSU nel suo complesso.
Se nell'art. 9 dello Statuto è previsto che i lavoratori <<mediante loro rappresentanze>> avessero
<<diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali [..] >>: tale rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletta (in seguito al
d.lgs 626/1994) direttamente dai lavoratori nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti,
mentre e designato nell'ambito delle RSA qualora siano presenti nell'unità produttiva oltre 15
dipendenti.
LE PREROGATIVE DELLA RSA
Prerogative delle RSA (così come contenute nello Statuto) sono:
– il potere di convocare l'assemblea (ex. art. 20) nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 8 di 105
–
–
fuori dell'orario di lavoro (o durante, entro il limite legale di 10 ore l'anno, od i più favorevoli
previsti dalla contrattazione collettiva) – e del diritto di partecipare a tale assemblea sono titolari i
singoli lavoratori occupati nell'unità produttiva, anche non iscritti al sindacato nel cui ambito è
costituita la RSA; l'art. 14 sembrerebbe inoltre garantire anche ai lavoratori di convocare
spontaneamente l'assemblea.
il potere di indire un referendum sindacale (ex. art. 21), da svolgersi fuori dell'orario di lavoro nei
locali del datore di lavoro, (a patto che ad indirlo sian congiuntamente tutte le RSA), al quale
possono partecipare <<tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria
particolarmente interessata>>, che abbia come oggetto esclusivamente <<materie di interesse
sindacale>>;
il potere di affissione (ex. art. 25), in appositi spazi, testi e comunicati inerenti a materi di
interesse sindacale e del lavoro.
L'art. 27, inoltre, obbliga il datore di lavoro a porre a disposizione delle RSA, all'interno dell'unità
produttiva, o nelle immediate vicinanze, un locale comune idoneo allo svolgimento delle loro funzioni.
Per quanto lo statuto non attribuisca espressamente alle RSA (salvo che riguardo ai particolari casi di
impianti audiovisivi di controllo ed alle visite personali) il potere di stipulare contratti collettivi a livello
aziendale, nella prassi le RSA hanno svolto il ruolo di agenti contrattuali a livello aziendale , in modo
tanto rilevante da far progressivamente decrescere l'intervento (in tale contrattazione) dei sindacati
provinciali.
Infine, sempre al di fuori dello Statuto, sia nella legge che nella contrattazione collettiva hanno trovato
sviluppo i diritti sindacali di informazione e consultazione, e di controllo sulle scelte organizzative e
sulle politiche delle imprese.
LA NOZIONE DI UNITA' PRODUTTIVA PER L'APPLICAZIONE DEL TITOLO III DELLO STATUTO
Nell'art. 35 lo Statuto dei lavoratori definisce il campo di applicazione del proprio Titolo III:
per le imprese commerciali ed industriali, si applicano tali disposizioni <<a ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupano più di quindici dipendenti >> (od alle
imprese agricole che occupino più di cinque dipendenti). Tale soglia numerica può essere raggiunta
sommando gli addetti a più unità produttive di minore dimensione, purché abbiano sede nello stesso
Comune.
Se lo Statuto non dà una definizione di “unità produttiva”, la Corte Costituzionale ribadisce che l'unità
produttiva si caratterizza all'interno dell'organizzazione dell'impresa per la sua autonomia, sia dal
punto di vista economico strutturale sia da quello del risultato produttivo.
La previsione di una soglia minima numerica, come affermato dalla Corte, trova la sua legittimità
nella necessità di collegare prerogative e diritti ricondotti alla RSA all'esistenza di un interesse
collettivo espresso da un gruppo di lavoratori dotato di una pur minima consistenza.
LA TUTELA DELLA LIBERTA' SINDACALE NELLO STATUTO DEI LAVORATORI
Lo Statuto dei Lavoratori si occupa, tra le altre cose, di realizzare nel nostro ordinamento la
protezione della libertà sindacale sancita dalla Costituzione.
In particolare, il Titolo II della legge contiene una serie di disposizioni il cui obiettivo è quello di
rafforzare l'effettività del principio di libertà sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
L'art. 15 sancisce la nullità di qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l'occupazione di un
lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un'associazione sindacale (ovvero cessi di
farne parte) – così come qualunque patto che discrimini il lavoratore nell'assegnazione di qualifiche o
mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o che comunque gli rechi pregiudizio a
causa della sua affiliazione od attività sindacale, ovvero della partecipazione ad uno sciopero.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 9 di 105
La discriminazione può altresì avvenire qualora siano attribuiti benefici ai lavoratori che tengano un
determinato comportamento con riferimento all'esercizio della loro libertà sindacale (ed infatti l'art. 16
vieta al datore di lavoro <<trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatori>>).
Lo Statuto non impone un trattamento uniforme di tutti i lavoratori, ma si limita a vietare che tra
lavoratori “comparabili” vengano operate differenze di trattamento illecite (come nel caso del c.d.
“premio anti-sciopero”). Per quanto l'art. 15 non preveda la nullità del trattamento collettivo
discriminatorio, parte della dottrina si è orientata nel senso di concedere l'esperibilità dell'azione di
nullità per violazione di norma imperativa di legge da qualunque lavoratore vi abbia interesse: d'altra
la materia dei trattamenti economici collettivi discriminatori per ragioni sindacali viene ricondotta
all'alveo della condotta antisindacale.
L'art. 26 dello Statuto (nel Titolo III) contiene una disposizione che garantisce ai singoli lavoratori la
possibilità di svolgere attività tipicamente sindacali, quali il proselitismo ed il collettaggio. In generalo,
in ogni caso, ogni ogni altra attività di propaganda è consentita nella misura in cui possa essere
ricondotta nell'alveo dell'art. 1 dello Statuto, che riconosce ai lavoratori il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero nei luoghi dove prestano la propria opera, nel rispetto dei principi della
Costituzione e delle norme dello Statuto. Il limite alle sole attività è individuato nello stesso art. 26 nel
vincolo del <<normale svolgimento dell'attività lavorativa>> (onde evitare che tale attività provochi
turbative all'attività degli altri lavoratori ed all'organizzazione aziendale).
LA REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
La condotta antisindacale ed il procedimento per la sua repressione sono regolati dall'art. 28 dello
Statuto dei Lavoratori: si configura condotta antisindacale ogniqualvolta <<il datore di lavoro ponga in
essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale
nonché del diritto di sciopero>>.
La dottrina prevalente, concordemente all'orientamento espresso dalla Cassazione, ha respinto i
tentativi di interpretare estensivamente la norma ed applicarla al di fuori del <<conflitto che vede
contrapposti nei luoghi di lavoro prestatori e datori di lavoro>>, fermo restando che nel caso che i
comportamenti antisindacali siano posti in essere da dirigenti (o da chi altri sia delegato ad esercitare
il potere del datore di lavoro) sarà il datore di lavoro a risponderne.
Per quanto riguarda il “comportamento antisindacale”, l'art. 28 letteralmente lo fa configurare qualora
sia “diretto” <<ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto
di sciopero>>: con l'espressione “diretto” l'interpretazione attualmente prevalente (avvallato dalla
Cassazione) intende non un atteggiamento “intenzionalmente diretto”, ma a oggettivamente idoneo
(anche solo potenzialmente) a produrre lesione delle libertà sindacali.
Per quanto riguarda il procedimento, quello regolato dall'art. 28 è un procedimento speciale e di
urgenza: qualora il giudice accolga il ricorso, condannerà il datore di lavoro alla cessazione della
condotta antisindacale ed alla rimozione degli effetti.
IL DIRITTO INTERNAZIONALE
Il diritto internazionale non viene direttamente applicato, ma passa dal parlamento ed entra nel diritto
interno con una legge di notifica.
Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) è costituita da 14 rappresentanti dei governi, dei
datori di lavoro e dei lavoratori: questa si propone anche finalità umanitarie (come l'abolizione del
lavoro minorile) di difficile realizzazione, vista la partecipazione di diversi paesi con diverse culture
all'interno della stessa organizzazione.
Le convenzioni sono accordi tra stati che individuano comportamenti standard che dovrebbero
essere adottati dagli stati: le convenzioni (accompagnate da raccomandazioni) trattano i principi
fondamentali da seguire.
La Commissione Europea rappresenta il governo dell'Unione Europea anche se deve sempre
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 10 di 105
confrontarsi con il Parlamento Europeo. Ha funzione di controllo del diritto interno dei singoli stati,
che deve essere conforme a quello comunitario.
Il lavoro è sempre stato un'area di interesse del diritto comunitario, che negli ultimi anni è
prepotentemente entrato nel diritto interno del lavoro.
La fonte primaria del diritto comunitario è il Trattato Costitutivo dell'Unione Europea (che ne
rappresenta la base giuridica), dal quale derivano le fonti derivate: direttive, raccomandazioni e
regolamenti.
Le direttive, vincolanti per gli stati membri (che sono i destinatari delle stesse – non i cittadini, salvo
che risultino sufficientemente chiare), che conservano in ogni caso un margine di discrezionalità, in
quanto possono decidere quali strumenti utilizzare per attivarle (questo perché ogni stato ha il proprio
istituto giuridico, e di conseguenza la direttiva andrà applicata tenendo conto della legislazione dello
stato).
Il c.d. recepimento, è il modo in cui lo stato italiano si conforma alle direttive: qualora taluni elementi
delle legislazione interna non siano conformi alla normativa comunitaria, verranno emanate quelle
disposizioni che permettano una migliore integrazione tra diritto interno e comunitario.
Per quanto riguarda le modalità del recepimento esso può avvenire:
– in via diretta, qualora gli articoli della direttiva siano inseriti direttamente nel testo di una legge
dell'ordinamento interno;
– per via delegata, ed in tal caso la direttiva assume il valore di legge delega entro la quale il
governo dovrà emanare un relativo d. lgs.
Qualora la direttiva non sia recepita in tempo, o sia recepita male, si potrà aprire la c.d. procedura di
infrazione nella quale verrà verificato lo stato d'inadempienza dello stato membro.
La questione è esposta alla Corte di Giustizia che, qualora valuti che il diritto interno non si sia
conformato alla direttiva può pronunciare una condanna nella quale si stabilisce che:
– che la direttiva venga applicata direttamente al diritto interno;
– che la norma venga interpretata (secondo le indicazioni della stessa Corte) così da integrare
diritto comunitario e diritto interno.
Qualora il mancato recepimento di una direttiva (qualora questa non possa essere direttamente
applicata al diritto interno) vada a ledere un diritto del cittadino, lo stato sarà obbligato a risarcire il
danno causato (ed un precedente importante in merito è rappresentato dal caso Francovich).
Per quanto riguarda le sanzioni da applicare nei confronti dei cittadini, è lasciata discrezionalità al
singolo stato membro, a patto che queste rispettino determinati principi: devono infatti essere
effettive, deterrenti e proporzionate.
I regolamenti sono norme (vincolanti) direttamente applicabili nei confronti del singolo cittadino e
riguardano materie di competenza esclusiva del diritto comunitario.
Le raccomandazioni sono atti non vincolanti di natura generica.
La carta fondamentale dei diritti fondamentali è una fonte anomala (di debole valore giuridico) che
non è mai stata inserita nel trattato costitutivo: rappresenta una mera proclamazione di quelli che gli
stati membri considerano essere i diritti fondamentali della persona.
Se le hard law sono leggi vincolanti, le soft law sono disposizioni non vincolanti nelle quali sono
stabilite strategie ed obiettivi (come avviene per il sistema pensionistico, oggetto di un sistema aperto
di coordinamento).
Obiettivi della comunità europea sono:
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 11 di 105
promuovere la parità dei sessi;
promuovere lo sviluppo sociale;
– promuovere un armonico sviluppo economico tra gli stati.
Per raggiungere tali obiettivi, la Commissione Europea promuove una proposta di direttiva che prima
di diventare effettiva percorre un lungo iter nel quale ha sempre maggiore peso il Parlamento
Europeo.
L'art. 138 del tratta promuove un diverso modo di elaborazione delle direttive in cui, oltre a chi la
redige, assumono valore decisivo le parti chiamate in causa, che vengono preventivamente
consultate.
–
–
Per quanto riguarda l'occupazione negli ultimi anni sono stati riconosciuti a livello internazionale
alcuni diritti con lo scopo di creare forza lavoro competente (quindi con obiettivi qualitativi e
quantitativi fissati di anno in anno tramite un “piano dell'occupazione”, di debole valore giuridico –
non vincolante, nella forma di raccomandazioni di soft-law).
Sempre sul piano dell'occupazione attenzione particolare è dedicata alla parità di trattamento sul
lavoro fra sessi (ex. art. 2 Trattato Costitutivo – supportato dall'art. 141, che pone obiettivi di
uguaglianza sostanziale; e dall'art. 13, che sancisce la legittimità normativa di prendere
provvedimenti per combattere le discriminazioni).
Il principio cardine della comunità europea è la libera circolazione di beni e capitali, nonché dei
lavoratori. Altri principi sono la libera concorrenza, il divieto di riconoscere diritti monopolistici ad
imprese pubbliche. Vige inoltre il c.d. principio della sussidiarità, che è diritto di intervenire qualora sia
opportuno riguardo a determinate materie.
LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Accanto al ruolo della legge, emerge nel diritto del lavoro la funzione del contratto collettivo che – per
quanto frutto dell'autonomia negoziale privata – ha nell'ordinamento vigente un'importante funzione
di fonte materiale.
In tale modello (come affermato dall'art.40 dello Statuto dei Lavoratori), la legge si pone come
disciplina dei minimi di trattamento (inderogabile se non “in mejus”, non fosse per alcune circostanze
nelle quali viene a mutare il verso dell'inderogabilità, soprattutto a causa dell'odierno rapporto di forte
integrazione tra le due fonti).
Rispetto alla legge, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, risulta una competenza
legislativa concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” tra Stato e Regioni: in tale ambito
la potestà legislativa spetta alle regioni entro i principi generali ed i limiti imposti dalla legge statale.
Anche per merito della dottrina, la competenza regionale è restata relegate a quelle tematiche che si
prestano con minori controindicazioni ad un'articolazione normativa su base territoriale, mentre
(come affermato dalla Corte Costituzionale) << la disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di
lavoro [..] rientra nella materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva dello Stato >> (così
come lo sono, con riferimento al diritto del lavoro, – sulla base di quanto stabilito dall'art. 117 Cost. –
le questioni inerenti all'ordinamento penale, alla giurisdizione ed alle norme processuali, alla giustizia
amministrativa, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, che devono essere garantiti a libello nazionale; sono invece di competenza concorrente –
oltre alla tutela e sicurezza sul lavoro – la tutela della salute, la previdenza complementare ed
integrativa).
In generale, << deve [..] ritenersi certamente precluso alle regioni di intervenire, in ambiti di potestà
normativa concorrente, dettando norme che vanno a incidere sul terreno dei principi fondamentali >>.
Sarà quindi compito della legge statale (onde evitare eventuali “federalismi” nella tutela dei diritti )
tutelare diritti del (come nel caso delle c.d. leggi anti-mobbing) preclusi alla potestà legislativa delle
regioni. D'altra parte (come dimostrato dalle sentenze della Corte in merito alla legittimità del d.lgs
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 12 di 105
276/2003 – nel caso specifico in materia di tirocini e stage esterni)
Tra le fonti del diritto del lavoro, è sicuramente fondamentale la legislazione comunitaria, che di fatto
è penetrata nel nostro ordinamento (sia attraverso il recepimento di direttive comunitaria, sia a
seguito di numerose sentenze della Corte di Giustizia) – molto più di quanto sia avvenuto per i
principi affermati nelle convenzioni e raccomandazioni elaborate nell'ambito dell'Oil.
In ultima istanza, presentando il rapporto di lavoro – secondo l'opinione dominante – origine e natura
contrattuale, risulta ineludibile il confronto tra diritto (individuale) del lavoro e diritto civile: benché il
primo si sia negli anni sempre maggiormente svincolato dalla disciplina civilistica, è sempre
nell'ambito della struttura di quest'ultima che si è costruito il discorso giuslavoristico.
IL CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO
Il contratto collettivo è una fonte anomala del diritto del lavoro, stipulato da enti (le organizzazioni
sindacali) che rappresentano una pluralità di soggetti (da una parte i lavoratori, e dall'altra i datori di
lavoro), nel quale si cerca di trovare “punto di mediazione” tra i diversi interessi collettivi (sintesi
degli interessi individuali dei singoli soggetti rappresentati).
Il capo III del Titolo I del Libro V del Codice Civile è dedicato al contratto collettivo di lavoro, ma fa
ancora riferimento al contratto collettivo di efficacia erga omnes presente nel periodo corporativo
dell'età fascista.
Le caratteristiche del contratto collettivo (che scaturiscono dal Codice Civile) sono:
– l'efficacia erga omnes (ex art. 2070), per cui se il datore di lavoro (nella codice, è utilizzata
l'espressione “imprenditore”, ma essa va riferita in generale al datore di lavoro) esercita distinte
attività tra loro autonome, si applicano ai rapporti di lavoro le norme previste dai contratti collettivi
per le singole attività.
– l'inderogabilità in pejus (ex art. 2077), per cui il rapporto tra contratto collettivo ed individuale si
risolve nel fatto che il secondo deve obbligatoriamente uniformarsi a quanto previsto dal primo
(salvo per quanto riguarda clausole più favorevoli al lavoratore previste dal contratto individuale) –
qualora una clausola del contratto individuale non sia conforma a quella corrispondente nel
contratto collettivo, essa viene sostituita da quella più favorevole contenuta in quest'ultimo.
– l'ultrattività (ex art. 2074), per cui il contratto collettivo mantiene la propria efficacia anche oltre la
scadenza – onde evitare un vuoto normativo – fino all'intervento di un nuovo regolamento
collettivo (e tale caratteristica ha fortemente rallentato i processi di rinnovamento dei contratti
collettivi nel dopoguerra – in quanto i datori di lavoro non avevano alcun interesse a rivedere tali
contratti; oggi infatti si ritiene inapplicabile.
LA LEGGE VIGORELLI
A partire dal momento in cui iniziarono ad essere applicati i nuovi contratti collettivi di diritto comune,
la giurisprudenza si trovò ad affrontare il problema della sostituzione dei contratti collettivi corporativi
ultrattivi ad opera dei nuovi contratti collettivi di diritto comune.
La giurisprudenza ritenne inapplicabile l'art. 2077, ai rapporti tra contratti collettivi aventi diversa
efficacia, ammettendo così che i nuovi contratti collettivi di diritto comune potessero derogare sia in
melius che in pejus a quelli corporativi: in tal modo si garantiva al dinamica della contrattazione
collettiva.
La sostituzione del nuovo contratto collettivo a quello corporativo poteva però avvenire solo in caso di
iscrizione del datore di lavoro all'associazione che aveva stipulato il nuovo contratto collettivo:
qualora il datore di lavoro non fosse iscritto all'associazione stipulante non sarebbe stato obbligato,
quindi, ad applicare il nuovo contratto collettivo, ed i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti avrebbero
continuato ad essere regolati dal contratto corporativo (che aveva mantenuto la propria efficacia erga
omnes).
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 13 di 105
La legge Vigorelli del 1959, mirava a sancire l'efficacia erga omnes dei nuovi contratti collettivi, onde
assicurare ai lavoratori trattamenti minimi economici e normativi uniformi, che potessero sostituire
integralmente i vecchi contratti collettivi corporativi ultrattivi: il legislatore si poneva l'obiettivo di
risolvere in via transitoria il problema della limitata efficacia soggettiva dei contratti di diritto comune.
Tale legge si presentava come una legge-delega che delegava il Governo <<ad emanare norme
giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi di trattamento economico e normativo nei
confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria>>.
L'estensione erga omnes dell'efficacia dei contratti collettivi nazionali di categoria avveniva mediante
la recezione in appositi decreti di tutte le clausole contenute nei contratti collettivi di cui si estendeva
l'efficacia: si prescriveva quindi che tutti i datori di lavoro (iscritti e non alle organizzazioni stipulanti),
che in ragione dell'attività effettivamente esercitata rientrassero nell'ambito della categoria per la
quale era stato stipulato il contratto collettivo poi recepito nel decreto, dovessero applicare il contratto
collettivo a tutti i lavoratori da loro dipendenti.
Infine, era regolato il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello (introducendo il principio
dell'inderogabilità in pejus anche tra gli stessi contratti collettivi):
– l'efficacia erga omnes riguardava infatti sia i contratti provinciali integrativi sia quelli provinciali
autonomi rispetto ai contratti nazionali, la cui estensione era subordinata alla presenza di
condizioni di miglior favore rispetto al contratto nazionale;
– le condizioni di carattere aziendale più favorevoli ai lavoratori rispetto a quelle previste dal
contratto collettivo erga omnes erano conservate.
– la regola di prevalenza del contratto collettivo più favorevole era prevista anche nella successione
nel tempo tra i contratti collettivi.
Infine, la legge stabiliva l'ultrattività oltre la scadenza del contratto collettivo erga omnes, fino a
quando non fosse sostituito da altro contratto collettivo di efficacia erga omnes.
La Corte Costituzionale fermò il tentativo del Parlamento di reiterare la Vigorelli (onde rendere meno
transitorio il meccanismo di estensione dei contratti collettivi) in quanto tale non presenta illegittimità
costituzionale (che avrebbe nel caso in cui andasse a sostituire definitivamente il sistema
costituzionale dell'art. 39), proprio in virtù del proprio carattere transitorio ed eccezionale, volta a
tutelare l'interesse pubblico della parità di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con riguardo alla sostituzione dei contratti resi erga omnes dalla Vigorelli, la stessa legge prevedeva
che questi potessero essere sostituiti con trattamenti previsti da nuovi contratti collettivi qualora
questi fossero più favorevoli ai lavoratori (per cui si prospettavano problemi simili a quelli riguardanti
la sostituzione dei contratti collettivi corporativi).
L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA CONTRATTUALE
Nel primo dopoguerra, e durante tutti gli anni '50, la contrattazione collettiva fu caratterizzata da una
forte centralizzazione; quando, all'inizio degli anni '60, le lotte per il rinnovo dei contratti collettivi di
alcune importanti categorie dell'industria (con particolare riferimento ad i metalmeccanici) portarono
al riconoscimento formale di una “contrattazione articolata” su più livelli – che raggiunse il proprio
apice all'inizio degli anni '70 (con il massimo decentramento e la minima istituzionalizzazione –
parallele, però, alla mancanza di procedure di coordinamento tra i livelli contrattuali).
Nella seconda metà degli anni '70, la crisi economica e le sfavorevoli condizioni del mercato del
lavoro determinarono un processo di ri-centralizzazione della contrattazione collettiva (ed un
conseguente ridimensionamento di quella aziendale).
La concertazione sociale (che era già apparsa nel sistema italiano negli anni '80) raggiunse il suo
apice con il Protocollo del 23 luglio del 1993, che pone le basi di un sistema contrattuale regolato
nella struttura e nel funzionamento.
Secondo quanto previsto dal Protocollo, il sistema contrattuale è articolato su due livelli:
– il contratto nazionale di categoria (di durata quadriennale per la parte normativa, e biennale per
la parte salariale);
– il contratto aziendale (di durata quadriennale), di competenze delimitate dal contratto nazionale,
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 14 di 105
con esclusione del potere di disciplinare materie già regolate nel contratto nazionale, e con
competenze in materia salariale sulla sola parte variabile legata agli incrementi della produttività
dell'impresa e del lavoro.
La coerenza tra i due livelli del sistema contrattuale è affidata alla disciplina delle RSU.
Nella seconda metà degli anni '90 sono aumentate le esperienze di contrattazione territoriale, più
vicine alle esigenze delle realtà locali e delle strutture produttive di piccole dimensioni, alle quali non
risponde la contrattazione nazionale centralizzata e per le quali la contrattazione aziendale risulta
inadeguata: tali esperienze hanno portato a forme di accordi di concertazione sociale a livello locale
(i cd. patti territoriali e contratti d'area) che contengono al loro interno anche veri accordi collettivi.
che incidono sulla disciplina dei rapporti di lavoro, talora in deroga ai contratti collettivi nazionali di
categoria.
La contrattazione territoriale ha trovato sostegno ed impulso nel “Patto di Natale” del '98, che ha
chiuso la stagione della concertazione sociale.
Il legislatore ha poi cercato di favorire l'adesione ai contratti collettivi con una serie di iniziative:
– i contributi che il datore di lavoro deve versare per il trattamento di maternità e pensione sono
calcolati in base alle previsioni del contratto collettivo;
– sono garantite agevolazioni per i datori di lavoro che aderiscono al contratto collettivo;
– il datore di lavoro non è tenuto a mandare copia del contratto collettivo a tutti i lavoratori e può
semplicemente fare rinvio al contratto collettivo.
IL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE
La dottrina dei primi del 1900 qualificava il contratto collettivo come un contratto unico, collettivo in
quanto stipulato da soggetti che rappresentavano una collettività, vincolante per le parti, dotato della
funzione di norma comune che predetermina in modo uniforme il contenuto dei contratti individuali di
lavoro.
Con l'avvento del fascismo, la legge sindacale del 1926 trasformava il contratto collettivo in contratto
di diritto pubblico (concluso tra enti pubblici, di efficacia erga omnes).
I contratti collettivi stipulati nel secondo dopoguerra (anche a causa della mancata attuazione dei
commi 2,3 e 4 dell'art. 39 Cost) sembrerebbero invece potersi ricondurre a contratti “di diritto
comune”. La teoria del contratto collettivo di diritto comune trova il proprio fondamento nella teoria
della rappresentanza sindacale.
Lo scopo del contratto collettivo è quello di esercitare nei confronti dei datori di lavoro la funzione
“normativa” di predeterminare il contenuto essenziale dei contratti di lavoro di cui questi diverranno
soggetti – con riguardo sia al trattamento economico dei lavoratori che tutti gli altri aspetti del
rapporto di lavoro. La regolazione dei rapporti tra datori e lavoratori è effettuata in virtù del potere di
rappresentanza volontaria che questi conferiscono alle parti collettive che stipulano il contratto
collettivo.
Per quanto riguarda la forma, la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso che viga il principio
di libertà formale; sempre la giurisprudenza prevalente è dell'opinione che, essendo tale contratto un
contratto di diritto privato, vada interpretato secondo i criteri dettati dal codice civile per
l'interpretazione dei contratti: tenendo tuttavia conto del fatto che i soggetti che stipulano il contratto
sono diversi dai soggetti destinatari, la dottrina si è espressa nel senso della prevalenza dei criteri
oggettivi di interpretazione.
Per quanto concerne la struttura del contratto collettivo, le regole relative allo svolgimento dei rapporti
di lavoro rappresentano la c.d. “parte normativa”, di cui sono destinatari datori di lavoro e datori di
lavoro, per i quali tale contratto costituisce una elle principali fonti di disciplina dei loro rapporti.
A questa parte, si è venuta progressivamente affiancando la c.d. “parte obbligatoria”, che non
riguarda direttamente le parti del rapporto di lavoro, bensì è atta ad instaurare rapporti obbligatori
direttamente tra le organizzazioni sindacali stipulanti.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 15 di 105
L'EFFICACIA SOGGETTIVA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI DIRITTO COMUNE
Se il contratto collettivo di diritto comune è stipulato da soggetti in rappresentanza di altri, come
prima conseguenza si avrà che tale contratto sarà vincolante per il datore di lavoro solo qualora sia
iscritto all'organizzazione dei datori di lavoro iscritti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
stipulanti: nel caso in cui un datore di lavoro iscritto receda dalla propria organizzazione sindacale si
libera dall'obbligo di applicare il contratti collettivi successivi al recesso (con l'obbligo dell'applicazione
del contratto vigente nel momento in cui il recesso si è verificato, fino alla scadenza dello stesso).
Se l'efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune dovrebbe essere limitata ai soggetti
direttamente rappresentati dalle parti, la più recente giurisprudenza ha progressivamente elaborato
una serie di criteri interpretativi che consentono di dare applicazione al contratto collettivo di diritto
comune anche al di fuori della rappresentanza sindacale strettamente intesa:
– qualora le parti, nel contratto individuale, ai fini della determinazione del contratto collettivo
abbiano fatto rinvio esplicito al contratto collettivo, esse dimostrerebbero così di aver “recepito”
tale contratto – ed il datore di lavoro non potrebbe unilateralmente liberarsi dall'obbligo di
applicare il contratto collettivo;
– qualora il datore di lavoro, pur non essendo obbligato ad applicare il contratto (perché non iscritto
all'associazione datoriale firmataria), applichi spontaneamente il contratto collettivo, od un
sufficiente numero di clausole (salvo che ne contesti esplicitamente le altre), si potrà ritenere che
il datore di lavoro abbia voluto recepire per intero tale contratto collettivo.
La giurisprudenza ha, inoltre, affermato che il datore di lavoro obbligato all'applicazione di un
contratto collettivo è tenuto ad applicarlo nei confronti dei lavoratori che da lui dipendono, senza
distinzione tra iscritti e non iscritti ai sindacati stipulanti; ciò per due ragioni in particolare:
– da una parte con l'adesione alla propria organizzazione sindacale, il datore di lavoro conferisce la
stessa il potere di rappresentarlo nella regolamentazione dei rapporti di lavoro che fanno capo
alla sua impresa nei contratti collettivi, che sono riferiti alla generalità dei lavoratori (e non solo a
quelli iscritti);
– dall'altra, il trattamento differenziale dei lavoratori in ragione della loro affiliazione sindacale
potrebbe costituire violazione del divieto di discriminazione di cui all'art 15 dello Statuto.
Un caso particolare nell'applicazione di tale regola giurisprudenziale potrebbe porsi qualora i
lavoratori non iscritti al sindacato firmatario di un contratto collettivo rifiutassero (invocando il rispetto
delle regole in materia di rappresentanza sindacale) l'applicazione del contratto.
Ulteriore criterio interpretativo elaborato dalla giurisprudenza onde estendere l'applicazione del
contratto collettivo oltre i limiti della rappresentanza sindacale strettamente intesa, fa leva
sull'applicazione dell'art. 36 Cost. (riguardo ai criteri di sufficienza e proporzionalità della retribuzione
in relazione alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato), al quale è riconosciuta immediata
precettività anche nei rapporti tra privati: il giudice, ove ritenga che la retribuzione prevista dal
contratto individuale di lavoro (inferiore a quella garantita dal contratto collettivo di categoria, che
nella specie non trova applicazione) sia contraria ai principi costituzionali di proporzionalità e
sufficienza della retribuzione, dichiarerà la nullità della clausola del contratto individuale e, facendo
ricorso all'art. 2099 c.c. (per cui <<in mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la
retribuzione è determinata dal giudice>>), determina egli stesso la retribuzione proporzionale e
sufficiente – e privilegiato parametro di riferimento è rappresentato (secondo la giurisprudenza
prevalente) dal contratto collettivo di categoria (che tuttavia non costituisce parametro vincolante).
L'APPLICABILITA' DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del contratto collettivo di diritto comune, la dottrina
prevalente esclude l'applicabilità dell'art. 2070 c.c. (così come la più recente giurisprudenza).
Qualora il datore di lavoro eserciti una certa attività che rientri nella categoria alla quale si riferisce un
certo contratto collettivo, qualora non sia iscritto all'organizzazione stipulante (né abbia aderito,
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 16 di 105
esplicitamente od implicitamente) non sarà obbligato ad applicare tale contratto collettivo (e potrà
dunque applicarne, a sua discrezione, magari anche uno relativo ad altra categoria), ed al più tale
contratto (secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale) potrà costituire termine di riferimento ove
il trattamento previsto sia considerato insufficiente e non proporzionato.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, iscritto ad un'organizzazione sindacale firmataria di un contratto
collettivo non corrispondente all'attività effettivamente esercitata, applichi tale contratto la Cassazione
ha ribadito che nel nostro ordinamento vige il principio dell'autodefinizione della categoria, per cui
spetta unicamente alle organizzazioni stipulanti definire il campo di applicazione del contratto
collettivo.
Portata residuale all'art. 2070 è riconosciuta dalla giurisprudenza solo qualora il contratto individuale
o quello aziendale facciano rinvio generico al contratto collettivo di categoria, e si debba dunque
stabilire a quale contratto le parti abbiano voluto riferirsi.
La giurisprudenza, infine, considera ancora applicabile il comma 2 dell'art. 2070 c.c. per cui <<se
l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di
lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività>>, a patto che (onde
rispettare il principio della libertà sindacale) il datore di lavoro sia iscritto alle rispettive associazioni
sindacali (od abbia aderito volontariamente ai diversi contratti collettivi).
L'INDEROGABILITA' DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE
Al dibattito sull'applicabilità dell'art. 2077 ai contratti collettivi di diritto comune, un forte contributo è
dato dal legislatore del 1973 con la “riforma del processo del lavoro”, che stabilì (nella riformulazione
dell'art. 2113 c.c.) l'invalidità di rinunce e transazioni del lavoratore sui diritti derivanti da <<norme
inderogabili della legge e dei contratti collettivi>>: tale disposizione viene letta dalla dottrina
prevalente come espressa previsione di inderogabilità dei contratti di diritto comune, che porta
(secondo alcuni) all'applicabilità dell'art. 2077. I contratti collettivi si dovranno, dunque, uniformare
alle clausole del contratto collettivo, anche successivamente stipulato.
Per quanto riguarda la derogabilità in melius, l'art. 2077 c.c. prevede che all'inderogabilità generale
dei contratti collettivi, siano eccezioni quelle clausole individuali più favorevoli ai lavoratori.
L'EFFICACIA NEL TEMPO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
I contratti collettivi prevedono una durata al cui definizione è rimessa esclusivamente alle parti: in
applicazione del Protocollo del 23 Luglio 1993, la durata del Contratto Collettivo Nazionale di
categoria è quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva: i contratti collettivi
prevedono il “rinnovo tacito” di anno in anno del contratto scaduto, rinnovo che può essere evitato
mediante “disdetta” che ciascuna delle parti può dare prima della scadenza.
Essendo opinione comune che l'art. 2074 c.c. non sia applicabile al contratto collettivo di diritto
comune, qualora non preveda esplicitamente una “clausola di ultrattività”, esso non può essere
considerato ultrattivo. Secondo il Protocollo del 1993, tre mesi prima della scadenza le organizzazioni
sindacali di datori di lavoro e lavoratori si incontrano per avviare le trattative per il rinnovo del
contratto: poiché le trattative ordinariamente si prolungano oltre la scadenza del contratto, è stato
previsto (al fine di disincentivare comportamenti dilatori e ritardi) l'indennità di vacanza
contrattuale, che comporta un aumento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione
programmato qualora la vacanza si prolunghi oltre 3 mesi dalla scadenz, e pari al 50% qualora si
prolunghi oltre i 6 mesi.
Qualora il contratto collettivo privo, invece, di clausola di ultrattività sia definitivamente scaduto,
questo non sarà più in grado di disciplinare i rapporti di lavoro che ne erano destinatari: questo
perché (secondo la dottrina prevalente, avvallata dalla Cassazione) il contratto collettivo non si
“incorpora” nei contratti individuali, ma li regola dall'esterno – come fonte inderogabile.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 17 di 105
Ogni modifica intervenuta nella sfera dell'autonomia collettiva si riflette, quindi, sui contenuti del
contratto individuale (senza distinzione tra modifiche migliorative e peggiorative).
Secondo un'opinione largamente diffusa in dottrina ed accolta da buona parte della giurisprudenza,
alla scadenza del contratto viene meno anche il principio dell'irriducibilità del trattamento
economico (venendo meno anche la disciplina di riferimento contenuta nel contratto collettivo): alla
scadenza del contratto collettivo potrà essere pattuita – a livello individuale – un'inferiore retribuzione
sia con i nuovi assunti che con i lavoratori già in servizio. Resta, in ogni caso, ferma la tutela offerta
al lavoratore dall'art. 36 Cost, sempre se si tiene conto che le clausole del contratto collettivo scaduto
possono essere prese dal giudice come riferimento per la determinazione della retribuzione
proporzionale e sufficiente.
Un diverso orientamento è emerso di recente in alcune sentenze della Corte di Cassazione, secondo
la quale la scadenza del contratto collettivo non determina l'automatica cessazione delle clausole a
contenuto retributivo, essendo la retribuzione un bene a rilevanza costituzionale: tesi contestabile, in
difetto di una norma che sancisca l'intangibilità della retribuzione.
Diversa sorte tocca a quei trattamenti economici e normativi che trovano fonte non nel contratto
collettivo ma in quello individuale, che possono “resistere” alla scadenza del contratto collettivo: le
clausole più favorevoli del contratto individuale possono sopravvivere alle modificazioni che
intervengono a livello della “fonte” di disciplina (il contratto collettivo) a patto che trovino
effettivamente fonte nel contratto individuale (quindi nel caso di clausole più favorevoli stipulate
intuitu personae, o comunque di carattere strettamente individuale), od ancora nel caso che la
clausola più favorevole trovi fonte in un reiterato comportamento unilaterale del datore di lavoro
(vincolante ai sensi dell'art. 1340 c.c. sulle “clausole d'uso”).
LA SOSTITUZIONE DEL NUOVO CONTRATTO AL CONTRATTO COLLETTIVO SCADUTO
Una massima giurisprudenziale, ormai consolidata, afferma che in caso di successione tra contratti
collettivi di diritto comune dello stesso livello, le clausole del nuovo contratto collettivo (sia più
favorevoli che meno favorevoli) si sostituiscono in toto alle precedenti: le parti collettive stupulanti
possono tuttavia prevedere la salvaguardia dei trattamenti più favorevoli previsti dal contratto
collettivo precedente con apposita clausola.
Il contratto individuale è dunque esposto alle modificazioni della disciplina del suo contenuto,
determinate dal succedersi dei contratti collettivi che lo regolano. La sostituzione del nuovo al
vechhio contratto non può tuttavia incidere sui diritti quesiti dei lavoratori, che sono quei diritti che,
trovando fonte nelle clausole del contratto collettivo previgente, siano già entrati a far parte del
patrimonio dei lavoratori in una fase del rapporto già esaurita (ad esempio, qualora cessi il rapporto
di lavoro – così ha stabilito la Cassazione – si perviene alla definitiva cristallizzazione di taluni diritti
correlati all'attività svolta alla stregua della disciplina all'epoca vigente, e l'eventuale modificazione
della disciplina intervenuta con la sopravvenienza del nuovo contratto collettivo non opera su tali
diritti già acquisiti).
Per quanto riguarda eventuali modifiche (in pejus) con effetto retroattivo della disciplina di un
beneficio economico previsto dal contratto previgente, la Cassazione ha risolto la questione sulla
base di tre regole interconnesse:
– la disciplina inter-temporale del contratto collettivo è affidata alla libera determinazione delle parti;
– in assenza di specifiche pattuizioni l'accordo non è retroattivo;
– ove le parti dispongano l'efficacia retroattiva della soppressione di benefici previsti da accordi
precedenti, o la decorrenza ex tunc di discipline meno favorevoli, queste pattuizioni incontrano il
limite dell'intangibilità dei diritti quesiti.
IL RAPPORTO TRA CONTRATTI COLLETTIVI DI DIVERSO LIVELLO
La contrattazione aziendale assume il riconoscimento di contrattazione “collettiva” da parte della
Cassazione nel 1968, in quanto questa realizza un interesse collettivo, per quanto limitata ad una
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 18 di 105
collettività ristretta ad una sola azienda. Il problema dell'efficacia generale del contratto aziendale nei
confronti dei lavoratori non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti emerse quando, sulla fine degli
anni '70, si intensificarono i casi di contratti aziendali che derogavano in pejus al contratto collettivo
nazionale.
Dopo il Protocollo del 1993, in tutte le imprese nelle quali questo ha trovato applicazione, agente
contrattuale da parte dei lavoratori è la RSU che, per la giurisprudenza, stipulano contratti vincolanti
per tutti i lavoratori che hanno partecipato all'elezione, in quanto nel voto deve ritenersi compresa la
volontà del lavoratore di accettare le regole elettorali e quindi la rappresentanza dei soggetti risultanti
vincitori.
Il problema si pone invece qualora ad una RSU coesistano diverse RSA non aderenti al contratto:
secondo l'orientamento della Cassazione, il contratto collettivo aziendale, che si trova in una
condizione “paritaria” quanto a forza giuridica rispetto al contratto collettivo di superiore livello,
vincola – indipendentemente dall'iscrizione – tutti i lavoratori dell'azienda, stante la sua attitudine ad
incidere su interessi collettivi indivisibili dei lavoratori.
Sempre nella giurisprudenza della Cassazione si è previsto che qualora una deroga in pejus
contenuta nel contratto collettivo aziendale non sia compensata da un vantaggio che corrisponde ad
un interesse collettivo dei lavoratori, chi ha stipulato il contratto non potrà vincolare ad esso se non
coloro che sono obbligati in base alle regole privatistiche della rappresentanza.
Queste problematiche sono superate nel Protocollo del Luglio del 1993 (per quanto solo in parte –
non avendo il protocollo efficacia generale) che detta regole largamente condivise in materia di
durata, cicli contrattuali, competenze della contrattazione aziendale.
Con riguardo al rapporto tra contratti collettivi di diverso livello:
– nel caso la stipulazione
Nel caso di stipulazione di un contratto collettivo aziendale derogatorio in pejus, la giurisprudenza è
concorde nel ritenere che tale deroga ad opera del contratto di livello inferiore possa essere
considerata legittima (come nel caso in cui la stipulazione è motivata dall'esigenza di gestire
situazioni di crisi aziendali, di contrattate la mobilità dei lavoratori, di rendere più flessibile l'uso della
forza lavoro in cambio di contropartite in termini di occupazione).
Il problema è stato risolto nella giurisprudenza della Cassazione in termini di competenza, cioè
qualora la deroga abbia ad oggetto una materia sulla quale la contrattazione aziendale può essere
ritenuta competente a disporre (cioè a patto che non contraddica i principi ispiratori della
contrattazione nazionale, e che sia coerente al complessivo equilibrio di categoria): tale criterio è
utilizzabile solo qualora i livelli di contrattazione diano vita ad un sistema organizzativamente e
funzionalmente coordinato – così come accade per la contrattazione aziendale successiva al
Protocollo del 1993, nell'ambito del sistema contrattuale da questo delineato.
In caso di violazione delle competenze, in ogni caso, la giurisprudenza ritiene che le clausole del
Protocollo abbiano natura obbligatoria (e non normativa), per cui non hanno effetto sulla validità del
contratto con cui i limiti sono stati violati.
Nel caso di sopravvenienza di un nuovo contratto nazionale, l'abrogazione dei contratti aziendali
(così ha stabilito la Cassazione) non è né implicita né automatica. Perché ciò si verifichi, occorre che
le parti manifestino la volontà di sostituire, con la nuova regolamentazione, tutte le preesistenti
discipline
Inoltre, tra contratto nazionale e contratti aziendali dei quali in contratto nazionale dispone
l'abrogazione deve sussistere un “rapporto di sistema”, cioè devono esistere nel sistema contrattuale
norme giuridicamente vincolanti in ordine alla ripartizione delle competenze, ed i contratti di diverso
livello siano conclusi tra soggetti collegati tra loro nell'ambito di un sistema organizzato – così come
accade nella contrattazione collettiva svolta nell'ambito del sistema delineato dal Protocollo del 1993.
IL LAVORO SUBORDINATO
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 19 di 105
Il lavoro subordinato costituisce il termine di riferimento intorno al quale operano le normative di
diritto del lavoro. E' essenziale quindi la qualificazione del rapporto di lavoro in quanto nella disciplina
giuslavoristica si è andata assestando l'inscindibilità del binomio fattispecie/effetti: nel concreto, nel
caso fosse incerta la qualificazione giuridica di un rapporto di lavoro, sarà necessario verificare se
esso sia riconducibile entro lo schema negoziale astratto del lavoro subordinato (o viceversa nella
categoria del lavoro autonomo) al quale si applicheranno quindi le norme del diritto del lavoro.
Nella dottrina italiana delle origini, ricondotte le varie attività umane entro lo schema della locazione,
la distinzione tra locatio operarum e locatio operis era identificata, secondo l'opinione prevalente,
nell'oggetto dell'obbligazione (di risultato o di mezzi). Grande innovazione del Barassi è
l'individuazione del tratto distintivo nella subordinazione intesa come eterodirezione (ovvero
sottoposizione alle direttive del datore di lavoro nell'esecuzione della prestazione lavorativa).
LA NOZIONE GIURIDICA DI LAVORO SUBORDINATO
La nozione giuridica di lavoro subordinato è consolidata nel nostro ordinamento in una disposizione
legale (già con il R.d.L 1825/1924 con il quale si afferma che <<il contratto d'impiego privato [..] è
quello per il quale una società o un privato, gestori di un'azienda, assumono al servizio dell'azienda
stessa [..] l'attività professionale dell'altro contraente>> e le relativa disposizioni risultano applicabili
anche a quei <<rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa [..] in
quanto compatibili con la specialità del rapporto>>): la norma definitoria contenuta nell'art. 2094 c.c.
stabilisce che <<è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore.>>; al contrario, ai sensi dell'art. 2222, si dà invece luogo alla stipulazione
di contratto d’opera <<Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o
un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente>>. Sembrerebbe quindi che il tratto differenziale essenziale fra le due tipologie
fondamentali di contratti di lavoro riseda nella presenza (od assenza) del vincolo di
subordinazione. La norma non specifica concretamente quali siano i connotati identificativi di tale
carattere: per tale motivo la giurisprudenza di merito si è spesso discostata dal metodo sussuntivo
(che si svolge attraverso un giudizio sillogistico d'indentità tra fattispecie concreta e fattispecie
astratta) adottando il metodo tipologico (per cui la qualificazione del rapporto sia compiuta attraverso
un giudizio di approssimazione della fattispecie concreta al tipo normativo – verificando la
sussistenza di un insieme di indici qualificatori, quegli indici di subordinazione caratterizzanti il
modello sociale prevalente di lavoro subordinato).
LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Nella giurisprudenza di merito è tradizionalmente determinante, ai fini della qualificazione, la
presenza di subordinazione gerarchica, intesa (seconda una consolidata massima della
Cassazione) come <<assoggettamento della prestazione lavorativa al potere del datore di lavoro di
disporne secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo proprio dell'organizzazione
imprenditoriale e di determinarne le concrete modalità con l'imposizione di decisioni e istruzioni alle
quali il lavoratore è obbligato ad attenersi>>: tale vincolo di soggezione al potere direttivo da
parte del lavoratore <<deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di
un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative>>.
Con l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro, per quelle forme di lavoro atipico per le quali
l'attività dei prestatori di lavoro è caratterizzata da più ampia autonomia operativa, assume valore
determinante l'inserimento nell'organizzazione imprenditoriale (riflesso della subordinazione, non
sempre né necessario né sufficiente ai fini della qualificazione).
Altri elementi caratterizzanti potrebbero invece essere la sussistenza e la permanenza:
– dell'obbligo del lavoratore di mantenere a disposizione del datore la propria attività lavorativa;
– dell'assoggettamento al potere direttivo ed al potere disciplinare.
IL METODO TIPOLOGICO
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 20 di 105
Il metodo tipologico opera una qualificazione del rapporto di lavoro in base ad un giudizio di
approssimazione del caso concreto ad una figura tipica alla stregua della concorrenza di indici da
combinarsi in una valutazione di prevalenza.
Criteri determinanti per la valutazione della sussistenza della subordinazione sono l'assoggettamento
del prestatore di lavoro ai poteri direttivo e disciplinare del datore di lavoro, nonché di un suo stabile
inserimento nell'organizzazione aziendale; la giurisprudenza ha elaborato una serie di indici
sintomatici della situazione di subordinazione quali:
– la continuità nello svolgimento delle mansioni;
– il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso;
– il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale;
– l'alienità del risultato;
– l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie
della stessa;
– l'osservanza di un vincolo di orario;
– l'assenza di rischio economico.
Ciascun indice autonomamente considerato non è idoneo a determinare la qualificazione del
rapporto: l'accertamento della sussistenza del requisito di subordinazione deve avvenire dall'analisi
degli stessi nella loro globalità.
IL METODO SUSSUNTIVO
La giurisprudenza della Cassazione sembra più attestata a difesa del più rigoroso metodo
sussuntivo: partendo dalla definizione astratta di subordinazione, il giudice qualifica come “lavoro
subordinato” quei rapporti di lavoro che, nelle loro concrete modalità di attuazione, presentino
caratteristiche – conformi alla definizione astratta della subordinazione (assoggettamento del
lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; inserimento stabile
nell'organizzazione del datore di lavoro) – corrispondenti al parametro normativo di riferimento,
individuato negli elementi della fattispecie del lavoro subordinato indicati dall'art. 2094 c.c. :
– la retribuzione (più che altro utilizzato per distinguere il lavoro prestato a titolo oneroso dal lavoro
gratuito – ammesso dalla giurisprudenza solo in particolari circostanze nelle quali l'attività
lavorativa è svolta affectionis vel benevolentiae causa);
– la collaborazione (attitudine meramente descrittiva che richiama un carattere un carattere di
normalità tecnico-organizzativa – riscontrabile infatti anche nell'ambito del lavoro autonomo);
– l'eterodirezione (intesa come subordinazione tecnico-funzionale – definita dalla Cassazione
dome <<vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del
datore di lavoro>> – , criterio distintivo fondamentale secondo la giurisprudenza dominante);
– la dipendenza (nel nuovo significato datole dalla Corte Costituzionale).
Le tendenza giurisprudenziali più recenti, in ogni caso, tendono all'adozione combinata di entrambi i
metodi: l'operazione qualificatoria si compie secondo i tradizionali canoni del metodo sussuntivo, al
più sostenuto (in via sussidiaria in caso di incerta classificazione) da quello tipologico.
LA RILEVANZA DEL NOMEN IURIS
Negli ultimi anni la giurisprudenza Costituzionale ha permesso, con sue indicazioni, di coniugare
l'interpretazione della norma definitoria del codice civile con il quadro di principi e valori scolpiti nella
costituzione a favore del lavoro subordinato.
Una prima sentenza (nel 1995) censura l'orientamento tendente ad iper-valorizzare ai fini qualificatori
la volontà delle parti espressa nel nomen iuris utilizzato: <<stravolgerebbe gli stessi fondamenti del
diritto del lavoro>> un precetto in forza del quale <<il rapporto descritto nel contratto come rapporto
d'opera o di prestazione professionale non sia mai suscettibile di una diversa qualificazione neppure
in caso di contrasto tra il contratto e le risultanze del rapporto svoltosi tra le parti>>.
Ne consegue che <<allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 21 di 105
svolgimento – eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il nomen juris
enunciato – siano quelle del rapporto di lavoro subordinato, solo quest'ultima può essere la
qualificazione da dare al rapporto>> (con i conseguenti effetti della disciplina ad essa applicabile).
Il nomen iuris assume quindi il valore di presunzione semplice di adeguamento delle parti alla volontà
contrattuale: <<in caso di contrasto tra i dati formali e dati fattuali [..] è necessario dare prevalente
rilievo ai secondi, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e
costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle
concrete modalità di esecuzione del rapporto>> infatti né il legislatore né le parti potrebbero negare
la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale
natura. La qualificazione giuridica è riservata al giudice, che si baserà sulle prove e sulle allegazioni
fornite, indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti stesse.
Per quanto riguarda la rilevanza da attribuire alla volontà contrattuale si distinguono diverse ipotesi:
– le parti hanno voluto attuare un rapporto di subordinazione simulandolo con altra richiesta – nel
qual caso prevale il contratto simulato (ai sensi dell'art 1414 c.c.);
– le parti si sono espresse in modo non chiaro – nel qual caso l'interprete non valuterà il significato
letterale, ma il comportamento delle parti in sede esecutiva.
Anche nel caso in cui le parti abbiano mutato la qualificazione di un rapporto di lavoro di tipo
subordinato in un rapporto di tipo autonomo (onde sottrarsi dagli obblighi previsti dalla legge) il
contenuto del contratto non potrà travalicare i contenuti e le finalità della disciplina legale che
tutelano il prestatore di lavoro (ai sensi dell'art. 1322 c.c <<le parti possono liberamente determinare
il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge>>): nel caso in cui il rapporto non sia mutato
nella sostanza, sarà quest'ultima a prevalere sulla forma.
E in ogni caso prevista la possibilità per cui i contraenti durante lo svolgimento del rapporto stesso
manifestino (anche attraverso fatti concludenti) modifiche o mutamenti della volontà negoziale già
espressa, con conseguente mutamento del regime normativo.
LA RIVALUTAZIONE DELLA DIPENDENZA
In una seconda sentenza (1996) la Corte dà un fondamentale apporto interpretativo in materia:
se la subordinazione tecnico-funzionale (quella che per la giurisprudenza di merito identificherebbe il
lavoro subordinato), per la Corte, è riscontrabile anche <<in altri contratti coinvolgenti la capacità di
lavoro di una delle parti>>, determinante valore qualificatorio è assunto dalla <<subordinazione in
senso stretto>>, peculiare del rapporto di lavoro subordinato, <<la quale è un concetto più pregnante
ed insieme qualitativamente diverso>>.
La fattispecie di “lavoro alle dipendenze” coincide con una condizione di doppia alienità del
lavoratore: essa si verifica, in altre parole, solo quando la prestazione lavorativa è destinata a
svolgersi nel contesto di un'organizzazione produttiva altrui (alienità dei mezzi) ed in vista di un
risultato di cui il titolare dell'organizzazione (e dei mezzi di produzione) è immediatamente legittimato
ad appropriarsi (alienità del risultato).
E' questa condizione di doppia alienità, espressiva della “subordinazione in senso stretto”
(“dipendenza”) – e non l'eterodirezione – a caratterizzare dunque il tipo legale del lavoro subordinato
ed a costituirne, per la Corte, la ragione ultima dell'imputazione delle tutele del diritto del lavoro.
L'ONEROSITA' ED IL LAVORO GRATUITO
La Cassazione ha più volte ribadito che, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione
di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso; la sua riconducibilità ad un rapporto di
lavoro non subordinato istituito affectionis vel benevolentiae causa a titolo gratuito esige prova
rigorosa: spetta al datore di lavoro provare che le eventuali erogazioni periodiche di denaro effettuate
in favore del prestatore di lavoro hanno causa solvendi diversa da quella retributiva.
La presunzione è invece invertita qualora la prestazione lavorativa sia resa fra persone conviventi
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 22 di 105
(legate da vincolo di parentela od affinità) od in caso di attività svolte in favore di congregazioni
religiose da parte di un adepto: in tali casi si esclude l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
e la prestazione lavorativa si presume effettuata a titolo gratuito: onde poter verificare la sussistenza
di un rapporto lavorativo subordinato, sarà rilevante il carattere di onerosità del rapporto configuratosi
nello scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione.
IL LAVORO PARA-SUBORDINATO
Nel codice civile i tratti del lavoro autonomo si ricavano dalla definizione di contratto d'opera
(contenuta nell'art.2222. , di opera compiuta <<verso un corrispettivo [..], con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente>>)
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono una sotto-categoria del lavoro
autonomo, ma che presentano elementi di affinità con il lavoro subordinato che comportano esigenze
di tutela in parte assimilabili: tali rapporti presentano un riscontro normativo nell'art.409 del cod. proc.
civ. (nella definizione di contratto d'agenzia, che si concreta in <<una prestazione di opera
continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato>>) e
beneficiano dello speciale rito processuale previsto per le controverse relative ai rapporti di lavoro
subordinato.
Alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale (in particolare della Cassazione), si può ritenere che si
abbiano gli elementi caratterizzanti la fattispecie del rapporto quando:
– la collaborazione autonoma abbia carattere durevole nel tempo con prestazioni ininterrotte o
periodiche (continuità);
– vi sia prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e
sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale (personalità);
– sussista una connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione
aziendale (coordinazione).
Tale coordinazione è di particolare rilievo nella distinzione tra lavoro subordinato e para-subordinato:
nel primo caso tale collaborazione comporta un nesso strutturale con l'organizzazione del datore di
lavoro, mentre nel secondo rappresenta un mero inserimento funzionale nell'organizzazione altrui e
presuppone l'instaurazione di un nesso tra l'organizzazione del collaboratore e quella del
committente.
La ratio delle controversie giudiziarie nell'ambito del processo del lavoro è rappresentata, per la
Corte Costituzionale, dal rapporto di dipendenza (“subordinazione”) socio-economica che viene ad
instaurarsi anche nel lavoro para-subordinato; d'altra parte è la stessa Corte che ha riconosciuto che
tale criterio non può estendere indiscriminatamente al lavoro para-subordinato le tutele riconosciute
al lavoro subordinato.
Certamente bisogna tenere conto che il sempre crescente impiego di co.co.co a fronte di contratti di
lavoro subordinato è spesso utilizzato (anche in frode alla legge) per mascherare rapporti di
differente natura, onde aggirare le tutele proprie del lavoro subordinato (ed assicurarsi un
considerevole risparmio sul costo del lavoro, in quanto tali prestazioni para-subordinate prevedono
una contribuzione previdenziale di livello sensibilmente inferiore a quella propria del lavoro
subordinato): sarà dunque necessario distinguere tra quelli che si presentano nominalmente tra
lavoratori autonomi, innanzitutto quelli sottratti indebitamente dall'ambito del lavoro subordinato (in
modo da ricondurli – soprattuto in sede processuale – al loro proprio inquadramento normativo), ed
ancora – tra quelli che effettivamente si presentino come lavoratori autonomi – quali che siano quei
lavoratori “deboli” (in quanto “economicamente dipendenti”) per i quali risulterebbe giusto estendere
(principalmente in sede legislativa) parte delle tutele proprie del lavoro subordinato (come d'altra
parte risulta incongruo fare per quelle figure professionali di elevato libello, anch'esse rientranti nella
categoria del lavoro autonomo).
IL LAVORO A PROGETTO
La figura del contratto di lavoro a progetto è stata introdotta (con il d.lgs 276/2003) nel nostro
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 23 di 105
ordinamento con lo scopo di regolare l'area delle co.co.co. contrastando il ricorso abusivo alle
stesse. La stipulazione di un tale contratto deve necessariamente risultare funzionale alla
realizzazione di un <<progetto o programma di lavoro, o fasi di esso>> secondo le indicazioni
risultanti dal contratto di lavoro, da stipularsi in forma scritta (a fini di prova): <<rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione [..] devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o
fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente
dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa>>. A tali figure la legge fa corrispondere
uno standard protettivo assolutamente non comparabile con quello proprio del lavoro subordinato.
Le co.co.co. si configurano come rapporti necessariamente a termine (in quanto legati alla
realizzazione di uno specifico progetto) e da ciò scaturiscono alcune regole:
– l'obbligo di indicare nel contratto la <<durata, determinata o determinabile, della prestazione di
lavoro>>;
– il fatto che tali contratti <<si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del
programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto>>;
– e la previsione per cui <<i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto [..] sono considerati rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto>>.
Tale carattere temporaneo del lavoro a progetto (con lo scopo disincentivare l'uso abusivo della
fattispecie) si presta ad essere agevolmente eluso, anche a causa delle indicazioni contenute nella
circolare 1/2004, secondo cui il programma necessario per la stipulazione del contratto di co.co.co.
avrebbe come oggetto <<la produzione di un risultato solo parziale, destinato ad essere integrato in
vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali>> (risultati parziali che ben si
adatterebbero a descrivere le mansioni esigibili da qualsiasi lavoratore subordinato), ed <<analogo
progetto o programma di lavoro può esser oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso
collaboratore>> (con il rischio quindi che tale collaborazione venga rinnovata illimitatamente).
Secondo un indirizzo consolidato della Cassazione, il lavoratore a progetto si configura come
lavoratore para-subordinato (e quindi si distacca dalla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro
subordinato, ma anche da quella applicabile al lavoratore autonomo) qualora sussistano tre requisiti:
– la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo,
comportando un impegno costante del prestatore a favore del committente;
– la coordinazione, intesa come connessione funzionale, derivante da un protratto inserimento
nell'organizzazione aziendale o da un accordo programmatico diretto al coordinamento tra attività
del prestatore d'opera e l'impresa del committente;
– la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta
dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura materiale.
Si deve escludere il rapporto di para-subordinazione qualora il professionista operi, con prestazioni
omogenee e consone alla sua specializzazione, per conto di più clienti senza che nei confronti
dell'uno possa essere accertato un impegno più assiduo e costante che nei confronti degli altri.
LA PRESTAZIONE LAVORATIVA ESEGUITA DAI SOCI
Altre figure spesse volte utilizzate con finalità elusive della disciplina tipica del lavoro subordinato,
possono essere svolte non necessariamente nel contesti di un contratto di cambio (di lavoro
subordinato od autonomo) ma anche in adempimento di obblighi nascenti da un contratto di società.
Nel caso del socio d'opera (per il quale non sussiste la condizione di doppia alienità di
organizzazione e risultato) l'attività lavorativa costituisce oggetto di un conferimento ed il lavoro si
configura come adempimento del contratto sociale; la giurisprudenza (della Cassazione) ammette,
tuttavia, la possibilità di cumulo fra la posizione di lavoratore subordinato e socio di società di
persone (come avviene anche nel caso dell'amministratore non unico di S.p.A.), nel caso in cui <<la
prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale>> e che il socio <<presti la sua
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 24 di 105
attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia>>.
PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN FAVORE DI SOCIETA' COOPERATIVE
Nel caso di prestazioni lavorative rese in favore di società di cooperativa di produzione e lavoro
dai soci della stessa, la prestazione va ad integrare adempimento del contratto di società.
D'altra parte la l.142/2001 stabilisce che tale attività lavorativa vada considerata giuridicamente sotto
due diversi profili, dovendo la medesima attività costituire oggetto di prestazione mutualistica (nella
logica del rapporto associativo) e contemporaneamente essere resa in conseguenza
dell'instaurazione di un rapporto di lavoro (ispirato alla logica dello scambio contrattuale) al quale si
applicherà la disciplina specifica del particolare rapporto instaurato (con eccezione delle regole
protettive nei confronti del licenziamento ingiustificato nel caso di lavoro subordinato – in quanto
l'art.18 dello Statuto dei Lavoratori resta inoperante <<ogni volta che venga a cessare, col rapporto di
lavoro, anche quello associativo>>): infatti, è espressamente previsto che <<il socio lavoratore di
cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto
associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra
forma>>.
Per quanto riguarda l'inscindibilità dei due rapporti, una precedente sentenza del Tribunale di Milano
(nella quale si affermava che per far cessare legittimamente il rapporto di lavoro fosse necessario un
licenziamento, adottato in forma scritta e motivato, secondo la disciplina generale della risoluzione
dei rapporti di lavoro subordinato) è stata contraddetta dal legislatore che ha modificato (nel 2003) la
l.142 , prevedendo espressamente che <<il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o
l'esclusione del socio deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli
2526 e 2527 del codice civile>>.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di accertare in sede giudiziale il carattere simulato del
rapporto mutualistico e la sussistenza di un normale rapporto di lavoro subordinato.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Nel caso di contratto di associazione in partecipazione (regolato dall'art. 2549 c.c. ), tramite il quale
<<l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa [..] verso il
corrispettivo di un determinato apporto>> (che può anche consistere in un'attività lavorativa), la
titolarità dell'impresa e la relativa gestione permangono in capo all'associante, ma d'altra parte non vi
è alienità del risultato d'impresa; formalmente distinguibile dal lavoro subordinato, tale fattispecie si
presta ad un suo impiego fraudolento (agevolato da alcuni indirizzi giurisprudenziali, come la
compatibilità di tale rapporto con la garanzia di un compenso minimo, erogato a cadenze mensili,
nonché alla rigida ricerca dell'eterodirezione nella definizione del rapporto).
Il d.lgs 276/2003 ha previsto che qualora tali rapporti siano resi senza effettiva partecipazione ed
adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ad i trattamenti contributivi, economici e
normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per l'equivalente lavoratore subordinato.
La Cassazione, in ogni caso, ha recentemente ribadito che, ove il rapporto abbia le caratteristiche
proprie del lavoro subordinato (assoggettamento del lavoratore ai poteri direttivo e disciplinare del
datore di lavoro e stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale) deve escludersi
l'associazione in partecipazione.
L'elemento costitutivo essenziale del contratto di associazione in partecipazione (come si evince
dall'art. 2549) è la pattuizione a favore dell'associato di una prestazione correlata agli utili
dell'impresa e di un rendiconto periodico (in quanto tale contratto – contenente elementi di aleatorietà
– ha finalità affini ad un contratto societario).
Infine, la Cassazione, ribadito che è la posizione paritetica dell'associato nell'azienda ad escludere
l'esistenza della subordinazione, ha precisato che non potranno essere i soli elementi
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 25 di 105
dell'osservanza di un orario di lavoro e di precise disposizioni a far desumere necessariamente la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (essendo elementi compatibili con l'associazione in
partecipazione).
I LAVORI SUBORDINATI
L'ordinamento riconosce l'esistenza di molteplici figure di lavoratori subordinati, distinguibili in ragione
del contenuto professionale delle rispettive posizioni di lavoro e della collocazione nella struttura
organizzativa dell'impresa: tale divisione dei lavoratori avviene innanzitutto attraverso le categorie
individuate nell'art.2095 c.c. : dirigenti, quadri, impiegati e operai (a loro volta differenziati in
qualifiche). Ai sensi dell'art. 96 disp. att. cod. civ. , inoltre <<l'imprenditore deve far conoscere al
prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in
relazione alle mansioni per cui è stato assunto>>.
La definizione più rilevante per distinguere operai ed impiegati è quella contenuta nella r.d.l.
1825/24 secondo cui la figura dell'impiegato viene legata all'esercizio di <<un'attività professionale [..]
con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata, pertanto, ogni prestazione
che sia semplicemente di mano d'opera>>: da tale norma si possono rilevare i criteri di
differenziazione (professionalità, non manualità, collaborazione) ma la loro interpretazione ha perso
di rilevanza in quanto le tutele previste per gli impiegati sono state estese dalla contrattazione
collettiva e dalla legislazione anche agli operai (e per quanto esistano ancora regole specifiche in
favore degli impiegati, le differenze più rilevanti sono gradualmente venute meno).
Di maggiore rilievo è invece la distinzione rispetto alla categoria dei quadri (introdotta con la
l.190/1985 per rispondere all'esigenza di differenziazione di trattamento e riconoscimento di una
propria identità di ruolo alle fasce più elevate del settore impiegatizio e tecnico) che corrisponde a
quei lavoratori che, <<pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con
carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi
dell'impresa>> (definizione generica i cui requisiti di appartenenza sono individuati dalla
contrattazione collettiva entro lo schema classificatorio dell'inquadramento unico). Ai quadri si
applicano (secondo la norma) le norme riguardanti gli impiegati, salvo diversa espressa disposizione:
per quanto riguarda il trattamento dei quadri il riconoscimento è infatti rimasto circoscritto alla sola
attribuzione di una maggiorazione retributiva, erogata generalmente sotto forma di indennità di
funzione.
LA FIGURA DEL DIRIGENTE
La figura del dirigente (per la quale categoria si ha un'organizzazione sindacale separata)
corrisponde a quel lavoratore che, quantunque titolare anch'esso di un contratto di lavoro
subordinato, si colloca in posizione particolare nella struttura organizzativa dell'impresa, esercitando
normalmente nei confronti degli altri lavoratori dell'impresa una frazione dei poteri di pertinenza
dell'imprenditore: la figura (di elaborazione giurisprudenziale) di alter-ego dell'imprenditore è però
rispondente solo alle caratteristiche dei dirigenti di vertice, e non risulta idonea a descrivere
adeguatamente quei c.d. dirigenti meramente convenzionali (pseudo-dirigenti), lavoratori in
possesso di elevate conoscenze scientifiche e tecniche (o comunque di professionalità tali da porli in
condizioni di particolare forza nel mercato del lavoro) ai quali – pur in assenza di poteri di direzione –
la contrattazione collettiva e la prassi aziendale ha riconosciuto la qualifica dirigenziale; per questi
ultimi si è posta la questione di estendere parte di quelle discipline che l'ordinamento nega, senza
distinzioni, agli appartenenti alla categoria dirigenziale.
Secondo la Cassazione, il riconoscimento a un lavoratore della qualifica di dirigente – a prescindere
dalla corrispondenza della stessa alle mansioni effettivamente svolte – è legittima qualora risponda
ad un apprezzabile interesse delle parti e non sia posta in essere onde eludere norme imperative.
La giurisprudenza ritiene inapplicabile la disciplina legale della categoria dei dirigenti agli pseudodirigenti: in tal senso si può considerare dirigente esclusivamente <<il lavoratore che effettivamente
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 26 di 105
“sostituisca” il capo di un'impresa di dimensioni medio-grandi nelle funzioni strettamente sue proprie,
ovvero la cui posizione corrisponda sostanzialmente al prototipo del c.d. top manager>>, che è colui
che, <<pur nell'ambito delle direttive generali impartite dal datore di lavoro>>, ha poteri decisionali di
tale entità da poter <<influenzare l'intero andamento dell'attività aziendale>>.
In generale (secondo il principio dell'uguaglianza sostanziale, per cui sarebbe improprio collegare
modelli di protezione indifferenziati ad una disomogeneità di condizione sociale tra le categorie),
alcune delle fondamentali regole fondamentali del diritto del lavoro non si applicano alle categorie più
elevate (dirigenti e quadri) – come le regole in materie di promozione automatiche, che per tali
categorie risultano sensibilmente più restrittive – ed in particolare i dirigenti non fruiscono delle
limitazioni previste dalla legge in materia di durata dell'orario di lavoro, e soprattutto di tutela nei
confronti del licenziamento privo di giustificato motivo.
LE REGOLE SUL LAVORO NELL'IMPRESA
Le regole sul lavoro nell'impresa risultanti dal codice civile e dalla successiva legislazione speciale
rappresentano uno standard normativo utilizzabile come generale modello di riferimento per la
disciplina del lavoro subordinato. D'altra parte l'applicazione di alcune regole è subordinata in ragione
di alcuni parametri (l'appartenenza ad una categoria, la dimensione occupazionale dell'azienda).
Ancora l'ordinamento riconosce alcuni rapporti speciali di lavoro per i quali il legislatore ha ritenuto
opportuno dettare regole specifiche (formando specifiche discipline, più o meno diverse da quella
generale del lavoro subordinato): tali discipline speciali sono state dettate con una tipica
caratterizzazione settoriale, per rapporti alle dipendenze di determinati datori di lavoro (in
considerazione di interessi pubblici o di esigenza di tutela della collettività), od in riguardo alla
peculiarità della prestazione lavorativa od al contesto organizzativo in cui deve essere resa.
Altri rapporti di lavoro subordinato per i quali l'ordinamento riconosce nuclei di disciplina specifica
sono i rapporti di lavoro atipici, che si possono distinguere dalla “categoria” dei rapporti speciali di
lavoro per l'assenza di una caratterizzazione settoriale (possono infatti essere instaurati in tutti i
settori e con qualsiasi datore di lavoro).
ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO
Il sistema monopolistico statale del collocamento dei lavoratori – era proibito l'esercizio di mediazione
privata fra domanda ed offerta in quanto il collocamento era concepito come una funzione pubblica –
strutturato in liste di collocamento (unico mezzo per i disoccupati in cerca di lavoro per concludere un
contratto di lavoro subordinato) organizzate in graduatorie (stilate sulla base di elementi quali carico
familiare, situazione economica e patrimoniale, anzianità d'iscrizione nelle liste) alle quali i datori di
lavoro attingevano con una richiesta numerica (mentre la richiesta nominativa ammessa solo in casi
eccezionali, ridotti ad ipotesi residuali con lo statuto dei lavoratori) è stato progressivamente
deregolamentato: dopo la fallimentare riforma del 1987, già nel 1991 era stata riconosciuta ai datori
di lavoro la facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa, e nel 1996 la
possibilità di procedere alle assunzioni in via diretta, saltando anche formalmente la mediazione degli
uffici di collocamento (fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'assunzione effettuata,
contestuale all'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato).
La riforma del collocamento del 1997 (varata con il d.lgs. 496/1997) è stata costruita essenzialmente
attorno a tre principi guida:
– il decentramento dei servizi per l'impiego, attuato mediante il conferimento alle regioni dei relativi
compiti e funzioni;
– il superamento della concezione del collocamento come funzione pubblica da esercitarsi in
regime di quasi-monopolio dalle competenti strutture statali;
– conseguente apertura dell'ordinamento nei confronti dei privati ammessi (a determinate
condizioni) a svolgere attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro.
Alle regioni sono stati conferiti compiti sia in materia di politica attiva del lavoro, sia con riguardo al
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 27 di 105
collocamento: si è passati dunque da una situazione di uniformità nel collocamento ad una difformità
da regione a regione (per quanto stemperata da una serie di criteri direttivi impartiti dal legislatore, in
parte dichiarati incostituzionali dalla Corte che ne ha però salvato i più importanti: l'obbligo di
attribuire funzioni ed obblighi in materia di collocamento alle provincie, tenute a provvedere alla
gestione ed erogazione dei relativi servizi tramite apposite strutture denominate centri per
l'impiego). E' stata inoltre prevista l'istituzione in ogni provincia di una commissione per le politiche
del lavoro, un organo tripartito permanente di concertazione e consultazione delle parti sociali.
Il d.lgs 181/2000 contiene i <<principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle
regioni [..] in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento>> ed i criteri di
indirizzo per le attività dei servizi competenti con particolare riguardo agli interventi volti a prevenire la
disoccupazione giovanile e quella di lunga durata; precisa inoltre i principali destinatari ti tali misure di
promozione all'inserimento nel mercato del lavoro (adolescenti, giovani, disoccupati di lunga durata,
inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo) ed introduce la nozione di stato di
disoccupazione quale <<condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente
disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa>>.
Ai fini dell'attività dei servizi per l'impiego (tenendo conto che si considerano giovani i soggetti fino a
25 anni di età, 29 per i laureati) si considerano:
– disoccupati di lunga durata sono <<coloro che, dopo avere perso un posto di lavoro o cessato
un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o
da più di sei mesi se giovani>>;
– inoccupati di lunga durata sono <<coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività
lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più do sei mesi se
giovani>>;
– donne in reinserimento lavorativo sono <<quelle che, già precedentemente occupate,
intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni d'inattività>>.
Il D.P.R. 442/2000 ha previsto l'istituzione di un elenco anagrafico nel quale vadano iscritti tutti coloro
che ricercano un lavoro ed intendono avvalersi dei servizi per l'impiego; i dati in esso registrati sono
riportati in una scheda professionale contenente le informazioni sulle passate esperienze formative
e professionali (e sulle disponibilità dell'interessato).
Il d.lgs. 181/2000 ha definitivamente soppresso le liste di collocamento; è restato invece in vigore
(per quanto attenuato) l'istituto della riserva di assunzioni in favore di determinati soggetti deboli:
compete alle regioni la facoltà di <<prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di
lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio
di esclusione sociale>>.
Con la riforma del 1997 sono state legittimate le agenzie private di collocamento (regolate poi tramite
successivi interventi normativi): le attività che possono essere svolte nel mercato del lavoro sono
quattro e minuziosamente descritte nei rispettivi contenuti:
– somministrazione di lavoro;
– intermediazione;
– ricerca e selezione del personale;
– supporto alla ricollocazione professionale.
Tali attività possono essere svolte solo da soggetti, denominati agenzie per il lavoro, che abbiano
preventivamente ottenuto la relativa autorizzazione (da parte del ministero del lavoro entro 60gg dalla
richiesta a titolo provvisorio, e dopo 2 anni – previo accertamento del corretto andamento dell'attività
svolta – a tempo indeterminato entro 90gg dalla richiesta dell'agenzia; <<decorsi inutilmente i termini
previsti, la domanda di autorizzazione [..] si intende accettata>>) con cui si accompagna l'iscrizione
in un apposito albo. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla presenza di una serie di
requisiti:
– il soggetto richiedente dev'essere una <<società di capitali ovvero cooperativa [..] italiana o di
altro stato membro dell'Unione Europea>> (ma anche società di persone, dove l'autorizzazione
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 28 di 105
non riguardi lo svolgimento di attività di mediazione);
amministratori e dirigenti non devono aver riportato condanne penali in relazione ad una serie di
delitti (in particolare per reato di associazione di tipo mafioso e per quelli dipendenti dalla
violazione di leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro).
Alle agenzie sono imposte alcune “regole di comportamento” a tutela dei lavoratori:
– la loro attività dev'essere svolta a fronte degli stessi a titolo gratuito (sia direttamente che
indirettamente);
– devono essere assicurato ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti cui propri dati devono essere
comunicati e garantire l'ambito di diffusione di tali dati, rispettando le indicazioni fornite dai
lavoratori stessi
– sono bandite pratiche discriminatorie attraversi il divieto <<di effettuare qualsivoglia indagine o
comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso>>
con riguardo ad una serie di oggetti (convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo
religioso, sesso, orientamento sessuale, stato matrimoniale, stato di famiglia, stato di gravidanza,
età, handicap, origine etnica, colore, ascendenza, origine nazionale, gruppo linguistico, stato di
salute, eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro), fonte di potenziale
discriminazione, salvo che costituiscano <<un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell'attività lavorativa>> (ma, sembrerebbe, anche quando esse solo vadano ad
incidere sulle modalità di svolgimento).
–
Il d.lgs 276/2003 ha incrementato i soggetti che possono svolgere attività di intermediazione tra
domanda ed offerta di lavoro (in regimi particolari di autorizzazione):
– sia soggetti pubblici (tra cui università, comuni, camere di commerci, istituti di scuola secondaria
di secondo grado – a condizione che tale attività sia svolta senza fini di lucro);
– sia soggetti privati (associazioni sindacali – sia datoriali che dei lavoratori – , sia enti bilaterali –
organismi costruiti da entrambi le parti sociali ai quali il legislatore ha assegnato una molteplicità
di compiti in qualità di <<sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro>>).
La borsa continua nazionale del lavoro è uno strumento informatico (istituito con il d.lgs 276/2003)
che contiene <<ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro>>
fornita da tutti i soggetti autorizzati a svolgere le rispettive attività nell'ambito della collocazione: ciò
risponde all'attuale concezione nella quale, se il collocamento ha perso la sua natura di funzione
pubblica per acquisire quella di servizio pubblico alla cui erogazione possono concorrere anche
soggetti privati, il rapporto tra pubblico e privato non può ridursi alla semplice concorrenza, ma
comporta l'instaurazione di forme di cooperazione strumentali al miglior funzionamento del mercato
del lavoro. Inoltre è stato stabilito che la borsa sia <<liberamente accessibile da parte dei lavoratori e
delle imprese>> che <<hanno la facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale
direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario>>.
Per la stessa ragione è stato previsto che, oltre ai centri per l'impiego, anche altri organismi
(individuati dalle regioni) possano svolgere attività di promozione all'inserimento nel mercato del
lavoro (subordinatamente all'iscrizione in appositi elenchi).
SISTEMI SPECIALI DI COLLOCAMENTO
Accanto al sistema generale del collocamento, nel nostro ordinamento ne sono previste forme
particolari per determinate categorie di lavoratori (sempre secondo il criterio dell'assunzione diretta,
per cui il ricorso ad un intermediario – pubblico o privato – non è un passaggio necessario
nell'instaurazione del rapporto di lavoro):
– particolare attenzione è dedicata al sistema di collocamento dei lavoratori extra-comunitari, che si
intreccia con il problema dell'immigrazione (rilevante per profili sociali, economici, umanitari e di
ordine pubblico) che è regolata secondo l'ottica della programmazione degli accessi (tramite la
definizione i quote massime); i soggetti extra-comunitari che intendano fare ingresso in Italia per
motivi legati allo svolgimento di attività lavorativa subordinata devono essere iscritti in apposite
liste, ivi <<specificando le loro qualifiche e mansioni>> – d'altra parte i datori di lavoro che
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 29 di 105
–
–
vogliano <<instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato [..] con uno straniero residente
all'estero>> devono rivolgere allo sportello unico per l'immigrazione una richiesta di nulla osta al
lavoro; la stipulazione del contratto di lavoro subordinato (da effettuarsi presso lo sportello unico)
condiziona il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; è stato invece soppresso
l'istituto della prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro (che permetteva il rilascio di un
permesso di soggiorno ai fini di inserimento nel mercato del lavoro); nel caso in cui il lavoratore
straniero perda il posto di lavoro egli potrà avvalersi degli interventi dei servizi pubblici per
l'impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno;
l'attività lavorativa all'estero (in paese non appartenente all'Unione Europea) svolta da lavoratore
italiano è subordinata all'iscrizione in apposita lista di collocamento ed al rilascio di nulla osta
all'assunzione;
caratteri propri ha il sistema di reclutamento del personale nel pubblico impiego, in virtù di una
precisa disposizione costituzionale (art.97) secondo cui (salvo <<i casi stabiliti dalla legge>> –
cioè per lavoratori di ridotta qualificazione professionale) <<agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso>>; la norma che regola le assunzioni impone alle
pubbliche amministrazioni di effettuare una selezione fra gli iscritti nelle liste di collocamento, i
quali devono essere avviati numericamente secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste
(provvisoriamente ancora in vigore, finché non vengano emanati provvedimenti regionali in
merito) alla selezione che <<deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a
svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa>>.
L'OBBLIGO DI ASSUNZIONE
L'istituto dell'obbligo di assunzione (costituzionalmente legittimato dagli artt. 2 e 38 – oggi
contenuto nella l.68/1999) ha come finalità il favorire l'ingresso nel mercato del lavoro di soggetti in
condizione di particolare difficoltà occupazionale.
Campo di applicazione alla legge si estende ad ampia tipologia di soggetti disabili (persone in età
lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali) ed in particolare:
– e portatori di handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
– invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
– invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra;
– ciechi e sordomuti.
Il relativo obbligo di assunzione grava su tutti i datori di lavoro (privati e pubblici) che occupino
almeno 15 dipendenti, con graduazione relativa alla dimensione occupazionale dell'organizzazione
produttiva:
– 7% dei lavoratori occupati, per quelle che occupano più di 50 dipendenti;
– 2 lavoratori, per quelle che occupano da 36 a 50 dipendenti;
– 1 solo lavoratore per quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti.
I soggetti interessati ad accedere al sistema di collocazione obbligatoria devono iscriversi in un
apposito elenco (tenuto dai centri per l'impiego) – previa sottoposizione ad accertamento delle
effettive condizioni di disabilità – organizzato in un'unica graduatoria (la cui utilità appare nel caso di
richiesta numerica).
La nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie prevede inoltre:
– la possibilità per le regioni di autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento di attività di
riqualificazione professionale del disabile presso la stessa azienda che effettua l'assunzione;
– l'obbligo per gli uffici competenti di predisporre una scheda professionale del disabile che
contenga tutte le indicazioni utili a favorirne l'inserimento lavorativo;
– che ove risulti impossibile avviare lavoratori con la qualifica richiesta, gli uffici competenti saranno
tenuti ad avviare lavoratori di qualifiche simili, previo addestramento o tirocinio;
– la facoltà di assunzione di disabili (anziché mediante richiesta di avviamento) stipulando con gli
stessi una convezione di inserimento lavorativo, che contenga tempi e modalità di assunzione.
Il rapporto di lavoro subordinato instaurato obbligatoriamente con disabili dev'essere improntato al
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 30 di 105
rispetto del principio di parità di trattamento (<<si applica il trattamento economico e normativo
previsto dalle leggi e dai contratti collettivi>>). Qualora si determini una situazione di incompatibilità
fra condizioni di salute e mansioni affidategli (sia nel caso che dipenda da variazioni
nell'organizzazione del lavoro, sia nel caso di un aggravamento dello stato invalidante), il disabile ha
diritto a sospensione non retribuita del rapporto di lavoro finché l'incompatibilità persista (e durante
tale periodo può essere impiegato in tirocinio formativo): la risoluzione del rapporto di lavoro è
ammessa solo previo accertamento della definitiva impossibilità di reinserimento del disabile
all'interno dell'azienda.
Al rifiuto di assumere il disabile (per quanto non esista una norma specifica in preciso) la
giurisprudenza prevalente riconosce al disabile a cui sia rifiutata l'assunzione solo il diritto al
risarcimento del danno, e non una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso.
TESI CONTRATTUALISTICHE ED ACONTRATTUALISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Secondo la concezione contrattualistica (quella prevalente nella dottrina italiana), la fonte del
rapporto di lavoro è da ricercarsi nel contratto di lavoro (così come anche espressamente
riconosciuto in numerose norme dell'ordinamento) – in contrasto con le tesi acontrattualistiche
(addotte in passato da impostazioni organicistico-comunitarie; ed odiernamente da coloro che
ritengono la dimensione cotrattuale inadeguata a cogliere la realtà del lavoro subordinata, la cui
disciplina andrebbe costruita sul rapporto in quanto tale) per il rapporto di lavoro subordinato
deriverebbe dall'inserimento del lavoratore nell'impresa.
Le ragioni addotte dalle tesi recenti acontrattualistiche si fondano essenzialmente sul fatto che è lo
stesso ordinamento ad imporre norme che prevalgono sull'autonomia negoziale individuale: d'altra
parte, anche altri rapporti di origine contrattuale che riguardano beni di primaria importanza risultano
provvisti di larga regolamentazione eteronoma a tutela del contraente più debole; ancora l'autonomia
privata ha possibilità di manifestarsi anche oltre la fase costitutiva, negoziando successivamente
trattamenti migliorativi rispetto a quelli previsti dalla legge.
CONTRATTO E RAPPORTO DI LAVORO
La disciplina del contratto di lavoro risulta, in ogni caso, segnata da tratti di peculiarità rispetto a
quella del diritto generale delle obbligazioni e dei contratti, riconducibili fondamentalmente alla
condizione di dipendenza tipica del lavoratore subordinato ed alla connessa esigenza di tutela.
Scarsa rilevanza hanno, ad esempio, le regole generali dei contratti riguardo alla simulazione ed ai
vizi del consenso:
– in caso di divergenza tra dichiarazione di volontà e concreto assetto del rapporto, il problema
viene risolto in sede giudiziale in termini di corretta qualificazione dello stesso (e non risulta
necessario ricorrere allo schema civilistico della simulazione relativa);
– la possibilità di richiedere annullamento di un contratto di lavoro subordinato viziato da vizio della
volontà, ed in particolare da errore sulle qualità personali del lavoratore, è ammessa nel caso in
cui l'errore risulti essenziale dal punto di vista del datore di lavoro, tale appunto da ridimensionare
le condizioni fiduciarie del rapporto di lavoro (errore, quindi, non sulle generiche qualità della
persona, ma sulle sue attitudini professionali riferite alle mansioni per le quali si è assunti).
Alternativa funzionale, di immediata praticabilità, all'azione di annullamento per i vizi del consenso è
rappresentata dalla clausola (di normale inserzione nel contratto di lavoro subordinato) di prova con
facoltà di recesso senza obbligo di motivazione.
L'art. 2126 c.c. , riguardo alla c.d. “prestazione di fatto con violazione di legge”, dispone che <<la
nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha
avuto esecuzione>>, introducendo quindi una deroga rispetto al regime generale della retroattività
della dichiarazione di nullità e della pronuncia di annullamento (regola generale che tornerà ad
operare qualora la nullità del contratto derivi dall'illiceità dell'oggetto, della causa o da motivo illecito
comune). La previsione derogatoria dell'art. 2126 ha permesso di ammettere (nell'ambito della
giurisprudenza) che gli effetti del contratto invalido possano essere fatti salvi pur a fronte della
mancanza di licenza, abilitazione od autorizzazione amministrativa prescritte per lo svolgimento di
determinate attività lavorative o del requisito dell'iscrizione all'albo professionale nei casi previsti dalla
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 31 di 105
legge, in quanto tali irregolarità porterebbero a nullità del contratto per violazione di norme imperative
e non per illiceità di oggetto o causa.
In caso di prestazioni svolte senza il consenso (invito domino) o contro la volontà del datore di lavoro
(prohibente domino) non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ed al
lavoratore si potrà riconoscere al più il diritto ad un giusto indennizzo, previo esercizio dell'azione
generale di arricchimento senza causa (ex art. 2041 secondo cui <<chi, senza una giusta causa, si è
arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare
quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale>>) che si potrà applicare anche in caso di
nullità del contratto per illiceità di oggetto o causa (salvo che si applichi la disposizione di cui all'art.
2435, per cui <<chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca
offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.>>)
NULLITA' DEL CONTRATTO
La Cassazione ha ribadito più volte che la violazione di norme imperative di legge non dà luogo a
nullità del contratto di lavoro qualora tali norme abbiano ad oggetto rapporti di per sé non incidenti sul
rapporto di lavoro.
Secondo la giurisprudenza prevalente, troverà applicazione l'eccezione contenuta nell'art. 2126 c.c.
(per cui nullità avrà effetto retroattivo qualora <<la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della
causa>>) solo qualora illiceità dell'oggetto e della causa siano contrari ai principi etici fondamentali
dell'ordinamento giuridico.
In ogni caso, la stipulazione del contratto di lavoro in violazione di norme imperative non esclude che
tale contratto produca i suoi normali effetti, anche sul piano previdenziale ed assistenziale: nel
pubblico impiego, al più, potrà determinare l'applicazione di sanzioni o provvedimenti inibitori
dell'attività lavorativa, ma non incide sulla validità dei rapporti di lavoro di dipendenti e sulla loro
posizione previdenziale.
Le garanzie costituzionali che tutelano il rapporto di lavoro, anche sotto l'aspetto previdenziale
assicurativo, non consentono di considerare privo di tutela un rapporto di fatto costituito per volontà
delle parti, sia pure in violazione di una norma imperativa di legge: se il rapporto viene costituito in
violazione di norma imperativa (anche se tale violazione è sanzionata penalmente) l'attività di fatto
prestata dal lavoratore dev'essere retribuita, non incidendo la violazione della norma imperativa sulla
causa del rapporto di lavoro, né rendendo illecito l'oggetto del contratto.
In forza dell'art. 2126 c.c. la nullità del contratto non produce effetti limitatamente al periodo in cui ha
avuto esecuzione: nel caso di violazione di norme riguardanti la qualifica richiesta dalla legge
professionale il lavoratore potrà chiedere la retribuzione per l'attività prestata, ma non potrà
rivendicare il diritto a vedersi reintegrato nel posto di lavoro: al contratto viene riconosciuta efficacia
limitatamente al periodo in cui esso ha avuto attuazione.
Infine, sempre ai sensi dell'art 2126 c.c. , <<se il lavoro è stato prestato con violazione di norme
poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione>>
L'ETA' MINIMA LAVORATIVA
Fatte salve previsioni specifiche in relazioni a particolari attività lavorative, la recente l.296/2006 ha
fissato a 16 anni l'età minima per l'accesso al lavoro:
– con riguardo al contratto di lavoro la capacità giuridica (attitudine ad essere parte di rapporti
giuridici) non può acquistarsi alla nascita ma solo dal momento del compimento della prescritta
minima età;
– allo stesso modo anche la capacità d'agire (attitudine a stipulare il contratto e di esercitare i diritti
conseguenti) si ritiene acquistata al compimento dell'età minima per l'accesso al lavoro.
A seguito della l.39/1975 è stato infatti abrogato l'articolo del codice dedicato alla capacità in materia
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 32 di 105
di lavoro, ne nel nuovo testo dell'art.2 c.c. è stata inserita la disposizione per la quale, fissata la
maggiore età al compimento del 18esimo anno, sono fatte <<selve le leggi speciali che stabiliscono
un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro>>, aggiungendosi che <<in tal caso
il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro>>.
Requisito di età minima specifico è stato previsto per il pubblico impiego, per cui possono accedere
agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti di età <<non inferiore ai 18 anni e non
superiore ai 40>>.
I REQUISITI DI FORMA DEL CONTRATTO DI LAVORO
La stipulazione di un contratto di lavoro subordinato non risulta vincolata al rispetto di requisiti
formali. In linea di massima si impone la regola generale della libertà di forma, in forza della quale
risulta ammissibile persino la stipulazione di un contratto per fatti concludenti. E' fatta eccezione per il
contratto di arruolamento marittimo, per la quale stipulazione è richiesto l'atto pubblico, pena la
nullità. Inoltre il requisito di forma scritta tende, sempre più frequentemente, ad essere richiesto dal
legislatore nell'ambito dei lavori atipici (e nel lavoro somministrato), con l'obbiettivo di rendere
consapevole il lavoratore delle particolari caratteristiche del rapporto instaurato.
La forma scritta è altresì richiesta quantunque soltanto a fini di prova anche nel contratto di lavoro a
tempo parziale, nel lavoro ripartito, nel lavoro intermittente, ed nel lavoro a progetto.
Fatte salve tali eccezioni, la regola della libertà di forma può considerarsi valida nel nostro
ordinamento pur a fronte delle disposizioni del d.lgs 152/1997 con il quale si è provveduto a recepire
una direttiva comunitaria: è stato imposto al datore di lavoro l'obbligo di informare, all'atto
dell'assunzione, il lavoratore relativamente a determinati elementi essenziali del rapporto (identità
delle parti, luogo di lavoro, data dell'inizio del rapporto, durata, inquadramento, importo e periodicità
di versamento della retribuzione, ferie, orario di lavoro, termini di preavviso in caso di licenziamento)
contenuti nel contratto scritto, in una lettera d'assunzione, o genericamente in un qualsiasi altro
documento scritto; a tale comunicazione scritta, va riconosciuto un certo valore probatorio (e si ritiene
assistita da una presunzione di veridicità – smentibile ove necessario dal lavoratore o datore di
lavoro).
IL PATTO DI PROVA
La libertà di forma viene meno riguardo a singole clausole del contratto di lavoro: il patto di prova
(previsto dall'art. 2096 c.c. a tutela formalmente sia dell'interesse del lavoratore che del datore di
lavoro) può essere inserito nel contratto di lavoro subordinato; è opinione comune che la forma scritta
debba intendersi richiesta per la validità del medesimo (ed in mancanza il patto di prova vada
considerato nullo – ferma restando la validità del contratto di lavoro, da considerarsi a tempo
indeterminato ab origine).
La Cassazione ha affermato che il patto di prova deve contenere la specifica indicazione delle
mansioni da espletarsi (ed in mancanza opera automatica conversione dell'assunzione in definitiva
sin dall'inizio): è necessario che il lavoratore conosca preventivamente il contenuto della prova cui
sarà sottoposto (e pertanto le mansioni alle quali sarà adibito durante il relativo periodo) onde poter
dimostrare le proprie attitudine de il datore di lavoro esprimere la propria valutazione in ordine ai
compiti predeterminati. La specificazione è alla base del patto di prova e, pur nell'ambito di un
richiamo a contratti collettivi (attraverso riferimenti alle astratte e generiche figure ivi previste),
devono essere indicate le mansioni nella loro materiale struttura.
Durante il periodo di prova (sottoscritto da entrambe le parti in un momento anteriore o coevo alla
costituzione del rapporto – di durata non superiore ai 6 mesi dall'inizio del rapporto), entrambe le
parti possono recedere senza obbligo di motivazione né preavviso: oltre al trattamento di fine
rapporto, il lavoratore licenziato durante il periodo di prova avrà diritto ad un periodo di ferie retribuite
(od alla corrispondente indennità sostitutiva).
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 33 di 105
La Corte Costituzionale ha stabilito alcuni limiti a tale potere di recesso, derivanti dalla previsione (ex
art. 2096 c.c.) per cui <<l’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a
consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova>>:
Tenuto conto delle finalità per cui è preordinata la prova (la valutazione delle capacità e del
comportamento professionale del lavoratore) il giudice può sindacare la legittimità del recesso
qualora:
– non sia stata consentita l'effettuazione dell'esperimento;
– l'inserimento non abbia avuto durata adeguata;
– l'esperimento sia stato positivamente superato dal lavoratore;
– quest'ultimo sia imputabile a motivo illecito (diretto quindi ad eludere norme imperative).
In ogni caso, l'onere della prova spetta al lavoratore, il quale è tenuto a dimostrare che il recesso è
stato ispirato a motivi del tutto estranei alla funzione tipica del patto di prova (o che non sia stato
posto in gradi di dimostrare le sue attitudini all'apprendimento delle mansioni per le quali è stato
assunto, o la sua capacità di tradurre in pratica gli insegnamenti ricevuti).
Infine, <<compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva ed il servizio prestato si
computa nell'anzianità del prestatore di lavoro>>.
Si è ritenuta (in giurisprudenza) legittima anche l'apposizione di patto di prova nel contratto di
formazione e lavoro, purché la prova abbia ad oggetto non la valutazione di una compiuta capacità
professionale, ma l'idoneità ad acquisirla. Espressamente prevista dall'ordinamento per il contratto
d'apprendistato, si deve ritenere che la norma possa essere infine estesa anche al contratto
d'inserimento.
ASSUNZIONE IN PROVA DEL LAVORATORE DISABILE
La Corte Costituzionale (con una sentenza del 1989) ha ritenuto legittimo il patto di prova anche nel
contratto di lavoro stipulato con un invalido, tenendo però presente che <<l'esperimento deve
riguardare mansioni compatibili con lo stato d'invalidità o di minorazione fisica del lavoratore e l'esito
della prova non deve essere assolutamente influenzato da considerazioni di minor rendimento
dovute alla infermità o alle minorazioni>> e che, nel caso specifico, <<il recesso del datore di lavoro
deve avere un'adeguata motivazione>>.
Sempre la Corte ha affermato che <<il lavoratore può rifiutarsi di sottoporsi alla prova adducendo un
giusto o giustificato motivo. Il rifiuto è soggetto al sindacato del giudice. Se esso risulta ingiustificato,
il datore di lavoro e` liberato dall'obbligo della stipulazione; in caso contrario (sussistenza del giusto o
giustificato motivo) il datore di lavoro deve egualmente stipulare il contratto di lavoro >>.
In ogni caso, la possibilità di assumere in prova il lavoratore disabile è stata espressamente prevista
dalla l.68/1999 purché l'esito della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il
soggetto non costituisca motivo di risoluzione del contratto.
Nel caso di assunzioni obbligatorie, la Cassazione ha ribadito che spetta al giudice il potere-dovere di
accertare la nullità o meno del recesso in esisto della prova che risulti determinata (o comunque
influenzata) dalle condizioni di inabilità cui è collegato l'obbligo di assunzione: d'altra parte l'assenza
di una motivazione contestuale all'atto di licenziamento non può, di per sé, incidere sulla validità ed
efficacia del medesimo – in quanto lo scrutinio della legittimità del licenziamento potrà basarsi su altri
elementi indiziari (come la brevissima durata della prova; la compatibilità delle mansioni affidate con
lo stato di menomazione del lavoratore; la complessità delle mansioni affidate; la natura e le modalità
di attuazione dell'esperimento).
IL DIVIETO DI INDAGINI DISCRIMINATORIE
Se le capacità professionali di un dato lavoratore costituiscono oggetto di possibile accertamento
prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, l'ordinamento si preoccupa di prevenire possibili
prassi discriminatorie, circoscrivendo (con l'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori) l'ambito degli
accertamenti leciti: essendo vietate quelle <<indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche,
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 34 di 105
religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoratore>>, emerge che quelle lecite rimangono esclusivamente quelle <<rilevanti
ai fini della valutazione dell'attitudine professionale>>. In relazione alle mansioni d'assunzione il
concetto di “rilevanza ai fini della valutazione” assume un carattere elastico: è infatti ammesso che
indagini politiche, sindacali o religiose possano essere svolte da parte delle c.d. “organizzazioni di
tendenza” in relazioni a mansioni intimamente connesse con la “tendenza” di cui l'organizzazione è
portatrice.
Infine, con particolare riguardo alle indagini sullo stato di salute dei dipendenti (che rientra nella sfera
personale del lavoratore, salvo per quelle determinate attività per cui l'esposizione del lavoratore a
determinate patologie potrebbe risultare pericolosa per i terzi):
– la l.135/1990 ha vietato ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare l'esistenza
di uno stato di sieropositività, sia sui dipendenti che <<in persone prese in considerazione per
l'instaurazione di un rapporto di lavoro>> salvo il caso in cui (come affermato dalla Corte
Costituzionale) tali accertamenti risultino <<condizione per l'espletamento di attività che
comportano rischi per la salute di terzi>>;
– il D.P.R. 309/1990 ha inoltre imposto ai datori di lavoro di sottoporre i lavoratori <<destinati a
mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi [..] ad
accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio>>;
– da ritenersi sicuramente compreso entro l'ambito dell'art. 8 dello Statuto ricadono invece i test
genetici, volti a prevedere l'andamento futuro dello stato di salute dei candidati all'assunzione.
IL CONCETTO DI LAVORO ATIPICO
L'espressione lavoro atipico è utilizzata per designare un fenomeno multiforme: è un ampio
contenitore che racchiude una variegata tipologia di rapporti di lavoro con caratteristiche difformi da
quelle considerate inerenti al modello storicamente radicatosi come modello standard (a tempo pieno
e durata indeterminata, alle dipendenze per tutto l'arco della carriera del medesimo datore di lavoro,
con svolgimento della prestazione in locali propri di quest'ultimo).
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche proprie della c.d. new economy, il parallelo
consolidamento di nuovi modelli di organizzazione e lavoro, le accresciute pressioni competitive fra le
imprese (indotte dall'apertura dei mercati e della globalizzazione dell'economia) hanno determinato,
nel corso dell'ultimo ventennio dei XX secolo, un forte sviluppo del fenomeno, sia in termini
quantitativi che qualitativi – al quale è seguito l'attivismo dei vari legislatore: sempre meno, quindi, i
lavori atipici possono essere considerati tali dato il loro sempre minor carattere di residualità e
marginalità.
IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei diversi ordinamenti giuridici, ha storicamente
caratterizzato il modello standard di rapporto di lavoro subordinato: il principio, già presente nel
nostro ordinamento (nell'abrogato art. 2097 c.c. secondo cui <<il contratto di lavoro si reputa a tempo
indeterminato se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto>>), è stato ribadito
con l'attuazione della direttiva comunitaria 70/1999 che si riferisce ai rapporti a tempo indeterminato
come <<forma comune dei rapporti di lavoro>>.
Se ai sensi dell'art. 2097 c.c. l'assunzione con contratto a tempo determinato era sempre possibile
purché il termine risultasse <<dalla specialità del rapporto o da atto scritto>>, il legislatore del 1962
(con la l.230/1962) abrogò espressamente la norma, abbandonando il generico richiamo alla
specialità del rapporto sostituendolo con un'elencazione tassativa di ipotesi. Il rigore della norma si è
affievolito mano a mano che la lista chiusa veniva integrata da nuove ipotesi, da parte del legislatore
e (ai sensi della l.56/1987) dalla contrattazione collettiva.
Il d.lgs. 368/2001 (in pretesa attuazione di una direttiva comunitaria) ha innovato profondamente la
materia, all'apparenza spogliando l'assunzione a termine di ogni carattere di eccezionalità:
effettivamente la nuova normativa afferma che <<è consentita l'apposizione di un termine alla durata
del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 35 di 105
sostitutivo>>, e (salvo il riferimento alle ragioni di carattere “sostitutivo”, già previsto nella l.230/1962
e dalla contrattazione collettiva) tali indicazioni sono così ampie e generiche da comportare, in favore
dei datori di lavoro, una larghissima discrezionalità di scelta in ordine alla tipologia contrattuale ed
una parallela, sostanziale, liberalizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato (a fronte di
marginali divieti, tra cui quello di assumere a tempo determinato per sostituire lavoratori in sciopero).
La Cassazione ha subito fornito una chiave interpretativa della vigente normativa, ri-affermando
innanzitutto il carattere eccezionale del contratto a tempo determinato: la Corte di Cassazione, pur
rilevando la tendenza ad un progressivo ampliamento delle ipotesi di legittima stipulazione di contratti
a termine, conclude che la descritta tendenza non implica una piena libertà di apposizione al termine
– ma la necessità di un'effettiva giustificazione causale del termine (essendo insufficiente un rinvio a
generiche “ragioni tecnico-organizzative”, meramente ripetitive della formula usata dal legislatore.
Poiché per il contratto a termine è necessario un atto scritto e motivato, ed illegittime proroghe
vanificano il termine stesso, si deve desumere che il termine costituisca deroga di un generale
sottinteso principio per cui il contratto di lavoro subordinato, per sua natura, non è a termine.
Alla dichiarata nullità della clausola temporale consegue l'automatica conversione del contratto a
termine in un contratto a tempo indeterminato ab origine, dovendosi ritenere il termine come mai
apposto.
LA DISCIPLINA DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Onde bilanciare la condizione di precarietà del lavoratore assunto a tempo determinato,
l'ordinamento ha previsto una serie di tutele:
– innanzitutto, la forma scritta ad substantiam dell'apposizione del termine (sia prestabilito che
per relationem – cioè con riferimento ad evento futuro e certo) che <<se non risulta [..] da atto
scritto nel quale sono specificate le ragioni>> legittima il lavoratore a chiedere in giudizio la
conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (sia nel caso che
l'omissione riguardi le ragioni specifiche dell'assunzione che del solo termine finale);
– in caso di contestazioni, l'onere della prova relativa all'<<obiettiva esistenza delle ragioni che
giustificano l'eventuale proroga del termine>> spetta al datore di lavoro; per via interpretativa si
può ritenere che, in mancanza di prova, il giudice possa procedere a dichiarare sussistente inter
partes un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– la legittimità della proroga di un contratto a termine è subordinata alla sussistenza di condizioni:
– che vi sia il consenso del lavoratore;
– che la durata iniziale sia inferiore a 3 anni;
– che vi sia una sola proroga;
– che sia richiesta per ragioni oggettive;
– che si riferisca <<alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato>>.
Sempre ai sensi del d.lgs 368/2001, nel caso di continuazione del rapporto a termine oltre la
scadenza inizialmente concordata tra le parti (o successivamente prorogata), il datore di lavoro sarà
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva (il 20% per i primi 10 gg, il 40%
per ogni ulteriore giorno) – così fino al 21esimo giorno (per contratti di durata prevista fino a 6 mesi)
od al 31esimo giorno (per i contratti di durata superiore ai 6 mesi) quando tornerà ad operare la
sanzione della conversione ed il contratto si considererà a tempo indeterminato (seppur soltanto
<<dalla scadenza dei predetti termini>>).
Quanto all'ipotesi che <<il lavoratore venga riassunto a termine [..] entro un periodo di 10 giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza
di un contratto di durata superiore ai sei mesi>> essa prefigura presunzione di fronde (a fronte della
quale non occorre dimostrare l'intento fraudolento del datore di lavoro per rivendicare il giudizio la
conversione del secondo contratto a termine in contratto a tempo indeterminato: <<quando si tratta di
due assunzioni successive a termine [..] il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla
data di stipulazione del primo contratto>> solo nel caso in cui queste siano <<effettuate senza alcuna
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 36 di 105
soluzione di continuità>> (quindi senza neppure un giorno di intervallo tra le due).
Riguardo al principio di parità di trattamento fra lavoratori precari e assunti a tempo indeterminato, la
norma stabilisce che ai primi spettino le ferie, la tredicesima, il TFR ed <<ogni altro trattamento in
atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili>> naturalmente
<<in proporzione al periodo lavorativo prestato>> (e compatibili con la natura del contratto a termine).
Il diritto di precedenza per i lavoratori subordinati, che riguarda nuove assunzioni (a termine od a
tempo indeterminato) <<presso la stessa azienda e con la medesima qualifica>>, è esercitabile solo
se previsto dai contratto collettivi nazionali, ed <<in ogni caso [..] si estingue entro un anno dalla data
di cessazione del rapporto stesso>>.
La normativa stabilisce la contrattazione collettiva possa fissare <<limiti quantitativi di utilizzazione
dell'istituto del contratto a tempo determinato>> salvo per quelle ipotesi di assunzione a termine che
la legge ha reso esenti da limitazioni quantitative.
L'impugnazione di un contratto a termine illegittimo, secondo l'impostazione prevalente (in assenza di
chiare indicazioni ad opera del legislatore) andrebbe invocata tramite tramite azione di nullità
imparziale (imprescrittibile – per quanto la Cassazione abbia affermato che la mancanza di qualsiasi
manifestazione di interesse alle funzionalità di fatto di un contratto con termine illegittimamente
apposto può indurre, tenuto conto delle circostanze concrete, a ritenere perfezionata la fattispecie
negoziale della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) ed il termine illegittimamente apposto
potrà assimilarsi a licenziamento (la cui contestazione è soggetta a breve termine di decadenza
60gg) solo quando il datore di lavoro, nel presupposto dell'intervenuta conversione del rapporto,
abbia intimato un vero e proprio licenziamento.
Durante la durata del contratto a termine, nessuna delle due parti può sottrarsi agli obblighi nascenti
dal contratto salvo ricorra giusta causa (che cioè, ai sensi dell'art. 2119 c.c. <<non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto>>): a fronte di un recesso ingiustificato ante tempus
del datore di lavoro, la giurisprudenza esclude l'applicazione dei rimedi previsti in materia di
licenziamento, considerati circoscritti ai rapporti a tempo indeterminato, ed al lavoratore potrà solo
riconoscersi il risarcimento del danno, di importo pari all'entità delle retribuzioni che sarebbero state
percepite (deducendo però quanto avrebbe potuto percepire od avrebbe percepito, usando l'ordinaria
diligenza, da altra occupazione).
La normativa del 2001 ha mantenuto in vita la preesistente regolamentazione del lavoro a termine nel
settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali; inoltre è stata confermata la possibilità,
limitatamente ai settori del turismo e dei pubblici servizi, di stipulare rapporti a termine <<per
l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni>> sulla base di previsioni conformi
dei contratti collettivi; risultano ancora esclusi dal decreto altri rapporti di carattere temporaneo per i
quali operano discipline specifiche, nonché le attività lavorative che non presuppongono
l'instaurazione di un rapporto di lavoro; infine i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e
gli operai a tempo determinato, e quelli instaurati con le aziende che esercitano l commercio di
esportazione, importazione ed all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli; ai rapporti a termine con dirigenti
si applicano solo le disposizioni sulla parità di trattamento e sulla computabilità nell'organico
dell'impresa.
Tale disciplina dovrebbe potersi applicare anche al pubblico impiego, salvo che l'eventuale violazione
delle regole in materia di assunzioni a termine non può <<in ogni caso [..] comportare la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato>>; è stato tuttavia riconosciuto il diritto <<al risarcimento
del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative>>.
IL LAVORO PART-TIME
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) è regolato dal d.lgs 276/2003 (poi modificato dalla
l.247/2007) che ha innovato per molti aspetti la precedente disciplina contenuta nel d.lgs 61/2000:
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 37 di 105
obiettivo delle modifiche introdotte è l'incremento della flessibilità nelle modalità di gestione del parttime, anche mediante l'allargamento dell'autonomia individuale (e la riduzione dello spazio riservato
alla contrattazione collettiva).
Ai sensi del d.lgs 61/2000, <<nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo
pieno od a tempo parziale>> dove per tempo pieno si definisce l'orario di lavoro di 40 ore settimanali
(come stabilito dal d.lgs 66/2003) – od al minor orario stabilito dalla contrattazione collettiva –, mentre
per tempo parziale si definisce un orario minore rispetto a quello a tempo pieno.
Con relazione a come si applica la riduzione del lavoro si distinguono diverse tipologie di part-time:
– nel part-time di tipo orizzontale la riduzione di orario rispetto al lavoro pieno è prevista in relazione
all'orario normale giornaliero (che per via interpretativa si può ricavare dividendo per 5 o per 6 la
durata dell'orario settimanale di 40 ore);
– nel part-time di tipo verticale l'attività lavorativa si svolge a tempo pieno rispetto all'orario
giornaliero, ma limitatamente a predeterminati periodi nel corso della settimana, del mese o
dell'anno;
– il part-time misto è risultante da una combinazione delle due precedenti tipologie.
Il contratto di lavoro part-time ha forma scritta per la prova, e deve contenere <<puntuale indicazione
della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario di lavoro con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno>>; «l'eventuale mancanza o indeterminatezza
nel contratto scritto>> di tali indicazioni <<non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo
parziale.>>, ed in particolare:
– <<qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore
può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire
dalla data del relativo accertamento giudiziale.>>;
– <<qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice
provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo
parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi [..] o, in mancanza, con valutazione
equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato,
della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo
svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. >>.
E' inoltre stabilito che <<per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il
lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un
ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno>>.
LA DISCIPLINA DEL PART-TIME
Da accordo tra datore di lavoro e lavoratore (formalizzato per iscritto e convalidato dalla direzione
provinciale del lavoro) è possibile operare una trasformazione di un rapporto a tempo pieno in uno a
tempo parziale; in ogni caso <<il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro [..]
non costituisce giustificato motivo di licenziamento>>.
Eventuale diritto di precedenza (ex lege nella previgente normativa – onde contrastare il fenomeno
del c.d. part-time involontario) dei lavoratori subordinati part-time nel caso di nuove assunzioni a
tempo pieno (di personale adibito a stesse od equivalenti mansioni) è rimesso alla volontà negoziale
delle parti in sede di stipulazione: la l.247/2007 ha infine ripristinato tale diritto nel caso dei soli
lavoratori che siano part-time in seguito ad una trasformazione.
Nel caso opposto (cioè con riferimento ai lavoratori a tempo pieno che abbiano interesse trasformare
il proprio rapporto full-time), in caso di assunzione di personale part-time, il datore di lavoro è tenuto
a <<prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del
rapporto dei dipendenti a tempo pieno>>, per quanto tale disposizione effettivamente non riconosca
alcun diritto alla trasformazione del rapporto (ed il rifiuto del datore di lavoro, a seguito delle
modifiche apportate dal d.lgs 276/2003, non debba più essere <<adeguatamente motivato>>).
Per quanto riguarda la computabilità nell'organico dell'impresa, è previsto che (secondo un criterio
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 38 di 105
di proporzionalità pura) <<i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero
di lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno>>.
Il d.lgs 61/2000 afferma anche per i lavoratori part-time il principio di non discriminazione, per cui ad
essi non si può riservare <<un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno
comparabile [..] per il solo motivo di lavorare a tempo parziale>>: il diritto al medesimo trattamento
spettante ad un lavoratore a tempo pieno deve però essere riproporzionato <<in ragione della ridotta
entità della prestazione lavorativa>>.
CLAUSOLE ELASTICHE E CLAUSOLE FLESSIBILI NEL PART-TIME
Il lavoro supplementare è <<quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di
lavoro concordato fra le parti [..] ed entro il limite del tempo pieno>>: è riconosciuta (dalla nuova
normativa) al datore di lavoro la possibilità di richiedere al lavoratore part-time (anche se assunto con
contratto a termine) lo svolgimento di prestazioni supplementari.
Tale possibilità – prevista esclusivamente nel caso di rapporto part-time orizzontale – è subordinata
al consenso del lavoratore interessato ed, in ogni caso, il rifiuto del lavoratore ad eseguire la
prestazione supplementare <<non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento>> (tuttavia potrebbe esporre il lavoratore a sanzioni disciplinari).
A seguito delle modifiche della disciplina operate dal d.lgs 276/2003 era consentito che tali clausole
(la cui apposizione è consentita anche in caso di lavoro a tempo determinato) potessero essere
pattuite direttamente fra le parti nel contratto individuale di lavoro, senza che fosse più necessaria la
preventivaprevisione e regolamentazione della clausola da parte della contrattazione collettiva (così
come era previsto dal d.lgs. 61/2000): tale previsione è stata abrogata dalla l.247/2007, che ha così
reso alla contrattazione collettiva l'originaria determinante importanza a riguardo.
Il contratto di lavoro part-time può contenere clausole flessibili (riguardo la collocazione temporale
della prestazione lavorativa nell'unità di tempo considerata), e clausole elastiche (riguardo
l'estensione temporale – ammesse solo per rapporti di lavoro a tempo parziale verticale e misto).
L'attivazione di tali clausole è subordinata a due condizioni:
– il datore di lavoro può variare la collocazione temporale o la durata della prestazione lavorativa
con un preavviso minimo di almeno (così come stabilito dalla l.247/2007, a fronte dei due giorni
previsti nella previgente disciplina) cinque giorni lavorativi (fatte salve le intese fra le parti);
– al lavoratore va riconosciuto <<il diritto a specifiche compensazioni nella misura ovvero nelle
forme fissate dai contratti collettivi>> (che sembrerebbero poter consistere anche in
compensazioni di carattere non pecuniario).
La normativa vigente ha cancellato il diritto di ripensamento che permetteva (a fronte di
documentate ragioni) di far continuare il rapporto di lavoro nelle modalità orarie indicate inizialmente
nel contratto di lavoro.
E' infine stabilito che <<lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili [..] senza il rispetto >>
dell'obbligo di preavviso (e della corresponsione delle compensazioni), e (soprattutto) <<del
consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto>> <<comporta a favore del
prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno>>.
IL PART-TIME NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La disciplina del part-time si può anche applicare ai lavoratori a tempo parziale nelle pubbliche
amministrazioni (salvo le disposizioni espressamente escluse – come l'obbligo di forma scritta e
relative sanzioni); inoltre il pubblico dipendente può chiedere di trasformare (salvo poi l'esercizio del
diritto di ripensamento) il proprio a tempo pieno in lavoro part-time (onde magari affiancarlo ad altra
occupazione, che comporti prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno), e
tale trasformazione gli si può negare solo nel caso in cui l'eventuale seconda attività lavorativa
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 39 di 105
(subordinata od autonoma) comporti una situazione di <<conflitto di interessi con la specifica attività
di servizio>> svolta nella pubblica amministrazione.
La l.133/2008 ha stabilito inoltre che il mancato rispetto dei vincoli quantitativi di durata della
prestazione (il 50% di quella a tempo pieno) entro cui si può operare tale trasformazione possono
configurare l'ipotesi di giusta causa di licenziamento.
E' stato infine stabilito che ai pubblici dipendenti che scelgono il part-time sia concessa la possibilità
di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione.
IL RAPPORTO DI LAVORO RIPARTITO
Il rapporto di lavoro ripartito (job sharing, regolato dal d.lgs 276/2003) è <<uno speciale contratto
di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica
obbligazione lavorativa>> (e ciò implica che <<fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti [..]
ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera
obbligazione lavorativa>>); il contratto di job sharing deve essere stipulato in forma scritta a fini di
prova, e nell'atto scritto devono essere indicate <<la misura percentuale e la collocazione temporale
del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei
lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse>>.
Nei confronti della coppia di coobbligati vale il principio di non discriminazione (ed in particolare che il
lavoratore coobbligato non debba ricevere, <<per i periodi lavorati, un trattamento economico e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di
mansioni svolte. >> ): in generale, salvo eventuali regole introdotte dalla contrattazione collettiva, al
contratto di lavoro ripartito si applica <<la normativa generale del lavoro subordinato in quanto
compatibile con la particolare natura del rapporto>>.
Riguardo la fase estintiva del rapporto, il legislatore ha stabilito che:
– <<le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione
dell'intero vincolo contrattuale>>, salvo che il datore di lavoro proponga all'altro lavoratore di
continuare a ricoprire (del tutto od in parte) il posto di lavoro in relazione al quale si era stipulato il
contratto di job-sharing, nel cui caso <<il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale
contratto di lavoro subordinato>>;
– fatto salva diversa intesa tra le parti, <<l'impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati>> può
determinare la risoluzione ipso iure del contratto di lavoro (prescindendo quindi l'applicabilità della
disciplina speciale in materia di licenziamento).
IL LAVORO INTERMITTENTE
Il lavoro intermittente è un particolare rapporto di lavoro subordinato senza alcun orario di lavoro (né
fisso, né variabile), stipulando il quale un lavoratore <<si pone a disposizione di un datore di lavoro>>
pronto a rispondere all'eventuale chiamata di quest'ultimo per l svolgimento di prestazioni (<<di
carattere discontinuo o intermittente>>):
– nel caso in cui la disponibilità del lavoratore sia piena ed incondizionata, è previsto che il
lavoratore abbia il diritto a percepire un'“indennità di disponibilità” mensile, destinata a
remunerare <<i periodi nei quali il lavoratore [..] garantisce la disponibilità al datore di lavoro in
attesa di utilizzazione>> (in misura fissata dai contratti collettivi, comunque non inferiore a quella
indicata con decreto del ministero del lavoro – ad oggi pari al 20% della retribuzione prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato), non dovuta <<in caso di malattia o di altro
evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata>>; il rifiuto ingiustificato
di rispondere alla chiamata può comportare, oltre alla risoluzione del contratto, l'obbligo di
corrispondere un <<congruo risarcimento del danno>> al datore di lavoro.
– nel caso in cui egli non si obblighi <<contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di
lavoro>> gli sarà dovuta solo la retribuzione corrispondente alle prestazioni eventualmente
richieste ed effettivamente rese.
La possibilità di stipulare tale contratto è stata limitata dal legislatore solo a determinati soggetti:
– soggetti di età inferiori a 25 anni;
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 40 di 105
lavoratori ultraquarantacinquenni, anche se pensionati;
altre categorie di soggetti individuate dai contratti collettivi (o con decreto del ministero del lavoro).
Per tale categoria negoziale è stabilito che:
– richieda la forma scritta a fini di prova (che deve indicare la durata; la ragione in forza della quale
è stato stipulato; il preavviso di chiamata – comunque non inferiore ad un giorno lavorativo – ; la
modalità della disponibilità garantita dal lavoratore);
– vi sia la possibilità di stipulare tali contratti limitatamente a <<periodi predeterminati nell'arco della
settimana, del mese o dell'anno>>.
–
–
Per quanto riguarda il principio di non discriminazione (richiamato come nel job-sharing), si deve
rilevare una peculiarità della condizione del lavoratore intermittente, il quale durante il periodo di
disponibilità alla chiamata del datore di lavoro <<non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai
lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo>>, salvo l'eventuale
indennità di disponibilità. In relazione a tale periodo si suppone inoltre – nel silenzio del legislatore –
che persista l'obbligo di fedeltà del lavoratore.
Per quanto riguarda la computabilità dei lavoratore intermittenti nell'organico dell'impresa, questa è
ammessa <<in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre>>.
I CONTRATTI A CAUSA MISTA
Nella previgente disciplina, strumento di incontro tra lavoro e formazione professionale era
rappresentato dal CFL. Il CFL è caratterizzato da una causa mista costituita dallo scambio fra lavoro
retribuito ed addestramento finalizzato all'acquisizione della professionalità necessaria al lavoratore
per immettersi nel mondo del lavoro: diversamente dall'apprendistato, il CFL ha l'obiettivo di attuare
una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro: la funzione formativa compresa nella
causa del contratto consiste nel conseguimento della qualificazione professionale prevista dal
progetto di formazione e lavoro, e non in un generico affinamento professionale attraverso un
generico addestramento – e certamente tale formazione (destinata a qualificare il giovane anche
nella prospettiva di mancata conferma nell'azienda) non può esaurirsi per il datore di lavoro
nell'impartire quelle fondamentali istruzioni che in qualsiasi attività lavorativa, a qualsiasi livello
professionale, sono ordinariamente impartite al neoassunto.
L'attività di formazione costituisce il parametro di valutazione, dell'approvazione e del successivo
controllo da parte della commissione regionale per l'impiego.
Nel caso in cui si riscontri inadempimento contrattuale per quanto riguarda la formazione da parte del
datore di lavoro, la sanzione è la trasformazione (ab origine) del rapporto in lavoro subordinato.
L'apposizione di un termine al CFL è fortemente legata alla finalità formativa, che deve essere
conseguito nel termine non inferiore a quello previsto: il termine massimo di durata dev'essere
sospeso e differito in tutti i casi in cui si verifichino fatti oggettivamente impeditivi della formazione
professionale tali da consentire una proroga pari alla sospensione, ai fine del completamento della
formazione.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
L'obbiettivo di favorire l'accesso al lavoro alle nuove leve è stato tradizionalmente perseguito tramite
il contratto di formazione e lavoro (CFL), contratto di lavoro con finalità formative fortemente
caratterizzato dalla funzione di inserimento nel mercato del lavoro dei giovani lavoratori interessati.
La recente legislazione (con il d.lgs 276/2003) ha marginalizzato la sfera operativa del CFL,
sviluppando invece la forma del contratto d'apprendistato (contratto a causa mista caratterizzato
fortemente dall'elemento della formazione, non esaurendosi infatti nel semplice scambio fra lavoro e
retribuzione, ma che implica un più complesso nesso di corrispettività fra attività lavorative,
retribuzione e formazione); innanzitutto l'istituto dell'apprendistato è stato affiancato al diritto-dovere
di istruzione e formazione, e per tale motivo il legislatore ha articolato l'apprendistato in due principali
varianti:
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 41 di 105
il <<contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione>>,
esplicitamente finalizzato al <<conseguimento di una qualifica professionale>> (di durata non
superiore ai 3 anni – destinato a soggetti che abbiano compiuto il 15esimo anno di età – anche se
nn si coglie se tale previsione resti eccezione alla regola dettata dalla recente l.296/2006 che
stabilisce età minima lavorativa di 16 anni);
– il <<contratto di apprendistato professionalizzante>>, il cui scopo è far acquisire una
qualificazione (intesa come più elevato grado di specializzazione) <<attraverso una formazione
sul lavoro e un apprendistato tecnico-professionale>> (di durata non superiore sei anni, essendo
stato abrogato dalla l.133/2008 il precedente limite minimo di due anni – destinato a <<soggetti di
età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni>>).
Entrambi i contratti possono essere stipulati in tutti i settori di attività (con eccezione delle pubbliche
amministrazioni), in forma scritta ad substantiam, che deve contenere:
– il piano formativo individuale;
– la prestazione lavorativa richiesta all'apprendista;
– la qualifica o l'eventuale specializzazione professionale acquisibili <<al termine del rapporto di
lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extraziendale>>.
Il riconoscimento di agevolazioni contributive per i datori di lavoro che stipulino contratti
d'apprendistato sono subordinate alla condizione che gli apprendisti partecipino ad iniziative di
formazione esterna all'azienda (con contenuti e durata stabiliti dalla contrattazione collettiva sulla
base di indicazioni disposte dal ministero del lavoro): alla normative regionali è riconosciuto il compito
di provvedere al <<riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di
formazione [..] della qualifica professionale ai fini contrattuali>>.
Se la l.196/1997 puntava sulla formazione esterna, la l'133/2008 ammette che la formazione possa
risultare esclusivamente interna – ed in tal caso i contratti collettivi determineranno definizione,
modalità e durata della formazione.
–
Onde garantire che lo svolgimento della prestazione dell'apprendista in un contesto organizzativo
effettivamente favorevole all'acquisizione di una qualificazione professionale, è stato stabilito che
<<il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di
apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio
presto il datore di lavoro stesso>>, tuttavia <<il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre,
può assumere apprendisti in numero non superiore a tre>>.
Se in generale al contratto d'apprendistato si possono applicare le regole ricavate dal d.lgs.
276/2003, in particolare riguardo alla specifica disciplina:
– è possibile inserire un patto di prova;
– è stato fatto <<divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo>>;
– è stabilito che il c.d. salario d'ingresso non possa essere, così come in generale la categoria
d'inquadramento del lavoratore, <<inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante>>.
Nell'apprendistato la contrattazione collettiva ha sempre previsto trattamenti salariali ridotti,
giustificati dal fatto che la prestazione degli apprendisti non è omologabile a quella di un lavoratore
già pienamente formato: la nuova disciplina tale trattamento retributivo ridotto potrebbe mantenersi
uniformemente stabile nel corso del rapporto d'apprendistato (non essendo più previste tappe
progressive di incremento).
In materia di orario di lavoro, è oggi ammesso che il datore di lavoro possa richiedere prestazioni di
lavoro straurdinario, anche notturno (fatto salvo il divieto di lavoro notturno – nella fascia compresa
tra le 22 e le 6 – per gli apprendisti minorenni).
Sono previsti inoltre consistenti incentivi normativi ed economici:
– << i lavoratori assunti con contratto di apprendimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti>>;
– sono previsti obblighi contributivi per il datore di lavoro decisamente meno costosi rispetto a quelli
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 42 di 105
–
derivanti da normale contratto di lavoro subordinato;
come incentivo alla stabilizzazione, è stabilito che i benefici contributivi di cui gode il datore di
lavoro durante l'apprendistato <<sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto
a tempo indeterminato>>.
Sotto il profilo del recesso da parte del datore di lavoro (al pari dei contratti a termine) è stabilito che
questi possa liberamente recedere al termine del periodo di apprendistato, mentre non potrà farlo nel
corso del rapporto in assenza di giusta causa o giustificato motivo.
Quanto alle sanzioni, l'art.276/2003 colpisce il mancato perseguimento delle finalità formative
stabilendo che <<in caso di inadempimento nell'erogazione della formazione, di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro>> quest'ultimo <<è tenuto a versare la differenza tra
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100%>>; tale maggiorazione <<esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione
prevista in caso di omessa contribuzione>>, ferma restando la facoltà del lavoratore di rivolgersi
all'autorità giudiziaria per ottenere la dichiarazione di sussistenza tra le parti di lavoro subordinato (a
tempo indeterminato, essendo il termine strettamente connesso alla funzione formativa del contratto).
Infine, anche in mancanza di indicazioni espresse, è da ritenersi che il lavoratore possa rivendicare il
giudizio la sussistenza inter partes di un normale rapporto di lavoro subordinato (anche in tal caso a
tempo indeterminato).
Per quanto orientamento consolidato giurisprudenziale vada nella direzione di escludere la possibilità
di instaurare un rapporto di apprendistato quando <<per la semplicità e l'elementarità delle mansioni
non v'è bisogno alcuno di tirocinio>>, il legislatore ha in parte indebolito tale orientamento
cancellando il precedente divieto di <<adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni
in serie>>.
IL CONTRATTO D'INSERIMENTO
Il contratto d'inserimento (che può essere stipulato anche da enti pubblici economici ed enti di
ricerca pubblici o privati) è un contratto con finalità formative, per quanto tali finalità rivestano un
ruolo secondario rispetto all'obiettivo di <<realizzare [..] l'inserimento ovvero il reinserimento nel
mercato del lavoro>> di soggetti ritenuti in condizioni di particolare difficoltà nel reperimento di
un'occupazione.
Tale obiettivo è perseguito tramite il perseguimento di un <<progetto individuale d'inserimento,
finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al
contesto lavorativo>> (e tale progetto è qualificabile al tempo stesso come <<condizione per
l'assunzione con contratto d'inserimento>>): è palesato quindi l'obbiettivo di tale istituto, cioè di
permettere al lavoratore l'<<adattamento [..] a un determinato contesto lavorativo>>. Tale progetto
deve essere definito, con il consenso del lavoratore, entro le disposizioni stabilite dai contratti
collettivi.
Il legislatore ha elencato quali siano quei soggetti “deboli” che possono usufruire di tale istituto:
– quelli di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
– disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 ed i 32 anni;
– disoccupati ultracinquantenni;
– lavoratori che aspirino a rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno un biennio di inattività;
– donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche caratterizzate da particolari difficoltà per il
lavoro femminile (con tasso di occupazione femminile inferiore al 20% di quello maschile, o il cui
tasso di disoccupazione femminile sia superiore del 10% rispetto a quello maschile);
– persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il contratto di inserimento va stipulato in forma scritta ad substantiam con specifica indicazione del
progetto individuale d'inserimento (in mancanza del quale il lavoratore <<si intende assunto a tempo
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 43 di 105
indeterminato>>).
In generale, il contratto d'inserimento va considerato un contratto a termine (per cui si applicano per
quanto compatibili le relative norme) di durata minima (nove mesi) e massima (18 mesi) stabilita dal
legislatore, che può essere raddoppiata nel caso che il contratto sia stipulato con soggetti
handicappati: è consentita, esclusivamente nel caso che il perseguimento del progetto lo richieda,
una proroga (a patto che la durata complessiva non vada oltre il limite dei 18 mesi – 36 per gli
handicappati). Il contratto <<non è rinnovabile tra le stesse parti>>, è previsto invece che lo stesso
soggetto possa stipulare successivi contratti d'inserimento con diversi datori di lavoro.
Per quanto riguarda gli incentivi alla stipulazione del contratto d'inserimento:
– è previsto un salario d'ingresso conseguente allo stesso meccanismo di sotto-inquadramento
valido in tema di apprendistato;
– i lavoratori assunti sotto contratto d'inserimento <<sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti>>;
– le agevolazioni contributive (salvo ai contratti stipulati con i soggetti tra 18 e 29 anni) sono quelle
previste dalla <<disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro>>.
In caso di <<gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale d'inserimento di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro>>, lo stesso è colpito dalla stessa misura
sanzionatoria prevista in materia di apprendistato.
IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Il contratto di formazione e lavoro è diventato con la riforma del 2003, una tipologia negoziale di
carattere residuale, applicabile <<esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione>>,
che può essere stipulato solo lavoratori di età prevista tra i 16 ed i 32 anni, e presuppone la
predisposizione di un progetto nel quale devono essere indicati tempi e modalità di svolgimento
dell'attività di formazione e lavoro.
Sono previste due tipologie di CFL:
– il CFL di tipo A (della durata massima di 24 mesi) mira all'acquisizione di professionalità
intermedie od elevate e prevede un monte-ore (da 80 a 130) di formazione retribuita da effettuarsi
in luogo della prestazione lavorativa;
– il CFL di tipo B (della durata massima di 12 mesi) è caratterizzato da più generiche finalità di
inserimento professionale attraverso un'esperienza lavorativa, e con ridotti momenti formativi.
A tale contratto si applicano in linea di massima le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di
lavoro subordinato salvo il divieto di rinnovo del contratto tra le parti; va stipulato in forma scritta, la
cui mancanza però (così come la violazione delle regole relative agli obblighi formativi) non può
comportare il riconoscimento della sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato (ma al più il risarcimento del danno).
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
I tirocini formativi e di orientamento (gli stage) sono destinati a soggetti che hanno già assolto
l'obbligo scolastico; possono essere promossi da soggetti pubblici (od a partecipazione pubblica) e
da soggetti privati senza scopo di lucro; devono svolgersi sulla base di apposite convenzioni stipulate
fra i soggetti promotori ed i datori di lavoro pubblici o privati.
La durata degli stage (in ogni caso non superiore ai 12 mesi – 24 nel caso che il tirocinante sia
soggetto portatore d'handicap) va modulata in funzione della specificità dei soggetti coinvolti.
Tale istituto, il cui scopo è quello di “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, non
presuppone l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato: l'effettuazione del tirocinio non
dovrebbe comportare la prestazione di attività lavorativa utile a fini produttivi e, qualora le modalità di
svolgimento di tale tirocinio fossero quelle proprie di un rapporto di lavoro subordinato, la sussistenza
di quest'ultimo e l'applicazione della relativa disciplina potrebbero essere rivendicate in sede
giudiziarie.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 44 di 105
LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
La somministrazione di lavoro (prima rigorosamente vietata in quanto attività d'interposizione nelle
prestazioni di lavoro) è definita (con il d.lgs 276/2003) come attività di <<fornitura professionale di
manodopera, a tempo indeterminato o a termine>> (di cui non possono usufruire le P.A. salvo nel
caso si tratti di somministrazione di lavoro a termine).
La caratteristica fondamentale del lavoro somministrato rispetto al tradizionale rapporto di lavoro
subordinato è la dissociazione tra il somministratore (il soggetto che assume il lavoratori allo scopo di
metterne le prestazioni a disposizioni di terzi) e l'utilizzatore, senza che si instauri con i lavoratori
coinvolti alcuna relazione negoziale “triangolare”: rimangono separati infatti il contratto di lavoro
subordinato stipulato tra il lavoratore somministrato ed il somministratore ed il contratto di
somministrazione di lavoro stipulato fra somministratore ed utilizzatore.
L'attività di somministrazione è riservata a soggetti che abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione
(ai sensi del d.lgs 276/2003) necessaria ad operare come agenzia per il lavoro; è inoltre richiesto il
rispetto di regole più restrittive rispetto alle altre ipotesi di agenzia per il lavoro:
– il loro capitale versato dev'essere non inferiore a 600.000€;
– l'agenzia deve disporre, <<a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, [..] per i primi due anni, di un deposito cauzionale di
350.000€>> sostituito, a partire dal terzo anno di attività, da fideiussione bancaria o assicurativa
non inferiore al 5% del fatturato (al netto dell'iva) realizzato nell'anno precedente (e comunque
non inferiore a 350.000€).
Il contratto di somministrazione di lavoro fra agenzia somministratrice e soggetto utilizzatore richiede
la forma scritta: il contratto deve menzionare lo stabilirsi di una responsabilità solidale fra le parti in
relazione al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, ed al versamento dei relativi contributi
previdenziali. L'istituto prevede che l'obbligo del pagamento (retrobuzione e contributi) dei lavoratori
cada sul somministratore, il quale ha diritto di ottenere il rimborso di tali oneri (oltre che il corrispettivo
per la fornitura di personale) dall'utilizzatore, che dovrà sostenerli in prima persona in caso di
inadempimento da parte del somministratore (fatto salvo diritto di rivalsa nei confronti di
quest'ultima).
I poteri direttivo e di controllo sull'attività lavorativa sono attribuiti all'utilizzatore della stessa,
viceversa il potere disciplinare è prerogativa del datore di lavoro formale (il somministratore), e sarà
esercitabile dall'utilizzatore solo indirettamente.
Per somminsistrazione di lavoro a tempo determinato e staff leasing sono previsti i medesimi divieti
(ripresi da quelli stabiliti, rispettivamente, in relazione al lavoro intermittente ed alle assunzioni a
termine): in particolare va sottolineato il divieto di ricorrere a somministrazione di lavoro per sostituire
lavoratori in sciopero; inoltre sussiste l'obbligo d'informazione – gravante sull'utilizzatore – riguardo
all'eventuale pericolosità delle mansioni richieste.
Riguardo all'apparato sanzionatorio, quando la somministrazione si svolga prescindendo dal rispetto
delle regole stabilite i rapporti vengono imputati all'utilizzatore effettivo. Somministrazione irregolare
(per cui il contratto di somministrazione <<è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze dell'utilizzatore>>, si può ritenere a tempo indeterminato) si ha qualora:
– non siano rispettati gli obblighi formali (come la forma scritta);
– non siano rispettate le regole sostanziali (come assenza di una delle ragioni che legittimano il
ricorso allo staff leasing; conclusione del contratto con agenzia non autorizzata, violazione dei
divieti previsti).
Sanzioni di carattere penale sono previste in alcuni particolari casi:
– esercizio non autorizzato di attività di somministrazione;
– utilizzo di servizi da agenzia non autorizzata;
– somministrazione fraudolenta (<<quando [..] posta in essere con la specifica finalità di eludere
norme inderogabili di legge o contratto collettivo applicato al lavoratore>>);
– violazione del divieto di percepire compensi (direttamente od indirettamente) da parte di
lavoratori.
Quest'ultima ipotesi, oltre a sanzioni pecuniarie prevede la cancellazione dall'albo.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 45 di 105
La somministrazione a tempo determinato è ammessa <<a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore>> (ragioni
che, una volta accertate in sede giudiziale, non potranno comunque essere sindacate nel merito);
rispetto alla normale assunzione a termine tale istituto risulta più elastico: il termine inizialmente
apposto al contratto di lavoro <<può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e
per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal
somministratore>>.
Ai lavoratori somministrati, infine, è riconosciuta parità di trattamento (economico e normativo)
rispetto agli altri dipendenti dell'utilizzatore (ivi compreso <<il diritto a fruire di tutti i servizi sociali e
assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore>>); riguardo ai rischi per salute e sicurezza,
l'obbligo di informare il lavoratori e fornire loro la formazione necessaria all'uso delle attrezzature di
lavoro grava sul somministratore (salvo il contratto di somministrazione disponga che tale obbligo
ricada sull'utilizzatore).
È stabilito che i lavoratori somministrati non siano computabili nell'organico dell'utilizzatore; infine,
dalla logica del contratto, l'utilizzatore non risentirà di delle conseguenze dell'eventuale malattia del
lavoratore somministrato, potendo richiederne l'immediata sostituzione all'agenzia fornitrice.
Nel nostro ordinamento è legittimata anche la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
(staff leasing – utile ad esempio nei processi di esternalizzazione da parte delle imprese di attività
secondarie), alla quale si può ricorrere solo a fronte di determinate ipotesi previste dal legislatore:
oltre a quelle stabilite dai contratti collettivi (nazionali o territoriali) l'elenco riguarda una serie di
determinati settori (tra cui, ad esempio, la gestione di call-center).
Quanto al contratto di lavoro subordinato fra agenzia e lavoratore somministrato, nel caso si abbia
staff leasing <<i rapporti di lavoro [..] sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro>>: è
un contratto a tempo indeterminato, per quanto dotato di specifiche caratteristiche (come l'indennità
mensile di disponibilità – non inferiore a 350€ mensili – dovuta dall'agenzia al lavoratore per i periodi
in cui questi non siano inviato presso un utilizzatore, ma debba comunque restare a disposizione).
Nel caso di <<fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato>>, infatti, quale
che sia il numero dei lavoratori coinvolti, non si applicano le regole in materia di licenziamenti
collettivi: la cessazione del contratto di somministrazione potrebbe essere quindi agevolmente fatta
valere come giustificato motivo obbiettivo di licenziamento; d'altra parte la circ. 7/2005 afferma che il
giustificato motivo di licenziamento <<non può coincidere con il venir meno del contratto di
somministrazione>> salvo che <<risulti l'impossibilità di avviare ad altra missione il lavoratore, tenuto
conto anche dell'infruttuoso decorso di un congruo periodo di disponibilità>>.
Infine, per quanto riguarda i distinti rapporti che vengono ad instaurarsi nella somministrazione a
tempo determinato, la Cassazione (seppur con riferimento ad una normativa ad oggi abrogata) ha
affermato che per quanto riguarda le regole per la gestione del lavoratore somministrato, il contratto
base è quello stipulato tra l'impresa somministratrice ed il lavoratore, e questo deve ritenersi unico
parametro temporale, risultando del tutto irrilevante l'eventuale diversa indicazione contenuta nel
contratto di somministrazione: lo scopo dell'istituto, infatti, è quello di permettere all'impresa
utilizzatrice di fronteggiare esigenze temporanee di forza lavoro, lasciando la gestione normativa del
rapporto all'impresa somministratrice; l'istituto che è pur articolato in due rapporti formalmente
separati postula un collegamento negoziale tra gli stessi. Il lavoratore, oggetto del contratto di
somministrazione non ha alcun obbligo di conoscenza di tale contratto, e trova quadro di riferimento
del suo rapporto di lavoro esclusivamente nel contratto stipulato con l'impresa somministratrice.
IL LAVORO A DOMICILIO
Il lavoro a domicilio (regolato dalla l. 877/2003) è un contratto di lavoro per il quale la prestazione
lavorativa si svolge presso il domicilio dell'interessato (od in locali di cui egli abbia la disponibilità,
salvo che tali locali siano di pertinenza dell'imprenditore – anche se per l'uso di questi è corrisposto al
datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura): esso realizza una forma di decentramento
produttivo caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo come
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 46 di 105
energie lavorative utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno
dell'azienda.
Il vincolo di subordinazione, in tal caso, è qualificato dall'elemento di inserimento dell'attività
lavorativa nel ciclo produttivo dell'azienda: è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe
ovvero complementari a quelle eseguite all'interno dell'impresa, sotto le direttive dell'imprenditore.
La soggezione al potere direttivo del datore di lavoro si configura anch'essa come determinante ai fini
qualificatori: <<la subordinazione [..] ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le
direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da
svolgere nell'esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nell'esecuzione
parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore
committente>>; tale potere direttivo, come ribadito più volte dalla giurisprudenza, potrà configurarsi
anche sotto forma di istruzioni tecniche impartite al momento dell'affidamento della commessa e
controllo finale sulla rispondenza del lavoro finito alle disposizioni impartite.
Lavoro autonomo a domicilio è riconoscibile qualora (presso il soggetto cui l'imprenditore
commette una determinata opera) sia presente una distinta organizzazione, a proprio rischio, dei
mezzi produttivi ed una struttura imprenditoriale; qualora il lavoratore non sia dotato di una propria
struttura organizzativa è configurabile un rapporto di lavoro autonomo solo quando la scelta delle
modalità esecutive sia rimessa completamente al lavoratore (con esclusione dunque di qualsiasi tipo
di subordinazione – anche solo tecnica).
Talvolta la giurisprudenza ha escluso l'esistenza del vincolo di subordinazione in base alla facoltà del
lavoratore di accettare o rifiutare il lavoro: d'altra parte, a tal proposito le opinioni dei giudici
divergono.
Onde contrastare prassi elusive della normativa di tutela (che cercano di far configurare il rapporto di
lavoro come autonomo), è stabilito che non fuoriesce dall'area della subordinazione la prestazione
lavorativa a domicilio di chi si limiti ad avvalersi dell'aiuto accessorio di membri della sua famiglia e a
carico>> ed utilizzi per eseguirla <<materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso
imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi>>.
Una serie di divieti sono imposti onde evitare che il ricorso al lavoro a domicilio avvenga al di fuori di
plausibili ragioni tecnico-amministrative:
– vi è divieto di accogliere la domanda d'iscrizione nel registro dei committenti lavoro a domicilio
presentata da imprenditori che intendano ricorrere a lavoro a domicilio <<a seguito di cessione –
a qualsiasi titolo – di macchinari e attrezzature trasferite fuori dall'azienda>> e che vogliano <<in
tal modo proseguire lavorazioni>> precedentemente svolte all'interno della propria organizzazione
produttiva;
– vi è divieto, nei confronti delle imprese interessate da programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione e conversione, che abbiano comportato licenziamenti o sospensione dal lavoro,
di <<affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento
di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni>>.
Per quanto riguarda la disciplina del rapporto, è stabilito che i lavoratori a domicilio vadano
<<retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria>>
Le particolari modalità di esecuzione della prestazione possono comportare rischi aggiuntivi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti: è stata dunque vietata l'esecuzione di lavoro a domicilio
<<per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari>> (ed il mancato rispetto di tale divieto comporta
sanzioni penali per il datore di lavoro).
Inoltre la legge prevede espressamente che il lavoratore a domicilio possa svolgere la propria attività
<<per conto di uno o più imprenditori>>, e non può eseguire lavoro in concorrenza con l'imprenditore
solo <<quando questi gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 47 di 105
corrispodente all'orario normale di lavoro>> (nel qual caso i lavoratori a domicilio vanno computati
per determinare la consistenza dell'organico aziendale).
IL TELELAVORO
Telelavoratore è qualunque soggetto che utilizzi nello svolgimento della propria attività lavorativa uno
strumento di carattere telematico:
– nel telelavoro on-line (nel quale il lavoratore riceve direttive e controlli in tempo reale) si
configurerà un rapporto subordinato a tutti gli effetti.
– il telelavoro one way line (nel quale il lavoratore potrà ricevere solo direttive preventive e
controlli successivi) si potrà ricondurre al lavoro a domicilio (una volta superate le opinioni
giurisprudenziali per le quali si potrebbe avere lavoro a domicilio solo riguardo ad attività
manifatturiere di non elevata professionalità).
Per quanto riguarda la disciplina del telelavoro nel pubblico impiego (lasciata invece del tutto alla
contrattazione collettiva per quanto riguarda il settore privati), è stato genericamente stabilito che i
dipendenti delle P.A. possono chiedere di <<effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in
luogo di verso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verigica
dell'adempimento della prestazione lavorativa>> (salvo diritto di ripensamento).
I lavori socialmente utili rappresentano un rilevante esempio di attività lavorativa che non comporta
l'insorgenza di un rapporto di lavoro (con la conseguente inapplicabilità della relativa disciplina):
coloro che sono impiegati il lavoro socialmente utili senza essere titolari di alcun trattamento
previdenziale hanno diritto a percepire (non una retribuzione ma) un assegno di 489.33€ mensili per
un orario settimanale di 20 ore, erogato dall'INPS.
La disciplina del lavoro accessorio (introdotta dal d.lgs. 276/2003) vuole regolare determinate
attività lavorative (di <<natura meramente occasionale>> – in quanto non comportanti
complessivamente <<con riferimento al medesimo committente [..] compensi superiori a 5000€ nel
corso di un anno solare), tradizionalmente relegate nell'area dell'economia informale: può essere
svolto da determinati soggetti a rischio di esclusione sociale (disoccupati da oltre un anno;
casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori
extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro)
che abbiano preventivamente comunicato la loro disponibilità al riguardo nei centri per l'impiego. Tale
lavoro riguarda attività lavorative marginali elencate tassativamente (tra cui <<assistenza domiciliare
ai bambini e alle persone anziane>> e <<l'insegnamento privato>>).
PARITA' E NON DISCRIMINAZIONE
La Costituzione individua (nell'art 37) donne e minori come soggetti deboli meritevoli di tutela (sia in
senso protettivo che in senso di garanzie paritarie): con la l.903/1977 vengono separate le discipline
su donne e minori, e la tradizionale legislazione in senso protettivo nei riguardi delle prime viene
riscritta nel segno dell'uguaglianza di trattamento, con forte enfasi della tutela antidescriminatoria. La
l.125/1991, infine, pone l'obiettivo della promozione di pari opportunità, da raggiungere anche tramite
azioni positive.
D'altra parte la legislazione in tema di lavoro dei minori è restata di ispirazione protettiva, lasciando il
compito di sviluppare le direttive paritarie presenti nella costituzione a giurisprudenza e
contrattazione collettiva.
LA LOGICA PROTETTIVA NELLA DICIPLINA DEL LAVORO FEMMINILE
Nella disciplina costituzionale del lavoro femminile (art. 37 Cost.) è riconoscibile un doppio motivo
ispiratore: alla prospettiva paritaria (per cui <<la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore>>) si accompagna la più tradizionale logica
protettiva (atta a <<consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione>>).
Nella logica protettiva si deve ricordare la disposizione dettata dalla l.7/1963 con la quale si stabilisce
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 48 di 105
la nullità delle clausole di nubilato (<<clausole di qualsiasi genere [..] che prevedano comunque la
risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio>>) e dei
licenziamenti intimati per causa di matrimonio (così come è presunto il licenziamento nel periodo
intercorrente dalla pubblicazione ad un anno dopo la celebrazione, presunzione ammissibile di prova
contraria da parte del datore di lavoro); nulle sono infine le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel
periodo indicato, salvo che non provveda a confermarle entro un mese presso la direzione
provinciale del lavoro.
Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, (ripreso dalla l.1204/1971) contenuto nel “T.U. in
materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” (d.lgs 151/2001), opera <<in connessione
con lo stato oggettivo di gravidanza>> (a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia o meno a
conoscenza della particolare condizione della lavoratrice) ed è esteso dall'inizio del periodo di
gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il divieto conosce quattro eccezioni:
– nel caso di colpa grave della lavoratrice;
– nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda (che ricomprende – secondo l'orientamento
prevalente della Cassazione – <<anche l'ipotesi della soppressione di un singolo ramo o reparto
organizzato avente autonomia funzionale, senza quindi che ricorra l'esaurimento totale dell'attività
dell'impresa>>, ma non ipotesi analoghe non espressamente previste – quali modifiche
dell'assetto organizzativo – essendo la norma <<non anaogamente estensibile a casi in essa non
considerati>>) solo nel caso di impossibilità di utilizzazione della lavoratrice in altri rami o settori
dell'azienda (con onere della prova gravante sul datore di lavoro);
– nel caso di scadenza dell'eventuale termine apposto al contratto;
– nel caso di esito negativo della prova (a patto che tale esito non sia stato determinato dalla
condizione di donna incinta dell'interessata).
La Corte Costituzionale ha affermato (come ha poi ribadito il d.lgs 151/2001) che il licenziamento che
violi tali divieti è affetto da nullità (e non temporaneamente inefficace – come precedentemente
sostenuto dalla Cassazione), in quanto il mero differimento dell'efficacia del licenziamento
rappresenterebbe una misura di tutela insufficiente rispetto alle direttive costituzionali: per legittimare
il licenziamento scaduti i termini del divieto, il motivo inizialmente addotto deve ancora sussistere.
Resta aperto il problema del regime sanzionatorio applicabile al licenziamento nullo: se il regime di
nullità di diritto comune per contrarietà a norma imperativa, o quello di cui all'art. 18 dello Statuto con
riguardo al licenziamento discriminatorio (opinione minoritaria ma più conforme alle pronunce della
Corte di Giustizia, secondo cui il licenziamento di una lavoratrice a motivo della sua gravidanza
rappresenta una discriminazione diretta fondata sul sesso).
In generale, l'ordinamento riconosce (già nella l.1204/1971) una serie di tutele alle lavoratrici madri:
– il divieto di adibizione a lavori pesanti <<durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età
del figlio>> (e conseguente obbligo ai datori di lavoro di attribuire tali lavoratrici a mansioni
compatibili con lo stato delle interessate);
– il divieto di adibizione a qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di astensione obbligatoria
(immediatamente precedente e successivo al parto – in particolare nei 2 mesi precedenti e nei 3
successivi, o nel mese precedente ed i 4 successivi).
Tali tutele sono di applicazione generalizzata alle lavoratrici – sia del settore privato che pubblico –
ed estese alle socie-lavoratrici di cooperative di lavoro, seppur con qualche eccezione (come per le
lavoratrici lavoratrici a domicilio, non interessate dal divieto di adibizione a lavori pesanti; e le
lavoratrici domestiche, non protette nei confronti del licenziamento).
Con il d.lgs 151/2001, sono state introdotte una serie di altre tutele tra cui:
– è stato previsto l'istituto del permesso retribuito per esami prenatali (utilizzabile anche per
accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, da effettuarsi necessariamente durante l'orario
di lavoro);
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 49 di 105
–
sono stati dettati particolari obblighi di protezione delle lavoratrici madri dal rischio di esposizione
a determinati agenti fisici, chimici o biologici.
Accanto a tali norme protettive, nel nostro ordinamento hanno continuato a sussistere a lungo norme
specificamente legate al lavoro femminile che, più che assicurare quella tutela protettiva
costituzionalmente garantita, hanno illegittimamente operato come barriere all'ingresso delle donne
nel mercato del lavoro.
IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELLA LEGGE DI PARITA'
La parità dei diritti fra i lavoratori dei due sessi (affermato nell'art. 37 Cost), fondamentale motivo
ispiratore della disciplina costituzionale del lavoro femminile, si è esplicata fortemente con la legge di
parità (l.903/1977), in recepimento delle direttive comunitarie in tema di parità.
Nucleo centrale della disciplina è il principio di non discriminazione tra lavoratori e lavoratrici
(accanto al quale è riconoscibile un intento promozionale del lavoro femminile).
Infine la legge di parità ha ampliato il divieto di atti e patti discriminatori contenuto nell'art. 15 dello
Statuto dei Lavoratori, che individua una serie di motivi (sindacali, politici, religiosi) in relazione ai
quali è vietata qualsiasi differenza di trattamento.
Sono stati poi introdotti (negli ultimi anni, in adeguamento alle direttive comunitarie in materia di
<<attuazione del principio di pari trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica>> ed di un <<quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e condizioni di lavoro>>) nuovi motivi discriminatori riguardanti razza, lingua e sesso
(quest'ultimo applicabile anche alle <<iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i
contenuti>>) per i quali è prevista una parziale inversione dell'onere della prova:
Per quanto riguarda i casi di discriminazione per motivi di nazionalità, questi erano già
espressamente vietati dall'ordinamento con il d.lgs 286/1998 (T.U. in materia di immigrazione), che
definisce discriminatoria la condotta posta in essere da <<chiunque illegittimamente imponga
condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione [..] allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero [..] o
nazionalità>>: deve infatti ritenersi implicitamente abrogata (come affermato dalla Corte d'Appello) la
disposizione contenuta nel d.lgs. 487/1994 che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana o di
altri Stati membri dell'Unione Europea per l'accesso ai pubblici concorsi – ed allo stesso modo deve
ritenersi che tale disposizione sia stata riprodotta nel d.lgs. 165/2001 solo per difetto di
coordinamento: è salvaguardata quindi la possibilità per gli extracomunitari (qualora muniti di
permesso di soggiorno) di accedere alla P.A. , esclusa ogni discriminazione che possa
compromettere il diritto di accesso all'occupazione (che si riflette nel diritto alle pari opportunità in
tema di occupazione), che può essere annoverato tra i diritti umani fondamentali.
DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO AL LAVORO
Discriminazioni di sesso sono bandite in relazione all'accesso al lavoro, indipendentemente dalle
modalità di assunzione, nell'ambito dell'intero mercato del lavoro ed a tutte le professionalità ivi
operanti, (anche quando la discriminazione sia attuata con riferimento allo stato matrimoniale o di
famiglia o di gravidanza) – anche in modo indiretto tramite meccanismi di preselezione che indichino
<<come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso>>.
In linea con la normativa comunitaria, è prevista l'eccezione ai sensi della quale non costituisce
discriminazione l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo all'appartenenza all'uno
o all'altro sesso, <<quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione>>.
La giurisprudenza ritiene che, per quanto la l.903/1977 non imponga obblighi puntuali riguardo
all'assunzione di donne, la procedura di assunzione deve garantire alle aspiranti lavoratrici pari
chances iniziali rispetto ai lavoratori di sesso maschile: la Cassazione ha ritenuto, ad esempio,
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 50 di 105
illegittimo il rifiuto di assunzione di una lavoratrice in stato di gravidanza per l'esecuzione di lavori
pericolosi, malgrado l'adibizione a tali lavori sia vietata durante tale periodo: l'accesso al lavoro è
garantito, in forza dell'assoluta libertà di accesso al lavoro delle donne in stato di gravidanza (infatti la
donna sarebbe pregiudicata rispetto all'uomo se si dovesse valutare a suo carico la gravidanza, con
perdita della possibilità di accesso al lavoro). Per le stesse ragioni, la Cassazione ha affermato che
non sussiste alcun obbligo in capo alla lavoratrice di comunicare il proprio stato di gravidanza al
momento dell'assunzione (anche qualora si tratti di assunzione a tempo determinato).
Stesso principio è stato espresso dalla Corte di Giustizia, che ha sottolineato che un rifiuto di
assunzione per motivo di gravidanza potrebbe essere opposto solo alle donne e rappresenta quindi
una discriminazione diretta basata sul sesso.
LA NORMATIVA ANTIDISCRIMINATORIA
È ribadita nella l.903/1977 inoltre la garanzia costituzionale della parità di trattamento retributivo fra
lavoratori e lavoratrici quando le prestazioni richieste sia uguali o di pare valore (in relazione alle
mansioni assegnate a prescindere dal rendimento individuale).
Inoltre, è stabilito che <<i sistemi di classificazione professionale [..] debbono adottare criteri comuni
per uomini e donne>>: dal che si può presumere l'illegittimità sia di classificazioni separate per
sesso, sia di distinzioni a fini retributivi fra lavori considerati tipicamente maschili e lavori ritenuti
tipicamente femminili.
La l.903/1977 nomina espressamente alcune tra le discriminazioni più frequenti, cioè quelle relative
all'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e alla progressione nella carriera: in generale è però
da ritenersi che la norma vada applicata a tutti gli istituti del rapporto di lavoro.
Si è cercato di porre rimedio ad altra forma di discriminazione con riguardo alla progressione in
carriera è stata, tramite la disposizione per cui i periodi di astensione obbligatoria per maternità
devono essere <<considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa>>
(anche quando la contrattazione collettiva abbia subordinato l'avanzamento di carriera alla
permanenza effettiva nel tempo del rapporto di lavoro.
Sostegno all'offerta di lavoro femminile è perseguito mediante la fiscalizzazione degli oneri
contributivi connessi al godimento dei c.d. riposi per allattamento (in precedenza a carico dei datori
di lavoro).
Nella vigente normativa permangono alcune differenze di trattamento tra lavoratori e lavoratrici:
– è confermata la diversa età pensionabile delle donne (60 anni) rispetto a quella prevista per gli
uomini (65 anni) – fatta salva l'eccezione per cui le lavoratrici possono continuare a <<prestare la
loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini>> (godendo, in tal caso, delle
medesime protezioni previste dall'ordinamento nei confronti dei licenziamenti ingiustificati);
– è stata riconosciuta alla contrattazione collettiva la facoltà di individuare mansioni di lavoro
particolarmente pesanti, in relazione alle quali derogare al principio di parità in materia di accesso
all'impiego;
– è rimasta invariato il divieto di <<adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino>>.
Superata la logica della protezione differenziale, la normativa vigente contiene regole sessualmente
neutre, stabilendo che non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di
età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il
lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la
lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
LA DISCRIMINAZIONE DIRETTA
La l.903 ha permesso di colpire solo le manifestazioni più evidenti della discriminazione, fondate
direttamente sulla considerazione del sesso dell'interessato, ma non le prassi discriminatorie più
sofisticate. La l.125/1991 è stata varata con l'obbiettivo di ampliare il raggio d'azione della tutela
antidiscriminatoria, mediante strumenti e tecniche normative in grado di cogliere le ragioni sostanziali
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 51 di 105
della discriminazione di sesso, definendo innanzitutto cosa si debba intendere per discriminazione:
discriminazione diretta è <<qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto
pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il
trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in
situazione analoga>>.
La fonte della discriminazione può risultare sia da prassi unilaterali che da clausole contrattuali, che
anche da un mero comportamento; il divieto di discriminazione riguarda anche trattamenti che
derivino dall'applicazione di regole di un contratto collettivo e persino da norme di legge (l'illecito
infatti deriva dalla produzione oggettiva di un effetto pregiudizievole, indipendentemente dall'intento
dell'autore); inoltre la norma esplicita il proprio carattere bidirezionale, riguardando anche quelle c.d.
discriminazioni alla rovescia nei confronti dei lavoratori di sesso maschile.
Nella nozione di discriminazione è implicito un elemento di comparazione (con riferimento al
<<trattamento meno favorevole rispetto a quello di [..] altro lavoratore o [..] lavoratrice in situazione
analoga>>), salvo – ovviamente – per quanto riguarda discriminazioni derivanti dallo stato di
gravidanza di una lavoratrice.
Dall'interpretazione della norma alla luce del diritto comunitario, si può sostenere che la normativa
antidiscriminatoria sia utilizzabile anche per colpire trattamenti penalizzanti legati all'identità
sessuale; per quanto riguarda quelli motivati dall'orientamento sessuale, è stato lo stesso intervento
del legislatore a renderne esplicito il divieto (in adeguamento alla diritto comunitario).
LE MOLESTIE
I d.lgs. 215 e 216 dell 2003 hanno introdotto una nozione generale di molestia intesa come
<<comportamento indesiderato>> posto in essere per una serie di motivi (razza, origine etnica,
religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale) ed <<avente lo scopo o
l'effetto di violare la dignità della persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo>>: tale comportamento è considerato (a tutti gli effetti) una discriminazione e,
come tale, comporta per i lavoratori l'applicabilità delle tutele previste contro ogni forma di
discriminazione.
In passato, la giurisprudenza prevalente aveva ricondotto le molestie sessuali all'inadempimento
contrattuale del datore di lavoro riguardo agli obblighi di garanzia del rispetto della personalità morale
del lavoratore (ex art. 2087 c.c.); allo stesso modo si era posto l'accento sugli obblighi di sicurezza
gravanti sul datore di lavoro, affermando che è obbligo del datore di lavoro predisporre tutte le
misure (anche di natura disciplinare ed organizzativa) necessarie a garantire la tutela dei dipendenti
in caso di molestie.
Il d.lgs 145/2005 ha esteso la tutela antidiscriminatoria alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, che
sono ora espressamente riconosciute dall'orientamento come forma di discriminazione (per quanto
non siano discriminazioni in senso tecnico – non riguardano questioni di parità violata, ma di tutela
della libertà e dignità della persona offesa): sono <<considerate come discriminazioni le molestie
sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica,
verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo>>.
La giurisprudenza, infine, ha affermato che le molestie sessuali configurano giusta causa di
dimissioni, ed in tal caso la lavoratrice dimissionaria avrà diritto all'indennità sostitutiva del preavviso
ed all'indennità risarcitoria prevista per il licenziamento ingiustificato del lavoratore, oltre al
risarcimento del danno morale e biologico (qualora risulti provato nel caso specifico)
IL MOBBING
Il mobbing è definito come comportamento, da parte di una o più persone, colleghi o superiori della
vittima, teso a respingere dal contesto lavorativo il soggetto “mobbizzato” (isolarlo <<dall'ambiente di
lavoro e, nei casi più gravi, [..] espellerlo>>) che a causa di tale comportamento (consistente in
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 52 di 105
metodiche e sistematiche violenze psicologiche, vessazioni, angherie e soprusi) subisce delle
conseguenze negative anche di ordine fisico: in giurisprudenza si è, infatti, tenuto presente che sono
stati oggettivamente provati i riflessi di tali situazioni sulla salute individuale – <<tali pratiche
intaccano gravemente l'equilibrio psichico del lavoratore, menomandone la capacità lavorativa e la
fiducia in se stesso e provocando la catastrofe emotiva, la depressione e talora persino il suicidio>>.
La giurisprudenza di merito ha precisato che il mobbing si compone di due elementi:
– un elemento oggettivo, consistente in ripetuti soprusi posti in essere da parte di colleghi o
superiori ed, in particolare, in pratiche (per quanto di per sé legittime) dirette a danneggiare il
lavoratore ed a determinarne l'isolamento all'interno del contesto lavorativo;
– un elemento psicologico, consistente – oltre che nel dolo generico (animus nocendi) – nel dolo
specifico di nuocere psicologicamente al lavoratore al fine di emarginarlo.
Nel caso di tale condotta vessatoria, qualora ne sia provata la sussistenza – nonché il nesso di
causalità tra la patologia insorta improvvisamente nel lavoratore e l'ambiente di lavoro – , dev'essere
richiamato a rispondere il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c. (in quanto tenuto a garantire
l'integrità fisio-psichica dei propri dipendenti – e quindi ad impedire e scoraggiare con efficacia
contegni aggressivi e vessatori da parte di preposti e responsabilità, nei confronti dei rispettivi
sottoposti).
In ogni caso il danno di natura psichica si pone (secondo la giurisprudenza) come danno autonomo
(e non in conseguenza di un danno fisico): può essere risarcibile, quindi, anche il danno psichico
puro (anche qualora non rientri nelle categorie proprie della nosografia psichiatrica).
Esso non si configura necessariamente come danno biologico (cioè quel danno compromettente la
capacità di relazione nella vita civile mediante la causazione di un pregiudizio fisico o psichico) ma
anche come danno esistenziale (corrispondente ad una lesione della dignità personale), da
liquidarsi in via equitativa per violazione dell'art. 2087 c.c. .
LA DISCRIMINAZIONE INDIRETTA
Sempre la l.125/1991 ha definito la c.d. discriminazioni indiretta, cioè quella fonte di trattamento
pregiudizievole, che si distingue da quella diretta perché determinata in ragione di caratteri di per sé
neutri (diversi da quelli la cui considerazione è espressamente vietata dall'ordinamento), ma
assimilabili a discriminazioni data la loro idoneità a produrre conseguenze particolarmente
svantaggiose, sanzionabili anche se l'effetto discriminatorio abbia carattere meramente potenziale.
Precisamente, si ha discriminazione indiretta quando <<una disposizione, un criterio, una prassi, un
atto, un patto o comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un
determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso>>.
Non si può, d'altra parte, sostenere la sussistenza di una discriminazione indiretta quando i criteri in
questione <<riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo
sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari>> – ed al tale
proposito è sempre riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di fornire giustificazione fondata su
ragioni obiettive, del tutto estranee al fattore la cui considerazione è interdetta dal divieto di
discriminazione.
La Corte Costituzionale ha, infine, stabilito che l'adozione di requisiti fisici per l'accesso identici per
uomini e donne sono causa di discriminazione indiretta a sfavore di persone di sesso femminile,
proporzionalmente svantaggiate rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica
statisticamente riscontrabile ed obiettivamente dipendete dal sesso.
GIUSTIFICAZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE
L'applicazione di criteri che producano effetti proporzionalmente più svantaggiosi per gli appartenenti
ad un determinato sesso può essere giustificata solo qualora tali criteri riguardino requisiti essenziali
per la natura del lavoro o della prestazione.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 53 di 105
Ad esempio la Corte di Giustizia ha giudicato legittima l'applicazione di trattamenti meno favorevoli ai
lavoratori part-time qualora giustificata dall'obiettivo di occupare il minimo possibile di lavoratori a
tempo ridotto, se tale scopo risponde ad un'esigenza effettiva dell'impresa (e non a sfavorire la
categoria dei part-time esclusivamente in ragione della prevalente composizione femminile).
La Corte di Giustizia ha escluso l'ammissibilità di giustificazioni del tutto generiche, ed ha valutato
che potrebbero avere carattere indirettamente discriminatorio per le lavoratrici:
– di criteri di differenziazione di trattamenti fondati su anzianità di servizio, se non in relazione a
specifiche mansioni per le quali sussista incontestabile nesso fra anzianità ed esperienza
professionale;
– criteri riguardanti la formazione professionale ed adattabilità a luoghi ed orari di lavoro;
Sicuramente poi sono giudicati discriminanti sistemi di classificazione basati su criteri che
enfatizzano (al di là di quanto strettamente necessario in relazione alla natura delle mansioni da
svolgersi nell'impresa) qualità tipiche di appartenenti ad un sesso.
Per quanto riguarda <<giustificazione basata su ragioni economiche>> la corte ha stabilito la loro
insufficienza, per quanto prima avesse ammesso che ragione idonea ad escludere discriminazione
indiretta potesse riguardare esigenze effettive dell'impresa od “esigenze di mercato”.
LA TUTELA PROCEDURALE ANTIDISCRIMINATORIA
Una tradizionale ragione di fragilità della disciplina antidiscriminatoria dipendeva dal fatto che la
possibilità di reagire per via giudiziaria alla discriminazione era perseguita tramite l'azione ordinaria
(così come previsto dalla l.903/1977), con la quale al più si sarebbe raggiunta la dichiarazione di
nullità dell'atto discriminatorio (privando dunque del beneficio discriminatorio il lavoratore
avvantaggiato, senza però recare alcuna utilità al lavoratore discriminato); con il d.lgs. 196/2000 (ora
contenuto nel d.lgs 198/2006) è stata dilatata la sfera operativa della procedura d'urgenza
precedentemente utilizzabile solo a fronte di violazioni di regole sul lavoro notturno e riguardo a
discriminazione in materia di accesso al lavoro: ora tale procedura riguarda <<tutti i casi di azione
individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse>> (e può essere promossa sia
dal diretto interessato che da organizzazione sindacale). Il giudice, qualora ritenga sussistenti le
lamentate violazioni, ordinerà <<all'autore del comportamento denunziato, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti>>.
Il d.lgs. 145/2005 (anch'esso assorbito nel d.lgs 198/2006), ha inoltre previsto che la possibilità di
ottenere, tramite azione ordinaria, anche <<il risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei
limiti della prova fornita>>.
Le tradizionali sanzioni di stampo civilistico e l'azione individuale non riescono a contrastare se non
marginalmente le prassi discriminatorie, tanto più se nell'ambito delle discriminazioni indirette: la
l.125/1991 ha cercato di fornire nuovi strumenti – tramite innovazioni processuali e sanzionatorie, per
colpire soprattutto quest'ultima fattispecie di stampo collettivo: è stato introdotto il principio
dell'inversione (parziale) dell'onere della prova nei giudizi in materia di discriminazione e la connessa
prova statistica (che può basarsi su dati relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione
di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti), che mira
ad accertare l'impatto differenziato sui lavoratori dei due sessi conseguente all'adozione di un criterio
apparentemente neutro.
Non è necessario inoltre cercare fornire prova piena della discriminazione subita, ma è sufficiente
limitarsi a produrre elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, purché <<idonei a
fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori in ragione del sesso>>, nel cui caso graverà sul convenuto <<l'onere della prova
sull'insussistenza della discriminazione>>. Tale parziale inversione dell'onere della prova è stato
esteso con la l.101/2008 a tutte le discriminazioni.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 54 di 105
Le azioni in reazione a discriminazioni indirette possono essere mosse (oltre che dalle organizzazioni
sindacali) dai consiglieri provinciali e regionali di pari opportunità (che possono agire in giudizio <<su
delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla
medesima>>); è anche prevista la possibilità di un'azione pubblica, (promossa dal consigliere
regionale o nazionale di parità) per l'accertamento di discriminazioni di carattere collettivo: il giudice
ordinerà al datore di lavoro di adottare un piano di rimozione delle discriminazioni accertate
(indicante <<criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione).
LE AZIONI POSITIVE
La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimi, in base al principio costituzionale di eguaglianza
sostanziale, quegli interventi positivi del legislatore diretti ad attenuare lo squilibrio a sfavore delle
donne: la Repubblica ha, infatti, il compito (ex art. 3 Cost. ) di <<rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittandini impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese>>. Le “azioni positive” comportano l'adozione di discipline
giuridiche differenziate a favore delle categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale
principio di formale parità di trattamento.
La l.125/1991, nel senso dell'uguaglianza sostanziale, dà particolare importanza alle <<misure,
denominate azioni positive per le donne>>, da adottare <<al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono la realizzazione di pari opportunità>>.
Le azioni positive (che non devono determinare discriminazioni alla rovescia) sono identificate dalla
normativa in base alla loro funzione (realizzare pari opportunità fra lavoratori e lavoratrici, appunto –
e nello specifico, <<promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei
livelli nei quali esse sono sotto-rappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati
ed ai livelli di responsabilità>>); d'altra parte sono state elencate alcune tipologie di azioni positive
onde disegnare un ampio spettro di misure finalizzate ad incidere sulle situazioni di svantaggio delle
donne nel mercato del lavoro.
La Corte di Giustizia si è dimostrata disponibile ad ammettere la compatibilità col diritto comunitario
solo di quei sistemi di quote flessibili, che non garantiscono alle donne una <<preferenza assoluta e
incondizionata>>: una normativa nazionale in tal senso andrebbe oltre la promozione delle pari
opportunità. D'altra parte la stessa Corte di Giustizia ha successivamente affermato che nei settori di
attività pubblici nei quali siano impiegate meno donne che uomini nei livelli professionali superiori, le
prime debbano avere la precedenza nella promozione in caso di pari qualificazioni – salvo non
prevalgano motivi inerenti alla persona di un candidato di sesso maschile.
Il d.lgs. 162/2000 ha cercato di potenziare il meccanismo di azioni positive previsto dalla l.125/1991:
è ora previsto che il Comitato Nazionale formuli annualmente un programma-obiettivo che indichi le
tipologie di azioni che intende promuovere (che tengano conto, fra l'altro, dell'obiettivo di favorire <<il
riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario
fra generi non inferiore a due terzi>>).
La l.125/1991 precisa che i progetti di azione positiva possono essere promossi da una pluralità di
soggetti pubblici (tra cui il Comitato Nazionale di Pari Opportunità) e privati (tra i quali spiccano datori
di lavoro e organizzazioni sindacali – per quanto legate alla libera iniziativa di tali soggetti): per
quanto riguarda progetti che possano scaturire da accordi tra datori di lavoro ed organizzazioni
sindacali, è previsto – quale incentivo – l'accesso al beneficio di rimborso (totale o parziale) degli
oneri finanziari connessi alla loro attuazione, purché presentati secondo le indicazioni del
programma-obiettivo predisposto da Comitato Nazionale.
IL LAVORO MINORILE
La disciplina del lavoro minorile segue mira ad affermare un principio di parità con riguardo al
trattamento retributivo (ex. art. 37 Cost che riconosce ai minori <<a parità di lavoro, il diritto alla parità
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 55 di 105
di trattamento>> – dove per parità di lavoro, la giurisprudenza si è orientata nel senso di intendere
parità di qualifica, e non di rendimento), e d'altra parte a tutelare il corretto sviluppo psico-fisico di tali
soggetti.
La l.977/1967 articola la tutela del lavoro dei minori attraverso disposizioni relative all'età minima di
accesso al lavoro (dove la distinzione tra bambini, a cui è vietata l'adibizione a lavoro, salvo
particolari eccezioni – in attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e dello spettacolo – ed
adolescenti si collega all'età minima di ammissione al lavoro dei minori, dal <<momento in cui il
minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria>> e comunque legato al limite di età, che la
l.296/2006 ha elevato a 16 anni) ed alla garanzia di particolari condizioni di svolgimento dell'attività
lavorativa (alla quale è funzionale l'obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi,
ed il condizionamento dell'accesso al lavoro per il minore previo superamento di una visita medica
d'idoneità di ripetersi nel corso dello svolgimento del rapporto).
Sono previsti diversi limiti in materia di orario di lavoro:
– divieto assoluto di adibizione di minori al lavoro notturno (dove con il termine “notte” si intende un
<<periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le
ore 23 e le ore 7>>);
– il limite di 35 ore settimanali e 7 giornaliere all'orario di lavoro dei bambini (quando sia ammessa
l'attività lavorativa); e di 8 ore giornaliere e 40 settimanali per gli adolescenti;
– il diritto del minore ad un riposo intermedio di almeno un'ora, qualora l'orario giornaliero superi le
4 ore e mezza;
– il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite non inferiore a 20 giorni (30 giorni per coloro che
non abbiano ancora compiuto 16 anni) ed un riposo settimanale di almeno due giorni,
possibilmente consecutivi, comprendenti la domenica.
LA TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA NEL LAVORO DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI
Il T.U. sull'Immigrazione (d.lgs 286/1998) riconosce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti nel nostro paese e alle loro famiglie una garanzia di <<parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani>> (è imposto in proposito infatti l'obbligo ai datori di
lavoro di offrire agli stranieri condizioni di lavoro conformi alle <<prescrizioni del contratto collettivo
applicabile>>). Con il T.U. la protezione riconosciuta agli immigranti extracomunitari ha giovato di
quelle tutele operanti nell'area delle discriminazioni sessuali: <<qualsiasi atto o comportamento che
produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della
loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa>> è
da qualificarsi come discriminazione diretta; <<ogni trattamento pregiudizievole conseguente
all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti
ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata
confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento
dell'attività lavorativa>> ricade nella fattispecie della discriminazione indiretta.
E' stata poi prevista un'azione civile contro la discriminazione esercitabile contro le discriminazioni in
materi di lavoro che comporta, in caso di accoglimento, che il giudice possa <<ordinare la cessazione
del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione>>, nonché condannare il convenuto al
risarcimento del danno, anche non patrimoniale. E' stata ammessa in tal caso inoltre la c.d. prova
statistica e, seppur lasciando alcuni dubbi interpretativi, anche la più generale parziale inversione
dell'onere della prova (con la l.101/2008)
Infine, è stata prevista un'azione collettiva esercitabile dalle rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali a seguito del quale il giudice può ordinare al datore di lavoro di definire un
piano di rimozione delle discriminazioni collettive (dirette ed indirette) accertate.
AMPLIAMETO DEL RAGGIO DI INCIDENZA DELLA TUTELA DISCRIMINATORIA
La tutela antidiscriminatoria (il cui ambito di applicazione include sia il settore privato sia il pubblico
impiego) è stata ampliata per colpire disparità di trattamento originate da un'ampia gamma di motivi:
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 56 di 105
per impulso comunitario la tutela in questione è oggi applicabile alle discriminazioni dovute alla razza
ed all'origine etnica, nonché a quelle fondate sulla religione, convinzioni personali, handicap, età e
tendenze sessuali – e risulta oggi ancora più amplia nel nostro ordinamento grazie alla più recente
legislazione in materia (ed in particolare con i d.lgs 215/2003 e d.lgs 216/2003)
In generale, si considera discriminazione quando (per uno dei motivi previsti dall'ordinamento) <<una
persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una
situazione analoga>>; discriminazione indiretta ricorre quando <<una disposizione, un criterio, una
prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere [..] in una
situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre>> determinate persone per i motivi discriminatori
stabiliti.
Sia le molestie (<<comportamenti indesiderati [..] aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una
persona e di creare un clima intimidatori, ostile, degradante, umiliante e offensivo>>) sia l'ordine di
discriminare (legati ad uno dei motivi descritti) legati ad uno qualsiasi dei motivi prescritti sono da
ricondursi a discriminazioni.
Rispetto alle discriminazioni dirette, le differenze di trattamento dovute ad uno dei motivi prescritti
non costituiscono discriminazione <<qualora, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in
cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e
determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima.>>; si è infatti precisato che;
– il divieto di discriminazioni razziali ed etniche non riguarda le differenze di trattamento basate
sulla nazionalità, lasciando dunque impregiudicate le regole relative all'ingresso, al soggiorno ed
all'accesso al lavoro degli immigrati extracomunitari;
– il divieto di discriminazioni in relazione all'età non può mettere in discussione disposizione che
prevedano trattamenti differenziati con riguardo ad adolescenti, giovani, lavoratori anziani,
lavoratori con persone a carico motivate << dalla particolare natura del rapporto>> e da
<<legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale>>;
– è consentita alle organizzazioni di tendenza la pratica di <<differenze di trattamento basate sulla
professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali>> qualora tali
convincimenti siano <<requisito essenziale, legittimo e giustificato>> ai fini dello svolgimento
dell'attività lavorativa nell'ambito di tali organizzazioni.
Anche rispetto a tali discriminazioni sembrerebbe operare, a seguito della l.101/2008, l'istituto della
parziale inversione dell'onere della prova.
LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro subordinato si configura come rapporto complesso nella quale la relazione di
scambio fra le due contrapposte obbligazioni fondamentali (inerenti a lavoro e retribuzione) risulta
accompagnata da ulteriori obblighi nonché dalla previsione di specifiche modalità di adempimento
(non riscontrabili con la stessa enfasi in alcun altro rapporto obbligatorio).
Il legislatore del '42 ha ritenuto non sufficienti le regole generali dettate riguardo alla correttezza (art.
1175 c.c.) ed alla buona fede (art. 1375 c.c.) dovute nell'esecuzione del contratto, ed ha specificato
che lo svolgimento del rapporto di lavoro deve avvenire secondo obbedienza e diligenza (art. 2104
c.c.) per il lavoratore, che è gravato ulteriormente dell'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c).
Obbedienza e diligenza si configurano come criteri normativi predeterminati di valutazione
dell'esattezza dell'adempimento.
LA DILIGENZA
La diligenza (che viene richiamata soprattutto riguardo alla categoria degli obblighi preparatori
all'adempimento – comportamenti al di fuori dell'orario di lavoro, funzionali all'adempimento della
prestazione lavorativa dovuti dalla diligenza) è quella <<richiesta dalla natura della prestazione
dovuta, dall’interesse dell’impresa [..]>> (mentre il riferimento all'<<interesse superiore della
produzione nazionale>> è da considerarsi implicitamente abrogato).
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 57 di 105
<<La diligenza richiesta [..] dall'interesse dell'impresa>> si presenta, così come può essere
recuperata alla luce dell'odierno assetto normativo, come attitudine a rendere una prestazione
positivamente inseribile nell'organizzazione produttiva predisposta dal datore di lavoro.
Il riferimento alla natura della prestazione dovuta va a ribadire il concetto espresso dall'art. 1176 in
tema di obbligazioni (<<nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata>>): è proprio
con riferimento alla qualifica professionale ed alla natura delle incombenze affidate al lavoratore
(sempre tenendo presente la situazione ambientale ed aziendale nella quale egli opera) che dovrà
essere valutata l'eventuale violazione dell'obbligo di diligenza.
La Cassazione ha, inoltre, affermato che tale obbligo riguarda anche tutti i comportamenti accessori
e le cautele necessarie ad assicurare una gestione professionalmente corretta: d'altra parte è
necessario ricordare che tale obbligazione lavorativa è sicuramente un'obbligazione di mezzi, ed
ancora che non potrà configurarsi violazione dell'obbligo di diligenza quando la prestazione oggetto
dell'obbligo accessorio faccia parte di altra e specifica mansione.
Come affermato dalla Cassazione, dalla violazione dell'obbligo di diligenza discende una
responsabilità di tipo contrattuale in capo al lavoratore per il danno causato al suo datore di lavoro
dalla sua condotta negligente od imprudente: ove il danno sia recato dal furto di somme di denaro
affidate in custodia al dipendente nell'espletamento delle sue mansioni, quest'ultimo è tenuto al
relativo risarcimento del danno qualora l'ammanco sia dovuto ad un “casus culpa determinatus”, cioè
qualora sia ricolellgabile ad una sua condotta colposa sotto al profilo della negligenza od imperizia o
alla violazione di istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro.
In ogni caso, secondo l'orientamento espresso dalla Cassazione, l'onere della prova della condotta
colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza e del rapporto di derivazione causale
del danno da tale condotta grava sul datore di lavoro.
LA FEDELTA'
L'obbligo di fedeltà è un particolare obbligo (con la finalità di evitare che l'inserimento del lavoratore
all'interno dell'organizzazione dell'impresa possa compromettere la capacità produttiva di
quest'ultima), che scaturisce dal rapporto di lavoro gravante sul lavoratore indipendentemente dal
fatto che la prestazione lavorativa sia dovuta (es. in caso di malattia, o partecipazione a sciopero),
che si configura in una serie di specifici divieti elencati dall'art. 2105:
– l'obbligo di non concorrenza – divieto di <<trattare affari, per conto proprio o di terzi, in
concorrenza con l'imprenditore>>, configurabile in ipotesi come storno di dipendenti, sviamento di
clientela in favore di impresa concorrente, conflitto d'interesse conseguente alla gestione di altra
impresa in concorrenza con quella del datore di lavoro (rientra in quest'ultima ipotesi anche lo
svolgimento di attività lavorative alle dipendenze di impresa concorrente derivante da gestione di
altra impresa, ma esclusivamente qualora ciò possa tradursi effettivamente in un vantaggio
competitivo per l'imprenditore concorrente);
– l'obbligo di segreto, volto a tutelare il c.d. patrimonio immateriale dell'impresa, esteso a
quell'insieme di notizie e conoscenze la cui diffusione potrebbe, in qualsiasi modo, nuocere alle
sorti della stessa (da distinguersi a sua volta in segreto aziendale – riguardante notizie che
possono essere apprese tramite il mero inserimento nell'organizzazione produttiva, che comporta
conseguenze esclusivamente sul piano civile – e segreto industriale – riguardante informazioni
conoscibili solo in virtù dello svolgimento di determinate mansioni, di rilevanza anche penale);
sono escluse quelle informazioni e conoscenze tecniche che vanno a costituire il bagaglio
professionale del lavoratore.
L'aspetto più delicato di questa giurisprudenza è ravvisabile in una certa inclinazione a rileggere in
termini estensivi l'obbligo di fedeltà, onde farvi ricadere comportamenti anche non espressamente
previsti dal codice civile, spesso anche facendo (discutibilmente) riferimento al generico concetto di
fiducia (che la giurisprudenza definisce come parte essenziale del rapporto): a tal riguardo, la
Cassazione fonda il suo giudizio sull'attribuzione di un ampio significato all'obbligo di fedeltà, esteso
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 58 di 105
a <<comportamenti che per la loro natura e le loro conseguenze appaiono in contrasto coi doveri
connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creino
situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa>>. In particolare, la giurisprudenza,
ritiene rilevanti a fini disciplinari i fatti della vita privata del lavoratore qualora la natura della
prestazione dovuta richieda un ampio margine di fiducia esteso ai comportamenti privati.
Ancora, la Cassazione ha affermato che l'obbligo di fedeltà cui è tenuto il dipendente non sussiste a
riguardo di attività illecite dell'imprenditore, non potendosi certo richiedere al lavoratore l'osservanza
del dovere di collaborazione col datore di lavoro in attività volte a perseguire interessi illeciti.
Infine, va rilevato che la stessa Corte non ha sempre avuto orientamenti concordanti per quanto
riguarda il conflitto tra esigenze di segretezza dell'azienda ed il diritto di difesa in giudizio: se in una
sentenza è stata affermata la prevalenza del secondo rispetto alle prime, in altri casi è stato ribadito
che tale contrasto non può essere risolto unilateralmente dal lavoratore (es. con la sottrazione di
documentazione dell'impresa), ma va valutato in sede giudiziaria.
Per quanto riguarda la durata degli obblighi di fedeltà, l'opinione prevalente è quella per cui a durare
oltre il termine del rapporto di lavoro sia solo il segreto professionale (come ha affermato la
Cassazione in tema di concorrenza, infatti, l'art. 2105 vieta al lavoratore quella concorrenza
<<illecitamente svolta ancora durante il servizio>>); l'obbligo di non concorrenza proseguirà oltre il
rapporto di lavoro solo se previsto da uno specifico patto di non concorrenza stipulato fra le parti
(che richiede forma scritta per la sostanza – e deve indicare, pena la nullità, determinati limiti di
oggetto, di tempo e di luogo – , ed ha durata massima di cinque anni per i dirigenti e tre per i
lavoratori), che può essere reso nullo (dall'interpretazione della Cassazione dell'art. 2125 c.c.) anche
qualora non preveda un equo corrispettivo; inoltre, tale patto è valido nei limiti in cui non contenga
clausole tali da impedire, di fatto, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ed, in ogni caso,
(secondo quanto affermato dalla Cassazione) non abbia ampiezza di oggetto e luogo <<tale da
comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non salvaguardino
un margine di attività sufficiente per il soddisfacimento delle esigenze di vita>>.
BUONA FEDE E CORRETTEZZA NEL RAPPORTO
Per quanto riguarda i generali principi di buona fede e correttezza da parte del datore di lavoro,
questi ultimi vengono invocate in materia giuslavoristica più che altro come limite interno all'esercizio
dei poterei del datore di lavoro, ovvero come criteri atti a verificare che quei poteri non siano
esercitati in materia arbitraria o irrazionale, bensì in coerenza con la funzione per la quale essi sono
riconosciuti dall'ordinamento.
LIMITI AL POTERE DIRETTIVO
Il potere direttivo, con riguardo alla gestione dei rapporti di lavoro, rappresenta il potere organizzativo
che si deve riconoscersi all'imprenditore con riguardo all'insieme dei fattori produttivi utilizzati ai fini
dell'esercizio della propria attività economica, e corrisponde alla facoltà di impartire <<disposizioni
per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro>>.
Il riconoscimento di tale potere è affermato in via indiretta dal codice civile (art.2094) che impone al
lavoratore subordinato l'obbligo di obbedienza: tale sottoposizione al potere direttivo del datore di
lavoro rappresenta uno degli elementi fondamentali in tema di caratterizzazione del lavoro
subordinato.
Il potere direttivo, d'altra parte, è vincolato da quei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva. Limiti di carattere generale si rintracciano nello Statuto dei Lavoratori.
Tra questi fondamentale è il divieto di atti discriminatori, per cui ogni atto o patto diretto a recare in
qualsiasi modo pregiudizio ad un lavoratore per le ragioni prescritte dalla norma stessa è colpito con
la sanzione di nullità.
LA TUTELA DELLA PERSONALITA' MORALE DEL LAVORATORE
Ai sensi dell'art. 2087 c.c. <<l’imprenditore è tenuto ad adottare [..] le misure [..] necessarie a tutelare
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 59 di 105
[..] la personalità morale dei prestatori di lavoro>>: da tale espressione traspare il riconoscimento del
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
Riguardo alla libertà di abbigliamento, innanzitutto va tutelata qualora vi sia un preciso nesso tra
aspetto personale ed adesione a determinate confessioni religiose, ma anche in generale in quanto
questa corrisponde in generale a modalità di espressione: la giurisprudenza finora formatasi in
proposito è andata nella direzione di negare al datore di lavoro potere di dettare arbitrariamente
regole relative all'abbigliamento ed all'aspetto personale, salvo pere ragioni oggettivamente
apprezzabili (per motivi di sicurezza, o quando le mansioni del lavoratore comportino un contatto con
la clientela e vi sia conseguente necessità di renderlo riconoscibile, o comunque quando il datore di
lavoro voglia imporre “regole minime di decoro”).
Recenti orientamenti della giurisprudenza di merito hanno sottolineato che sanzioni disciplinari con
riguardo alle regole sull'aspetto fisico personale sono legittime solo qualora la violazione del
lavoratore sia idonea a compromettere in modo rilevante l'immagine aziendale – fermo restando che i
diritti della persona possono essere limitati solo con riguardo a quella parte del rapporto di lavoro
strettamente inerente all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, e che fuori dall'ambiente e
dagli obblighi di lavoro (in linea di principio) il rapporto di lavoro non può incidere sulla libertà in ogni
aspetto della propria vita privata e di relazione.
Dall'art. 21 Cost. può essere ravvisato un diritto di critica (espressamente garantito dall'art. 1 dello
Statuto) esercitabile dal dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro, che – secondo il più
moderno orientamento della Cassazione – è ammissibile qualora vengano rispettati:
– il principio di continenza formale, che impone un'esposizione misurata dei fatti contestati (che
non presenti carattere offensivo nelle espressioni utilizzate);
– il principio di continenza sostanziale, in forza dal quale <<i fatti narrati devono corrispondere a
verità>>.
La Cassazione ha rilevato illegittimo superamento di tali limiti formali qualora, pur non configurandosi
il reato di diffamazione, venga rilevato – non tanto una maggiore o minore aggressività
dell'espressione od asprezza dei toni (specie nella critica sindacale) – una gratuità delle aggressioni,
non pertinenti ai temi apparentemente in discussione (screditando il proprio datore di lavoro mediante
l'evocazione di una sua pretesa indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che criticandone i
comportamenti o le azioni); ancora, la forma della critica non è da considerarsi civile qualora:
– ecceda rispetto allo scopo informativo da conseguire;
– difetti di serenità od obiettività, o vada a calpestare la dignità della persona;
– non sia improntata a leale chiarezza (drammatizzando artificiosamente notizie neutre od
adducendo vere e proprie insinuazioni).
Sul piano normativo il legislatore riconosce una certa prevalenza dell'obiezione di coscienza
rispetto all'obbligo di esecuzione della prestazione lavorativa: nel caso che il lavoratore ne faccia
esercizio, si configura ipotesi di inesigibilità (in quanto non potrebbe essere legittimamente richiesta)
della prestazione lavorativa (sarebbe materialmente possibile – per cui non si può parlare di
impossibilità sopravvenuta); in tal caso i datore di lavoro potrà adibire il lavoratore a diverse mansioni
compatibili con i dettami della propria coscienza, fermo restando il diritto del lavoratore a conservare
la medesima qualifica e trattamento economico.
In generale la libertà di coscienza è destinata a cedere di fronte all'ideologia di cui l'organizzazione è
portatrice nel caso delle c.d. organizzazioni di tendenza che sono tali proprio perché la loro ragion
d'essere è legata alla diffusione di un certo orientamento di pensiero, cui i dipendenti devono
necessariamente aderire.
DANNO ESISTENZIALE E DIRITTO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
Nella giurisprudenza più recente si è dato spazio alle esigenze di tutela della personalità morale del
lavoratore attraverso la valorizzazione delle implicazioni dell'art. 2087 c.c. : la Corte Costituzionale ha
elaborato in tema di operatività del diritto alla salute (ex. art. 32 Cost.), esteso ai rapporti inter-privati,
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 60 di 105
la categoria del danno biologico; la possibilità di attribuire al soggetto offeso un risarcimento a fronte
di un danno biologico è stata punto di partenza per attribuire rilevanza a fini risarcitori a beni quali
dignità e personalità del lavoratore (richiamate in particolare nelle ipotesi di dequalificazione
professionale, licenziamento intimato con modalità ingiuriose, molestie sessuali) ed il conseguente
riconoscimento del danno esistenziale.
Il datore di lavoro, per quanto concerne la prestazione lavorativa (come riguardo ad ogni rapporto
obbligatorio), è gravato di un obbligo di cooperazione all'adempimento e nel caso di mora credendi
questi sarà obbligato al risarcimento dei danni (in misura ragguagliata alla retribuzione). Per alcuni
rapporti di lavoro il legislatore riconosce espressamente un vero e proprio diritto del lavoratore allo
svolgimento della prestazione lavorativa, in particolare nei rapporto di lavoro con finalità formative
(nelle quali la prestazione è funzionale alla formazione professionale); per analogia di ratio, la stessa
conclusione andrebbe ammessa con riferimento a quei lavori ove la mancata effettuazione della
prestazione inciderebbe negativamente sulla quotazione di mercato (ed in tal caso sarebbe
legittimata la richiesta di un risarcimento dei danni per equivalente monetario, stante l'ineseguibilità in
forma specifica di un obbligo di fare infungibile del datore di lavoro).
DIVIETO DI INDAGINI SULLE OPINIONI E PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI
Già contenuto nello Statuto, il divieto di indagine sulle opinioni è ora espressamente richiamato
dal d.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy): con riguardo ai rapporti di lavoro particolare attenzione
viene data alla protezione dei dati sensibili, il cui trattamento potrebbe essere accompagnato da
rilevanti implicazioni discriminatorie, definiti come <<dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale>>.
In ogni caso è lo stesso Statuto (negli artt. 8 e 28) che vieta le indagini del datore di lavoro, anche a
mezzo di terzi, <<su fatti non rilevanti ai fini delle valutazioni dell'attitudine professionale del
lavoratore>> (il che costituisce un comportamento illegittimo, sanzionabile penalmente e comportante
il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni morali): più in generale, il datore di lavoro non può
indagare sulla vita privata del lavoratore salvo che questa non sia legittimamente funzionale a
valutarlo sul piano della professionalità.
L'ordinamento ha, con il d.lgs. 196/2003, regolato in modo dettagliato ed unitario la disciplina
riguardante la tutela riservata dall'ordinamento alla privacy (già tutelata dallo Statuto), intesa come
diritto alla riservatezza, a non rivelare alcuni dati, all'identità personale, a poter accedere ai propri dati
personali al fine di verificarne la correttezza (che sussiste, secondo quanto affermato dal Garante
della Privacy, anche nei casi in cui tali dati personali non siano eventualmente suscettibili di
correzione in quanto contenuti nell'ambito di un giudizio o di una valutazione – tale orientamento è
stato poi censurato dalla giurisprudenza in quanto dati rilevanti dovrebbero potersi tradurre in atti
esterni giuridicamente rilevanti e come tali impugnabili, e non soltanto inerenti alle convinzioni
soggettive del datore di lavoro).
Il concetto di dato personale (secondo la giurisprudenza) ricomprende ogni notizia, informazione o
elemento che abbia un'efficacia informativa tale da fornire un contributo di conoscenza rispetto a un
soggetto interessato identificato od identificabile (e nella categoria ricadono anche i dati relativi al
lavoro straordinario prestato ed ai relativi compensi).
LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA' DEL LAVORATORE
Le mansioni esigibili (i compiti che il lavoratore è tenuto ad adempiere in esecuzione del contratto di
lavoro) rappresentano oggetto fondamentale dell'obbligazione del lavoratore: generalmente l'oggetto
della prestazione lavorativa non è individuata con analitica precisione dal contratto, che si limita (ex.
art. 2103 c.c.) invece a richiamare il livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo
applicabile con accompagnata indicazione di qualifica o profilo professionale, rendendo così
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 61 di 105
determinabile la prestazione lavorativa (dal datore di lavoro che ne specificherà la mansione
nell'ambito del proprio potere direttivo).
Peculiarità del potere direttivo è rappresentata dal c.d. ius variandi, nell'esercizio del quale il datore
di lavoro può modificare le mansioni del lavoratore al di là di quanto convenuto al momento
dell'assunzione. Lo Statuto dei Lavoratori ha introdotto l'attuale versione dell'art. 2103 c.c. , che
rispondono a necessità di tutela della professionalità del lavoratore a fronte del potere
modificativo del datore di lavoro: è stabilito che <<il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza
alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove
la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a
tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo>>.
E' dunque consentita mobilità orizzontale nel limite dell'equivalenza professionale, e comunque
garantendo il mantenimento del livello retributivo acquisito nella mansione di provenienza (e, come
ha aggiunto la Cassazione, a patto che non comporti l'adibizione a mansioni di eccessiva
disomogenea rispetto alle precedenti, tale da ostacolare l'impiego del bagaglio di conoscenze
professionali del lavoratore).
La mobilità verticale è consentita solo verso l'alto e comporta il riconoscimento (immediato) ad un
miglioramento retributivo; l'assegnazione della mansione diventa definitiva solo dopo un periodo
prefissato (dai contratti collettivi) di durata non superiore ai 3 mesi.
In proposito la Cassazione ha affermato che le <<reiterate assegnazioni di un lavoratore a mansioni
superiori, ciascuna inferiore al termine legale [..], non danno di per sé diritto alla promozione
automatica prevista dall'art. 2103 >> salvo che tali assegnazioni a mansioni superiori per brevi
periodi non celino l'intenzione di eludere il disposto dell'art. 2103 c.c. (ed in tal caso <<si perviene
alla maturazione del termine [..] per sommatoria dei diversi periodi di applicazione alle mansioni
superiori>>.
Infine, secondo un orientamento diffuso in giurisprudenza (come ribadito dalla Cassazione)
<<l'ipotesi di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto comprende
anche quella in cui la sostituzione riguardi un lavoratore assente per ferie, difettando anche in tal
caso quella effettiva vacanza del posto che costituisce il presupposto dell'acquisizione della qualifica
superiore>>.
Per quanto riguarda il pubblico impiego, il dipendente pubblico può essere adibito a mansioni
considerate dai contratti collettivi equivalenti a quella d'assunzione, mentre (fermo restando il divieto
di dequalificazione professionale) la mobilità verticale verso l'alto è ammessa entro limiti stringenti
previsti dal legislatore (cioè solo per mansioni proprie del livello d'inquadramento immediatamente
superiore, in occasione di vacanza di posti in organico, od in sostituzione di altro dipendente assente
con diritto alla conservazione del posto).
L'EQUIVALENZA DELLE MANSIONI
La nozione di equivalenza delle mansioni è ricostruita dalla giurisprudenza con riferimento alla ratio
dell''art. 2103 c.c. che è quella di tutelare la professionalità del lavoratore che subisce un mutamento
di mansioni: non è sufficiente che le mansioni precedenti e quelle di arrivo siano inquadrate al
medesimo livello nel sistema di inquadramento previsto dal contratto collettivo, essendo invece
necessario che le nuove mansioni consentano lo sviluppo delle competenze e dell'esperienza
acquisite nello svolgimento delle precedenti mansioni: nell'opinione della Cassazione, l'equivalenza è
rispettata quando le nuove mansioni, seppur non identiche a quelle in precedenza espletate,
corrispondano alla specifica competenza tecnica del dipendente e ne salvaguardino il livello
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 62 di 105
professionale; inoltre, non devono danneggiarlo nell'ambito del settore o socialmente e devono
comunque essere tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio di esperienza lavorativa acquisita
nella pregressa fase del rapporto.
Sempre la Cassazione ha affermato che <<il giudizio di equivalenza [..] deve essere effettuato
raffrontando il contenuto professionale delle mansioni di partenza con quello delle mansioni di
destinazione in una prospettiva dinamica, di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio
bagaglio di conoscenze e di esperienze>.
Per quanto riguarda eventuali riduzioni quantitative delle mansioni, queste (come affermato dalla
Cassazione) corrispondono a demansionamento quando, pur senza conseguenze sulla retribuzione,
lascino il dipendente <<in condizioni di forzata attività e senza assegnazione di compiti, costituendo il
lavoro non solo un mezzo di guadagno ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del
soggetto>>: più in generale sono violate le norme in tutela della professionalità qualora la modifica
delle mansioni comporti <<un progressivo deperimento del bagaglio culturale del dipendente e una
perdita di quelle conoscenze ed esperienze richieste dal tipo di lavoro svolto>> che portano
necessariamente ad <<un graduale appannamento della propria professionalità ed [..] una sua più
difficile futura utilizzazione>>.
Per ultimo, nel caso di legittimo esercizio dello jus variandi, la retribuzione per quale vale il principio
di irriducibilità è da considerarsi (sempre secondo l'orientamento della cassazione) corrispondente al
<<compenso della professionalità intrinseca alle mansioni stesse, e non all'aspetto attinente alla
quantità e alle modalità di lavoro>>: sono quindi escluse le indennità ed i compensi relativi alle
particolari modalità di svolgimento delle mansioni di provenienza non correlate con le prospettate
qualità professionali della stessa.
L'ONERE DELLA PROVA PER IL DEMANSIONAMENTO
Secondo parte della giurisprudenza l'onere della prova dell'effettiva sussistenza del danno
patrimoniale ricade sul lavoratore, che dovrà provare il danno subito (in quanto conseguenza
possibile ma non necessaria di una violazione dell'art. 2103 c.c. ), nella sua oggettiva consistenza del
pregiudizio (in modo che si possa determinare un preciso valore del risarcimento).
Secondo un orientamento opposto, invece, esisterebbe una presunzione a favore della
configurazione del danno anche in mancanza di una prova specifica della sua sussistenza, ed in tal
caso il danno patrimoniale risarcibile (da valutarsi anche per via equitativa) risulterebbe dal mero
accertamento del demansionamento.
ECCEZIONI ALLA DISCIPLINA GENERALE DI TUTELA DELLA PROFESSIONALITA'
La nullità che colpisce (ex. art. 2103 c.c.) generalmente ogni patto contrario a tali tutele della
professionalità trova eccezione in talune ipotesi per le quali il legislatore ha ritenuto che a riguardo la
norma fosse eccessivamente rigida; tra queste:
– la possibilità di adibire la madre durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio anche
eventualmente a mansioni di minor contenuto professionale (fermo restando il diritto a conservare
la retribuzione) rispetto a quelle abitualmente esercitate, nel caso in cui queste ultime possano
essere pregiudizievoli per la sua salute;
– la possibilità di adibire temporaneamente il lavoratore a mansioni inferiori qualora ciò risulti
necessario per proteggerne le condizioni di salute minacciate dall'esposizione ad un agente
chimico, fisico o biologico;
– la possibilità (a tutela dell'interesse al mantenimento dell'occupazione) di prevedere – con accordi
sindacali stipulati a fronte di un licenziamento collettivo – il riassorbimento [..] dei lavoratori ritenuti
eccedenti>>, anche in assegnazione a mansioni inferiori senza che ciò comporti il mantenimento
dell'anteriore più elevato livello retributivo.
In generale (come ha affermato la Cassazione) la nullità <<non è riferibile all'ipotesi in cui la modifica
in pejus delle mansioni sia stata concordata nell'interesse del lavoratore e al fine di evitare il
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 63 di 105
licenziamento>> con particolare riferimento alla situazione per cui il lavoratore che non sia <<più in
grado, per ragioni di salute, di svolgere in modo adeguato le mansioni precedenti>>.
Per quanto riguarda i rimedi, la lesione della professionalità è tutelata, oltre che dall'annullamento dei
patti contrari, da un congruo risarcimento patrimoniale del danno.
LA DISCIPLINA DELLE INVENZIONI
Le invenzioni del lavoratore si distinguono in invenzioni occasionali (invenzioni industriali realizzate
da un lavoratore al di fuori dell'orario di lavoro e con mezzi propri, ma rientranti nel campo di attività
dell'impresa) ed invenzioni fatte nell'esecuzione di un contratto di lavoro, che si dividono a loro volta
in invenzioni di servizio (quando l'attività inventiva costituisce l'oggetto del contratto) ed invenzioni
aziendali (quando l'invenzione è realizzata in connessione con lo svolgimento del rapporto):
per le invenzioni occasionali i diritti spettano a chi le ha realizzate (fatto salvo il diritto di opzione per
l'uso dell'invenzione o l'acquisto del relativo brevetto, esercitabile dal datore di lavoro entro 3 mesi
dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto),
mentre per invenzioni di servizio ed aziendali i diritti spettano al datore di lavoro, mentre nel caso di
invenzioni realizzate nell'esecuzione di un contratto i diritti spettano al datore di lavoro ed il lavoratore
avrà diritto ad un equo premio qualora l'invenzione realizzata presenti i tratti dell'invenzione aziendale
ed il datore di lavoro abbia ottenuto il relativo brevetto; in ogni caso al lavoratore è riconosciuto
(dall'art. 2590 c.c.) il <<diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del
rapporto di lavoro>>.
LA DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO
L'art. 1182 c.c. stabilisce che il luogo di adempimento della prestazione è determinato dal contratto o
dagli usi: nel rapporto di lavoro subordinato è però (ex art. 2103 c.c) riconosciuto al datore di lavoro il
potere di variare il luogo di esecuzione intimando al lavoratore un trasferimento in costanza di
rapporto. Tale trasferimento non si giustifica (ai sensi dello Statuto) se non a fronte di <<comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive>> (in cui mancanza il provvedimento deve considerarsi
nullo).
Onde evitare che il provvedimento di trasferimento venga adottato nell'impossibilità di intimare un
licenziamento giustificato, con il solo scopo di esercitare una pressione psicologica sul lavoratore,
spingendolo a rassegnare le dimissioni, le ragioni motivanti il trasferimento devono essere suscettibili
di dimostrazione, gravando l'obbligo della prova sul datore di lavoro (ma secondo la prevalente
giurisprudenza non è necessario che vengano comunicate contestualmente al relativo
provvedimento) qualora il lavoratore ne faccia richiesta. D'altra parte, la valutazione giudiziale non
potrà entrare nel merito della decisione, essendo quest'ultima espletamento del potere di scelta
dell'imprenditore fra più soluzioni organizzative (ed il datore di lavoro non sarà tenuto a dimostrare
l'inevitabilità del trasferimento stesso).
Poiché, dall'applicazione dell'art. 2103 c.c. , il datore di lavoro potrebbe esercitare il potere di
trasferire il lavoratore senza sottostare ad alcun obbligo di giustificazione qualora il trasferimento si
verificasse all'interno della medesima unità produttiva, resta fondamentale un identificazione della
stessa, che la cassazione ha inteso come ogni <<entità aziendale che [..] si caratterizzi per
sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si
esaurisca per intero il ciclo relativo ad [..] un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale>>
(anche prescindendo dai limiti dimensionali contenuti nell'art. 35 dello Statuto dei Lavoratori): in ogni
caso, tutela al lavoratore andrà sicuramente assicurata qualora il mutamento del luogo di esecuzione
della prestazione porti inevitabilmente ad un mutamento della residenza o dimora, o comunque
comporti disagi personali o familiari per il lavoratore.
Il luogo della prestazione lavorativa può subire variazioni in forza dell'esercizio del potere direttivo
anche nell'ipotesi in cui il lavoratore venga inviato in trasferta (che comporta uno spostamento solo
momentaneo, legato ad esigenza organizzativa circoscritta nel tempo), nel qual caso si applica
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 64 di 105
quanto stabilito dalla disciplina legale o dai contratti collettivi.
La disciplina del trasferimento vale anche nella P.A. , nella quale è altresì regolato il trasferimento a
domanda dell'interessato mediante il quale un'amministrazione può (previo permesso di quella
d'appartenenza del lavoratore) provvedere alla copertura di posti vacanti in organico.
LA POSSIBILITA' DEL TRASFERIMENTO DISCIPLINARE
Se la dottrina ha, in passato, escluso il ricorso al trasferimento come sanzione disciplinare (salvo,
come ricordato in giurisprudenza dalla Cassazione, qualora tale provvedimento sia <<incluso da
parte della contrattazione collettiva nella tipologia delle sanzioni contemplate>>), la giurisprudenza si
è orientata nell'ammettere la possibilità di individuare ragione organizzativa legata a profili di
carattere soggettivo legati al comportamento del lavoratore, legittimando il ricorso al trasferimento
per incompatibilità ambientale: la Corte di Cassazione ha, infatti, riconosciuto al datore di lavoro la
facoltà al datore di lavoro di disporre il trasferimento del lavoratore <<ad altra unità produttiva, al di
fuori di ogni intento punitivo [,,] per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, ove il
contegno del lavoratore [..] determinasse [..] una situazione di incompatibilità nell'ambiente di lavoro,
così da incidere oggettivamente in senso negativo sul normale svolgimento dell'attività [..]
dell'impresa>>.
Infine, è la stessa Cassazione ad aver ammesso in linea teorica la possibilità del trasferimento
disciplinare, in quanto <<il trasferimento ha un carattere conservativo e non comporta un mutamento
definitivo del rapporto di lavoro, incidendo soltanto sul luogo di adempimento della prestazione
lavorativa>>, e ciò <<non costituisce, di per sé e in via generale, un elemento immutabile del
rapporto di lavoro>>: il trasferimento non modifica quindi <<il rapporto di lavoro, ma soltanto una sua
modalità topografica, che neppure incide sul contenuto qualitativo e professionale della prestazione
svolta>>.
IL DISTACCO
Variazione del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa può determinarsi a fronte della prassi
di inviare un lavoratore in distacco presso altra impresa: tale istituto, frutto di costruzione
giurisprudenziale (poi disciplinato dal d.lgs. 276/2003), si riscontra qualora <<uno o più lavoratori a
disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa>> (anche senza il
consenso del lavoratore, salvo nel caso in cui ciò comporti un mutamento di mansioni).
Durante il distacco il datore di lavoro rimane <<responsabile del trattamento economico e normativo
a favore del lavoratore>>.
Infine è previsto che, qualora il distacco comporti un trasferimento ad una sede di lavoro sita a più di
50km da quella di provenienza esso può avvenire <<soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive>>.
La Cassazione ha, infine, formulato alcuni principi sui quali fondare il giudizio di legittimità della
fattispecie, subordinata:
– all'esistenza di un interesse del datore di lavoro distaccante ;
– al carattere temporaneo del distacco (che può anche coincidere con l'intera durata del rapporto);
Nell'assenza di tali condizioni il lavoratore può chiedere <<la costituzione di una rapporto di lavoro
alle dipendenze>> del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
L'assenza di un rilevante interesse, nel distacco da parte del datore di lavoro di un suo dipendente
presso altro imprenditore perché esegua le sue prestazioni nell'azienda di questo, porta all'illegittimità
del negozio in quanto, in tal caso, la dissociazione tra autore dell'assunzione ed effettivo beneficiario
delle prestazioni non si risolverebbe in altro che in un ostacolo al diritto del lavoratore di pretendere il
più vantaggioso trattamento che gli sarebbe spettato se assunto direttamente dall'utilizzatore.
L'ORARIO DI LAVORO
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 65 di 105
La disciplina dell'orario di lavoro adempie alla primaria funzione di delimitare l'entità massima della
prestazione che può essere richiesta al lavoratore, onde tutelare la sua salute ed integrità psicofisica: in tale materia il potere direttivo del datore di lavoro può esercitarsi solo nel rispetto dei limiti
legali (e contrattuali) di durata della prestazione lavorativa.
Il d.lgs 66/2003 (poi modificato dal d.lgs 213/2004) regola in modo organico la materia degli orari di
lavoro (sia a riguardo al tempo di lavoro che ai riposi) per quanto riguarda il settore privato e pubblico
(salvo limitate eccezioni), ferma restando la disciplina specifica per i lavoratori minorenni.
L'orario di lavoro è definito come <<qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia la lavoro, a disposizione
del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni>>.
I limiti di durata (di sicuro fondamento costituzionale, ex art.36 cost. per cui <<la durata massima
della giornata lavorativa è stabilita dalla legge>>) sono stati individuati (dopo essere stati per anni
legati alle indicazioni del R.d.l. 692/1923, che stabiliva un massimale di 8 ore al giorno e 48 alla
settimana, più eventuali straordinari di non più di 2 ore al giorno e 12 la settimana) nella previsione
per la quale l'orario normale di lavoro è <<fissato in quaranta ore settimanali>> (tetto suscettibile di
abbassamento ad opera dei contratti collettivi): la stessa norma stabilisce che tale orario vada riferito
<<alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno>>.
Per quanto invece riguarda la commisurazione di tali limiti, il d.lgs 66/2003 supera i precedenti
orientamenti giurisprudenziali definendo l'orario di lavoro come <<qualsiasi periodo in cui il lavoratore
sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue
funzioni>>, sulla scia di una sentenza della Corte di Giustizia, che ha valutato che il fatto che i
lavoratori siano <<presenti e disponibili sul luogo di lavoro per prestare la loro opera professionale
dev'essere considerato rientrante nell'esercizio delle loro funzioni>> (e ne deriva che ciò che induce
a ritenere la prestazione lavorativa rientrante nell'orario di lavoro sia l'indisponibilità da parte del
lavoratore del proprio tempo, messo a disposizione alle esigenze del datore di lavoro).
Ciò consente dunque il ricorso a schemi di orario multiperiodale da parte delle imprese, a patto che
la durata media dell'orario di lavoro non superi le 48 ore settimanali (ivi comprese le ore di lavoro
straordinario) con riferimento ad un periodo di durata non superiore a quattro mesi (elevabile
discrezionalmente a sei mesi dai contratti collettivi, e fino ad un massimo di <<dodici mesi a fronte di
ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti
collettivi>>). Per quanto riguarda il limite giornaliero di durata della prestazione lavorativa – data
l'attuale disciplina – questo viene quantificato dalla prevalente dottrina in un massimale di 13 ore
(dalla previsione che riconosce ai lavoratori il <<diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore>>).
IL RIPOSO GIORNALIERO
In base al d.lgs. 66/2003, il lavoratore ha diritto ad un riposo giornaliero di undici ore consecutive ogni
24 ore, che devono essere fruite in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata;
E' poi previsto che, nel caso in cui lo svolgimento della prestazione lavorativa ecceda il limite di sei
ore, <<al lavoratore dev'essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di
ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti>> (stabilita dai contratti
collettivi).
In ogni caso l'ordinamento ha riconosciuto ampia facoltà derogatoria ai contratti collettivi (od ancora il
Ministero del Lavoro può adottare ulteriori deroghe con riguardo ad una vasta serie di ipotesi, su
richiesta delle parti sociali): ogni deroga è accompagnata da una clausola di salvaguardia per cui ai
lavoratori devono essere <<accordati periodi equivalenti di riposo compensativo>> (salvo non <<non
sia possibile per motivi oggettivi>>) ed in ogni caso dev'essere assicurata loro una (non ben definita)
<<protezione appropriata>>.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 66 di 105
IL LAVORO STRAORDINARIO
Per lavoro straordinario si intende quello <<prestato oltre l'orario normale di lavoro>> (cioè quello –
mediamente, vista la vigente disciplina – eccedente la quarantesima ora settimanale di lavoro) che
può essere svolto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, a condizione che non superi il tetto
annuale di 250 ore (eventualmente modificabile, anche in aumento, dalla contrattazione collettiva).
Ai sensi dell'attuale disciplina, non è più assicurato il diritto ad una maggiorazione retributiva per il
lavoro straordinario, che viene rimessa alla contrattazione collettiva (che può stabilire anche che in
alternativa alle maggiorazioni retributive i lavoratori possano godere di riposi compensativi).
IL LAVORO NOTTURNO
Sovente l'organizzazione produttiva comporta un'articolazione in turni di lavoro, nei quali la
collocazione della prestazione lavorativa è rimessa al potere direttivo del datore di lavoro, esercitabile
nel rispetto di eventuali vincoli eventualmente posti dal contratto collettivo od individuale.
Limiti legali riguardano invece l'eventuale adibizione del lavoratore a svolgimento di lavoro notturno
(dove il periodo notturno è ogni <<periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo
tra la mezzanotte e le cinque del mattino>> – e lavoratore notturno è <<qualsiasi lavoratore che
durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in
modo normale>> o vi svolga almeno parte del suo lavoro – secondo diversi requisiti definiti dai
contratti collettivi – o comunque <<che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi
all'anno>>) che non deve essere svolto da:
– la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni (o in alternativa il lavoratore padre
convivente con la stessa);
– la lavoratrice od il lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età
inferiore a 12 anni;
– la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile;
– i lavoratori che non abbiano raggiunto la maggiore età;
– altri lavoratori che rispondano a requisiti previsti dai contratti collettivi.
In generale, in ogni caso, la durata del lavoro notturno non può superare le 8 ore giornaliere.
Non potrà, infine, prestare lavoro dalle ore 24 alle 6 la lavoratrice madre nel periodo compreso tra
l'accertamento dello stato di gravidanza ed il compimento di 1 anno di età del bambino.
Nel caso abbia alle dipendenza lavoratori notturni, il datore di lavoro è tenuto (attraverso controlli
preventivi e periodici), a valutare lo stato di salute di tali lavoratori e, qualora ne sia stata l'inidoneità
al lavoro notturno per ragioni di salute, dovrà assegnare loro (se possibile) lavoro diurno in mansioni
equivalenti.
IL DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE
Il diritto al riposo settimanale ha fondamento costituzionale (nell'art. 36 Cost.) ed il lavoratore che ne
è titolare non può validamente rinunciarvi: il d.lgs 66/2003 stabilisce che <<il lavoratore ha diritto ogni
sette giorni ad un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive>> (di regola in
coincidenza con le domeniche): la Cassazione ha affermato che la legge ed i contratti collettivi od
individuali possono prevedere a riguardo disciplina differente (rispetto al riposo domenicale, ed alla
fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi), <<alla condizione che sussistano situazioni che la
rendano necessaria a tutela di interessi apprezzabili e che, inoltre non venga snaturato o eluso il
rapporto – nel complesso – fra sei giorni di lavoro ed uno di riposo e non vengano superati i limiti di
ragionevolezza, soprattutto riguardo alla tutela della salute del lavoratore>>, ferma restando l'illiceità
di una prestazione lavorativa di sette giorni consecutivi – certezza, quest'ultima, che sembra essere
stata cancellata dalla l.133/2008, che prevede che tale rapporto sia calcolato come media in un
periodo non superiore a 14 giorni.
Il danno derivato dalla mancata fruizione del riposo settimanale (nell'orientamento della Cassazione,
ancorché formatosi in relazione alla previgente normativa) è correlato ad un'inadempienza
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 67 di 105
contrattuale del datore del lavoro, il cui risarcimento dev'essere quantificato dal giudice in concreto,
nel merito (ricorrendo anche ad una valutazione equitativa), e più precisamente (secondo una
sentenza sempre della Cassazione) deve corrispondere:
– alla retribuzione giornaliera (già dovuta) per il giorno di riposo;
– ad una maggiorazione retributiva per la maggiore penosità del lavoro domenicale (qualora sia
avvenuta nella giornata di domenica);
– ad un'attribuzione patrimoniale di natura risarcitoria del danno di “usura psicofisica”, derivante dal
mancato (od irregolare) godimento del riposo, derivante da una scelta organizzativa in contrasto
con norme imperative poste a tutela di diritti fondamentali del lavoratore.
FERIE ED ALTRE FESTIVITA' SETTIMANALI
Anche il diritto a ferie annuali retribuite è di rilevanza costituzionale e non può essere rinunziato dal
lavoratore: ai sensi del d.lgs 66/2003 , i lavoratori hanno <<diritto ad un periodo annuale di ferie
retribuite non inferiore a quattro settimane>>; ai sensi dell'art. 2109 c.c. spetta al datore di lavoro
determinarne il periodo di godimento (<<tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del
prestatore di lavoro>>), preventivamente comunicato all'interessato e possibilmente continuativo. La
vigente normativa (così come modificata dal d.lgs 213/2004) stabilisce inoltre che:
– il lavoratore abbia diritto a godere nell'anno di maturazione soltanto due delle quattro settimane di
ferie retribuite;
– per poterne godere in maniera ininterrotta è necessario che l'interessato formuli esplicita richiesta;
– le ulteriori due settimane possono essere godute a discrezione del datore di lavoro nei 18 mesi
successivi al termine dell'anno di maturazione.
Essendo, infine, tale diritto irrinunciabile, non sarà ammessa indennità sostitutiva per ferie non
godute salvo che il rapporto di lavoro cessi prima del periodo fissato dall'impresa per il godimento
delle ferie.
Riguardo invece alle festività infrasettimanali, il conseguente diritto al tempo libero può essere
liberamente utilizzato dagli interessati, eventualmente anche per svolgere attività lavorativa (che
potrebbe essere legittimamente richiesta dal datore di lavoro, a fronte di una doppia retribuzione –
quella già dovuta per la giornata festiva, nonché quella ulteriore per le ore di lavoro svolte, con
maggiorazione per il lavoro festivo).
Il conteggio dei giorni di godimento delle ferie può essere sospeso qualora sopravvenga (nel solco di
una sentenza della Corte Costituzionale) una malattia, tale da rendere il lavoratore non solo incapace
di effettuare la prestazione lavorativa, ma anche (ed a riguardo l'onere della prova spetterà al
lavoratore) di godere del proprio tempo libero: la malattia in grado di sospendere il decorso delle ferie
è quella che, <<per le sue modalità terapeutiche, sia tale da impedire l'effettivo recupero delle
energie psico-fisiche a cui l'istituto feriale è finalizzato>>.
LA MODIFICABILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO
In forza del d.lgs. 152/1997, l'orario di lavoro è oggetto dell'informazione scritta sulle condizioni
essenziali di contratto, nonché su ogni eventuale modifica che il datore di lavoro deve comunicare al
lavoratore.
La giurisprudenza prevalente configura la durata dell'orario di lavoro quale elemento essenziale del
contratto, come tale modificabile solo con il consenso di entrambe le parti; per quanto riguarda
invece al collocazione temporale dell'orario nell'arco della giornata, l'eventuale modifica – dovuta ad
esigenze organizzative e funzionali – è da includersi (o almeno così ritiene la giurisprudenza
prevalente) nell'ambito dell'esercizio dei poteri del datore di lavoro riconosciuti dall'ordinamento;
naturalmente tale potere di modificare unilateralmente la distribuzione dell'orario di lavoro trova limite
nei diritti e nei principi dello stesso ordinamento (tra cui il diritto al riposo, alla salute; nonché ad un
più generale principio di ragionevolezza).
IL POTERE DI CONTROLLO
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 68 di 105
Il potere di controllo costituisce tipica proiezione del potere direttivo del datore di lavoro:
l'ordinamento giuridico riconosce la legittimità sia di controlli sull'esatto adempimento della
prestazione aziendale, sia controlli funzionali ad assicurare l'integrità del patrimonio aziendale.
A riguardo, lo Statuto dei Lavoratori stabilisce che:
– per quanto riguarda l'utilizzo di guardie giurate, queste possono essere utilizzate dal datore di
lavoro <<soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale>> (e da ciò consegue il divieto del
loro utilizzo per vigilare sull'andamento dell'attività lavorativa, per cui queste <<non possono
accedere nei locali dove si svolge tale attività [..] se non eccezionalmente>> per specifiche e
motivate esigenze legate all'assolvimento della funzione cui sono addette);
– le visite personali di controllo sono vietate, ad eccezione di quando risultino indispensabili ai
fini della tutela del patrimonio aziendale ed avvengano con l'applicazione di sistemi che assicurino
l'imparzialità della scelta dei lavoratori da sottoporre a controllo (e previo raggiungimento di
accordo del datore di lavoro con le rappresentanze sindacali od, in mancanza, con provvedimento
sostitutivo ricorribile al Ministero del Lavoro).
– con riguardo ai controlli sull'attività lavorativa è ammessa la sorveglianza (oltre a quella da parte
dei lavoratori gerarchicamente sovraordinati) da personale specificamente adibito a tale funzione,
a patto che siano comunicati agli altri lavoratori i nominativi e le mansioni del personale di
vigilanza.
– è vietato l'utilizzo di impianti audiovisivi ed altre apparecchiature che abbiano esclusive finalità
di controllo a distanza dei lavoratori, salvo nel caso di esigenze organizzative e produttive o di
sicurezza del lavoro. (ed, in ogni caso, la Cassazione ricorda che che <<la vigilanza sul lavoro,
ancorché necessaria nell'organizzazione produttiva>> non deve essere <<esasperata dall'uso di
tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di
riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro>> – per cui è da ritenersi illecito ogni
controllo a distanza finalizzato a controllare l'attività dei dipendenti, mentre è da ritenersi legittimo
quello atto ad accertare condotte illecite del lavoratore, quali sistemi all'accesso ad aree
riservate).
In generale, in ogni caso, la giurisprudenza riconosce un potere di controllo particolarmente ampio
quando si tratti di verificare l'eventuale commissione di atti illeciti da parte del lavoratore: la Corte di
Cassazione ha ritenuto legittima <<la vigilanza sui lavoratori, limitatamente ad atti e comportamenti
degli stessi, che siano configurabili come fonte di responsabilità extracontrattuale>>, precisando che
questa <<è diretta sia sulle prestazioni lavorative che sulle eventuali irregolarità>>; è stato poi
affermato, in altra occasione, che lo Statuto non esclude<<il potere dell'imprenditore [..] di controllare
direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni
lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di
esecuzione e ciò indipendentemente dalle modalità di controllo>>.
LEGITTIMITA' DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI
Con riguardo agli accertamenti sanitari dello stato di salute dei dipendenti, è stato vietato che questi
possano essere svolti direttamente dal datore di lavoro attraverso un proprio medico di fiducia: il
controllo delle assenze per infermità, dovuta a malattia od infortunio, potrà essere svolto, su richiesta
del datore di lavoro, soltanto dai servizi ispettivi degli enti pubblici competenti (ai quali è affidato
anche il controllo d'idoneità fisica dei propri lavoratori a determinate mansioni).
Per quanto riguarda la legittimità di tali controlli anche in fase pre-assuntiva, la giurisprudenza ha
espresso orientamenti contrapposti: secondo un'interpretazione estensiva dell'art. 5 dello Statuto,
questo si riferirebbe con il termine “lavoratori” anche a coloro che aspirino a lavorare, e non solo ai
lavoratori già dipendenti.
IL POTERE DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO
L'art. 2106 c.c. riconosce al datore di lavoro la facoltà di applicare sanzioni disciplinari a fronte di
violazione dei doveri di diligenza ed obbedienza e dell'obbligo di fedeltà. Tale potere disciplinare,
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 69 di 105
con la possibilità di colpire l'inadempimento del lavoratore attraverso l'irrogazione di una speciale
pena privata, contrastante con la posizione paritaria generalmente propria delle parti di un contratto,
(mancante di funzione risarcitoria) risponde alla <<funzione di diffidare dal compimento di ulteriori
violazioni>: sempre ai sensi dell'art. 2106 c.c. la sanzione disciplinare dev'essere proporzionata alla
gravità dell'infrazione (secondo rapporti di proporzionalità che vanno riferiti alle previsioni in materia
dei contratti collettivi, di valore però non assoluto e disattendibili qualora il giudice non le ritenga
corrispondenti al requisito della proporzionalità).
Il codice disciplinare contiene indicazioni (anche di carattere generale) sulle infrazioni e sulle
sanzioni ad esse collegate, nonché alle procedure di contestazione; dove esistano previsioni
individuate dal contratto collettivo, il codice dovrà contenerle.
E' compito del datore di lavoro portare <<a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo
accessibile a tutti>> il contenuto del codice disciplinare (e tale forma di pubblicità non può essere
surrogata con qualsivoglia modalità equipollente): secondo l'opinione prevalente l'affissione ha natura
costitutiva per cui <<è nulla la sanzione irrogata in difetto di tale forma di pubblicità>>.
L'irrogazione di una sanzione disciplinare presuppone il rispetto di una procedura (con finalità di
garanzia del diritto di difesa del lavoratore interessato) che va avviata attraverso la contestazione
preventiva dell'addebito, da effettuarsi per iscritto: la contestazione scritta adempie alla funzione di
consentire al lavoratore di presentare le proprie difese (eventualmente con l'assistenza di un
rappresentante del sindacato cui aderisce); salva l'ipotesi del rimprovero verbale, che rappresenta la
sanzione minima, nessun'altra sanzione può essere applicata <<prima che siano trascorsi cinque
giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa>> (la c.d. pausa di riflessione).
La previsione della c.d. pausa di riflessione ha scopo (oltre a quello di offrire al datore di lavoro
occasione di riflessione ed eventualmente ripensamento) di consentire al lavoratore di comunicare le
proprie giustificazioni (per iscritto od oralmente): affinché tale funzione possa essere adeguatamente
perseguita, la contestazione deve avere carattere di specificità, onde consentire all'interessato di
conoscere con precisione i fatti addebitatigli, in modo da consentirgli di raccogliere e fornire adeguate
prove a propria difesa.
Per quanto lo Statuto non preveda un termine ultimo entro il quale il datore di lavoro potrà effettuare
la contestazione (dall'accertamento dell'illecito), la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito il
principio (già affermato in giurisprudenza) dell'immediatezza dell'esercizio del potere disciplinare (pur
sempre compatibile con <<un intervallo di tempo indispensabile per l'accertamento dei fatti e la loro
valutazione>>, tenendo conto che complessità della struttura aziendale può influire sulla tempestività
di reazione del datore di lavoro). Tale principio cade qualora il datore di lavoro, per cause a lui non
imputabili, sia pervenuto a conoscenza dell'atto illecito solo successivamente.
Sempre la Cassazione ha interpretato la disposizione contenuta nell'art. 7 dello Statuto (per cui <<il
datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare al lavoratore [..] senza averlo
sentito a sua difesa>>) nel senso che il datore di lavoro sarà tenuto a sentire il lavoratore solo
qualora quest'ultimo lo richieda espressamente (e <<nessuna violazione del citato art. 7 è ravvisabile
nell'ipotesi che la sanzione disciplinare sia stata irrogata dopo che al lavoratore sia stata effettuata la
relativa contestazione, senza che risulti alcuna sua successiva richiesta d'audizione>>)
La contestazione può riguardare anche la c.d. recidiva, cioè la reiterazione di un determinato
comportamento, qualora questa sia essenziale per integrare gli estremi di un'infrazione: è stabilito in
ogni caso che <<non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione>>.
Le tipologie di sanzioni (le c.d. sanzioni conservative) elencate nello Statuto dei Lavoratori sono: il
rimprovero verbale, l'ammonizione scritta, la multa (<<di importo non superiore a quattro ore della
retribuzione base>>), la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (che non può eccedere i dieci
giorni). In ogni caso, è fatto divieto di irrogare <<sanzioni disciplinari che comportino mutamenti
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 70 di 105
definitivi del rapporto di lavoro>>.
La Corte Costituzionale ha legittimato la possibilità di licenziamenti disciplinari (eccezione alla regola
per cui le sanzioni non possono comportare mutamenti definitivi) giustificabili – ad esempio – a fronte
di comportamenti contrari alle fondamentali regole del vivere civile: nella more della decisione il
datore di lavoro può adottare un provvedimento di sospensione cautelare.
Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate (in alternativa che all'autorità giudiziaria) attivando
la procedura arbitrale eventualmente prevista dal contratto collettivo, o chiedendo alla direzione
provinciale del lavoro la costituzione di un apposito collegio arbitrale: in caso di ricorso, indipendente
dalle modalità, la sanzione resterà sospesa sino alla definizione del giudizio.
L'OBBLIGO DI SICUREZZA
Oltre all'obbligazione principale del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, cioè la retribuzione,
sussistono ulteriori obblighi, tra cui quello di sicurezza: stando all'art. 2087 c.c. l'imprenditore è tenuto
ad adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (garantita dal diritto alla
salute sancito dall'art. 32 Cost.).
In giurisprudenza (con riferimento agli obblighi derivanti dall'art. 2087) si è affermato il principio
della massima sicurezza tecnologicamente fattibile (ripreso dal d.lgs. 626/1994), in forza del
quale il datore di lavoro è tenuto ad apprestare tutte le cautele consentite dall'evoluzione della
tecnica a tutela della salute dei lavoratori – e ciò indipendentemente dalle specifiche disposizioni
normative in tema di sicurezza: responsabilità contrattuale del datore di lavoro potrà farsi valere (a
prescindere dal verificarsi di un concreto danno alla salute dei lavoratori coinvolti) solo per il fatto
della mancata predisposizione delle misure di sicurezza. In conformità con tale principio, la
Cassazione ha affermato che la sicurezza non può essere subordinata a criteri di fattibilità
economica o produttiva: il datore di lavoro è tenuto a trovare le misure sufficienti a conseguire il fine
della protezione della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti in modo conforme al principio
direttivo costituzionale dell'art. 32 (anche qualora ciò vada a limitare il potere imprenditoriale
legittimato dall'art. 41 Cost).
Tra gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro contenuti nel d.lgs 626/1994, spicca quello di
procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (alla quale segue la
relazione di un documento indicante i criteri di valutazione utilizzati, sulle misure di prevenzione e di
protezione adottati e sul programma delle misure opportune <<per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza>>). D'altra parte gravano in capo ai singoli lavoratori obblighi di
cooperazione al miglior funzionamento delle misure di sicurezza.
Nell'assolvimento degli obblighi contenuti nel d.lgs 626/1994, il datore di lavoro si avvale di:
– un servizio di prevenzione e protezione da lui stesso organizzato all'interno dell'impresa;
– dell'attività del medico competente (che deve effettuare gli accertamenti preventivi e periodici
funzionali alla formulazione del giudizio di idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni;
– dal rappresentante per la sicurezza eletto dai lavoratori.
Sempre il d.lgs 626/1994 dispone che ogni lavoratore debba ricevere <<una formazione sufficiente
ed adeguata [..] con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni>> in
momenti specificamente rilevanti per la tutela della sua salute e sicurezza.
La violazione del dovere di garantire la sicurezza dei dipendenti si configura indipendentemente dal
fatto che la violazione integri gli estremi del reato (essendo violato il dovere di sicurezza nei confronti
dei dipendenti sia qualora siano omesse misure tassativamente previste dalla legge, sia quelle
esigibili nell'esecuzione del rapporto secondo regole di correttezza e buona fede): stante la natura
contrattuale dell'inadempimento, il lavoratore potrà far valere l'eccezione di inadempimento (ex art.
1460 c.c.) secondo cui ciascun contraente potrà rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro
non adempie la propria (salvo si tratti di eccezione in mala fede, o che l'inadempimento della
controparte sia di scarsa importanza). Il licenziamento posto in essere a seguito del rifiuto di
adempiere da parte del lavoratore è nullo per motivo illecito.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 71 di 105
Per quanto riguarda l'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligo di sicurezza, quest'ultimo
grava sul lavoratore che chiede il risarcimento del danno: qualora sia però provato tale
inadempimento (ai sensi dell'art. 1218 c.c. ) graverà sul datore di lavoro la prova che l'evento lesivo
dipenda da fatto a lui non imputabile.
Nel caso che venga rilevato concorso di colpa del lavoratore nell'aver dato causa all'evento, la
Cassazione ha affermato che la colpa del lavoratore subordinato può essere valutata per
determinare una riduzione della responsabilità penale degli altri soggetti che abbiano contribuito a
determinare l'infortunio ma non potrà esonerare il datore di lavoro, salvo nel caso in cui la condotta
del lavoratore si ponga come causa esclusiva dell'infortunio.
In ogni caso, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che <<il datore di lavoro, in caso di
violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile
dell'infortunio che ne sia conseguito, e non può invocare il concorso di colpa del lavoratore, perché
egli ha il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo, nonostante la sua imprudenza e
negligenza>>.
IL DANNO BIOLOGICO
Il combinato disposto dell'art. 32 Cost e dell'art. 2087 c.c. porta alla legittimità della richiesta di
risarcimento del danno biologico, che è inteso come il danno <<rappresentato dalle lesioni
all'integrità psicofisica, ossia alla salute della persona>>, che può riguardare <<ogni [..] genere di
lesioni dell'integrità corporale e mentale della persona>> (compreso il danno alla salute derivante
dallo stress da “super lavoro”, come espresso dalla Cassazione) .
L'art. 2087 c.c. può essere invocato per richiedere il risarcimento del danno biologico procurato
dall'attività criminosa di terzi, cui possono essere esposti lavoratori attivi in particolari settori: la
responsabilità del datore di lavoro si potrà affermare solo nel caso in cui non siano state assunte tutte
le cautele necessarie ad evitare possibili eventi dannosi prevedibili.
LA RETRIBUZIONE
Principale obbligazione gravante sul datore di lavoro, e parallelamente diritto primario del lavoratore
subordinato, è la retribuzione (che si distingue dal più generico corrispettivo previsto per il
contratto d'opera dall'art. 2222 c.c.) per la quale si usa il termine di salario in relazione alla
retribuzione degli operai, e stipendio con riguardo a quella di impiegati, quadri e dirigenti.
Le caratteristiche fondamentali dell'istituto (ed in particolare la determinazione dei suoi aspetti
quantitativi) sono rimessi all'autonomia privata (contrattazione collettiva, ed individuale solo con
funzione di integrazione migliorativa della prima), mentre la legislazione ordinaria si limita ad
intervenire solo su alcuni profili essenziali dell'istituto, relativi alle forme della retribuzione ed alle
modalità di versamento della stessa.
La Cassazione ha affermato che, <<qualora la disciplina del rapporto sia tale da escludere>> lo
scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, <<il rapporto non può essere definito come
rapporto di lavoro subordinato, per mancanza di causa tipica>>.
L'art. 36 Cost. stabilisce che <<il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza
libera e dignitosa>>; tale disposizione rimanda:
– al principio di proporzionalità, che porterebbe a pensare che il prezzo del fattore lavoro
risponda a criteri oggettivi di proporzionalità (individuati dai contratti collettivi, che hanno il compito
di fissare retribuzioni proporzionali alla qualità – valutabile in relazione alla qualifica del
lavoratore, ed in particolare al suo livello d'inquadramento – e quantità del lavoro – rapportabile
all'orario di lavoro), e non sia determinato semplicemente dalle soggettive valutazioni dei
contraenti); al principio di proporzionalità può essere, inoltre, collegata l'attribuzione di un
trattamento individuale aggiuntivo in ragione dei particolari meriti che il datore di lavoro intende
premiare (e qualora il datore di lavoro richiedesse indietro le somme pagate oltre la retribuzione
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 72 di 105
–
minima dovrà provare che tale corresponsione è frutto di un errore essenziale e riconoscibile
dall'altro contraente).
ed al principio di sufficienza (in forza del quale la retribuzione non dovrebbe scendere
comunque sotto un livello minimo – scostamento evidente dal nesso di corrispettività che lega le
prestazioni contrapposte nei contratti sinallagmatici).
Se in altri ordinamenti è stato fissato normativamente un salario minimo legale, in quello italiano pari
funzione è svolta dalla c.d. giurisprudenza sulla retribuzione sufficiente che ha indicato nelle aule
di giustizia (per quanto in termini molto generali) parametri minimi di retribuzione, spesso rifacendosi
a quei livelli retributivi correlate ai diversi livelli di inquadramento individuati dalla contrattazione
collettiva: in tal modo si è finito per determinare una specie di estensione erga omnes dell'ambito di
efficacia soggettiva dei contratti collettivi (sia pure limitatamente ai trattamenti economici), rendendoli
operanti anche rispetto a rapporti di lavoro di per sé non rientranti nella loro sfera applicativa (a
causa della mancata iscrizione del datore di lavoro all'associazione stipulante).
Se l'art. 2099 c.c. consentirebbe al giudice di intervenire per fissare la retribuzione soltanto <<in
mancanza [..] di accordo tra le parti>>, si è ritenuto di poter parificare all'ipotesi di contratto mancante
quella di contratto nullo per contrasto con la norma imperativa dell'art. 36 Cost.
Quando la retribuzione concordata individualmente sia corretta alla luce di parametri offerti dal
contratto collettivo di categoria più pertinente rispetto al caso concreto, non si potrà parlare di
estensione per via giudiziale della sfera di efficacia collettiva, in quanto tali parametri di riferimento
sono considerati come criteri orientativi suscettibili di correzioni qualora il giudice non li ritenga
corrispondenti nel caso concreto al precetto costituzionale.
Il giudice (nel caso di determinazione della “giusta retribuzione” in mancanza di adesione del
lavoratore al contratto collettivo) – nell'orientamento espresso dalla Cassazione – non potrà
determinare un importo inferiore ai minimi salariali fissati dalla contrattazione collettiva giustificata da
un generico richiamo alle condizioni del mercato del lavoro relative al luogo in cui la prestazione è
verificata; al più potrà rifarsi alla previsione contenuta in un contratto collettivo aziendale o locale,
anche se inferiore rispetto a quella portata dal contratto nazionale; ancora, potrà discostarsi dalla
previsione collettiva nazionale sulla base di dati statistici ufficiali (o generalmente riconosciuti) sul
potere di acquisto della moneta qualora in tale zona, qualora sia accertato il maggiore potere
d'acquisto rispetto alla media nazionale.
LA PARITA' DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVA
Sempre la Costituzione (nell'art. 37) si fa garante di parità retributiva per le lavoratrici nei confronti dei
lavoratori, e dei minori nei confronti dei lavoratori maggiorenni: la giurisprudenza ha svolto un ruolo
decisivo nel negare, invece, l'esistenza nel nostro ordinamento di un generale principio di parità di
trattamento.
Nonostante in una propria sentenza la Corte Costituzionale poteva sembrare aprirsi ad una simile
soluzione, la Cassazione ha interpretato la sentenza della Corte Costituzionale nel senso che il
principio generale di parità di retribuzioni a parità di mansioni non si configura in una norma
imperativa ma in una tendenza per cui, ferma restando la libertà di iniziativa economica privata, il
giudice sarà privo del potere sanzionatorio che gli è attribuito in presenza di norme imperative o di
clausole di ordine pubblico.
La successiva giurisprudenza – allineandosi all'orientamento della Cassazione – ha reputato il
giudizio di proporzionalità, imposto dalla norma costituzionale, circoscritto al singolo rapporto di
lavoro): conseguenza pratica di tale orientamento è che neppure l'esistenza di un contratto collettivo
garantisce ai lavoratori, a parità di mansioni svolte, parità di condizioni retributive.
Assicurato un minimo retributivo dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro potrà secondo
propri criteri di valutazione differenziare le retribuzioni effettive attribuendo in maniera selettiva
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 73 di 105
trattamenti di miglior favore.
Allo stesso modo non si potrà invocare, a sostegno di un principio di parità generale di trattamento
(del quale si potrà parlare solo con riferimento ai dipendenti nel settore pubblico), il divieto di
trattamenti economici collettivi discriminatori, previsto dallo Statuto, in quanto tale norma colpisce
quelle illegittime differenziazioni di trattamento motivate dalle ragioni che non possono essere poste
a base di un provvedimento datoriale (sindacali, politiche, religiose, ecc).
LE MODALITA' DELLA RETRIBUZIONE
L'art. 2099 la retribuzione dev'essere versata al lavoratore <<con le modalità e nei termini in uso nel
luogo in cui il lavoro viene eseguito>>: tale previsione codicistica è integrata dai contratti collettivi con
riguardo alle cadenze temporali di pagamento.
La retribuzione diretta è quella erogata periodicamente (normalmente su base mensile), con
puntuale corrispondenza con le singole prestazioni lavorative (corrisposta in ragione delle ore
effettivamente lavorate); retribuzione differita (rispetto alla quale emerge un legame con il rapporto
di lavoro in quanto tale) è una retribuzione per cui sono previste cadenze molto ampie (come per le
retribuzioni feriali o delle mensilità aggiuntive).
Per quanto riguarda le modalità, è obbligo per il datore di lavoro consegnare un prospetto paga
contenente quelle indicazioni che possono rendere più agevole il controllo sull'esattezza
dell'adempimento dell'obbligazione gravante sul datore di lavoro.
Per quanto riguarda la tipologia di retribuzioni, l'art. 2099 c.c. stabilisce una rilevante distinzione:
– la retribuzione a tempo (che assicura costanza e certezza di reddito) presuppone un
corrispettivo determinato in funzione di criteri di calcolo meramente basato sulla quantità di tempo
richiesta al lavoratore per lo svolgimento della prestazione;
– nella retribuzione a cottimo vi è un forte nesso tra retribuzione e rendimento (individuale o
collettivo, a seconda che si tenga conto della prestazione resa dal singolo o da un gruppo di
lavoratori), in quanto in tale sistema retributivo il corrispettivo non dipende dalla durata ma
dall'intensità dell'impegno del lavoratore nell'unità di tempo.
Nella prassi del lavoro subordinato, il cottimo puro ha spesso ceduto il passo a forme di cottimo a
tempo (cottimo misto, dalla duplice funzione di assicurare un minimo retributivo ai lavoratori, ed al
contempo incentivarli ad una maggiore produzione) nelle quali è fissata una parte di retribuzione
fissa (commisurata alla durata della prestazione) alla quale si aggiunge il guadagno di cottimo:
inoltre, spesso i contratti collettivi prevedono un minimo garantito di guadagno di cottimo, riducendo
ulteriormente la parte variabile della retribuzione.
Qualora non venga raggiunta la produzione del cottimo minimo (come affermato dalla Cassazione):
– se il minor rendimento dipende da cause non imputabili al lavoratore, quest'ultimo avrà diritto alla
retribuzione prevista per il minimo di cottimo;
– se il minor rendimento dipende dal suo volontario e scarso rendimento, il datore di lavoro può
ridurre unilateralmente la retribuzione in proporzione all'entità del minor rendimento.
Per quanto riguarda il cottimo integrale, nell'ambito del lavoro subordinato, è utilizzato solo nel
lavoro a domicilio (per ovvie ragioni legate all'impossibilità di controllare altrimenti la quantità di una
prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali dell'impresa); è invece vietato in qualsiasi forma con
riguardo all'apprendistato.
L'art. 2100 c.c. indica i casi in cui è obbligatorio ricorrere al sistema del cottimo (cioè qualora il
lavoratore sia vincolato <<in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, [..] all’osservanza di un
determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato
delle misurazioni dei tempi di lavorazione>>), ed affida alla contrattazione collettiva il compito di
stabilire quando essi concretamente ricorrano, nonché di fissare i criteri per la formazione delle tariffe
di cottimo.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 74 di 105
Il legislatore (con la l.135/1997) ha cercato di dare sostegno (escludendole dalla retribuzione
imponibile) a quelle forme di retribuzione variabile collegate a parametri di produttività e/o redditività
aziendale (determinate sulla base di indicatori tecnico-economici di diversa natura – fatturato, qualità
del prodotto, margine operativo lordo), attribuite alla collettività dei dipendenti subordinatamente al
raggiungimento degli obiettivi programmati.
Nonostante l'indicazione contenuta nell'art. 2099 (secondo cui <<il prestatore di lavoro può anche
essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con
prestazioni in natura>>) è da ritenersi che le altre forme retributive elencate nell'articolo possano
rappresentare solo una parte del compenso spettante al lavoratore, onde evitare il rischio di non
rispettare il parametro di sufficienza retributiva fissato dall'art. 36 Cost.
La più rilevante altra forma retributiva è la provvigione, che costituisce un compenso ragguagliato in
percentuale al valore degli affari conclusi e/o andati a buon fine; marginale rilievo hanno le
prestazioni in natura, salvo il caso del servizio di mensa ed i fringe benefits (altri benefici spettanti in
genere al personale di qualifica più elevata).
Infine ai sensi dell'art 2102 c.c. <<la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è
determinata in base agli utili netti dell’impresa>>: non costituisce invece forma retributiva l'azionariato
dei dipendenti (la cui funzione è soprattutto di coinvolgere i lavoratori nelle sorti dell'impresa>>.
IL PROSPETTO PAGA
Nel prospetto di paga (la busta-paga), vanno indicati quei componenti che vanno a formare la
consistenza della retribuzione totale:
– i minimi retributivi (minimi tabellari la correlati dai contratti collettivi alle diverse professionalità
raggruppate in livelli d'inquadramento);
– l'indennità di contingenza (un emolumento legato all'andamento del costo della vita);
– scatti d'anzianità (voce retributiva legata all'anzianità di servizio);
– altri emolumenti previsti dai contratti collettivi che concorrono a determinare la retribuzione
complessiva tra cui:
– superminimi (emolumenti che incrementano il libello retributivo standard – prevedibili
anche dagli accordi individuali);
– aumenti di merito (concessi ad personam su discrezione del datore di lavoro;
– maggiorazioni (percentuali di incremento della retribuzione oraria dovute in relazioni a
prestazioni giudicate di valore più elevate rispetto a quelle usuali – come avviene in
relazione al lavoro straordinario, a quello notturno, ed a quello svolto nelle ricorrenze
festive);
– indennità (riconoscimenti retributivi per prestazioni svolte in particolari condizioni di modo,
di tempo o di luogo – indennità di maneggio di denaro, indennità di turno, indennità di
sottosuolo) che fanno parte della retribuzione qualora non rappresentino rimborso spese.
Le componenti più rilevanti nella retribuzione indiretta sono riconoscibili nelle mensilità aggiuntive
(tredicesima e, qualora prevista, quattordicesima corrisposte nel periodo natalizio) ed il trattamento di
fine rapporto;
Anche premi di produzione e gratifiche di bilancio vengono corrisposte durante tale periodo.
IL CONCETTO DI ONNICOMPRENSIVITA' DELLA RETRIBUZIONE
Nel nostro ordinamento oggi la nozione di retribuzione imponibile a fini previdenziali è stata sostituita
da una nozione unitaria di reddito (rilevante sia a fini fiscali che contributivi); d'altra parte una vera
nozione di reddito non è deducibile né dall'art. 2099 c.c. né dall'art 36 Cost che vi fanno riferimento:
si parlerà quindi generalmente di retribuzione con riferimento al corrispettivo dell'attività lavorativa
subordinata.
La retribuzione si compone di una pluralità di elementi: la paga base (la normale retribuzione che
compensa la prestazione lavorativa, senza riguardo agli elementi accessori) alla quale si aggiungono
una serie di voci previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Per retribuzione globale si
intende l'insieme di tutti quegli emolumenti caratterizzati dalla ricorrenza e dalla continuità.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 75 di 105
Risulta però necessario dare una definizione di quale sia la retribuzione-parametro, intesa come
termine di riferimento per il calcolo di altre attribuzioni patrimoniali di natura retributiva: l'elaborazione
giurisprudenziale ha portato a delineare in passato il c.d. principio di onnicomprensività della
retribuzione, oggi abbandonato in favore della concezione (affermata dalla Cassazione) per cui è
dato all'autonomia collettiva (salvo specifiche disposizioni legali) lo stabilire le componenti della
retribuzione che rientrano nella base di calcolo di altri istituti (retributivi).
Nonostante quest'ultimo orientamento sia ampiamente consolidato, persistono incertezze e
divergenze riguardo a particolari questioni:
– in materia di retribuzione feriale un tradizionale indirizzo (ripreso recentemente dalla
Cassazione) va nel verso di assicurare l'erogazione di tutte le componenti della retribuzione
normalmente corrisposte;
– per quanto riguarda l'ipotesi di esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, si sono
fatte strada, in giurisprudenza, interpretazioni restrittive del principio di irriducibilità della
retribuzione del lavoratore, riguardo all'assegnazione di certe voci retributive accessorie
successivamente al cambiamento di mansione (e si è cercato a riguardo di distinguere fra
indennità intrinseche – inerenti alla professionalità del lavoratore – ed estrinseche);
– riguardo la base di calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario la giurisprudenza ha
ritenute legittime le clausole collettive che, pur circoscrivendo la base di computo, elevavano la
percentuale di maggiorazione rispetto a quella legale (assicurando vantaggio economico pari o
superiore per il lavoratore).
Va ricordato, infine, l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'uso personale di autovettura, concessa
dal datore di lavoro al lavoratore, in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa,
costituisce prestazione di natura retributiva (il cui valore deve rientrare nella base di calcolo del TFR).
GLI AUTOMATISMI RETRIBUTIVI
Automatismi retributivi, infine, sono quegli emolumenti la cui dinamica d'incremento dipende da fattori
automatico: l'indennità di contingenza (legata all'indice dei prezzi al consumo), lungamente utilizzata
nel nostro ordinamento, è stata soppressa nel 1992 in seguito ad un accordo tra governo e parti
sociali e, da allora, il compito di adeguare le retribuzioni all'andamento del costo della vita è stato
rimesso ai contratti collettivi nazionali (che a tal scopo vengono rinnovati ogni due anni); la vecchia
indennità di contingenza continua a comparire nelle buste-paga ma il relativo importo è rimasto
bloccato ai valori raggiunti nel 1992.
L'accordo inteconfederale del 1993 ha previsto l'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale,
destinata ad operare solo a fronte di ritardi nel rinnovo dei contratti collettivi (i misura pari al 30% del
tasso d'inflazione programmata dopo un ritardo di tre mesi nel rinnovo – elevata al 50% oltre il sesto
mese di ritardo.
Automatismi legati all'anzianità di servizio sono gli scatti di anzianità (normalmente di cadenza
biennale), prima previsti nell'area del pubblico impiego ed ora estesi dai contratti collettivi al settore
privato (prima agli impiegati e poi agli operai).
Il più rilevante emolumento legato all'anzianità di servizio è il TFR (trattamento di fine rapporto)
esteso a tutti i lavoratori con l'art. 2120 c.c. ; la Corte Costituzionale ne ha determinato la
corresponsione generalizzata <<in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro>>): a tutti gli effetti il
TFR ha natura giuridica (così come concordemente affermato da dottrina e giurisprudenza) di
retribuzione (per cui vigono le regole in materia di retribuzione, tra cui le norme sulla non
compensabilità dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro) rispetto alla prestazione resa nell'intero
arco del rapporto di lavoro; d'altra parte (come afferma la Cassazione) ha anche una funzione
previdenziale, in quanto la sua corresponsione alla cessazione del rapporto consente al lavoratore di
far fronte alle necessità del momento.
Nel dettaglio, la quota di accantonamento annuale si determina dividendo per 13,5 l'importo <<pari e
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 76 di 105
comunque non superiore>> a quello della retribuzione erogata al lavoratore in corso d'anno
(calcolata secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione per cui <<la retribuzione annua
[..] comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in
pendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto è corrisposto a
titolo di rimborso spese>> – salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, che può
intervenire nella definizione della base di calcolo della retribuzione annuale, precisando le voci che vi
rientrano); è stato inoltre previsto un meccanismo di adeguamento annuale per cui ogni anno si
dovrà rivalutare il TFR in misura corrispondente al 75% dell'indice ISTAT maggiorato dell'1,5%.
Per quanto riguarda l'inclusione nelle base di calcolo del TFR, la Cassazione ha affermato che
dev'essere inclusa l'indennità sostitutiva del preavviso (in quanto somma corrisposta in dipendenza
del rapporto di lavoro e per effetto di una vicenda attinente all'aspetto istituzionale di questo); per
quanto riguarda il lavoro straordinario, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza
(confermato dalla Cassazione): <<la computabilità del compenso per il lavoro straordinario ai fini
della determinazione del TFR presuppone la continuità di tale lavoro>>, per cui restano esclusi dal
computo <<i compensi per quelle prestazioni straordinarie a carattere saltuario o non continuativo>>.
E' stato infine istituito un Fondo di Garanzia, alimentato da contributi dei datori di lavoro, cui il datore
di lavoro può rivolgersi per ottenere il pagamento del TFR nelle situazioni di insolvenza del datore di
lavoro a fronte delle quali sia stata aperta una procedura consorsuale (o qualora i lavoratore abbia
inutilmente esperito la procedura di esecuzione forzata per il soddisfacimento del suo credito.
LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL TFR
E' possibile (ex art. 2120 c.c.) per il lavoratore (avente almeno 8 anni di anzianità di servizio)
richiedere l'anticipazione del TFR in costanza di rapporto di lavoro per far fronte a bisogni di
particolare rilievo sociale (spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, acquisto della prima
casa di abitazione per sé o per i figli – od ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi) in misura non
superiore al 70% di quello maturato alla data della richiesta; tale istituto è fruibile dai dipendenti entro
il limite del 4% degli stessi.
La Cassazione ha poi precisato che il diritto all'anticipazione del TFR presuppone una connessione
funzionale tra la richiesta di anticipo e le necessità del lavoratore: qualora l'acquisto della casa, ad
esempio, sia già avvenuto e si sia già perfezionato col pagamento del prezzo, la richiesta di
anticipazione non è più giustificata.
Ancora, per quanto riguarda il significato di “straordinarietà” degli interventi medici che giustificano la
richiesta di anticipazione, la Cassazione ha affermato che si deve trattare di <<terapia o intervento di
rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico>>, da sostenersi anche
presso struttura privata (previo riconoscimento di tale necessità da parte di struttura pubblica).
La riforma del 2006 ha sostanzialmente lasciato invariata la normativa dal punto di vista del
lavoratore: per le imprese con meno di 50 dipendenti, è data ai lavoratori la scelta se far accantonare
il proprio TFR in azienda (conservando per l'impresa la tradizionale funzione di autofinanziamento) o
destinarlo ad un fondo pensione gestito dall'INPS; per le imprese con più di 50 dipendenti, il fondo
sarà gestito in ogni caso al di fuori dell'azienda.
LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Temporanea sospensione dell'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa può avvenire per cause
attinenti alla sfera del lavoratore o pertinenti alla sfera dell'impresa. Nell'ambito delle prime si
distingue fra quelle che integrano fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione
determinata da ragioni di carattere biologico (infortunio, malattia, maternità ) od assolvimento di
obblighi giuridici (servizio militare) ed altre ipotesi dove la sospensione della prestazione consegue
ad un'iniziativa del lavoratore resa possibile da specifiche normative che la prevedono – come nel
caso dell'esercizio di diritti sindacali (es. di sciopero), od in fruizione dei congedi parentali o formativi.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 77 di 105
Per quanto riguarda invece le situazioni in cui il mancato svolgimento della prestazione dipende dal
godimento dei riposi previsti dall'ordinamento, nel qual caso si parla di pause (che non comportano
una sospensione del lavoro, ma piuttosto una modalità di svolgimento dello stesso).
Nell'ipotesi di sospensione (in senso tecnico) si verifica una deviazione dalla regola di corrispettività
propria dei contratti sinallagmatici, in quanto il datore di lavoro è tenuto ad assolvere (del tutto od in
parte) l'obbligo retributivo.
Il nostro ordinamento tutela (artt. 2110 e 2111 c.c.) la posizione del lavoratore qualora si verifichi
ipotesi di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione, garantendo:
– la conservazione del posto di lavoro durante al c.d. periodo di irrecedibilità (o periodo di
comporto) stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità;
– un trattamento economico (di natura previdenziale e/o retrivutiva);
– il diritto alla computabilità nell'anzianità di servizio dei periodi di assenza dal lavoro dovuta ad
ipotesi quali infortunio, malattia, maternità.
SOSPENSIONE PER INFORTUNI E MALATTIE
Infortuni e malattie si configurano come cause di sospensione solo qualora determino una condizione
di incapacità lavorativa: in tali casi è riconosciuto a tutti i lavoratori subordinati il diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un periodo di comporto, determinato dalla contrattazione
collettiva – che ha talvolta previsto il c.d. comporto per sommatoria, per cui la durata del periodo in
cui opera il diritto alla conservazione del posto di lavoro terrà conto delle eventuali più malattie
verificatesi in un certo arco di tempo.
La Cassazione ha affermato che <<vanno ricompresi nel periodo di comporto anche i giorni non
lavorativi che precedono e seguono le assenze per malattia, per operatività della presunzione logica
della continuità dell'evento morboso, e la conseguente indisponibilità del lavoratore in tali giorni>>,
salvo che il lavoratore non fornisca prova contraria.
L'art 2110 stabilisce che, <<in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge
o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al
prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi
speciali [..], dagli usi o secondo equità>>. La Cassazione ha affermato, in merito, che <<l'inesigibilità
della prestazione è, in caso di malattia del lavoratore, fondata sulla tutela di interessi
costituzionalmente rilevanti, la quale comporta, da un lato, la permanenza dell'obbligo retributivo e,
dall'altro, la prevalenza di tale condizione sull'interesse all'adempimento dell'obbligazione di
lavoro>>.
Per quanto concerne le garanzie di carattere economico, è rilevante la distinzione tra operai ed
impiegati:
– i primi hanno diritto a percepire un'indennità giornaliera (pari al 60% della retribuzione normale) di
carattere previdenziale, a partire dal quarto giorno dopo l'inizio dell'evento invalidante (da parte
dell'INPS), per un periodo massimo di 180gg nell'anno solare – mentre la contrattazione collettiva
ha fatto sì che i tre giorni di retribuzione non coperti dall'INPS gravino sul datore di lavoro;
– i secondi hanno diritto a continuare a percepire la retribuzione loro dovuta dal datore di lavoro
(inizialmente in misura integrale).
Ulteriore ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro legata alle condizioni fisiche dell'interessato
(per quanto non tali da determinare una situazione di vera e propria incapacità lavorativa), si verifica
quando un lavoratore ricorra ad un periodo di cure termali – al di fuori del periodo di ferie annuali
<<esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative>> (certificate da medico
specialista della competente struttura pubblica).
Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, il contenuto della certificazione medica
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 78 di 105
prodotta dal lavoratore a giustificazione dell'assenza per malattia è sindacabile dal giudice, sia con
riguardo alla verifica della gravità della malattia che dell'idoneità di quest'ultima a costituire
impedimento al lavoro: a tal proposito, la giurisprudenza ha elaborato il principio per cui <<la malattia
rilevante ai fine della sospensione del rapporto di lavoro non è una semplice e qualsiasi infermità del
lavoratore, ma è quella che comporta incapacità lavorativa in termini di “inesigibilità” della
prestazione specifica>>.
Altra importante elaborazione giurisprudenziale riguarda la nozione di malattia (rilevante ai sensi
dell'art. 2110 c.c. ) che va a comprendere non soltanto “l'evento morboso” ma anche la conseguente
convalescenza: <<ai fini della determinazione della durata della malattia, deve tenersi conto anche
delle terapie che si rendano indispensabili [..] perché possa pervenirsi alla completa guarigione del
lavoratore o alla stabilizzazione della parziale remissione della malattia>>.
LE VISITE DOMICILIARI DI CONTROLLO DELLA MALATTIA
Il legislatore è intervenuto (integrando le previsioni in materia contenute nello Statuto) provvedendo a
dettare regole assai severe in materia di visite mediche di controllo:
– è imposto l'obbligo di recapitare o trasmettere (a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento), entro 2 gg dal rilascio del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata
presunta della malattia al datore di lavoro;
– si sono inoltre rafforzate le strutture preposte ai controlli sullo stato di salute dei lavoratori, da
effettuarsi <<entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie
di reperibilità>>.
L'assenza ingiustificata del lavoratore durante le fasce orarie di reperibilità comporta la decadenza
<<dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni>> e – qualora il
lavoratore risulti nuovamente assente senza giustificato motivo alla seconda visita di controllo
(prevista dalla Corte Costituzionale allo scadere dei 10gg) – << nella misura della metà per l'ulteriore
periodo>>.
Inoltre, come affermato dalla Cassazione, è ininfluente ai fini della configurazione del comportamento
sanzionabile che il lavoratore assente alla visita di controllo fosse comunque effettivamente malato.
Sempre la Cassazione ha escluso che l'obbligo di reperibilità, che si riferisce alle assenze per
malattia, sia applicabile alle assenze dovute ad infortunio sul lavoro (per quanto l'art. 5 dello Statuto
legittimi il datore di lavoro a far controllare la sussistenza dell'impedimento al lavoro del lavoratore
infortunatosi in azienda).
La giurisprudenza ammette che il lavoratore, al fine di evitare la perdita del trattamento economico di
malattia, possa giustificare l'assenza dal proprio domicilio durante la visita di controllo: la Cassazione
individua tale giustificazione nell'esistenza di un “ragionevole impedimento” provato dal lavoratore,
che corrisponde ad una <<situazione sopravvenuta che comporti la necessità, assoluta ed
indifferibile, di allontanarsi dal luogo nel quale il controllo deve essere esercitato>>.
La giurisprudenza, inoltre, individua in capo al lavoratore un obbligo di cooperazione alla visita
domiciliare per cui, durante le fasce di reperibilità, egli mantenga un comportamento tale da
consentire al medico della struttura pubblica l'immediato accesso all'abitazione.
La Cassazione inoltre afferma che le disposizioni dell'art. 5 dello Statuto non impediscono che il
datore di lavoro utilizzi a fini probatori <<ogni risultanza di fatto – pur non risultante da accertamento
sanitario – atta a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a
determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza>>; alle indagini
relative all'accertamento dell'eventuale svolgimento da parte del lavoratore in malattia di attività
incompatibili con il suo stato non si può attribuire il carattere di indagini sanitari (che dovrebbero
svolgersi secondo le modalità previste dallo statuto) solo in ragione del fatto che da queste emergano
circostante relative allo stato di salute del dipendente.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 79 di 105
Infine, il d.lgs 81/2008 prevede la figura del “medico competente”, che può essere anche un
dipendente del datore di lavoro: ciò non contrasta con la normativa a riguardo di indagini sanitarie, in
quanto tale figura è adibita ad attestare la sola idoneità a specifiche mansioni.
ALTRE IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Altre ipotesi di sospensione del rapporto (ex. art. 2110 c.c.) riguardano la maternità (gravidanza e
puerperio) della lavoratrice.
In favore delle lavoratrici opera (ex. d.lgs. 151/2001) il divieto di adibizione a qualsiasi attività
lavorativa: tale periodo di congedo di maternità, (astensione obbligatoria) della durata di 5 mesi, si
ripartisce nei 2 mesi precedenti la presunta data del parto ed i 3 mesi successivi (o nel mese
precedente e nei quattro successivi, a scelta della gestante avvalorata da adeguate certificazioni
mediche che ne attestino la non nocività per la stessa e per il nascituro): la fruizione del congedo di
maternità dà diritto (oltre che alla conservazione del posto di lavoro) a rientrare nella stessa unità
produttiva (e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino), alle stesse mansioni
(od equivalenti).
Durante il congedo di maternità, alle lavoratrici è dovuta un'indennità giornaliera di carattere
previdenziale (a carico dell'ente pubblico gestore della relativa assicurazione obbligatoria, pari
all'80% della retribuzione – salvo eventuali integrazioni versate dai datori di lavoro in forza di
previsioni dei contratti collettivi).
Ulteriore ipotesi di sospensione (prevista e regolamentata oggi dal d.lgs. 151/2001) del rapporto può
verificarsi in relazione alle esigenze di cura di un figlio ammalato in tenerà età: ad entrambi i
genitori è alternativamente riconosciuto (dietro prestazione di idonea certificazione) il diritto ad
astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età non superiore ai 3 anni; nella fascia tra i 3
e gli 8 anni, tale diritto potrà essere esercitato nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun
genitore.
Le cause di sospensione del lavoro non coincidono necessariamente con ipotesi di sopravvenuta
impossibilità della prestazione; a riguardo la l.53/2000 prevede
– congedi familiari retribuiti in caso di decesso o documentata infermità del coniuge, parente
entro il secondo grado o convivente, nella misura di 3 giorni l'anno;
– congedi familiari non retribuiti per gravi e documentati motivi familiari, di durata non superiore
a due anni – durante i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (nel
rispetto del divieto di <<svolgere alcun tipo di attività lavorativa>>);
– congedi per la formazione, di cui possono avvalersi lavoratori con almeno cinque anni di
anzianità di servizio, per periodo non superiore ad 11 mesi complessivi nell'arco dell'intera vita
lavorativa – durante i quali si ha il solo diritto alla conservazione del posto, ed al più a chiedere
l'anticipazione del TFR.
Infine l'art. 53 Cost. garantisce a <<chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive>> il <<diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro>>.
LA PARIFICAZIONE DEI RUOLI GENITORIALI NELLA DISCIPLINA DI PERMESSI E CONGEDI
Adeguandosi alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (che mirava al superamento della
tradizionale <<concezione di una rigida distinzione dei ruoli>> familiari ed alla tutela di <<un
equilibrato sviluppo della personalità del bambino>>, che <<esige spesso l'assistenza da parte di
entrambe le figure genitoriali anche per aspetti di carattere affettivo e relazionale>>), il legislatore ha
esteso ai padri lavoratori la disciplina dei periodi di sospensione previsti per la donna lavoratrice in
funzione del proprio ruolo familiare (anche qualora quest'ultima non sia lavoratrice dipendente).
E' stato stabilito che, in caso di morte o di grave infermità della madre, il padre lavoratore ha diritto di
astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità successivo al parto (o per la parte
residua che sarebbe spettata alla lavoratrice): tale congedo di paternità è sottoposto alla medesima
disciplina applicabile al congedo di maternità.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 80 di 105
E' stato, infine, riconosciuto ad entrambi i genitori la possibilità di fruire di un congedo parentale, nei
primi otto anni di vita di ogni figlio, per un periodo massimo complessivo di 10 mesi: nel rispetto di
tale limite massimo, ognuno dei due genitori ha diritto ad un congedo parentale della durata di sei
mesi (frazionati o continuativi).
Durante tale congedo, è prevista un'indennità previdenziale pari al 30% della retribuzione per un
periodo massimo complessivo (tra i genitori) di 6 mesi, a condizione che sia goduto entro il terzo
anno di vita del bambino), mentre per l'ulteriore periodo il diritto a tale indennità è previsto solo per
quelle famiglie che non superino un determinato reddito. Per sopperire all'esiguità della tutela in
questione, è stato previsto che in relazione alle spese da sostenere durante i periodi di congedo
parentale possa essere richiesta l'anticipazione del TFR.
La disciplina dei riposi per allattamento è stata svincolata dall'originaria motivazione di carattere
strettamente biologico (e riformulata in senso paritario): le lavoratrici madri (od – in alternativa – il
padre, qualora la madre sia impossibilitata o non intenda avvalersi di tale diritto), durante il primo
anno di vita del figlio, hanno diritto a due periodi di riposo di un'ora ciascuno, da considerarsi come
attività lavorativa, durante i quali le interessate possono allontanarsi dal luogo di lavoro.
LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Le regole relative alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG – inizialmente introdotta dalla
contrattazione collettiva in favore degli operai del settore industriale) si configurano come disciplina di
diritto speciale rispetto alle regole altrimenti applicabili al rapporto in aderenza al diritto comune:
all'iniziale obiettivo di garanzia di una continuità di reddito dei lavoratori, si sono aggiunti quelli di
salvaguardare i livelli occupazionali, nonché di consentire all'impresa di affrontare una situazione di
difficoltà a costi contenuti senza dover rinunciare alle proprie maestranze (evitando di disperdere il
proprio capitale umano) – anche se si è cercato di ricondurre il sistema della CIG alle sue iniziali
funzionalità iniziali.
I riferimenti essenziali in materia di CIG si rintracciano nella l.164/1975 e nella l.223/1991.
Premesso che il ricorso alla CIG si giustifica non soltanto quando i lavoratori interessati siano sospesi
dal lavoro, ma anche quando la sospensione sia solo parziale; si distingue a proposito:
– integrazione salariale ordinaria ammessa a fronte di:
– situazioni aziendali <<dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli
operai>>;
– crisi temporanee di mercato;
– integrazione salariale straordinaria ammessa a fronte di:
– ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;
– specifici casi di crisi aziendale che presentino <<particolare rilevanza sociale in relazione
alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva>>;
– soggettamento dell'impresa ad una procedura consorsuale, purché non sia stata disposta
la cessazione dell'attività aziendale.
Per quanto concerne il campo d'applicazione: dal punto di vista soggettivo, il trattamento di CIG
ordinaria, rimasto a lungo riservato agli operai, può essere fruito anche da impiegati e quadri. Dal
punto di vista oggettivo possono avere accesso soltanto le imprese che, inclusi ne computo anche gli
apprendisti, <<abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la
data di presentazione della richiesta>>; in generale, se l'intervento ordinario resta fondamentale
prerogativa del settore industriale, quello straordinario si è progressivamente esteso a diverse altre
realtà produttive
Possibilità di accedere alle CIG è stata riconosciuta alle cooperative di produzione e lavoro, alle
imprese commerciali con più di 200 dipendenti, ed alle imprese artigiane sottoposte ad <<influsso
gestionale prevalente>> da parte di impresa che abbia sospeso o ridotto l'attività produttiva e sia
stata ammessa al trattamento di integrazione salariale straordinaria (nonché alle imprese di trasporto
aereo).
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 81 di 105
LA PROCEDURA PER IL RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Il ricorso alla CIG presuppone svolgimento di una procedura articolata in una fase sindacale ed una
amministrativa:
– nella procedura di consultazione sindacale, sarà necessario dare preventiva comunicazione alle
rappresentanze sindacali, presentando il programma che l'impresa intende attuare – programma
che sarà oggetto di un esame congiunto con i sindacati;
– data esecuzione agli adempimenti previsti nella procedura di consultazione si potrà dare avvio
alla fase di amministrativa della procedura (a livello locale per la CIG ordinaria – presso la sede
provinciale dell'INPS, che accoglierà la domanda in forza di una deliberazione assunta da una
commissione provinciale a composizione tripartita – , presso il ministero del lavoro per la CIG
straordinaria – che deciderà dell'ammissione della domanda con proprio decreto);
Con riguardo alla durata del trattamento d'integrazione:
– l'integrazione salariale ordinaria può essere concessa per un periodo massimo di tre mesi
continuativi (eccezionalmente prorogabile fino ad un massimo complessivo di 12 mesi);
– l'integrazione salariale straordinaria ha limiti di durata variabile in relazione alle diverse cause che
la giustificano:
– per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, l'integrazione può avere durata non
superiore a 2 anni (prorogabile annualmente – per ragioni tecniche dovute ad una
particolare complessità dei programmi – di ulteriori 24 mesi).
– nel caso di crisi aziendale non può eccedere i 12 mesi (con ulteriori limiti a riguardo di
nuove erogazioni per la medesima causale);
– nel caso di imprese assoggettate a procedure consorsuali, è previsto un limite di 12 mesi,
ulteriormente prorogabili di un ulteriore semestre.
E' stato inoltre previsto un limite cumulativo, per cui ciascuna attività produttiva, i trattamenti
straordinari di integrazione salariale non possono avere durata complessiva superiore a 36 mesi in 5
anni (salvo per eccezioni previste con decreto del Ministero del Lavoro).
LE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA CIG
All'obiettivo di contenere i trattamenti di integrazione salariale concorrono anche le modalità di
finanziamento della Cassa: la CIG ordinaria è finanziata da un contributo a carico delle imprese (in
percentuale delle retribuzioni versate ai rispettivi dipendenti); la CIG straordinaria è finanziata a
carico del bilancio dello Stato. Per entrambe le casse è previsto un contributo addizionale a carico
delle imprese che ricorrano agli interventi di integrazione salariale, calcolato in misura percentuale
all'integrazione salariale corrisposta (raddoppiato nel caso in cui l'impresa usufruisca di proroghe del
trattamento di CIG straordinaria).
E inoltre prevista la subordinazione dell'<<ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione
salariale straordinaria [..] al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno
novanta giorni alla data della richiesta del trattamento>>.
Quanto all'entità del trattamento d'integrazione salariale, esso è ragguagliato all'80% della
retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate (sino al limite di 40 ore settimanali), ed
ulteriormente limitato da ulteriori massimali funzionali al contenimento delle prestazioni assicurate
dalla Cassa.
REQUISITI PER LA SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La Cassazione ha riaffermato l'orientamento (già presente in giurisprudenza) per cui <<solo a seguito
del provvedimento di ammissione alla CIGs il datore di lavoro acquista la facoltà di sospendere
unilateralmente i rapporti di lavoro dei dipendenti ammessi all'integrazione salariale>>, mentre
<<nella fase anteriore al provvedimento amministrativo il rapporto continua ad essere retto dal diritto
comune>>.
Tale provvedimento, <<ha natura costitutiva: [..] solo a seguito di esso sorgono il rapporto
previdenziale e le relative posizioni soggettive, consistenti nel diritto del lavoratore alla prestazione
costituita dall'integrazione salariale e nel diritto del datore di lavoro ad ottenere dall'INPS il rimborso
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 82 di 105
delle somme da esso [..] versate ai suoi dipendenti non più a titolo di retribuzione ma di integrazione
salariale>>.
Nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio alcuni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di
ammissione al trattamento di cassa integrazione <<il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti
del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una
causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non
imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa
gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva>>.
LA SCELTA DEI LAVORATORI DA PORRE IN CASSA INTEGRAZIONE
Con riguardo ai criteri di scelta dei lavoratori da porre in Cassa Integrazione, si può considerare
consolidata l'opinione che le scelte dell'imprenditore siano vincolate essenzialmente soltanto al
rispetto dei divieti di discriminazione e delle regole di correttezza e buona fede, e tali <<criteri di
individuazione dei lavoratori da sospendere [..] devono formare oggetto delle comunicazioni e
dell'esame congiunto>>.
In giurisprudenza si è affermata l'opinione per cui la mancata comunicazione di tali criteri comporti
illegittimità del provvedimento amministrativo di ammissione al trattamento di integrazione salariale,
con conseguenza che, in tali casi, il datore di lavoro <<sarà tenuto a corrispondere la retribuzione
con effetto ex tunc>>).
La l.223/1991 ha cercato di favorire, inoltre, l'adozione di criteri di rotazione (tra i lavoratori che
svolgono medesime mansioni nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni) – che non è però
configurabile come obbligo, essendo sufficiente indicare le ragioni tecnico-organizzative per cui
l'impresa non ritiene di poter adottare tali meccanismi: nel caso il ministero del lavoro ritenga
infondati i motivi promuoverà un accordo con le parti, e nel caso quest'ultimo risulti infruttuoso,
stabilirà con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione (che l'impresa potrà evitare
optando per il pagamento in misura doppia del contributo addizionale per ogni lavoratore sospeso).
Nel caso che la rotazione sia stata raggiunta tramite accordo collettivo, è possibile che quest'ultimo
contenga clausole di rientro (che consentono rientro in servizio da parte dei lavoratori coinvolti) che
originano un vero e propri diritto soggettivo che, nel caso in cui venga leso, legittima i lavoratori ad
una richiesta di risarcimento dei danni.
ULTERIORI PROFILI GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVI DELLA DISCIPLINA DELLA CIG
Infine, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale, è da ritenersi che il collocamento dei lavoratori in
CIG consegua all'esercizio di un potere unilaterale dell'imprenditore (esercitabile solo dopo aver
esperito la relativa procedura): non è però l'imprenditore ad essere legittimato a sospendere i rapporti
di lavoro dall'esistenza di una causa integrabile, che sarà al più oggetto di valutazione dell'autorità
amministrativa, il cui provvedimento ha natura costitutiva del potere di sospensione dei rapporti di
lavoro; prima dell'emanazione del provvedimento amministrativo di ammissione all'integrazione
salariale, il rapporto di lavoro continua ad essere retto dal diritto comune ed, in particolare,
l'obbligazione retributiva resterà inalterata (nonostante l'eventuale già operante sospensione
dell'attività produttiva).
E' stato inoltre espressamente previsto che, nel caso in cui l'imprenditore ometta o ritardi la richiesta
di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria) e da ciò derivi la perdita (totale o parziale) del
trattamento per i lavoratori, sarà l'imprenditore ad essere tenuto a corrispondere ai lavoratori una
somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
IL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
Il contratto di solidarietà è uno strumento previsto dal nostro ordinamento per fronteggiare
situazioni di eccedenza di personale: onde evitare che l'impresa proceda ad un licenziamento
collettivo, è prevista la possibilità di stipulare in contratto collettivo aziendale nella quale venga
stabilita una certa riduzione dell'orario di lavoro dei singoli lavoratori (ripartendo così la quantità di
lavoro disponibile fra un numero più ampio di lavoratori). Onde rendere meno gravosa la solidarietà
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 83 di 105
tra lavoratori, è stata prevista un'integrazione salariale da parte della CIG (con concessione del
Ministero del Lavoro per una durata massima di 48 mesi) in misura al 60% della retribuzione perduta
a seguito della riduzione d'orario (senza l'applicazione di ulteriori massimali).
Onde stimolare la propensione delle imprese alla stipula di un contratto di solidarietà – a patto che la
riduzione dell'orario sia concordata in misura superiore al 20% – è stato riconosciuta alle imprese
una consistente riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale, per una durata massima
di 24 mesi.
In linea teorica è previsto che un simile meccanismo venga utilizzato onde incrementare i livelli
occupazionali mediante l'assunzione, contestuale alla riduzione di orario, di nuovo personale con
contratto a tempo indeterminato.
IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Per i contratti di lavoro subordinato opera la regola (prevista dell'art. 2558 c.c.) per cui <<l'acquirente
dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano
carattere personale>>, con l'importante differenza che per tali rapporti la norma opera
imperativamente, senza possibilità di pattuizione contraria.
Se inizialmente tale principio rispondeva alle sole esigenze dell'alienante (di conseguire il massimo
ricavato possibile dalla cessione della propria attività economica, trasferendola nella sua integrità) e
del cessionario (di acquisire un'impresa in grado di operare nel mercato nel pieno delle sue
potenzialità), esso ha assunto funzione di tutela della continuità d'occupazione dei lavoratori –
essendo venuta meno la libertà di recesso dal contratto di lavoro, condizionata invece dalla
sussistenza di un giustificato motivo, che comunque non potrà essere il mero trasferimento
dell'azienda.
LA QUALIFICAZIONE DEL TRASFERIMENTO D'AZIENDA
La nozione di trasferimento d'azienda ha subito, nel corso del tempo, un graduale allargamento ad
opera principalmente delle numerose sentenze della Corte di Giustizia: la disciplina del trasferimento
di azienda è stata così progressivamente estesa ogni qual volta il trasferimento abbia ad oggetto un
insieme di mezzi organizzati che consentano l'esercizio di un'attività economica finalizzata al
perseguimento di un determinato obiettivo, e che l'entità in questione conservi nel trasferimento la
propria identità.
Orientamento consolidato è quello per cui alla qualificazione di entità economica organizzata si può
pervenire dall'analisi di una serie di elementi (da valutare complessivamente) tra cui:
– il tipo di impresa o stabilimento in questione;
– la cessione o meno di elementi materiali (edifici e beni mobili);
– il valore degli elementi immateriali;
– la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore;
– il trasferimento o meno della clientela;
– il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione;
– la durata di un'eventuale sospensione della attività.
Tale entità economica (come affermato dalla Corte di Giustizia) conserverà la propria identità anche
al di là del trasferimento qualora il nuovo imprenditore, nel proseguire l'attività stessa, riassuma una
parte essenziale (in termini di numero e competenza) del personale specificamente destinato dal
predecessore a tali compiti: in tal ipotesi il nuovo imprenditore acquisisce l'insieme organizzato di
elementi che gli consentirà il proseguimento delle attività dell'impresa cedente; al contrario la mera
circostanza che i servizi prestati dal precedente e dal nuovo appaltatore siano analoghi non consente
di concludere nel senso che sussista ipotesi di trasferimento di un'entità economica.
Riguardo all'applicabilità delle direttive comunitarie sul trasferimento d'azienda, secondo la Corte di
Giustizia, è irrilevante il mezzo giuridico con il quale si realizza il trasferimento; ed a tal proposito la
stessa esistenza di un legame contrattuale tra cedente e cessionario (per quanto possa costituire
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 84 di 105
indizio a riguardo) non riveste importanza determinante.
Proprio nel solco delle direttive comunitarie in merito (e nelle indicazioni della Corte di Giustizia), così
come modificato dal d.lgs 18/2001, l'art. 2112 c.c. prevede che le tutele previste in favore dei
lavoratori riguardo al trasferimento d'azienda siano applicabili, oltre all'ovvio caso di vendita
dell'impresa, a <<qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il
mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla
tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi
l’usufrutto o l’affitto d’azienda>>.
Tale definizione è ampiamente comprensiva delle più svariate ipotesi attraverso cui si può dare luogo
a trasferimento d'azienda, tra cui anche quella di vendita di un ramo d'azienda: come stabilito dal
d.lgs. 276/2003, le regole in materia di trasferimento d'azienda <<si applicano altresì al trasferimento
di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo
trasferimento>>.
La giurisprudenza, in passato, non si era mostrata concorde riguardo al fatto che la qualificazione del
complesso di beni ceduto come ramo d'azienda fosse possibile anche qualora questo risultasse solo
potenzialmente autonomo (e quindi dotato di risorse umane e materiali idonee, nel complesso, a
continuare la propria attività – pur se prima del trasferimento questa non fosse compiutamente
indipendente presso il cedente) o se, invece, fosse necessario per tale qualifica che il ramo d'azienda
fosse obiettivamente preesistente (ove scongiurare che venga creata artificiosamente
dall'imprenditore proprio al momento del trasferimento, proprio per qualificare lo stesso come
trasferimento di ramo d'azienda): la Cassazione (in sintonia con la riforma dell'art. 2112 c.c. introdotta
dal d.lgs. 18/2001) ha risolto la questione nell'affermare che il ramo d'azienda <<per essere tale deve
avere una sua autonomia funzionale, nel senso che deve presentarsi come una sorta di piccola
azienda in grado di funzionare in modo autonomo e non rappresenti, al contrario, il prodotto dello
smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro>>.
Un ultimo intervento normativo (con le modifiche apportate all'art. 2112 dal d.lgs. 276/2003) ha infine
cancellato il requisito, prima esplicitamente espresso, della preesistenza del ramo d'azienda ceduto.
Qualora sia identificata cessione del ramo d'azienda, sarà infine necessario individuare quali
lavoratori afferiscano al ramo oggetto del trasferimento.
Secondo la giurisprudenza fin ora espressasi in merito, l'afferenza di un dipendente ad un ramo
cdeduto può essere determinata in base all'analisi degli specifici compiti svolti, in modo da verificare
se la sua attività sia prevalentemente eseguita a favore di un certo settore o linea produttiva.
TUTELA INDIVIDUALE NEL TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Per quanto riguarda la tutela riconosciuta dall'ordinamento in ambito individuale <<il rapporto di
lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano>>: da ciò
consegue che per il lavoratore è come se il trasferimento non fosse avvenuto.
Il trasferimento (come ribadito dalla Cassazione) è automatico ex lege, per cui non è richiesto il
consenso dei lavoratori, fatto salvo per questi ultimi il diritto di rassegnare le dimissioni in tempo utile
(e comunque anche successivamente, con diritto all'indennità di mancato preavviso, qualora le loro
condizioni di lavoro subiscano <<sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento
d'azienda>>, modifica che quindi abbia rilevanza tale da incidere pesantemente sulla condizione
dell'interessato – per quanto legittimamente effettuata dal datore di lavoro).
L'imprenditore cessionario avrà obbligo di continuare ad applicare lo stesso trattamento economico
previsto dai contratti collettivi (di qualsiasi livello) applicati dall'imprenditore cedente fino alla loro
scadenza, salvo che ad essi si sostituiscano <<altri contratti collettivi applicabili all'impresa del
cessionario>> del medesimo livello (per cui il contratto collettivo nazionale applicato dal cessionario
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 85 di 105
non potrà sostituire quello aziendale applicato dal cedente, sostituibile solo da un nuovo contratto
collettivo aziendale).
Infine, è minoritaria quella giurisprudenza che riconosce il diritto del lavoratore ad opporsi al
trasferimento, rifacendosi al Codice Civile negli artt. 1406 (che permette la cessione del contratto
solo qualora vi sia il consenso del contraente ceduto) e 2558 (che dispone che l'acquirente subentra
al cedente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, salvo quelli che abbiano carattere
personale): qualora il lavoratore esercitasse la facoltà di rimanere alle dipendenze del cedente, in
ogni caso, si esporrebbe al rischio di essere giustificato per giustificato motivo oggettivo qualora se
ne verifichino i presupposti (es. il venir meno della prestazione cui era addetto, soppressione del
posto ed impossibilità di ricollocazione).
TUTELA COLLETTIVA NEL TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Sul piano collettivo, il d.lgs 18/2001 impone (anche qualora nel trasferimento sia coinvolto un ente
pubblico) lo svolgimento di una procedura d'informazione e consultazione con i rappresentanti dei
lavoratori, preventiva rispetto all'attuazione del trasferimento: qualora si intendo effettuare
trasferimento di azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori, cedente e
cessionario dovranno informare (<<almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui
deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente>>) per
iscritto le rispettive rappresentanze sindacali aziendali ed i sindacati di categoria; a tale informazione
potrà far seguito un esame congiunto su richiesta delle rappresentanze sindacali (da concludersi
entro 10 giorni dal suo inizio).
Mancato rispetto di tali obblighi procedurali, da parte di cedente o cessionario, costituisce condotta
antisindacale (controverso però se la rimozione giudiziale degli effetti debba riguardare solo le
misure assunte nei confronti dei dipendenti, come affermato recentemente dalla Cassazione, o possa
spingersi fino alla dichiarazione di nullità del negozio traslativo).
Allo scopo di rendere meno onerosa l'operazione di trasferimento è stata prevista una disciplina
derogatoria applicabile alle imprese sottoposte a procedure consorsuali, qualora la continuazione
dell'attività non sia stata disposta o cessata: al trasferimento di tali imprese non si applica il principio
del mantenimento dei diritti qualora si sia raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali circa
il mantenimento (anche parziale) dell'occupazione; tale accordo <<può altresì prevedere che il
trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o
in parte, alle dipendenze dell'alienante>> (in tal caso, in favore di tali dipendenti è previsto diritto di
precedenza qualora il cessionario effettui altre assunzioni entro un anno dala data del trasferimento,
ferma restando l'inapplicabilità nei loro confronti).
L'APPALTO
I processi organizzativi delle imprese possono comportare che determinate attività siano svolte
ricorrendo alle prestazioni di lavoratori dipendenti da altri imprenditori, sia ricorrendo allo strumento
della somministrazione di manodopera, sia utilizzando il più tradizionale strumento dell'appalto.
Il d.lgs. 276/20003 ha dettato nuova disciplina in materia di appalti, che non prevede regole di parità
di trattamento in favore dei dipendenti delle imprese appaltatrici (salvo per ipotesi di appaltatore non
di nazionalità italiana), come invece avviene nel caso di somministrazione di lavoro (effettuabile solo
da soggetti autorizzati) – la norma infatti sottolinea i tratti differenziali fra somministrazione ed appalto
nell'espressione per cui <<il contratto di appalto [..] si distingue dalla somministrazione di lavoro per
l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore [..] nonché per l'assunzione, da parte
del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa>>.
Il committente <<è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti>>.
Trascorso tale termine, sarà aperta la possibilità di esercitare la c.d. azione diretta di rivalsa (ex.
1676 c.c.) per cui dipendenti ed appaltatore possono chiamare in giudizio il committente <<per
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 86 di 105
conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso
l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda>>.
Analogamente a quanto avviene riguardo alle ipotesi di somministrazione irregolare e distacco contra
legem, nel caso di appalto privo dei requisiti legali (appalto irregolare) è previsto che il lavoratore
interessato possa ottenere, per via giudiziale, <<la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze>> nei confronti del committente.
La norma per cui <<l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un
nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del
contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda>>, si presta ad aggirare gli obblighi di
adeguamento alla direttiva comunitaria in materia di trasferimento dell'impresa, interpretata dalla
Corte di Giustizia nel senso di far rientrare nella sfera operativa della disciplina anche l'ipotesi di
successione nella titolarità di un appalto di servizi, ancorché non presupponga legame contrattuale
diretto fra vecchio e nuovo imprenditore.
L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La cessazione del contratto di lavoro può dipendere (secondo le regole generali dettate dall'art. 1372
c.c.) dal mutuo consenso delle parti, fermo restando che tale risoluzione consensuale è affrontata
con prudente diffidenza dalla giurisprudenza – che cerca di accertare con rigore l'effettiva volontà
delle parti, in particolare quella del lavoratore (senza accontentarsi di generici comportamenti
concludenti od acquiescenza di quest'ultimo) – potendosi pervenire ad una dichiarazione di nullità del
negozio estintivo ove esso risulti concluso in frode alla legge.
Riguardo all'impossibilità sopravvenuta della prestazione, essa può dipendere sia da eventi che
riguardano la sfera del lavoratore che da eventi ricadenti nella sfera dell'impresa: le ipotesi previste
dal diritto comune, invero, tendono ormai ad essere riportate dalla giurisprudenza nell'ambito del
giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
L'estinzione del rapporto di lavoro può verificarsi anche per morte del lavoratore (ferme restando
alcune conseguenze patrimoniali a carico del datore di lavoro), mentre il rapporto non viene ad
estinguersi nel caso di morte del datore di lavoro (salvo quando l'intuitus personae rivesta un rilievo
assorbente).
In giurisprudenza si è affermato (da ultimo con una recente sentenza della Cassazione) il principio
per il quale all'autonomia privata (individuale e collettiva) <<non è consentito di regolare la disciplina
del rapporto di lavoro prevedendo cause estintive del rapporto a tempo indeterminato ulteriori rispetto
a quelle contemplate dal codice civile e dalle leggi speciali>>, che si tradurrebbero inevitabilmente in
un aggiramento dei vincoli al potere di licenziamento fissati dall'ordinamento.
LE DIMISSIONI
Mentre con riguardo al licenziamento da parte del datore di lavoro si è progressivamente sviluppata
una disciplina speciale, per quanto riguarda le dimissioni del lavoratore risulta applicabile la
disciplina del recesso unilaterale (previsto già dall'art 1373 c.c. – strumento tipico di diritto comune
attraverso cui si pongono fine agli effetti di contratti stipulati a tempo indeterminato).
Tale diritto potestativo si configura anche come atto unilaterale recettizio (per cui i suoi effetti si
producono solo dal momento in cui l'altra parte ne viene a conoscenza), non sottoposto ad oneri
formali (come affermato Cassazione, le dimissioni costituiscono un atto a forma libera – salvo che
per esse non sia stata convenzionalmente pattuita la forma scritta ad substantiam) e svincolato da
ragioni giustificatrici.
In generale, in ogni caso, onde evitare che dietro le dimissioni si celi un licenziamento, mascherato
onde aggirarne la propria disciplina specifica, in caso di interruzione di fatto del rapporto l'indagine
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 87 di 105
del giudice di merito dovrà accertare che l'esatto soggetto da cui promana l'atto di risoluzione del
rapporto sia il lavoratore – attraverso l'interpretazione dell'atto di recesso e la valutazione dei
comportamenti in concreto osservati dal lavoratore.
Per quanto riguarda il caso delle “dimissioni in bianco” fatte sottoscrivere al dipendente al momento
dell'assunzione o durante lo svolgimento del rapporto e successivamente completate dal datore di
lavoro, la giurisprudenza ha qualificato la fattispecie come licenziamento nullo ed inefficace, in
quanto intimato senza il rispetto delle forme imposte dalla legge: rappresenta infatti non una
consapevole autodeterminazione del dipendente, bensì denota inequivocabilmente la volontà del
datore di lavoro di estromettere il lavoratore dall'azienda.
Come ogni atto negoziale privato, anch'esso risulta annullabile per vizi del consenso (qualora ad
esempio siano derivanti da pressioni psicologiche): come affermato dalla Cassazione <<la rinuncia al
proprio posto di lavoro [..] deve derivare sempre da una sua libera valutazione>> non <<condizionata
da comportamenti del datore di lavoro>>.
Qualora il lavoratore voglia far valere in giudizio l'invalidità del negozio delle dimissioni, spetterà a lui
l'onere della prova dell'esistenza di vizi (ed in particolare di violenza morale esercitata dal proprio
datore di lavoro): il giudice, sulla base del materiale probatorio, dovrà indagare adeguatamente sulla
sussistenza o meno di un comportamento intimidatorio posto in essere da datore di lavoro per
indurre il dipendente a firmare le dimissioni (e del nesso di causalità tra tale violenza e le dimissioni),
ed in particolare, saranno valutate le modalità fattuali del comportamento tenuto dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, gli effetti della pronuncia di invalidità del negozio viziato, la
giurisprudenza non è concorde riguardo agli effetti: secondo alcuni, oltre al diritto al ripristino della
situazione di fatto e di diritto preesistente al negozi annullato, il diritto alle retribuzioni non corrisposte
maturate a decorrere dalla data di dimissioni dipenderebbero dalla messa a disposizione del datore
di lavoro delle proprie energie lavorative anche oltre la cessazione del rapporto; per altri invece tale
diritto deriverebbe dall'inadempimento del datore di lavoro, e quindi sarebbe in ogni caso dovuto.
L'ISTITUTO DEL PREAVVISO E DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA
L'istituto del preavviso (già contemplato dal codice civile) ha funzione essenziale di permettere alla
parte che subisce il recesso di poter fruire di un certo periodo di tempo per affrontarne le
conseguenze: esso opera in materia simmetrica, e le proprie modalità sono determinate dai contratti
collettivi (in mancanza dei quali si fa ricorso agli usi od all'equità, ex art. 2118 c.c.), così come i
termini – generalmente variabili in funzione dell'anzianità di servizio e dell'inquadramento del
lavoratore. E' inoltre stabilito che, <<in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra
parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso>>: tale indennità sostitutiva non può considerarsi alternativa all'obbligo di preavviso e la
sua corresponsione non vale ad estinguere il rapporto di lavoro (che resta in essere, con tutti i suoi
effetti giuridici, sino alla fine del preavviso) salvo che sia lo stesso lavoratore a rinunciare (con una
manifestazione di volontà inequivoca) alla prosecuzione del rapporto durante il preavviso.
L'obbligo di preavviso viene meno (ex art. 2119 c.c.) qualora (a prescindere da quale sia la parte
recedente) sia presente una giusta causa, tale da non consentire <<la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto>>. Nel caso che il recesso per giusta causa sia invocato da un lavoratore
(come nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni protratto nel tempo, o di molestie sessuali)
esso comporta il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Per quanto sia stata affermato il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, la Cassazione afferma
che <<le dimissioni, ancorché per giusta causa, non sono totalmente assimilabili al licenziamento in
quanto l'effetto risolutivo dipende sempre da un atto di volontà del lavoratore>>: è stato quindi
escluso, in linea di principio, il diritto del lavoratore al risarcimento dell'ulteriore danno rappresentato
dallo stato di disoccupazione, ferma restando la risarcibilità di tutti gli altri danni (diversi dai pregiudizi
direttamente derivanti dalla risoluzione del rapporto) cagionati dall'inadempimento del datore di
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 88 di 105
lavoro.
L'indennità sostitutiva è dovuta – con funzione assistenziale – anche nel caso di morte del lavoratore,
in favore dei familiari (ex art. 2122 c.c.); ancora è dovuta nel caso che il rapporto si estingua a
seguito di fallimento od liquidazione coatta amministrativa (che, per espressa indicazione dell'art.
2119 c.c. non costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro).
Infine, l'art. 2112 c.c. , prevede che le dimissioni del lavoratore <<le cui condizioni di lavoro
subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda>> abbiano lo
stesso effetto delle dimissioni per giusta causa (ex art. 2119).
LA GIUSTA CAUSA DI DIMISSIONI
La Cassazione stabilisce che giusta causa (che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria
del rapporto) deve corrispondere a circostanze di obbiettiva gravità (e non solo valutate
soggettivamente gravi dal lavoratore) <<dalle quali si deduca un'effettiva incompatibilità per il
lavoratore di permanere nel posto occupato>>: il giudice di merito dovrà valutare <<qualsiasi fatto
che renda effettivamente intollerabile per il lavoratore la permanenza nell'impresa>>, tenendo contro
che (come affermato dalla cassazione) <<nella nozione di giusta causa vanno comprese non soltanto
le ipotesi di inadempimento contrattuale, ma anche tutti quei fatti che pur essendo oggettivamente
determinati da un comportamento lecito appaiano [..] idonei a determinare [..] l'immediata
impossibilità di continuare a mantenere in vita il rapporto>>.
Accertata la veridicità dei fatti addotti a fondamento del recesso, spetterà al giudice rilevare la
sussistenza di un effettivo nesso causale con la formazione della volontà del lavoratore di dimettersi:
in tal senso, l'immediatezza della reazione si configura come condizione di credibilità del nesso
causale.
Possono inoltre configurarsi specifiche ipotesi di giusta causa di dimissioni derivanti dalla
contrattazione collettiva: emblematico esempio è l'ipotesi prevista dal CCNL dei giornalisti a riguardo
del “caso di coscienza” (addotto come giusta causa delle dimissioni di massa presentate da numerosi
giornalisti a seguito del mutamento di indirizzo politico del quotidiano “il giornale”).
TUTELA REALE E TUTELA OBBLIGATORIA
La l.604/1966 ha subordinato il licenziamento del lavoratore a determinati requisiti di forma e,
soprattutto, ragioni giustificatrici (<<nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato [..] il licenziamento
del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa [..] o per giustificato motivo>>) ed
imbastito un primo impianto di disciplina sanzionatoria, impostato su una tutela obbligatoria: il
licenziamento illegittimo (perché privo di giusta causa o giustificato motivo) resta valido ed efficace
(in quanto comunque idoneo a determinare la cessazione del rapporto di lavoro); di fronte
all'accertamento giudiziale, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di scegliere tra riassunzione
del lavoratore (entro 3gg dalla sentenza) – che comporta l'instaurazione tra le parti di un nuovo
rapporto di lavoro – ed il consolidamento della propria (illegittima) decisione di porre fine al rapporto
di lavoro, mediante il versamento di una somma di denaro all'interessato a titolo di risarcimento
forfettario del danno (e tale indennità risarcitoria forfettaria sarà decisa dal giudice, in riguardo <<al
numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di
lavoro, al comportamento ed alle condizioni delle parti>>).
Sarà poi lo Statuto dei Lavoratori (nell'art. 18) ad introdurre un vero e proprio regime di stabilità del
posto di lavoro, protetto da una vera e propria tutela reale, per cui – se privo di giusta causa o
motivo giustificativo – il licenziamento viene colpito radicalmente e privato dal giudice di ogni effetto
giuridico, ed il datore di lavoro sarà condannato alla reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro; ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, infatti:
– <<il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento [..] o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità [..]
ordina al datore di lavoro [..] di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro>> ed il rapporto di
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 89 di 105
–
lavoro si ricostituisce senza soluzione di continuità (come se non fosse mai stato ininterrotto);
è inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno (commisurato <<alla retribuzione globale
di fatto effettuata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione>>, nonché
<<al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali>> – fatta salva la possibilità che il
lavoratore provi l'esistenza di danni superiori per effetto del licenziamento illegittimo) che in ogni
caso non sarà in misura inferiore <<a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto>>.
La l.108/1990 ha previsto la possibilità per il lavoratore (una volta ottenuta la sentenza di
dichiarazione d'illegittimità del licenziamento) di rinunciare alla reintegrazione, chiedendo
un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto (che si configura come
diritto potestativo del lavoratore) che andrà a sommarsi al risarcimento del danno.
La Cassazione ha affermato che il lavoratore può esercitare direttamente il diritto di opzione,
apparendo <<del tutto incongruo che questi richieda, quale mezzo al fine, la condanna del datore ad
una reintegrazione cui egli abbia già deciso di rinunciare>>.
Ancora stabilisce che <<la revoca del licenziamento, preordinata ad impedire la pronuncia dell'ordine
di reintegrazione, e l'invito a riprendere servizio non possono sottrarre al prestatore il diritto
all'indennità sostitutiva, il cui esercizio verrebbe altrimenti ad essere rimesso di fatto al datore di
lavoro>> (ed ad analoghe conclusioni è giunta la giurisprudenza con riferimento al diritto del
lavoratore all'indennizzo (in alternativa alla riassunzione) nell'area della stabilità obbligatoria)
Il risarcimento del danno configura (nell'interpretazione della Cassazione) una sanzione dell'illiceità
del comportamento datoriale, autonoma rispetto al diritto alla reintegrazione (e quindi è dovuta anche
qualora questa non abbia luogo); qualora invece venga revocato il licenziamento (e la revoca venga
accettata da parte del lavoratore) l'indennità di risarcimento non sarà dovuta, in quanto in tal caso
verrebbe meno l'interruzione del rapporto. In ogni caso, <<il licenziamento illegittimo resta [..] un
inadempimento contrattuale, dal quale possono derivare per il lavoratore danni di diversa natura>>
che il prestatore potrà farsi risarcire qualora riesca a provare natura ed entità di tali diversi danni.
Sempre per quanto riguarda l'indennità risarcitoria, la giurisprudenza ha ritenuto detraibile
dall'importo delle retribuzioni complessivamente maturate l'aliunde perceptum (applicando la regola
della compensatio lucri cum damno) qualora il datore di lavoro provi che il lavoratore abbia medio
tempore percepito redditi, diretta conseguenza del licenziamento: l'aliunde perceptum deducibile dal
risarcimento – secondo la Cassazione – potrà essere <<soltanto un reddito da lavoro subordinato o
da lavoro autonomo, certo nel suo ammontare>> e dovrà essere <<riferito allo stesso lavoratore e
non già ad altri componenti del suo nucleo familiare>>; detraibile è anche il perceipiendum, qualora
sia provato fatto colposo del lavoratore in relazione al mancato guadagno che avrebbe potuto evitare
con la ordinaria diligenza ricercando una nuova occupazione.
Infine, secondo l'art.18 dello Statuto, <<qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti>>.
IL CAMPO D'APPLICAZIONE DI TUTELA REALE ED OBBLIGATORIA
La l. 108/1992 ha stabilito quali siano i campi d'applicazione della tutela obbligatoria e di quella reale
in funzione della dimensione dell'organizzazione produttiva riguardo al solo criterio ricavabile dalla
consistenza occupazionale della medesima (o della singola unità produttiva).
Tutela reale si applica – secondo lo Statuto – a tutti i datori di lavoro (imprenditori e non), che
occupino più di 15 dipendenti (5 per le imprese agricole) nell'attività produttiva in cui ha avuto luogo il
licenziamento; tale criterio si applica, inoltre:
– a quelle imprese (criterio di calcolo su base territoriale) <<nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti [..] anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti>>;
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 90 di 105
qualora l'impresa, (criterio di calcolo economico-organizzativo) considerata nella sua
dimensione complessiva <<occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro>>.
Inoltre è previsto che la tutela reale si applichi, <<quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal
datore di lavoro>>, nel caso di licenziamento discriminatorio – nonché nel pubblico impiego (<<a
prescindere dal numero dei dipendenti>>).
La Corte Costituzionale ha individuato la ratio di tali limiti dimensionali nell'<<esigenza di
salvaguardare la funzionalità dell'unità produttiva ed in specie di quelle con minor numero di
dipendenti nelle quali la reintegrazione nel medesimo ambiente del lavoratore licenziato avrebbe
potuto determinare il verificarsi di una tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro>>.
–
Il campo d'applicazione della tutela obbligatoria è determinato in via residuale, contro il licenziamento
illegittimo nei confronti di tutti i datori di lavoro (imprenditori e non) cui non risulti applicabile la
disciplina della tutela reale.
E' inoltre applicata (quale che sia il numero di dipendenti) nelle c.d. organizzazioni di tendenza (ove
rientrano – ai sensi della l.108/1990 – i <<datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di
lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, d'istruzione ovvero di religione o di culto>>), e di
volta in volta sarà necessario valutare attentamente se l'attività in questione rientra in quelle previste;
ed il parametro di riferimento sarà la nozione di imprenditore contenuta nell'art. 2082 c.c. secondo cui
<<è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi>> (pur tenendo presente che, secondo la Cassazione,
rientreranno nella normativa anche quegli enti che oggettivamente producano ricchezza, ma la
destinino a terzi, non perseguendo propri fini di lucro). Tale esenzione dalla tutela reale per le
organizzazioni di tendenza ha carattere (discutibilmente secondo la prevalente dottrina)
indifferenziato – ed è la stessa Cassazione a ribadire la “scelta totalizzante” del legislatore (salvo poi,
in una successiva sentenza, distinguere mansioni “neutre” e mansioni “di tendenza”).
Con la l.108/1990, infine, si è ulteriormente ristretto il campo di applicazione del recesso ad nutum,
che è stato reso del tutto residuale; esso sopravvive in particolari casi specifici:
– per lavoratori domestici;
– per lavoratori (e lavoratrici) ultrasessatacinquenni in possesso dei requisiti per il conseguimento
della pensione di vecchiaia;
– per dirigenti (che al più, in assenza di giustificatezza del licenziamento, potranno ottenere
un'attribuzione patrimoniale risarcitoria).
– per lavoratori in prova.
Come ribadito dalla Cassazione, l'onere probatorio della sussistenza dei limiti dimensionali necessari
<<grava sul lavoratore che non si limiti a chiedere la tutela obbligatoria ma proponga la domanda di
reintegrazione nel posto di lavoro>> (fermo restando che tale onere gravante sul lavoratore può
essere ridimensionato dai poteri di acquisizione d'ufficio del materiale probatorio esercitabile dal
giudice); qualora il lavoratore richieda che il computo del numero dei dipendenti tenga conto anche di
quelli di altre articolazioni organizzative dell'azienda, la prova della consistenza numerica dev'essere
accompagnata dalla prova della “non-autonomia” dell'articolazione produttiva.
I più recenti orientamenti in merito (con particolare attenzione ad una recente sentenza della
Cassazione in Sezioni Unite) sembrano invece propendere per far ricadere l'onere della prova delle
dimensioni produttive, in ogni caso, al datore di lavoro.
Spetta, sicuramente, <<invece al datore di lavoro, per sottrarsi agli effetti di cui alla tutela
obbligatoria, [..] provare che si versa in una delle fattispecie>> residuali, nelle quali persiste la
possibilità di recesso ad nutum.
Riguardo agli elementi qualificatori dell'ambito di applicazione, la Cassazione ritiene:
– debba <<considerarsi autonoma quell'articolazione organizzativa, dotata anche essa di una
propria autonomia amministrativa o funzionale, capace in quanto tale di realizzare, anche se solo
in parte, l'attuazione dello scopo perseguito dal datore di lavoro>>;
– il computo dei lavoratori va riferito a riguardo la “media occupazionale” nel medio periodo
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 91 di 105
–
antecedente all'epoca del licenziamento, considerando però di <<rilievo decisivo anche la
riduzione del numero dei dipendenti operata in prossimità del disposto licenziamento, allorquando
essa risulti conseguenza non di condotte elusive del datore di lavoro ma di oggettive ed accertate
condizioni di mercato e/o comprovate esigenze economiche dell'impresa, tali da far
ragionevolmente ritenere una ormai stabile contrazione dell'attività produttiva e,
conseguentemente, anche una definitiva riduzione della manodopera al di sotto del numero di 15
dipendenti>>;
nel computo dei lavoratori, si tiene conto anche di quelli assunti a tempo indeterminato a tempo
parziale, con meccanismo idoneo a rapportarne la prestazione a quella del lavoratore a tempo
pieno.
LA COMUNICAZIONE
Per quanto riguarda l'efficacia del licenziamento, essendo tale negozio un atto ricettizio, questo
produce i suoi effetti giuridici solo dal momento in cui viene conosciuto dal destinatario; d'altra parte
(come più volte ribadito dalla Cassazione) <<non vi è un onere del datore di lavoro di consegna
materiale nelle mani del lavoratore>> e la <<presunzione di conoscenza [..] opera per il solo fatto
oggettivo dell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario>>, che va inteso come <<luogo
più idoneo per la ricezione, che [..] risulti in concreto nella sfera di dominio o di controllo del
destinatario>>.
Inoltre va tenuto presente che <<il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere
l'atto stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta>>
CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLA MANCANZA DI FORMA
Ai sensi della l.604/1966, l'illegittimità del licenziamento consegue non soltanto all'assenza di giusta
causa o giustificato motivo, ma anche al mancato rispetto dei requisiti formali previsti per la sua
intimazione: in particolare la comunicazione del licenziamento dev'essere effettuata per forma scritta
– e l'atto di inviare al lavoratore tale comunicazione è inequivocabile manifestazione della volontà di
porre termine al rapporto.
Nell'ambito della tutela obbligatoria, (come affermato dalla Cassazione) il licenziamento <<il
licenziamento carente della forma scritta è un licenziamento nullo, inidoneo a produrre alcun effetto
e, quindi, anche la risoluzione del rapporto>> (e così il licenziamento i cui motivi non siano stati
comunicati per iscritto, entro 15gg, qualora richiesti dal lavoratore): come poi affermato dalla Corte
Costituzionale, <<il licenziamento verbale, non producendo alcun effetto, non incide sulla continuità
del rapporto stesso e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in
servizio>>; d'altra parte la più recente giurisprudenza della Cassazione (tenendo conto della natura
sinallagmatica del rapporto lavorativo, in quanto contratto a prestazioni corrispettive) ha affermato
che, fermo restando il fatto che il licenziamento carente di forma <<non produce effetti sulla
continuità giuridica del rapporto>> (essendo ricondotto al regime della nullità di diritto comune in
mancanza di forma), il diritto del lavoratore sarà diritto <<al risarcimento del danno eventualmente
commisurato alle mancate retribuzioni>> (ma non necessariamente equivalente al loro ammontare).
Qualora, invece, il datore di lavoro sia soggetto a disciplina di tutela reale (poiché l'art. 18 dello
Statuto equipara licenziamento reso inefficace per carenza di forma e nullo per mancanza di giusta
causa o giustificato motivo) si avrà diritto alla reintegrazione ed al risarcimento del danno.
IL GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO DI LICENZIAMENTO
La l. 604/1966 ha introdotto la distinzione tra due diverse fattispecie motivi giustificativi del
licenziamento (per i quali continua a valere l'obbligo del preavviso): giustificato motivo soggettivo e
giustificato motivo oggettivo.
Il giustificato motivo soggettivo dipende (ex l.604/1966) da un <<notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali>> del lavoratore tale da (come ribadito dalla Cassazione) incrinare il rapporto
fiduciario, e di entità tale da giustificarne (secondo il principio di proporzionalità) la sanzione del
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 92 di 105
licenziamento: l'area di tale inadempimento contrattuale è da riferirsi all'obbligazione strettamente
inerente la prestazione lavorativa, così come agli ulteriori obblighi gravanti sul lavoratore – quali
obbligo di fedeltà ed obblighi preparatori all'adempimento.
Si dovranno quindi valutare gli aspetti concreti dei fatti addebitati al lavoratore, <<con riguardo alla
natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione della parti stesse, al grado di affidamento
richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi ed
all'intensità dell'elemento intenzionale>>, tenendo inoltre presente che il comportamento del
lavoratore andrà valutato <<secondo la sua astratta idoneità ad arrecare pregiudizio all'interesse del
datore di lavoro, indipendentemente dalla verificazione o meno di un effettivo danno economico>>.
La Cassazione ha affermato che <<il datore di lavoro che intenda assumere>> lo scarso
rendimento (eventualmente configurante il mancato raggiungimento del rendimento minimo
prefissato dai contratti collettivi) <<a fondamento del giustificato motivo soggettivo [..] non può
limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma
deve altresì dimostrare che la causa di esso derivi da negligenza nell'espletamento della prestazione
lavorativa>>: poiché l'obbligazione a carico del lavoratore (anche nel caso di lavoro a cottimo) resta
un'obbligazione di fare (e non di risultato) e <<la inadeguatezza della prestazione fornita, prima
ancora che alla mancanza della particolare diligenza che essa richiede, può essere imputabile alla
stessa organizzazione dell'impresa, comunque, a fattori non dipendenti dal lavoratore>> il giudice del
merito dovrà valutare attentamente l'imputabilità dell'inadempimento.
La Cassazione ha stabilito che <<la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente
impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro [..]
non è ravvisabile nella sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore, ma può
essere esclusa dalla possibilità di altra attività riconducibile [..] alle mansioni attualmente assegnate o
a quelle equivalenti [..] o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché detta attività sia utilizzabile
nell'impresa secondo l'assetto organizzativo insindacabile stabilito dall'imprenditore>>; proprio con
riguardo all'insindacabilità delle scelte organizzative dell'imprenditore, questi potrà legittimamente
rifiutarsi di adibire il lavoratore a mansioni anche inferiori, qualora ciò comporti aggravi organizzativi.
Il diritto che la Corte di Cassazione riconosciuto al lavoratore è configura deroga al divieto di
adibizione a mansioni inferiori (di cui all'art. 2103 c.c.), in quanto quest'ultimo è posto nell'interesse
esclusivo del lavoratore.
Secondo la Cassazione, qualora il licenziamento trovi (legittima, ex art. 2110 c.c.) giustificazione
nelle assenze per malattia del lavoratore (quand'anche l'infermità non sia permanente), qualora
venga superato il periodo di comporto, graverà sul datore di lavoro l'onere di indicare specificamente
il numero delle assenze; infine, la giurisprudenza si è orientata nel consentire il meccanismo dell'art.
2110 c.c. solo qualora l'inadempimento del lavoratore non sia imputabile al datore di lavoro, quale
conseguenza di un inadempimento degli obblighi del datore di lavoro (es. nel caso di inidoneità
psicofisica del lavoratore causata dal mancato adempimento dell'obbligo di sicurezza da parte del
datore di lavoro).
IL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DI LICENZIAMENTO
Il giustificato motivo oggettivo è determinato (ex l.604/1966) da <<ragioni inerenti all'attività
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa>>.
Qualora venga addotto come giustificato motivo oggettivo una delle vicende dell'azienda, il controllo
giudiziale – non potendosi sindacare nel merito le scelte aziendali addotte come motivazione del
licenziamento – si concentrerà:
– sull'effettività delle ragioni economico-produttive addotte;
– sull'effettività della soppressione del posto di lavoro;
– sul nesso di causalità fra le due fattispecie.
Tali motivazioni si considereranno però insussistenti qualora il lavoratore licenziato venga
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 93 di 105
immediatamente sostituito da altro lavoratore con le stesse mansioni (mentre è considerato legittimo
l'affidamento all'esterno delle funzioni precedentemente svolte dai lavoratori licenziati).
Secondo una consolidata giurisprudenza, il datore di lavoro non si dovrà limitare a provare l'effettività
della motivazione (sussistente al momento dell'intimazione del licenziamento, e non fondata su
circostanze future ed eventuali) della propria scelta gestionale ed il nesso causale rispetto al
licenziamento, ma deve altresì dimostrare l'impossibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni di
medesimo od equivalente contenuto professionale. Tale onere probatorio potrà <<essere assolto
mediante la prova di fatti positivi, quali le circostanze che i posti di lavoro riguardanti mansioni
equivalenti fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati>> o che, <<dopo il licenziamento
e per un congruo periodo, non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica dei
lavoratori>>. In ogni caso, l'obbligo di repêchage non può spingersi sino al punto di rendere
necessarie modifiche dell'assetto organizzativo; ed è comunque escluso nel caso che il motivo
oggettivo consista nella mera necessità di ridurre il personale.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, sempre meno condiviso però in dottrina,
nell'ambito del giustificato motivo oggettivo non andrebbero accolte solo le vicende inerenti alle
scelte del datore di lavoro, ma anche quegli eventi <<che, per incidenza immediata sulla realtà
aziendale in cui il lavoratore è inserito, cagionano l'effettiva esigenza del datore di porre al rapporto di
lavoro>>, anche quando tali vicende siano riconducibili al comportamento del lavoratore: si riconduce
quindi la temporanea impossibilità della prestazione (es. determinata da carcerazione del lavoratore)
a giustificato motivo oggettivo.
Nel caso però che si adduca a giustificato motivo oggettivo la vicenda legata al lavoratore,
l'accertamento della non-colpevolezza di quest'ultimo non potrà incidere sulla legittimità del
licenziamento (dovuto appunto ad un motivo oggettivo): d'altra parte, la valutazione dovrà essere
esercitata secondo criteri rigorosi – al punto, sembrerebbe, di invadere l'ambito dell'organizzazione
del lavoro, di esclusiva disponibilità dell'imprenditore.
La Cassazione ha più volte ribadito che l'indagine del giudice non può <<estendersi ad un sindacato
sulla opportunità e sulla congruità delle scelte in materia di assetti produttivi ed organizzativi, rispetto
a cui l'imprenditore gode di una riserva di autonomia, garantita dall'art. 41 Cost>>: il giudice potrà
solo verificare il nesso causale tra la provata esistenza di motivo oggettivo (che si configurerà, ad
esempio, nel caso di effettività soppressione del posto di lavoro ricoperto dal lavoratore
licenziato; o nel caso di riassetto organizzativo, attuato per più economica gestione dell'impresa,
che comporti la soppressione di alcuni posti – anche, magari, per fronteggiare situazioni sfavorevoli
non contingenti) ed il conseguente licenziamento, senza che la sua valutazione possa riguardarne il
merito.
LA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO
La giusta causa (che esclude l'obbligo di preavviso nel licenziamento) , secondo consolidato
orientamento giurisprudenziale, è <<una qualificazione giuridica di comportamenti idonei a legittimare
la cessazione – con effetto immediato – del rapporto di lavoro, consistendo essa in un
inadempimento colpevole degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, connotato da una
particolare gravità>> che si ritiene <<debba rivestire il carattere di grave negazione degli elementi
essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, che costituisce il
presupposto indefettibile della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavoro>>; e tale elemento
fiduciario va inteso <<sotto il profilo del verificarsi di un presupposto oggettivo che ponga in luce la
mancanza di idoneità del lavoratore a svolgere la propria funzione [..] tale da menomare la fiducia del
datore di lavoro nell'esattezza dei successivi adempimenti da parte del lavoratore>>.
Altro elemento costitutivo del recesso per giusta causa (che lo differenzia, secondo la Cassazione,
da quello per giustificato motivo soggettivo) è rappresentato dall'immediatezza del provvedimento
espulsivo, da intendersi <<in senso relativo, essendo compatibile con un congruo intervallo di tempo,
necessario al datore di lavoro per una valutazione unitaria dei vari comportamenti del dipendente>>,
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 94 di 105
tenuto conto della <<complessità complessità delle indagini che possono rendersi indispensabili per
accertare l'illecito del dipendente>> e dell'eventuale <<complessità della struttura organizzativa
dell'impresa che può far ritardare il provvedimento di recesso>>.
Tale principio va rispettato anche durante il periodo di assenza per malattia, durante il quale –
nell'orientamento prevalente – il lavoratore può essere licenziato per giusta causa (anche se non è
pacifico se l'efficacia di tale licenziamento sia immediata o differita al termine del periodo di
comporto).
La gravità del fatto qualificato dal datore come giusta causa va valutata dal giudice di merito <<con
specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto all'entità della mancanza, considerata
non solo dal punto di vista oggettivo ma anche nella sua portata soggettiva, specialmente in
relazione alla particolare circostanza in cui essa è stata posta in essere, ai moventi, all'intensità
dell'elemento intenzionale e al grado di quello colposo>>.
Tipiche ipotesi di giusta causa sono ravvisabili nelle violazioni degli obblighi fondamentali gravanti sul
lavoratore, tra cui l'insubordinazione che è “negazione della subordinazione” che si realizza
<<attraverso l'aperta contestazione dei poteri del datore>>, con riguardo allo <<spazio del potere
assegnato al superiore>> e <<non gli atti del superiore palesemente ed incontrovertibilmente (anche
per illegittima forma) esterni a questo spazio>>.
Atti di violenza che si svolgono nel contesto lavorativo e, più in generale, alterchi tra colleghi, sono
spesso contemplati dalla stessa contrattazione collettiva quali fattispecie che integrano una giusta
causa di licenziamento (disciplinare): in ogni caso, la Cassazione ha stabilito che andrà valutata la
specifica situazione verificatasi e l'effettiva gravità della condotta del lavoratore.
Con riguardo allo specifico obbligo di diligenza, la Cassazione ha precisato il rilievo assunto dal
rispetto di obblighi di comportamento, pur non codificati, desumibili dalle regole di organizzazione
aziendale e dalla collocazione nella scala gerarchica del lavoratore.
Infine, si ravvisa giusta causa nelle ipotesi di frode perpetrata ai danni del datore di lavoro, in quanto
queste fanno venire meno la fiducia del datore nell'esatto adempimento da parte del dipendente dei
propri obblighi contrattuali; d'altra parte, per quanto la giurisprudenza abbia affermato l'irrilevanza
dell'entità del pregiudizio economico causato dal comportamento fraudolento del lavoratore (in ogni
caso idoneo a ledere il rapporto fiduciario), talvolta – qualora questo si fosse dimostrato alquanto
modesto – la giurisprudenza ha censurato la sproporzione tra infrazione contestata e sanzione
addotta (ex art. 2106 c.c. ).
Secondo consolidato orientamento della Cassazione, <<il comportamento del lavoratore subordinato
nella sua vita privata, non [..] di regola idoneo ad incidere sull'elemento fiduciario [..], può costituire
giusta causa di licenziamento allorché, per la sua gravità e natura, sia tale da far ritenere il lavoratore
professionalmente inidoneo alle peculiari caratteristiche>> del rapporto di lavoro, qualora la specifica
prestazione (appunto per tale peculiarità) <<richieda un ampio margine di fiducia>>.
Per quanto riguarda la valutazione della gravità dell'atto extra-lavorativo, <<il datore di lavoro può
legittimamente intimare il licenziamento in tronco per giusta causa per avere il lavoratore commesso
fatti che costituiscono reato, qualora questi siano di tale gravità da determinare una situazione di
improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva
di condanna, atteso che il principio di non colpevolezza fino alla condanna [..] non riguarda [..] la
disciplina dei rapporti di natura privatistica>>; spetterà tuttavia al giudice l'accertamento della
sussistenza dei presupposti di legge al licenziamento intimato, ed in particolare il ruolo del
dipendente all'interno dell'azienda ed il nesso tra il comportamento extra-lavorativo e il contenuto
delle sue mansioni.
Infine, legittima il licenziamento per giusta causa l'esercizio del diritto di critica che valichi il limite del
rispetto della verità oggettiva, soprattuto qualora si configuri diffamazione.
IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Secondo quanto affermato dalla Cassazione, <<il licenziamento ha natura disciplinare ogni volta che
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 95 di 105
sia motivato da un comportamento imputabile a titolo di colpa (intesa in senso generico) al
lavoratore>> (c.d. tesi ontologica).
La Corte Costituzionale ha stabilito che poiché <<il licenziamento per motivi disciplinari [..] può
incidere sulla sfera morale e professionale del lavoratoe>> questi <<deve essere posto in grado di
conoscere l'infrazione contestata, la sanzione ed i motivi>> e dev'esser posto nella condizione di
difendersi adeguatamente: a tal proposito, le garanzie poste dall'art. 7 dello Statuto <<devono essere
riconosciute anche ai lavoratori di imprese che occupino meno di sedici dipendenti>>.
Diverse saranno invece le conseguenze alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento per
violazione di regole procedurali, a seconda che ci si trovi nell'ambito della tutela obbligatoria o di
quella reale.
Come affermato dalla Cassazione, <<il datore di lavoro, a fronte di comportamenti del lavoratore che
la coscienza sociale considera lesivi del vivere civile, può procedere al licenziamento anche
nell'ipotesi in cui sia mancata l'affissione del codice disciplinare>>.
A tal proposito infatti, poiché <<ogni recesso fondato su ragioni imputabili al lavoratore è un
licenziamento disciplinare, il mancato inserimento del licenziamento con preavviso nel novero delle
sanzioni disciplinari>> non esclude <<la natura disciplinare del recesso>>, né limita <<il potere di
licenziamento del datore di lavoro>>, dato che il licenziamento <<non deve essere necessariamente
contemplato dal codice disciplinare, a differenza delle sanzioni conservative>>
IL LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO
Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie (come affermato dalla l.604/1966) è <<nullo
indipendentemente dalla motivazione addotta>> ed in ogni caso vi si applica il regime di tutela reale.
Si configura quindi licenziamento discriminatorio ogniqualvolta sia determinato dalla sussistenza di
uno dei motivi che l'ordinamento riconduce a motivo discriminatorio (quelli contenuti nello Statuto dei
lavoratori e nella l. 604/1966 – così come nei successivi interventi normativi in attuazione delle
direttive comunitarie in materia di discriminazione).
Per quanto riguarda, in particolare, il licenziamento della lavoratrice madre, la giurisprudenza
prevalente esclude – nonostante l'evidente riconducibilità di tale licenziamento nell'ambito delle
discriminazioni dirette fondate sul sesso – l'applicabilità della tutela reale e la conseguente possibilità
di reintegrazione.
In generale, secondo l'orientamento prevalente spetterà al lavoratore, in applicazione delle regole
generali in materia di onere probatorio, provare la sussistenza del motivo discriminatorio,
indipendentemente dalla motivazione addotta dal datore di lavoro per il licenziamento; fatta salva la
previsione della l.125/1991 che prevede una parziale inversione dell'onere della prova per le
discriminazioni di sesso (qualora il ricorrente ricorra alla c.d. prova statistica).
Ancora, il licenziamento discriminatorio è fatto nullo, dalla l.108/1990, anche nei confronti dei
dirigenti, nel qual caso opererà la stessa tutela prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per i
lavoratori subordinati.
Più in generale, la tutela reale andrà a colpire in ogni caso il licenziamento discriminatorio, anche a
prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro.
Più controversa è invece l'applicabilità della disciplina sul licenziamento discriminatorio nelle
organizzazioni di tendenza, visto il contrasto tra gli interessi in gioco (la tutela della libertà del
lavoratore e, d'altra parte, dell'ideologia del datore di lavoro), e spesso in giurisprudenza si ricorre
alla distinzione tra mansioni neutre e di tendenza.
Ciò che, invece, pare ragionevole ritenere in ogni caso è che, qualora un licenziamento sia fondato
su un fattore discriminatorio non coincidente con l'ideologia dell'organizzazione di tendenza, questo
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 96 di 105
configurerà come licenziamento discriminatorio illegittimo e si applicherà la disciplina di tutela reale.
ALTRE IPOTESI DI NULLITA' DEL LICENZIAMENTO
L'ordinamento, infine, riconosce espressamente (con la l.7/1963 ed il d.lgs 151/2001) due particolari
ipotesi di nullità del licenziamento: si considerano <<nulli [..] i licenziamenti attuati a causa di
matrimoni>> ed il licenziamento intimato alla lavoratrice madre nel periodo compreso tra l'inizio della
gravidanza ed il compimento di un anno di età del bambino. Le regole espressamente previste
potrebbero essere sostituite da quelle meno datate previste per i licenziamenti discriminatori, e quindi
sottoposti al regime di tutela reale.
Nel caso di licenziamento del lavoratore in prova, qualora l'interessato sia riuscito a dimostrare
l'illegittimità del licenziamento (per mancato od inadeguato esperimento della prova, o perché
imputabile a motivo illecito): talune opinioni sono nella direzione di applicare i rimedi propri del
licenziamento ingiustificato (a seconda dei casi, di tutela reale od obbligatoria), mentre per altri, il
lavoratore avrebbe diritto solo al completamento della prova ovvero al risarcimento del danno.
IL LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI
Con la l.108/1990 si è generalizzato l'obbligo di giustificare il recesso intimato ai lavoratori
subordinati; ed al più spetterà al datore di lavoro l'onere della prova del fatto che nel caso si configuri
una delle residuali fattispecie per cui è consentito il recesso ad nutum.
Secondo la Cassazione, la disciplina applicabile per i dirigenti è quella prevista dall'art. 2118, il
<<recesso ad nutum da parte del datore di lavoro, avendo rilievo la eventuale giusta causa solo ai fini
della mancata indennità di preavviso>>.
L'applicabilità del regime del recesso ad nutum ai dirigenti non comporta automaticamente la
legittimità di qualsiasi licenziamento intimato a qualsiasi lavoratore inquadrato come dirigente, né
l'irrilevanza della sussistenza o meno di una ragione che giustifichi il recesso.
Innanzitutto, il giudice di merito dovrà verificare la <<reale posizione di dirigente dell'attore,
stabilendo se questi occupava una posizione indubbiamente verticistica, oppure una posizione solo
formalmente dirigenziale>> (innanzitutto perché spesso sono gli stessi contratti collettivi di categoria
ad individuare direttamente i destinatari della disciplina codicistica, soprattutto in relazione alla
posizione del lavoratore nell'organigramma aziendale – riservando la risoluzione ad nutum ai soli
dirigenti con posizione apicale).
Ancora, pur essendo il recesso ad nutum caratterizzato dalla mancanza di un obbligo di motivazione,
la Cassazione ha ritenuto che non sia preclusa al giudice l'indagine <<in ordine alle effettive ragioni
del licenziamento>>: qualora il licenziamento risulti ingiustificato, è lo stesso contratto collettivo che
spesso prevede (legittimamente, secondo la Cassazione) per i dirigenti la corresponsione di
un'indennità complementare – ed in generale forme di tutela patrimoniale analoghe a quelle che la
legge non garantisce ai dirigenti. Ancora, la Cassazione ha stabilito che <<l'onere probatorio in
relazione alla veridicità, fondatezza e idoneità dei motivi addotto a giustificazione del recesso
incombe sempre sul datore di lavoro>>.
Saranno diversi, invece, i criteri di valutazione della “giustificatezza” del licenziamento (che
dovranno tenere conto della <<specialità della posizione assunta dal dirigente nell'ambito
dell'organizzazione aziendale e la peculiarità di un rapporto lavorativo, in cui l'aspetto fiduciario
assume rilevanza incisiva>>), e la legittimità di tale negozio andrà valutata (fermo restando l'esplicito
richiamo della l.108/1990 sulla nullità, anche per i dirigenti, del licenziamento discriminatorio) sulla
base del <<rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi di correttezza e buona fede
nell'esecuzione del contratto [..] e del divieto di licenziamento per motivo illecito>>.
QUESTIONI PROCESSUALI IN TEMA DI LICENZIAMENTO
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 97 di 105
Per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, è stato previsto un breve termine di decadenza per
l'impugnazione del licenziamento, da effettuare entro 60gg dal ricevimento della comunicazione –
con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore; una volta evitata la
decadenza, l'azione in giudizio può essere esercitata nel rispetto degli ordinari termini di prescrizione.
L'onere della prova della sussistenza di giusta causa o giustificato motivo grava sul datore di lavoro:
è invertito l'onere della prova, ed il lavoratore dovrà al più provare la sussistenza del rapporto di
lavoro ed il licenziamento.
L'onere della prova grava senz'altro su lavoratore, invece, quando si voglia far valere il carattere
discriminatorio di un licenziamento (con l'eccezione del licenziamento discriminatorio per ragioni di
sesso, per il quale vale il regime di parziale inversione dell'onere probatorio – che sembrerebbe
essere stato esteso dalla l.101/2008 a tutte le discriminazioni riconosciute dall'ordinamento).
Per quanto riguarda invece la prova dei requisiti occupazionali da cui dipende l'applicabilità della
tutela reale od obbligatoria, si è fatta strada in giurisprudenza l'opinione che questa spetti sul datore
di lavoro (qualora egli volesse sottrarsi al regime di tutela previsto dall'art. 18 dello Statuto).
L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emesso dal giudice non è suscettibile di esecuzione
forzata in forma specifica, trattandosi di obbligazione di fare infungibile per cui il datore di lavoro
potrebbe limitarsi a corrispondere all'interessato le retribuzioni.
Infine, la giurisprudenza ha affermato che <<tutti gli importi erogati dal datore di lavoro in esecuzione
della sentenza che ordina la reintegrazione, anche per il periodo successivo alla data di detta
decisione, costituiscono [..] risarcimento del danno derivante dall'illegittimo licenziamento e come tali
sono interamente ripetibili a seguito della sentenza di riforma in appello che esclude con effetto
immediato l'illecito e l'obbligo di risarcimento>>.
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI
L'evidente rilevanza dei licenziamenti collettivi è confermata dall'attenzione ad essi dedicata dalle
autorità comunitaria, testimoniata dall'adozione di due direttive in proposito, al cui adeguamento si è
provveduto con la l.223/1991: tale legge disegna un modello di tutela di tipo procedurali.
In aderenza alla direttiva comunitaria, la nozione di licenziamento collettivo si compone di un criterio
numerco-quantitativo e di un criterio qualitativo, in quanto si ha licenziamento collettivo qualora:
– un'impresa con più di 15 dipendenti intenda effettuare almeno 5 licenziamenti (nell'arco di 120
giorni, in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia);
– sia diretta <<conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o lavoro>>.
La Cassazione ricorda che nel licenziamento collettivo sono ricompresi tutti i licenziamenti che, entro
tali parametri temporiali e territoriali, siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
Per espressa disposizione normativa (ex. l.223/1991) la disciplina del licenziamento collettivo non si
applica nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili (e la
ratio di tale esclusione è stata individuata dalla Cassazione nel fatto che in tali imprese <<il
licenziamento di una pluralità di lavoratori [..] non denota una crisi della stessa ma rientra nella
normalità del suo esercizio>>) e nei casi di attività stagionali o saltuarie; la Cassazione ha ritenuto,
infine, che <<le imprese che gestiscono servizi di pulizia in appalto e che occupano più di quindici
dipendenti sono soggette alla disciplina>> dei licenziamenti collettivi, <<non rientrando nelle
eccezioni previste>>.
Licenziamento collettivo non deve conseguire necessariamente ad una situazione di crisi aziendale,
ma anche a fronte di mutamenti nel processo produttivo che non devono necessariamente
accompagnarsi ad un ridimensionamento dell'impresa (essendo ammessa dalla l.223/1991 la
legittimità del c.d. licenziamento tecnologico – riduzione di personale senza parallela riduzione delle
strutture od attività produttive): ancora, la Cassazione ritiene che, qualora si voglia ricorrere alla
procedura di licenziamento collettivo, <<il datore di lavoro debba dimostrare di aver seguito la
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 98 di 105
procedura di legge e l'esistenza del nesso di causalità tra il ridimensionamento e il licenziamento
stesso>> ma non invece che <<non vi era alcuna possibilità di collocamento dei lavoratori in altre
mansioni compatibili in azienda>>.
Come affermato dalla Cassazione, verificata la sussistenza del requisito causale (individuato nella
l.233/1991 appunto in una <<una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro>>) andrà poi
verificato il <<“nesso di causalità” tra la decisione imprenditoriale e la soppressione dei posti di
lavoro, in relazione sia al numero dei licenziati, che alla loro individuazione>>, ed in ogni caso il
giudice non potrà <<sindacare l'opportunità delle scelte tecniche operate dal datore di lavoro né i
criteri economico-produttivi seguiti nella modifica dell'assetto organizzativo dell'impresa>> – ed al più
bisognerà verificare che tale licenziamento collettivo sia utilizzato per procedere ad una pluralità di
licenziamenti individuali altrimenti non giustificati.
Allorché la soglia quantitativa non risulti superata, i molteplici licenziamenti andranno considerati
come un licenziamento plurimo per giustificato motivo oggettivo, al quale non si applicheranno le
regole procedurali previste per i licenziamenti collettivi; ai sensi del d.lgs 110/2004 (emanato onde
adeguarsi ad una sentenza della Corte di Giustizia in proposito) si dovranno applicare – qualora
siano soddisfatti i requisiti quantitativi e qualitativi previsti – anche al licenziamento collettivo attuato
da un datore di lavoro privato non imprenditore (comprese le c.d. organizzazioni di tendenza).
Nel contesto della l.233/1991 sussiste un intreccio fra disciplina del licenziamento collettivo e
disciplina della CIG: infatti, al licenziamento collettivo si può pervenire o direttamente, qualora
l'imprenditore ritenga sin dal primo momento che la situazione di eccedenza sia irreversibile; ovvero
dopo un periodo di ricorso all'intervento straordinario della CIG, <<qualora nel corso di attuazione del
programma [..] ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di
non poter ricorrere a misure alternative>>.
Fermo restando il presupposto qualitativo del licenziamento collettivo, perché se ne configuri la
fattispecie sarà sufficiente che il licenziamento segua ad un periodo di ricorso alla CIG, pur non
rispettando il requisito minimo numerico.
REGOLE PROCEDURALI DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Una volta assunta la decisione relativa al licenziamento collettivo, prima di passare alla fase attuativa
è necessario che l'impresa attivi la procedura per la dichiarazione di mobilità, che si articola in fase
sindacale (di comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali, contenente le informazioni
funzionali a consentire ai rappresentanti di intavolare una discussione sulle possibili alternative al
licenziamento) che può svilupparsi (qualora i sindacati lo richiedano) in un esame congiunto (nel
corso del quale si cerca di individuare soluzioni alternative al licenziamento collettivo – la legge
indica, in via esemplificativa, alcuni strumenti quali contratti di solidarietà, part-time, assegnazione dei
lavoratori a mansioni diverse anche in deroga alle tutele della professionalità contenute nello statuto,
distacco temporaneo presso altre imprese); in caso di esito negativo dell'esame congiunto, si apre la
fase amministrativa (nella quale la direzione provinciale del lavoro convoca le parti per un nuovo
eseme della situazione), terminata la cui procedura preliminare l'impresa (indipendentemente
dall'intesa con i sindacati) potrà procedere all'attuazione del licenziamento collettivo, collocando in
mobilità i lavoratori eccedenti (previa comunicazione scritta a ciascuno di essi del recesso, nel
rispetto dei termini di preavviso), contestualmente all'invio di comunicazione scritta (contenente in
particolare la <<puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta>> dei lavoratori da licenziare) alla direzione regionale del lavoro, all'organismo regionale
competente, ed ai sindacati di categoria.
Per quanto riguarda le regole sulla scelta dei lavoratori da licenziare, qualora i contratti collettivi non
abbiano stabilito criteri propri, sono stati previsti tre criteri sussidiari che l'impresa sarà tenuta a
rispettare, applicandoli in concorso fra loro:
– carichi di famiglia;
– anzianità;
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] )
pagina 99 di 105
–
esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
Come affermato dalla Corte Costituzionale con riguardo alla determinazione pattizia dei criteri di
scelta (che potranno risultare anche dall'accordo conclusivo della procedura di mobilità), <<l'accordo
non è valido – con conseguente annullabilità del recesso intimato dal datore di lavoro – quando è
contrario a principi costituzionali o a norme imperative di legge>>; ed in particolare i criteri di scelta
dovranno rispettare i principi di razionalità e non discriminazione, e dovranno avere il carattere della
generalità e dell'oggettività – essendo escluso che possano essere <<ritagliati caso per caso a
misura delle situazioni personali degli interessati>>.
I criteri (contrattuali o legali) andranno applicati con riguardo all'intero complesso aziendale (esclusa
dalla Cassazione la legittimità di <<ogni decisione uniilaerale del datore di lavoro a limitare l'ambito di
selezione ad un singolo settore o ad un reparto>> cosicché <<concorrano lavoratori con analoghe
professionalità>>), salvo che <<il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ed
esaustivo a uno dei settori dell'azienda>>.
Come affermato dalla Cassazione, nell'applicare i criteri di scelta (che dovranno avvenire nel rispetto
dei generali principi di buona fede e correttezza), il datore di lavoro dovrà <<indicare le regole di
ponderazione degli stessi, attribuendo a ciascuno di essi uno specifico e predeterminato indice
valutativo, sì da permettere una vera e propria graduatoria tra i lavoratori da licenziare>>.
Qualora l'accordo individui il criterio di scelta nel diritto del lavoratore al prepensionamento, il datore
di lavoro potrà comunque mantenere in servizio alcuni lavoratori che hanno tale requisito, a
condizione che provi che la particolare professionalità di tali lavoratori sia funzionale alla
prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
L'APPARATO SANZIONATORIO DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO ILLEGITTIMO
Quanto all'apparato sanzionatorio, la legge (l.223/1991) considera inefficace il licenziamento
collettivo intimato senza l'osservanza della forma scritta o senza il rispetto delle regole procedurali,
mentre sarà annullabile qualora siano stati violati i criteri di scelta.
Il rigore della previsione normativa è giustificabile, con la volontà legislativa di garantire la
trasparenza delle scelte aziendali ed un effettivo ruolo agli organismi sindacali: proprio per tale
motivazione, la giurisprudenza ha voluto intendere come <<obblighi di allegazione preventiva,
l'inottemperanza ai quali si risolve in un inadempimento essenziale>> i “requisiti minimi di contenuto”
della comunicazione; e la Cassazione ha più volte ribadito <<l'obbligo del datore di dare pubblicità
sia ai criteri utilizzati per pervenire alla scelta dei lavoratori da licenziare, sia alle modalità di
applicazione degli stessi [..] agli organismi sindacali [..] ai fini del controllo dell'esercizio dei poteri
datoriali, [..] che solo la dimensione collettiva consente di verificare nella loro effettiva correttezza>>.
Nonostante un precedente orientamento contrario (secondo cui poteva determinarsi solo un'azione di
risarcimento dei danni) la più recente Cassazione ha stabilito che è da ritenersi inefficace il
licenziamento intimato al lavoratore quando contestualmente non sia inviata ai lavoratori interessati
la comunicazione del recesso nei termini del preavviso, e contestualmente non venga fatta agli uffici
pubblici competenti ed agli organi sindacali comunicazione contenente (ai sensi della l.223/1991),
<<l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo,
del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia,
nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta>>:
infine è stato stabilito che a tale <<vizio procedurale può essere dato rimedio mediante il compimento
dell'atto mancante o la rinnovazione dell'atto viziato>>.
Il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso, invece, non determina l'inefficacia del licenziamento, ma
<<il sorgere dell'obbligo di pagamento dell'indennità>> sostitutiva del preavviso.
Sempre ai sensi della l.223/1991, il singolo lavoratore che voglia far valere l'illegittimità del
licenziamento è tenuto ad impugnarlo (con qualsiasi atto scritto idoneo a renderne nota la volontà)
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] ) pagina 100 di 105
entro 60gg dal ricevimento della comunicazione; salvo nel caso di inefficacia per vizio di forma, per il
quale non opereranno i termini di decadenza.
Sia nel caso di licenziamento inefficace che annullabile, opererà tutela reale (salvo che per le
organizzazioni di tendenza, per le quali si applicheranno le regole proprie del sistema di tutela
obbligatoria).
Qualora poi la reintegrazione nel posto di lavoro sia stata disposta in conseguenza del mancato
rispetto dei criteri di scelta, l'impresa potrà procedere (nel rispetto dei criteri di scelta) <<alla
risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati
senza dover esperire una nuova procedura>>, previa comunicazione alle rappresentanze sindacali.
LA LISTA DI MOBILITA'
Qualora un lavoratore perda il posto a causa di una riduzione di personale, questi va iscritto (ai sensi
della l.233/1991) in un apposita lista di mobilità.
Il diritto di iscrizione nella lista è riconosciuto a tutti il lavoratori licenziati per riduzione di personale
(anche da datori di lavoro non imprenditori) e persino (con disposizioni di carattere temporaneo più
volte prorogate) ai lavoratori licenziati <<per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro>> anche da parte di imprese con meno di 15
dipendenti – e ciò contestualmente alla previsione di ipotesi di iscrizione nelle liste da parte dello
stesso lavoratore interessato.
L'iscrizione in tale lista dà diritto al conferimento dell'indennità di mobilità (erogata dall'INPS, sulla
base di una contribuzione ordinaria a carico di tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione
dell'evento straordinario della CIG, nonché sul versamento – in trenta rate mensili – di una somma
pari a nove volte il trattamento mensile di mobilità per ciascun lavoratore licenziato, da parte
dell'impresa che ricorre al licenziamento collettivo) qualora i lavoratori siano licenziati da imprese
rientranti nel campo d'applicazione dell'intervento straordinario della CIG; tutti gli iscritti alla lista,
invece, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate entro sei mesi dall'impresa che ha
intimato il licenziamento, nonché ad una più elevata probabilità di rapido reinserimento nel mercato
del lavoro in virtù di una serie di agevolazioni riconosciute alle imprese che assumano tali lavoratori.
L'indennità di mobilità viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi (elevati a 24 per i
lavoratori di oltre 40 anni, e 36 per i lavoratori ultracinquantenni) e per un importo iniziale pari al
100% del trattamento straordinario di CIG (decresce poi all'80% all'inizio del tredicesimo mese): è
inoltre prevista la possibilità che l'importo possa essere corrisposto in un unica soluzione ai lavoratori
che ne facessero richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo od associarsi in
cooperativa.
Onde evitare aggiramenti fraudolenti degli scopi di tutela, è previsto che l'indennità spetti solo ai
lavoratori che, al momento del licenziamento, abbiano maturato un'anzianità aziendale minima di 12
mesi; ed in ogni caso questa non può essere corrisposta per periodo superiore all'anzianità di
servizio maturata dal lavoratore presso l'impresa che lo ha licenziato.
La cancellazione dalla lista è determinata da:
– la scadenza del periodo di godimento dell'indennità;
– l'assunzione a tempo pieno e indeterminato;
– la percezione dell'indennità in un'unica soluzione;
– una serie di ipotesi a fronte delle quali questa si configura come sanzione.
LE GARANZIE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
L'ordinamento corregge (in favore del contraente debole) lo squilibrio tipico fra le posizioni delle parti
nel contratto di lavoro, attraverso il carattere di inderogabilità attribuito alla norma di legge (e di
contratto collettivo): tale inderogabilità viene meno qualora la legge lo preveda ammettendo deroghe
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] ) pagina 101 di 105
di carattere consensuale, o nel caso in cui attraverso il contratto individuale vengano poste regole di
maggior favore per il lavoratore.
L'eventuale contrasto fra legge ed autonomia privata individuale viene usualmente risolto non
invalidando l'intero contratto, ma (operando il meccanismo di nullità parziale previsto dall'art 1419
c.c.) sostituendo alle clausole nulle le norme imperative violate.
I diritti derivanti da norme inderogabili hanno carattere dell'indisponibilità, per cui (ai sensi dell'art.
2113 c.c.) tutte <<le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi>> sono colpite da invalidità.
Riguardo al campo di applicazione, sotto il profilo soggettivo sono inclusi, oltre ai lavoratori
subordinati del settore privato, i lavoratori autonomi para-subordinati ed i pubblici dipendenti; sotto il
profilo oggettivo, sono esclusi quegli atti di disposizione riguardanti diritti la cui fonte sia rintracciabile
nel contratto individuale, od in norme di legge (o di contratto collettivo) derogabili.
Se generalmente, ai sensi dell'art. 1966 c.c. , gli atti di disposizione di diritti indisponibili sono colpiti
da nullità (riconducibile a quella prevista dall'art. 1418 c.c. per atti in contrasto con norme imperative),
nel diritto del lavoro (per esigenze di certezza nei rapporti) il regime giuridico dell'invalidità di rinunzie
e transazioni è l'annullabilità: ai sensi dell'art 2113 c.c. , <<l'impugnazione deve essere proposta, a
pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o
della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima>>; essa può essere
effettuata <<con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, [..] idoneo a renderne nota la volontà>>.
Una volta impedita la decadenza, il lavoratore potrà agire in giudizio entro l'ordinario termine di
prescrizione quinquennale previsto per l'azione di annullamento.
Il regime di annullabilità, in ogni caso, riguarda esclusivamente <<l'invalidità dei negozi di
disposizione di diritti già acquisiti>>, mentre è da ritenersi radicalmente nulla (ex. art 1418) la
clausola contrastante con norme inderogabili (sia che sia contenuta nella stipulazione iniziale, sia che
sia inserita successivamente nel contratto di lavoro).
Ancora la Cassazione ha ribadito che la la rinunzia preventiva del lavoratore subordinato a futuri,
eventuali e non precisati diritti, è estranea al regime di cui all'art. 2113 c.c. , in quanto atto di
disposizione di diritti non ancora entrati nel patrimonio del disponente, e perciò affetto da nullità.
Le regole dell'art. 2113 non si applicano alla conciliazione intervenuta davanti al giudice del lavoro,
come pure a quelle che possono concludersi, prima dell'instaurazione del giudizio, innanzi alla
commissione di conciliazione istituita presso la direzione provinciale del lavoro o in sede sindacale,
secondo le procedure previste dai contratti collettivi.
Le quietanze a saldo, sono quelle clausole di stile attraverso cui, all'atto della cessazione del
rapporto, il lavoratore (su richiesta del datore di lavoro) afferma di non aver più nulla a pretendere in
dipendenza del precorso rapporto di lavoro: esse sono considerate (dalla giurisprudenza) come mere
dichiarazioni di scienza, espressione di un convincimento soggettivo, di per sé prive di qualsiasi
volontà abdicativa di diritti – e la stessa potrà essere impugnata indipendentemente dal termine
decadenziale (di sei mesi, ex. art. 2113 c.c.) ed i diritti non soddisfatti potranno (sempre entro i
termini di prescrizioni previsti) essere fatti valere.
E' la stessa Cassazione ad affermare che a tale dichiarazione <<non può essere riconosciuto il
valore di rinuncia o transazione, salvo che elementi specifici [..] consentano al giudice di ritenere che
la dichiarazione stessa sia resa dal lavoratore con la chiara consapevolezza dell'esistenza di
determinati suoi diritti e con l'intento di abdicare ad essi o di transigere>>.
LA PRESCRIZIONE NEL DIRITTO DEL LAVORO
La prescrizione costituisce una modalità di estinzione dei diritti collegata al decorso del tempo ed
all'inerzia del titolare: ai sensi dell'art. 2934 c.c. , il diritto si estingue <<quando il titolare non lo
esercita per il tempo determinato della legge>>.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] ) pagina 102 di 105
Per quanto riguarda i termini di prescrizione applicabili nel diritto del lavoro:
– prescrizione decennale, di rilievo marginale nel diritto del lavoro, vale per:
– il diritto al risarcimento del danno per (totale o parziale) omissione contributiva;
– il diritto al risarcimento del danno contrattuale;
– il diritto alla qualifica (ove si ritenga applicabile la prescrizione);
– prescrizione quinquennale vale per la quasi totalità dei crediti retributivi; ai sensi dell'art. 2948
c.c. , <<tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>> e le
<<indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro>> (TFR ed indennità sostitutiva del
preavviso).
Sono, infine, soggetti a prescrizione presuntiva (cioè si presumono soddisfatti, fatta salva la
possibilità di addurre in giudizio prova contraria) gli emolumenti retributivi periodici: 1 anno (ex art.
2955 c.c.) per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, 3 anni (ex art. 2956 c.c.) per
le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese.
Se il diritto alla qualifica si ritiene di prescrizione decennale, il diritto alle differenze retributive
derivanti dal mancato riconoscimento della qualifica viene ricondotto, secondo la giurisprudenza
prevalente, nell'ipotesi prevista dall'art. 2948 c.c. per le erogazioni a carattere retributivo; allo stesso
modo le erogazioni pecuniarie dovute per ferie e riposi non goduti vengono considerate (come
affermato dalla Cassazione) non di carattere risarcitorio, ma retributivo <<dovendo esser avvenire
con la stesa periodicità della normale retribuzione relativa al periodo cui si riferiscono.
IL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE NEL DIRITTO DEL LAVORO
Se per regola generale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere, nel diritto del lavoro si tiene conto che in tale particolare ambito – come affermato dalla Corte
Costituzionale – sussistono <<ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che
può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato
a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento>>: in ogni caso, la stessa Corte Costituzionale (in una
successiva sentenza) ha precisato che la regola della sospensione della prescrizione dei crediti
retributivi si applica solo nel caso in cui il rapporto di lavoro del dipendente non sia garantito dal
regime di tutela reale contro i licenziamenti.
Tuttavia, tenendo presente che la tutela reale si applica in ragione di soglie dimensionali dell'unità
produttiva, la Cassazione ha affermato che <<la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in
costanza di rapporto qualora sussistano dubbi circa le dimensioni numeriche dell'impresa, perché
non viene meno per il lavoratore il timore di essere licenziato>>.
Ancora, la Cassazione si è orientata nel senso di negare il decorso della prescrizione durante il
rapporto di lavoro qualora la tutela reale allo stesso sia riconosciuta solo ex post dal giudice, in
quanto il presupposto della stabilità reale va verificato con riguardo <<al concreto atteggiarsi del
rapporto stesso [..] e non già alla stregua della diversa disciplina garantistica che avrebbe dovuto, in
astratto, regolare il rapporto>>.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza, la prova della stabilità reale del rapporto di lavoro
subordinato graverà sul datore di lavoro.
Per ultimo, va ricordato che la Cassazione ha affermato che il diritto del lavoratore all'inquadramento
professionale soggiace a prescrizione decorrente dal momento dell'insorgenza (così come parte
della giurisprudenza ritiene avvenga per i diritti a prescrizione decennale), non essendo precluso
l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo
in quanto <<permanendo la situazione cui la norma collega il diritto, la prescrizione decorre
autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale
situazione, fino alla cessazione della medesima>>.
LA DECADENZA NEL DIRITTO DEL LAVORO
La decadenza è una modalità di estinzione dei diritti che opera esclusivamente nei casi stabiliti dalla
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] ) pagina 103 di 105
legge o dall'autonomia privata, subordinata al mancato esercizio del diritto da parte del titolare entro
il termine stabilito.
Tra i pochi casi di decadenza di fonte legale vanno ricordati i brevi termini previsti ai fini
dell'impugnazione delle rinunzie e transazioni, così come il termine di 60gg previsto per
l'impugnazione del licenziamento.
La giurisprudenza ritiene nulle le clausole contrattuali di decadenza (individuali o collettive) tali da
rendere eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto: sono ritenute valide quelle
clausole contrattuali che prevedano termini non inferiori a 6 mesi, che comincino a decorrere solo
una volta cessato il rapporto di lavoro.
IL FONDO DI GARANZIA
Al fine di assicurare effettività dei diritti di carattere retributivo spettanti ai lavoratori, l'ordinamento
impone limiti alla possibilità di aggressione dei crediti di lavoro da parte dei creditori del datore di
lavoro:
– le somme dovute a titolo di retribuzione (o <<di altre indennità relative al rapporto di lavoro>>)
possono essere pignorate nella misura di un quinto (con eccezione dei crediti alimentari, con
riguardo ai quali la misura del pignoramento sarà quella autorizzata dal tribunale);
– pari limiti sono imposti al sequestro dei crediti di lavoro ed alla loro assoggettabilità a
compensazione.
E' stata inoltre prevista, in favore dei crediti di lavoro, una causa legittima di prelazione: alle
<<retribuzioni dovute [..] ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro>> è riconosciuto un privilegio generale sui mobili del datore di
lavoro. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, tali crediti sono collocati sussidiariamente sul
prezzo degli immobili, con preferenza rispetto a crediti chirografari; nell'ambito di tali crediti, ulteriore
preferenza è riconosciuta ai crediti relativi al TFE ed all'indennità di mancato preavviso.
Qualora il patrimonio del debitore risulti insolvente, a tutela dei lavoratori, è stato esteso l'ambito di
applicazione della disciplina del Fondo di Garanzia: è così assicurato il pagamento (previo
accertamento giudiziale del relativo credito) del pagamento delle retribuzioni periodiche non versate
dal datore di lavoro, limitatamente a quelle inerenti agli <<ultimi tre mesi del rapporto di lavoro>>, e
comunque per un importo non superiore (come stabilito dalla Corte di Giustizia) <<ad una somma
pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al
netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali>>.
LA TUTELA GIUDIZIALE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
Competente a trattare le controversie di lavoro (con riguardo sia a ai rapporti di lavoro subordinato
privato, sia quelle dei pubblici dipendenti “privatizzati”) in primo grado è il Tribunale in composizione
monocratica (ed in secondo grado la Corte d'Appello).
Il processo di lavoro riceve una tutela giudiziale differenziata, caratterizzata da <<strumenti ispirati a
principi di oralità, concentrazione ed immediatezza>>; le regole processuali sono organizzate in
modo da evitare espedienti dilatatori:
– nel ricorso introduttivo devono essere contenuti la determinazione dell'oggetto della domanda,
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda e le relative conclusioni,
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui ci si intende avvalere;
– nella memoria di costituzione il convenuto deve prendere posizione sui fatti affermati dall'attore
ed è tenuto a farlo <<in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione>>; deve
altre <<proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto>> ed indicare, a pena di decadenza, mezzi
di prova e documenti che si intendono utilizzare nel processo.
Al fine di assicurare tutela dei diritti che si assumono lesi, il giudice è munito di ampli poteri istruttori:
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] ) pagina 104 di 105
può disporre in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova (anche prescindendo dai
limiti stabiliti dal codice civile, eccezion fatta per il giuramento decisorio).
Onde rendere giustizia in tempi rapidi, è fatto espresso divieto di udienze di mero rinvio.
Nell'udienza fissata per la discussione della causa, il giudice, dopo l'interrogatorio libero delle parti,
tenta la conciliazione della lite: esito positivo del tentativo viene riprodotto in un verbale cui si
riconosce efficacia esecutiva; diversamente il processo prosegue sino alla pronuncia di sentenza la
quale è provvisoriamente esecutiva. Il giudice d'appello potrà sospenderne l'esecutorietà qualora
ricorrano <<gravi motivi>> nel caso la sentenza sia a favore del datore di lavoro; e solo qualora da
essa possa derivare <<un gravissimo danno>> alla controparte, qualora sia a favore del lavoratore.
La sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro comporta il diritto a
percepire (oltre alla somma capitale) ulteriori attribuzioni patrimoniali a titoli di interessi.
LA TUTELA STRAGIUDIZIALE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
Il legislatore è intervenuto (nel 1998) onde rafforzare gli strumenti di composizione stragiudiziale delle
controversie di lavoro: il tentativo di conciliazione è stato reso obbligatorio, da espletarsi entro 60gg
dalla presentazione della richiesta innanzi ad una commissione di conciliazione, istituita presso la
direzione provinciale del lavoro.
Ulteriore forma di conciliazione stragiudiziale (limitata alle controversie a contenuto patrimoniale) è
stata introdotta nell'ordinamento con il d.lgs. 124/2004: la conciliazione monocratica (così definita
perché gestita da un solo funzionario amministrativo) può avere luogo qualora a seguito di una
richiesta d'intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro, <<emergano elementi per una
soluzione conciliativa della controversia>>.
dispense di Diritto del Lavoro a cura di Paolo Meola (info: e-mail & msn
[email protected] ) pagina 105 di 105