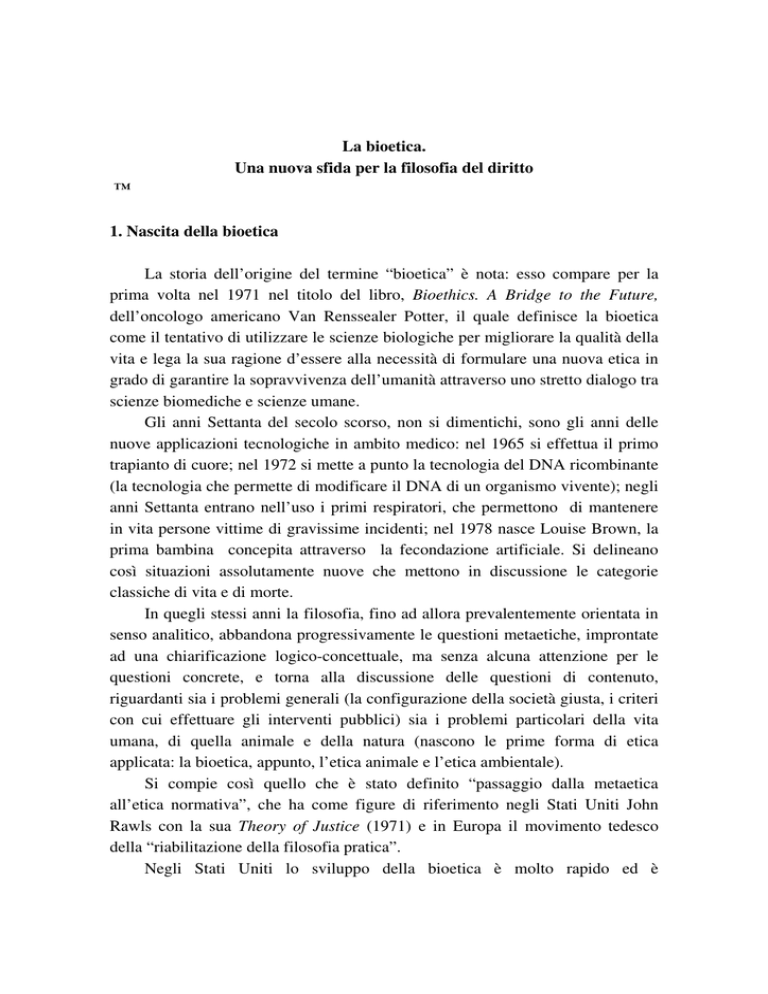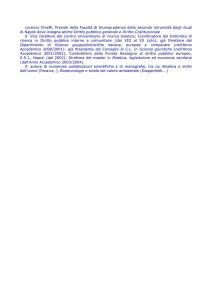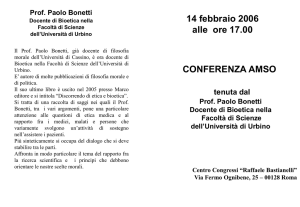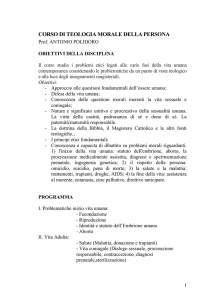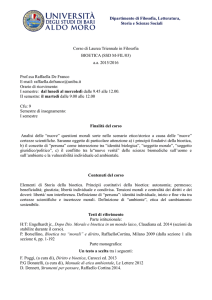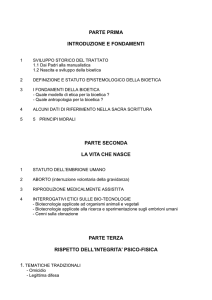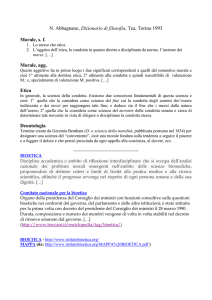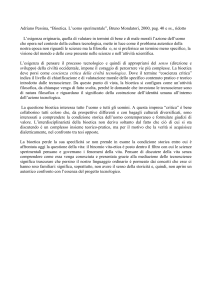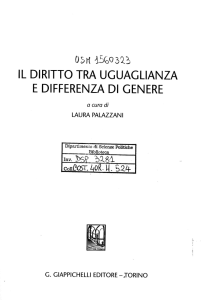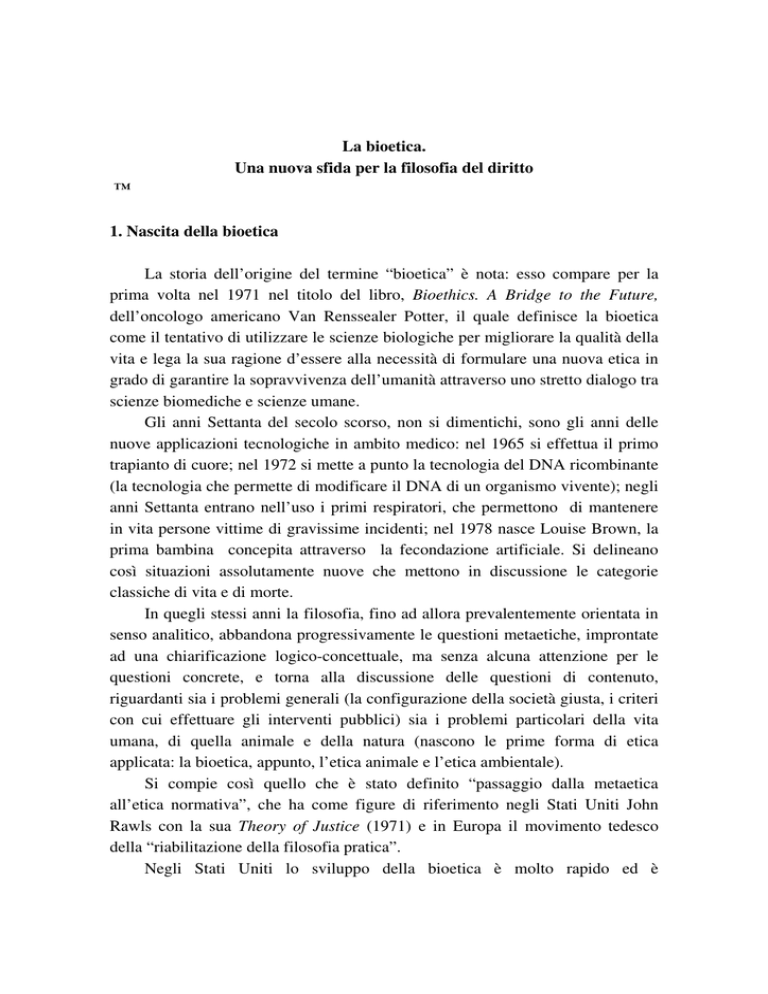
La bioetica.
Una nuova sfida per la filosofia del diritto
™
1. Nascita della bioetica
La storia dell’origine del termine “bioetica” è nota: esso compare per la
prima volta nel 1971 nel titolo del libro, Bioethics. A Bridge to the Future,
dell’oncologo americano Van Renssealer Potter, il quale definisce la bioetica
come il tentativo di utilizzare le scienze biologiche per migliorare la qualità della
vita e lega la sua ragione d’essere alla necessità di formulare una nuova etica in
grado di garantire la sopravvivenza dell’umanità attraverso uno stretto dialogo tra
scienze biomediche e scienze umane.
Gli anni Settanta del secolo scorso, non si dimentichi, sono gli anni delle
nuove applicazioni tecnologiche in ambito medico: nel 1965 si effettua il primo
trapianto di cuore; nel 1972 si mette a punto la tecnologia del DNA ricombinante
(la tecnologia che permette di modificare il DNA di un organismo vivente); negli
anni Settanta entrano nell’uso i primi respiratori, che permettono di mantenere
in vita persone vittime di gravissime incidenti; nel 1978 nasce Louise Brown, la
prima bambina concepita attraverso la fecondazione artificiale. Si delineano
così situazioni assolutamente nuove che mettono in discussione le categorie
classiche di vita e di morte.
In quegli stessi anni la filosofia, fino ad allora prevalentemente orientata in
senso analitico, abbandona progressivamente le questioni metaetiche, improntate
ad una chiarificazione logico-concettuale, ma senza alcuna attenzione per le
questioni concrete, e torna alla discussione delle questioni di contenuto,
riguardanti sia i problemi generali (la configurazione della società giusta, i criteri
con cui effettuare gli interventi pubblici) sia i problemi particolari della vita
umana, di quella animale e della natura (nascono le prime forma di etica
applicata: la bioetica, appunto, l’etica animale e l’etica ambientale).
Si compie così quello che è stato definito “passaggio dalla metaetica
all’etica normativa”, che ha come figure di riferimento negli Stati Uniti John
Rawls con la sua Theory of Justice (1971) e in Europa il movimento tedesco
della “riabilitazione della filosofia pratica”.
Negli Stati Uniti lo sviluppo della bioetica è molto rapido ed è
accompagnato dalla nascita delle prime strutture di ricerca: nel 1969 l’Hasting
Center, fondato dal filosofo Daniel Callahan; nel 1971 il Kennedy Center alla
Georgetown University, diretto da Warren Reich, che nel 1978 curerà la prima
grande opera di riferimento in ambito bioetico l’Encyclopedia of Bioethics. Negli
anni Ottanta e Novanta la bioetica si diffonde anche in Europa e nelle altre
nazioni tanto da poter essere definita “un fenomeno planetario” e si sviluppa a
due livelli: quello culturale e quello istituzionale attraverso centri e associazioni.
2. Ambiti tematici
Gli ambiti tematici coperti da questo neologismo sono molto vasti e vanno
costantemente ampliandosi con il progredire delle ricerche scientifiche e delle
loro applicazioni. Accanto alle problematiche strettamente biomediche si
collocano nell’ambito della bioetica, intensa in senso ampio, anche i temi della
tutela e dei diritti degli animali e della conservazione dell’ambiente.
Quanto alla bioetica medica si spazia dall’aborto all’eutanasia, dalla
procreazione medicalmente assistita all’ingegneria genetica, dal rapporto medicopaziente, al trapianto d’organi, alla sperimentazione sulle cellule staminali (delle
cellule cioè capaci di rigenerare dei tessuti danneggiati, in alcuni casi ricavate da
embrioni, cellule staminali embrionali, in altri da tessuti adulti).
La bioetica animalista si è sviluppata anch’essa all’inizio degli anni ’70 con
la pubblicazione di uno dei “testi sacri” dell’animalismo contemporaneo, Animal
Liberation, 1975, di Peter Singer (La liberazione animale, tr. It. 1991).
Le tesi di Singer sono ispirate all’utilitarismo di derivazione benthamiana:
poiché il piacere e la sofferenza fanno la differenza sul piano morale, allora
dobbiamo fare in modo – sostiene Singer – di minimizzare le sofferenze e
massimizzare il piacere sia con riferimento agli uomini sia con riferimento agli
animali. Singer introduce differenze tra i tipi di animali, cioè tra quelli che hanno
solo coscienza, del dolore appunto, e quelli che hanno anche autocoscienza (ad
esempio i mammiferi adulti).
Il tema dell’autocoscienza è ripreso e sviluppato dall’altro autorevole
esponente della lotta a favore degli animali, Tom Regan, autore di The Case for
Animal Rights, 1983 (I diritti animali, tr. It, 1990), opera nella quale egli cerca di
costruire una vera e propria teoria dei diritti degli animali.
Per Regan la presenza di autocoscienza rende gli animali (non umani e
umani) dotati di un valore peculiare, che egli chiama “valore inerente” e sul quale
fonda l’idea di attribuire diritti agli animali in quanto tali: se infatti – egli
argomenta – vengono attribuiti diritti agli esseri umani autocoscenti, non si
possono escludere tutti gli altri mammiferi dotati, al pari degli esseri umani, di
autocoscienza.
Quanto alla bioetica ambientale si possono individuare almeno due correnti:
quella dei conservazionisti (una delle voci più rappresentative di questa linea di
pensiero è considerato John Passmore, autore di Man’s Responsibility for Nature,
1974), i quali sostengono, partendo da un punto di vista antropocentrico, che la
natura è un bene al servizio dell’uomo e quindi va tutelato per motivi di utilità; e
quella dei preservazionisti (interessante la prospettiva di Paul W. Taylor, autore
di Respect for Nature. A Theory of Environmental Ethics, 1986), i quali, partendo
da una prospettiva biocentrica, ritengono che la terra e l’ambiente in genere siano
dotati di un valore intrinseco e quindi vadano rispettati per loro stessi.
Queste tesi sono state riprese dai movimenti della cosiddetta Deep Ecology
o ecologia profonda, contrapposti alla Shallow Ecology o ecologia di superficie.
Come si vede da questi semplici accenni il panorama è vastissimo.
Ma, se possiamo considerare ormai pacifica l’individuazione per grandi
linee del campo di studio della bioetica, costituito dalla chiarificazione e/o dalla
soluzione delle questioni etiche poste dagli interventi delle scienze e delle
tecnologie sulla vita dell’uomo e del suo ambiente, assai più controversa è la
definizione della natura della bioetica: se essa, sia, cioè, una mera disciplina
filosofica, collocabile nell’ambito dell’etica applicata o piuttosto un insieme di
ricerche su temi che rappresentano un terreno comune di riflessione tra varie
discipline riconducibili sia all’area delle scienze umane, come la filosofia, il
diritto o la sociologia, sia all’area delle scienze naturali, come la medicina e la
biologia.
Ridurre la bioetica nel suo insieme alla sola riflessione filosofica significa
ignorare da un lato l’apporto alla soluzione delle questioni della ricerca e della
pratica medica di chi vive queste realtà (medici, biologici, psicologi) e, dall’altro,
il contributo alla discussione che può venire solo dall’apporto ad un dibattito
aperto dai cultori di altre discipline, quali il diritto, la sociologia, l’economia ecc.
In questo senso si può individuare tra le caratteristiche intrinseche della
bioetica la multidisciplinarietà, da intendersi come occasione per l’incontro, lo
scambio e la discussione tra le diverse discipline in un rapporto paritario.
Ritenere al contrario che il ruolo nel dibattito bioetico dei saperi diversi dalla
filosofia sia meramente strumentale ad essa e che consista nell’apporto di dati
empirici da valutare o nella pura applicazione di idee elaborate in sede filosofica,
significa impoverire la capacità delle diverse discipline di riflettere su loro stesse,
di interagire e di comunicare tra di loro.
In questa prospettiva la bioetica si configura realmente come terreno ideale
per realizzare una relazione di interfaccia tra scienze naturali e scienze
umanistiche, nella quale la coesistenza delle varie discipline è tesa ad
un’integrazione e non ad una semplice giustapposizione delle diverse prospettive
scientifiche in vista della soluzione pratica dei problemi concreti: in questo senso
la multidisciplinarietà della bioetica si configura come un obbiettivo da
raggiungere, un punto d’arrivo piuttosto che una base di partenza.
3. Principali approcci morali
Fin dalla sua nascita la bioetica si è caratterizzata quale riflessione
orientata secondo le teorie etiche fondamentali; per citare solo le più influenti,
l’utilitarismo, il principialismo, la teoria della legge naturale, che hanno cercato
di individuare soluzioni ai problemi bioetici tramite procedure di giustificazione
dei giudizi morali.
Secondo la prospettiva utilitarista, la bontà di un’azione dipende
unicamente dalle sue conseguenze (consequenzialismo) e ciò che è rilevante per
queste conseguenze è l’utilità concepita come felicità o benessere, a seconda
delle varie versioni dell’utilitarismo (sostenitori di questo approccio a livello
bioetico sono importanti autori come Peter Singer, Helga Khuse e James
Rachels).
Secondo il principialismo, sviluppato soprattutto da Tom. L. Beauchamp e
James F. Childress, le questioni bioetiche vanno affrontate alla luce di alcuni
principi “evidenti intuitivamente”, ma “non assoluti”, quali l’autonomia, in
quanto capacità di libera scelta di ogni essere umano; la beneficenza, cioè il fatto
che le nostre azioni verso gli altri devono sempre essere indirizzate al loro bene;
la non maleficenza, cioè il fatto che le nostre azioni non devono mai provocare
un danno agli altri; e la giustizia, intesa come equità nella distribuzione delle
risorse mediche. Tali principi costituirebbero un terreno comune di discussione e
vanno bilanciati fra di loro nei casi di conflitto e specificati in coerenza con i
nostri giudizi ponderati (intuizioni comuni) finché non si giunge ad un equilibrio
soddisfacente.
Secondo la teoria della legge naturale, esistono beni che sono
fondamentali e inviolabili, vista la loro importanza metafisica nell’ordine del
creato, quindi secondo una legge naturale, e non sono fra loro scambiabili: non è,
ad esempio, possibile barattare la vita, uno dei beni assoluti, con la felicità (è la
prospettiva seguita, in particolare, da pensatori cattolici come John Finnis).
L’individuo (medico, infermiere, paziente, ricercatore ecc.) che deve
fronteggiare un caso problematico può giungere alla soluzione giusta ricorrendo
agli strumenti offerti da questi modelli teorici. La bioetica è stata a lungo pensata
come la semplice applicazione di teorie generali alla casistica particolare.
Facciamo un esempio: l’eutanasia. Se una persona si trova in una
situazione di sofferenza particolarmente grave e non è in grado di togliersi la vita
da sè, è moralmente lecito ad un dottore o ad altri soggetti farlo per lui?
Secondo l’utilitarismo la risposta può essere fornita solo giudicando le
conseguenze: se per la persona la situazione è insopportabile, permettendogli di
morire diminuiamo la sua sofferenza e aumentiamo la sua felicità. Peter Singer
sostiene che le eventuali resistenze a queste argomentazioni sono solo il rettaggio
di convinzioni tradizionali non adeguate ai nuovi problemi posti dalla tecnica;
James Rachels distingue tra vita biologica e vita biografica e sostiene che ciò che
conta non è il sostrato biologico, ma la vita come esistenza personale, quindi il
danneggiamento del corpo non è moralmente rilevante.
Secondo la prospettiva della legge naturale, al contrario, il bene della vita
è assoluto e quindi non lo si può confrontare con niente altro. E’ indifferente che
il nostro intento sia quello di alleviare le sofferenze di un malato. Un’azione
indirizzata a violare un bene inviolabile come la vita, a prescindere da qualunque
altra condizione, è immorale.
Secondo il principalismo l’obbligo di curare il malato, che risponderebbe
al principio della beneficenza e a quello di non maleficienza, vale a dire l’obbligo
di non causargli un danno, non sono assoluti e vanno bilanciati con gli altri
principi, ad esempio quello dell’autonomia del malato che sceglie di morire. In
situazioni specifiche, quindi, l’eutanasia può risultare moralmente legittima per
rispettare l’autonomia individuale.
4. La particolarità della situazione italiana: bioetica cattolica e bioetica laica
Nel nostro paese gli approcci sviluppati secondo questi termini di
riferimento si sono intersecanti con la contrapposizione tra etica laica ed etica
cattolica; sebbene il confronto tra queste due prospettive sia stato talvolta
fecondo, l’opposizione che si è generata corre oggi il rischio di cristallizzarsi
eccessivamente dando talvolta luogo a dispute ideologiche.
Le ragioni della particolarità dello sviluppo della bioetica in Italia sono di
varia natura, culturale e storica. La bioetica, come si è detto, è nata dapprima
negli Stati Uniti in connessione, da un lato, allo sviluppo delle ricerche
tecnologiche e alla loro applicazione in ambito medio e, dall’altro, a quello che
abbiamo definito “passaggio dalla metaetica all’etica normativa”, vale a dire il
progressivo abbandono delle ricerche metaetiche di ispirazione analitica e il
rinnovato interesse per i concreti e specifici problemi morali.
In Italia entrambi questi fattori si sono manifestati con un certo ritardo: lo
sviluppo delle ricerche in ambito medico è stato più lento e i maggiori esponenti
della cultura laica, di orientamento analitico, tranne alcune eccezioni, fra le quali
la più significativa quella rappresentata da Uberto Scarpelli, guardavano con
perplessità a una forma di etica applicata, come la bioetica, considerata un
inquinamento della purezza del discorso logico-scientifico. Parallelamente la
cultura cattolica manifestava un crescente interesse per le problematiche
bioetiche, considerandole alla luce di una seconda rinascita del giusnaturalismo,
dopo la prima rinascita del dopoguerra.
Di fronte a quella che è stata definita “l’invasione del terreno da parte
della cultura cattolica”, sin dagli anni Ottanta Scarpelli ha vigorosamente difeso
una concezione della bioetica come indagine razionale e libera, tesa a tutelare e
garantire le libertà individuali: una bioetica laica, appunto. Laico è infatti per
Scarpelli chi ragiona “etsi Deus non daretur”: essere laico non implica affatto né
l’agnosticismo né l’ateismo, ma solo l’esclusione di premesse metafisiche o
religiose che pretendano di valere per tutti. Chi è laico in questo senso può
benissimo essere religioso e aver fede in un Dio rivelato, purché ammetta che
tale fede è al di là della razionalità umana e non può costituire argomentazione
conclusiva di un ragionamento razionale di un’etica senza verità.
Il contributo di Scarpelli è stato determinante nel delineare un indirizzo
che ha trovato nel Manifesto di bioetica laica (estensori C. Flamigni, A.
Massarenti, M. Mori e A. Petroni, pubblicato in “Il sole 24 ore” del 9 giugno
1996) un primo momento di definizione e che, a oltre dieci anni di distanza,
mantiene tutta la sua validità, in un contesto storico in cui – come sostiene
Geminello Preterossi nell’introduzione di un libro recente, Le ragioni dei laici –
gli attacchi alla laicità sono stati diversi, ma, sotto il comune denominatore di un
“uso politico della religione”, tutti volti a delegittimare l’eredità della cultura
laica moderna e i suoi portati storici, tra i quali la distinzione tra diritto e morale,
tra politica e religione, la difesa dei principi di eguaglianza e di legalità che
implicano parità di trattamento e divieto di discriminazione.
Per sottolinearne l’attualità, riporto alcuni pezzi di quel Manifesto:
«I primi principi della visione laica – vi si legge – riguardano la natura della
conoscenza e del suo progresso.
In primo luogo, diversamente da quanto fanno la gran parte delle etiche
fondate su principi religiosi, la visione laica considera che il progresso della
conoscenza sia esso stesso un valore etico fondamentale. L’amore della
verità è uno dei tratti più profondamente umani, e non tollera che esistano
autorità superiori che fissino dall’esterno quel che è lecito e quel che non è
lecito conoscere.
In secondo luogo la visione laica vede l’uomo come parte della natura, non
come opposto alla natura. Essendo parte della natura, egli può interagire con
essa, conoscendola e modificandola nel rispetto degli equilibri e dei legami
che lo uniscono alle altre specie viventi.
In terzo luogo, la visione laica vede nel progresso della conoscenza la fonte
principale del progresso dell’umanità, perché è soprattutto dalla conoscenza
che deriva la diminuzione della sofferenza umana. Ogni limitazione della
ricerca scientifica imposta nel nome dei pregiudizi che questa potrebbe
comportare per l’uomo equivale in realtà a perpetuare sofferenze che
potrebbero essere evitate […].
Al contrario di coloro che divinizzano la natura, dichiarandola un qualcosa
di sacro e di intoccabile, i laici sanno che il confine tra quel che è naturale e
quel che non lo è dipende dai valori e dalle decisioni degli uomini. Nulla è,
più culturale dell’idea di natura. Nel momento in cui le tecnologie
biomediche allargano l’orizzonte di quel che è fattualmente possibile, i
criteri per determinare ciò che è lecito e ciò che non lo è non possono in
alcun modo derivare da una pretesa distinzione tra ciò che sarebbe naturale e
ciò che naturale non sarebbe. Essi possono soltanto derivare da principi
espliciti, razionalmente giustificati in base a come essi riescono a guidare
l’azione umana a beneficio di tutti gli uomini.[……]
Il primo dei principi che ispira noi laici è quello dell’autonomia. Ogni
individuo ha pari dignità, e non devono esservi autorità superiori che
possano arrogarsi il diritto di scegliere per lui tutte quelle questioni che
riguardano la sua salute e la sua vita. Questo significa che la sfera delle
decisioni individuali in questioni come l’eutanasia, la somministrazione di
nuovo farmaci, la sperimentazione di nuove terapie, deve venire allargata al
di là di quanto oggi non accada […].
Il secondo principio è quello di garantire il rispetto delle convinzioni
religiose dei singoli individui. Noi laici non osteggiamo la dimensione
religiosa. La apprezziamo per quanto possa contribuire alla formazione di
una coscienza etica diffusa. Quando sono in gioco scelte difficili, come
quelle della bioetica, il problema per il laico non è quello di imporre una
visione ‘superiore’, ma di garantire che gli individui possano decidere per
proprio conto ponderando i valori talvolta tra loro confliggenti che quelle
scelte coinvolgono, evitando di mettere a repentaglio le loro credenze e i
loro valori. Questo rispetto per le convinzioni religiose non ci fa tuttavia
dimenticare che dalla fede religiosa non derivano di per sé prescrizioni e
soluzioni precise alle questioni della bioetica. Vi può essere una discussione
e una giustificazione razionale dei principi morali anche senza la fede. Vi
può essere una discussione e una giustificazione razionale che parte dai
presupposti della fede. Ma non vi può essere alcuna derivazione automatica
di una giustificazione razionalmente accettabile a partire dalla sola fede.
Il terzo principio è quello di garantire agli individui una qualità della vita
quanto più alta possibile, di contro al principio che fa della mera durata
della vita il criterio dominante della terapia medica. Se vi è un senso nella
espressione ‘rispetto della vita’ questo non può risiedere nel separare un
concetto astratto di ‘vita’ dagli individui concreti, che hanno il diritto di
vivere e morire con il minimo di sofferenza possibile.
Il quarto principio è quello di garantire a ogni individuo un accesso a cure
mediche che siano dello standard più alto possibile, relativamente alla
società nella quale egli vive e alle risorse disponibili. Si tratta di una
conseguenza di quell’idea di equità che ispira i rapporti sociali nelle
democrazie moderne, e che rispetta sia i sentimenti di libertà sia i sentimenti
di uguaglianza profondamente diffusi tra i cittadini.
Noi siamo consapevoli che se all’equità non verrà dato un contenuto reale, i
progressi delle tecnologie biomediche rischiano di non diventare accessibili
ai membri più deboli della società.
I principi sopra enunciati si fondano a loro volta su di un assunto implicito:
la separazione della sfera morale da quella della fede religiosa. In modo
analogo, è proprio della visione laica tenere distinti i piani della morale e del
diritto. Per i laici, i principi morali si fondano sull’adesione volontaria da
parte degli individui. La loro diffusione deriva dall’accordo consapevole che
essi ricevono. Come tali, essi sono diversi dalle norme giuridiche, le quali
inevitabilmente vincolano l’individuo in base a sanzioni imposte
dall’esterno. Se è infatti vero che laddove non vi è consenso morale è pur
necessario che esitano norme giuridiche che evitino quanto possibile il
conflitto tra i diversi valori.
Questa distinzione è particolarmente rilevante per l’ambito biomedico.
Come ogni altra sfera dell’attività umana, anche questa ha bisogno sia di
principi morali che di norme giuridiche. Ma il peso relativo delle una e delle
altre è peculiare, e comunque diverso rispetto ad altre sfere, ad esempio
quella delle attività economiche […].
La società nella quale viviamo è una società complessa. E’ una società nella
quale convivono visioni diverse dell’uomo, visioni diverse della società,
visioni diverse della morale. Per questo è impossibile pensare che in un
campo come quello della bioetica, che tocca le concezioni e i sentimenti più
profondi dell’uomo, possa esistere un canone morale a vocazione
universale.
La visione laica della bioetica non rappresenta una versione secolarizzata
delle etiche religiose. Non vuole costituire una nuova ortodossia. Anche tra i
laici non vi è accordo unanime su molte questioni specifiche.
La visione laica si differenzia dalla parte preponderante delle visioni
religiose in quanto non vuole imporsi a coloro che aderiscono a valori e
visioni diverse. Là dove il contrasto è inevitabile, essa cerca di non
trasformarlo in conflitto, cerca l’accordo ‘locale’, evitando le
generalizzazioni. Ma l’accettazione del pluralismo non si identifica con il
relativismo, come troppo spesso sostengono i critici. La libertà della ricerca,
l’autonomia delle persone, l’equità, sono per i laici dei valori irrinunciabili.
E sono valori sufficientemente forti da costituire la base di regole di
comportamento che sono insieme giuste ed efficaci».
Ho riportato questa lunga citazione, perchè mi è sembrato importante
ricordare con le parole stesse degli estensori quei principi che suscitarono tanto
interesse e tanto intense discussioni non solo su riviste scientifiche, ma anche sui
giornali, discussioni che hanno segnato l’uscita del dibattito dall’ambito ristretto
degli esperti e l’apertura al grande pubblico e hanno comportato un chiarimento
del tanto contestato aggettivo “laico”, aggettivo al quale Francesco D’Agostino,
tra i maggiori esponenti della “bioetica cattolica”, aveva proposto in tema di
bioetica di rinunciare.
Nella replica gli estensori del Manifesto ribadiscono che laico è sinonimo
di atteggiamento razionale, critico, scevro da pregiudizi dogmatici, aperto al
pluralismo delle varietà delle visioni del mondo – laiche o religiose che siano – e
che la bioetica laica pluralista lo è nei fatti, quasi per definizione, per la natura
stessa dei problemi di cui si occupa.
Laico quindi è usato non in contrapposizione a religioso, bensì a
dogmatico, ma anche nella sua accezione più forte sopra descritta. Tuttavia
viene ribadito che il ragionamento “etsi Deus non daretur” non è volto a
impedire che ognuno persegua liberamente le proprie convinzioni religiose.
Una laicità, sotto questo profilo, quale è storicamente incorporata nelle
giurisdizioni moderne, fondate sulla separazione tra religione e Stato e presente
anche nella Costituzione italiana, come è stato riconosciuto, tra le altre, dalla
sentenza n. 203 del 1989, nella quale la Corte Costituzionale afferma: «Il
principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione,
implica non indifferenza dello Stato di fronte alle religioni, ma garanzia dello
Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo
culturale».
Una laicità oggi riconosciuta anche a livello europeo, dopo che la Carta di
Nizza e il testo della Costituzione europea hanno scelto, anche se tra accese
polemiche, di non fondare l’Unione sulle “radici cristiane” al fine di non
accedere alla confessionalizzazione del testo costituzionale e di dare spazio al più
ampio pluralismo.
I valori e i principi della bioetica laica, sono principalmente, come
abbiamo visto rileggendo il Manifesto, quelli dell’autonomia della persona e del
pluralismo.
Entrambi questi principi sono stati e sono oggetto di critiche aspre da parte
della cultura cattolica.
Quanto al primo, l’accusa è di libertarismo o arbitrarismo, vale a dire che
gli individui sarebbero liberi di agire come meglio ritengono. I bioeticisti laici
ribattono respingendo l’identificazione delle libertà individuale con una forma di
“autonomismo selvaggio” e puntualizzando che la libertà individuale è soggetta a
condizioni e limiti, a partire dalla responsabilità individuale. Demetrio Neri, ad
esempio, evidenzia come sia la stessa autonomia ad assegnare ad ognuno di noi
la responsabilità per ciò che decidiamo con la conseguenza che è propria la
connessa responsabilità ad assegnare a tale principio rilevanza morale.
Quanto al secondo, l’accusa è di relativismo.
I bioeticisti laici ritengono indubbio che l’esigenza di universalizzabilità
sia un aspetto essenziale dell’etica (in ossequio al principio kantiano che primo
dovere morale dell’uomo è rinunciare alla pretesa di fare delle proprie personali
credenze il modello del conoscere e dell’agire), con la conseguenza che i giudizi
morali o sono universalizzabili o non sono morali, ma negano la loro
assolutizzazione metafisica e metastorica. In altre parole, non essendo i valori
morali oggettivi e conoscibili, preesistenti all’uomo, bensì sue creazioni, essi
partecipano della sua storicità.
La bioetica cattolica, per contro, come possiamo esemplificare citando
Francesco D’Agostino, già indicato come uno tra gli esponenti più
rappresentativi di essa, si fonda su altri principi: il principio della difesa della vita
fisica, che sancisce l’inviolabilità della vita, in quanto la vita corporea, fisica, è
“il valore fondamentale della persona”; il principio di libertà e di responsabilità,
che implica sia la responsabilità di trattare il malato come persona sia la libertà
del medico di non aderire a richieste ritenute inaccettabili dalla coscienza morale;
il principio della totalità, che afferma che è lecito intervenire sulla vita fisica
della persona solo se ciò è necessario per salvaguardarne la totalità unitaria e
inscindibili di corpo-psiche-spirito; il principio di sussidarietà e solidarietà che
impegna ogni persona in virtù della costitutiva e ontologica relazionalità a vivere
partecipando alla realizzazione dei propri simili.
Come hanno dimostrato esempi recenti – quali il referendum sulla
procreazione medicalmente assistita e il caso Welby – il confronto tra le due
prospettive, laica e cattolica, che, peraltro, non costituiscono blocchi unitari, ma
sono estremamente diversificate al loro interno, ha dato spesso luogo a dispute
ideologiche, cristallizzando e bloccando il dibattito sullo scontro tra principi:
disponibilità o indisponibilità della vita; lo statuto dell’embrione, vale a dire se
sia o non sia persona ecc.
5. L’etica della cura come approccio alternativo
Per uscire da questa contrapposizione tra principi che risulta alquanto
sterile, io credo sia utile guardare con attenzione ad una prospettiva, quella
dell’etica della cura, nata negli stati Uniti nell’ambito del dibattito femminista
degli anni Settanta-Ottanta, che comincia a circolare anche in Italia nel contesto
degli studi di genere e tende, però, alla definizione di un approccio teorico
generale, che tenga conto della importanza della diversità sessuale, ma non si
limiti a questo ordine di considerazioni.
L’etica della cura richiama la nostra attenzione in primo luogo sul fatto che
siamo individui in relazione con altri individui, con cui condividiamo impegni,
speranze, affetti. Questo punto di partenza indica che la semplice raffigurazione
delle persone come atomi possessori di diritti, libertà e obblighi è una
semplificazione che trascura completamente il lato della emotività e delle
responsabilità. A partire dal pionieristico lavoro di Carol Gilligan (in a Differente
Voice: Psychological Theory and Women’s Development, 1982; tr. it. Con voce di
donna, Milano, 1987) - secondo cui le donne sono inclini a valorizzare il
prendersi cura riferito ad un contesto specifico e alla particolarità delle relazioni
umane mentre gli umani agiscono sulla base di principi - e con i successivi
contributi dell’etica femminista e delle riflessioni di genere, si è affermata
l’esigenza di pensare la vita morale non come conflitto e risoluzione razionale,
ma come cura e responsabilità verso gli altri, come riconoscimento del carattere
sempre contestuale delle nostre decisioni morali, su cui influiscono
l’appartenenza di genere, le storie personali, culturali e sociali.
Nonostante i limiti a cui è soggetto il lavoro di Gilligan e di altri studiosi
sull’etica della cura e sulla riflessione di genere, bioeticisti e professionisti
sanitari vi possono trovare una particolare pertinenza con le questioni della
bioetica e dell’assistenza medica.
In generale, all’etica della cura si richiede quindi lo sforzo di mettere in
discussione certe categorie tradizionali senza tuttavia proporre un definitivo
superamento della riflessione sui diritti, sui doveri e sulle libertà: la meta più
appropriata sembra quella di un’integrazione tra un’etica della giustizia o dei
principi e un’etica della cura. La crucialità dei problemi sollevati dalle nuove
biotecnologie rende necessario che la riflessione contestuale sulla cura si rivolga
non tanto a misurare la giustezza delle scelte, quanto le motivazioni che possono
indurre a compiere una scelta invece che un’altra. La natura interdisciplinare della
bioetica può senza dubbio risultare utile per enucleare dimensioni come il
rapporto psiche-corpo, le raffigurazioni simboliche legate alla dimensione sociale
di attività, pratiche e processi come la nascita e la morte oppure le discriminazioni
nascoste in tecniche che solo apparentemente promuovono la libertà degli
individui.
Più in generale, l’ambito dell’etica della cura concentra l’attenzione su
tutte quelle capacità che, pur non essendo direttamente conducibili alla “ragione”,
sono tuttavia essenziali per la vita morale: fra tutte l’immaginazione, le emozioni
e la fantasia, intese come facoltà che possono aiutarci a capire meglio i bisogni e
le sofferenze dell’altro e ad orientare le nostre scelte.
A proposito delle emozioni, ad esempio scrive M. Nussbaum:
“Invece di vedere la moralità come un sistema di principi che può
essere colto dal freddo intelletto e le emozioni come le motivazioni
che favoriscono o sovvertono la nostra decisione di agire secondo i
principi stessi, dovremmo considerarle come parte costitutiva del
sistema del ragionamento etico … Dobbiamo misurarci con il caotico
materiale del dolore e dell’ansia, della rabbia e della paura, e con il
ruolo che queste tumultuose esperienze giocano nel pensiero riguardo
al bene e al giusto”.
Questa impostazione costringe a ripensare radicalmente la natura e il ruolo
delle emozioni nel nostro ragionamento pratico. Esse non sono mere forze
irrazionali da tenere a freno se si vuole condurre un’adeguata vita morale ma
costituiscono forme di giudizio cognitivo e valutativo, in quanto sono
strettamente correlate agli impegni e ai valori a cui aspira la persona che le prova.
Soprattutto in situazioni tragiche – esperienze di malattia, morte, dolore che
riguardano noi stessi o persone a noi vicine – le emozioni disvelano le cose a cui
attribuiamo valore e che consideriamo essenziali perché le nostre vite siano
completamente riuscite.
Alcuni dei temi e delle questioni cruciali in bioetica subiscono mutamenti
significativi quando vengono analizzati dal punto di vista della etica della cura.
Riprendiamo l’esempio dell’eutanasia: molti degli argomenti proposti nel
dibattito contemporaneo, come si è visto, sono stati formulati nel linguaggio dei
diritti e in particolare del diritto di autodeterminazione. Tuttavia, tale prospettiva
trascura la relazionalità che è costitutiva della personalità e della stessa
autonomia del paziente che richiede l’assistenza al suicidio o l’eutanasia. Il
dibattito sull’ipotesi di legittimare il suicidio medicalmente assistito e l’eutanasia
si è sviluppato spesso tenendo conto di un paziente astratto, che non esiste, un
paziente che non ha genere, razza, ecc. Questo è lo stesso paziente generico che
figura nella maggior parte dei dibattiti bioetici. Solo una minima parte della
discussione si è concentrata sul modo in cui le differenze tra i pazienti potrebbero
alterare la loro eguaglianza. L’invasione estrema del proprio corpo, dovuta alla
medicalizzazione della morte e del morire porta a sostenere da un lato, il diritto a
non subire invasioni non volute del proprio corpo, ma dall’altro lato, induce a
tener conto della vulnerabilità e dell’isolamento in cui si trova il soggetto in tali
situazioni tragiche, le cui richieste di morte sono condizionate anche dal contesto
sociale, dalla rete di relazioni in cui è inserito e dalle modalità e dai limiti della
cura che gli è offerta. A questo livello il dibattito sull’eutanasia si intreccia con
quello sulle cure palliative, intese non solo come insieme di interventi finalizzati
all’eliminazione del dolore, ma come considerazione della situazione complessa
del malato con tutte le sue esigenze psicologiche e problemi relazionali. Dopo
tutto, il dibattito sul suicidio medicalmente assistito e sull’eutanasia ruota proprio
attorno a questioni su cui si è focalizzata la riflessione della prospettiva di
genere: cosa significa parlare dei diritti di auto-determinazione e di autonomia; la
conciliazione di questi diritti con i doveri medici di beneficenza e del prendersi
cura e come collocare questi aspetti in un contesto che include scarse competenze
e talvolta mancanza di capacità di assistenza delle famiglie, dei professionisti e
delle comunità, come pure effettive differenze e squilibri di potere e di risorse.
Sulla base di queste riflessioni, l’etica della cura suggerisce di coniugare la
specificazione rispetto al contesto con l’astrattezza dei principi.
6. Bioetica e filosofia del diritto
Data la multidisciplinarietà della bioetica, quale ruolo può svolgere la
filosofia del diritto? Mi soffermerò su due ambiti nei quali credo che l’apporto di
questa disciplina possa essere determinante:
1il primo ambito riguarda il problema se il diritto debba o no
disciplinare le questioni bioetiche e, in caso di risposta affermativa,
come devono essere le norme giuridiche che le regolano
2il secondo ambito concerne il grande tema dei diritti umani. Infatti
le nuove tecnologie biomediche possono migliorare la qualità della
vita, produrre benessere e così via, ma possono anche ledere diritti
di singoli e di gruppi, crescere le disuguaglianze, ecc.
6.1 Bioetica e diritto
Il problema dei rapporti tra bioetica e diritto ha come sfondo il tema più
generale del rapporto tra morale e diritto.
Nel corso della storia del pensiero filosofico-giuridico alla tesi della
connessione tra diritto e morale si è contrapposta la tesi della separazione tra
diritto e morale.
Lo scontro tra queste due opposte tesi è ben esemplificato da una polemica
scoppiata in Inghilterra a metà del secolo scorso sulla questione dell’opportunità
della repressione penale dell’omosessualità e della prostituzione. La
commissione a ciò nominata si era espressa negativamente, sostenendo, sulle
orme di John Stuart Mill (v. On liberty, 1859), il principio per cui, riguardo ai
comportamenti non offensivi per il prossimo (le self regarding actions, secondo
la definizione di Mill) non deve esserci interferenza da parte del diritto che deve
riguardare solo gli atti che recano un danno a terzi. A difesa di questo principio si
era espresso un celebre filosofo del diritto Herbert Hart, suscitando la reazione
polemica di Lord Patrick Devlin che obiettò che una morale condivisa – di cui, a
suo parere, le regole che condannano l’omosessualità e la prostituzione devono
essere considerate parte – è una componente irrinunciabile dell’organizzazione
sociale, nel senso che rappresenta un aspetto essenziale della struttura di una
società e ne determina l’identità in quanto tale. Di conseguenza la società ha la
facoltà di difendersi per evitare la propria distruzione, vietando gli atti che ne
distruggono le regole morali fondamentali.
Ho citato la polemica tra Hart e Devlin sul cosiddetto Wolfenden Report
perché le due posizioni sono emblematiche di due opposte ideologie: il
liberalismo e il moralismo giuridico. Il liberalismo sostiene che, salvo i casi di
harm to other (cioè di danni per altri), ciascuno dovrebbe essere lasciato libero di
scegliere i propri valori e fini, compatibilmente con un’uguale libertà di questo
tipo per tutti; mentre il moralismo giuridico considera la conservazione della
moralità di una società un valore meritevole di essere sostenuto dallo strumento
coercitivo del diritto.
All’una e all’altra posizione possono essere mosse numerose critiche. Al
liberalismo, ad esempio, si può obiettare che non esistono azioni propriamente
self regarding, perché ogni uomo non è un’isola e ogni azione del singolo ha
ricadute anche su altri; inoltre la neutralità circa i valori è solo apparente, perché i
principi che il liberalismo esalta, quali la libertà e l’autonomia, sono anch’essi
dei valori.
Al moralismo giuridico, invece, si può obiettare in primo luogo che è tutto
da dimostrare che ci sia un diritto della collettività prevaricante sui diritti
dell’individuo; poi che non c’è un’unica morale, perché la società è composta da
diversi individui, i quali, soprattutto nelle società multietniche, possono essere
portatori di differenti visioni morali, senza che una di esse assuma
necessariamente un carattere tanto prevalente e stabile da definirsi come la
morale del gruppo; inoltre le convinzioni morali possono essere aberranti e non si
vede perché il diritto debba preservarle o possono cambiare nel tempo,
producendo cambiamenti anche positivi nelle società che sarebbe assurdo
bloccare facendo uso del diritto.
Il discorso fatto fin qui circa i rapporti tra diritto e morale, fa, come si
diceva, da sfondo al problema specifico dei rapporti tra diritto e bioetica.
Semplificando e schematizzando si può dire che da una parte vi sono coloro che
nutrono dubbi o addirittura rifiutano una regolazione giuridica delle questioni
bioetiche; dall’altra quanti ritengono utile, se non necessario, che il diritto
disciplini i diversi ambiti della bioetica attraverso il cosiddetto biodiritto.
Cerchiamo di esaminare più da vicino le due posizioni che al loro interno
sono estremamente composite e diversificate. Tra gli avversari, per così dire,
della regolazione giuridica della bioetica alcuni, innanzitutto, temono che il
diritto possa creare ostacoli allo sviluppo scientifico; altri (soprattutto esponenti
di orientamenti religiosi) pensano che disciplinare, anche severamente e
restrittivamente, certe pratiche (ad es. procreazione medicalmente assistita o
eutanasia) significhi pur sempre leggittimarle; altri ancora ritengono che le
autoregolamentazioni della comunità scientifica (ad es. codici deontologici), i
pareri dei comitati etici; le dichiarazioni di principio adottate dalla comunità
internazionale dei medici e degli scienziati (Codice di Norimberga,
Dichiarazione di Helsinki e simili) siano sufficienti a garantire la correttezza
dell’operare; altri ancora che gli interventi giuridici nell’ambito della bioetica
costituiscano un’intrusione inaccettabile della sfera pubblica nella sfera privata
delle persone, imponendo quasi sempre modelli di comportamento conformi a
una particolare concezione morale.
Varie obiezioni possono essere mosse a queste posizioni: in primo luogo
che codici deontologici, dichiarazioni internazionali e simili valgono solo nella
misura in cui sono rispettati spontaneamente; inoltre che non ci sono ragioni per
lasciare in mano solo agli operatori sanitari la regolamentazione di questioni così
personali, ecc.
All’interno del partito degli avversari della regolazione giuridica delle
questioni bioetiche, una posizione a parte è occupata da coloro che ritengono che
non occorrono strumenti normativi nuovi con cui disciplinare le questioni
bioetiche in quanto ogni controversia può essere risolta ricorrendo al diritto che
c’è già, applicato in via analogica, o con il riferimento ai principi sanciti ad
esempio dalle costituzioni. Su questo punto è evidente che c’è grande differenza
tra i sistemi di Common Law più flessibili e i sistemi di Civil Law più rigidi.
Di fatto sia nei paesi di Common Law sia in quelli di Civil Law i giudici
delle corti supreme, ma anche di merito, devono spesso affrontare situazioni alle
quali fanno fronte ora adottando norme di leggi esistenti, ora modificando
precedenti giurisprudenziali, ora creando nuove norme giurisprudenziali
(svolgendo il ruolo che è stato detto di “fonte abusiva ma obbligata” di biodiritto)
Indagini empiriche della situazione, soprattutto europea, evidenziano che il
quadro delle risposte è disorganico, frammentario e limitato ad alcuni ambiti
considerati prioritari (aborto, trapianti, ecc.).
Da quanto sopra emerge che lo sfavore per la regolazione giuridica in
materia bioetica manifesta gradi di intensità diversi: si va da uno sfavore
assoluto: il diritto non deve entrare in nessuna forma nelle questioni bioetiche, a
uno sfavore relativo: limitato cioè allo strumento legislativo.
Passando quindi al partito dei fautori della regolazione giuridica in materia
bioetica anche in questo si trovano posizioni diverse che sono, tuttavia,
riconducibili sostanzialmente a due. Da una parte c’è chi sostiene che le questioni
bioetiche debbano essere disciplinate in maniera conforme a particolari valori
morali; dall’altra chi ritiene che il diritto nell’ambito della bioetica dovrebbe
garantire a ogni individuo la possibilità di perseguire i propri valori nelle azioni
che non danneggiano gli altri, realizzando quindi un equilibrio tra interessi
diversi, rinunciando a imporre una particolare concezione morale e
salvaguardando l’autonomia delle persone.
La prima posizione è riconducibile a quello che abbiamo definito
moralismo giuridico: si presuppone cioè l’esistenza (e la conoscibilità) di valori e
principi morali assolutamente giusti o, quanto meno, suscettibili di raccogliere
generale consenso e si afferma che il diritto debba porre al servizio di questi il
suo apparato coercitivo.
Ne consegue la richiesta di una legislazione che fissi modelli rigidi,
ponendo divieti e limiti rigorosi, una legislazione autoritaria che finirà per
sancire la superiorità di una particolare concezione morale e non sarà in grado di
comporre in maniera adeguata i conflitti tra diverse concezioni morali presenti
nelle moderne società pluraliste.
La seconda posizione è riconducibile a quello che abbiamo definito
liberalismo giuridico: si riconosce la difficoltà di fare appello a criteri morali
condivisi e si guarda al diritto non come ad un mezzo per imporre concezioni
morali particolari (come sosteneva Stuart Mill compito del diritto d’altra parte
non è quello di obbligare i cittadini a essere virtuosi), ma come a un mezzo per
permettere la convivenza sociale e il confronto tra posizioni diverse,
riconoscendo che, con l’unico limite del danno agli altri, ogni individuo (adulto e
consapevole) ha il diritto di vivere secondo le proprie convinzioni.
Ne consegue la richiesta di una legislazione che può essere definita
“leggera” o “aperta”: “leggera” perché richiede che le regole giuridiche siano
poco numerose e il più possibile povere di contenuti morali rivolte cioè a
regolamentare gli aspetti tecnici e procedurali; “aperta” perché rende possibile
realizzare diversi modelli di vita non privilegiando un unico punto di vista
morale.
Anticipo che personalmente ritengo questa seconda posizione superiore alla
prima, non solo dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista pratico: dal
punto di vista teorico tale posizione è coerente con una metaetica non
cognitivistica che è la premessa dell’etica della responsabilità e dal punto di vista
pratico essa risponde meglio a una società pluralistica e multietnica come la
nostra.
6.2 Le fonti del biodiritto
Lasciando da parte il piano teorico ed esaminando la realtà dei sistemi
giuridici attuali, quali sono oggi le fonti del biodiritto (neologismo plasmato
sull’altro neologismo bioetica, per indicare quel settore del diritto che riguarda i
problemi inerenti la tutela della vita umana e non umana, animale e ambiente)?
In Italia l’art. 1 delle disposizione preliminare al c.c. del 1943 indica quali
fonti la legge, i regolamenti, le norme corporative (poi soppresse), gli usi: è un
articolo, come molti altri, improntato al più stretto positivismo giuridico, oggi
largamente superato sia dalla teoria sia dall’evoluzione storica. Basti pensare
all’entrata in vigore della costituzione e delle norme costituzionali che
rivendicano le pretese di leges legum e, in tempi più recenti, delle fonti
sovranazionali (internazionali e comunitarie) anch’esse poste sopra la legge. Ma
il sistema delle fonti così come delineato dall’art. 1 d.p.c.c. sopra ricordato non è
stato scardinato solo dall’alto, ma anche dal basso. Ho in mente un famoso
saggio di Francesco Galgano del 1990 pubblicato nella rivista “Sociologia del
diritto”, Le fonti del diritto nella società post-industriale, nel quale, in apertura,
Galgano afferma «Le concezioni classiche del diritto non collocano la sentenza e
il contratto tra le fonti normative, ma se continuassimo a concepire il contratto e
la sentenza come mere applicazioni del diritto e non come fonti di diritto nuovo,
ci precluderemmo la possibilità di comprendere in quel modo muta il diritto nel
nostro tempo».
Quando quindi parliamo delle fonti del biodiritto occorre avere in mente
questa concezione allargata di fonte:
La costituzione contiene quei principi che sono considerati i principi base
della bioetica - autonomia, beneficialità, non maleficenza, giustizia. Basti
ricordare l’art. 32 sulla tutela della salute e il tendenziale divieto di
trattamenti sanitari obbligatori; l’art. 13 sulla inviolabilità della libertà
personale; l’art. 3 sui principi di eguaglianza, non discriminazione ecc.;
particolarmente rilevanti sono poi gli atti internazionali a partire dalla
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 fino alla più
recente Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, la cosiddetta
Convenzione di Oviedo del 1996 e all’ancora più recente Dichiarazione
Universale sul genoma umano del 1997. A proposito della Convenzione di
Oviedo rimane ancora qualche incertezza nel nostro paese perchè è stata
ratificata con la legge 145 del 28 marzo 2001, ma non sono mai stati
emanati “i decreti recanti ulteriori disposizioni per l’adattamento dell’ord.
Giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione”, come
previsto dall’art. 3 della legge citata. Il processo di ratifica non risulta
quindi completato e questo lascia dubbi sul fatto che essa sia diritto vigente
in Italia;
per quanto concerne gli usi, le consuetudini questi non possono assumere
rilievo o applicazioni particolari in materia bioetica per almeno due ragioni:
• il ritmo della novità e dei cambiamenti nel settore delle biotecnologie
non pare consentire la formazione dell’elemento materiale (l’usus, la
diuturnitas) che solo può nascere da una ripetizione generale, costante e
uniforme di un dato comportamento;
• la formazione dell’altro elemento fondante dalla consuetudine, l’opinio
juris seu necessitatis è ostacolato proprio dalla varietà dei valori presenti
nelle moderne società multietniche e della mancanza di condivisione di
principi.
Alcuni si spingono a ricondurre alla dimensione degli usi e delle consuetudini i
codici deontologici, intesi come una sorta di fissazione dei principi di base
vincolanti per le diverse categorie professionali. Su questo punto la dottrina in
Italia è divisa: alcuni, come si è detto, intendono la deontologia come fonte di
natura consuetudinaria, altri ne richiamano il carattere extragiuridico, altri ancora
le riconoscono un ruolo di supplenza in mancanza di una legislazione ad hoc.
la fonte giurisprudenziale riveste un ruolo di primissimo piano e non solo
nei sistemi di common law, ma anche nei sistemi di civil law come il
nostro: infatti i giudici svolgono un ruolo di supplenza laddove manca il
diritto legislativo. In ogni settore in cui ci siano casi da risolvere non
disciplinati dal legislatore, il giudice interviene, dato il divieto di non
liquet, utilizzando i principi a disposizione e giungendo talvolta a vere e
proprie creazioni di diritto nuovo.
sul fronte delle leggi va detto che in Italia, dopo un lungo periodo di
immobilismo, si è proceduto ad approvare numerose leggi in materia di
bioetica (la legge sull’accertamento di morte, sulla privacy, sulla
sperimentazione, sulla donazione di organi, sulla procreazione
medicalmente assistita) ma molte materie restano in attesa di una
regolamentazione (ad esempio l’eutanasia, a proposito della quale esistono
numerosi progetti di legge, che vanno sia nel senso di vietarla sia nel senso
di consentirla). A differenza di altri paesi che hanno scelto una legislazione
per principi ad esempio la Francia, l’Italia ha imboccato la strada di una
legislazione minuziosa, regolativa di singole fattispecie, che ha in sè vari
rischi:
• in primo luogo rischia di essere superata dalle trasformazioni
rapidissime della società contemporanea e dalle sempre nuove scoperte
scientifiche, rischia quindi di essere sempre in fisiologico ritardo;
• in secondo luogo rischia di mettere il diritto al servizio del
mantenimento di certi valori non condivisi e – come osserva Rodotà
anche nel suo più recente lavoro La vita e le regole – la mancanza di
valori condivisi non può essere sostituita da un’etica dei più imposta
attraverso lo strumento legislativo con l’adozione quindi di procedure
maggioritarie.
Prenderò ad esempio di questo ultimo punto la famosa legge 40 del 19
febbraio 2004 sulla procreazione medicalmente assistita. Ho scelto questo
esempio, oltre che per l’attualità della legge, perché nello spirito del Manifesto di
bioetica laica, nel 1998 fu pubblicato un documento, redatto da Cinzia Caporale,
Armando Massarenti, Angelo Petroni e Stefano Rodotà, “inteso a rilanciare una
discussione pubblica”, alla luce di “principi chiari e esplicitamente espressi”,
ispirati a un atteggiamento laico di pluralismo etico (che – sottolineano gli
estensori – nelle società moderne è sia un fatto sia un valore) in vista dell’assetto
giuridico che la materia doveva ricevere.
Da questo documento emergono alcuni punti che andremo a confrontare
con quanto previsto dalla legge 40:
1 – poiché “nulla è più culturale dell’idea di natura” e conseguentemente il
confine tra ciò che è naturale e ciò che non lo è dipende dai valori e dalle
decisioni degli uomini, la procreazione assistita non può essere interamente
ricompresa nel concetto di “terapia medica”. Infatti l’idea stessa di terapia
presuppone che vi sia una deviazione rispetto a qualcosa ritenuto naturale e
fa di chi vi ricorre un malato, al quale un trattamento viene accordato o
rifiutato in base a decisioni a lui esterne. Nel caso della procreazione
assistita questo potrebbe comportare anche una connotazione negativa sui
bambini che nascono grazie ad essa;
2 – la regolamentazione della procreazione assistita non deve privilegiare de
iure e de facto un certo modello di famiglia rispetto ad altri, in quanto nelle
società attuali il modello di famiglia per così dire tradizionale non è più
universalmente dominante e l’evoluzione dei rapporti sociali ed economici
ha portato all’emergere di forme diverse che meritano eguale rispetto;
3 – la regolamentazione della procreazione assistita non deve essere il risultato
del prevalere delle convinzioni morali espresse da una maggioranza
politica, infatti nelle società pluralistiche, dove non c’è un’unica morale,
ogni tentativo di costruire i principi giuridici sulla base delle norme di una
singola morale sarebbe in contrasto con i principi stessi della democrazia
liberale, nella quale la funzione primaria del diritto è quella di evitare quei
comportamenti che recano danno ad altri o alla società nel suo complesso;
4 – alla luce del principio precedente, le norme in materia di procreazione
assistita dovranno sì proibire interventi di selezione o di ingegneria
genetica che possano comportare conseguenze negative inaccettabili (ad
esempio la discriminazione tra individui su base biologica), ma le ragioni di
tali limiti dovranno risiedere nella necessità di evitare conseguenze
negative per la società, non nell’affermazione di un principio astratto di
“sacralità della vita” – si pensi alla questione dello statuto etico e
ontologico dell’embrione –, riconosciuto solo da alcune visioni morali;
5 – la forte tendenza al decremento demografico e all’invecchiamento della
popolazione rende giustificabile da parte dello Stato la destinazione di
risorse pubbliche volte ad aumentare la natalità anche attraverso la
procreazione assistita in strutture pubbliche e private al fine di permettere a
tutti i cittadini, indipendentemente dai loro mezzi economici, un effettivo
accesso alle prestazioni.
Andando ora ad esaminare alla luce di questi punti la legge 40 del 2004,
anche senza entrare nel dettaglio, possiamo facilmente constatare che il
legislatore italiano ha scelto una strada che si discosta totalmente dai principi
sopra indicati:
- con riferimento al punto 1, l’art. 2 esplicitamente recita che “il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri
metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità” e
l’art. 4 ribadisce: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai
casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai
casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”.
Come confermato anche dalle linee guida, l’accesso alla procreazione
assistita è consentita al solo ed esclusivo scopo di superare uno stato di
documentata impossibilità a procreare:
- con riferimento al punto 2, l’art. 5 sancisce che “possono accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso
diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi
viventi”. La figura di riferimento del legislatore è chiaramente la cosiddetta
“famiglia ideale”, l’unica in linea, secondo certa dottrina, con quella “società
naturale fondata sul matrimonio” riconosciuta dall’art. 29 della Costituzione.
Viene poi introdotta una concessione – peraltro molto problematica – alle
coppie conviventi in coerenza con molte pronunce della Corte costituzionale,
volte ad estendere i diritti dei componenti della cosiddetta famiglia legittima a
quelli della famiglia di fatto;
- con riferimento ai punti 3 e 4, l’art. 1 laddove proclama che la legge “assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito” pone a fondamento di
tutta la legge la tutela assoluta dell’embrione, introducendo, come l’ha definita
Stefano Rodotà, una sorta di “dittatura dell’embrione” in linea con una
particolare opzione morale;
- con riferimento al punto 5, pur prevedendo l’istituzione di un fondo per
favorire l’accesso alle tecniche di procreazione assistita (art. 18),
esplicitamente la legge indica delle alternative a tali tecniche (adozione,
affidamento familiare, ex art. 6) e un impegno finanziario prioritario per
ricerche volte a indagare “le cause patologiche, psicologiche, ambientali e
sociali dei fenomeni della sterilità e dell’infertilità” al fine di favorire “gli
interventi necessari per rimuoverli nonché per ridurne l’incidenza”(art. 2).
Da ciò emerge una chiara disincentivazione verso queste tecniche – che
Carlo Casonato molto efficacemente ha definito di procreazione medicalmente
assistita, ma giuridicamente ostacolata –, tecniche che, come già sta avvenendo,
vengono effettuate all’estero da chi ha maggiori disponibilità economiche.
Dalla lettura sinottica della legge 40 e del documento sulla procreazione
medicalmente assistita, ispirato ai principi del Manifesto di bioetica laica, si
ricavano quei due diversi modelli di biodiritto cui facevo riferimento in sede
teorica: da un lato un modello di diritto autoritario, che fissa norme rigide,
sancisce la superiorità di una particolare concezione morale e pone divieti e limiti
rigorosi, dall’altro un modello di diritto “aperto” e “leggero”, come l’ha definito
Stefano Rodotà. “Leggero”, perché richiede che le regole giuridiche siano poco
numerose e il più possibile povere di contenuti morali, rivolte cioè a
regolamentare gli aspetti tecnici e procedurali; “aperto”, perché rende possibile
realizzare diversi modelli di vita non privilegiando un unico punto di vista
morale.
Personalmente come ho già detto ritengo questa seconda opzione
preferibile alla prima, non solo dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di
vista pratico. Dal punto di vista teorico tale posizione è coerente con un’etica,
che, semplificando tra le tante classificazioni proposte, possiamo definire della
responsabilità, in contrapposizione all’etica dei principi. Quest’ultima poggia
sull’idea che esistono dei principi universali, assoluti, oggettivi, validi per tutti e
si coniuga con il cognitivismo etico, incorrendo nella fallacia naturalistica
(denunciata da Hume) di far derivare l’ought dall’is, ossia il dover essere
dall’essere.
L’etica della responsabilità, invece, parte dalla premessa che i giudizi di
valore non sono conoscitivi, ma costitutivi, ossia soggettivi e relativi, in quanto
l’uomo è soggetto non oggetto della legge morale (senza che tale relativismo,
come detto sopra, implichi lassismo morale) e si coniuga con il non
cognitivismo etico, evitando così di violare la legge di Hume.
Dal punto di vista pratico, poi, tale posizione meglio risponde a una
società pluralistica e multietnica come la nostra, retta da una Costituzione che
comprende tra i principi fondanti anche quello di laicità che, come riconosciuto
da varie sentenze della Corte Costituzionale, sopra richiamate, implica “garanzia
dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo
culturale”.
6.3 Diritti dell’età tecnologica
Il diritto come è a tutti noto ha due facce: il diritto oggettivo, vale a dire le
norme, le regole dei comportamenti, ma anche, indissolubilmente legato ad esso,
il diritto soggettivo che concerne diritti e obblighi di coloro che le norme le
vivono.
Sul piano dei diritti le ricadute in bioetica sono moltissime – in parte giù
adombrate – tanto che è stata definita una particolare categoria di diritti con
riferimento a questo contesto.
Norberto Bobbio ha ripetutamente affermato che i diritti umani «sono
diritti storici, cioè nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di
nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una
volta per sempre». Ad esempio, la libertà religiosa è un effetto delle guerre di
religione, le libertà civili delle lotte dei parlamenti contro i sovrani assoluti, la
libertà politica e quella sociale della nascita, crescita e maturità del movimento
dei lavoratori salariati e così via. Certe richieste nascono, infatti, solo quando
nascono certi bisogni e nuovi bisogni nascono in corrispondenza del mutamento
delle condizioni della società.
Seguendo questa linea interpretativa, sono state individuate, come è noto,
varie generazioni di diritti: la prima generazione è quella dei diritti di libertà
(libertà di pensiero, di coscienza, di religione ecc.), diritti di ispirazione liberale e
individualista, che pongono dei limiti all’attività dello Stato e all’ingerenza dei
pubblici poteri nella sfera privata: essi si sono venuti affermando nel pensiero
moderno sei-settecentesco e, attraverso le rivoluzioni liberal-borghesi, hanno
trovato riconoscimento nelle solenni dichiarazioni di fine Settecento.
La seconda generazione è quella dei diritti sociali, di ispirazione
democratica e socialista (diritto al lavoro, all’istruzione, all’assistenza ecc.), che
richiedono una politica attiva dei pubblici poteri attraverso l’erogazione di
prestazioni e di servizi: tali diritti, contemplati nella maggior parte delle
Costituzioni contemporanee, sono l’esito delle lotte della classe operaia tra Otto e
Novecento.
Mentre su queste due generazioni di diritti la dottrina è concorde, non
altrettanto concorde è sull’individuazione di una terza e/o una quarta generazione
di diritti.
Per lo più si identificano come diritti di terza generazione quelli che
riguardano i cosiddetti «soggetti deboli», vale a dire quegli individui che si
trovano in stati di difficoltà (ad esempio, malati, anziani, handicappati, ecc.) o
siano stati vittime di discriminazione sociale per ragioni di ordine storico (ad
esempio, neri, donne, ecc.). Tali diritti sono in linea di continuità rispetto a quelli
delle generazioni precedenti, di cui costituiscono una specificazione con
riferimento a particolari categorie di soggetti; per questo parte della dottrina non
li considera una generazione a sé stante.
Infine i diritti di quarta generazione - se si considerano quelli precedenti
appartenenti alla terza generazione - sono appunto i diritti dell’età tecnologica: si
tratta di un catalogo aperto, dai confini non facilmente delineabili, includente
pretese eterogenee che vanno dal diritto alla pace, allo sviluppo, all’ambiente,
alla riservatezza contro le intrusioni dell’informatizzazione, al diritto di morire
con dignità contro ogni accanimento terapeutico, all’integrità del patrimonio
genetico e così via.
Con riferimento a questa generazione di diritti, va rilevata, da un lato,
l’ampiezza dei fenomeni cui si riferiscono, dall’altro il problema della titolarità,
riferita non solo a soggetti individuali, ma a gruppi, popoli, nazioni, a soggetti
sempre più vasti, fino alle «generazioni future», ma anche soggetti non umani
come gli animali. In alcuni casi, come osserva sempre Bobbio, è improprio
parlare di diritti, ma l’uso di tale definizione è un espediente per attribuire un
titolo di nobiltà e maggiore forza ad alcune aspirazioni ideali in vista di una loro
regolamentazione.
A titolo meramente esemplificativo proporrò alcune riflessioni sui diritti
legati ai nuovi sviluppi della genetica, sviluppi che permettono possibilità ogni
giorno crescenti di migliorare la salute delle persone affette da una patologia
genetica e di identificare, prima o dopo la nascita, anomalie genetiche
responsabili di malattie in atto o di possibile insorgenza futura. Di qui un vero e
proprio boom dei test genetici che, in rapporto alla loro finalità, possono essere
variamente classificati in «test diagnostici», finalizzati a identificare e, se
possibile, curare una malattia genetica; «test presintomatici», che consentono di
identificare il gene di malattie genetiche non presenti alla nascita, ma che
potrebbero comparire nel corso della vita; «test predittivi», che consentono di
identificare genotipi che, da soli, non causano in genere una malattia, ma
aumentano il rischio di svilupparla; «test di screening genetico», condotti per una
popolazione nel suo complesso, con finalità di ricerca.
Ma, da un punto di vista teorico, quali caratteristiche hanno i dati genetici
che si ricavano da tali test? Come possono essere classificati? La risposta a tali
domande è preliminare per poi considerare i diritti che entrano in gioco: che
natura abbiano e chi ne sia titolare.
In ambito giuridico la definizione di dati genetici risale ad una
Raccomandazione del 1997 (R/97/5) del Consiglio d’Europa, in cui si dice che
dati genetici sono «quei dati, indipendentemente dalla tipologia, che riguardano i
caratteri ereditari di un individuo o le modalità di trasmissione di tali caratteri
nell’ambito di un gruppo di individui legati da vincoli di parentela». Si tratta
quindi di dati che si collocano nell’ambito dei dati personali o, più in particolare,
dei dati sanitari, ma con alcune peculiarità estremamente rilevanti. Come ha
sottolineato Stefano Rodotà, autorità indiscussa in materia, «la particolare
rilevanza delle informazioni genetiche deriva dal loro carattere strutturale e
permanente. Più precisamente, il patrimonio genetico è definito e inalterabile per
l’intero arco della vita biologica di un individuo: coglie il soggetto nella sua
unicità e lo pone in relazione inequivoca con altri soggetti: è il tramite biologico
diretto tra le generazioni e, come tale, immortale, mentre tutti gli altri caratteri
biologici, appartenendo alla linea somatica, muoiono con l’individuo. Ciò spiega
– conclude Rodotà – il carattere centrale da essi assunto nel quadro delle
informazioni personali».
Il punto principale che viene messo in luce è che i dati genetici, a
differenza degli altri dati personali, sono strutturalmente condivisi, sono cioè
permanenti e trasmissibili, il che comporta alcune conseguenze importanti
relative ad almeno tre questioni.
La prima questione è relativa al fatto che i dati genetici fanno riferimento
non a un soggetto singolo, ma a un gruppo di riferimento.
Strettamente legata alla prima, è la seconda questione, vale a dire: il
gruppo di riferimento è la famiglia biologica, che non coincide con la famiglia
giuridica (non vi appartengono, ad esempio, il coniuge o i genitori adottivi, ma
ne fanno parte i donatori di gameti nel caso di fecondazione assistita o la donna
che chiede di rimanere anonima dopo il parto). Qualche teorico si spinge ad
ipotizzare come parte di questo gruppo di riferimento anche le generazioni
future, categoria che crea parecchie perplessità dal punto di vista teoricogiuridico, data la difficoltà di considerare titolari di diritti esseri che non esistono
neppure in potenza e che non si sa neppure se e come esisteranno.
La terza questione è quella concernente i diritti dei diversi soggetti
appartenenti al gruppo di riferimento, sia esso più o meno allargato, come si è
detto sopra. Si tratta, a titolo esemplificativo, del diritto di accedere alle
informazioni di altri appartenenti al gruppo, del diritto alla privacy (che in questo
caso comprende anche il diritto di non sapere), delle modalità di esercizio di tali
diritti, dei poteri di utilizzazione e circolazione dei dati del gruppo.
Come è chiaro, si tratta, in parte, di problemi di sempre, come la tutela dei
diritti individuali, il rapporto tra interessi individuali e sociali, tra sfera privata e
pubblica, ma anche di problemi nuovi derivanti dalle innovazioni scientifiche e
tecnologiche che hanno rivoluzionato il mondo delle comunicazioni e hanno reso
possibile agire su fenomeni vitali in modi fino a qualche decennio fa ritenuti
impensabili (procreazione assistita, trapianti, ingegneria genetica e così via).
Le prime testimonianze di forme di regolamentazione giuridica di questa
materia a tutela dei diritti fondamentali si rinvengono nel diritto internazionale.
Il primo documento è considerato il codice di Norimberga, derivato dalla
sentenza di condanna dei crimini nazisti emanata nel 1947 dal Tribunale
Internazionale, a conclusione del processo di Norimberga, a cui sono seguite altre
importantissime dichiarazioni fino alla fondamentale «Convenzione giuridica sui
diritti dell’uomo e la biomedicina» del 1995 e alla «Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea» del 2000. La «Convenzione giuridica sui diritti dell’uomo
e la biomedicina», frutto di un lungo e faticoso percorso cominciato nel 1991 e
sottoscritta da numerosi paesi, tra i quali l’Italia, nel 1997 ad Oviedo, codifica
pronunce preesistenti ma frammentarie - si pensi, ad esempio, alle
Raccomandazioni rivolte dal Consiglio d’Europa agli Stati membri fino dal 1970
con l’intento di realizzare una cooperazione internazionale nell’ambito dell’etica
medica (al 1982 risalgono le prime pronunce in tema di genetica con la
Raccomandazione n. 934 sull’ingegneria genetica).
In essa sono esposti una lunga serie di princìpi fondamentali e di norme
che gli Stati firmatari, al momento della ratifica (in Italia è avvenuta nel 2001), si
impegnano ad includere nei loro ordinamenti.
Sul tema in oggetto, la genetica, la Convenzione vieta qualsiasi forma di
discriminazione dell’individuo a causa della sua costituzione genetica; consente i
test genetici solo per fini medici e di ricerca e solo previo ricorso ad una
consulenza genetica appropriata, ammette gli interventi sul genoma solo per fini
preventivi, diagnostici, terapeutici o di ricerca medica e solo nel caso in cui non
abbiano lo scopo di provocare alcuna modificazione del genoma della
discendenza; proibisce l’uso di tecniche di procreazione medicalmente assistita
finalizzate alla scelta del sesso o di altri caratteri, salvo il caso in cui tale ricorso
sia necessario al fine di evitare la nascita di un bambino affetto da grave malattia
ereditaria legata, ad esempio, al sesso. Si tratta quindi di una serie di disposizioni
che affermano un diritto alla propria identità genetica quale corollario, per così
dire, dei diritti alla vita e alla salute.
La «Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea», firmata a Nizza
nel 2000 e poi entrata a costituire la Parte II della futura Costituzione Europea,
conferma all’art. 21 il divieto di «qualsiasi discriminazione fondata, in
particolare, … sulle caratteristiche genetiche».
In Italia la normativa di riferimento per i dati genetici è quella sui dati
sanitari: già la legge 675 del 1996 sui dati sensibili aveva dedicato al trattamento
dei dati sanitari, considerati parte del più ampio genus dei dati sensibili,
disposizioni particolari, finalizzate a bilanciare il necessario trattamento di tali
dati con l’esigenza di tutela delle persone; nel 1997, all’atto dell’emanazione
della prima autorizzazione generale al trattamento di tali dati, prevista dalla legge
in oggetto, il Garante aveva affrontato il tema dei dati genetici, considerati come
dati sanitari particolarmente sensibili. In tale documento si autorizzava il
trattamento dei dati genetici «limitatamente alle informazioni e alle operazioni
indispensabili per tutelare l’incolumità fisica e la salute dell’interessato, di un
terzo o della collettività», dietro consenso scritto dell’interessato. In mancanza di
tale consenso era prevista apposita autorizzazione del Garante, nel caso in cui il
trattamento non fosse finalizzato alla tutela della salute di un terzo e della
collettività. La normativa oggi in vigore è rappresentata dal Codice in materia di
protezione dei dati personali del 2003, che dedica l’intero titolo V (articoli dal 75
al 94) al trattamento dei dati personali in ambito sanitario (l’art. 90 commi 1 e 2
disciplina in particolare i dati genetici).
È inoltre unanimemente riconosciuto che è stato il Garante per la
protezione dei dati personali a svolgere un ruolo di battistrada e a tracciare, di
fatto, le linee guida per inquadrare giuridicamente il tema e sensibilizzare
l’opinione pubblica. Particolarmente significativa è da ritenersi la pronuncia del
22 maggio 1999 che, in un caso concreto, mette in luce la molteplicità e la
problematicità dei profili concernenti la tutela dei diritti in materia di test
genetici.
Il caso in oggetto è quello di una donna affetta da malattia congenita che,
volendo avere un figlio, si era sottoposta ad indagini genetiche. I sanitari, per
poter formulare il loro giudizio sul rischio che la donna potesse trasmettere la sua
malattia, avevano necessità di acquisire alcuni dati sanitari riportati nella cartella
clinica del padre della donna, depositata presso una struttura ospedaliera. A tale
acquisizione il padre aveva negato il consenso e i medici dell’ospedale, presso il
quale la cartella era conservata, avevano opposto il segreto professionale,
sostenendo che la legge 675/1996 consente di acquisire dati sanitari senza
consenso solo nel caso in cui l’interessato sia incapace di intendere e di volere.
La donna si era pertanto rivolta al Garante, chiedendo di autorizzare
l’acquisizione della cartella clinica del padre, anche in presenza del suo dissenso.
Esaminando il caso, il Garante ha innanzitutto osservato che la conoscenza
(prima del concepimento o durante la gravidanza) del rischio di insorgenza di
patologie, anche di tipo genetico, può certamente contribuire a migliorare le
condizioni di benessere psico-fisico della gestante, nel quadro di una piena tutela
della salute come diritto fondamentale dell’individuo (art. 32 della Costituzione).
Nel caso specifico, l’accesso ad alcuni dati sanitari del padre della paziente
rappresentava un presupposto essenziale per l’accertamento delle modalità di
trasmissione della malattia e soltanto la disponibilità di questi dati poteva
consentire una scelta riproduttiva consapevole ed informata.
Il Garante ha ritenuto, pertanto, che, pur in presenza del rifiuto del padre,
l’ospedale poteva acquisire i suoi dati sanitari presso la struttura sanitaria dove
erano custoditi. Gli organismi sanitari pubblici, infatti, possono trattare i dati
senza il consenso dell’interessato qualora si debba tutelare la salute o
l’incolumità fisica di terzi o della collettività. L’esigenza di tutelare il benessere
della gestante, nella circostanza in esame, poteva comportare un ragionevole
sacrificio del diritto alla riservatezza dell’interessato.
Si osserva inoltre che, anche dal punto di vista del segreto professionale,
la tutela dell’incolumità psico-fisica di un terzo viene considerata «giusta causa»
dall’art. 622 del codice penale che legittima la rivelazione di informazioni
eventualmente coperte da segreto professionale. Lo stesso codice di deontologia
medica indica espressamente quale «giusta causa di rivelazione» sia l’urgenza di
salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi, nel caso in cui
l’interessato non sia in grado di prestare il proprio consenso, sia l’urgenza di
salvaguardare la vita e la salute di terzi, anche nel caso di rifiuto dell’interessato,
ma previa autorizzazione del Garante. In conclusione, a parere del Garante,
l’ospedale non incontra ostacoli né nella legge n. 675 del 1996, né nelle norme
sul segreto professionale e può legittimamente acquisire i dati sulla base della
citata autorizzazione.
L’Autorità ha, comunque, richiamato l’organismo sanitario ad adottare
precise cautele a tutela della riservatezza: ha indicato espressamente che i dati
sanitari da acquisire siano trasmessi con plico sigillato, in modo da assicurare la
segretezza della cartella clinica nei confronti di persone estranee; che il personale
dell’ospedale riferisca personalmente alla sola richiedente il risultato
dell’indagine genetica con informazioni chiare ed esaustive, senza però
comunicarle i dati sanitari relativi al padre, e di non comunicare a quest’ultimo
informazioni relative agli accertamenti eseguiti, fuori dei casi di diritto di accesso
ai dati che lo riguardano o di necessità di acquisizione di informazioni necessarie
per la tutela della sua salute o incolumità fisica.
Questa pronuncia, come ho detto, è molto significativa perché mette in
luce in un caso reale molti dei problemi cui accennavo all’inizio in una
dimensione teorica:
- i dati genetici hanno la particolare caratteristica – che li differenzia da tutti gli
altri dati personali – di essere condivisi e trasmissibili, quindi il diritto alla
privacy, che tutela i dati personali e che la teoria ascrive, come tutti i diritti
della personalità, tra i diritti assoluti, presenta, con riferimento ai dati
genetici, caratteri di relatività;
- in alcuni casi – come quello in questione – il diritto alla privacy (del padre)
cede in presenza di un altro diritto di pari rango (quello alla salute psico-fisica
della madre). Ovviamente il bilanciamento di interessi può essere fatto in
presenza di interessi di pari valore: va sottolineato che lo schema adottato nel
caso in oggetto non potrebbe essere adoperato in casi in cui gli interessi in
conflitto fossero di natura o di rango costituzionale diverso. Si prenda il caso
della richiesta di informazioni genetiche da parte di società di assicurazioni,
di istituti di credito o di datori di lavoro: in questi casi la comunicazione può
determinare situazioni di discriminazione ai danni di coloro che risultano
portatori di malattia genetiche e quindi è in tutti i casi vietata;
- deve essere garantito, come fa l’autorizzazione citata del Garante, con
riferimento al padre, il diritto di non sapere. È chiaro che la conoscenza del
proprio destino genetico rivelato da test predittivi (la cui attitudine è peraltro
assai variabile, perché pochissime sono le malattie genetiche monofattoriali,
mentre gran parte di esse sono polifattoriali, quindi senza nessuna previsione
certa di insorgenza) può avere implicazioni profonde sulla personalità del
singolo: può indurre a strategie tendenti ad evitare o ridurre i rischi
conseguenti, ma anche generare ansia, depressione o scelte tragiche (il caso
più spesso citato è quella della Corea di Huntington, malattia a insorgenza
tardiva). Di qui l’esigenza di rispettare il diritto di ciascuno di decidere di
essere informato o meno dei risultati di un esame genetico e delle sue
conseguenze. Sul piano filosofico il diritto a non sapere confligge con il
principio di responsabilità, ma è certamente un aspetto del diritto alla libera
autodeterminazione nelle proprie scelte di vita.
Commenta a questo proposito Stefano Rodotà che la possibilità di predire
vicende riguardanti il futuro biologico apre la strada ad interventi che fanno
passare alcune situazioni dal caso alla libertà, consentendo libere scelte dove
prima esistevano situazioni necessitate. Si creano così situazioni propizie ad una
deliberata costruzione del proprio avvenire biologico, nella prospettiva di un
‘antidestino’, di un passaggio cioè da situazioni che l’uomo subisce a situazioni
che l’uomo governa.
Ma proprio Rodotà ha puntato l’indice contro la tendenza in atto di
considerare le informazioni derivanti dai test genetici – la cui attitudine
predittiva, come si è detto, è assai variabile – come dati socialmente certi, tali da
poter trasformare la dimensione clinica di eventuali patologie in dimensione
sociale, attraverso discriminazioni ed abusi operati sulla base della conoscenza
delle informazioni genetiche.
Ed è questo il rischio che deve assolutamente essere evitato a tutela dei
diritti individuali.
Il rapporto tra diritto e bioetica va sempre considerato sotto il duplice
profilo della regolamentazione delle problematiche introdotte dalle applicazioni
nei diversi scritti delle nuove tecnologie e dei diritti degli individui o, meglio, dei
soggetti umani o non umani coinvolti.
La scienza e la tecnica sono una sorta di divinità o demoni, a seconda di
come li si guarda, bifronti, in quanto, da un lato, possono produrre cose
meravigliose in grado di risolvere molti problemi, migliorare la qualità della vita,
produrre benessere e così via, dall’altro, però, possono creare rischi, se non
addirittura danni immediati o futuri, ledere diritti di singoli o di gruppi,
accrescere le disuguaglianze.