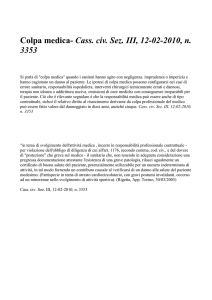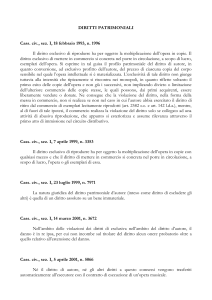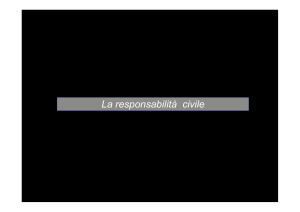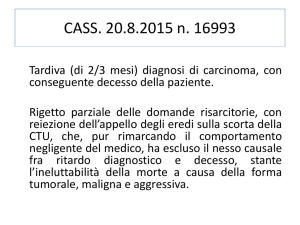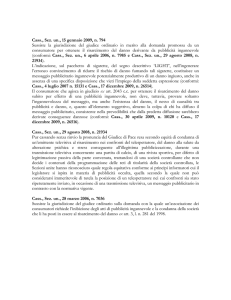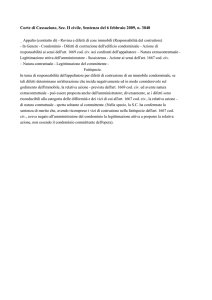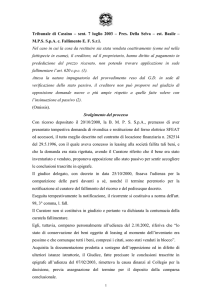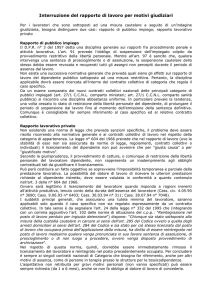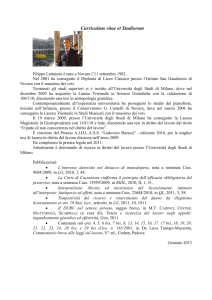3
LA NUOVA
ANNO XXVI
2010
GIURISPRUDENZA
CIVILE
COMMENTATA
N. 3 MARZO 2010 • Anno XXVI
RIVISTA MENSILE
de Le Nuove Leggi Civili Commentate
ISSN 1593-7305
LA NUOVA
GIURISPRUDENZA
CIVILE
COMMENTATA
a cura di
Guido Alpa e Paolo Zatti
In questo numero segnaliamo:
D 28,00
LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA
00111562
ISBN 978-88-13-30119-4
9!BM CF>:ROP XS!
5!;E ; F:P TUQR!
parte prima
In tema di abuso del diritto
(Cass., n. 20106/2009)
[Con Discussioni in Parte seconda di M. Orlandi, C. Scognamiglio
e F. Viglione]
Intervento del coniuge nell’acquisto di un bene personale
(Cass., sez. un., n. 22755/2009)
Conflitto tra ipoteca e privilegio a favore del promissario
acquirente
(Cass., sez. un., n. 21045/2009)
parte seconda
“Best interests of the child” o “best interests of
children”?
Uso del diritto comparato in tema di regime patrimoniale
della famiglia
Dove va la responsabilità civile?
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.a. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
DIREZIONE e REDAZIONE hanno sede presso:
Dipartimento di Diritto Comparato, Palazzo del Bo, via 8 Febbraio 2, 35122
PADOVA, Tel. 049.8278912 (Zatti), 049.8278915 (Mantovani), 049.8278914 (Pucella),
Fax e segreteria 049.8278913
La corrispondenza per la Rivista va indirizzata a Paolo Zatti, a Manuela Mantovani
o a Roberto Pucella, Dipartimento di Diritto Comparato, Palazzo del Bo, via 8
Febbraio 2, 35122 PADOVA
L’indirizzo di posta elettronica è il seguente: [email protected]
Sedi redazionali:
MILANO: Giovanni Iudica, via Chiossetto 8, 20122 MILANO, Tel. 02.76015728,
Fax 02.784327
ROMA: Salvatore Patti, via Tacito 41, 00193 ROMA, Tel. 06.68192371, Fax 06.68133385
NAPOLI: Enrico Quadri, c/o Dipartimento di diritto comune patrimoniale, via
Porta di Massa 32, 80133 NAPOLI, Tel. 081.2534299, 25343119, Fax 081.2534299
ABBONAMENTO per il 2010:
ITALIA 214,00 - ESTERO 278,00
Offerta triennale 2010-2012:
ITALIA 546,00 - ESTERO 709,00
Condizioni generali di abbonamento
L’abbonamento decorre dal 1° gennaio e scade il 31 dicembre successivo. In ipotesi il cliente sottoscriva
l’abbonamento nel corso dell’anno la scadenza è comunque stabilita al 31 dicembre del medesimo anno:
in tal caso l’abbonato sarà tenuto al pagamento dell’intera annata ed avrà diritto di ricevere gli arretrati
editi nell’anno prima dell’inizio dell’abbonamento.
L’abbonamento si intenderà tacitamente rinnovato per l’anno successivo in assenza di disdetta da
comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del 31 dicembre esclusivamente a mezzo lettera
raccomandata a.r.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro e non oltre un mese dal ricevimento del
fascicolo successivo. Decorso tale termine saranno spediti contro rimessa dell’importo.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite gli incaricati della Casa Editrice sottoscrivendo l’apposita
ricevuta intestata a WKI Srl - Cedam oppure con un versamento intestato a WKI Srl - Cedam - Viale
dell’Industria, 60 - 35129 Padova - utilizzando le seguenti modalità:
– Conto corrente postale 205351;
– Bonifico Cassa di Risparmio del Veneto - Agenzia Padova via Valeri, CIN C, ABI 06225,
CAB 12163, c/c 047084250184, IBAN IT 30 C 06225 12163 047084250184;
– Carta di credito Visa, Master Card, Carta Si, American Card, American Express, Diners Club,
– Eurocard specificando il numero e la data di scadenza.
i
SERVIZIO CLIENTI CEDAM
Informazioni commerciali:
tel. 02.82476707 • e-mail: [email protected]
Informazioni amministrative:
tel. 049.8239111 • e-mail: [email protected]
www.cedam.com • www.praticantidiritto.it
Editore: Wolters Kluwer Italia Srl - Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1, Pal. F6
20090 Assago (MI)
Autorizzazione del Tribunale di Padova del 12 dicembre 1984 n. 860
Direttore responsabile: Paolo Zatti
Stampa: Grafiche TPM S.r.l. - Via Vigonovese, 52/a - 35127 Padova
LA NUOVA
GIURISPRUDENZA
CIVILE
COMMENTATA
ANNO XXVI
2010
RIVISTA MENSILE
de Le Nuove Leggi Civili Commentate
a cura di
GUIDO ALPA e PAOLO ZATTI
Comitato Editoriale
G. ALPA, G. IUDICA, S. PATTI, E. QUADRI, P. ZATTI,
F. ADDIS, G. AMADIO, S. DELLE MONACHE, G. FERRANDO, L. LENTI, E. LUCCHINI GUASTALLA,
F. MACARIO, M. MANTOVANI, M. R. MAUGERI, E. NAVARRETTA, M. ORLANDI,
F. PADOVINI, C. SCOGNAMIGLIO, P. SIRENA
Comitato Scientifico
A. ANTONUCCI, P. AUTERI, M. BASILE, A. BELLELLI, A. BELVEDERE, F. BIANCHI D’URSO, G. BONILINI,
U. BRECCIA, F. CAPRIGLIONE, V. CARBONE, P. CENDON, S. CHIARLONI, V. COLUSSI, L. P. COMOGLIO, M. DE ACUTIS,
M. V. DE GIORGI, R. DE LUCA TAMAJO, E. DEL PRATO, F. GIARDINA, A. GORASSINI, A. GUARNERI, G. MARASÀ,
A. MASI, C. M. MAZZONI, O. MAZZOTTA, E. MOSCATI, M. NUZZO, G. PONZANELLI, V. ROPPO, G. SBISÀ, M. SESTA,
M. TAMPONI, M. TARUFFO, R. WEIGMANN, V. ZENO-ZENCOVICH
Redazione
Responsabili: R. PUCELLA, A. FUSARO
B. CHECCHINI, M. CINQUE, E. DE BELVIS, V. DURANTE, M. FARNETI, M. PICCINNI, U. ROMA, F. SALOTTO, F. VIGLIONE
Redazione Giudiziaria: L. A. SCARANO
INDICE-SOMMARIO DEL FASCICOLO 3o (marzo 2010)
Parte prima - Sentenze commentate
Cass. civ., II sez., 30.9.2009, n. 20995 [Appalto-Obbligazioni dell’appaltatore-Obbligo
di consegna della cosa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commento di M. Mattioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cass. civ., III sez., 29.9.2009, n. 20819 [Avvocato-Condanna ad una sanzione disciplinare-Segretezza della notizia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commento di V. Cugno Garrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cass. civ., III sez., 18.9.2009, n. 20106 [Contratto in genere-Esercizio di un diritto soggettivo-Abuso del diritto] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cass. civ., III sez., 31.8.2009, n. 18920 [Contratto in genere-Inadempimento-Clausola
risolutiva espressa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commento di I.L. Nocera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cass. civ., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 [Famiglia (regime patrimoniale)-Comunione
dei beni-Acquisto di un bene immobile destinato all’attività professionale di un coniuge-Intervento nell’atto di acquisto dell’altro coniuge ex art. 179, comma 2o, cod. civ.] .
Commento di R. Mazzariol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cass. civ., sez. lav., 22.9.2009, n. 20404 [Lavoro (rapporto)-Procedimento disciplinare-Lettera di contestazione-Principio della immediatezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commento di G. Cinque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cass. civ., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 [Obbligazioni-Garanzia patrimoniale-Cause di
prelazione] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commento di L. Ruggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cass. civ., II sez., 22.9.2009, n. 20409 [Proprietà e diritti reali-Servitù-Servitù di parcheggio] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commento di F. Esposito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cass. civ., III sez., 28.8.2009, n. 18805 [Responsabilità civile-Prestazione sanitaria
complessa-Disciplina/Danni civili-Risarcimento in via equitativa-Liquidazione] . . . . . . .
Commento di L. Klesta Dosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cons. Stato, IV sez., 8.9.2009, n. 5266 [Responsabilità civile-Provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione-Danno esistenziale] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commento di E. Bucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cass. civ., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 [Separazione dei coniugi-Affidamento dei figli-Ascolto dei figli minorenni] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commento di J. Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parte seconda
– Discussioni
Contro l’abuso del diritto (in margine a Cass., 18.9.2009, n. 20106)
di M. Orlandi
Sommario: 1. Usare il diritto. – 2. Titolarità ed esercizio del diritto. – 3. Concetto di
fonte. – 4. Segue: validità della fonte. Efficienza ed efficacia. – 5. Ambiguità del con-
pag. 213
» 214
»
»
221
224
»
231
»
»
239
242
»
»
249
253
»
»
261
263
»
»
266
275
»
»
279
284
»
»
290
295
»
»
300
305
»
»
307
312
cetto di abuso. Teoria dell’irrilevanza e teoria della doppia qualifica. – 6. Segue: combinazione e contraddizione di effetti. – 7. Carattere estrinseco dell’abuso. – 8. Negazione dommatica dell’abuso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 129
Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza (verso una riscoperta della
pretesa funzione correttiva dell’interpretazione del contratto?)
di C. Scognamiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
139
»
148
»
157
»
166
»
175
Il giudice riscrive il contratto tra le parti: l’autonomia negoziale stretta tra
giustizia, buona fede e abuso del diritto
di F. Viglione
Sommario: 1. Interpretare o riscrivere il contratto? – 2. Interpretazione del contratto e
abuso del diritto. – 3. Le antinomie nella costruzione giurisprudenziale del contratto
e della sua ermeneutica. – 4. Quale ruolo per l’abuso del diritto tra regole di validità
e di responsabilità? – 5. L’illegittima commistione tra piani diversi: abuso del diritto
e interpretazione del contratto nella prospettiva comparatistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Studi e opinioni
«Best interests of the child» o «best interests of children»?
di L. Lenti
Sommario: 1. Premessa. – 2. Alle origini della best interests of the child doctrine e dell’affermazione dei children’s rights. – 3. I best interests of the child nel diritto italiano.
– 4. I problemi nell’applicazione odierna dei best interests of the child. – 5. I best interests of the child e il principio di legalità: il caso Serena. – 6. Il contenuto dei best
interests of the child, fra autodeterminazione e paternalismo: il caso dei trattamenti
oncologici alternativi a quelli della medicina scientifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’uso del diritto comparato nella giurisprudenza italiana sul regime patrimoniale della famiglia
di An. Fusaro
Sommario: 1. Il riferimento ai modelli stranieri. – 2. Segue: l’intervento della Corte
cost. sull’art. 184 cod. civ. – 3. Segue: la Gemeinschaft zur gesamten Hand. – 4. La resistenza delle Corti nei confronti dell’utilizzo dell’argomento comparatistico. – 5. Lo
sdoganamento del trust ed il suo accostamento al fondo patrimoniale . . . . . . . . . . . . . .
Dove va la responsabilità civile?
di G. Alpa
Sommario: 1. La situazione di base. – 2. Il rapporto tra regole generali e regole speciali.
– 3. Le manipolazioni dell’interprete. – 4. Dietro lo schermo delle argomentazioni
formali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDICE ANALITICO DELLE DECISIONI
Appalto - Obbligazioni dell’appaltatore - Obbligo di consegna della cosa - Obbligo di
custodia della stessa - Sussistenza - Correlazione alla detenzione dei beni affidati all’appaltatore - Configurabilità (Cass. civ., II sez., 30.9.2009, n. 20995) . . . . . . . . . . . .
Avvocato - Condanna ad una sanzione disciplinare - Segretezza della notizia - Insussistenza (Cass. civ., III sez., 29.9.2009, n. 20819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contratto in genere - Esecuzione ed interpretazione del contratto - Principi di correttezza e buona fede - Operatività - Conseguenze (Cass. civ., III sez., 18.9.2009, n.
20106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contratto in genere - Esercizio di un diritto soggettivo - Abuso del diritto - Contenuto Effetti (Id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contratto in genere - Inadempimento - Clausola risolutiva espressa - Effetto risolutorio
- Presupposti - Dichiarazione di volersi avvalere della condizione - Necessità (Cass.
civ., III sez., 31.8.2009, n. 18920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danni civili - Risarcimento in via equitativa - Liquidazione - Indicazione dei criteri utilizzati - Necessità (Cass. civ., III sez., 28.8.2009, n. 18805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 213
»
221
»
231
»
231
»
239
»
290
Famiglia (regime patrimoniale) - Comunione dei beni - Acquisto di un bene immobile
destinato all’attività professionale di un coniuge - Intervento nell’atto di acquisto dell’altro coniuge ex art. 179, comma 2o, cod. civ. - Natura giuridica della partecipazione - Atto ricognitivo (Cass. civ., sez. un., 28.10.2009, n. 22755) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Famiglia (regime patrimoniale) - Comunione dei beni - Amministrazione - Atti compiuti senza il necessario consenso - Annullabilità - Effetti nei confronti dei terzi (Id.)
»
249
»
249
Lavoro (rapporto) - Procedimento disciplinare - Lettera di contestazione - Principio
dell’immediatezza - Contenuto - Applicabilità nel caso di una serie di fatti distanti
nel tempo che compongono una condotta unitaria - Decorrenza a partire dall’ultimo
dei fatti contestati (Cass. civ., sez. lav., 22.9.2009, n. 20404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
261
Obbligazioni - Garanzia patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Privilegio speciale su bene immobile - Forma di pubblicità - Incidenza sul suo rapporto con l’ipoteca (Cass. civ., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
266
Proprietà e diritti reali - Servitù - Servitù di parcheggio - Configurabilità - Esclusione
(Cass. civ., II sez., 22.9.2009, n. 20409) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
279
»
290
Responsabilità civile - Prestazione sanitaria complessa - Disciplina - Contratto con la
clinica relativo alla sola degenza - Contratto con il chirurgo relativo all’atto medico Ammissibilità - Prova certa e rigorosa dei due contratti e del loro contenuto - Necessità (Cass. civ., III sez., 28.8.2009, n. 18805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Responsabilità civile - Prestazione sanitaria complessa - Esito negativo imputabile ad
una molteplicità di fattori - Soggetto imputabile - Assunzione dell’organizzazione e
del coordinamento dell’attività - Soggetto responsabile (Id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Responsabilità civile - Provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione Danno esistenziale - Configurabilità - Oggetto - Risarcibilità (Cons. Stato, IV sez.,
8.9.2009, n. 5266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
290
»
300
Separazione dei coniugi - Affidamento dei figli - Ascolto dei figli minorenni - Limiti all’ascolto - Conseguenze processuali del mancato ascolto (Cass. civ., sez. un.,
21.10.2009, n. 22238) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
307
Separazione dei coniugi - Affidamento dei figli - Trasferimento all’estero ovvero mancato rientro in Italia di minori a opera del genitore affidatario - Inosservanza delle
condizioni di separazione da parte del genitore affidatario - Ripartizione della giurisdizione in ordine ai provvedimenti «de potestate» tra Stati della U.E. - Connessione
e litispendenza internazionale (Id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
307
»
»
»
266
307
249
»
300
INDICE CRONOLOGICO
Corte di Cassazione
28.8.2009,
31.8.2009,
18.9.2009,
22.9.2009,
22.9.2009,
29.9.2009,
30.9.2009,
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
18805
18920
20106
20404
20409
20819
20995
-
sez.
sez.
sez.
sez.
sez.
sez.
sez.
III . . . pag. 290
III . . . » 239
III . . . » 231
lav. . . . » 261
II . . . . » 279
III . . . » 221
II . . . . » 213
1o.10.2009, n. 21045 - sez. un. . .
21.10.2009, n. 22238 - sez. un. . .
28.10.2009, n. 22755 - sez. un. . .
Consiglio di Stato
8. 9.2009, n. 5266 - sez. IV . . . .
INDICE PER AUTORI (Parte prima)
E. Bucci
– Commento a Cons. Stato, IV sez., 8.9.2009, n. 5266 – Il danno esistenziale causato
all’imprenditore dal provvedimento illegittimo della p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 305
G. Cinque
– Commento a Cass. civ., sez. lav., 22.9.2009, n. 20404 – Illecito disciplinare a condotta
plurima e immediatezza della contestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
263
V. Cugno Garrano
– Commento a Cass. civ., III sez., 29.9.2009, n. 20819 – Diritto di cronaca e pubblicazione della sanzione disciplinare inflitta all’avvocato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
224
F. Esposito
– Commento a Cass. civ., II sez., 22.9.2009, n. 20409 – Considerazioni sull’ammissibilità della servitù di parcheggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
284
L. Klesta Dosi
– Commento a Cass. civ., III sez., 28.8.2009, n. 18805 – La chirurgia estetica tra consumerismo e valore della persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
295
J. Long
– Commento a Cass. civ., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 – Ascolto dei figli contesi e individuazione della giurisdizione nel caso di trasferimento all’estero dei figli da parte del
genitore affidatario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
312
M. Mattioni
– Commento a Cass. civ., II sez., 30.9.2009, n. 20995 – Obblighi di custodia nell’appalto
e art. 1177 cod. civ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
214
R. Mazzariol
– Commento a Cass. civ., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 – L’intervento del coniuge non
acquirente all’atto di acquisto di un bene personale: natura ed effetti. La presa di posizione delle sezioni unite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
253
I. L. Nocera
– Commento a Cass. civ., III sez., 31.8.2009, n. 18920 – Clausola risolutiva espressa e
condizione risolutiva tra autonomia contrattuale e automatismo della risoluzione . . . . .
»
242
L. Ruggeri
– Commento a Cass. civ., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 – L’intervento delle sezioni unite: l’ipoteca, iscritta in data anteriore, prevale sul privilegio del promissorio acquirente .
»
275
Cass., 30.9.2009, n. 20995
c CASS. CIV., II sez., 30.9.2009, n. 20995
Conferma Trib. Como, 27.9.2003
Appalto - Obbligazioni dell’appaltatore - Obbligo di consegna della cosa - Obbligo di custodia della stessa Sussistenza - Correlazione alla detenzione dei beni affidati all’appaltatore - Configurabilità (cod. civ., art.
1177)
Poiché l’obbligazione di consegnare una
cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all’obbligazione accessoria
di adeguata custodia – in relazione alla responsabilità per furto in cantiere edilizio
– ed è, pertanto, tenuto al risarcimento
dei danni, l’appaltatore che non dimostri
di avere adottato tutte le precauzioni che
le circostanze suggerivano, senza che possa rilevare l’avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto, atteso che
l’obbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati all’appaltatore e
non all’attualità del rapporto di appalto, al
quale esso sopravvive.
dal testo:
Il fatto. Con atto notificato il 2.10.01 F.L.,
socio della Cooperativa Edilizia Mughetto a r.l.
che aveva appaltato lavori di costruzione in
(Omissis) all’Impresa Antonio Castelli s.a.s., citò quest’ultima davanti al Giudice di Pace di
Como al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di L. 4.130.000, a titolo di
risarcimento dei danni per l’omessa custodia di
un caminetto prefabbricato, appartenente all’attore ed asportato da ignoti dal cantiere nel
(Omissis). Costituitasi la convenuta, chiese il
rigetto della domanda, segnatamente eccependo che alla data del furto non era più tenuta alla custodia del cantiere edilizio, in quanto la
cooperativa committente era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto
ministeriale del precedente 8/11/00, determinante ipso iure ai sensi della L. Fall., art. 81 lo
scioglimento del rapporto di appalto, con conNGCC 2010 - Parte prima
Appalto
seguente cessazione di ogni obbligazione, anche accessoria, dell’impresa appaltatrice.
All’esito della svolta istruttoria, documentale
e orale, con sentenza dell’8.4.02 il giudice adito
accolse la domanda e tale decisione, appellata
dalla soccombente, con resistenza del F., venne
confermata, con condanna dell’appellante alle
ulteriori spese, dal Tribunale di Como, con
sentenza monocratica del 1.7-27.9.03, come segue essenzialmente motivata: a) pur essendo
stata posta in liquidazione coatta amministrativa la cooperativa committente, con conseguente scioglimento del rapporto di appalto, l’obbligazione accessoria di custodia del cantiere
da parte dell’appaltatrice, che di fatto ne era rimasta nella detenzione, non poteva ritenersi
venuta meno, non essendo ancora intervenuta
una formale consegna dello stesso al curatore
del fallimento; b) tale obbligazione, conformata alla stregua delle disposizioni regolanti il
contratto di deposito, comportava l’osservanza
della custodia delle cose ricevute in consegna
con la diligenza del buon padre di famiglia e
l’onere del depositario di provare il fatto a lui
non imputabile, prova liberatoria non fornita
nel caso di specie, in cui era risultato che il furto, accertato e denunciato da un dipendente
dell’impresa Castelli intento alla periodica ricognizione del cantiere, era avvenuto durante
l’effettiva perdurante detenzione dello stesso.
Avverso tale sentenza la soccombente ha
proposto ricorso per cassazione affidato ad un
unico motivo, cui ha resistito il F. con controricorso, illustrato con successiva memoria.
I motivi. Nell’unico motivo di ricorso, deducente violazione e falsa applicazione di norme
di diritto, con riferimento agli artt. 1177, 1768
e 1218 del Codice Civile nonché all’art. 81 della legge fallimentare, si censura essenzialmente
l’argomentazione basilare della decisione di
merito, secondo la quale la società appaltatrice
avrebbe continuato a dover custodire il cantiere e quanto contenutovi, perché, pur essendo
cessato il rapporto di appalto, sarebbe comunque rimasta in vigore l’obbligazione, ad esso
connessa, della restituzione alla committente
dei beni in questione, comportante, fino alla
consegna la presunzione di responsabilità nell’ipotesi di asportazione degli stessi.
Si sostiene, in contrario, che l’intervenuta
213
Cass., 30.9.2009, n. 20995 - Commento
pronunzia del provvedimento di sottoposizione della committente alla liquidazione coatta
amministrativa avrebbe comportato, ai sensi
della L. Fall., art. 81, l’automatica risoluzione
del contratto di appalto, con connessa cessazione ipso iure di tutte le obbligazioni da esso
nascenti, ivi compresa quella accessoria, di custodire i beni ricevuti in consegna, permanendo il solo obbligo di liberare l’area occupata
dal cantiere, senza alcuna necessità al riguardo
di procedere ad una “consegna formale”, trattandosi di “area a cielo aperto”. Si soggiunge, a
riprova di tale assunto, che la deducente, per
rientrare in possesso di alcuni beni di sua proprietà, sarebbe stata costretta a chiedere l’autorizzazione del giudice delegato al procedimento concorsuale e che, solo a tutela dei propri
interessi e non in adempimento di obblighi
verso la controparte, avrebbe continuato a
controllare quotidianamente il cantiere, a mezzo dei propri dipendenti, al fine di evitare che,
in attesa del definitivo provvedimento del giudice di autorizzazione al ritiro, le proprie attrezzature venissero danneggiate o asportate.
Le censure non meritano accoglimento.
L’obbligazione di riconsegnare una cosa determinata comporta ai sensi dell’art. 1177 cod.
civ., quella di custodirla fino alla consegna.
Nel caso dell’appalto, l’esaurimento o lo
scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto
da luogo, a carico dell’appaltatore, non solo all’obbligo di lasciare liberi gli immobili del
committente sui quali avrebbero dovuto compiersi le opere, ma anche quello di restituire le
cose mobili eventualmente ed a tal fine ricevute in consegna. Tale obbligazione, proprio perché derivante dal venir meno delle esigenze in
funzione delle quali si giustificava la detenzione di tali beni, non può che sorgere nel momento in cui tale cessazione si sia verificata; ne
consegue, pertanto, che, fino a quando la stessa non sia stata comunque adempiuta, mediante la consegna all’avente diritto, l’appaltatore
continua, nonostante la cessazione del rapporto principale di appalto, ad essere detentore
dei beni in questione e, pertanto, in forza della
citata norma civilistica, tenuto alla relativa custodia. Non coglie nel segno, dunque, l’obiezione secondo la quale la risoluzione di diritto,
L. Fall., ex art. 81, del contratto di appalto
avrebbe determinato la cessazione anche del214
Appalto
l’obbligazione di custodire i beni, a suo tempo
ricevuti in consegna dalla committente, considerato che l’obbligo della custodia in siffatti
casi è da ritenersi correlato alla persistenza della detenzione, in attesa della restituzione dei
beni, e non anche all’attualità del rapporto di
appalto, al quale sopravvive.
Del resto, le stesse deduzioni in fatto, sulle
quali si basa il ricorso, confermano la persistenza di tale detenzione, che, non essendo stati i beni della committente ancora materialmente appresi dalla gestione del procedimento
concorsuale, non avrebbe potuto limitarsi alla
sole attrezzature di cantiere, lasciando gli altri
alla merce di estranei.
In definitiva, ribadito il principio, già ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, sicché risponde di inadempimento all’obbligazione di adeguata custodia, in relazione alla responsabilità per furti o rapine, il custode che
non offra prova liberatoria, dimostrando di aver
adottato tutte le precauzioni suggerite dall’ordinaria diligenza (v., tra le altre, Cass. 1510/07,
12089/07, 8512/04, 534/97), deve ritenersi che i
giudici di merito abbiano correttamente affermato, in cospetto della comprovata persistenza
della detenzione degli immobili e di quanto contenutovi, ed in assenza di prove liberatorie da
parte della convenuta la responsabilità di quest’ultima per l’avvenuta asportazione di un bene,
alla cui custodia la stessa era ancora tenuta, ai
sensi dell’art. 1177 c.c., obbligo dal quale l’ex appaltatrice avrebbe potuto liberarsi solo mediante la consegna dei beni in questione o facendone
formale offerta nei modi di legge.
Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza. (Omissis)
[Schettino Presidente – Piccialli Estensore –
Gambardella P.M. (concl. conf.). – Impresa Antonio Castelli s.a.s. (avv.ti Vitolo e Tolu) – F. (avv. Riva)]
Nota di commento: «Obblighi di custodia nell’appalto e art. 1177 cod. civ.»
I. Il caso
Qualche tempo dopo aver appaltato ad un’impresa dei lavori di costruzione, una società cooperativa
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 30.9.2009, n. 20995 - Commento
veniva posta in liquidazione coatta amministrativa,
con ciò determinandosi lo scioglimento del contratto d’appalto ai sensi del combinato disposto degli
artt. 81, comma 1o, e 201, comma 1o, r.d. 16.3.1942,
n. 267. Pochi giorni più tardi, un bene della committente veniva asportato ad opera di ignoti dal cantiere edilizio, il quale – non ancora smobilitato –
permaneva nella materiale disponibilità dell’impresa
appaltatrice. Agiva quindi in giudizio un socio della
cooperativa, chiedendo la condanna dell’appaltatrice al risarcimento del danno derivato dall’omessa
custodia del bene sottratto; resisteva la convenuta
eccependo che, alla data del furto, essa non era più
tenuta alla custodia del cantiere in ragione dell’avvenuto scioglimento del contratto di appalto «con conseguente cessazione di ogni obbligazione, anche accessoria, dell’impresa appaltatrice». Il Giudice di pace
accoglieva la domanda attorea, con decisione confermata dal Tribunale chiamato a pronunciarsi in seconda istanza su ricorso della soccombente. Osservava, in particolare, il Giudice dell’appello che non
poteva ritenersi venuto meno, per il sol fatto dello
scioglimento del contratto, il dovere di custodia gravante sull’impresa appaltatrice, la quale era di fatto
rimasta nella detenzione del cantiere e non aveva
proceduto ad «una formale consegna dello stesso al
curatore del fallimento» (recte: al commissario liquidatore).
Ricorreva nuovamente la soccombente innanzi alla Corte di cassazione, censurando il fondamentale
argomento della sentenza impugnata in base alla
considerazione che lo scioglimento ex lege del contratto d’appalto avrebbe determinato la «cessazione
ipso iure di tutte le obbligazioni da esso nascenti, (...)
permanendo il solo obbligo di liberare l’area occupata
dal cantiere»; essa aveva bensì continuato a sorvegliare quest’ultimo, ma al solo fine di evitare danni
alle proprie attrezzature e non invece in quanto tenuta a tale comportamento in forza di un’obbligazione ormai estinta. La Cassazione, nella sentenza in
esame, respinge l’unico motivo di ricorso affrontando – seppure in modo non del tutto esplicito – la
questione della fonte dell’obbligazione di custodia ex art. 1177 cod. civ.
II. Le questioni
1. La custodia nell’appalto. Il S.C. perviene
al rigetto del ricorso attraverso una motivazione
piuttosto sintetica e non sempre perfettamente lineare in merito alla fondamentale questione posta
dal caso di specie, vale a dire l’individuazione della
fonte dell’obbligo di custodia avente ad oggetto i
beni da restituire in seguito allo scioglimento del
rapporto contrattuale. Premesso che il risultato sostanziale cui la Corte giunge è del tutto condivisibiNGCC 2010 - Parte prima
Appalto
le, posto che un dovere di custodia indubbiamente
sussisteva nel caso di specie, e che dell’inosservanza
di esso l’obbligato risponde ex art. 1218 cod. civ.,
non sembra potersi rinvenire nella pur breve motivazione un’univoca ricostruzione della fisionomia di
tale obbligo e della sua scaturigine. Non è chiaro, in
particolare, se la custodia del cantiere e dei beni in
esso presenti, una volta venuto meno il rapporto
contrattuale, séguiti ad imporsi all’appaltatore in
forza di un obbligo che, originariamente inserito in
quel rapporto, «sopravvive» alla sua estinzione, ovvero gli si imponga come un obbligo nuovo, «incluso» ai sensi dell’art. 1177 cod. civ. in quello restitutorio, che origina dallo scioglimento del rapporto
contrattuale.
È proprio a quest’ultimo obbligo che la Cassazione, in un primo momento, sembra riconnettere il
dovere di custodia: l’obbligazione di restituire le cose ricevute per l’adempimento, in quanto «derivante
dal venir meno delle esigenze, in funzione delle quali
si giustificava la detenzione di tali beni, non può che
sorgere nel momento in cui tale cessazione si sia verificata», ed è quindi altro rispetto agli obblighi inclusi nell’originario rapporto contrattuale, i quali indubbiamente vengon meno in occasione e a causa
del suo scioglimento: il dovere di custodia violato
nel caso di specie parrebbe quindi esser quello di
fonte legale sancito dall’art. 1177 cod. civ. e sorto
dopo la caducazione del contratto. Senonché, poco
dopo, la Corte afferma che «l’obbligo della custodia
(...) è da ritenersi correlato alla persistenza della detenzione (...) e non anche all’attualità del rapporto di
appalto, al quale sopravvive», con ciò dando adito al
dubbio che l’obbligazione di cui si tratta non sorga
ex novo per effetto dello scioglimento del contratto,
in quanto implicata dagli obblighi restitutorî da tale
evento originati, bensì fosse già attuale durante la vigenza del contratto medesimo e ad essa sia «sopravvissuta», dando così luogo ad una singolare figura di
ultrattività di un obbligo inerente al rapporto contrattuale; una conclusione, questa, che già si sarebbe
potuta trarre da un passo della motivazione d’appello (come riportato nella pronunzia in esame), secondo il quale, nonostante lo «scioglimento del rapporto
di appalto, l’obbligazione accessoria di custodia del
cantiere da parte dell’appaltatrice (...) non poteva ritenersi venuta meno». Il dubbio, a ben vedere, non
sembra del tutto infondato alla luce dei contributi di
dottrina e giurisprudenza in tema di obblighi dell’appaltatore, ed appare perciò opportuno fugarlo.
È infatti pacifico che, nell’ambito del rapporto
d’appalto, s’impongano all’appaltatore, oltre all’obbligo principale di compier l’opera o il servizio commessogli, diversi obblighi di custodia. Ne formano
oggetto, innanzitutto, i materiali consegnati dal
committente ai fini dell’esecuzione (Rubino, L’ap215
Cass., 30.9.2009, n. 20995 - Commento
palto, 258; Giannattasio, 153; Contino, 99 s.,
tutti infra, sez. IV; in giurisprudenza, App. Firenze,
21.12.1954, infra, sez. III), ma un analogo dovere è
riscontrabile in capo all’appaltatore in relazione all’opera dedotta in contratto mano a mano ch’essa
viene ad esistenza, sicché all’obbligo di custodia dei
materiali subentra gradualmente quello avente ad
oggetto l’opera in costruzione, finché non sia compiuta. Quanto poi alla custodia dell’opus perfectum,
l’appaltatore vi è tenuto in tutti i casi in cui, giacché
normalmente «la consegna è successiva tanto alla verifica che al collaudo ed all’accettazione, corre un
intervallo di tempo dal momento in cui l’opera è ultimata e quello in cui l’opera stessa è consegnata al
committente» (Giannattasio, 284 s.; per l’appalto
di opere pubbliche, v. Musolino, 244, infra, sez.
IV, e Cass., 2.3.1988, n. 2203, in Rep. Foro it., 1988,
voce «Opere pubbliche», n. 265). Più in generale, è
oggetto di un obbligo di custodia «ogni bene, anche
diverso dai materiali, che debba essere consegnato
all’appaltatore perché esegua l’appalto» (Giannattasio; conf. Rubino, 258, nt. 1, e 282 s.; Contino,
100; Musolino, 243), come gli eventuali mezzi
d’opera e, negli appalti di servizi, «le cose oggetto
stesso delle operazioni di riparazione di modificazione o di manutenzione commesse» (Rubino, 258,
nt. 1; conf. Cass., 22.3.1967, n. 672, infra, sez. III);
quanto, in particolare, agli appalti d’opera, si è affermato che l’appaltatore è gravato da «un obbligo generico per quanto riguarda la custodia del cantiere»
(Musolino, 242; Coll. Arb., 20.5.1992, infra, sez.
III).
L’appaltatore è quindi tenuto non solo alla custodia dei beni che formano oggetto dell’obbligazione
principale del rapporto (quella di realizzare un’opera o di compiere un servizio), ma pure alla custodia
di tutti i beni che si venissero a trovare, in ragione
dell’esecuzione del contratto, nell’ambito del cantiere, o meglio all’interno dell’area di controllo dello
stesso appaltatore. Si tratta, per le ragioni che a breve si esporranno, non di un’unica obbligazione con
oggetto plurimo, ma di obblighi diversi quanto all’oggetto e alla fonte – non a caso si è parlato di obblighi di custodia dell’appaltatore (Rubino, 282 s.;
contra Musolino, 243, che pare sottintendere l’esistenza di un solo generale obbligo di custodia).
Quanto alla natura e alla fisionomia di essi, peraltro,
non si rinvengono – in dottrina come in giurisprudenza – che pochi cenni, dai quali non è agevole ricavare un quadro generale sufficientemente chiaro:
per tale ragione, sembra opportuno tentare di ricostruirne, seppur sinteticamente, i tratti salienti.
Si dirà quindi, a questo proposito, che entrambi
gli obblighi testé delineati s’inseriscono nel rapporto
instauratosi fra le parti del contratto d’appalto, ma
non sorgono dalla medesima fonte. Quello riguar216
Appalto
dante i beni che formano oggetto dell’obbligazione
principale sembra discendere direttamente dall’art.
1177 cod. civ. in quanto incluso nel diverso obbligo,
che ad essa accede, di consegnare i beni stessi. Quello relativo agli altri beni affidati all’appaltatore in ragione dell’esecuzione, invece, non può trovar fonte
nella norma citata, la quale presuppone l’esistenza
di un’obbligazione di consegna/restituzione: la sola
obbligazione di questo tipo che è dato rilevare nell’ambito del rapporto d’appalto è appunto quella relativa ai beni oggetto dell’obbligazione principale,
mentre l’obbligo di restituire gli altri beni affidati all’appaltatore diviene attuale soltanto una volta che
quell’obbligazione sia stata adempiuta. Il dovere di
custodire questi ultimi beni, dunque, sembra discendere piuttosto dall’art. 1175, cod. civ., ed integrare uno di quei cc.dd. obblighi di protezione
«che, in virtù del principio della buona fede, accedono al rapporto obbligatorio in vista dell’interesse
di ciascuna parte a preservare (...) le proprie cose
dalla specifica possibilità di danno, derivante dalla
particolare relazione costituitasi fra i due soggetti»
(Mengoni, 368, infra, sez. IV): si tratta, com’è noto,
di obblighi pienamente autonomi, volti non tanto
«ad assicurare l’adempimento o ad integrare il soddisfacimento del creditore, ma (...) a proteggere distinti interessi (...) correlati allo specifico rischio
connesso allo svolgimento del rapporto» (Cantillo, Le obbligazioni, nella Giurisprudenza Bigiavi,
Utet, 1992, 221 s.). La prospettata ricostruzione è
confermata, del resto, da dottrina e giurisprudenza,
da cui emerge come l’unico obbligo di consegna direttamente nascente dal contratto d’appalto sia
quello relativo ai beni oggetto dell’obbligazione
principale, al quale si suole infatti ricollegare, ex art.
1177 cod. civ., il dovere di custodia – ritenendovi
peraltro applicabile la disciplina del deposito –
(Giannattasio, 284 s.); ne segue, com’è ovvio, che
«quando l’appaltatore abbia effettuato la consegna
dell’opera al committente, cessa il suo dovere di custodia ex art. 1177» (Musolino, 245; conf. App.
Milano, 9.4.1976, n. 843, infra, sez. III). Nondimeno, si è affermato che «l’appaltatore ha l’obbligo di
custodire gli eventuali mezzi d’opera fornitigli dal
commettente, da quando li riceve fino a quando,
estintosi il rapporto d’appalto, deve restituirli» (Rubino, 282), così confermando che l’obbligo di riconsegnare tali beni, diversamente dall’altro, diviene attuale solo una volta che il rapporto d’appalto si
è estinto, e non prima.
Entrambi i descritti obblighi di custodia vengono
meno con lo scioglimento del contratto: quello ex
art. 1177 cod. civ., incluso in quello di consegnare i
beni oggetto dell’obbligazione principale, poiché
col contratto si estingue anche tale obbligo di consegna, e i detti beni vanno a formare oggetto di una
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 30.9.2009, n. 20995 - Commento
nuova obbligazione (quella restitutoria originata
dallo scioglimento del rapporto contrattuale, cui a
sua volta accederà un nuovo obbligo di custodia);
quello ex art. 1175 cod. civ., relativo agli altri beni
affidati all’appaltatore, sempre a causa del venir meno del rapporto contrattuale che ne costituiva il presupposto e l’alveo naturale. Come si è detto, ciò non
significa che in seguito allo scioglimento del contratto nessun dovere di custodia incomba sul soggetto
(già) appaltatore in relazione ai beni che egli era precedentemente tenuto a custodire ex artt. 1175 e
1177 cod. civ.: un tale obbligo, infatti, sussiste
senz’altro, e si tratta di un obbligo nuovo, avente
fonte legale in quanto incluso ex art. 1177 cod. civ.
in quello restitutorio. Se è dunque vero che già durante la vigenza del rapporto contrattuale l’appaltatore è tenuto alla custodia dei beni che formano oggetto dell’obbligazione principale dedotta in contratto, e più in generale dei beni affidatigli in ragione dell’esecuzione, è altresì vero ch’egli vi è tenuto
in base a degli obblighi che inevitabilmente si estinguono assieme al rapporto in cui s’inserivano, lasciando il posto ad un nuovo obbligo di custodia, il
quale accede a quello di restituire i detti beni in ragione dell’estinzione. Si comprende allora perché
non appaia corretto parlare di un obbligo di custodia che «sopravvive» al contratto: sciolto quest’ultimo, infatti, l’ex appaltatore sarà ancora obbligato alla custodia dei beni, ma in forza di un nuovo obbligo incluso in quello restitutorio originato dallo scioglimento del contratto. Inalterata, per così dire, è la
situazione di debenza della custodia, ma affatto diverso ne è il titolo.
2. L’obbligo di custodia ex art. 1177 cod.
civ. Natura giuridica ed inquadramento dogmatico. Chiarita la novità del dovere violato nel caso di specie ed indicatane la fonte, sembra ora opportuno fornire qualche cenno in ordine all’obbligazione di cui all’art. 1177 cod. civ. Com’è noto, tale
disposizione, dalla quale il S.C. prende le mosse,
sancisce che «[l]’obbligazione di consegnare una cosa
determinata include quella di custodirla fino alla consegna»; non è dubbio, peraltro, che sebbene essa
faccia esclusivo riferimento alle obbligazioni di consegnare, il suo ambito d’applicazione ricomprenda
anche gli obblighi restitutorî (la questione è pacifica:
v., per tutti, d’Avanzo, 22; Mastropaolo; Distaso, 86 s.; Breccia, 148, tutti infra, sez. IV; in giurisprudenza, Cass., 17.5.1969, n. 1702, infra, sez. III),
e una conferma di ciò può trarsi dalla stessa pronunzia in esame.
Quanto alla natura giuridica dell’obbligo di cui si
tratta, è rimasta isolata la posizione di chi ha sostenuto che la custodia sia un criterio di responsabilità
sui generis qualificante le obbligazioni di consegna
NGCC 2010 - Parte prima
Appalto
(Majello, passim e 52 ss., infra, sez. IV): è oggi largamente prevalente, infatti, la ricostruzione che assimila la custodia ex art. 1177 cod. civ. a qualsiasi altra attività suscettibile di formare oggetto di un autonomo dovere di prestazione, al pari della stessa
consegna, e a tal proposito si è parlato di «sostanzializzazione» della custodia (di Majo, 3; conf. Cannata, 60; Mastropaolo, 3 ss.; Mengoni, 387; Novità, 131 s., cui si rinvia per ulteriori riferimenti
dottrinali, tutti infra, sez. IV). La prima ricostruzione, in realtà, è probabilmente la più rispondente al
rilievo pratico della figura in discorso, se si pensa
che «chi riceve una cosa non promette una prestazione di un particolare contenuto, ma assume una
responsabilità in ordine alla conservazione della
stessa» (Dalmartello-Portale, voce «Deposito
(dir. vig.)», in Enc. del dir., XII, Giuffrè, 1964, 238),
sicché il dovere di custodia verrà in rilievo soltanto a
posteriori, allorché, di fronte all’inadempimento dell’obbligo (principale) di consegna/restituzione, occorrerà verificare se l’obbligato abbia diligentemente custodito (Majello, 31 s.). Tale impostazione,
tuttavia, entra in crisi dinanzi a quelle figure in cui la
custodia costituisce il momento centrale dell’attività
del soggetto obbligato, perdendo il suo carattere
strumentale e rendendosi difficilmente sostenibile
che essa conservi la sua accessorietà rispetto all’obbligo di consegna/restituzione (così, invece, Mengoni, 387, nt. 12; contra di Majo, 4 s.; Dalmartello-Portale, 238 ss.); inoltre, non si è mancato di
osservare come la stessa custodia, se intesa come criterio di responsabilità, si risolva in «un inutile doppione del concetto di diligenza, che certamente è
presente e operante anche nella obbligazione di custodia, come misura o criterio di responsabilità»
(Dalmartello-Portale, 238, nt. 10).
Più in generale, è parso «improponibile che, per i
sistemi moderni, si perpetui l’esistenza di un peculiare criterio di responsabilità, distinto da quello di
diligenza» (di Majo, 8): in un sistema in cui la diligenza costituisce il parametro generale e «normale»
di valutazione del comportamento del debitore, trovando applicazione alla stessa custodia, quest’ultima
finisce quindi con l’essere assimilata a tutte le altre
prestazioni. La «sostanzializzazione» della custodia
è stata così collocata lungo la «linea di evoluzione
teorica che tende ad arricchire la (struttura della)
obbligazione, convertendo i criteri di responsabilità
in comportamenti esigibili e/o prestazioni dovute»
(ivi, 11), sicché quello che era caratterizzato dalla
parallela operatività di più criteri di responsabilità si
va configurando come un sistema monistico fondato
sul principio di cui all’art. 1176 cod. civ. Su un piano più concreto, inoltre, si è osservato che «il comportamento di custodia presenta una complessità e
un’articolazione che non sembrano riducibili al pro217
Cass., 30.9.2009, n. 20995 - Commento
blema dell’individuazione del criterio di imputazione dell’inadempimento del[l]’obbligazione di consegnare» (Breccia, 151).
Una volta dimostrato che l’obbligo di custodia incluso in quello di consegnare una cosa determinata
ha natura di vero e proprio dovere di prestazione
(fra l’altro, è pacifico trattarsi di obbligazione di risultato: v., per tutti, Mengoni, 387; Cannata; contraddittoria Cass., 17.5.1969, n. 1702, cit.), le qualificazioni che ne sono state proposte e i tentativi d’inquadrarlo nell’ambito di una ricostruzione sistematica del rapporto obbligatorio sono stati diversi.
Nondimeno, è ricorrente e pressoché costante il riferimento al carattere accessorio e/o sussidiario di
tale obbligo (Cian, 246, infra, sez. IV; Novità, 135
s.), pur variando il grado di autonomia attribuitogli
rispetto all’obbligazione principale cui esso, per sua
natura, accede. L’opinione di gran lunga prevalente,
inoltre, è nel senso che «la violazione dell’obbligo di
custodia – mettendo in pericolo la integrità della cosa che costituisce il principale interesse protetto dal
rapporto obbligatorio – è autonomamente perseguibile, a prescindere cioè dalla successiva violazione
dell’obbligo di restituzione» (Giorgianni, 251;
conf., ex multis, Bianca, 26 ss.; Castronovo, sub
art. 1177, tutti infra, sez. IV). Se dunque la diligente
prestazione di custodia è autonomamente esigibile,
«anche se la negligenza non ha arrecato ancora alcun danno (...) non può negarsi al creditore il diritto
alla risoluzione del contratto e ad idonee misure
cautelari» (Giorgianni; conf. Bianca, 30; di
Majo, 11; Novità, 132 s., cui si rinvia per ulteriori
riferimenti dottrinali; contra Majello; contra Betti,
94 ss.; Cannata, 41 ss., infra sez. IV).
3. (Segue): profili di disciplina. Quanto alla
disciplina sostanziale dell’obbligo di cui all’art. 1177
cod. civ., si è osservato che, nella ricostruzione del
relativo statuto normativo, «[p]er un riflesso che è
da ritenere connaturale in tutti i fenomeni in cui si
utilizzano figure normative già sperimentate, dovrà
aversi riguardo a quelle fattispecie in cui l’aspetto
della custodia è già un dato stabilmente acquisito all’istituto giuridico» (di Majo, 12), come nel caso del
deposito. La questione è stata affrontata in giurisprudenza soprattutto sotto il profilo della responsabilità del custode (infra, sez. III, e sez. IV); più in
generale, però, è pacifica, in linea di principio, la
soggezione dell’obbligo di custodia al generale statuto normativo delle obbligazioni di fare, alla cui
stregua dev’esserne individuata la disciplina (di
Majo, 14; Cannata, 60 s.; Breccia, 148 s.), fatte
ovviamente salve le speciali regole previste per i casi
in cui l’obbligo in discorso s’inserisca nel quadro di
particolari rapporti contrattuali (v., per esempio,
l’art. 1477 cod. civ.).
218
Appalto
Ciò non esclude, peraltro, che di volta in volta
possano risultare applicabili all’obbligo di custodia,
per interpretazione estensiva od analogica, singole
regole dettate per altre figure quali il deposito, il comodato e, più in generale, i contratti che «hanno come scopo di assicurare il godimento di cose per un
tempo determinato (e) per uno scopo prestabilito»
(di Majo, 13, cors. orig.; conf. Breccia, 149 s.; Mastropaolo, 7). La disciplina dell’obbligo in esame
«si arricchisce dunque [...] di quelle singole norme
previste nelle sedi in cui il legislatore ha ritenuto di
dare espressa disciplina alla obbligazione di custodia» (di Majo, 15); occorre però aver sempre presente che quest’ultima, nella sua accezione «generica» ex art. 1177 cod. civ., «va vista (...) in un’ottica
diversa dall’obbligazione di custodia (...) come obbligazione principale che connoti un rapporto contrattuale» (Cian), sicché all’analogia dovrà farsi luogo con prudenza e «con riguardo soltanto a singole,
specifiche norme» (Cian). Particolarmente discussa, a tal proposito, è l’applicabilità degli artt. 1770 e
1780 cod. civ., dettati in materia di deposito: quanto
al primo, si è rilevato che la «stretta correlazione che
deve essere istituita tra la norma dell’art. 1770, comma 1o, cod. civ. e la causa depositi, in relazione alla
natura eminentemente fiduciaria che caratterizza il
rapporto tra depositante e depositario» (Dell’Utri,
825, infra, sez. IV), sconsiglia di ritenere, in linea di
principio, che la stessa norma possa essere esportata
oltre i confini del tipo contrattuale che ne rappresenta la sede naturale di applicazione; minori perplessità si registrano invece a proposito del comma
2o della citata disposizione, mentre è generalmente
dubbia l’applicabilità dell’art. 1780 cod. civ. (v., per
tutti, Grisoli, Alcune postille in tema di responsabilità del depositario, in Riv. dir. comm., 1956, II, 83
ss.), che pure talvolta è stata accolta dalla giurisprudenza (sull’esportabilità di tale norma al di fuori del
terreno del deposito, v., da ultimo, Cass., 19.7.2004,
n. 13359, in Rep. Foro it., 2004, voce «Deposito
(contratto di)», n. 6).
III. I precedenti
1. La custodia nell’appalto. Sugli obblighi di
custodia inerenti al rapporto d’appalto, v., ex multis,
Cass., 11.11.1950, n. 2586, in Giur. compl. Cass. civ.,
1950, III, 503 ss., con nota critica di Rubino, Limiti
e contenuto, infra, sez. IV; Cass., 22.3.1967, n. 672,
in Giur. it., 1968, I, 1, 178 ss.; App. Firenze,
21.12.1954, in Giur. tosc., 1955, 21; App. Roma,
25.1.1958, in Rep. Foro it., 1958, voce «Appalto», n.
42; App. Milano, 9.4.1976, n. 843, in Mon. trib.,
1976, 375 ss.; Coll. Arb., 20.5.1992, in Rep. Foro
it., 1994, voce «Appalto», n. 52. Quanto, in particolare, alla disciplina degli obblighi di custodia delNGCC 2010 - Parte prima
Cass., 30.9.2009, n. 20995 - Commento
l’appaltatore, la giurisprudenza ha sempre sostenuto
la diretta applicabilità ad essi della disciplina del deposito: v., per tutte, Cass., 11.11.1950, n. 2586, cit.;
conf. App. Firenze, 21.12.1954, cit.; App. Roma,
25.1.1958, cit.
2. L’obbligo di custodia ex art. 1177 cod.
civ. Natura giuridica ed inquadramento dogmatico. Non si registrano precedenti esattamente
in termini della sentenza in esame, la quale applica
l’art. 1177 cod. civ. agli obblighi restitutori originati
dallo scioglimento del contratto d’appalto. Della
stessa norma, tuttavia, già si era fatta applicazione in
fattispecie analoghe, e precisamente nei casi di annullamento del contratto di compravendita (Cass.,
11.11.1977, n. 4892, in Giur. it., 1978, I, 1, 1253 ss.,
e, amplius, in Foro it., 1978, I, 2021 ss.) e di sua risoluzione (Cass., 18.2.1980, n. 1192, in Mass. Foro it.,
1980; Cass., 23.4.1991, n. 4423, in Giust. civ., 1992,
I, 1341 ss., con nota redazionale cui si rimanda per
ulteriori riferimenti).
Qualche punto di contatto con la pronunzia in
esame è presente in Cass., 22.3.1967, n. 672, cit., in
relazione ad un caso di consegna di un autoveicolo
ad un’officina di riparazione e successiva distruzione del motore per colpa di un ausiliario dell’appaltatore, con conseguente impossibilità sopravvenuta
della prestazione: in tale occasione il S.C. ha sostenuto che «l’appaltatore risponde dei danni connessi
all’inadempimento del suo obbligo di custodia anche
dopo che sia divenuta impossibile per sua colpa la specifica prestazione (di riparazione) dedotta nel contratto». Alla tesi della parte ricorrente – analoga a quella
della ricorrente del caso di cui alla sentenza in commento – la Corte replica che essa «si basa sul falso
presupposto che, non eseguito il contratto per colpa
dell’appaltatore e divenuta anzi impossibile la specifica prestazione (di riparazione) nel contratto dedotta,
l’appaltatore si liberi dall’obbligazione di custodia, caratteristica dell’appalto d’opera. Al contrario deve ritenersi che (...) l’appaltatore risponde (...) dei danni
che siano conseguenza immediata e diretta del suo
inadempimento, e perciò anche di quelli connessi all’inadempimento dell’obbligazione di custodia che
(...) non è un’obbligazione accessoria, ma rientra nel
contenuto di quella, più ampia, di fare, che egli si è assunta»: anziché ritenere – come fa la Cassazione nella sentenza in commento – che l’appaltatore fosse
tenuto a custodire ai sensi dell’art. 1177 cod. civ. in
quanto obbligato alla riconsegna a seguito dell’estinzione dell’obbligazione ex art. 1256 cod. civ., la Corte ricostruisce qui il dovere di custodia non già come un obbligo a sé, ma come uno specifico profilo
della più ampia obbligazione di fare, la quale non
verrebbe del tutto meno nonostante la sopravvenuta
impossibilità del suo profilo principale.
NGCC 2010 - Parte prima
Appalto
Merita inoltre d’esser segnalata, per lo spazio che
dedica al tema della natura dell’obbligo di cui all’art.
1177 ed al suo inquadramento, Cass., 17.5.1969, n.
1702, in Foro it., 1969, I, 1697.
3. (Segue): profili di disciplina. La questione
dell’applicabilità della disciplina del deposito al generale dovere di custodia è stata affrontata in giurisprudenza non tanto con riferimento all’applicazione analogica di singole disposizioni, quanto in relazione al tema della responsabilità, sulla base dell’opinione – oggi in fase di superamento e non estranea
all’influenza dell’antica responsabilità ex recepto come forma di responsabilità aggravata – che la responsabilità del depositario sia sostanzialmente diversa sotto il profilo probatorio da quella di qualsiasi
altra figura di custode, e dunque anche da quella del
generico custode ex art. 1177 (Cass., 27.10.1981, n.
5618, in Rep. Foro it., 1981, voce «Obbligazioni in
genere», n. 10). Hanno così applicato in via diretta la
disciplina del deposito all’obbligo ex art. 1177:
Cass., 3.3.1965, n. 359, in Giur. it., 1965, I, 1, 556
ss., in base al criterio del negozio misto; Cass.,
27.10.1981, n. 5618, cit., in base a quello dell’accessorietà/prevalenza della prestazione di custodia;
Cass., 23.1.1986, n. 430, in Mass. Foro it., 1986, e
Cass., 12.11.1979, n. 5847, ivi, 1979, in base a quello
dell’esclusività di tale prestazione. Di diverso avviso
è invece la più recente giurisprudenza – prima di merito e poi di legittimità –, la quale ha condivisibilmente escluso «che dalla lettura dell’art. 1177 (...)
possa evincersi l’esistenza di due differenti regimi della responsabilità del custode a seconda che si verta in
tema di obbligazioni principali od accessorie» (Trib.
Verona, 2.11.1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 816 ss.,
con nota critica di Dell’Utri, infra, sez. IV; conf.
Cass., 10.12.1996, n. 10986, in Rep. Foro it., 1996,
voce «Lavoro autonomo», n. 2; da ultimo, Cass.,
24.5.2007, n. 12089, in Giust. civ., 2008, I, 1237 ss., e
in Giur. it., 2008, 881 ss., con ampia nota redazionale ricca di riferimenti).
IV. La dottrina
1. La custodia nell’appalto. Sugli obblighi di
custodia nell’appalto, v. Rubino, L’appalto, nel
Trattato Vassalli, VII, 3, Utet, 1980, 258 e 282 s.;
Giannattasio, L’appalto, nel Trattato Cicu-Messineo, XXIV, 2, Giuffrè, 1977, 153 ss. e 284 s.; Contino, Fornitura dei materiali, in L’appalto privato,
trattato diretto da Costanza, Utet, 2000, 99 ss.;
Musolino, La fornitura e la custodia dei materiali
per l’esecuzione del contratto di appalto, in Riv. trim.
app., 2002, 240 ss. Sui cc.dd. doveri di protezione, è
d’obbligo il rinvio a Mengoni, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi», in Riv. dir. comm.,
1954, I, 368 ss.; si segnalano inoltre, fra i contributi
219
Cass., 30.9.2009, n. 20995 - Commento
più recenti e ricchi di riferimenti, Benatti, voce
«Doveri di protezione», nel Digesto IV ed., Disc.
priv., sez. civ., VII, Utet, 1991, 221 ss.; Castronovo, voce «Obblighi di protezione», in Enc. giur.
Treccani, XXIV, Ed. Enc. it., 1991, 1 ss.
Quanto alla disciplina sostanziale degli obblighi
di custodia che s’inseriscono nel rapporto d’appalto,
è discussa l’applicabilità delle norme relative al deposito. Secondo un’opinione (Rubino, 283) essa sarebbe ammissibile nei limiti dell’analogia, ma la dottrina maggioritaria ne sostiene la diretta applicabilità (Giannattasio, 153; conf. Musolino, 242 s.).
In relazione all’art. 1770, cod. civ., sono peraltro state espresse notevoli perplessità (Rubino, Limiti e
contenuto dell’obbligo di custodia dei materiali da
parte dell’appaltatore, nota a Cass., 11.11.1950, n.
2586, supra, sez. III; Dell’Utri, Dovere di custodia,
obbligazioni accessorie e causa del contratto, nota a
Trib. Verona, 2.11.1992, supra, sez. III; conf.
Giannattasio, 154; Contino, 100 s.): sicuramente
inapplicabile all’appalto dovrebbe ritenersi il comma 1o, ma seri dubbi sono sorti anche in merito al 2o
(Musolino, 243).
In generale, sui rapporti fra appalto e deposito, v.
Novità, in Napoletano-Barbieri-Novità, I contratti reali, nella Giurisprudenza Bigiavi, Utet, 1965,
142 s.
2. L’obbligo di custodia ex art. 1177 cod.
civ. Natura giuridica ed inquadramento dogmatico. In generale, sull’obbligo di custodia di cui
all’art. 1177 cod. civ., v. di Majo, Dell’adempimento
in generale, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1994, sub art. 1177, 1 ss.; Mastropaolo, voce «Custodia, I, disc. priv.», in Enc. giur.
Treccani, XI, Ed. Enc. it., 1989, 1 ss.; Castronovo,
nel Commentario Cendon, IV, 1, Utet, 1991, sub art.
1177; Novità, 128 ss.; Breccia, Le obbligazioni, nel
Trattato Iudica-Zatti, Giuffrè, 1991,148 ss.; Cannata, Le obbligazioni in generale, nel Trattato Rescigno, 9, Utet, 1999, 60 s.; Distaso, Le obbligazioni in
generale, nella Giurisprudenza Bigiavi, Utet, 1970,
83 ss. Ormai datati, ma comunque utili per gli spunti che offrono, sono i contributi di Miccio, Delle
obbligazioni in generale, nel Commentario Utet, IV,
1, Utet, 1957, 44 ss., e di d’Avanzo, nel Commentario D’Amelio-Finzi, Libro delle obbligazioni, I, Barbèra, 21 s.
Unanimemente rifiutata è oggi la ricostruzione,
proposta da Majello, Custodia e deposito, Jovene,
1958, passim e 52 ss., della custodia come criterio di
responsabilità (per un’efficace critica, v. Schlesinger, recensione a Majello, in Riv. dir. civ., 1961, I,
407). La dottrina largamente maggioritaria, inoltre,
ritiene l’obbligo di custodia autonomamente aziona-
220
Appalto
bile (v. Giorgianni, L’inadempimento, Giuffrè,
1959, 249 ss.; Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1979, sub art. 1218, 26 ss.; Schlesinger; di Majo, 11; Castronovo; Novità, 131 ss.;
Cian, voce «Pagamento», nel Digesto IV ed., Disc.
priv., sez. civ., XIII, Utet, 1995, 246; in tal senso pare orientato anche d’Avanzo, 21 s.), sebbene non
siano mancati, anche di recente, i sostenitori dell’opposta tesi (Betti, Teoria generale delle obbligazioni, I, Giuffrè, 1953, 94 ss.; Cannata, 41 ss.). Sul
concreto contenuto dell’obbligo de quo, v. Mastropaolo, 7 ss.; Novità, 130 s. e 133 s.; cenni in Nicolò, voce «Adempimento (dir. civ.)», in Enc. del dir.,
I, Giuffrè, 1958, 562.
Sulle obbligazioni restitutorie conseguenti all’estinzione del rapporto contrattuale, v. Sacco, in
Sacco-De Nova, Il contratto, II, Utet, 1996, 636 ss.;
Gallo, voce «Ripetizione dell’indebito», nel Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., XVIII, Utet, 1998, 9
s.; Bruni, Contributo allo studio dei rapporti tra azioni di caducazione contrattuale e ripetizione di indebito, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1987, 173 ss.; Stolfi,
Teoria del negozio giuridico, Cedam, 1961, 70 ss.
3. (Segue): profili di disciplina. Circa l’individuazione della disciplina sostanziale applicabile all’obbligo di custodia, i necessari riferimenti sono
stati indicati supra, sez. II, sub 3.
L’orientamento giurisprudenziale che ha fatto applicazione della disciplina del deposito al generale
dovere di custodia in base al criterio del contratto
misto (v. sez. III; su quest’ultimo concetto e sulla
differenza rispetto a quello di contratto atipico, v.
Novità, 135 ss., cui si rimanda anche per una rassegna degli orientamenti giurisprudenziali in materia)
è stato criticato da di Majo, 13, poiché finisce con
lo svalutare la portata dell’art. 1177 cod. civ., in forza del quale «(l)’elevazione della custodia a prestazione dovuta negli obblighi di consegna di cosa determinata prescinde dalla volontà delle parti e quindi dalla ricorrenza di uno schema negoziale» (cors.
orig.). Si è inoltre osservato che, alla luce della generale tendenza che si risolve nel «passaggio da un sistema pluralistico di criteri di responsabilità a quello
di una loro unificazione (...), non dovrebbe esservi
spazio per una diversa valutazione, in termini di colpa, dell’attività di custodia» (di Majo, 5, cors.
orig.), tanto nel caso in cui quest’ultima costituisca
la principale o l’esclusiva prestazione dedotta in
contratto, quanto in quello in cui essa sia soltanto
accessoria ad altra prestazione (conf. Dell’Utri,
824; Castronovo; Mastropaolo, 4).
Matteo Mattioni
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 29.9.2009, n. 20819
c CASS. CIV., III sez., 29.9.2009, n. 20819
Conferma App. Trieste, 16.4.2005
Avvocato - Condanna ad una sanzione disciplinare - Segretezza della
notizia - Insussistenza (cod. civ., artt.
2043, 2059, 2697; cod. pen., art. 621; r.d.l.
27.11.1933, n. 1578, artt. 16; 46, 64; l. 31.12.1996, n.
675, art. 21)
Non ha diritto ad alcun risarcimento l’avvocato che scopre da un quotidiano la sua
condanna ad una sanzione disciplinare,
atteso che è lecito divulgare gli esiti del
procedimento a carico del legale, anche se
il professionista non era ancora al corrente della decisione finale.
dal testo:
Il fatto. Con atto di citazione, notificato in
data 29 agosto 2001, l’avvocato B.L. conveniva
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trieste, la
Editoriale F.V.G., S.p.A. in persona del legale
rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al pagamento della somma di lire
500.000.000 a titolo di risarcimento del danno
patito a cagione dei reati di cui agli art. 323 e
326, 595 e 621 c.p. commessi dalla convenuta
ai suoi danni, oltre alla violazione della legge
675/96 sulla riservatezza dei dati personali.
A fondamento della pretesa illustrava: che,
in data 27 gennaio 1999, sul quotidiano Il Piccolo era apparso un articolo che riferiva degli
esiti di un procedimento disciplinare a suo carico la cui decisione finale era ignota finanche
all’attore che aveva ricevuto notifica del provvedimento emesso dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Trieste appena in data 7 aprile 1999; ne desumeva la violazione del segreto
tutelato dagli artt. 323 e 326 c.p. e l’acquisizione indebita ex art. 621 c.p. della notizia che, il
responsabile della pubblicazione aveva trattato
in maniera difforme al dettato dell’art. 21 L. n
675/1996; rimarcava il contenuto manifestamente diffamatorio della notizia divulgata, che
non poteva essere scriminato dal diritto di cronaca per la non veridicità del fatto rivelato, in
quanto egli aveva subito una sanzione discipliNGCC 2010 - Parte prima
Avvocato
nare per altre vicende, ma era stato prosciolto
dalle accuse mossegli da una sua famosa cliente; concludeva chiedendo la condanna della
convenuta al risarcimento del danno, compreso quello alla reputazione per la diffusione nazionale e internazionale che la notizia aveva ricevuto, quantificando il risarcimento nella
somma di lire 500.000.000.
Con comparsa depositata in data 21 novembre 2002 si costituiva la Editoriale F.V.G.
S.p.A. contestando la domanda avversaria: sosteneva l’insussistenza della diffamazione perché l’articolo, con termini continenti, si era limitato a riportare una notizia vera e cioè l’esito
di un processo disciplinare a carico del B.L.
iniziato in seguito ad una denuncia presentata
da una sua cliente particolarmente famosa a livello nazionale; rappresentava la continenza e
correttezza del testo dell’articolo che aveva illustrato al pubblico lo stato della vicenda intercorrente fra due personaggi, molto noti, venuti
in contesa fra loro, stigmatizzando i vari aspetti
della notizia divulgata con atteggiamento equidistante fra i due contendenti; richiamava la riferibilità dei reati ai soli pubblici ufficiali e non
al giornalista che non aveva acquisito la notizia
illecitamente, ma attraverso normali canali informativi concernenti i procedimenti a carico
di un componente dell’Ordine professionale;
respingeva la tesi della non veridicità della notizia perché il nucleo centrale della stessa era
veritiero; concludeva, pertanto, chiedendo la
reiezione della domanda con vittoria di spese.
La causa veniva istruita esclusivamente con
acquisizione documentale e decisa con sentenza del Tribunale di Trieste depositata in data
28 marzo 2003.
Il primo giudice respingeva la domanda dell’attore ritenendo sussistere il diritto di cronaca legittimamente esercitato con la diffusione
di una notizia che era vera perché il professionista aveva subito una sanzione disciplinare
per un procedimento iniziato in base ad una
denuncia di una determinata persona.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il B.L. con atto di citazione notificato in
data 23 giugno 2003.
Con un unico motivo l’appellante: criticava
il ragionamento del primo giudice che non aveva tenuto in alcun conto la valenza diffamatoria, oltre che offensiva, del fatto inveritiero che
221
Cass., 29.9.2009, n. 20819
era stato comunicato al pubblico e cioè che
l’avvocato B.L. era stato sanzionato per addebiti mossi da quella cliente, mentre il professionista era stato assolto da quelle accuse, ma, per
altre vicende, aveva subito una sanzione pari a
quella divulgata dal giornale; ripresentava gli
argomenti relativi agli altri reati anch’essi fonte
del danno e le violazioni alla normativa sulla riservatezza per l’indebita acquisizione della notizia; concludeva chiedendo, nel merito, la totale riforma dell’impugnata sentenza, con accoglimento della domanda attrice che limitava
a P 51.645,00 e, in via istruttoria, l’acquisizione
ex art. 213 c.p.c. di informazioni presso il Consiglio dell’Ordine in merito all’esito del procedimento disciplinare celebrato contro l’avvocato B.L.
Si costituiva l’appellata società editrice, con
comparsa depositata in data 31 marzo 2004,
chiedendo il rigetto dell’appello; a tal fine richiamava le forme di lecita pubblicità delle decisioni del consiglio dell’Ordine e corretto il
diritto di cronaca esercitato con continenza e
imparzialità.
La causa, senza istruttoria, veniva decisa in
Camera di consiglio sulle conclusioni rassegnate dalle parti all’udienza, ex art. 352 c.p.c., in
data 12 gennaio 2005.
Con sentenza del 6-16 aprile 2005 la Corte
d’Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “... rigetta l’appello
proposto da B.L. avverso la sentenza n. 391/03
del Tribunale di Trieste che, per l’effetto, conferma in ogni sua parte; b) condanna l’appellante B.L. alla rifusione delle spese sostenute
dall’appellata società che liquida per il presente grado in complessivi euro 5.095,00 di cui euro 127,00 per spese, euro 1.068,00 per diritti
ed euro 4.500,00 per onorari (inclusi rimborsi
forfettari) oltre IVA e CPA come per legge”.
Contro questa decisione ha proposto ricorso
per cassazione l’avvocato B.L. (che ha anche
depositato memoria); ha resistito con controricorso la Editoriale F.V.G. S.p.A.
I motivi. I motivi di ricorso vanno esaminati
insieme in quanto connessi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Art. 360 n. 3 e 5
c.p.c. – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Omessa insufficiente contraddittoria motivazione” esponendo doglianze da
222
Avvocato
riassumere come segue. La sentenza impugnata
è stata pronunciata in violazione dei più elementari principi in materia di prova ed in particolare della previsione di cui all’art. 2697 II
comma c.c.: “... Chi eccepisce ... che il diritto si
è modificato o estinto deve provare i fatti su
cui l’eccezione si fonda”.
L’avvocato B.L. ha comprovato la diffusione
di una notizia oggettivamente diffamatoria. Invero, la pubblicazione di un articolo – che riferisce di una sanzione disciplinare inflitta ad un
professionista, con accostamento di foto – costituisce sicuramente lesione dell’onore e della
reputazione. “... Ancor di più, tali beni appaiono lesi, laddove nell’articolo si legge che il professionista venne accusato da D.D.R. e A.M. di
aver sollecitato la propria nomina a difensore,
essendosi impegnato a prestare attività professionale gratuitamente (in quanto pago della
pubblicità che la vicenda avrebbe procurato)
per avere in seguito preteso giudizialmente un
compenso ...”.
Invece controparte non ha assolto l’onere di
dimostrare di aver legittimamente esercitato il
diritto di cronaca: l’avv. B.L. ha sempre contestato la veridicità della notizia, chiedendo, in
via istruttoria e con ciò facendosi carico di un
onere probatorio a lui non diretto, l’acquisizione di informazioni presso il C.O.A. di Trieste
ex art. 213 c.p.c., in ordine al suo proscioglimento, per i fatti indicati nell’articolo oggetto
di causa.
Afferma la Corte che, essendo il ricorrente in
possesso della decisione del Consiglio dell’Ordine, sarebbe stato suo onere provvedere al deposito della stessa.
L’assunto, oltre a dar vita a un vizio di contraddittorietà della motivazione, stravolge i
principi stabiliti dall’art. 2697, II comma, c.c.
in tema di onere della prova. Mai potrà essere
imposto a parte attrice l’onere di produrre in
giudizio un documento asseritamente attestante la modificazione o l’estinzione del diritto da
lui vantato. Oltretutto, trattandosi di documento riservato e segreto, nonché relativo a
fatti che nulla hanno a che vedere con l’esposto
cui fa cenno l’articolista de “Il Piccolo”, non
potrà mai formare onere di prova attorea la
produzione dello stesso.
Proprio al fine di evitare la produzione di
documenti riservati l’attore richiedeva l’assunNGCC 2010 - Parte prima
Cass., 29.9.2009, n. 20819
zione di informazioni presso il C.O.A., relative
unicamente al suo proscioglimento, con riferimento ai fatti pubblicati sulla stampa, evitando
con ciò di rendere pubbliche notizie coperte
da segreto e non pervenute agli organi di stampa stessi, nonché riguardanti persone estranee
eventualmente coinvolte nella vicenda.
Neppure appare invocabile il disposto del
secondo comma dell’art. 116 c.p.c., che consente al Giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. Invero,
tale norma sicuramente non inficia i principi
relativi all’onere della prova e non rientra sicuramente in un atteggiamento valutabile negativamente, la mancata produzione di documenti
di cui deve farsi carico parte avversa.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia
“Art. 360 nn. 3 e 5 c.c. – Violazione o falsa applicazione di norma di diritto – Omessa insufficiente contraddittoria motivazione” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente.
Afferma la Corte d’Appello che non sarebbe
stato in alcun modo dimostrata la violazione
del segreto d’Ufficio, che ha comportato successivamente l’indebita diffusione della notizia.
L’art. 621 c.p., tuttavia, sanziona chiunque essendo venuto abusivamente a cognizione del
contenuto, che debba ritenere segreto, di altrui
atti o documenti, lo rivela. Non appare quindi
importante a tal punto fornire la prova di chi e
come abbia posto in essere la violazione del
contenuto di documenti segreti, apparendo
sufficiente la prova della abusiva rivelazione
degli stessi. Del fatto che si tratti di documenti
coperti da segretezza e riservatezza non viene
posto alcun dubbio neppure dalla Corte d’Appello di Trieste, nella motivazione della sentenza impugnata.
D’altra parte, conformi sono i pareri del
Consiglio Nazionale Forense (n. 6 del 19 aprile
1998, parere dd. 24 settembre 1992) che ribadiscono la segretezza e riservatezza delle decisioni disciplinari.
Connessa alla natura segreta di tale documento è pure la violazione della privacy, nonché la natura diffamatoria della notizia indipendentemente dalla veridicità della medesima.
Il ricorso non può essere accolto in quanto
l’impugnata decisione si basa su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e
rispettosa della normativa in questione.
NGCC 2010 - Parte prima
Avvocato
In particolare, con riferimento alla “... violazione del segreto...” va rilevato che nell’impugnata sentenza si legge quanto segue: “... Dal
canto suo la convenuta appellata ha contestato
la caratteristica di segretezza della notizia riguardante il professionista condannato a sanzione disciplinare indicando negli artt. 16 e 46
R.D.L. n. 1578/1933 e 51 e 64 R.D. n. 37/1934
le forme di pubblicità legale che consentono a
coloro che intendano consultare gli albi professionali di conoscere i provvedimenti disciplinari presi a carico degli iscritti. La tesi alternativa
proposta dalla convenuta appellata esclude in
radice l’ipotizzabilità di una illegittima acquisizione di notizia segreta perché le modalità di
apprendimento della notizia possono essere
state assolutamente lecite ed incombe a chi invoca il reato, quale fonte del risarcimento, di
dimostrarne l’esistenza anche in termini vaghi
e senza indicazione dell’autore, ma pur sempre
nel concreto verificarsi del crimine.
Nell’ipotesi in esame manca totalmente anche il più piccolo indizio sull’appropriazione
indebita della notizia la cui segretezza non può
desumersi dalla segretezza delle udienze del
Consiglio dell’Ordine posto che le decisioni
anche non definitive hanno una pur limitata
forma di diffusione. Chiuso l’argomento segretezza...”.
Da tale brano (specie se inquadrato nel contesto della decisione) appare palese che la Corte di merito ha recisamente negato la caratteristica di segretezza della notizia riguardante il
professionista condannato a sanzione disciplinare; e che lo ha fatto sulla base di una motivazione del tutto adeguata (immune da vizi logici
o da violazioni della normativa sopra citata).
Di fronte a tale negazione ed a tale motivazione della medesima la parte ricorrente ha
esposto censure decisamente generiche (e
quindi inammissibili prima ancora che prive di
pregio) poiché non prendono in rituale considerazione il reale contenuto della sentenza sul
punto.
Anche la residua motivazione esposta dalla
Corte è ineccepibile sotto tutti i profili in esame, tra cui quelli riguardanti l’onere probatorio.
In particolare, con riferimento all’art. 116
c.p.c., appare inidonea a suffragare l’assunto
del ricorrente l’affermazione del medesimo che
223
Cass., 29.9.2009, n. 20819 - Commento
“... tale norma sicuramente non inficia i principi relativi all’onere della prova...”. È infatti indubbio che l’art. 116 non inficia detti principi;
ma è altrettanto indubbio che, nel pieno rispetto dei principi medesimi, il Giudice può ritenere raggiunta la prova (anche a favore del soggetto in capo al quale incombe l’onere probatorio) allorquando ritiene di applicare il seguente principio di diritto (implicitamente utilizzato nell’impugnata sentenza): “il comportamento processuale (nel cui ambito rientra
anche il sistema difensivo adottato dal suo procuratore) o extraprocessuale delle parti, può
costituire, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.,
non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte
di prova” (v. tra le altre Cass. n. 14748 del 26/
06/2007, Cass. n. 9279 del 04/05/2005; e Cass.
n. 12145 del 10.08.2002).
Non rimane dunque che rigettare il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come esposto nel dispositivo. (Omissis)
[Filadoro Presidente – Fico Estensore – Fucci
P.M. (concl. conf.). – B.L. (avv. Tarlao) – Editoriale
F.V.G. s.p.a. (avv.ti Martinetti e Fornasaro)]
Nota di commento: «Diritto di cronaca e pubblicazione della sanzione disciplinare inflitta all’avvocato»
I. Il caso
Un avvocato conveniva in giudizio l’editore del
giornale che ha pubblicato l’esito di un procedimento disciplinare celebrato nei suoi confronti dal locale
Ordine professionale – la cui decisione era sconosciuta persino allo stesso legale – con accostamento
delle fotografie delle persone coinvolte nella vicenda.
Il quotidiano aveva dato alle stampe la notizia
che il legale era stato accusato da una sua cliente,
molto famosa anche a livello nazionale, di aver sollecitato la propria nomina a difensore, con l’impegno di prestare gratuitamente la propria attività
professionale (in quanto pago della pubblicità che
la vicenda gli avrebbe procurato) e di avere, in seguito, invocato in via giudiziale un compenso subendo un procedimento deontologico con relativa
sanzione. Il legale, pertanto, chiedeva il risarcimento del danno patito anche per la lesione del suo
onore e della sua reputazione, quantificato nella
misura di lire 500.000.000.
224
Avvocato
Sia il Tribunale che la Corte d’appello di Trieste
respingevano la domanda del professionista ritenendo nella fattispecie non sussistente l’esimente del diritto di critica, per essere la notizia pubblicata veritiera e di spiccato interesse pubblico, nonché sul rilievo che l’irrogazione di una sanzione disciplinare
da parte dell’Ordine professionale di appartenenza
non integra una notizia coperta da segreto; sul presupposto, infine, che incombe a chi invoca il reato,
quale fonte del risarcimento, l’onere di dimostrarne
l’esistenza, anche in termini vaghi e senza indicazione dell’autore, ma pur sempre nel concreto verificarsi del crimine.
Il professionista ricorreva in Cassazione lamentando la violazione dei principi in tema di onere della prova sanciti dall’art. 2697, comma 2o, cod. civ.,
nonché del divieto di diffusione di notizie segrete
stabilito dall’art. 621 cod. pen. L’avvocato sosteneva, in primo luogo, che competeva all’editore la
prova di avere esercitato lecitamente il diritto di cronaca, nonché in secondo luogo che
l’esito dei procedimenti disciplinari è coperto
da segreto e che la sua divulgazione ha natura diffamatoria indipendentemente dalla veridicità della notizia riportata.
II. Le questioni
1. Pubblicità della sanzione disciplinare.
La Supr. Corte, respingendo la domanda di risarcimento del danno formulata dal legale sul rilievo che
il giornalista, pubblicando la notizia relativa all’esito
di un procedimento disciplinare a suo carico, avrebbe violato il segreto tutelato dall’art. 326 cod. pen.
(Rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio) ed il
divieto di rivelazione del contenuto di documenti
segreti sancito dall’art. 621 cod. pen., ha confermato
la decisione appellata che aveva negato il carattere
di segretezza della notizia riguardante la condanna
del professionista a sanzione disciplinare.
La sentenza in commento, inoltre, ha statuito che
le modalità di apprendimento della notizia da parte
del cronista sono state assolutamente lecite.
La materia è disciplinata dagli artt. 16 e 46 del
r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e dagli artt. 51 e 64
del r.d. 22.1.1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), che individuano le forme di pubblicità legale
che consentono a coloro che intendano consultare
gli albi professionali di conoscere i provvedimenti
disciplinari presi a carico degli iscritti.
Tali disposizioni, per quanto datate, non sono state modificate, né tantomeno abrogate dalla sopravvenuta normativa disciplinante la c.d. privacy.
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 29.9.2009, n. 20819 - Commento
In forza della normativa sopra richiamata, oltre
ad essere comunicati ai Ministri di giustizia e del lavoro e ai presidenti della Corte d’appello e dei Tribunali del distretto, i provvedimenti disciplinari devono «essere affissi nelle sale di udienze della Corte,
dei Tribunali e delle Preture del distretto medesimo
per mezzo di ufficiale giudiziario» (art. 16, comma
4o, r.d.l. 27.11.1933, n. 1578).
In proposito va osservato che la ratio sottesa alla
pubblicità degli albi e dei periodici aggiornamenti
relativi a nuove iscrizioni e cancellazioni ricorre anche, con evidenza, per i provvedimenti che comportano una sospensione o l’interruzione dell’esercizio
della professione, i quali, per loro stessa natura, devono considerarsi soggetti anch’essi ad un regime di
ampia conoscibilità.
L’art. 46, commi 1o e 3o, del citato r.d.l. n. 1578/
1933 stabilisce che i provvedimenti di radiazione e
di sospensione sono «comunicati a tutti i Consigli
dell’ordine degli avvocati e procuratori della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale
il professionista appartiene». In relazione a tali
provvedimenti vengono, poi, in considerazione le
disposizioni del r.d. 22.1.1934, n. 37, sia in riferimento alle decisioni dei Consigli dell’Ordine che sono soggette ad un regime di pubblicazione mediante
deposito presso gli uffici di segreteria (art. 51, comma 3o, r.d. n. 37/1934), sia per quanto riguarda le
decisioni adottate in secondo grado dal Consiglio
nazionale forense, soggette anch’esse a pubblicità
(l’art. 64, comma 2o, r.d. n. 37/1934 prevede la pubblicazione della decisione del Consiglio mediante
deposito in segreteria, oltre che la sua comunicazione immediata al procuratore generale presso la Corte di Cassazione).
Tale deposito realizza una pubblicità circoscritta.
Permette però a chiunque (al Consiglio dell’Ordine,
come ad altri soggetti, anche privati) di venire lecitamente a conoscenza di determinati provvedimenti e
di darne correttamente ulteriore notizia.
In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Milano secondo il quale «il consiglio dell’ordine è organo preposto alla sorveglianza ed alla disciplina dei
suoi iscritti ed i suoi provvedimenti sono, e devono essere, per la loro natura accessibili a tutti. Pertanto la
pubblicazione integrale sulla stampa del provvedimento disciplinare non costituisce comportamento illecito lesivo dei diritti dell’incolpato» (Trib. Milano, 27.7.1998, infra, sez. III).
I provvedimenti disciplinari dei Consigli dell’Ordine e del Consiglio Nazionale Forense si configurano pertanto quali atti pubblici soggetti ad un regime
di conoscibilità da parte di altri professionisti e di
terzi, pur in assenza di ulteriori e più analitiche disposizioni di legge o di regolamento che prevedano
una specifica divulgazione in favore di altri soggetti
NGCC 2010 - Parte prima
Avvocato
rispetto a quelli indicati nel citato art. 46 r.d.l. n.
1578/1933 o particolari modalità di diffusione dei
dati.
Ai sensi dell’art. 63, comma 3o, del r.d. n.
37/1934, del resto, anche le udienze dibattimentali
che si tengono nei procedimenti disciplinari avanti il
Consiglio Nazionale Forense devono essere celebrate in pubblica udienza, salvo le tassative deroghe ivi
stabilite.
L’odierna pronuncia, peraltro, ribadisce il principio di diritto, già in precedenza sancito in sede penale dalla Supr. Corte, secondo cui «nel caso di professionista al quale sia stata applicata dal consiglio
dell’Ordine una sanzione disciplinare, non costituisce
lesione della sua reputazione, tale da dar luogo al delitto di diffamazione, la diffusione di un giudizio di
adesione, formulato in termini di civile correttezza, alla decisione del detto consiglio, essendo questa già per
sua natura destinata ad essere potenzialmente conosciuta da chiunque, anche prima che abbia assunto carattere di definitività. (Fattispecie relativa a comunicazione inviata al Consiglio nazionale forense e al Ministro di grazia e giustizia da un gruppo di professionisti in relazione all’intervenuta condanna disciplinare
di un collega)» (Cass. pen., 20.12.1991, infra, sez.
III).
A differenza della Supr. Corte (che si è occupata
della materia solo in rare occasioni), l’Autorità Garante per la privacy ha più volte affrontato il tema
della segretezza delle notizie afferenti l’irrogazione
di sanzioni disciplinari ai propri iscritti da parte degli Ordini professionali (e quindi della liceità o meno della relativa pubblicazione, anche sui mezzi di
informazione).
L’Authority, proprio in una fattispecie relativa alla pubblicazione di sanzioni adottate da un Ordine
Forense, aveva anch’essa stabilito che «è soggetto a
deposito e quindi fonte di ampia conoscibilità il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati
che dispone la sanzione disciplinare della sospensione
dalla professione. Può essere quindi divulgato anche
attraverso riviste, notiziari e pubblicazioni anche del
Consiglio dell’Ordine, a prescindere dall’opportunità
o meno di tale pubblicazione e dall’obbligo di riportare comunque dati esatti e completi» (Garante per
la protezione dei dati personali, 29.3.2001, infra, sez. III).
Nella fattispecie il legale aveva chiesto al Consiglio di non menzionare, in un numero in via di stampa di una rivista curata dal medesimo Ordine, un
provvedimento di sospensione temporanea dall’esercizio della professione di avvocato già eseguito
nei suoi confronti. La diffusione di tali dati, nel cosiddetto foglio aggiuntivo dell’albo inserito in calce
alla rivista, avrebbe violato, a suo avviso, le norme
sulla privacy. Disattendendo la richiesta (con la qua225
Cass., 29.9.2009, n. 20819 - Commento
le era stata lamentata anche l’affissione del provvedimento di sospensione nelle bacheche dell’Ordine
presenti in diversi uffici giudiziari), il Consiglio aveva deciso di pubblicare comunque i dati. L’avvocato
si era, pertanto, rivolto al Garante per impedire tale
pubblicazione.
In tale pronuncia l’Authority per la privacy ha per
l’appunto statuito che il Consiglio non ha violato le
norme sulla privacy e che il libero professionista
iscritto all’albo non può invocare il diritto alla riservatezza rispetto alla notizia dell’esistenza di un provvedimento disciplinare a suo carico che si rifletta
sull’esercizio della sua professione.
Ciò in quanto, rispetto al sopra descritto regime di
conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si
fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia ed al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, non
può ritenersi prevalente l’interesse alla riservatezza
del singolo professionista destinatario di una misura
disciplinare, ferma restando la necessità che la menzione del provvedimento che applica la misura avvenga in modo corretto e in termini esatti e completi.
Secondo il Garante della privacy, quindi, le norme
relative ai vari albi permettono ai diversi ordini professionali di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi
albi in armonia con la legge sulla privacy.
La conoscibilità delle informazioni relative ai
provvedimenti disciplinari rende quindi lecita la loro divulgabilità, anche tramite eventuali riviste, notiziari o altre pubblicazioni curati dai Consigli dell’Ordine purché i dati siano esatti ed aggiornati nonché riportati in termini di sostanziale correttezza. La
pubblicazione di queste riviste, ha spiegato il Garante, da parte di soggetti pubblici ricade peraltro
nell’ampia nozione di trattamento dei dati personali
finalizzato alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero, trattamento cui si applica la disciplina prevista
in generale per l’attività giornalistica e di informazione, a prescindere dalla natura privata o pubblica
del soggetto che cura la pubblicazione.
In senso contrario, autorevole dottrina ha sostenuto che il diritto dei soggetti terzi rispetto al procedimento disciplinare di conoscere il provvedimento
conclusivo sarebbe soggetto ai presupposti dettati in
materia di accesso agli atti amministrativi dalla l.
7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal d.p.r. 27.6.1992, n. 352
(Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24,
comma 2o, della l. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo
226
Avvocato
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
(Danovi, 140, infra, sez. IV).
2. L’esimente del diritto di cronaca. Nella
sentenza in commento, la Supr. Corte affronta, per
l’ennesima volta, il tema dell’attività giornalistica e,
in particolare, della responsabilità civile dell’editore
della testata conseguente alla diffamazione a mezzo
stampa.
L’esercizio del diritto di stampa (e quindi di cronaca e di critica) garantito dall’art. 21 Cost., può essere censurato anche soltanto in sede civile ex art.
2043 cod. civ., indipendentemente dalla circostanza
che l’illecito sia previsto come reato e, comunque,
non sia punibile per difetto di condizioni interessanti esclusivamente il diritto penale.
In caso di pubblicazione di notizie lesive dell’altrui reputazione, come ben noto, l’editore è tenuto,
in solido col giornalista autore dell’articolo, al risarcimento dei danni arrecati al soggetto diffamato, salvo il ricorrere di una legittima causa di giustificazione quale, solitamente, quella dell’esercizio di un diritto prevista dall’art. 51 cod. pen. (nella fattispecie,
di cronaca), che esclude l’antigiuridicità di un comportamento che altrimenti potrebbe integrare gli
estremi di un reato o di un illecito civile.
In applicazione del principio di non contraddizione dell’ordinamento, che impedisce di vietare e nel
contempo consentire un medesimo comportamento,
ove ricorra la scriminante dell’esercizio di un diritto,
nonostante sussista un fatto astrattamente riconducibile ad una fattispecie di reato, la condotta del cronista perde il carattere illecito.
In riferimento all’attività giornalistica, infatti, sorge la necessità di contemperare il diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero sancito
dall’art. 21 Cost. (comprendente il diritto di cronaca
e di critica, ma anche di satira), con gli altri diritti
anch’essi costituzionalmente garantiti all’identità
personale, alla dignità, all’onore, alla reputazione e
alla riservatezza (c.d. privacy).
Come ben noto, cronaca e critica rappresentano
le due facce della professione giornalistica: da un lato, la narrazione del fatto, dall’altro la sua valutazione ed analisi, finalizzate ad «apprezzarne l’intimo significato e le conseguenze che vi siano causalmente
riconducibili» (Polvani, 177, infra, sez. IV).
La legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti dichiara espressamente che «è diritto insopprimibile
dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica».
Molto spesso, peraltro, cronaca e critica si fondono
in un medesimo articolo, in particolare nelle materie
più dibattute, quali la politica e l’economia, in cui i
giornalisti non si attengono ad un’asettica narrazione dei fatti.
Essendo entrambi diritti soggettivi assoluti, conNGCC 2010 - Parte prima
Cass., 29.9.2009, n. 20819 - Commento
sentono l’applicazione della scriminante del legittimo esercizio di un diritto.
La Supr. Corte, pertanto, al fine di effettuare un
bilanciamento degli interessi in gioco, fin dalla celebre sentenza Cass., 18.10.1984, n. 5259 (infra, sez.
III), nota come il «Decalogo del Giornalista», ha fissato le regole per l’esercizio del diritto di cronaca,
individuando tre criteri per contemperare i beni, entrambi di rango costituzionale, dell’onore e della
cronaca.
Il diritto di stampa, cioè la libertà di diffondere
attraverso i mezzi d’informazione notizie e commenti, sancito in linea di principio dall’art. 21 Cost. e regolato dalla l. 8.2.1948, n. 47 (Diposizioni sulla stampa), è legittimo quando concorrono le seguenti tre
condizioni: a) utilità sociale dell’informazione, vale a
dire l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto
(c.d. pertinenza); b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata
quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano
dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti
altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da
mutarne completamente il significato; c) forma civile
dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione
(c.d. continenza), cioè non eccedente rispetto allo
scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni
caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì
da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica
non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso
sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono
sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o,
comunque, all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e
proprie insinuazioni. In tali ipotesi l’esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche
ove non costituisca reato (Cass., 18.10.1984, n.
5259, infra, sez. III).
Un’ipotesi del tutto peculiare è data dalla c.d. intervista diffamatoria, rispetto alla quale in giurisprudenza si sono creati due distinti orientamenti.
Secondo il primo il giornalista ha l’obbligo di verificare il rispetto del requisito della c.d. doppia verità, vale a dire di riprodurre fedelmente le dichiarazioni rilasciate durante l’intervista ed altresì di controllare la rispondenza al vero delle circostanze di
fatto riferite dal soggetto intervistato e riportate nell’articolo. La ragione di tale doppio obbligo si spiega nel fatto che sarebbe proprio il cronista, attraverso l’intervista, a permettere la diffusione dell’offesa.
Il secondo orientamento (maggioritario), viceverNGCC 2010 - Parte prima
Avvocato
sa, ritiene che in tema di responsabilità aquiliana da
diffamazione a mezzo stampa il significato di verità
oggettiva della notizia vada inteso non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come
verità della notizia come fatto in sé e, in ogni caso,
indipendentemente dalla verità del suo contenuto.
Ciò in quanto nel caso dell’intervista la notizia di
cronaca risiede proprio nelle dichiarazioni così come rilasciate dall’intervistato. Ne consegue che il limite della verità, atteggiandosi in maniera del tutto
diversa e peculiare, andrebbe considerato non in relazione al contenuto dell’intervista, cioè alla rispondenza della circostanza riferita alla realtà fenomenica, bensì al fatto che l’intervista sia stata effettivamente rilasciata e le parole del giornalista siano perfettamente rispondenti a quanto esternato dall’intervistato.
A dirimere il conflitto tra i contrapposti orientamenti, le sezioni unite della Supr. Corte, alleggerendo la portata dell’indirizzo più liberale, hanno osservato come l’orientamento rigoristico che richiede,
nel caso di intervista dai caratteri diffamatori, il rispetto dei requisiti della verità, dell’interesse sociale
della notizia e della continenza, non può essere suscettibile di una generalizzata applicazione; vi sono,
infatti, dei casi nei quali l’interesse sociale della notizia può acquistare una importanza tale da prevalere sugli altri due, situazione che si verifica quando
un personaggio che occupa una posizione di alto rilievo nella vita sociale, politica, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni diffamatorie nei
confronti di altro personaggio del medesimo rilievo.
In tale ipotesi, infatti, la notizia è costituita proprio
dalla dichiarazione rilasciata, indipendentemente
dalla veridicità di quanto affermato dall’intervistato
e dalla continenza formale delle parole usate (Cass.
pen., sez. un., 30.5.2001, n. 37140, infra, sez. III).
In questa ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale
propagazione costituisca di per sé un fatto così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse, fermo restando che il cronista ha inoltre il dovere di mettere bene in evidenza che la verità non si
estende al contenuto del racconto e di riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di responsabilità (Cass., 24.4.2008, n. 10687, infra, sez.
III).
Questi doveri, inoltre, debbono essere adempiuti
dal cronista contestualmente alla comunicazione, in
modo da garantire la fedeltà dell’informazione che
nella specie consiste nella rappresentazione al lettore o all’ascoltatore della esatta percezione che egli
ha avuto del fatto.
Il giudice, inoltre, sarà chiamato ad accertare se il
cronista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, restando neutrale, ovvero sia stato
227
Cass., 29.9.2009, n. 20819 - Commento
una sorta di dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria.
In definitiva, in ipotesi di intervista diffamatoria,
al fine di scriminare il giornalista si dovrà accertare
la sussistenza di tutti i seguenti requisiti: a) la verità
(oggettiva o anche soltanto putativa, purché l’intervista risulti condotta in modo serio e diligente) del
fatto che l’intervistato abbia realmente formulato le
espressioni riportate, nelle circostanze di tempo e di
luogo indicate dal cronista; b) la posizione di terzietà assunta dal giornalista; c) la rilevanza pubblica
dell’intervistato ed il corrispondente interesse da
parte dell’opinione pubblica ad esserne informata;
d) il contesto valutativo e descrittivo in occasione
del quale sono state riportate le dichiarazioni diffamatorie; e) la plausibilità e l’occasione di tali dichiarazioni che non devono costituire mera opportunità
per apprezzamenti ed insinuazioni gratuite (Scarantino, 2702, infra, sez. IV).
III. I precedenti
1. Pubblicità della sanzione disciplinare.
Non sono molti i precedenti in tema di lesione della
reputazione del professionista a seguito della pubblicazione di notizie afferenti provvedimenti disciplinari emessi a suo carico da Ordini professionali;
si possono comunque consultare le seguenti pronunce: Garante per la protezione dei dati personali, 29.3.2001, in Boll. garante privacy, 2001, 3,
18; Trib. Milano, 27.7.1998, in Rass. forense, 1999,
200; Cass. pen., 20.12.1991, in Cass. pen., 1993,
1428.
2. L’esimente del diritto di cronaca. Sui requisiti per l’operatività della scriminante del diritto
di cronaca le sentenze di maggiore interesse sono
rappresentate dalle seguenti pronunce: Cass., sez.
un., 18.10.1984, n. 5259, in questa Rivista, 1985, I,
89; in Foro it., 1984, II, 531, con nota di Fiandaca,
e in Giust. civ., 1985, I, 356, con nota di Dogliotti;
Cass. pen., sez. un., 30.6.1984, in Giust. pen., 1985,
II, 577; Cass. pen., sez. un., 30.5.2001, n. 37140, in
Resp. civ. e prev., 2002, 179, con nota di Gennari, e
in Foro it., 2001, II, 629, con nota di Palmieri e
Pardolesi.
In tema di intervista diffamatoria si segnalano, nel
senso che il requisito della verità debba riguardare
sia la fedele riproduzione di quanto dichiarato durante l’intervista, sia la rispondenza al vero delle circostanze riferite dall’intervistato: Cass. pen.,
27.6.2000, in Cass. pen., 2001, 864; Cass. pen.,
11.4.2000, in Giur. it., 2002, 1934 e in Foro it., 2001,
II, 178.
Si sono espresse, invece, nel senso che il requisito
della verità debba riguardare esclusivamente il fatto oggettivo dell’avvenuta intervista e la risponden228
Avvocato
za di quanto riportato dal giornalista alle dichiarazioni effettivamente rilasciate all’interessato: Cass.,
24.4.2008, n. 10687, in Guida al dir., 2008, n. 31, 81;
Cass., 19.1.2007, n. 1205, in Mass. Giust. civ., 2007;
Cass., 15.12.2004, n. 23366, in Giur. it., 2005, 693,
con nota di Poncibò; Cass., 19.7.2004, n. 13346, in
Giust. civ., 2005, I, 3074; Cass., 26.6.2003, n. 27778,
in Guida al dir., 2003, n. 32, 74; Cass., 26.7.2002, n.
11060, in Danno e resp., 2003, 41; Cass., 25.2.2002,
n. 2733, in Giur. it., 2002, I, 2050, con nota di Poncibò; Cass. pen., sez. un., 30.5.2001, n. 37140, cit.;
Cass., 18.4.2001, n. 31912, in Foro it., 2002, II, 2;
Cass. pen., 14.12.1999, n. 2144, in Resp. civ. e prev.,
2002, 178.
Nel senso di riconoscere capacità esimente a sostituti della verità quali la verità putativa e la verosimiglianza: Cass., 31.3.2006, n. 7605, in Resp. civ. e
prev., 2006, 1887, con nota di Peron; Cass. pen.,
9.7.2004, n. 37435, in Dir. e giust., 2004, n. 36, 36;
Cass., 24.9.1997, n. 9391, in Danno e resp., 1998,
285; Cass., 20.8.1997, n. 7747, in Mass. Giust. civ.,
1997; Cass., 16.9.1996, n. 8284, in Resp. civ. e prev.,
1997, 453; Cass., 25.2.1993, in Cass. pen., 1994,
2989; Cass., 21.3.1991, ivi, 1992, 2076. Tra le pronunce di merito si segnalano: Trib. Milano,
7.5.2007, in Giustizia a Milano, 2007, 5, 38; Trib.
Venezia, 10.1.2006, in Corr. merito, 2006, 584;
Trib. Milano, 25.11.2004, in Giustizia a Milano,
2004, 79; Trib. Roma, 22.12.1999, in Giur. romana,
2000, 321.
In senso opposto, vale a dire di negare efficacia
esimente alla verità putativa per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell’involontarietà dell’errore, dell’avvenuto controllo – con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all’urgenza di informare il pubblico – della fonte e della attendibilità
di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati: Cass., 4.2.2005, n. 2271, in
Mass. Giust. civ., 2005 e in Giust. civ., 2006, I, 1590;
Cass., 11.6.1992, n. 7154, in Riv. pen. econ., 1992,
337, con nota di La Cute; Cass. pen., 21.4.1982, in
Cass. pen., 1983, 1089; Cass. pen., 12.1.1982, ibidem, 5.
Sui requisiti per l’operatività della scriminante del
diritto di critica si segnalano: Cass. pen., 22.5.2009,
n. 40408, in Dir. e giust., 2009, con nota di Gioffreda; Cass., 7.1.2009, n. 25, in Mass. Giust. civ.,
2009; Cass., 24.4.2008, n. 10690, in Resp. civ. e
prev., 2009, 148, con nota di Peron; Cass.,
21.3.2008, n. 7684, in Giust. civ., 2009, I, 1075;
Cass., 8.11.2007, n. 23314, ivi, 2008, I, 647, con nota di Ballarani, e in Dir. fam. e pers., 2008, 629;
Cass., 20.10.2006, n. 22527, in Mass. Giust. civ.,
2006; Cass., 13.6.2006, n. 13646, ibidem; Cass.,
31.3.2006, n. 7605, cit.; Cass., 27.10.2005, n. 20907,
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 29.9.2009, n. 20819 - Commento
in Mass. Giust. civ., 2005; Cass., 11.1.2005, n. 379,
in Foro it., 2005, I, 2406, con nota di Chiarolla.
Sulla critica giudiziaria si segnalano da ultimo:
Cass. pen., 16.6.2009, n. 37442, in Dir. e giust.,
2009; Cass., 10.3.2009, n. 5727, in Mass. Giust. civ.,
2009; Cass., 16.5.2008, n. 12420, ivi, 2008; Cass.
pen., 21.2.2007, n. 25138, in Foro it., 2007, II, 694,
con nota di Nicosia; Cass., 6.8.2007, n. 17180, in
Foro it., 2009, I, 1210; Cass., 20.10.2006, n. 22527,
in Mass. Giust. civ., 2006; Cass., 18.10.2005, n.
20139, ivi, 2005; Cass., 27.4.1998, n. 4285, in Giur.
it., 1999, con nota di Facci.
Sui requisiti per l’operatività del diritto di critica
satirica si segnalano: Cass., 28.11.2008, n. 28411, in
Mass. Giust. civ., 2008; Cass., 24.4.2008, n. 10656,
in Dir. aut., 2009, 1, 124, con nota di Mari; Cass.,
8.11.2007, n. 23314, in Giust. civ., 2008, I, 647, con
nota di Ballarani; Cass. pen., 11.5.2006, n. 23712,
in Guida al dir., 2006, n. 38, 54, con nota di Amato;
Cass., 21.6.2004, n. 11470, in Giust. civ., 2005, I,
2438, con nota di Ballarani; Cass. pen., 4.6.2001,
n. 36348, in Riv. pen., 2002, 367, in Giur. it., 2002,
1256, e in Studium iuris, 2002, 532; Cass.,
7.11.2000, n. 14485, in Danno e resp., 2001, 29, con
nota di Carbone, e in Giur. it., 2001, 1360, con nota di Baroli; Cass. pen., 12.3.1999, n. 2128, in Dir.
inf., 2001, 258, e in Cass. pen., 2000, 1311.
In tema di satira politica: Cass., 7.11.2000, n.
14485, in Danno e resp., 2001, 29, con nota di Carbone; Cass., 29.5.1996, n. 4993, in Danno e resp.,
1996, 585, con nota di Carbone, e in Resp. civ. e
prev., 1997, 1183, con nota di Peron; Cass. pen.,
3.3.1952, in Rep. Foro it., 1952, voce «Presidente
della Repubblica», nn. 2 e 3.
IV. La dottrina
1. Pubblicità della sanzione. Sulla pubblicità
dei provvedimenti disciplinari emessi dai Consigli
degli Ordini professionali si vedano: Perfetti, Corso di deontologia forense, Cedam, 2008; Santarcangelo, Il procedimento disciplinare a carico dei
notai, Giuffrè, 2007; Raimondi, Il procedimento disciplinare nelle professioni sanitarie, Giuffrè, 2006;
Alpa-Zatti, Codici deontologici e autonomia privata, Giuffrè, 2005; Danovi, Il procedimento disciplinare nella professione di avvocato, Giuffrè, 2005,
140; Orsoni, L’ordinamento professionale forense,
Cedam, 2005; Gianniti, Principi di deontologia giudiziaria, Cedam, 2002; De Tilla, La professione di
avvocato, Giuffrè, 1998; Boneschi, La deontologia
del giornalista, Egea, 1997; Busnelli-Scalfi, Le pene private, Giuffrè, 1985.
2. L’esimente del diritto di cronaca. In materia di diffamazione a mezzo stampa si vedano:
Foffa, Diffamazione a mezzo stampa: il punto sulla
NGCC 2010 - Parte prima
Avvocato
critica giudiziaria, in Danno e resp., 2009, 57; Santarsiere, Dati personali e diritto di cronaca. Problemi di contemperamento, in Resp. civ. e prev., 2008,
1155; Ballarani, Profili giuridici dell’informazione.
Cronaca, critica e satira, in Giust. civ., 2007, II, 409;
Verri-Cardone, Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno, Giuffrè, 2007; Peron, La critica giudiziaria tra fatti ed opinioni, in Resp. civ. e
prev., 2007, 2544; Bevere-Cerri, Il diritto di informazione e i diritti della persona, Giuffrè, 2006;
Chindemi, Diffamazione a mezzo stampa (radio - televisione - internet), Giuffrè, 2006; Peron, Diffamazione tramite «mass-media», Cedam, 2006; Alessandrini, È la stampa, bellezza. La stampa. E tu non
puoi farci niente, in Giur. merito, 2005, 1047; Poncibò, Libertà di espressione e personaggi pubblici, in
Giur. it., 2005, 693 ss.; G.B. Ferri, Informare ed essere informati, in Rass. dir. civ., 2003, 588 ss.; Palmieri, Riproduzione di dichiarazioni offensive: liceità
e limiti, in Danno e resp., 2003, 41; Sgroi, Il diritto
all’onore, in Nuovi diritti della persona e risarcimento
del danno: tutela civile e penale, a cura di Cassano,
Utet, 2003; Zaccaria, Diritto dell’informazione e
della comunicazione, Cedam, 2003; Bonetta, I limiti della riparazione del danno nel settore della violazione dei diritti fondamentali della personalità, in La
responsabilità civile. Tredici variazioni sul tema, a cura di Ponzanelli, Cedam, 2002; Poncibò, L’intervista del Vip e il diritto di essere informati, in Giur.
it., 2002, I, 2050 ss.; Carbone, Testo, contesto e notorio nella responsabilità civile per diffamazione, in
Danno e resp., 2001, 687; Pace-Petrangeli, voce
«Cronaca e critica (diritto di)», in Enc. del dir., Agg.,
V, Giuffrè, 2001, 303 ss.; Le Pera, Intervista diffamatoria e responsabilità del giornalista: due decisioni
opposte per due casi identici, in Cass. pen., 2001, 864
ss.; Bellantoni, Lesione dei diritti della persona,
Cedam, 2000; Corrias Lucente, Il diritto penale
dei mezzi di comunicazione di massa, Cedam, 2000;
Corasaniti, Diritto dell’informazione, Cedam,
1999; Garrone, Profili giuridici del sistema dell’informazione e della comunicazione, Utet, 1999; Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, Cedam,
1998; Chiarola, L’onore tra tutela penale e responsabilità civile, in Danno e resp., 1996, 456; Chiola,
voce «Manifestazione del pensiero», in Enc. giur.
Treccani, XIX, Ed. Enc. it., 1990; Ricciuto-Zeno
Zencovich, Il danno da mass media, Cedam, 1990;
Paladin, Libertà di pensiero e libertà di informazione, in Quad. cost., 1987, 5; Dogliotti, La Cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona, in Giust. civ., 1985, I, 356; Fiandaca, Nuove
tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo
stampa, in Foro it., 1984, II, 531; Garutti, Il diritto
all’onore e la sua tutela civilistica, Cedam, 1985; Barile, voce «Libertà di manifestazione del pensiero»,
229
Cass., 29.9.2009, n. 20819 - Commento
in Enc. del dir., XXIV, Giuffrè, 1974, 424; F. Mantovani, voce «Esercizio del diritto (dir. pen.)», in
Enc. del dir., XV, Giuffrè, 1966; Spasari, Sintesi di
uno studio dei delitti contro l’onore, Giuffrè, 1962.
In particolare sul tema del diritto di cronaca si segnalano: Ces, Diritto di cronaca e limite della verità,
in La resp. civ., 2009, 230; Santarsiere, Dati personali e diritto di cronaca. Problemi di contemperamento, cit.; Scarantino, Nota in tema di diritto di cronaca, in Giur. it., 2008, 2702; Ballarani, Profili giuridici dell’informazione. Cronaca, critica e satira, 409;
Longobardi, Diritto di cronaca, tutela a maglie larghe. Manuale di difesa per editori e cronisti, in Dir. e
giust., 2006, n. 17, 95; Giuggioli, Brevi riflessioni
circa l’esercizio del diritto di cronaca: verità del fatto
narrato e verità putativa, in Giur. merito, 2005, 640;
Peron, Brevi note in tema di cronaca e di critica giudiziaria, in Resp. civ. e prev., 2005, 232; Cacace, Il
titolo che condanna ed il criterio di continenza nella
responsabilità del giornalista, in Danno e resp., 2004,
172; Manna, Il diritto di cronaca, di critica, di denuncia e la diffamazione: «gli arresti giurisprudenziali», in Cass. pen., 2003, 3600; Palmieri, Riproduzione di dichiarazioni offensive: liceità e limiti, in Danno
e resp., 2003, 41; Gennari, La pubblicazione di
un’intervista ed il diritto-dovere d’informazione, in
Resp. civ. e prev., 2002, 178; Corrias Lucente, I
canoni del diritto di cronaca e l’intervista, in Riv. inf.
e informatica, 2002, 343; Serani, Diritto di cronaca e
verità putativa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002,
1462; Pace-Petrangeli, voce «Cronaca e critica
(diritto di)», in Enc. del dir., Agg., V, Giuffrè, 2001,
303 ss.; Marra, Importanti precisazioni circa i limiti
del diritto di cronaca, in Cass. pen., 2000, 61; De Michel, Diritto di cronaca, dichiarazioni del terzo e
«credibilità» del dichiarante, in Resp. civ. e prev.,
1998, 1176; Peron, La verità della notizia tra il diritto di satira ed il diritto di cronaca, ibidem, 754; Le
Pera, Cronaca e verità oggettiva: un equivoco che si
perpetua nei giudizi di diffamazione a mezzo della
stampa, in Cass. pen., 1995, 406; Dogliotti, La
Cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona, 356.
In materia di scriminante dell’esercizio del diritto
di critica: Catullo, Il diritto di critica come strumento di democrazia, in Cass. pen., 2008, 2849; Ballarani, Profili giuridici dell’informazione. Cronaca, critica
e satira; Peron, Diritto di critica: esercizio e limiti, in
Resp. civ. e prev., 2007, 2, 318; Minnella, Spazi sempre più ampi al diritto di critica in materia politica nella diffamazione a mezzo stampa, in Giur. merito,
2006, 990; Ballarani, La diffamazione tra «critica» e
«cronaca», in Giust. civ., 2005, I, 2438; Parola, Precisazioni in merito ai limiti del diritto di critica, in Resp. civ. e prev., 2004, 1397; Ardita, Diffamazione e
diritto di critica dell’attività politica, in Cass. pen.,
230
Avvocato
2002, 2355; Gennari, La discrezionalità del giudice
nel valutare la portata diffamatoria di un articolo giornalistico privilegia il criterio dei «due pesi e delle due
misure»?, in Resp. civ. e prev., 2001, 159; Pelissero,
Diritto di critica e verità dei fatti, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 1992, 1233; Conso, Libertà di espressione e tutela dell’onore sui mezzi di informazione di massa, in
Tutela dell’onore nei mezzi di comunicazione di massa. Atti del Convegno giuridico «Informazione, diffamazione, risarcimento», promosso dal Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, Feltrinelli,
1979; Delitala, I limiti giuridici della libertà di
stampa, in Diritto penale, Raccolta degli scritti, II,
Giuffrè, 1976, 947; Ferrante, Appunti in materia di
diritto di critica, in Giur. merito, 1974, II, 217; Moscon, Liceità della critica e limiti al diritto di comunicare il proprio pensiero, in Dir. aut., 1973, 449; Jannelli, Libertà di manifestazione del pensiero e diritto
al proprio onore: spunti per una linea di demarcazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1969, 533.
In particolare in tema di critica giudiziaria: Peron, La critica giudiziaria tra fatti ed opinioni, cit.;
Peron, Brevi note in tema di cronaca e di critica giudiziaria; Cesare, Cronaca giudiziaria, illazioni e allusioni, in Cass. pen., 2001, 3045; Facci, Diritto di cronaca, diritto di critica e reputazione del magistrato, in
Giur. it., 1999, 8; Boneschi, Etica e deontologia del
giornalista nella cronaca giudiziaria: qualche regola
da rispettare, in Dir. inf., 1999, 569; F. Mantovani,
Cronaca giudiziaria e limiti alla tutela penale dell’onore del cittadino processato, in Giust. pen., 1991,
II, 519.
In materia di scriminante dell’esercizio del diritto
di satira: Bacciardi, Note sui confini della libertà di
far sorridere: Quando la satira... è più che «satura», in
Resp. civ. e prev., 2008, 1094; Ballarani, Il labile
confine della satira tra variabili interpretative soggettive e tentativi di inquadramento oggettivo, in Giust.
civ., 2008, I, 647; Ballarani, Profili giuridici dell’informazione. Cronaca, critica e satira; Fano, Ciò che
chiamiamo satira, in Satira, Giuffrè, 2006, 8; Infante, Satira: diritto o delitto?, in Dir. inf., 1999, 377;
Peron, Diritto di satira: rilevanza costituzionale e limiti all’esercizio, in Resp. civ. e prev., 1999, 1312;
Laghezza, Quanto vale l’onore di un magistrato?, in
Danno resp., 1998, 793; Schermi, Diritto della personalità e satira, in Giust. civ., 1998, I, 549; A.M. Benedetti, Il diritto di satira fra libertà di espressione e
tutela dei valori della persona, in questa Rivista,
1996, I, 338; Lodato, Diritto di sorridere e finalità
informativa della vignetta satirica, in Riv. inf., 1995,
622; Dogliotti, Al Bano, Romina, Arbore, D’Agostino: satira, privacy e mass media, in Dir. fam. e
pers., 1994, 171; Weiss, Diritto costituzionale di satira o diritto di pettegolezzo?, ibidem, 181; Lopez, Sui
limiti di liceità del diritto di satira, ibidem, 198; F.
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 18.9.2009, n. 20106
Mantovani, Profili penalistici del diritto di satira, in
Dir. inf., 1992, 295; Corasaniti, Libertà di sorriso,
ivi, 1989, 536 ss.
Sul tema della tutela dei dati personali e della libertà di espressione si possono consultare: Santarsiere, Dati personali e diritto di cronaca. Problemi di
contemperamento; Corrias Lucente, Le recenti
prescrizioni del garante sulla pubblicazione di atti di
procedimenti penali e la cronaca giudiziaria. Rigide
c CASS. CIV., III sez., 18.9.2009, n. 20106
Cassa App. Roma, 13.1.2005
Contratto in genere - Esecuzione ed
interpretazione del contratto Principi di correttezza e buona fede
- Operatività - Conseguenze (cod. civ.,
artt. 1175, 1366, 1375) (a)
Contratto in genere - Esercizio di
un diritto soggettivo - Abuso del diritto - Contenuto - Effetti (cod. civ.,
artt. 1175, 1375) (b)
(a) I princìpi di correttezza e buona fede
nell’esecuzione e nell’interpretazione dei
contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375
cod. civ., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su
quello del bilanciamento dei contrapposti
interessi delle parti. Sotto il primo profilo,
essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti
dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della
controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in
senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contemperamento
degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto.
(b) Si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza
di divieti formali, lo eserciti con modalità
NGCC 2010 - Parte prima
Contratto in genere
interferenze tra privacy e libertà d’informazione, in
Riv. inf., 2007, 592; Messina, Tutela dei dati personali e manifestazione del pensiero, in Codice del trattamento dei dati personali, a cura di Cuffaro,
D’Orazio e Ricciuto, Giappichelli, 2007; Nuovi
diritti della persona e risarcimento del danno: tutela
civile e penale, a cura di Cassano, Utet, 2003.
Vincenzo Cugno Garrano
non necessarie ed irrispettose del dovere
di correttezza e buona fede, causando uno
sproporzionato ed ingiustificato sacrificio
della controparte contrattuale, ed al fine di
conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali
presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti
compiuti in violazione del divieto di abuso
del diritto, oppure condannare colui il
quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall’esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell’individuo o dell’imprenditore, giacché ciò che è
censurato in tal caso non è l’atto di autonomia negoziale, ma l’abuso di esso (in
applicazione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito la quale aveva
ritenuto insindacabile la decisione del
concedente di recedere ad nutum dal contratto di concessione di vendita, sul presupposto che tale diritto gli era espressamente riconosciuto dal contratto).
dal testo:
Il fatto. Tra il 1992 ed il 1996 gli attuali ricorrenti, tutti ex concessionari della Renault
Italia spa, furono revocati dalla stessa società,
sulla base della facoltà di recesso ad nutum
231
Cass., 18.9.2009, n. 20106
previsto dall’art. 12 del contratto di concessione di vendita.
Poiché in tale condotta fu ravvisato un comportamento abusivo, e comunque illecito da
parte della Renault Italia spa, fu fondata la Associazione Concessionari Revocati, con lo scopo di “programmare, provvedere, sviluppare,
organizzare, gestire ogni iniziativa ed attività
idonea alla tutela e difesa, nonché alla rappresentanza, dei diritti dei Concessionari d’auto
revocati dalle case automobilistiche (concessionari) aventi sede nel territorio (OMISSIS)”.
L’Associazione ed i concessionari revocati
convenivano, quindi, la Renault Italia spa davanti al tribunale di Roma, allo scopo di ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso
per abuso del diritto, e la conseguente condanna della Renault Italia spa al risarcimento dei
danni subiti per effetto dell’abusivo recesso.
Renault Italia spa si costituiva chiedendo il
rigetto della domanda, con la condanna alle
spese.
Il tribunale, con sentenza in data 11.6.2001,
rigettava la domanda compensando le spese.
Ad eguale conclusione perveniva la Corte
d’Appello che, con sentenza del 13.1.2005, rigettava gli appelli proposti dall’Associazione e
dai concessionari, che condannava al pagamento delle spese.
Riteneva, in particolare, la Corte di merito
che la previsione del recesso ad nutum in favore della Renault Italia rendesse superfluo ogni
controllo causale sull’esercizio di tale potere.
Hanno proposto ricorso principale per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da
memoria i soggetti indicati in epigrafe.
Resiste con controricorso la Renault Italia
spa che ha, anche, proposto ricorso incidentale
affidato ad un motivo.
I motivi. Preliminarmente, i ricorsi – principale ed incidentale – vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Ricorso principale.
Con il primo motivo i ricorrenti principali
denunciano la violazione e falsa applicazione
dell’art. 216 c.p.c. in relazione all’art. 158 c.p.c.
(art. 360 c.p.c., n. 4).
Sostengono che la sentenza impugnata sia affetta da nullità per vizi relativi alla costituzione
del giudice, vale a dire per “mancanza di colle232
Contratto in genere
gialità nella decisione testimoniata dal fatto che
la sentenza impugnata risulta estesa il 28 settembre 2004, ossia molto prima che fosse tenuta la camera di consiglio del 12 ottobre 2004”.
Il motivo non è fondato.
L’apposizione in calce alla sentenza della data del 28 settembre 2004, invece di quella del
12 ottobre 2004 (data in cui si è tenuta la camera di consiglio) risulta frutto di un semplice
errore materiale, posto che – come risulta dagli
atti – nella data del 28 settembre 2004 la Corte
di merito si era già riunita in camera di consiglio per l’esame dell’appello.
Peraltro, l’errore materiale commesso è stato
emendato attraverso il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., con ordinanza
emessa in data 25.5.2005 – a seguito di scioglimento della riserva adottata all’udienza collegiale del 24.5.2005 – del seguente tenore “corregge la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 136 depositata il 13 gennaio 2005 nel
senso che dove è scritto, alla fine della sentenza
e dopo la parola Roma, “28 settembre 2004”
deve intendersi scritto “12 ottobre 2004”, disponendo che la cancelleria effettui l’annotazione di rito”.
La correzione così effettuata rende inammissibile la censura, posto che i ricorrenti non denunciano la correttezza del procedimento
adottato, di correzione dell’errore materiale
contenuto nella sentenza impugnata.
Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione delle clausole generali della buona fede, ed in particolare sulla
pretesa insindacabilità degli atti di autonomia
privata e della conseguente non applicabilità
della figura dell’abuso del diritto all’esercizio
del recesso ad nutum (art. 360 c.p.c., n. 3, in
relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c.).
Con il terzo motivo denunciano la violazione
e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.; contraddittorietà della motivazione sul punto (art. 360
c.p.c., n. 5).
Con il quarto motivo denunciano la violazione e falsa applicazione delle disposizioni sull’agenzia ed errata valutazione della giurisprudenza tedesca in materia (art. 360 c.p.c., n. 3).
Il secondo, terzo e quarto motivo, investendo profili che si presentano connessi in ordine
alle questioni prospettate, vanno esaminati
congiuntamente.
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 18.9.2009, n. 20106
Essi sono fondati, nei limiti di cui in motivazione, per le ragioni che seguono.
Costituiscono principii generali del diritto
delle obbligazioni quelli secondo cui le parti di
un rapporto contrattuale debbono comportarsi
secondo le regole della correttezza (art. 1175
c.c.) e che l’esecuzione dei contratti debba avvenire secondo buona fede (art. 1375 c.c.).
In tema di contratti, il principio della buona
fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di
condotta, deve presiedere all’esecuzione del
contratto, così come alla sua formazione ed alla
sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. 5.3.2009 n. 5348;
Cass. 11.6.2008 n. 15476).
Ne consegue che la clausola generale di buona fede e correttezza è operante, tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del
complessivo assetto di interessi sottostanti all’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.).
I principi di buona fede e correttezza, del resto, sono entrati, nel tessuto connettivo dell’ordinamento giuridico.
L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere
giuridico, espressione di un generale principio
di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica (v. in questo senso, fra le
altre, Cass. 15.2.2007 n. 3462).
Una volta collocato nel quadro dei valori introdotto dalla Carta costituzionale, poi, il principio deve essere inteso come una specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall’art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica nell’imporre, a ciascuna delle parti
del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in
modo da preservare gli interessi dell’altra, a
prescindere dall’esistenza di specifici obblighi
contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
In questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce
strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi.
La Relazione ministeriale al codice civile, sul
punto, così si esprimeva: (il principio di correttezza e buona fede) “richiama nella sfera del
NGCC 2010 - Parte prima
Contratto in genere
creditore la considerazione dell’interesse del
debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore”, operando,
quindi, come un criterio di reciprocità.
In sintesi, disporre di un potere non è condizione sufficiente di un suo legittimo esercizio
se, nella situazione data, la patologia del rapporto può essere superata facendo ricorso a rimedi che incidono sugli interessi contrapposti
in modo più proporzionato.
In questa ottica la clausola generale della
buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. è stata utilizzata, anche nell’ambito dei diritti di credito,
per scongiurare, per es. gli abusi di posizione
dominante.
La buona fede, in sostanza, serve a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell’equilibrio e della proporzione.
Criterio rivelatore della violazione dell’obbligo di buona fede oggettiva è quello dell’abuso del diritto.
Gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto – ricostruiti attraverso l’apporto dottrinario e
giurisprudenziale – sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di
quel diritto possa essere effettuato secondo una
pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio
concreto, anche se formalmente rispettoso della
cornice attributiva di quel diritto, sia svolto
secondo modalità censurabili rispetto ad un
criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale
modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.
L’abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea
l’utilizzazione alterata dello schema formale
del diritto, finalizzata al conseguimento di
obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore.
È ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al
soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell’atto rispetto al
potere che lo prevede.
Come conseguenze di tale, eventuale abuso,
l’ordinamento pone una regola generale, nel
senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e in233
Cass., 18.9.2009, n. 20106
teressi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva.
E nella formula della mancanza di tutela, sta
la finalità di impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti – ed i diritti connessi – attraverso atti di per sé strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui l’ordinamento fa
espresso richiamo nella disciplina dei rapporti
di autonomia privata.
Nel nostro codice non esiste una norma che
sanzioni, in via generale, l’abuso del diritto.
La cultura giuridica degli anni ’30 fondava
l’abuso del diritto, più che su di un principio
giuridico, su di un concetto di natura etico morale, con la conseguenza che colui che ne abusava era considerato meritevole di biasimo, ma
non di sanzione giuridica.
Questo contesto culturale, unito alla preoccupazione per la certezza – o quantomeno prevedibilità del diritto –, in considerazione della
grande latitudine di potere che una clausola
generale, come quella dell’abuso del diritto,
avrebbe attribuito al giudice, impedì che fosse
trasfusa, nella stesura definitiva del codice civile italiano del 1942, quella norma del progetto
preliminare (art. 7) che proclamava, in termini
generali, che “nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il
quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto” (così ponendosi l’ordinamento italiano in
contrasto con altri ordinamenti, ad es. tedesco,
svizzero e spagnolo); preferendo, invece, ad
una norma di carattere generale, norme specifiche che consentissero di sanzionare l’abuso in
relazione a particolari categorie di diritti.
Ma, in un mutato contesto storico, culturale e
giuridico, un problema di così pregnante rilevanza è stato oggetto di rimeditata attenzione da
parte della Corte di legittimità (v. applicazioni
del principio in Cass. 8.4.2009 n. 8481; Cass.
20.3.2009 n. 6800; Cass. 17.10.2008 n. 29776;
Cass. 4.6.2008 n. 14759; Cass. 11.5.2007 n.
10838).
Così, in materia societaria è stato sindacato,
in una deliberazione assembleare di scioglimento della società, l’esercizio del diritto di voto sotto l’aspetto dell’abuso di potere, ritenendo principio generale del nostro ordinamento,
234
Contratto in genere
anche al di fuori del campo societario, quello
di non abusare dei propri diritti – con approfittamento di una posizione di supremazia –
con l’imposizione, nelle delibere assembleari,
alla maggioranza, di un vincolo desunto da una
clausola generale quale la correttezza e buona
fede (contrattuale).
In questa ottica i soci debbono eseguire il
contratto secondo buona fede e correttezza nei
loro rapporti reciproci, ai sensi degli artt. 1175
e 1375 c.c., la cui funzione è integrativa del
contratto sociale, nel senso di imporre il rispetto degli equilibri degli interessi di cui le parti
sono portatrici.
E la conseguenza è quella della invalidità
della delibera, se è raggiunta la prova che il potere di voto sia stato esercitato allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, ovvero risulti
in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione
del contratto (v. Cass. 11.6.2003 n. 9353).
Con il rilievo che tale canone generale non
impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all’esercizio di una pretesa, essendo
finalizzato al contemperamento degli opposti
interessi (Cass. 12.12.2005 n. 27387).
Ancora, sempre nell’ambito societario, la
materia dell’abuso del diritto è stata esaminata
con riferimento alla qualità di socio ed all’adempimento secondo buona fede delle obbligazioni societarie ai fini della sua esclusione
dalla società (Cass. 19.12.2008 n. 29776), ed al
fenomeno dell’abuso della personalità giuridica quando essa costituisca uno schermo formale per eludere la più rigida applicazione della
legge (v. anche Cass. 25.1.2000 n. 804; Cass.
16.5.2007 n. 11258).
In tal caso, proprio richiamando l’abuso, ne
sarà possibile, per così dire, il suo “disvelamento” (piercing the corporate veil).
Nell’ambito, poi, dei rapporti bancari è stato
più volte riconosciuto che, in ossequio al principio per cui il contratto deve essere eseguito
secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.), non
può escludersi che il recesso di una banca dal
rapporto di apertura di credito, benché pattiziamente consentito anche in difetto di giusta
causa, sia da considerarsi illegittimo ove in
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 18.9.2009, n. 20106
concreto assuma connotati del tutto imprevisti
ed arbitrari (Cass. 21.5.1997 n. 4538; Cass.
14.7.2000 n. 9321; Cass. 21.2.2003 n. 2642).
E, con riferimento ai rapporti di conto corrente, è stato ritenuto che, in presenza di una
clausola negoziale che, nel regolare tali rapporti, consenta all’istituto di credito di operare la
compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, senza obbligo di
preavviso, la contestazione sollevata dal cliente
che, a fronte della intervenuta operazione di
compensazione, lamenti di non esserne stato
prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli, impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua
del fondamentale principio della buona fede
nella esecuzione del contratto. Con la conseguenza, in caso contrario, del riconoscimento a
carico della banca, di una responsabilità per risarcimento dei danni (Cass. 28.9.2005 n.
18947).
In materia contrattuale, poi, gli stessi principi sono stati applicati, in particolare, con riferimento al contratto di mediazione (Cass.
5.3.2009 n. 5348), al contratto di sale and lease
back connesso al divieto di patto commissorio
ex art. 2744 c.c., (Cass. 16.10.1995 n. 10805;
Cass. 26.6.2001 n. 8742; Cass. 22.3.2007 n.
6969; Cass. 8.4.2009 n. 8481), ed al contratto
autonomo di garanzia ed exceptio doli (Cass.
1.10.1999 n. 10864; cass. 28.7.2004 n. 14239;
Cass. 7.3.2007 n. 5273).
Del principio dell’abuso del diritto è stato,
da ultimo, fatto frequente uso in materia tributaria, fondandolo sul riconoscimento dell’esistenza di un generale principio antielusivo (v.
per tutte S.U. 23.10.2008 nn. 30055, 30056,
30057).
Il breve excursus esemplificativo consente,
quindi, di ritenere ormai acclarato che anche il
principio dell’abuso del diritto è uno dei criteri
di selezione, con riferimento al quale esaminare anche i rapporti negoziali che nascono da atti di autonomia privata, e valutare le condotte
che, nell’ambito della formazione ed esecuzione degli stessi, le parti contrattuali adottano.
Deve, con ciò, pervenirsi a questa conclusione.
Oggi, i principi della buona fede oggettiva, e
NGCC 2010 - Parte prima
Contratto in genere
dell’abuso del diritto, debbono essere selezionati e rivisitati alla luce dei principi costituzionali – funzione sociale ex art. 42 Cost. – e della stessa qualificazione dei diritti soggettivi assoluti.
In questa prospettiva i due principi si integrano a vicenda, costituendo la buona fede un
canone generale cui ancorare la condotta delle
parti, anche di un rapporto privatistico e l’interpretazione dell’atto giuridico di autonomia
privata e, prospettando l’abuso, la necessità di
una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono conferiti.
Qualora la finalità perseguita non sia quella
consentita dall’ordinamento, si avrà abuso.
In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio.
Alla luce di tali principi e considerazioni
svolte deve, ora, esaminarsi la sentenza, in questa sede, impugnata.
La struttura argomentativa della sentenza si
sviluppa secondo i seguenti passaggi logici:
1) il giudice non ha alcuna possibilità di controllo sull’atto di autonomia privata; “2) la previsione contrattuale del recesso ad nutum dal
contratto non consente, quindi, da parte del
giudice, il sindacato su tale atto, non essendo
necessario alcun controllo causale circa l’esercizio del potere, perché un tale potere rientra
nella libertà di scelta dell’operatore economico
in un libero mercato; 3) La Renault Italia non
doveva tenere conto anche dell’interesse della
controparte o di interessi diversi da quello che
essa aveva alla risoluzione del rapporto”; 4) la
insussistenza di un’ipotesi di recesso illegittimo
comporta la non pertinenza del richiamo agli
artt. 1175 e 1375 c.c.; 5) i principii di correttezza e buona fede non creano obbligazioni autonome, ma rilevano soltanto per verificare il
puntuale adempimento di obblighi riconducibili a determinati rapporti; 6) Non sono presenti nel caso in esame i principi enucleati dalla
giurisprudenza in tema di abuso del diritto;
e ciò perché “La sussistenza di un atto di abuso
del diritto (speculare ai cosiddetti atti emulativi) postula il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell’assenza di utilità per il titolare del diritto, e di un elemento soggettivo costituito dall’animus nocendi, ossia l’intenzione
di nuocere o di recare molestia ad altri”; 7) “Il
mercato, concepito quale luogo della libertà di
235
Cass., 18.9.2009, n. 20106
iniziativa economica (garantita dalla Costituzione), presuppone l’esistenza di soggetti economici in grado di esercitare i diritti di libertà
in questione e cioè soggetti effettivamente responsabili delle scelte d’impresa ad essi formalmente imputabili. La nozione di mercato libero
presuppone che il gioco della concorrenza venga attuato da soggetti in grado di autodeterminarsi”;
8) “Alla libertà di modificare l’assetto di vendita, da parte della Renault Italia spa, conseguiva che il recesso ad nutum rappresentava, per il
titolare di tale facoltà, il mezzo più conveniente
per realizzare tale fine: non sussiste, quindi,
l’abuso”; 9) La impossibilità di ipotizzare “un
potere del giudice di controllo diretto sugli atti
di autonomia privata, in mancanza di un atto
normativo che specifichi come attuare tale
astratta tutela”, produce, come effetto, quello
della introduzione di “un controllo di opportunità e di ragionevolezza sull’esercizio del potere
di recesso; al che consegue una valutazione politica, non giurisdizionale dell’atto”; 10) La impossibilità di procedere ad un giudizio di ragionevolezza in ambito privatistico e, particolarmente, “in ambito contrattuale in cui i valori di
riferimento non sono unitari, ma sono addirittura contrapposti e la composizione del conflitto avviene proprio seguendo i parametri legali
dell’incontro delle volontà su una causa eletta
dall’ordinamento come meritevole di tutela” fa
sì che “Solo allorché ricorrono contrasti con
norme imperative, può essere sanzionato l’esercizio di una facoltà, ma al di fuori di queste ipotesi tipiche, normativamente previste, residua
la più ampia libertà della autonomia privata”.
Le affermazioni contenute nella sentenza impugnata non sono condivisibili sotto diversi
profili.
Punto di partenza dal quale conviene prendere le mosse è quello che non è compito del
giudice valutare le scelte imprenditoriali delle
parti in causa che siano soggetti economici,
scelte che sono, ovviamente, al di fuori del sindacato giurisdizionale.
Diversamente, quando, nell’ambito dell’attività imprenditoriale, vengono posti in essere
atti di autonomia privata che coinvolgono – ad
es. nei contratti d’impresa – gli interessi, anche
contrastanti, delle diverse parti contrattuali.
In questo caso, nell’ipotesi in cui il rapporto
236
Contratto in genere
evolva in chiave patologica e sia richiesto l’intervento del giudice, a quest’ultimo spetta di
interpretare il contratto, ai fini della ricerca
della comune intenzione dei contraenti.
Ciò vuoi significare che l’atto di autonomia
privata è, pur sempre, soggetto al controllo
giurisdizionale.
Gli strumenti di interpretazione del contratto sono rappresentati: il primo, dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate;
con la conseguente preclusione del ricorso ad
altri criteri interpretativi, quando la comune
volontà delle parti emerga in modo certo ed
immediato dalle espressioni adoperate, e sia
talmente chiara da precludere la ricerca di una
volontà diversa; con l’adozione eventuale degli
altri criteri interpretativi, comunque, di natura
sussidiaria.
Ma il contratto e le clausole che lo compongono – ai sensi dell’art. 1366 c.c. – debbono essere interpretati anche secondo buona fede.
Non soltanto.
Il principio della buona fede oggettiva, cioè
della reciproca lealtà di condotta, deve accompagnare il contratto nel suo svolgimento, dalla
formazione all’esecuzione, ed, essendo espressione del dovere di solidarietà fondato sull’art.
2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell’ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi
contrattuali o di norme specifiche.
La sua violazione, pertanto, costituisce di
per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato
(v. anche S.U. 15.11.2007 n. 23726; Cass.
22.1.2009 n. 1618; Cass. 6.6.2008 n. 21250;
Cass. 27.10.2006 n. 23273; Cass. 7.6.2006 n.
13345; Cass. 11.1.2006 n. 264).
Il criterio della buona fede costituisce, quindi, uno strumento, per il giudice, finalizzato al
controllo – anche in senso modificativo o integrativo – dello statuto negoziale; e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi (v. S.U. 15.11.2007 n. 23726 ed i richiami
ivi contenuti).
Il giudice, quindi, nell’interpretazione secondo buona fede del contratto, deve operare
nell’ottica dell’equilibrio fra i detti interessi.
Ed è su questa base che la Corte di merito
avrebbe dovuto valutare ed interpretare le
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 18.9.2009, n. 20106
clausole del contratto – in particolare quella
che prevedeva il recesso ad nutum – anche al
fine di riconoscere l’eventuale diritto al risarcimento del danno per l’esercizio di tale facoltà
in modo non conforme alla correttezza ed alla
buona fede.
Sotto questo profilo, pertanto, dovrà essere
riesaminato il materiale probatorio acquisito.
In sostanza la Corte di merito – di fronte ad
un recesso non qualificato – non poteva esimersi dal valutare le circostanze allegate dai
destinatari dell’atto di recesso, quali impeditive del suo esercizio, o quali fondanti un diritto
al risarcimento per il suo abusivo esercizio.
Anche con riferimento all’abuso del diritto,
le indicazioni fornite dalla Corte di merito non
possono essere seguite.
Il controllo del giudice sul carattere abusivo
degli atti di autonomia privata è stato pienamente riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, cui si è
fatto cenno.
La conseguenza è l’irrilevanza, sotto questo
aspetto, delle considerazioni svolte in tema di
libertà economica e di libero mercato.
Nessun dubbio che le scelte decisionali in
materia economica non siano oggetto di sindacato giurisdizionale, rientrando nelle prerogative dell’imprenditore operante nel mercato,
che si assume il rischio economico delle scelte
effettuate.
Ma, in questo contesto, l’esercizio del potere
contrattuale riconosciutogli dall’autonomia
privata, deve essere posto in essere nel rispetto
di determinati canoni generali – quali quello
appunto della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e delle correttezza – alla
luce dei quali debbono essere interpretati gli
stessi atti di autonomia contrattuale.
Ed il fine da perseguire è quello di evitare
che il diritto soggettivo, che spetta a qualunque
consociato che ne sia portatore, possa sconfinare nell’arbitrio.
Da ciò il rilievo dell’abuso nell’esercizio del
proprio diritto.
La libertà di scelta economica dell’imprenditore, pertanto, in sé e per sé, non è minimamente scalfita; ciò che è censurato è l’abuso,
ma non di tale scelta, sebbene dell’atto di autonomia contrattuale che, in virtù di tale scelta, è
stato posto in essere.
NGCC 2010 - Parte prima
Contratto in genere
L’irrilevanza, per il diritto, delle ragioni che
sono a monte della conclusione ed esecuzione
di un determinato rapporto negoziale, non
esclude – ma anzi prevede – un controllo da
parte del giudice, al fine di valutare se l’esercizio della facoltà riconosciuta all’autonomia
contrattuale abbia operato in chiave elusiva dei
principii espressione dei canoni generali della
buona fede, della lealtà e della correttezza.
Di qui il rilievo riconosciuto dall’ordinamento – al fine di evitare un abusivo esercizio del
diritto – ai canoni generali di interpretazione
contrattuale.
Ed in questa ottica, il controllo e l’interpretazione dell’atto di autonomia privata dovrà essere condotto tenendo presenti le posizioni delle
parti, al fine di valutare se posizioni di supremazia di una di esse e di eventuale dipendenza,
anche economica, dell’altra siano stati forieri di
comportamenti abusivi, posti in essere per raggiungere i fini che la parte si è prefissata.
Per questa ragione il giudice, nel controllare
ed interpretare l’atto di autonomia privata, deve operare ed interpretare l’atto anche in funzione del contemperamento degli opposti interessi delle parti contrattuali.
Erra, pertanto, il giudice di merito quando
afferma che vi è un’impossibilità di procedere
ad un giudizio di ragionevolezza in ambito
contrattuale, escludendo che lo stesso possa
controllare l’esercizio del potere di recesso; ritenendo che, diversamente si tratterebbe di
una valutazione politica.
Il problema non è politico, ma squisitamente
giuridico ed investe i rimedi contro l’abuso
dell’autonomia privata e dei rapporti di forza
sul mercato, problemi questi che sono oggetto
di attenzione da parte di tutti gli ordinamenti
contemporanei, a causa dell’incremento delle
situazioni di disparità di forze fra gli operatori
economici.
Al giudicante è richiesta, attraverso il controllo e l’interpretazione dell’atto di recesso –
al fine di affermarne od escluderne il suo esercizio abusivo, condotto alla luce dei principi
più volte enunciati – proprio ed esclusivamente una valutazione giuridica.
Le considerazioni tutte effettuate consentono, quindi, di concludere che la Corte di merito abbia errato quando ha adottato le seguenti
proposizioni argomentative: 1) che la sussisten237
Cass., 18.9.2009, n. 20106
za di un atto di abuso del diritto sia soltanto
speculare agli atti emulativi e postuli il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell’assenza di utilità per il titolare del diritto, e di
un elemento soggettivo costituito dall’animus
nocendi; 2) che, stabilito che la Renault Italia
era libera di modificare l’assetto di vendita, il
recesso ad nutum era il mezzo più conveniente
per realizzare tale fine; al che conseguirebbe
l’insussistenza dell’abuso; 3) che, una volta che
l’ordinamento abbia apprestato un dato istituto, spetta all’autonomia delle parti utilizzarlo o
meno; 4) che non sussista la possibilità di utilizzare un giudizio di ragionevolezza in ambito
privatistico – in particolare contrattuale – in
cui i valori di riferimento non solo non sono
unitari, ma sono addirittura contrapposti; 5)
che nessuna valutazione delle posizioni contrattuali delle parti – soggetti deboli e soggetti
economicamente “forti” –, anche con riferimento alle condizioni tutte oggetto della previsione contrattuale, rientri nella sfera di valutazione complessiva del Giudicante.
La Corte di merito ha affermato che l’abuso
fosse configurabile in termini di volontà di
nuocere, ovvero in termini di “neutralità”; nel
senso cioè che, una volta che l’ordinamento
aveva previsto il mezzo (diritto di recesso) per
conseguire quel dato fine (scioglimento dal
contratto di concessione di vendita), erano indifferenti le modalità del suo concreto esercizio.
Ma il problema non è questo.
Il problema è che la valutazione di un tale atto deve essere condotta in termini di “conflittualità”. Ovvero: posto che si verte in tema di
interessi contrapposti, di cui erano portatrici le
parti, il punto rilevante è quello della proporzionalità dei mezzi usati.
Proporzionalità che esprime una certa procedimentalizzazione nell’esercizio del diritto di
recesso (per es. attraverso la previsione di trattative, il riconoscimento di indennità ecc.).
In questo senso, la Corte di appello non poteva esimersi da un tale controllo condotto, secondo le linee guida esposte, anche, quindi,
sotto il profilo dell’eventuale abuso del diritto
di recesso, come operato.
In concreto, avrebbe dovuto valutare – e tale
esame spetta ora al giudice del rinvio – se il recesso ad nutum previsto dalle condizioni con238
Contratto in genere
trattuali, era stato attuato con modalità e per
perseguire fini diversi ed ulteriori rispetto a
quelli consentiti.
Ed in questo esame si sarebbe dovuta avvalere del materiale probatorio acquisito, esaminato e valutato alla luce dei principi oggi indicati,
al fine di valutare – anche sotto il profilo del
suo abuso – l’esercizio del diritto riconosciuto.
In ipotesi, poi, di eventuale, provata disparità di forze fra i contraenti, la verifica giudiziale
del carattere abusivo o meno del recesso deve
essere più ampia e rigorosa, e può prescindere
dal dolo e dalla specifica intenzione di nuocere: elementi questi tipici degli atti emulativi,
ma non delle fattispecie di abuso di potere
contrattuale o di dipendenza economica.
Le conseguenze, cui condurrebbe l’interpretazione proposta dalla sentenza impugnata, sono inaccettabili.
La esclusione della valorizzazione e valutazione della buona fede oggettiva e della rilevanza anche dell’eventuale esercizio abusivo
del recesso, infatti, consentirebbero che il recesso ad nutum si trasformi in un recesso, arbitrario, cioè ad libitum, di sicuro non consentito
dall’ordinamento giuridico.
Il giudice del rinvio, quindi, dovrà riesaminare la questione, tenendo conto delle indicazioni fornite e dei principi enunciati, al fine di
riconoscere o meno il carattere abusivo del recesso e l’eventuale, consequenziale diritto al risarcimento del danni subiti.
Tutto ciò in chiave di contemperamento dei
diritti e degli interessi delle parti in causa, in
una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici.
Le conclusioni raggiunte consentono di ritenere irrilevante, e, quindi, superfluo l’esame
degli ulteriori profili di censura proposti.
I temi dell’abuso di dipendenza economica e
della applicabilità analogica od estensiva della
normativa in materia di subfornitura (in particolare L. 18 giugno 1998, n. 172, art. 9) non
hanno costituito oggetto di specifica censura
contenuta nei motivi di ricorso.
Quanto alle analogie riscontrate dai ricorrenti fra il contratto di concessione di vendita e
quella di agenzia, ai fini del riconoscimento del
diritto dei concessionari a percepire una somma a titolo di indennità, poi, ad un sommario
esame – il quale, peraltro, si presenterebbe suNGCC 2010 - Parte prima
Cass., 31.8.2009, n. 18920
perfluo ai fini che qui interessano, per le conclusioni raggiunte sui temi in precedenza trattati – si presentano di dubbia praticabilità.
Il contratto di concessione di vendita, infatti,
per la sua struttura e la sua funzione economico-sociale, presenta aspetti che lo avvicinano al
contratto di somministrazione, ma non può,
però essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto
innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione
e consiste, sul piano strutturale, in un contratto
– quadro o contratto normativo (Cass. 17 dicembre 1990, n. 11960), dal quale deriva l’obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita, ovvero l’obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle
condizioni fissate nell’accordo iniziale (v. anche Cass. 22.2.1999 n. 1469; Cass. 11.6.2009 n.
13568).
Proprio una tale struttura e funzione economica, che esclude profili rilevanti di collabora-
c CASS. CIV., III sez., 31.8.2009, n. 18920
Contratto in genere
zione, sembra doverlo porre al di fuori dell’area di affinità con il contratto di agenzia (v.
anche Cass. 21.7.1994 n. 6819). (Omissis)
Conclusivamente, va rigettato il primo motivo del ricorso principale; vanno accolti, nei limiti di cui in motivazione, il secondo, terzo e
quarto motivo; vanno dichiarati assorbiti il
quinto motivo ed il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi, come accolti, e la causa va rimessa
alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Il giudice del rinvio si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
[Varrone Presidente – Vivaldi Estensore – Destro P.M. (concl. diff.). – A.G. ed al. (avv.ti Molfese e Galgano) – Renault Italia S.p.A. (avv.ti Battaglia
e Di Amato)]
[La sentenza è oggetto di commento in, Parte seconda, 139, con Opinioni di Orlandi, Scognamiglio, Viglione]
Conferma App. Campobasso, 15.6.2005
immediatamente – senza ricorrere al giudice – il contratto e, quindi, di liberarsi
dalla prestazione dell’obbligazione.
Contratto in genere - Inadempimento - Clausola risolutiva espressa - Effetto risolutorio - Presupposti - Dichiarazione di volersi avvalere della condizione - Necessità (cod. civ., artt.
dal testo:
1353, 1456)
A differenza della condizione risolutiva,
perché si possa produrre la risoluzione la
clausola risolutiva espressa richiede oltre
all’inadempimento della specifica obbligazione dedotta, anche la dichiarazione di
volersi avvalere della risoluzione per l’avveramento delle circostanze indicate, in
quanto essa costituisce una forma di autotutela privata ammessa dalla legge e consente alle parti di prevedere che, in caso di
inadempimento, la parte creditrice abbia
il potere (diritto potestativo) di risolvere
NGCC 2010 - Parte prima
Il fatto. Con sentenza del 28 febbraio 2002 il
Tribunale di Larino rigettava la domanda proposta da R.F. e P.G. nei confronti di M.S., tesa
a far dichiarare la risoluzione di diritto del contratto stipulato in data (Omissis) tra gli stessi
nonché la domanda riconvenzionale dispiegata
dal M. e compensava le spese.
Avverso la decisione proponevano appello
con atto del 18 settembre 2003 gli originari attori.
Si costituiva il M. che dispiegava appello incidentale.
La Corte di appello di Campobasso con sentenza del 15 giugno 2005 accoglieva per quanto
239
Cass., 31.8.2009, n. 18920
di ragione l’appello principale e in riforma della sentenza di primo grado dichiarava risolto di
diritto il contratto stipulato l’(Omissis); condannava quindi il M. all’immediata restituzione
dell’immobile, oggetto di quel contratto preliminare, oltre al risarcimento dei danni e spese
di entrambi i gradi del giudizio; condannava gli
appellanti alla restituzione di Euro 10.379,14
(valore equivalente ai venti milioni di lire, ricevute a titolo di acconto sulla somma ulteriore di
L. 200 milioni allora convenuta per la vendita).
Contro questa sentenza insorge il M. con un
ricorso affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso R.F. e P.G.
(Omissis)
I motivi. Va preliminarmente esaminata la
eccezione di inammissibilità del controricorso,
contenuta nella memoria del M., per asserito
difetto di procura speciale.
La eccezione è palesemente infondata, come
si evince dalla semplice lettura della conferita
procura.
Con il primo motivo, che, a parere del Collegio, costituisce il punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole del fatto che il giudice dell’appello abbia applicato al contratto la
norma di cui all’art. 1353 c.c., ovverosia abbia
ritenuto il concluso preliminare sottoposto ad
una condizione risolutiva e non già ad una
clausola risolutiva espressa.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
La clausola, oggetto della questione sottoposta
al Collegio, era contenuta nel preliminare di
vendita stipulato l’(Omissis) tra i R.F. e P.G.
da un lato e M.S. dall’altro e concernente un
immobile di proprietà dei primi sottoposto alla
procedura dell’esecuzione forzata.
In quel preliminare venne inclusa una clausola dal seguente tenore: “Qualora entro due
anni da oggi i promittenti non avranno ottenuto l’autorizzazione alla vendita o la riduzione
del pignoramento o comunque l’estinzione
della procedura immobiliare del bene in oggetto, il presente contratto dovrà ritenersi a tutti
gli effetti risoluto di pieno diritto e il promissario avrà diritto alla restituzione” (p. 8 sentenza
impugnata).
Nell’atto di citazione in primo grado i promettenti venditori-attori deducevano che nello
spirare del termine dei due anni, non essendosi
240
Contratto in genere
verificate alcune delle condizioni pattuite, era
stata inviata formale diffida alla riconsegna del
bene, nel cui possesso era stato immesso il M.,
con offerta di restituzione delle somme già acquisite, ma il M. non aveva ottemperato agli
obblighi assunti, costringendoli all’azione giudiziaria.
Sul punto, e prima di esaminare la censura
circa la correttezza in punto di diritto sostanziale a quanto statuito nella sentenza impugna,
ritiene il Collegio di dover esaminare il secondo
motivo di ricorso, secondo il quale il giudice erroneamente non avrebbe ritenuto “domanda
nuova” quella svolta dai promittenti in appello.
Infatti, avendo questi nel giudizio di primo
grado solo ed esclusivamente avanzato richiesta di risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c.,
oltre alla richiesta di risarcimento danni (p. 16
ricorso), la domanda ex art. 1353 c.c., sarebbe
dovuta essere dichiarata inammissibile.
Questa censura è destituita di fondamento.
Il giudice dell’appello ha solo qualificato diversamente la natura della clausola indicata nel
contratto, mentre la domanda su cui si fondava
la pretesa degli attori era rimasta sempre la
stessa, con la indicazione di tutti i suoi elementi costitutivi.
Peraltro, sottolinea il giudice del merito che
non vi è stata “nemmeno imputazione degli argomenti giuridici dedotti in primo grado, atteso che proprio l’appellato – odierno ricorrente
– aveva sostenuto doversi applicare alla fattispecie l’art. 1353 c.c., tanto è vero che il Tribunale, investito della controversia, ha ampiamente esaminato la vicenda sia sotto l’aspetto
dell’art. 1353 c.c. che dell’art. 1456 c.c.” (p. 11
sentenza impugnata), che poi condivise e la cui
statuizione diede vita all’appello degli attuali
resistenti.
In sintesi, non vi è stata una pretesa diversa,
per la sua intrinseca essenza, rispetto a quella
di primo grado.
Ciò posto e tornando all’esame del primo
motivo, deve osservarsi quanto segue.
Ha, invero, ritenuto il giudice dell’appello
che la c.d. clausola risolutiva del contratto preliminare non fosse altro che “una condizione
risolutiva ex art. 1353 c.c., condizione legata al
presupposto necessario della “autorizzazione
alla vendita” da parte dei creditori procedenti
con esecuzione forzata.
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 31.8.2009, n. 18920
Infatti, il conseguimento dell’autorizzazione
non si poteva ricondurre in alcun modo alla
volontà degli esecutati promittenti venditori,
“atteso che tale autorizzazione restava nella
sfera volitiva di terzi e così pure la riduzione
del pignoramento o comunque l’estinzione
della procedura immobiliare” non era riconducibile alla volontà e alla disponibilità dei predetti esecutati-promittenti atteso che dipendeva dalle vicende processuali del giudizio di esecuzione forzata, regolato dalla attività delle
parti e dalle decisioni del giudice.
Ed è noto che la procedura esecutiva si svolge, di per sé, allorché il debitore non riesce ad
adempiere ed onorare i propri debiti ed in essa
più che dalla sua volontà, ogni mutamento in
melius e a suo favore dipende dalla volontà dei
creditori esecutanti e dall’avallo a questa volontà da parte del giudice dell’esecuzione.
Conclude, quindi, il giudice dell’appello che
“le parti hanno pattuito di subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto ad un avvenimento futuro, perché si sarebbe dovuto verificare nei prossimi due anni, ed incerto, perché
dipendente dalla volontà di terzi”, ovvero per
cause indipendenti dalla volontà dei promettenti.
A questa argomentazione il ricorrente risponde affermando che il consenso alla alienazione del bene promesso in vendita e/o comunque la riduzione o cancellazione del pignoramento sull’immobile era rimesso, esclusivamente, alla volontà dei promittenti venditori
nella qualità di debitori.
Il tutto perché, se avessero onorato i propri
debiti, i creditori avrebbero prestato il consenso alla vendita del bene.
Diversamente l’avrebbero negato, così come
hanno effettivamente fatto fino all’(Omissis)
(scadenza dell’autorizzazione alla vendita da
parte dei creditori entro i due anni dalla sottoscrizione del preliminare di vendita (Omissis)
(p. 7 ricorso).
Ora, mentre è certo che gli attori originari –
promittenti venditori – proprio in virtù di
quella clausola, definita dalle stesse parti, come
producente effetto di risoluzione di pieno diritto, hanno fondato la loro domanda di risoluzione, va subito detto che compete al giudice
del merito la qualificazione del contratto e delle singole clausole nonché la interpretazione
NGCC 2010 - Parte prima
Contratto in genere
della volontà dei contraenti (ex plurimis n.
7198/99; n. 5095/01).
Nell’esercizio di tale potere, il giudice dell’appello ha ritenuto non già trattarsi di una
clausola risolutiva espressa, bensì di una condizione risolutiva, in sintonia con il tenore letterale delle parole adoperate dai contraenti nel
preliminare, che di risoluzione hanno parlato.
Ed, infatti, la clausola risolutiva espressa richiede anche la dichiarazione di volersi avvalere
della risoluzione per l’avveramento delle circostanze indicate (nel caso in esame i promittenti
hanno atteso lungamente lo scadere dei due anni: la citazione è del 28 novembre 1998), in quanto essa costituisce una forma di autotutela privata ammessa dalla legge e consente alle parti di
prevedere che, in caso di inadempimento, la parte creditrice abbia il potere (diritto potestativo)
di risolvere immediatamente – senza ricorrere al
giudice – il contratto e, quindi, di liberarsi dalla
prestazione dell’obbligazione.
Di contro, per la condizione risolutiva è sufficiente il non verificarsi del fatto dedotto come condizione perché si possa produrre la risoluzione.
Nel caso in esame, come si legge dalla clausola del preliminare più sopra riportata, non vi
è chi non veda che le parti hanno condizionato
la risoluzione ad un fatto, o più fatti, se si vuole, tutti attinenti alla procedura di esecuzione
forzata, pattuendo il preliminare.
Nelle more del preliminare, quell’evento risolutivo si è ampiamente verificato, senza che
ne siano imputabili i promittenti esecutati, essendo quell’avveramento unicamente attribuibile alla volontà dei creditori esecutanti, estranei a quel preliminare (v. per quanto valga
Cass. n. 3631/82).
Il giudice dell’appello ha, quindi, dedotto
che andava applicato l’art. 1353 c.c., per cui
nessuna altra indagine avrebbe dovuto effettuarsi sull’imputabilità (colposa o meno) dei
promittenti (Cass. n. 6506/79, richiamata puntualmente nella sentenza impugnata a p. 10).
Con il terzo motivo il ricorrente si duole del
riconoscimento del danno attribuito a favore
dei resistenti.
Anche questo motivo non merita di essere
accolto. Infatti, decorso il periodo pattuito nel
contratto ed avendo con lettera raccomandata
del 7 ottobre 1995 gli attuali resistenti invitato
241
Cass., 31.8.2009, n. 18920 - Commento
il M. a restituire il bene, perché si era avverata
la condizione risolutiva, questi non vi adempiva, divenendo dunque, inadempiente ad un
preciso obbligo contrattualmente assunto.
Tuttavia, perché la risoluzione non avvenne
se non per un fatto futuro ed incerto, non dipendente da sua colpa, correttamente la Corte
del merito ha applicato l’art. 1218 c.c., rinvenendo il danno nel mancato guadagno che i
proprietari avrebbero potuto ricavare dalla locazione dell’immobile.
Il danno è stato liquidato in via equitativa,
stante pur sempre un principio di prova, costituito dalla testimonianza di soggetti, che erano
stati precedenti locatari di quell’immobile.
Né si può condividere la censura sulla inammissibilità di quelle prove (p. 17-18 ricorso),
perché a fronte della valutazione operata dal
giudice dell’appello, di piena legittimità del loro espletamento (p. 13 sentenza impugnata), il
ricorrente si limita ad affermare che la prova
testimoniale, di cui in primo grado, “verte su
una circostanza che esula dall’oggetto del procedimento”, trascurando di considerare che in
virtù della mancata restituzione, i promittenti
non potettero godere dell’immediata disponibilità dell’immobile, pur ad essi dovuta.
Infatti, al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell’inadempimento della obbligazione contrattualmente assunta (la restituzione del bene,
se non si fosse avverata la condizione indicata
nel contratto preliminare), il M. avrebbe dovuto provare che l’inadempimento era stato determinato da causa non imputabile (art. 1218
c.c.), mentre non risulta che egli abbia agito
con la normale diligenza, onde escludere ogni
sua imputabilità al riguardo.
È mancata questa prova da parte sua, mentre
i creditori-promittenti hanno offerto un principio di prova circa la certezza ontologica del
danno, con le testimonianze acquisite al processo che hanno confermato che essi in precedenza locavano l’immobile a terzi, traendone il
relativo guadagno (v. per quanto valga Cass.
3327/02).
Conclusivamente il ricorso va respinto.
(Omissis)
[Varrone Presidente – Uccella Estensore – Ceniccola P.M. (concl. conf.). – M.S. (avv. Saracino)
– R.F. e P.G. (avv.ti Moscarini e Greco)]
242
Contratto in genere
Nota di commento: «Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva tra autonomia contrattuale e automatismo della risoluzione»
I. Il caso
La fattispecie da cui origina la controversia in
questione è assai lineare, ma densa di rilevanti implicazioni giuridiche. Due parti stipulano un contratto preliminare di compravendita relativo ad un
immobile. Poiché l’oggetto del contratto è sottoposto alla procedura di esecuzione forzata, i contraenti appongono una clausola a tenore della quale, se
entro due anni i promittenti venditori non avranno
ottenuto l’autorizzazione alla vendita o la riduzione
del pignoramento o comunque l’estinzione della
procedura immobiliare del bene, il preliminare dovrà ritenersi a tutti gli effetti risoluto ed il promissario acquirente avrà diritto alla restituzione degli
acconti. Decorso il termine pattuito senza che fosse
intervenuta alcuna modifica della situazione dell’immobile i promittenti venditori inviavano formale diffida alla riconsegna del bene con offerta di restituzione delle somme già acquisite, cui la controparte immessa nel possesso dell’immobile si rifiutava di ottemperare.
La decisione da parte del giudice di primo grado
di rigetto della domanda di risoluzione di diritto del
contratto proposta dai promittenti venditori veniva
riformata in appello sulla base della qualificazione
della suddetta clausola non alla stregua di una clausola risolutiva espressa bensì come condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 cod. civ. Ad opinione
del giudice di secondo grado, poi confermata dalla
Corte di cassazione, infatti, l’autorizzazione alla vendita da parte dei creditori procedenti con esecuzione forzata rappresenta l’evento futuro e incerto dedotto in condizione.
La decisione in esame, pertanto, pur senza diffondersi nella ricostruzione degli istituti, offre in un
obiter lo spunto per precisare il ruolo giudiziale rispetto all’art. 1456 cod. civ. e ribadisce in maniera
puntuale la differenza tra la clausola risolutiva espressa e la condizione risolutiva. La Supr. Corte, infatti, considera corretta l’interpretazione letterale della clausola data dal giudice di seconde cure, in base all’assunto per cui la clausola risolutiva espressa postula la dichiarazione
della parte di volersi avvalere della risoluzione per l’avveramento delle circostanze indicate. Le
parti contraenti quindi, facendo uso della propria
autonomia contrattuale, hanno inteso inserire nel
contratto non una clausola risolutiva espressa, bensì
una condizione risolutiva.
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 31.8.2009, n. 18920 - Commento
II. Le questioni
1. La clausola risolutiva espressa come
strumento oggettivante dell’autonomia privata. Ai fini di una proficua analisi della sentenza in
commento, considerando le brevi riflessioni che la
Supr. Corte dedica alla disamina della figura iuris,
appare preliminare una ricostruzione relativa alla
funzione della clausola risolutiva espressa (di seguito c.r.e.).
Essa appartiene al più ampio genus delle clausole
risolutive, ovverosia all’insieme di pattuizioni,
espressione dell’autonomia di soggetti privati, che,
al pari della condizione risolutiva in senso stretto,
dell’attribuzione di una facoltà di recesso unilaterale ovvero della specificazione della risolubilità di un
atto di liberalità per inadempimento del modus
(artt. 648 e 793 cod. civ.), producono l’effetto di
determinare il venir meno della vincolatività della
vicenda contrattuale prevedendo la risoluzione degli effetti derivanti dal negozio medesimo. Più nello
specifico è possibile circoscrivere la c.r.e. alla previsione esplicita che il contratto cui attiene si risolva
nel caso in cui una determinata obbligazione non
sia adempiuta secondo le modalità stabilite, conseguentemente è possibile ascrivere la c.r.e. nella disciplina legale generale della risoluzione per inadempimento quale possibile regolamentazione convenzionale (si veda in merito Busnelli, infra, sez.
IV). In virtù della stipulazione della clausola infatti
il creditore della prestazione inadempiuta può conseguire la risoluzione in maniera sicuramente più
tempestiva e sicura giacché la previsione di una
clausola ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. comporta
che la gravità dell’inadempimento della obbligazione dedotta nella c.r.e. risulti in re ipsa, così derogando alla disciplina generale della risoluzione, la
quale prevede, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., che
l’inadempimento debba rivestire non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse della parte in bonis. È evidente che nell’ambito dei contratti sinallagmatici alla duttilità del criterio generale della
gravità dell’inadempimento corrisponde, in caso di
c.r.e., l’indeterminatezza dello stesso parametro in
relazione alla sussistenza dei presupposti della risoluzione, per cui si comprende l’esigenza di predeterminare in maniera analitica la rilevanza dell’inadempimento risolutorio considerato ex se dalle parti grave all’interno dell’economia del contratto, precludendo al giudice l’apprezzamento in ordine alla
gravità e importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.
Non è infatti considerata valida una c.r.e. non sufficientemente specifica quale quella genericamente
riferita alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto. Una pattuizione così formulata
costituirebbe infatti una mera clausola di stile iniNGCC 2010 - Parte prima
Contratto in genere
donea a derogare alla regola generale della risoluzione giudiziale.
Mediante l’utilizzo della c.r.e. si realizza quindi
un’oggettivazione degli specifici interessi che hanno
indotto il creditore a contrattare, giacché vengono
integrati all’interno del regolamento contrattuale,
dando rilievo a motivi peculiari in dipendenza dei
quali anche un inadempimento obiettivamente tollerabile può essere posto a fondamento della risoluzione. Le specificità dell’economia individuale del
contraente assurgono a giustificazione dell’esercizio
della pretesa risolutoria per cui al giudice sarà totalmente inibita ogni valutazione economica dell’inadempimento essendo questa devoluta alle parti; nella fattispecie ad esempio, secondo la parte ricorrente, il suo interesse ad acquistare un immobile non
sottoposto ad un giudizio di esecuzione forzata viene integrato nel regolamento contrattuale, in quanto
egli considera grave e rilevante, in riferimento al
perdurare della sua adesione al contratto, la mancata autorizzazione alla vendita o la riduzione del pignoramento sull’immobile.
Ciò è ancor più vero se si pone mente all’ulteriore
deroga alla disciplina generale rappresentata dall’art. 1454 cod. civ., a tenore del quale il creditore
deve fissare al debitore un termine congruo per
l’adempimento prima di risolvere il contratto: prevedendo una clausola risolutiva invece tale requisito
decade, per cui il creditore può utilmente ottenere
la risoluzione con effetto immediato senza attendere
la rinnovazione dell’inadempimento del debitore,
potendo dunque tornare sul mercato allo scopo di
soddisfare il suo interesse rimasto inappagato. Attraverso della c.r.e. la risoluzione del contratto assume dunque una maggiore funzione deterrente che
incoraggia il debitore ad un più tempestivo adempimento al fine di evitare la perdita del corrispettivo.
È utile sottolineare che dalla c.r.e. non discende
l’automatica risoluzione del contratto in seguito al
verificarsi dell’inadempimento previsto, bensì si origina un diritto potestativo, astrattamente condizionabile e rinunciabile, al recesso unilaterale della parte non inadempiente. Conseguentemente è l’esercizio di tale diritto in via di autotutela per tramite di
una dichiarazione della parte interessata di volersi
avvalere della clausola a provocare una risoluzione
ipso iure e non il mero inadempimento. In ipotesi di
c.r.e. la decisione giudiziale, la quale, ancora a differenza della risoluzione per grave inadempimento,
assume natura dichiarativa e non costitutiva, dovrà
quindi accertare l’esistenza di un comportamento
costituente inadempimento dell’obbligazione prevista nel contratto ascrivibile alla parte infedele e alla
quale le parti hanno ricollegato la risoluzione, ed infine verificare se il creditore della prestazione inadempiuta abbia esercitato, mediante la dichiarazio243
Cass., 31.8.2009, n. 18920 - Commento
ne di volersi avvalere della clausola, il diritto potestativo di provocare la risoluzione del rapporto. Si
precisa tuttavia che il contratto deve comunque essere interpretato secondo buona fede per cui le parole adoperate per formulare la clausola, oltre a risultare tali da poter individuare con precisione le
obbligazioni la cui violazione possa produrre la risoluzione, non devono essere intese secondo un significato eccessivamente rigoroso.
Al cospetto di una clausola risolutiva espressa
quindi la pronuncia giudiziale si risolve in una verifica di conformità che, se positiva, si limita alla declaratoria della già intervenuta risoluzione, della
quale non fa che prendere atto, senza negare nella
sostanza, la natura e la funzione proprie della risoluzione automatica del rapporto, quale espressione
dell’autonomia contrattuale inveratasi nella preconfigurazione negoziale dell’importanza dell’inadempimento dedotto nella c.r.e.
2. Importanza dell’adempimento e perimetro del sindacato del giudice nel quadro del
principio di buona fede. Occorre dunque chiarire il passaggio in cui la Supr. Corte nella pronuncia
de qua, nell’individuare la c.r.e. come fonte del diritto potestativo in capo alla parte creditrice di risolvere immediatamente il contratto, ha cura di precisare
«senza ricorrere al giudice». In proposito si rivela opportuno segnalare come l’automatismo della risoluzione derivante dall’apposizione di una clausola pattizia ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. debba essere difesa dal fuoco di opposti estremismi relativi al ruolo
del giudice con riferimento al contenuto della c.r.e.
Da una parte infatti si potrebbe reclamare una radicale estromissione del giudice rispetto alla vicenda
risolutoria, la cui interferenza vanificherebbe o inciderebbe negativamente sul carattere d’efficienza e
tempestività che ontologicamente connota la risoluzione ipso iure (Smiroldo; Barbero, entrambi infra, sez. IV). Sarebbe quindi connotato da superfluità il sindacato del giudice sul collegamento realizzato dall’autonomia delle parti tra singoli inadempimenti considerati nella c.r.e. e risoluzione dell’intero
contratto, in quanto l’unico limite ammesso alla libertà contrattuale può essere costituito dalle reciproche autolimitazioni della volontà dei contraenti
che trasforma la risolubilità ordinaria, frutto dell’inadempimento, a risoluzione per volontà liberamente espressa dalle parti. Specularmente invece,
dall’esaltazione della funzione integrativa della buona fede quale regola di condotta valutativa ex post
del contenuto dell’obbligo di prestazione, si pretenderebbe una centralità dell’art. 1455 cod. civ. quale
criterio di controllo al fine di scongiurare abusi nell’utilizzo dello strumento risolutorio nell’intero sistema della risoluzione per inadempimento, esten244
Contratto in genere
dendo il sindacato giudiziale sulla gravità dell’inadempimento anche in caso di previsione di c.r.e.,
qualora questo, assunto dalle parti come causa della
rottura del vincolo negoziale, appaia del tutto irrilevante ai fini della realizzazione degli scopi dell’operazione economica. L’art. 1455 cod. civ. assumerebbe dunque portata generale avallando la valutazione
d’incidenza dell’inadempimento dedotto nella clausola risolutiva sull’equilibrio contrattuale ovvero
sull’economia complessiva del rapporto (Turco, infra, sez. IV).
L’opinione largamente affermata in giurisprudenza tuttavia rintraccia la corretta interpretazione della
c.r.e. nel juste milieu tra i due suesposti orientamenti. Per meglio comprendere l’esatta latitudine dell’art. 1456 cod. civ. e verificarne la compatibilità con
il controllo di gravità giudiziale previsto dall’art.
1455 cod. civ. vale effettuare due considerazioni.
In primis storicamente non si può trascurare che
la clausola risolutiva appaia come un elemento di
novità dell’attuale codice. Nel vigore del precedente
infatti l’art. 1165 cod. civ. del 1865, recependo il
modello dell’art. 1184 code civil, si prevedeva che in
tutti i contratti sinallagmatici l’inadempimento dell’obbligazione di una parte costituiva la tacita condizione risolutiva dell’obbligazione corrispettiva, i cui
effetti però erano subordinati alla domanda al giudice della parte in bonis della risoluzione del contratto
il quale aveva la facoltà di concedere al contraente
inadempiente un termine di grazia. Accanto a tale tipologia di risoluzione le parti potevano tuttavia risolvere in via convenzionale il contratto per mezzo
del c.d. patto commissorio che costituiva, in varie
modalità, una condizione risolutiva espressa e dunque una fattispecie risolutoria automatica alternativa
a quella giudiziale. Nel codice oggi imperante il legislatore ha valorizzato proprio quella specifica applicazione del patto commissorio che connetteva all’inadempimento di specifiche obbligazioni la risoluzione di pieno diritto ritenendo inammissibile la
risoluzione come condizione risolutiva tacita.
Risulta opportuno inoltre richiamare alla mente
come la giurisprudenza abbia generalmente negato
la riconducibilità della c.r.e. al novero delle clausole
vessatorie che nei contratti per adesione richiedono
la specifica approvazione per iscritto dell’aderente
ai sensi dell’art. 1341, comma 2o, cod. civ. (cfr.
Cass., 3.8.2005, n. 16253; Cass., 8.1.1992, n. 126,
entrambe infra, sez. III). Si ritiene infatti che l’elenco contenuto nella suddetta norma non sia meramente esemplificativo ma tassativo e dunque non
suscettibile di estensione in via interpretativa. A sostegno di tale conclusione milita il tenore letterale
della disposizione laddove in maniera puntuale il legislatore prevede delle clausole specifiche che in eccezione alla regola generale pretendono un ulteriore
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 31.8.2009, n. 18920 - Commento
requisito formale. Si evidenzia inoltre come pur
concentrandosi sul contenuto della clausola non si
giunga a differenti conclusioni posto che risulta palese come la c.r.e. sia ontologicamente diversa dagli
altri patti di cui all’art. 1341 cod. civ. Infatti diversamente dalle pattuizioni che limitano la facoltà di opporre eccezioni o che facoltizzano la sospensione
dell’esecuzione aggravando la condizione di una
delle parti, la clausola risolutiva consolida la facoltà
già insita nel contratto di domandare la risoluzione
del contratto semplicemente anticipando l’indagine
sull’importanza di un determinato inadempimento
rispetto all’interesse dell’altro contraente. Non si
può tuttavia trascurare come nell’ambito dei contratti del consumatore si possa assimilare la c.r.e. ad
un patto che attribuisca la facoltà di recesso al solo
predisponente (art. 33, comma 2o, lett. g, cod. cons.)
e dunque per tale via considerata vessatoria in quanto alterante lo squilibrio contrattuale in maniera significativa attraverso una globale valutazione dei
molteplici interessi in causa.
Alla base dell’orientamento che ammette la sottomissione della c.r.e. alla valutazione del giudice secondo il parametro della non scarsa importanza di
cui all’art. 1455 cod. civ., vi è la convinzione, alternativamente definibile come eccessivamente ottimistica o oltremodo invasiva, che affida al giudizio di
buona fede (e al giudice attraverso l’utilizzo di tale
clausola generale) il ruolo non (solo) di ricostruire i
desiderata delle parti, in caso di difetto di adeguata
determinatezza dell’inadempimento ovvero di comporre l’equilibrio negoziale una volta accertata una
disparità di trattamento salvaguardando il modello
di contratto paritario, bensì di edificare il limite di
operabilità della c.r.e. rispetto ad un presunto interesse negoziale. Assumendo tale visione infatti attraverso la verifica della gravità dell’inadempimento sarebbe il giudice a selezionare gli interessi meritevoli
di tutela in chiara espropriazione dell’autonomia
delle parti le quali, in maniera consapevole e senza
che sia ravvisabile uno stato d’inferiorità di una parte, hanno magari collegato la risoluzione ad un lieve
inadempimento o hanno perfino previsto una c.r.e.
unilaterale. Il criterio della gravità dell’inesatto
adempimento agli effetti specifici della risoluzione
dunque non si rivela il mezzo più idoneo per rispondere al reale ed effettivo pericolo di abuso di una
parte sull’altra nell’ambito di una predeterminazione negoziale della rilevanza sull’economia del rapporto. Come ha osservato la Supr. Corte (cfr. Cass.,
18.2.2008, n. 3954, infra, sez. III) infatti, ai fini della
valutazione della gravità dell’inadempimento l’autorità giudiziale deve porre in essere una duplice indagine che investa da una parte i comportamenti assunti dalle parti nelle more del rapporto contrattuale, valorizzando ad esempio una tempestiva riparaNGCC 2010 - Parte prima
Contratto in genere
zione, e che riguardi dall’altra l’incidenza sull’economia complessiva del rapporto, considerando sia il
pregiudizio economico concretamente sopportato
dalla parte in bonis, sia l’entità dell’inadempimento
medesimo, la cui soglia sarebbe però già stata prefissata dalla c.r.e. Ciò non deve comunque trasbordare
nella negazione di cittadinanza al generale principio
di buona fede in caso di previsione di una c.r.e. la
quale deve appunto rimanere a presidio dell’equilibrio inteso come parità di condizioni: in questo terreno si deve dunque verificare l’ingiustizia in maniera effettiva. Su questo piano e in questo senso, e non
mediante il parametro di rilevanza di cui all’art.
1455 cod. civ., il giudice deve accertare la conformità tra fattispecie concreta e fattispecie astratta.
Del resto costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità la regola per cui il giudice
dovrà altresì verificare che l’inadempimento sia imputabile al debitore, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.,
in quanto la pattuizione della c.r.e., non incide sui
principi regolatori della risoluzione diversi dalla gravità, non potendo dare luogo ad una responsabilità
senza colpa (cfr. Cass., 14.7.2000, n. 9356; Cass.,
5.8.2002, n. 11717, entrambe infra, sez. III). Peraltro anche avendo riguardo ad istituti sistematicamente e topograficamente affini quali il termine essenziale, la diffida ad adempiere e la risoluzione per
inadempimento, appare evidente come la risoluzione del rapporto costituisca una sanzione la quale
non sarebbe ammissibile qualora non si riscontrasse
quanto meno l’elemento colposo.
Il giudice quindi non è tenuto solo ad appurare
che l’evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve altresì vagliare, con riferimento al
principio della buona fede, il comportamento dell’obbligato. Versandosi in tema di responsabilità
contrattuale, la colpa dell’inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta
sino a prova contraria, e tale presunzione è destinata
a cadere solo a fronte di risultanze dedotte e provate
dal debitore, le quali dimostrino che quest’ultimo,
nonostante abbia usato una normale diligenza, non
sia stato in grado di eseguire tempestivamente le
prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.
Del resto perché l’impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non è sufficiente eccepire che la prestazione
non possa essere eseguita per fatto del terzo, risultando necessario dimostrare la propria assenza di
colpa, con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo interposto da altri all’esatto adempimento.
Il giudice non potrà inoltre trascurare anche la reciproca posizione delle parti in ossequio alla locuzione inadimplenti non est adimplendum che trova
riferimento nell’art. 1460 cod. civ. in caso di reci245
Cass., 31.8.2009, n. 18920 - Commento
proci inadempimenti, compiendo una valutazione
basata sulla loro importanza in relazione agli interessi contrattualmente rilevanti. Tale postulato si giustifica alla luce della funzione medesima della c.r.e.
la quale elimina soltanto la necessità dell’indagine
circa l’importanza di un determinato inadempimento, che è stata misurata anticipatamente dai contraenti, senza incidere sulle altre regole concernenti
la risoluzione dei contratti. Tuttavia l’exceptio inadimpleti contractus non deve appiattirsi sul criterio
di cui all’art. 1455 cod. civ. comportando ai fini dell’opponibilità dell’eccezione l’accertamento della
non scarsa importanza dell’inadempimento eccepito, ma deve fondarsi su una globale comparazione
dell’effettiva entità dei reciproci inadempimenti
identificando anche interessi non riconducibili alla
causa del contratto o alla volontà delle parti, sulla
base di una visione complessiva che includa sia i
comportamenti delle parti sia le circostanze anche
sopravvenute.
3. La dichiarazione di avvalersi della clausola e differenza tra c.r.e. e condizione risolutiva. L’essenza della c.r.e. come forma di autotutela privata ammessa dalla legge è sottolineata dalla
Cassazione nella sentenza de qua laddove il S.C. individua nel diritto potestativo a favore della parte
nel cui interesse è stata stipulata la clausola il criterio distintivo rispetto alla condizione risolutiva.
Tali due figurae iuris infatti mostrano elementi di
affinità, in particolar modo nel caso in cui le parti
deducano l’inadempimento ad oggetto di una condizione risolutiva: al verificarsi dell’inadempimento
dedotto il contratto si risolve di diritto. Tale relazione risultava maggiormente sottolineata nei primi
anni di entrata in vigore dell’attuale codice, derivante dalla concezione suesposta relativa all’imperio del codice del 1865 laddove si riconduceva la
c.r.e. appunto allo schema della condizione risolutiva. È noto che quest’ultima consta di due elementi:
la clausola condizionale e l’evento condizionante
che riguarda gli effetti del contratto, dall’avveramento del quale le parti fanno dipendere l’esistenza
del rapporto consequenziale. Con l’apposizione
della condizione le parti danno rilevanza ai motivi
che hanno determinato una certa pattuizione, specificano cioè che gli effetti del contratto stipulato
sono voluti soltanto se o fino a quando un certo
fatto si verifichi.
Emerge tuttavia in maniera nitida come la condizione risolutiva sia connotata da una maggiore oggettività pur costituendo una autolimitazione della
volontà al pari della c.r.e., dove il ruolo del creditore
è essenziale. A differenza di questa infatti non rappresenta una sanzione per il caso di inadempimento,
in quanto il verificarsi di questo produce immedia246
Contratto in genere
tamente ed in maniera automatica gli effetti senza
presupporre un’indagine sulla sussistenza della colpa né richiedere alcuna dichiarazione da parte del
contraente in bonis «di volersi avvalere della risoluzione per l’avveramento delle circostanze indicate»,
come osserva la pronuncia in analisi, in quanto subordina il perseguimento di uno specifico interesse
programmatico ad un dato evento futuro ed incerto,
estraneo alla sfera di controllo delle parti.
L’effetto precipuo della c.r.e. invece non è la risoluzione ipso iure del contratto, bensì la facoltà di recesso unilaterale a favore del creditore titolare del
diritto potestativo, la cui dichiarazione di giovarsi
della clausola costituisce presupposto indefettibile
per l’operatività della c.r.e. Ciò è del resto confermato dal tenore letterale dell’art. 1456 cod. civ. laddove al comma 2o precisa che la risoluzione si realizza in presenza di inadempimento appunto «quando
la parte interessata dichiara all’altra che intende avvalersi della c.r.e.», cristallizzando dunque il momento
in cui si produce l’effetto risolutivo: la risoluzione
del rapporto avviene quindi per volontà innovativa
del soggetto che produce un negozio giuridico unilaterale recettizio.
Il ruolo dirimente di tale dichiarazione è sottolineato dal fatto che il debitore può adempiere la propria obbligazione, sanando il precedente inadempimento, fino al momento in cui il creditore manifesta
l’intenzione di avvalersi della c.r.e.; ugualmente qualora si realizzi l’inadempimento e la parte in bonis rimane inattiva o la dichiarazione non viene a conoscenza del debitore che provvede ad un adempimento tardivo, la successiva dichiarazione si rivela
tamquam non esset. Appare quindi palese come il
fondamento della rilevanza giuridica della dichiarazione sia il precedente inadempimento dell’altra
parte, la cui assenza infatti priva di funzionamento
la stessa dichiarazione.
Il mancato effetto automatico della risoluzione
potrebbe del resto non essere più conforme all’interesse del creditore nell’atto in cui l’inadempimento
si verifica, egli infatti potrebbe optare per conservare comunque il contratto. Peraltro la regola di cui al
comma 2o dell’art. 1456 cod. civ., come la stessa disciplina del termine essenziale di adempimento inserito nel tessuto normativo dell’art. 1457 cod. civ., è
finalizzata a preservare in capo al contraente adempiente lo jus variandi già scolpito nell’art. 1453 cod.
civ. di fronte all’inadempimento della controparte, e
cioè la possibilità di scegliere tra risoluzione o
adempimento. Si evidenzia anche in questo aspetto
la funzione della c.r.e. come mezzo diretto a rendere
maggiormente efficace la tutela della posizione del
soggetto senza percorrere le ordinarie vie giudiziali.
In aggiunta all’assoluta irrilevanza del comportamento del creditore in ipotesi di condizione risolutiNGCC 2010 - Parte prima
Cass., 31.8.2009, n. 18920 - Commento
va, questa è caratterizzata rispetto alla c.r.e. anche
dal proprio oggetto: un fatto futuro ed incerto attinente alla realizzazione del contratto o alla sua efficacia può infatti ben essere dedotto in condizione risolutiva, giammai essere oggetto di una c.r.e. che attiene invece all’adempimento delle prestazioni corrispettive. Nella fattispecie della controversia in commento l’autorizzazione alla vendita, la riduzione del
pignoramento o comunque l’estinzione della procedura di esecuzione forzata del bene immobile costituiscono eventi esterni al piano delle obbligazioni
presenti nel contratto e estranei alla sfera volitiva
degli esecutati promittenti venditori, risultando
bensì subalterni alle svariate vicende processuali del
giudizio di esecuzione forzata, dipendenti, oltre dalla condotta della parte esecutata, dalla volontà dei
creditori e dal giudizio finale dell’autorità giudiziaria.
Correttamente dunque il S.C., confermando la
decisione del giudizio d’appello, ha configurato la
clausola come condizione risolutiva, estranea al
comportamento imputabile delle parti benché incidente sul profilo effettuale del contratto. Appare infatti evidente come la posizione dell’avente causa
nella controversia in questione sia assolutamente
coincidente con la posizione di attesa di un effetto
acquisitivo qualificabile come aspettativa rispetto all’avveramento di fatti relativi alla procedura di esecuzione forzata.
III. I precedenti
1. La clausola risolutiva espressa come
strumento oggettivante dell’autonomia privata. La funzione della c.r.e. è individuata dalla
Cass., 8.5.1987, n. 4246, in Foro it., 1987, I, 3071
nel «sostituire il normale meccanismo giudiziale della
risoluzione con una regolamentazione della stessa che
è espressione dell’autonomia delle parti». È ormai acclarato in giurisprudenza che requisito di validità
della c.r.e. è la specifica indicazione delle prestazioni obbliganti il cui inadempimento determini il venir
meno automatico e stragiudiziale della vincolatività
dell’accordo: in tema Cass., 27.1.2009, n. 1950, in
Contratti, 2009, 547, e Cass., 6.4.2001, n. 5147, in
Mass. Giur. it., 2001. Con riferimento al ruolo del
giudice in seguito all’operatività della c.r.e. si vedano ex multis Cass., 27.10.2005, n. 20880, in Obbl. e
contr., 2006, 362; Cass., 5.1.2005, n. 167, in Mass.
Giur. it., 2005; Cass., 7.3.2001, n. 3343, in Contratti,
2001, 688.
2. Importanza dell’adempimento e perimetro del sindacato del giudice nel quadro del
principio di buona fede. I profili rilevanti ai fini
dell’indagine sulla gravità dell’inadempimento ai
sensi dell’art. 1455 cod. civ. sono analizzati dalla
NGCC 2010 - Parte prima
Contratto in genere
Cass., 18.2.2008, n. 3954, in questa Rivista, 2008, I,
825, con nota di Amram, e Cass., 2.3.2007, n. 4982,
in Guida al dir., 2007, n. 16, 82. L’oggetto dell’accertamento del giudice in presenza di c.r.e. è evidenziata da Cass., 14.11.2006, n. 24207, in Contratti,
2007, 578; Cass., 5.1.2005, n. 167, in Mass. Giur. it.,
2005; Cass., 28.1.1993, n. 1029, in Foro it., 1993, I,
1475.
Negano la vessatorietà della c.r.e. Cass., 3.8.2005,
n. 16253, in Mass. Giust. civ., 2005; Cass., 8.1.1992,
n. 126, in Mass. Giur. it., 1992; Cass., 19.1.1989, n.
265, in Arch. loc., 1990, 57. La necessità di verificare
l’imputabilità dell’inadempimento in presenza di
c.r.e. è affermata tra le altre da Cass., 6.2.2007, n.
2553, in Contratti, 2007, 965; Cass., 17.10.1995, n.
10815, in Gius, 1996, 314; Cass., 14.7.2000, n. 9356,
in Contratti, 2000, 1108; Cass., 5.8.2002, n. 11717,
ivi, 2003, 38.
3. La dichiarazione di avvalersi della clausola e differenza tra c.r.e. e condizione risolutiva. Il rapporto tra c.r.e. e la condizione risolutiva è precisato da Cass., 24.6.2008, n. 17181, in
Mass. Giust. civ., 2008, e Cass., 21.1.1982, n. 400,
ivi, 1982. L’interpretazione letterale dell’art. 1456
cod. civ. al fine di distinguerla con la condizione risolutiva è sottolineata da Cass., 8.7.1948, in Giur.
civ. compl., 1948, II, 225, con nota di Rubino.
L’eventualità che il contraente non inadempiente
scelga di conservare il contratto è evidenziata da
Cass., 17.5.1995, n. 5436, in Mass. Giust. civ., 1995.
Sull’efficacia sanante dell’adempimento tardivo del
debitore prima della dichiarazione del creditore di
volersi giovare della c.r.e. si veda Cass., 6.12.1980,
n. 6344, in Rep. Giur. it., 1980, voce «Obbligazioni
e contratti», n. 411.
IV. La dottrina
1. La clausola risolutiva espressa come
strumento oggettivante dell’autonomia privata. Sulla risoluzione del contratto in generale si
veda Paladini, voce «Risoluzione del contratto per
inadempimento», in Enc. dir. Sole 24 ore, Il Sole 24
ore, 2008. Con riferimento alla funzione della c.r.e
in generale si rinvia a Busnelli, voce «Clausola risolutiva espressa», in Enc. del dir., VII, Giuffrè,
1960, 196; Dellacasa-Addis, Inattuazione e risoluzione: i rimedi, in Rimedi, 2, a cura di Roppo, nel
Trattato Roppo, V, Giuffrè, 2006, 295; in particolare
sulla deroga alla disciplina di cui all’art. 1455 cod.
civ., Belfiore, voce «Risoluzione per inadempimento», in Enc. del dir., XL, Giuffrè, 1989, 1311, individua in tale caratteristica «la principale ragion
d’essere» dell’istituto. Sottolinea la funzione della
c.r.e. quale strumento per fornire una consistenza
247
Cass., 31.8.2009, n. 18920 - Commento
oggettiva agli interessi del creditore Collura, Importanza dell’inadempimento e teoria del contratto,
Giuffrè, 1992, 127.
2. Importanza dell’adempimento e perimetro del sindacato del giudice nel quadro del
principio di buona fede. La sottrazione al giudice
di ogni valutazione relativa alla gravità dell’inadempimento è esaminata da Spallarossa, La risoluzione
del contratto per inadempimento, in questa Rivista,
1989, II, 189, e Iudica, Risoluzione per inadempimento, in Riv. dir. civ., 1983, II, 191, ed in particolare da Smiroldo, Profili della risoluzione per inadempimento, Giuffrè, 1982, e prima ancora da Barbero, La «clausola risolutiva espressa» in rapporto alla disciplina eccezionale degli alloggi, in Temi, 370;
contra si v. Gonnelli, La clausola risolutiva espressa
tra principio di buona fede e importanza dell’inadempimento, in Obbl. e contr., 2009, 708, e l’approfondita analisi di Turco, L’imputabilità e l’importanza
dell’inadempimento nella clausola risolutiva, Giappichelli, 1997, 103.
Per l’evoluzione storica della condizione risolutiva espressa si veda Laurent, Principes de Droit Civil, XVII, Bruylant, 1878, 170. In merito al principio di buona fede riferito alla c.r.e. si rinvia alle considerazioni di Smiroldo, 182, e Turco, 141; e in
generale si veda Breccia, Diligenza e buona fede
nell’attuazione del rapporto obbligatorio, Giuffrè,
1968; Busnelli, Note in tema di buona fede ed equità, in Riv. dir. civ., 2001, I, 537; Natoli, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, Giuffrè, 1955.
L’imputabilità dell’inadempimento derivante dal
carattere sanzionatorio della risoluzione del rapporto è riconosciuto da Busnelli, 198; Auletta, La risoluzione per inadempimento, Giuffrè, 1942; Bigliazzi Geri, Della risoluzione per inadempimento,
nel Commentario Scialoja-Branca, II, Zanichelli-Foro
it., 1990, 18; e con riferimento al termine essenziale
da Natoli, Il termine essenziale, in Riv. dir. comm.,
1947, I, 233; più recentemente si vedano le osservazioni di Fontanella, Imputabilità dell’inadempimento e clausola risolutiva espressa, in Contratti,
248
Contratto in genere
2007, 967; Addante, Colpa dell’obbligato ed operatività della clausola risolutiva espressa, ivi, 2003, 234.
Contra Sacco, Il contratto, nel Trattato Vassalli, VI,
Utet, 1975, 948, e Giorgianni, L’inadempimento,
Giuffrè, 1975, 888, il quale ritiene la risoluzione
conseguenza dell’impossibilità di attuazione del
contratto a “prestazioni corrispettive”; mentre con
riferimento alla c.r.e. cfr. Mutarelli, Per il superamento della colpa nella clausola risolutiva espressa, in
Riv. dir civ., 1978, II, 255, e Turco, 21.
Per quanto riguarda l’eccezione di inadempimento si rinvia a Bigliazzi Geri, Profili sistematici dell’autotutela privata, Giuffrè, 1974, e Zana, La regola
della buona fede nell’eccezione di inadempimento, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1972, 1378.
3. La dichiarazione di avvalersi della clausola e differenza tra c.r.e. e condizione risolutiva. Assai sovente la c.r.e. è stata avvicinata alla
condizione risolutiva di inadempimento su cui si
rinvia ex multis alla lucida analisi di Martone, Condizione risolutiva d’inadempimento, in questa Rivista, 2008, II, 71, e Lenzi, Condizione, autonomia
privata e funzione di autotutela: l’adempimento dedotto in condizione, Giuffrè, 1996. Sulla differenza
tra i due istituti si vedano Natoli, Condizione risolutiva espressa e rapporto enfiteutico, in Foro it.,
1944-46, I, 570; Romoli, Sul rapporto tra clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva di adempimento, in Riv. notar., 2007, 1208; Dellacasa-Addis, 316.
Sul tenore letterale dell’art. 1456 cod. civ. e la rilevanza della dichiarazione del creditore in costanza
di inadempimento cfr. Caianiello, Della risoluzione del contratto. Artt. 1456-1457, in Nuova rass. giur.
cod. civ., a cura di Ruperto e Sgroi, IV, 3, Giuffrè,
1994, 1556.
Rimarcano la funzione della tutela di un eventuale
interesse alla conservazione del contratto da parte
del creditore Scognamiglio, Contratti in generale,
nel Trattato Grosso-Santoro Passarelli, IV, Vallardi,
278, e ancora Natoli, 573.
Ivan Libero Nocera
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755
c CASS. CIV., sez. un., 28.10.2009, n. 22755
Famiglia (regime patrimoniale)
dal testo:
Cassa App. Palermo, 15.3.2005
Famiglia (regime patrimoniale) - Comunione dei beni - Acquisto di un bene immobile destinato all’attività
professionale di un coniuge - Intervento nell’atto di acquisto dell’altro coniuge ex art. 179, comma 2o,
cod. civ. - Natura giuridica della
partecipazione - Atto ricognitivo
(cod. civ., artt. 177, comma 1o, lett. a), 179) (a)
Famiglia (regime patrimoniale) - Comunione dei beni - Amministrazione Atti compiuti senza il necessario
consenso - Annullabilità - Effetti
nei confronti dei terzi (cod. civ., artt.
184, 1445) (b)
(a) Ha natura ricognitiva la dichiarazione
con la quale uno dei coniugi riconosce che
il corrispettivo dell’acquisto compiuto
dall’altro coniuge viene pagato con il prezzo del trasferimento di altri beni personali. Non può attribuirsi invece natura ricognitiva alla dichiarazione con la quale uno
dei coniugi esprima condivisione dell’intento dell’altro coniuge di destinare in futuro alla propria attività personale il bene
che viene acquistato. In tale ipotesi, occorrerà accertare quale destinazione il bene avrà effettivamente, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così manifestati.
(massima non ufficiale)
(b) Il coniuge non acquirente di un bene
può successivamente proporre domanda
di accertamento della comunione legale
anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall’altro coniuge,
non risultando precluso tale accertamento
dal fatto che il coniuge non acquirente
fosse intervenuto nel contratto per aderirvi; salvi gli effetti della trascrizione della
domanda, il sopravvenuto accertamento
della comunione legale non è opponibile
al terzo acquirente di buona fede.
(massima ufficiale)
NGCC 2010 - Parte prima
Il fatto. Il 25 giugno 1996 R. B. convenne in
giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala l’ex
marito P. B. e N. P., cui in data 12 luglio 1991
lo stesso P. B. aveva venduto un alloggio, che
in precedenza era stato destinato a casa coniugale sin dal suo acquisto in data 7 luglio 1986,
benché entrambi i coniugi ne avessero all’epoca simulato la destinazione all’attività professionale del marito, per sottrarlo a scopo fiscale
alla comunione legale. Chiese dunque che, dichiarata la simulazione dell’atto pubblico per
notar L. F. di acquisto dell’immobile a nome
del solo P. B., fosse accertata la comune proprietà dell’alloggio in capo a entrambi i coniugi
e ne fosse di conseguenza annullata la successiva vendita a N. P.
Ripropose così la domanda già proposta nel
giudizio di separazione personale dei coniugi e
trascritta il 10 luglio 1991, ma dichiarata inammissibile in quella sede. Il tribunale qualificò la
domanda di R. B. come azione di simulazione
del contratto di compravendita stipulato dai
coniugi B. per l’acquisto dell’immobile controverso. Ordinò pertanto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A. F. e M. L. A.,
danti causa di P. B. e R. B. e rigettò la domanda per mancanza di prova scritta.
La decisione, impugnata da R. B., fu tuttavia
riformata dalla Corte d’appello di Palermo,
che, qualificata la domanda come azione di accertamento della comunione legale, riconobbe
R. B. comproprietaria dell’immobile e di conseguenza annullò il contratto di compravendita
per notar C. stipulato da N. P. con il solo P. B.
Ritennero i giudici d’appello che l’indiscussa e
comunque accertata destinazione dell’immobile a casa coniugale ne aveva determinato l’immediata inclusione nella comunione legale sin
dall’acquisto, perché la dichiarazione resa da
R. B. nell’atto pubblico di compravendita del 7
luglio 1986, circa la destinazione dell’immobile
all’attività professionale del marito commercialista, non aveva avuto efficacia negoziale e non
aveva comportato pertanto la sottrazione del
bene alla comunione.
Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione N. P., con un unico motivo d’impugnazione, cui resiste con controri249
Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755
corso R. B., che ha proposto altresì, ricorso incidentale condizionato e ha poi depositato anche una memoria. Mentre non ha spiegato difese P. B.
La prima sezione civile di questa corte, cui il
ricorso era stato assegnato, ne ha sollecitato la
rimessione alle Sezioni unite. Ha rilevato infatti un contrasto di giurisprudenza circa la disponibilità del diritto alla comunione legale su
beni che per legge vi sarebbero inclusi; e la
particolare importanza della consequenziale
questione degli effetti nei confronti dei terzi
acquirenti nel caso di sopravvenuto accertamento della comunione legale sui beni alienati
dal coniuge unico intestatario. Successivamente P. B. ha depositato memoria.
I motivi. 1. – Disposta a norma dell’art.
335 c.p.c. la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza, va innanzitutto rilevato
che nella memoria depositata dalla controricorrente R. B. viene eccepita l’improcedibilità
del ricorso principale per omessa notifica ai
chiamati in causa A. F. e M. L. A.
Si tratta tuttavia di eccezione palesemente
infondata, perché non è più in discussione in
questo giudizio il contratto di compravendita
cui parteciparono A. F. e M. L. A., bensì solo il
contratto di compravendita stipulato da N. P.
con P. B.
Né rileva in questa sede se violi l’art. 112
c.p.c. la modificazione della qualificazione giuridica della domanda da parte della corte d’appello, posto che si tratterebbe comunque di un
error in procedendo non dedotto dal ricorrente
e non rilevabile d’ufficio (Cass., sez. III, 17
gennaio 2007, n. 978, n. 596924).
2. – Con l’unico complesso motivo del suo
ricorso N. P. deduce violazione degli art. 179,
184, 1445 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata.
Lamenta innanzitutto che la corte d’appello
non abbia tenuto conto della sua buona fede di
terzo acquirente, cui non poteva addossarsi
una responsabilità del solo P. B.
Eccepisce poi la prescrizione dell’azione di
annullamento, perché proposta a oltre un anno
sia dall’acquisto dell’immobile da parte dei coniugi B. sia dal successivo acquisto dello stesso
immobile da parte sua.
Lamenta infine che la dichiarazione resa da
250
Famiglia (regime patrimoniale)
R. B. all’atto dell’acquisto dell’immobile da
parte del marito sia stata erroneamente qualificata come meramente ricognitiva, anziché negoziale, senza considerarne la destinazione a rifiutare gli effetti traslativi del contratto. E rilevato che su tale questione v’è contrasto di giurisprudenza, chiede che la questione sia risolta
dalle Sezioni unite della corte.
3. – Risulta preliminare l’esame dell’eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente,
perché, ove tale eccezione risultasse ammissibile e fondata, la conseguente dichiarazione di
estinzione del diritto azionato da R. B. renderebbe irrilevante l’accertamento della sua effettiva esistenza (Cass., sez. un., 11 gennaio 2008,
n. 581).
Sennonché, posto che quella prevista dall’art. 184 c.c. è effettivamente una prescrizione
e non una decadenza (Cass., sez. II, 19 febbraio 1996, n. 1279, n. 495904), l’eccezione è
inammissibile, perché il ricorrente non ha neppure allegato di averla già proposta sin dal giudizio di primo grado.
Infatti l’art. 345 comma 2 c.p.c. ammette che
siano dedotte in appello nuove eccezioni solo
quando sarebbero rilevabili d’ufficio.
Sicché, essendo quella di prescrizione un’eccezione non rilevabile d’ufficio (art. 2938 c.c.),
il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno allegare, non solo di averla dedotta già in primo
grado, ma anche di averla poi riproposta in appello a norma dell’art. 346 c.p.c. (Cass., sez. L,
7 settembre 2007, n. 18901, Cass., sez. L, 12
novembre 2007, n. 23489). In mancanza di tale
allegazione, l’eccezione di prescrizione è preclusa anche in questa sede.
4. – Risulta dunque rilevante la questione
della natura e degli effetti della dichiarazione
con la quale R. B., intervenuta nell’atto per notar L. F. stipulato da P. B. il 7 luglio 1986, riconobbe che l’immobile controverso veniva acquistato allo scopo di destinarlo all’attività professionale del marito commercialista. Ed è con
riferimento a tale questione che s’è manifestato
nella giurisprudenza di legittimità il contrasto
denunciato dalla prima sezione civile di questa
corte. I riferimenti normativi di questa controversa questione sono tre:
a) l’art. 177 comma 1 lettera a) c.c., che include nella comunione legale “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755
durante il matrimonio, ad esclusione di quelli
relativi ai beni personali”;
b) l’art. 179 comma 1 c.c., che elenca i beni
esclusi dalla comunione in quanto personali e
tra gli altri vi annovera, alla lettera d), anche “i
beni che servono all’esercizio della professione
del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione”;
c) l’art. 179 comma 2 c.c., laddove prevede
che l’acquisto di beni immobili o equiparati,
benché effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, se di esso sia stato
parte anche l’altro coniuge e ove si tratti di
“beni di uso strettamente personale di ciascun
coniuge” (art. 179, comma 1, lettera c), di
“beni che servono all’esercizio della professione del coniuge” acquirente (art. 179, comma
1, lettera d), di “beni acquisiti con il prezzo
del trasferimento” di altri beni già personali
del coniuge acquirente (art. 179, comma 1,
lettera f).
4.1. – Come risulta dalla citata ordinanza
interlocutoria della prima sezione civile, è controverso sia in dottrina sia in giurisprudenza se
abbia natura meramente ricognitiva ovvero negoziale l’atto con il quale uno dei coniugi, intervenendo nel contratto stipulato dall’altro
coniuge, riconosca a norma dell’art. 179 comma 2 c.c. la natura personale del bene acquistato e consenta perciò alla sua esclusione dalla
comunione legale.
Dalla natura meramente ricognitiva attribuita all’atto previsto dall’art. 179 comma 2 c.c.,
in particolare, un orientamento maggioritario
della giurisprudenza di questa corte fa discendere l’enunciazione di un principio di indisponibilità del diritto alla comunione legale (Cass.,
sez. I, 27 febbraio 2003, n. 2954, Cass., sez. I,
24 settembre 2004, n. 19250), benché ne riconosca poi la irretrattabilità, quale “dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio,
idonea a determinare l’effetto di una presunzione “juris et de jure” di non contitolarità dell’acquisto, di natura non assoluta ma superabile mediante la prova che la dichiarazione sia
derivata da errore di fatto o da dolo e violenza
nei limiti consentiti dalla legge” (Cass., sez. II,
6 marzo 2008, n. 6120, Cass., sez. I, 19 febbraio 2000, n. 1917).
NGCC 2010 - Parte prima
Famiglia (regime patrimoniale)
Sennonché può certo ammettersi che la dichiarazione prevista dall’art. 179 comma 2 c.c.
abbia natura ricognitiva e portata confessoria
quando risulti descrittiva di una situazione di
fatto, ma non quando sia solo espressiva di una
manifestazione di intenti.
Infatti una dichiarazione di intenti può essere più o meno sincera o affidabile, ma non è
una attestazione di fatti, predicabile di verità o
di falsità; e quindi, secondo quanto prevede
l’art. 2730 c.c., non può avere funzione di
confessione (Cass., sez. un., 26 maggio 1965,
n. 1038, Cass., sez. II, 6 febbraio 2009, n.
3033).
Esemplificando, può avere dunque natura ricognitiva la dichiarazione con la quale uno dei
coniugi riconosca appunto che il corrispettivo
dell’acquisto compiuto dall’altro coniuge viene
pagato con il prezzo del trasferimento di altri
beni già personali (art. 179, comma 1, lettera f).
Ma non può attribuirsi natura ricognitiva alla
dichiarazione con la quale uno dei coniugi
esprima condivisione dell’intento dell’altro coniuge di destinare alla propria attività personale il bene che viene acquistato.
Certo, non può negarsi una peculiare efficacia probatoria all’intervento del coniuge non
acquirente che sia effettivamente ricognitivo
dei presupposti di fatto dell’esclusione dalla
comunione del bene acquistato dall’altro coniuge. Ma il problema qui realmente in discussione non è tale possibile efficacia probatoria.
4.2. – Il problema che è effettivamente in
discussione è se l’intervento ex art. 179 comma
2 c.c. del coniuge non acquirente sia elemento
costitutivo della fattispecie cui si ricollegano gli
effetti di esclusione dalla comunione del bene
acquistato dall’altro coniuge.
Occorre dunque stabilire non solo se l’intervento adesivo del coniuge non acquirente sia
condizione sufficiente dell’esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge; ma anche se sia condizione necessaria di un
tale effetto. Secondo una parte della dottrina e
della giurisprudenza, infatti, l’intervento adesivo del coniuge non acquirente è di per sé sufficiente all’esclusione dalla comunione del bene
acquistato dall’altro coniuge, indipendentemente dall’effettiva natura personale del bene
(Cass., sez. I, 2 giugno 1989, n. 2688).
Secondo altra parte della dottrina e della
251
Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755
giurisprudenza, invece, l’intervento adesivo del
coniuge non acquirente non è sufficiente a
escludere dalla comunione il bene acquistato
dall’altro coniuge, ma è condizione necessaria
di tale esclusione; sicché, quand’anche sia effettivamente personale, il bene rimane incluso
nella comunione in mancanza dell’intervento
adesivo del coniuge non acquirente (Cass., sez.
I, 24 settembre 2004, n. 19250).
4.3. – Dalla stessa lettera dell’art. 179 comma 2 c.c. risulta peraltro che l’intervento adesivo del coniuge non acquirente non è di per sé
sufficiente a escludere dalla comunione il bene
che non sia effettivamente personale.
La norma prevede infatti che i beni acquistati risultano esclusi dalla comunione “ai sensi
delle lettere c), d) ed f) del precedente comma,
quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge”. Sicché dall’atto deve risultare alcuna
delle cause di esclusione della comunione tassativamente indicate nel primo comma dello
stesso art. 179 c.c.; e l’effetto limitativo della
comunione si produce solo “ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma”, vale a dire solo se i beni sono effettivamente personali.
L’intervento adesivo del coniuge non acquirente può dunque rilevare solo come prova dei
presupposti di tale effetto limitativo, quando,
come s’è detto, assuma il significato di un’attestazione di fatti. Ma non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione. E quando la
natura personale del bene che viene acquistato
sia dichiarata solo in ragione di una sua futura
destinazione, sarà l’effettività di tale destinazione a determinarne l’esclusione dalla comunione, non certo la pur condivisa dichiarazione
di intenti dei coniugi sulla sua futura destinazione.
Secondo il sistema definito dagli art. 177 e
179 comma 1 c.c., infatti, l’inclusione nella comunione legale è un effetto automatico dell’acquisto di un bene non personale da parte di alcuno dei coniugi in costanza di matrimonio.
Ed è solo la natura effettivamente personale
del bene a poterne determinare l’esclusione
dalla comunione.
Se il legislatore avesse voluto riconoscere ai
coniugi la facoltà di escludere ad libitum determinati beni dalla comunione, lo avrebbe fatto
prescindendo dal riferimento alla natura per252
Famiglia (regime patrimoniale)
sonale dei beni, che condiziona invece gli effetti previsti dall’art. 179 comma 2 c.c.
Certo, potrebbe anche ritenersi che una tale
facoltà debba essere riconosciuta ai coniugi per
ragioni sistematiche, indipendentemente da
un’espressa previsione legislativa. Come potrebbe ritenersi che, dopo C. cost., n. 91/1973,
non possa negarsi a ciascun coniuge il diritto di
donare anche indirettamente all’altro la proprietà esclusiva di beni non personali. Tuttavia
tali facoltà non potrebbero affatto desumersi
dall’art. 179 comma 2 c.c., che condiziona comunque l’effetto limitativo della comunione alla natura realmente personale del bene; e attribuisce all’intervento adesivo del coniuge non
acquirente la sola funzione di riconoscimento
dei presupposti di quella limitazione, ove effettivamente già esistenti.
4.4. – Deve nondimeno ritenersi che l’intervento adesivo del coniuge non acquirente sia
condizione necessaria dell’esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge. L’art. 179 comma 2 c.c. prevede infatti che
l’esclusione della comunione ai sensi dell’art.
179 comma 1 lettere c) d) e f) c.c. si abbia solo
se la natura personale del bene sia dichiarata
dall’acquirente con l’adesione dell’altro coniuge.
Sicché nei casi indicati la natura personale
del bene non è sufficiente a escludere di per sé
l’esclusione dalla comunione, se non risulti
concordemente riconosciuta dai coniugi. E tuttavia l’intervento adesivo del coniuge non acquirente è richiesto solo in funzione di necessaria documentazione della natura personale del
bene, unico presupposto sostanziale della sua
esclusione dalla comunione.
Sicché l’eventuale inesistenza di quel presupposto potrà essere comunque oggetto di
una successiva azione di accertamento, pur nei
limiti dell’efficacia probatoria che l’intervento
adesivo avrà in concreto assunto.
4.5. – Come correttamente ritenuto nella
sentenza impugnata, pertanto, il coniuge non
acquirente può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale
anche rispetto a beni che siano stati acquistati
come personali dall’altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che
il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel
contratto per aderirvi.
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento
Tuttavia, se l’intervento adesivo ex art. 179
comma 2 c.c. assunse il significato di riconoscimento dei già esistenti presupposti di fatto dell’esclusione del bene dalla comunione, l’azione
di accertamento presupporrà la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti in cui è
ammessa dall’art. 2732 c.c. Se invece, come nel
caso in esame, l’intervento adesivo ex art. 179
comma 2 c.c. assunse il significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione del bene, occorrerà accertare
quale destinazione il bene ebbe effettivamente,
indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così manifestati.
E poiché nel caso in esame è indiscusso che
l’immobile, benché acquistato come bene personale, fu in realtà destinato a casa coniugale, il
ricorso è sotto questo aspetto infondato.
5. – Viene allora in considerazione l’ultima
questione posta dal ricorrente principale, quella dell’opponibilità al terzo acquirente in buona fede del sopravvenuto accertamento della
comunione legale sul bene vendutogli.
Come lo stesso ricorrente riconosce, all’azione
proposta a norma dell’art. 184 c.c. è applicabile
la disposizione dell’art. 1445 c.c., che fa salvi gli
effetti della trascrizione della domanda di annullamento anche in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede.
Quella prevista dall’art. 184 c.c. è infatti
un’azione di annullamento (C. cost., n. 311/
1988); e per tutto quanto non diversamente
stabilito dalla norma speciale che la prevede,
deve ritenersi applicabile la disciplina generale
dell’azione di annullamento dei contratti.
L’art. 184 c.c., come l’art. 1445 c.c., si riferisce infatti a un caso di invalidazione dell’atto di
acquisto del terzo per vizio del titolo del suo
dante causa. E non rileva il fatto che il vizio del
titolo del dante causa dipende nel caso dell’art.
184 c.c. da un’azione di accertamento, nel caso
dell’art. 1445 c.c. da altra azione di annullamento.
Sicché deve ritenersi che, salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto
accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede.
Nel caso in esame è indiscusso che il ricorrente trascrisse il suo atto di acquisto il 12 luglio
1991, prima della domanda di annullamento del
contratto proposta il 25 giugno 1996 da R. B.
NGCC 2010 - Parte prima
Famiglia (regime patrimoniale)
È vero che l’attrice aveva già trascritto in data 10 luglio 1991 la sua domanda di accertamento della comunione. Ma come risulta anche dalla sentenza impugnata, quella domanda
fu dichiarata inammissibile il 26 novembre
1994. Sicché la trascrizione non può giovare a
R. B., che ripropose la sua domanda solo il 25
giugno 1996 (Cass., sez. II, 9 gennaio 1993, n.
148).
Ne consegue che il sopravvenuto accertamento dell’appartenenza anche a R. B. del bene acquistato da N. P. può essere opposto al
compratore solo se si dimostri che egli non era
in buona fede.
Ma di tale questione la corte d’appello non
s’è occupata affatto.
Va pertanto accolto sotto questo profilo il ricorso di N. P.
E la sentenza impugnata deve essere cassata
con rinvio, perché il giudice del merito proceda all’accertamento di tale fatto rilevante e
controverso.
Del resto, con il ricorso incidentale condizionato, R. B. censura la sentenza impugnata per
avere appunto omesso l’accertamento della
mancanza di buona fede dell’acquirente. Sicché la sentenza impugnata va cassata anche in
accoglimento del ricorso incidentale. (Omissis)
[Carbone Presidente – Nappi Estensore – Pivetti
P.M. (concl. conf.). – N.P. (avv. Salemi) – R.B. (avv.
Cacopardo)]
Nota di commento: «L’intervento del coniuge
non acquirente all’atto di acquisto di un bene
personale: natura ed effetti. La presa di posizione delle sezioni unite»
I. Il caso
Un marito acquista un immobile per destinarlo all’esercizio della sua attività di libero professionista.
All’atto di compravendita interviene la moglie, la
quale dichiara, d’accordo con il proprio consorte,
che il bene verrà in futuro impiegato dal marito quale studio professionale. In realtà, il cespite viene adibito, sin dal principio, a casa coniugale. Intervenuta
la separazione personale tra i coniugi, la moglie reclama la caduta in comunione del bene e chiede
l’annullamento del negozio di vendita con il quale il
marito, dopo l’acquisto, aveva alienato l’immobile
ad un terzo.
253
Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento
La risposta da attribuire al quesito concernente la
reale titolarità in capo agli sposi del cespite compravenduto dipende dalla portata e dal valore conferiti
alla partecipazione del coniuge non agente all’atto
di acquisto di un bene personale compiuto, manente
communione, dal proprio consorte. I vari orientamenti sul punto possono riassumersi nell’alternativa
tra la natura negoziale dell’intervento, espressa nel
consenso del coniuge non acquirente all’esclusione
del cespite dalla comunione, e la partecipazione non
negoziale a contenuto dichiarativo.
Con la sentenza in commento, le sezioni unite
della Supr. Corte, dirimendo un contrasto che da
almeno vent’anni vedeva contrapposte queste due
ricostruzioni giuridiche, hanno accolto l’opinione
da ultimo citata, optando per la natura non negoziale dell’intervento del coniuge non acquirente. Hanno, di conseguenza, ritenuto che
l’immobile acquistato dal marito sia entrato in comunione ed è stato, quindi, affermato che all’azione di annullamento, proposta dalla moglie a norma
dell’art. 184 cod. civ., è applicabile la disposizione
di cui all’art. 1445 cod. civ. che fa salvi gli acquisti
compiuti dai terzi in buona fede, sicché deve ritenersi che il sopravvenuto accertamento della comunione legale non sia a loro opponibile. Infine, sebbene in un obiter dictum, la Corte di cassazione
sembra aver lasciata aperta la possibilità per una
maggiore incisione dell’autonomia negoziale nei
rapporti patrimoniali tra coniugi attraverso lo strumento del rifiuto del coacquisto.
II. Le questioni
1. Natura e portata della partecipazione
del coniuge non acquirente all’atto di acquisto. Centrale, nel ragionamento della Corte, risulta essere il problema concernente la natura giuridica da attribuire alla partecipazione all’atto di
acquisto del coniuge non acquirente. Come è noto,
secondo l’opinione tradizionale, ai sensi dell’art.
179 cod. civ., al di fuori dei casi di cui alle lett. a),
b) ed e), tre sono le condizioni affinché possa darsi
luogo ad una deroga al principio secondo cui tutti
gli acquisti immobiliari effettuati dai coniugi durante il matrimonio cadono in comunione: il bene deve
avere i requisiti oggettivi di cui alle lett. c), d) ed f)
del comma 1o (deve, cioè, essere un bene di uso
strettamente personale, un bene necessario all’esercizio della professione ovvero un bene acquistato
con il prezzo del trasferimento o lo scambio di un
altro bene personale), l’esclusione dal patrimonio
comune deve risultare dall’atto di acquisto ed, infine, l’altro coniuge deve essere «parte» del negozio
traslativo. Per comprendere appieno la portata di
quest’ultimo requisito, occorre tenere a mente la ra254
Famiglia (regime patrimoniale)
tio ispiratrice della disposizione di cui all’art. 179
cod. civ.
La comunione legale è il risultato del contemperamento di due interessi: l’interesse alla libertà negoziale e quello alla parità patrimoniale dei coniugi.
Avrebbe ripugnato ai più un sistema nel quale a ciascun consorte non fosse stata concessa la possibilità
di gestire in modo indipendente il proprio patrimonio. Il legislatore ha voluto riconoscere un ruolo
fondamentale alla dimensione individuale di ciascuno sposo all’interno della famiglia, tutelando con il
disposto in questione il coniuge acquirente, il quale
non si è visto così spogliato della possibilità di essere
titolare di autonomi rapporti giuridici. Pertanto,
l’analisi ermeneutica volta ad individuare l’esatta natura da attribuire alla partecipazione del coniuge
non agente non può non tenere conto della precipua
funzione che assolve il disposto in questione. Essa
conduce, quindi, preliminarmente, a rigettare l’opinione di quanti assegnano all’intervento adesivo una
natura negoziale, sulla considerazione che il coniuge
non acquirente sia chiamato ad esprimere una propria volontà e, precisamente, il proprio consenso all’estromissione del bene dalla comunione. Invero,
questa impostazione condurrebbe ad un esito incompatibile con la citata ratio dell’art. 179 cod. civ.,
poiché farebbe dipendere la possibilità per uno sposo di effettuare un acquisto personale, pur in presenza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma, da
un atto discrezionale (il consenso) del proprio partner, con ciò privandolo di qualsiasi autonomia di gestione in ordine ai beni che gli appartengono in modo esclusivo. Invero, a ben vedere, l’eventuale mancato consenso del coniuge non agente non potrebbe
nemmeno essere superato da un accertamento giudiziale successivo, il quale risulterebbe impossibile
se il coniuge di cui vuole escludersi il coacquisto fosse davvero chiamato a dichiarare una volontà negoziale.
Per le medesime ragioni sembra, poi, sia da respingere anche la tesi di chi ha attribuito una natura
«mista» all’intervento adesivo, distinguendo il caso
in cui la partecipazione venga richiesta al fine di riconoscere la personalità dell’acquisto effettuato in
base alle lett. c) e d), da quello in cui riguardi la fattispecie di cui alla lett. f). Nelle prime due ipotesi,
l’intervento del coniuge assumerebbe carattere negoziale, dato che la destinazione a carattere personale (per uso strettamente personale o professionale)
sarebbe sempre e necessariamente artificiale, voluta
e tutt’altro che inevitabile (Corsi, 115, infra, sez.
IV); mentre solo nel caso in cui operi un acquisto
per surrogazione, l’intervento del coniuge avrebbe
natura meramente ricognitiva. Tuttavia, anche questa ricostruzione, configurando (ancorché solo in
parte) l’intervento adesivo quale dichiarazione avenNGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento
te un contenuto volitivo, ripresenta le medesime incompatibilità con il principio di libertà negoziale
poc’anzi analizzate.
Escluso, quindi, che il coniuge non agente possa
essere chiamato a prestare un vero e proprio consenso all’estromissione del cespite dal patrimonio
comune, non resta che attribuire – come correttamente hanno ritenuto le sezioni unite – una natura
non negoziale a tale partecipazione, la quale quindi
rappresenta una dichiarazione di scienza a carattere
ricognitivo od, al più, confessorio. In quest’ultimo
caso, maggiore sarebbe la rilevanza probatoria e
processuale della medesima in quanto la confessione
sarebbe revocabile unicamente nei limiti in cui ciò è
ammesso dall’art. 2732 cod. civ.
Stante tale approdo interpretativo, la Corte di
cassazione ne ha tratto due importanti corollari: in
primo luogo, la partecipazione del coniuge non
agente non può essere considerata condizione sufficiente a determinare l’esclusione dalla comunione
del bene acquistato, in ragione del carattere non negoziale dell’intervento, il quale si limita a dare testimonianza della presenza di fatti giuridici indipendenti dal volere dei coniugi (i cc.dd. requisiti oggettivi della fattispecie); secondariamente, la dichiarazione adesiva concorre, assieme alla natura effettivamente personale del bene, a determinare paritariamente il mancato coacquisto del cespite a favore
degli sposi. Ad opinione delle sezioni unite, dunque,
la partecipazione dell’altro coniuge configura un elemento costitutivo della fattispecie, rappresentando
una condizione necessaria ma non sufficiente a determinare un acquisto personale. Pertanto, da un lato,
nonostante l’intervento adesivo, il coniuge non acquirente potrebbe proporre una successiva domanda di accertamento della caduta in comunione anche rispetto a beni che sono stati dichiarati da entrambi gli sposi (scientemente quanto falsamente)
come personali; dall’altro lato, viceversa, in assenza
della anzidetta partecipazione, pur in presenza degli
elementi di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1o
dell’art. 179 cod. civ., il cespite entrerebbe nel patrimonio comune ed al coniuge agente non resterebbe
che esperire una successiva azione di accertamento
giudiziale, avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti oggettivi, per ottenere l’estromissione del bene
personale dalla comunione.
Ad opinione di chi scrive tale impostazione non
sembra convincere del tutto. Premesso come non
possa negarsi all’intervento in questione una natura
meramente ricognitiva (pena un’inammissibile limitazione della libertà negoziale dei coniugi), esso produrrà, quale unico effetto, quello di ab onere probandi relevare, ma non avrà diretta incidenza sulla
attuale inclusione o meno del cespite nel patrimonio
comune. In altri termini, il bene, da un punto di viNGCC 2010 - Parte prima
Famiglia (regime patrimoniale)
sta sostanziale, diverrà in ogni caso personale al momento dell’acquisto qualora sussistano i presupposti
oggettivi, di cui alle lett. c), d) ed f), ed il coniuge acquirente renda la dichiarazione di cui all’art. 179,
comma 1o, cod. civ. L’eventuale partecipazione adesiva avrà il solo effetto di invertire l’onere della prova nell’ipotesi in cui il coniuge non acquirente, che
non sia stato parte dell’atto di acquisto, adisca successivamente l’autorità giudiziaria per accertare la
natura comune del cespite acquistato dal proprio
partner. Diversamente opinando ed imponendo
dunque al coniuge agente di intraprendere, prima
della stipula del negozio traslativo, un lungo giudizio civile volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 179, comma 1o, cod. civ., si impedirebbe, di fatto, a quest’ultimo di procedere ad un
acquisto personale e si concederebbe, quindi, surrettiziamente, all’altro consorte un illogico potere di
veto sulle scelte personali del coniuge.
Non si deve poi dimenticare che il bene personale
caduto in comunione, in seguito all’immotivato rifiuto dell’altro coniuge di partecipare all’atto, soggiacerebbe alle regole ed alle garanzie previste per
l’amministrazione dei cespiti facenti parte del patrimonio comune con ciò determinandosi due incresciose conseguenze: per un verso, il coniuge unico
vero titolare del bene dovrebbe, per poterne disporne, negoziare e chiedere il consenso al proprio consorte (il quale, in realtà, si badi, non avrebbe alcun
diritto sullo stesso); per altro verso, il cespite potrebbe essere aggredito dai creditori della comunione, con preferenza rispetto ai creditori personali del
coniuge acquirente. Infine, si pensi al caso limite in
cui il coniuge non agente venga autorizzato dal giudice, ai sensi dell’art. 181 cod. civ., a disporre del
bene nell’interesse della famiglia, prima che sia
avanzata la domanda giudiziale per l’accertamento
della natura non comune del cespite, con ciò privando inopinatamente il proprio consorte di un bene
che, in realtà, appartiene unicamente a questi. Pertanto, un rimedio che operi a posteriori non sembra
offrire un’adeguata tutela al coniuge acquirente.
La soluzione qui prospettata sembra peraltro essere avvalorata, su di un piano sistematico, anche
dal combinato disposto degli artt. 179, comma 2o, e
210 cod. civ. Infatti, secondo quest’ultima disposizione, i beni indicati nelle lett. c) e d) dell’art. 179
cod. civ. non possono essere ricompresi nella comunione convenzionale, imponendo così un limite inderogabile all’ampliamento dell’oggetto della comunione. Non si vede, quindi, come potrebbe essere
consentito ad un coniuge di far rientrare nel patrimonio comune un cespite personale ai sensi delle
lett. c) e d), appartenente all’altro consorte, attraverso il semplice rifiuto di partecipare all’atto di acquisto, nonostante sussista in capo al singolo coniuge
255
Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento
un diritto perfetto alla titolarità esclusiva dei beni
indicati ex lege come personali. Pertanto, sul piano
sostanziale, il bene deve essere considerato personale, in presenza dei presupposti oggettivi, a prescindere dall’intervento adesivo dell’altro coniuge.
Prevenendo un’obiezione che potrebbe essere
mossa a tale ricostruzione, va, tuttavia, rilevato come la soluzione proposta possa assurgere a paradigma tipico del fenomeno discratico tra teoria e prassi
che sovente si riscontra nelle ricostruzioni giuridiche. Infatti, sebbene il mancato intervento non impedisca la personalità dell’acquisto, è d’uopo distinguere tra effetti che si producono sul piano sostanziale e quelli che si riverberano nei confronti dei terzi. In quest’ultimo caso, infatti, ci si deve interrogare
se il coniuge acquirente, nonostante il rifiuto opposto dal partner di partecipare all’atto di compravendita, possa comunque far trascrivere l’acquisto del
bene a proprio favore ex art. 2647 cod. civ. ovvero,
come sembra accada nella prassi, se gli sarà preclusa
tale possibilità nell’ipotesi in cui non venga allegata
la dichiarazione del coniuge non agente. Il dubbio è,
infatti, che la solenne esistenza di tutti i requisiti formali previsti dall’art. 179 cod. civ. sia considerata,
dalla Conservatoria dei registri immobiliari (ora
Agenzia del Territorio), un presupposto necessario
ed imprescindibile per ottenere la trascrizione del
negozio traslativo ai sensi e per gli effetti dell’art.
2647 cod. civ.
Sulla base di queste premesse, va, infine, dato
conto di un’ultima questione sollevata dalla Corte di
cassazione riguardante la natura della partecipazione del coniuge non acquirente nel caso in cui egli
esprima una mera condivisione dell’intento del proprio consorte di destinare alla propria attività personale (o ad un uso strettamente personale), successivamente all’atto di compravendita, il bene oggetto
del negozio traslativo. In tale ipotesi, infatti, rilevano
le sezioni unite, la dichiarazione del coniuge non
agente non potrebbe essere ricognitiva di una situazione di fatto già concretizzatasi. La natura meramente descrittiva della partecipazione adesiva si riscontrerebbe unicamente nel caso in cui il corrispettivo dell’acquisto compiuto dall’altro coniuge venga
pagato, ai sensi dell’art. 179, comma 1o, lett. f), con
il prezzo del trasferimento di altri beni già personali
ovvero nel caso in cui l’immobile compravenduto
sia già destinato dal coniuge ad un uso personale o
professionale (in quanto, ad esempio, già detenuto
in locazione). Al di fuori di queste ipotesi, invece, in
presenza dei requisiti di cui alle lett. c) e d), la Supr.
Corte ha rilevato come l’intervento adesivo assumerebbe il significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione del bene e
risulterebbe, quindi, necessario effettuare un’indagine successiva circa la reale destinazione attribuita al
256
Famiglia (regime patrimoniale)
cespite, a prescindere dall’esame sulla sincerità degli
intenti manifestati, per verificare la caduta o meno
del bene nel patrimonio comune. Invero, per definizione, le dichiarazioni di scienza, proprio perché
hanno lo scopo di provare l’esistenza di fatti giuridici, implicano un momento accertativo di una situazione di fatto preesistente al tempo in cui esse vengono compiute; talché possono essere rese a condizione che abbiano ad oggetto situazioni fattuali ad
esse antecedenti che siano predicabili di verità o falsità. Viceversa, una dichiarazione di futuri intenti
non potrebbe assurgere a dichiarazione di scienza
poiché essa non può attestare l’avvenuta verificazione di fatti che, in realtà, sono presenti, in quel momento, esclusivamente nella mente di chi effettua la
dichiarazione adesiva. In una situazione come quella
descritta, quindi, a detta delle sezioni unite, l’intervento del coniuge non agente non può avere natura
confessoria (né ricognitiva) e solamente la reale, futura sussistenza dei requisiti di cui alle lett. c) e d)
dell’art. 179, comma 1o, cod. civ., dichiarati concordemente dai coniugi nell’atto di acquisto, consentirà
l’esclusione del bene dal patrimonio comune.
2. Azione di annullamento proposta a norma dell’art. 184 cod. civ. e sorte degli acquisti compiuti dai terzi. Con la decisione in commento, le sezioni unite riducono lo iato esistente tra
la normativa generale stabilita in tema di annullamento e la disciplina del diritto di famiglia, prescrivendo che, salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento del carattere
comune di un bene non è opponibile, ai sensi dell’art. 1445 cod. civ., al terzo acquirente di buona fede a titolo oneroso del bene medesimo.
Il principio espresso dalla Supr. Corte, nella sentenza succintamente motivato, muove dalla considerazione che, come a suo tempo stabilito dalla Corte
cost. (Corte cost., 10.10.1988, n. 311, infra, sez.
III), l’azione proposta a norma dell’art. 184 cod. civ.
è un’azione di annullamento e, pertanto, ad essa deve applicarsi la disciplina generale posta in materia
contrattuale. A nulla, quindi, rileva – a detta delle
sezioni unite – che, nel caso in esame, il vizio del titolo del dante causa, che giustifica il rimedio dell’invalidazione del negozio, origini da un’azione di accertamento, mentre nel caso di cui all’art. 1445 cod.
civ. dipenda da altra azione di annullamento. Di
conseguenza, deve considerarsi come la peculiarità
della normativa posta in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi non impedisca di ritenere che, anche nella comunione legale, il terzo acquirente di un
bene comune, sulla base di un negozio di compravendita stipulato con uno solo dei coniugi, poi annullato su istanza dell’altro, faccia salvo il suo acquisto qualora sia in buona fede.
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento
In ragione della sinteticità della pronuncia, per
comprendere appieno il ragionamento seguito dai
giudici di legittimità, spetta all’interprete il compito
di ricostruire le premesse logico-giuridiche, parzialmente inespresse nella motivazione, fondanti la statuizione della Supr. Corte. A tal fine, appare preliminarmente opportuno delineare i limiti della fattispecie in esame: l’interrogativo che occorre risolvere
concerne la sorte degli atti dispositivi, compiuti da
uno solo dei coniugi, riguardanti beni la cui appartenenza comunitaria non sia stata adeguatamente
pubblicizzata in ragione della loro trascrizione come
personali (pur essendo, in realtà, comuni). In tali
ipotesi, prima di agire per l’annullamento dell’atto
dispositivo del bene compiuto dal proprio consorte,
il coniuge pretermesso dovrà, pregiudizialmente, far
«invalidare» la propria dichiarazione di assenso che,
a norma dell’art. 179, lett. f), ha consentito la trascrizione del cespite come personale e dovrà, quindi, instaurare un giudizio volto all’accertamento dell’inesistenza dei requisiti oggettivi di cui all’art. 179 cod.
civ. Naturalmente, se il titolo di acquisto del terzo è
stato trascritto successivamente alla domanda di annullamento, questi non potrà validamente opporre
al coniuge il proprio acquisto, anche se in buona fede, ai sensi degli artt. 2652, n. 6 e 2690, n. 3, cod.
civ.
Circoscritto così l’ambito di indagine, venendo al
nucleo centrale della questione posta a monte del
ragionamento seguito dai giudici di legittimità, va rilevato come, in virtù della previsione di cui all’art.
1445 cod. civ., è stata prevista una tutela a favore di
colui che, in buona fede, vede venire meno il proprio acquisto a titolo oneroso a causa della successiva caducazione degli effetti del negozio di provenienza del cespite compravenduto. Per regola generale, a seguito dell’accertamento del vizio (che cagiona l’annullamento) della fattispecie negoziale acquisitiva del bene da parte del suo dante causa, il
terzo dovrebbe perdere l’acquisto con effetti retroattivi. Tuttavia, la norma di cui all’art. 1445 cod.
civ. rende a lui inopponibile questo effetto nel caso
in cui, incolpevolmente, ignori la causa di annullamento del contratto intercedente tra il suo dante
causa e l’avente causa di quest’ultimo. Nel conflitto
tra esigenze di protezione dell’autonomia contrattuale ed esigenze di sicurezza nella circolazione dei
beni, la legge dunque sacrifica le prime e protegge le
seconde.
L’interrogativo che si sono poste le sezioni unite
riguarda la possibilità di applicare tale principio anche in relazione all’azione di annullamento, stabilita
dall’art. 184 cod. civ. a favore di colui che contrae
col singolo coniuge in seguito all’avvenuto accertamento del carattere non personale del bene. Ad una
prima analisi, una simile soluzione potrebbe ritenerNGCC 2010 - Parte prima
Famiglia (regime patrimoniale)
si inammissibile in ragione del fatto che nell’art. 184
cod. civ. verrebbe disciplinata un’ipotesi di annullamento di un negozio stipulato tra un coniuge ed un
soggetto che, in senso tecnico-giuridico, non può essere considerato «terzo» rispetto al contratto annullato. Si potrebbe inferire, infatti, che l’art. 1445 cod.
civ. appronti una peculiare tutela unicamente a dei
soggetti che sono estranei al negozio annullato e,
cioè, ai terzi aventi causa da colui che ha contrattato
col coniuge non legittimato.
Tuttavia, a ben vedere, un punto in comune tra le
due fattispecie è rinvenibile ed è dato dalla comune
perdita del cespite compravenduto in capo ad un
soggetto (rappresentato dal «terzo» nell’art. 1445 e
dalla parte che contrae col singolo sposo nell’art.
184), in ragione della ridefinizione degli effetti dell’atto di provenienza del bene acquistato dal suo
dante causa. Invero, sia nelle ipotesi di annullamento poste in tema di contratti, sia in quella prevista all’interno dei rapporti patrimoniali tra coniugi, si assiste all’accertamento di un difetto nel titolo di colui
che ha trasferito il diritto che fa venir meno, con effetti generalmente retroattivi, l’acquisto del cespite a
danno di un altro soggetto che con questi ha contrattato. In altri termini, in entrambi i casi, il terzo
subisce una caducazione degli effetti dell’atto di origine della res acquistata, vuoi per un vizio di un elemento della fattispecie negoziale (si pensi alla disciplina stabilita in tema di errore, violenza o dolo),
vuoi per l’avvenuto accertamento dell’appartenenza
del bene al patrimonio comune degli sposi. Pertanto, poiché gli artt. 184 e 1445 cod. civ. regolano casi
di invalidazione dell’atto di acquisto del terzo per
un vizio del titolo del suo dante causa, ad opinione
della Supr. Corte, l’acquirente del bene che appare
come personale farà salvo il suo acquisto se era in
buona fede, ai sensi dell’art. 1445 cod. civ., salvi gli
effetti della trascrizione della domanda, la quale –
per un parallelismo di disciplina – sarà quella di accertamento dell’appartenenza comunitaria del cespite.
Attraverso tale approdo interpretativo, la Corte di
cassazione ha, quindi, in ultima analisi, di fatto stabilito un’ulteriore condizione, oltre al limite temporale annuale, affinché possa proporsi l’azione di cui
all’art. 184 cod. civ. nell’ipotesi di avvenuto accertamento del carattere comune di un bene: la buona fede del contraente acquirente. Si è giunti, così, in via
ermeneutica, alla creazione di una regola di «diritto
giurisprudenziale» che, in materia coniugale, non
trova testuale riscontro nel dato letterale codicistico.
3. L’obiter dictum delle sezioni unite: un
nuovo spiraglio per il riconoscimento della
figura del rifiuto del coacquisto? È risaputo
che gli obiter dicta presenti nelle sentenze non pos257
Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento
sono assurgere alla dignità di veri e propri argomenti giuridici, posto che essi rappresentano delle mere
affermazioni parentetiche prive di reale rilevanza argomentativa. Tuttavia, è parimenti noto che gli obiter dicta costituiscono anche il sintomo di un disagio
psicologico in colui che scrive poiché essi tradiscono
una volontà di intervento ulteriore rispetto al ristretto ambito della causa, intervento che – proprio perché estraneo al thema decidendi – non può essere
svolto se non in un inciso argomentativo che, per
sua stessa natura, potrebbe essere espunto dal testo
della sentenza senza che, per tale ragione, ne risenta
il complessivo iter logico.
Orbene, appare evidente che, anche nella statuizione giurisdizionale in commento, sia possibile rinvenire un obiter dictum di particolare rilevanza che
offre la possibilità all’interprete, almeno così ci sembra, di trovare uno spiraglio per discorrere in termini positivi del c.d. rifiuto del coacquisto. Si tratta di
una figura non espressamente prevista dal legislatore che permette di individuare un’ulteriore categoria
di beni personali, oltre a quelli elencati dall’art. 179
cod. civ., i quali, pur in presenza dei requisiti di cui
all’art. 177 cod. civ., tali da farli rientrare astrattamente in comunione, non ricadono in concreto in
essa per effetto di una espressa manifestazione di
volontà resa dal coniuge beneficiario con la quale
egli rifiuta il coacquisto dei suddetti beni, consentendone così l’acquisto personale da parte del proprio consorte.
Tale fattispecie va tenuta nettamente distinta dalla pur simile ipotesi di esclusione dal patrimonio
comune di beni personali regolata dall’art. 179 cod.
civ. Invero, mentre in quest’ultimo caso, come si è
detto, la partecipazione del coniuge non acquirente, attesa la sua natura ricognitiva, è diretta unicamente a riconoscere che il bene acquistato dal consorte appartiene alle categorie oggettive di cui alle
lett. c), d) ed f), col rifiuto del coacquisto il coniuge
non agente esprime un vero e proprio consenso all’esclusione del bene dal patrimonio comune proprio perché non può operare il meccanismo di cui
all’art. 179 cod. civ., non ricorrendone le circostanze obiettive ivi previste. Parimenti, anche la ratio
che sorregge tali due previsioni differisce sensibilmente sotto il profilo degli interessi protetti. Da un
punto di vista funzionale, infatti, la dichiarazione
adesiva mira a tutelare il coniuge acquirente che
non si vedrà privato della possibilità di essere titolare di autonomi rapporti giuridici anche qualora il
partner rifiuti di partecipare al negozio traslativo.
Viceversa, l’atto di rifiuto è posto nell’esclusivo interesse del coniuge non acquirente, il quale non
può essere costretto, contro la propria volontà, a
subire un incremento della propria sfera giuridica
patrimoniale, (co)acquistando un bene che, in con258
Famiglia (regime patrimoniale)
creto, potrebbe portare ad esiti per lui sfavorevoli.
Ciò premesso, non v’è dubbio che le sezioni unite, nella sentenza annotata, hanno avuta ben chiara
la distinzione testé delineata. Esse, infatti, dopo aver
correttamente escluso che l’art. 179 cod. civ. possa
essere impiegato dai coniugi per estromettere un bene dalla comunione in assenza dei requisiti oggettivi
di cui al comma 1o del disposto anzidetto, hanno affermato che «certo, potrebbe anche ritenersi che una
tale facoltà debba essere riconosciuta ai coniugi per ragioni sistematiche, indipendentemente da un’espressa
previsione legislativa. Come potrebbe ritenersi che,
dopo Corte cost., n. 91/1973, non possa negarsi a ciascun coniuge il diritto di donare anche indirettamente
all’altro la proprietà esclusiva di beni non personali.
Tuttavia tali facoltà non potrebbero affatto desumersi
dall’art. 179, comma 2o, cod. civ., che condiziona comunque l’effetto limitativo della comunione alla natura realmente personale del bene».
Si tratta, a ben vedere, di una presa di posizione
che pare abbracciare la tesi poc’anzi accennata attraverso il riconoscimento, ancorché implicito, della possibilità per ciascuno sposo di poter, in ogni
caso, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 179 cod.
civ., impedire la caduta nel patrimonio comune di
un bene. Con tale obiter dictum, la Supr. Corte basa la (asserita) legittimità della figura del rifiuto del
coacquisto su (non meglio specificate) «ragioni sistematiche». Spetta, quindi, all’interprete il compito di individuarle. Ebbene, sembra che queste non
possano che fondarsi su due argomentazioni: da un
lato, sull’esistenza del principio generale espresso
dal brocardo latino nemo invitus locupletari potest,
in base al quale il nostro ordinamento fa sempre
salva la possibilità di rifiutare l’effetto incrementativo, determinato da una volontà altrui, incidente
sul patrimonio di un terzo (si pensi, a tal proposito, alla disciplina prevista in tema di legato, di remissione del debito, di contratto a favore di terzi o
con obbligazioni a carico solo proponente, et cetera, ove al destinatario dell’attribuzione patrimoniale è sempre consentito di opporre un rifiuto); dall’altro lato, sulla prevalenza delle ragioni dell’autonomia negoziale su quelle di matrice pubblicistica
che taluni assegnano all’istituto della comunione
legale.
A tal proposito, preme sottolineare come – ad
opinione dello scrivente – anche all’interno delle
norme disciplinanti il regime di comunione legale
abbia vigenza non solo il principio dell’intangibilità
della sfera giuridica patrimoniale ma anche quello
dell’autonomia privata, di cui l’atto di rifiuto è
espressione. Non sussistono, invero, valide ragioni
per assegnare al sistema comunitario un qualsivoglia
valore pubblicistico che trascenda la dimensione individuale di ciascuno sposo. Infatti, il regime di coNGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento
munione legale non è stato posto per offrire tutela al
coniuge ritenuto generalmente «debole», prevedendo un sistema di retribuzione indiretto della donna
nella famiglia, atteso che, se così davvero fosse, si sarebbe dovuto introdurre un regime differenziato per
l’ipotesi in cui entrambi gli sposi svolgano un’attività produttiva da quella in cui la moglie si dedichi
unicamente ad un lavoro domestico. Né, tanto meno, può ritenersi che col sistema comunitario sia stata data attuazione al modello di famiglia accolto dalla Costituzione, rispondendo ai valori tutelati dall’art. 29 (uguaglianza dei coniugi ed unità della famiglia). In realtà, così ragionando, si arriverebbe all’inaccettabile conclusione di avere una parte della
popolazione (quella che ha scelto il regime di comunione) che vive nel rispetto della Carta costituzionale ed un’altra (quella che, per i più svariati motivi, ha
ripudiato tale sistema) che, per converso, si colloca
al di fuori della Costituzione.
Appare evidente come la parità giuridica tra coniugi non sempre sia accompagnata da una parità
che si esplichi anche patrimonialmente, atteso che i
coniugi possono, d’accordo tra loro, optare per il regime della separazione dei beni. La radicale derogabilità del sistema comunitario impedisce, quindi, di
attribuire qualsivoglia valore pubblicistico allo stesso. Con ciò non si nega che la riforma del diritto di
famiglia non abbia tentato di perseguire l’obiettivo
di raggiungere un’uguaglianza morale e giuridica tra
i coniugi, ma per l’attuazione di tale scopo sono stati
posti altri istituti, tutti attinenti al cosiddetto regime
primario della famiglia, previsto dagli artt. 143 ss.
cod. civ., che non casualmente è assistito dalla inderogabilità stabilita dall’art. 160 cod. civ. (si pensi, ad
esempio, agli obblighi di contribuzione ai bisogni
della famiglia e di assistenza materiale tra gli sposi o
ai doveri verso i figli). Come può facilmente evincersi, quindi, la problematica del rifiuto del coacquisto
pone in discussione ed innerva valori generali, quali
l’autonomia dei privati o il controllo pubblico sulla
persona nella formazione sociale primigenia, che in
ultima analisi sono espressione dell’idea personale
dell’interprete circa il senso della famiglia e del matrimonio e, più in generale, circa il ruolo dell’individuo e della sua libertà nella società, il quale rappresenta l’elemento primario di esegesi delle norme e di
formazione dei concetti atti a permettere un’analisi
sistematica dell’intera materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
III. I precedenti
1. Natura e portata della partecipazione
del coniuge non acquirente all’atto di acquisto. In una sua prima fase, la giurisprudenza di
legittimità ha ritenuto che la dichiarazione adesiva
NGCC 2010 - Parte prima
Famiglia (regime patrimoniale)
del coniuge non acquirente, resa ai sensi dell’art.
179, comma 2o, cod. civ., avesse natura negoziale:
v. Cass., 2.6.1989, n. 2688, in questa Rivista, 1999,
I, 22. Tale impostazione non ha però trovato seguito nelle decisioni successivamente assunte sia dalle
Corti di merito che dalla Corte di cassazione che
hanno optato per la natura confessoria (o, comunque, ricognitiva) della partecipazione del coniuge
non agente: v. Trib. Piacenza, 9.4.1991, in Riv.
notar., 1993, 119; Trib. Parma, 21.1.1994, in Fam.
e dir., 1994, 310; Cass., 19.2.2000, n. 1917, in Foro
it., 2000, I, 2247; Cass., 27.2.2003, n. 2954, in Riv.
notar., 2003, 411; Cass., 24.9.2004, n. 19250, in Familia, 2005, 580.
In una posizione non del tutto dissimile da quella
da noi prospettata, cfr. Cass., 8.2.1993, n. 1556, in
Giust. civ., 1993, I, 2415; Cass., 18.8.1994, n. 7437,
in questa Rivista, 1995, I, 551, secondo le quali, nel
caso di beni acquistati con la permuta di altri beni
personali, è del tutto irrilevante che, in mancanza
dell’altro coniuge, nell’atto venga omessa la dichiarazione bilaterale di esclusione, essendo questa necessaria solo quando è obiettivamente incerto se
l’acquisto realizzi o meno il reinvestimento di denaro o di beni personali.
2. Azione di annullamento proposta a norma dell’art. 184 cod. civ. e sorte degli acquisti compiuti dai terzi. Sulla applicabilità anche in
tema di comunione legale della disciplina prevista
dall’art. 1445 cod. civ. nell’ipotesi di annullamento
del negozio di acquisto, proposta dal coniuge pretermesso ai sensi dell’art. 184 cod. civ., non si rinvengono precedenti degni di nota della Supr. Corte.
Quanto ai rilievi inerenti alla singolarità dell’istituto previsto dall’art. 184 cod. civ. ed alla sua consequenziale specialità di disciplina, v. Cass., 27.10.2003,
n. 16099, in questa Rivista, 2005, I, 68.
Sulla natura dell’azione di annullamento proposta dal coniuge extraneus v. Corte cost.,
10.10.1988, n. 311, in Foro it., 1990, I, 2146; Cass.,
21.12.2001, n. 16177, in Riv. notar., 2002, 976;
Cass., 2.2.1995, n. 1252, in Corr. giur., 1995, 6,
719; Cass., 17.12.1994, n. 10872, in questa Rivista,
1995, I, 889.
3. L’obiter dictum delle sezioni unite: un
nuovo spiraglio per il riconoscimento della
figura del rifiuto del coacquisto? A favore
della legittimità nel nostro ordinamento della figura
del rifiuto del coacquisto, l’unico precedente della
giurisprudenza di legittimità è rappresentato da
Cass., 2.6.1989, n. 2688. Invece, in senso conforme
alla sentenza annotata, v. Trib. Piacenza, 9.4.1991;
Trib. Parma, 21.1.1994; Cass., 19.2.2000, n. 1917;
Cass., 27.2.2003, n. 2954; Cass., 24.9.2004, n.
19250.
259
Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento
IV. La dottrina
1. Natura e portata della partecipazione
del coniuge non acquirente all’atto di acquisto. Con riferimento al tema della natura della
partecipazione adesiva, non molti sono gli aa. che
assegnano alla stessa una valenza negoziale: v. Detti, Oggetto, natura, amministrazione della comunione legale dei coniugi, in Riv. notar., 1976, I, 170; Finocchiaro, Permuta di beni personali e omessa dichiarazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 179
cod. civ. Pretesa irrilevanza, nota a Cass., 8.2.1993,
n. 1556, in Giust. civ., 1993, I, 2429; Tamborlini,
La trascrizione dell’acquisto «separato» del coniuge,
in Riv. notar., 1977, II, 1042.
Attribuisce natura «mista» all’intervento Corsi,
Il regime patrimoniale della famiglia, nel Trattato Cicu-Messineo, VI, Giuffrè, 1979, 108 ss.
La dottrina maggioritaria è, invece, dell’avviso
che l’anzidetta partecipazione abbia valore ricognitivo o, al più, confessorio: v. Patti, Il cosiddetto rifiuto del coacquisto alla luce della sentenza n. 2954/
2003, in Riv. notar., 2003, 575 ss.; Regine, Acquisto di beni personali e ruolo dell’art. 179, comma secondo c.c., in questa Rivista, 2001, I, 20 ss.; Pitrone, La natura giuridica della partecipazione del coniuge all’acquisto di un bene personale, in Rass. dir.
civ., 1989, 824 ss.; Gabrielli, Scioglimento parziale
della comunione legale fra coniugi, esclusione della
comunione di singoli beni e rifiuto preventivo del
coacquisto, in Riv. dir. civ., 1988, I, 362; De Paola,
Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del
diritto privato, II, Il regime patrimoniale della famiglia, Giuffrè, 1995, 588; Radice, I beni personali,
nel Trattato Bonilini-Cattaneo, II, Utet, 1997, 156;
Lo Sardo, Acquisto di beni con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio e dichiarazione di esclusione dalla comunione legale, in
Riv. notar., 1995, 835; Rampolla, L’intervento del
coniuge non acquirente all’atto di acquisto di bene
personale: natura e trascrizione, in Vita not., 1993,
LXIX; Auletta, Diritto di famiglia, La comunione
legale, nel Trattato Bessone, IV, 2, Giappichelli, 222
ss.; Galasso, Regime patrimoniale della famiglia,
nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro
it., 2003, 291.
In una posizione del tutto isolata si pongono
Cian-Villani, La comunione dei beni tra coniugi
(legale e convenzionale), in Riv. dir. civ., 1980, 400
ss., secondo i quali l’art. 179, comma 2o, cod. civ.
troverebbe applicazione solamente nel caso in cui i
coniugi si rendano acquirenti congiuntamente di un
260
Famiglia (regime patrimoniale)
bene immobile o mobile registrato, ai sensi delle
lett. c), d) ed f), legittimamente cointestabile in comunione ordinaria.
Accolgono l’opinione che non assegna alla partecipazione adesiva un valore costitutivo-sostanziale:
Gabrielli, Scioglimento parziale, 362 e in nt. 53;
Rampolla, LXXIV; Lo Sardo, 840; Pitrone, 825.
2. Azione di annullamento proposta a norma dell’art. 184 cod. civ. e sorte degli acquisti compiuti dai terzi. Per una panoramica sulla
natura dell’azione di annullamento ex art. 184 cod.
civ., v. ex multis Ceccherini, Trasferimento di bene
immobile in comunione legale senza il consenso dell’altro coniuge, nota a Cass., 2.2.1995, n. 1252, in
Corr. giur., 1995, 719 ss.; Schlesinger, nel Commentario rif. dir. fam., I, Cedam, 1977, sub art. 184,
423; Corsi, 141; Bianca, Gli atti di straordinaria
amministrazione, in La comunione legale, a cura di
Bianca, Giuffrè, 1989, 603 ss.; Gabrielli, I rapporti patrimoniali tra coniugi, Libreria Goliardica, 1981,
132 ss.
Sul tema dell’applicabilità all’azione prevista dall’art. 184 cod. civ. della disciplina stabilita dall’art.
1445 cod. civ., cfr. Corsi, 152; Galasso, 371; Di
Martino-Rovera, L’amministrazione dei beni, in Il
diritto di famiglia, II, Giuffrè, 2001, 199; Schlesinger, 426.
Da segnalare, infine, Segni, Gli atti di straordinaria amministrazione del singolo coniuge sui beni immobili della comunione, in Riv. dir. civ., 1980, I, 632
ss., per il quale, qualora il cespite comune sia stato
trascritto come personale, l’apparente personalità
del bene non impedirebbe di far valere l’annullabilità di fronte agli acquisti che non siano stati seguiti
da trascrizione e, quindi, in tutti i casi in cui l’atto
sia avvenuto per scrittura privata, atteso che il conflitto tra il coniuge extraneus ed il subacquirente
verrebbe risolto sulla base dell’art. 2652, n. 4, cod.
civ. che fa salvi gli acquisti dei terzi in precedenza
trascritti.
3. L’obiter dictum delle sezioni unite: un
nuovo spiraglio per il riconoscimento della
figura del rifiuto del coacquisto? Per
un’esposizione particolareggiata delle molteplici
opinioni dottrinali esposte in materia, sia consentito
rinviare a Mazzariol, Comunione legale tra coniugi
e rifiuto del coacquisto, in questa Rivista, 2006, II,
487 ss. ed, in particolare, agli aa. citati nelle nt. 30 e
45.
Riccardo Mazzariol
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 22.9.2009, n. 20404
c CASS. CIV., sez. lav., 22.9.2009, n. 20404
Conferma App. Torino, 14.2.2006
Lavoro (rapporto) - Procedimento
disciplinare - Lettera di contestazione - Principio della immediatezza
- Contenuto - Applicabilità nel caso
di una serie di fatti distanti nel tempo che compongono una condotta
unitaria - Decorrenza a partire dall’ultimo dei fatti contestati (cod. civ.,
artt. 2119, 2697; l. 20.5.1970, n. 300, art. 7)
Ove la condotta addebitata al lavoratore
si componga di una serie di fatti da valutare in modo unitario, le contestazioni disciplinari, ai fini della loro immediatezza,
possono seguire l’ultimo dei fatti anche se
posto in essere ad una certa distanza di
tempo da quelli precedenti.
dal testo:
Il fatto. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi
al Tribunale – giudice del lavoro di Asti G.L.
conveniva in giudizio la s.p.a. Sanpaolo Imi
esponendo che, assunto dalla convenuta il 16
aprile 1977 era stato licenziato per giusta causa
in data 22 aprile 2002 e che, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., con ordinanza del 4/8 luglio 2002 il Tribunale di Asti aveva disposto la
sua reintegrazione nel posto di lavoro; chiedeva, quindi, all’adito Giudice del lavoro la conferma del provvedimento ex art. 700 c.p.c., con
condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro, alla corresponsione di un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento
a quello della reintegrazione e al risarcimento
dei danni derivanti dall’omessa effettiva reintegrazione. Si costituiva in giudizio la s.p.a.
Sanpaolo Imi che impugnava integralmente la
domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Asti, con sentenza in data 28 aprile
2005, accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l’illegittimità del licenziamento e
condannando la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli
un’indennità pari alla retribuzione globale di
NGCC 2010 - Parte prima
Lavoro (rapporto)
fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, ma respingendo la domanda di risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall’omessa effettiva reintegrazione. Avverso tale
decisione proponevano appello sia il G. che la
s.p.a. Sanpaolo Imi e la Corte di appello di Torino, con sentenza in data 14 febbraio 2006,
così decideva: “in accoglimento dell’appello di
Sanpaolo Imi s.p.a., respinge le domande proposte da G.L. con il ricorso introduttivo; respinge l’appello proposto da G.L.; condanna
G.L. a rimborsare a Sanpaolo Imi spa le spese
di entrambi i gradi”. Per la cassazione di tale
sentenza G.L. propone ricorso assistito da due
motivi. L’intimato s.p.a. Sanpaolo Imi resiste
con controricorso. Entrambe le parti hanno
depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
I motivi. 1. Con il primo motivo di ricorso il
ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, dell’art.
2119 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione al
principio dell’immediatezza delle contestazioni
ed alla ripartizione degli oneri probatori”. Con
il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia “vizi di motivazione su un fatto decisivo per la risoluzione della controversia”, rilevando, a censura della sentenza impugnata,
che “proprio in merito alla conoscibilità dei
fatti ben prima della contestazione del marzo
2002, nel tentativo di affermare la correttezza
della condotta aziendale e dunque la tempestività della contestazione, la Corte di appello è
caduta in palesi contraddizioni ed ha del tutto
ignorato alcuni elementi di prova (testimoniali
e documentali) che invece avrebbero permesso
una differente lettura dei problemi di causa e
di conseguenza una affatto diversa decisione
sul punto”.
2 – I cennati motivi di ricorso – da valutarsi
congiuntamente in quanto intrinsecamente
connessi – non sono meritevoli di accoglimento.
2/a – Al riguardo, in merito all’asserito
“mancato rispetto del principio della immediatezza della contestazione, si rileva che la Corte
di appello, per ritenere che nella specie fosse
stato rispettato il principio dell’immediatezza,
si è riportata espressamente alla giurisprudenza di questa Corte (e, specialmente, a Cass. n.
3483/2003). In ogni caso la regola in discorso
261
Cass., 22.9.2009, n. 20404
dev’essere intesa tenendo conto delle ragioni
oggettive che possono ritardare la percezione o
il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati, soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di
fatti che, convergendo a comporre un’unica
condotta, esigono una valutazione unitaria: in
tali casi la contestazione può seguire l’ultimo di
questi fatti, anche ad una certa distanza temporale dei fatti precedenti (cfr. Cass. n. 23739/
2008). Nella specie il giudice di merito, nel suo
discrezionale ed in concreto incensurabile apprezzamento di fatti e circostanze, ha posto in
evidenza che: “nella fattispecie è sufficiente
esaminare il contenuto della Lettera di contestazione del 22 marzo 2002 per accorgersi che
gli addebiti si fondano su circostanze di fatto
molto complesse ed articolate che non potevano certo essere apprese se non attraverso le
specifiche indagini effettuate nel corso dell’ispezione del 2002; aggiungendo che non bisogna d’altra parte dimenticare che è principio
consolidato in giurisprudenza quello secondo
il quale la contestazione deve essere precisa e
analitica, in modo da consentire al lavoratore
un adeguato esercizio del diritto di difesa: sicché, non si vede proprio come avrebbe potuto
il Sanpaolo Imi effettuare una contestazione
precisa e analitica (come quella contenuta nella
lettera del 22 marzo 2002) prima degli accertamenti effettuati con l’ispezione del 2002, solo
sulla base dei generici accenni a irregolarità riscontrabili in atti”. Ne deriva la piena legittimità della decisione impugnata in merito alla corretta valutazione nella fattispecie concreta del
principio della immediatezza della contestazione disciplinare.
2/b – Con riferimento, poi, alle censure concernenti l’errata valutazione delle risultanze
probatorie (documentali e testimoniali), vale
rimarcare che la cennata valutazione rientra
nell’attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile anch’essa in Cassazione se non sotto il profilo della congruità
della motivazione del relativo apprezzamento
(Cass. n. 322/2003). Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di
disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo suffi262
Lavoro (rapporto)
ciente, ai fini della congruità della motivazione,
che da questa risulti che il convincimento si sia
realizzato attraverso una valutazione dei vari
elementi processuali acquisiti, considerati nel
loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non
accolti, anche se allegati, purché risulti logico e
coerente il valore preminente attribuito a quelli
utilizzati. Si rileva, altresì, che le censure con
cui una sentenza viene impugnata per vizio
della motivazione in ordine alla valutazione
delle risultanze probatorie non possono essere
intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del
merito al diverso convincimento soggettivo
della parte – pure in relazione al valore da conferirsi alle “presunzioni” la cui valutazione è
anch’essa incensurabile in sede di legittimità
alla stregua di quanto già riferito in merito alla
valutazione delle risultanze probatorie (Cass.
n. 11906/2003) – e, in particolare, non vi si
può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni
all’ambito della discrezionalità di valutazione
degli elementi di prova e dell’apprezzamento
dei fatti, attengono al libero convincimento del
giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della
disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5: in
caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul
fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
2/c – Circa, inoltre le doglianze concernenti
l’asserita inattendibilità del teste G. – la cui deposizione sarebbe stata impropriamente utilizzata nella decisione della Corte territoriale a
preferenza rispetto a quelle (pure asseritamente valutate in modo parziale) di altri testimoni
(C., GA., GI., P.) – questa Corte ha statuito –
con la sentenza n. 21412/2006 a cui vale riportarsi integralmente anche per la relativa parte
motiva – che “il giudizio sull’attendibilità dei
testi e sulla credibilità di alcuni invece che di
altri, come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti
di fatto riservati al giudice del merito, il quale
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 22.9.2009, n. 20404 - Commento
nel porre a fondamento della propria decisione
una fonte di prova con esclusione delle altre,
non incontra altro limite che quello di indicare
le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o
a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati
specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”.
2/d – Con riferimento, infine, alle doglianze
in merito agli asseriti vizi di motivazione – che
inficerebbero la sentenza impugnata – si precisa: – il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto
quando dall’esame del ragionamento svolto dal
giudice e quale risulta dalla sentenza stessa
emerga la totale obliterazione di elementi che
potrebbero condurre ad una diversa decisione
ovvero l’obiettiva deficienza, nel complesso di
essa, del procedimento logico che ha indotto il
giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al
suo convincimento, ma non già, invece, – come
per le censure mosse nella specie dal ricorrente
– quando vi sia difformità rispetto alle attese
ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli
elementi delibati; – il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del
giudice non consentano di ripercorrere l’iter
logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando
nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia
mancato l’esame di punti decisivi della controversia, irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta; – per poter
considerare la motivazione adottata dal giudice
di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al
fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente
che il giudice indichi – come, nella specie,
esaustivamente ha fatto la Corte di appello di
Torino – le ragioni del proprio convincimento,
dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
3 – A conferma della pronuncia di rigetto dei
motivi del ricorso vale riportarsi al principio
enunciato nella sentenza di questa Corte n.
5149/2001 (e, più di recente, da Cass. Sezioni
NGCC 2010 - Parte prima
Lavoro (rapporto)
Unite n. 1497/2007) in virtù del quale, essendo
state rigettate le principali assorbenti ragioni di
censura, il ricorso deve essere respinto nella
sua interezza poiché diventano inammissibili,
per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di
censura.
4 – In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da G.L. deve
essere respinto e il ricorrente, per effetto della
soccombenza, va condannato al pagamento a
favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo. (Omissis)
[Ianniruberto Presidente – Balletti Estensore –
Fedeli P.M. (concl. conf.). – G.L. (avv.ti Nigro,
Berti) – San Paolo Imi s.p.a. (avv. C. Scognamiglio,
R. Scognamiglio)]
Nota di commento: «Illecito disciplinare a condotta plurima e immediatezza della contestazione»
I. Il caso
Un lavoratore impugna il licenziamento e chiede
la reintegrazione nel posto di lavoro, eccependo la
violazione del principio di immediatezza delle contestazioni disciplinari. La sentenza si segnala per
l’affermazione del principio in base al quale ove il
comportamento del lavoratore consista in
una serie di fatti convergenti in una condotta
unitaria, il cui disvalore sul piano disciplinare sia percepibile o comunque accertabile e
valutabile in modo definitivo solamente dopo
l’ultimo dei fatti rilevanti, la contestazione
può validamente seguire tale ultimo fatto anche se posto in essere a distanza di tempo da
quelli precedenti.
II. La questione
L’unica questione affrontata dalla Corte, insieme
all’eccepito difetto di motivazione, concerne l’immediatezza o meno della contestazione disciplinare
seguita dal licenziamento impugnato in sede giudiziale. Com’è noto, l’art. 7 l. 20.5.1970, n. 300, prevede taluni limiti all’esercizio del potere disciplinare
del datore di lavoro, tra cui l’obbligo della contestazione. In particolare, l’articolo citato, al comma 2o,
stabilisce che «il datore di lavoro non può adottare
alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l’addebito e senza averlo sentito a sua discolpa». La
263
Cass., 22.9.2009, n. 20404 - Commento
norma, nella sua formulazione, non prevede un termine entro il quale deve essere fatta la contestazione
disciplinare. In alcuni contratti collettivi è prevista
una integrazione in proposito, ma, con riferimento
alla disciplina legale, la dottrina e la giurisprudenza
hanno affermato che la contestazione deve essere
immediata, in stretta connessione temporale con il
fatto addebitato al dipendente o con la conoscenza
che di esso abbia avuto il datore di lavoro; e così anche per la comunicazione del successivo recesso che
deve essere tempestiva rispetto alla contestazione
per iscritto dell’addebito. È stato anche detto che il
principio della immediatezza della contestazione disciplinare e della pedissequa sanzione espulsiva deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più
o meno lungo, quando la percezione, l’accertamento
o la valutazione dei fatti contestati richieda un lasso
di tempo maggiore, ovvero quando la complessità
della struttura organizzativa dell’impresa possa far
ritardare il provvedimento di recesso e più in generale quando il ritardo sia giustificato da ragioni oggettive (l’intervallo feriale; una trattativa per la risoluzione consensuale del rapporto; la connivenza del
cedente l’azienda con il lavoratore, che non consente al cessionario di contestare tempestivamente;
ecc.). Il fondamento del principio in esame viene individuato, da un lato, nell’esigenza di tutelare l’affidamento del lavoratore, poiché la tardiva contestazione del fatto da parte del datore di lavoro potrebbe ingenerare nel dipendente la convinzione della
sua neutralità sul piano disciplinare, con il rischio di
una eventuale recidiva e di una più grave risposta
sanzionatoria. Dall’altro, il principio in parola riflette l’esigenza di assicurare la pienezza del diritto di
difesa del lavoratore, che potrebbe essere frustrato o
comunque limitato dal decorso di un eccessivo lasso
di tempo tra il fatto e la contestazione disciplinare.
È importante sottolineare che la contestazione, per
sua natura, non esige l’assoluta certezza della realtà.
Anzi, in quanto mezzo che ha la funzione di consentire al lavoratore di esprimere la sua ricostruzione
dei fatti, essa presuppone la possibilità che la realtà
sia oggettivamente diversa dai fatti contestati. Per
questa ragione la Corte di cassazione suole ripetere
che, ai fini della contestazione, è sufficiente una
realtà che consenta di ritenere ragionevolmente sussistenti i fatti da addebitare, laddove invece la certezza diventa necessaria ai fini della irrogazione della sanzione. Questa ragionevolezza, non solo giustifica la contestazione, conferendole la veste della serietà ed escludendo un comportamento arbitrario,
ma la rende necessaria. Ed il suo insorgere delinea
(con ovvia approssimazione) il «dies a quo» per la
valutazione della tempestività.
Il senso relativo del principio di immediatezza si
264
Lavoro (rapporto)
traduce sul piano processuale in un criterio di giudizio mobile, di fronte al quale il lasso di tempo tra il
fatto imputabile e la contestazione, ai fini del valido
esercizio del potere disciplinare, può variare anche
sensibilmente (da un minimo di qualche settimana
sino a diversi anni). Inutile ripercorrere l’estrema
varietà della casistica giurisprudenziale formatasi
sull’argomento, se non per sottolineare che la validità della condotta datoriale è subordinata in concreto
alla possibilità di dimostrare in giudizio che l’iter di
accertamento dell’illecito disciplinare non abbia registrato pause troppo lunghe, non giustificate da
motivi oggettivi idonei anche ad escludere eventuali
strumentalizzazioni non conformi a buona fede. Un
limite alla discrezionalità del giudice è talvolta previsto dalla contrattazione collettiva che fissa un termine entro il quale deve comunicarsi al lavoratore la
contestazione scritta dell’addebito (es. ccnl attività
ferroviarie) ed un termine oltre il quale, se la sanzione non viene irrogata, le giustificazioni del lavoratore devono intendersi accolte (ccnl industrie metalmeccaniche e ccnl aziende del terziario).
De iure condendo, utile sarebbe in termini di certezza del diritto se fosse il legislatore a dettare, una
volta per tutte, i tempi del procedimento disciplinare, individuando sia un termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la
contestazione disciplinare, decorrente dal momento
in cui egli ha avuto conoscenza del presunto illecito,
sia un termine oltre il quale, una volta che il lavoratore ha presentato le eventuali giustificazioni e, se richiesto, è stato sentito a sua discolpa, viene a cadere
la possibilità di irrogare una sanzione disciplinare e
le giustificazioni rese devono intendersi accolte. I
predetti termini, che dovrebbero avere natura decadenziale e consumare, con il loro inutile decorso, il
potere disciplinare, andrebbero così ad aggiungersi
all’unico termine oggi previsto a difesa del lavoratore dalle contestazioni. Pur senza dimenticare la discrezionalità del sindacato giurisdizionale in materia, la suggerita novella potrebbe forse assicurare
maggiore uniformità di giudizio.
I repertori della giurisprudenza annoverano diversi esempi di illeciti disciplinari a formazione progressiva, composti cioè non da un singolo atto o
comportamento, ma da una serie di atti, anche di diversa natura, posti in essere a distanza di tempo
l’uno dall’altro. In alcuni casi si tratta di una sequenza di atti penalmente rilevanti, la cui gravità è data
dalla somma delle singole infrazioni (es. piccoli, ma
continui, furti di traffico telefonico dal cellulare
aziendale per un ammanco di migliaia di euro). In
altre situazioni, il licenziamento è collegato alla lesione del vincolo fiduciario dovuta ad una serie continua di atti di insubordinazione di varia natura e
gravità (episodi di scarso impegno, di comportaNGCC 2010 - Parte prima
Cass., 22.9.2009, n. 20404 - Commento
mento inurbano e volgare all’indirizzo dei colleghi,
di mancata osservanza degli ordini di servizio, di erronea redazione di atti, ecc.). In simili fattispecie il
«dies a quo» della contestazione disciplinare, ai fini
della valutazione del requisito della immediatezza,
viene allineato all’ultimo atto della serie considerata
un unicum sul piano disciplinare; ciò nel caso in cui
il disvalore della vicenda non emerge chiaramente
dai singoli atti, ma dalla situazione nel suo complesso. Invero, il cennato principio, applicato anche al
caso deciso con la sentenza in commento, appare
condivisibile. L’immediatezza delle contestazioni disciplinari non può essere intesa in maniera tale da
compromettere l’effettività del potere disciplinare.
Se è vero che tale prerogativa datoriale deve esercitarsi nel rispetto dei principi di correttezza e buona
fede nonché dei corollari individuati dalla giurisprudenza (es. tutela dell’affidamento del lavoratore), è
altresì vero che la tempestività della contestazione
non può prescindere dal fatto che venga riservato al
datore di lavoro il tempo necessario a rendersi conto
dell’accaduto, sia pure in termini di ragionevole sussistenza, dovendosi considerare talvolta le esigenze
investigative o l’oggettiva ambiguità della condotta,
talaltra la complessità dell’organizzazione aziendale
e così via.
Sotto altro profilo, si prende spunto dalla decisione in commento per sottolineare come il requisito della tempestività della contestazione disciplinare e della pedissequa sanzione espulsiva, venga inteso dalla giurisprudenza come requisito di validità
del recesso. Questo aspetto dà luogo ad alcune perplessità sul piano processuale. Partendo dalle più
recenti pronunce della Supr. Corte si assume che la
tardività della contestazione sia elemento costitutivo del diritto di licenziare e in quanto tale dovrebbe essere individuato dal giudice attraverso l’efficace e prudente apprezzamento delle circostanze, con
la conseguenza di escludere che sul lavoratore gravi
l’onere di provare lo specifico pregiudizio difensivo
subito nel corso del procedimento disciplinare e,
ancor prima, l’onere di allegazione del fatto lesivo
sotto forma di eccezione in senso stretto (cfr.,
Cass., 17.9.2008, n. 23739; Cass., 6.9.2006, n.
19159; Cass., 15.6.2006, n. 11100; Cass.,
20.6.2006, n. 14113, tutte infra, sez. III). Nel caso
di licenziamento per giusta causa soggettiva, ovvero
senza necessità del preavviso, l’assunto discenderebbe direttamente dall’art. 2119, comma 1o, cod.
civ., in relazione a quei fatti che non consentono la
prosecuzione «anche provvisoria» del rapporto di
lavoro. Ove si tratti di licenziamento per giustificato motivo, la regola della immediatezza sarebbe invece fondata sulle esigenze difensive del lavoratore
in seno sia al procedimento disciplinare che al successivo procedimento giudiziario, frustrate dall’inNGCC 2010 - Parte prima
Lavoro (rapporto)
giustificato indugio del datore di lavoro nella comunicazione dell’addebito. Orbene, l’assunto persuade nel caso di licenziamento per giusta causa
soggettiva in quanto il testo dell’art. 2119 cod. civ.,
collega espressamente il diritto di recesso ad un
motivo che, come ricordato, «non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro», con la conseguenza che la eventuale tardività della contestazione e del successivo atto di recesso sarebbe di per sé indice della insussistenza del
motivo stesso. Ad analoga conclusione non si perviene invece nel caso in cui la stabilità del rapporto
lavorativo venga meno a causa di un giustificato
motivo soggettivo che, a tenore dell’art. 3, comma
1o, l. 15.7.1966, n. 604, s’identifica con «un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro». Tale norma non ripete la formulazione letterale dell’art. 2119 cod. civ., e non fa
cenno a motivi che rendono impossibile la prosecuzione, anche per poco tempo, del rapporto di lavoro. In più, la suddetta ipotesi di recesso è con
«preavviso» («il licenziamento per giustificato motivo con preavviso...»), presuppone cioè che il rapporto lavorativo continui per un limitato periodo di
tempo. Attesa la differenza di presupposti applicativi tra le due fattispecie, si ritiene che il requisito
della tempestività della contestazione disciplinare,
nel caso del giustificato motivo soggettivo, non sia
un elemento costitutivo del recesso, tale cioè da legittimare sul piano processuale la sua rilevabilità ex
officio. Al contrario, in questo caso, gli aspetti connessi alla eventuale tardività delle contestazioni disciplinari possono essere dedotti esclusivamente
dalla parte mediante la formulazione di una eccezione in senso proprio. Tanto in applicazione del
generale principio di distribuzione dell’onere della
prova di cui all’art. 2697 cod. civ.
Le accennate differenze sul piano del riparto dell’onere probatorio a proposito della tardività delle
contestazioni disciplinari nel caso di recesso per giusta causa e per giustificato motivo, si ritrovano almeno in parte nella giurisprudenza meno recente, la
quale aveva ben chiara la distinzione sul piano processuale tra la tardività del recesso e la tardività delle
contestazioni disciplinari nel caso dell’art. 2119 cod.
civ. Emblematica al riguardo è Cass., 23.6.1994, n.
6051 (infra, sez. III), ove si afferma che se, da un lato, è compito del giudice rilevare d’ufficio tutti gli
elementi costitutivi del diritto potestativo di licenziare di cui all’art. 2119 cod. civ., incluso quello della tempestività del recesso, dall’altro, nel caso in cui
il lavoratore lamenti il difetto di immediatezza della
contestazione dell’addebito quale vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa garantito dall’art. 7,
St. lav., in tale ipotesi la doglianza costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, assoggettata al265
Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045
le preclusioni di cui agli artt. 414, 416 e 437 del codice di rito (Cass., 2.7.1992, n. 8121, in Mass. Giust.
civ., 1992; Cass., 21.11.1986, n. 6866, ivi, 1986;
Cass., 23.11.1985, n. 5850, ivi, 1985).
III. I precedenti
Sul principio in base al quale nel caso di condotte
oggettivamente complesse, composte cioè da una pluralità di atti posti in essere a distanza di tempo, la tempestività delle contestazioni va valutata a partire dall’ultimo atto della serie, ove sia questo il momento nel
quale il datore di lavoro abbia potuto percepire ed accertare definitivamente i fatti contestati, v. Cass.,
22.10.2007, n. 22066, in Notiz. giur. lav., 2007, 660.
A proposito dell’applicazione «in senso relativo»
del principio di immediatezza, cfr., Cass., 8.6.2009,
n. 13167, in Mass. giur. lav., 2009, 842; Cass.,
12.5.2005, n. 9955, in Rep. Foro it., 2005, voce «Lavoro (rapporto)», n. 1430; Cass., 30.1.2006, n. 2023,
in Notiz. giur. lav., 2006, 192; Cass., 19.8.2004, n.
16291, in Rep. Foro it., 2004, voce «Lavoro (rapporto)», n. 1615; Cass., 7.3.2003, n. 3483, ivi, 2003, voce «Impiegato dello Stato e pubblico», n. 1018.
Quanto al fatto che le contestazioni disciplinari
presuppongono la prova della «sola» ragionevole
sussistenza dei fatti addebitati, v. ancora Cass.,
12.5.2005, n. 9955.
Circa la rilevabilità ex officio della tempestività
delle contestazioni disciplinari e del recesso, tanto
nel caso di giusta causa che di giustificato motivo,
c CASS. CIV., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045
Conferma Trib. Forlì, 7.4.2004
Obbligazioni - Garanzia patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi Privilegio speciale su bene immobile Forma di pubblicità - Incidenza sul
suo rapporto con l’ipoteca (cod. civ.,
Obbligazioni
cfr. Cass., 17.9.2008, n. 23739, in Rep. Foro it.,
2008, voce «Lavoro (rapporto)», n. 1668; Cass.,
15.6.2006, n. 11100, in Mass. giur. lav., 2006, 660;
Cass., 20.6.2006, n. 14113, in Rep. Foro it., 2006,
voce «Lavoro (rapporto)», n. 1097. A proposito della distinzione tra immediatezza della contestazione
disciplinare oggetto di eccezione in senso stretto e
tempestività del licenziamento quale condizione di
validità del recesso rilevabile d’ufficio dal giudice, v.
Cass., 6.9.2006, n. 19159, in Rep. Foro it., 2006, voce «Lavoro (rapporto)», n. 1531. A proposito del recesso di cui all’art. 2119, cod. civ. la stessa distinzione è fatta da Cass., 23.6.1994, n. 6051, in Giur. it.,
1995, I, 1, 408.
IV. La dottrina
Sul principio della immediatezza della contestazione disciplinare, per tutti, cfr. D’Avossa, Il potere
disciplinare nel rapporto di lavoro, 1989, Ipsoa Informatica, 59; Montuschi, sub art. 7, in Statuto dei diritti dei lavoratori (art. 1-13), a cura di Ghezzi,
Mancini Montuschi, Romagnoli, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1979, sub
art. 7, 98.
Sul rapporto tra fatti penalmente rilevanti e procedimento disciplinare, v. Calcaterra, Immediatezza della contestazione disciplinare e attesa della
sentenza penale, in Riv. it. dir. lav., 2007, 685 ss.
Giovanni Cinque
pubblicità costitutiva, resta sottratto alla
regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca e soggiace agli ordinari
principi in tema di pubblicità degli atti.
dal testo:
artt. 2644, 2645 bis, 2745, 2748, 2762, 2772)
Il privilegio speciale sul bene immobile,
che assiste i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai
sensi dell’art. 2645 bis cod. civ., siccome
subordinato ad una particolare forma di
266
Il fatto. Nel fallimento della Nu.Na. S.n.c. di
F. C. P. & C., pendente dinanzi al Tribunale di
Forlì, la Cassa dei Risparmi di Forlì propose
opposizione ad un piano di riparto parziale dichiarato esecutivo dal giudice delegato. Premesso che la somma distribuita costituiva il ricavato della vendita di un appartamento sul
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045
quale risultava iscritta ipoteca a garanzia del
credito dalla Cassa stessa vantato in virtù di un
mutuo fondiario concesso alla società costruttrice dell’immobile, l’opponente sosteneva che
erroneamente tale credito era stato collocato
con grado inferiore a quello vantato dal B. per
il rimborso della caparra da questo versata
contestualmente alla stipulazione di un contratto preliminare di acquisto del medesimo
appartamento, trascritto in data successiva all’iscrizione dell’ipoteca e scioltosi ai sensi della
L. Fall., art. 72.
Ad avviso dell’opponente, infatti, l’ipoteca
concessa a garanzia del finanziamento di un intervento edilizio ai sensi del D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, art. 38, prevalendo sulla trascrizione anteriore del contratto preliminare, a
norma dell’art. 2825 bis c.c., doveva prevalere,
a maggior ragione, sulla trascrizione posteriore.
Il Tribunale accolse la domanda, osservando, anzitutto, che la particolare causa di prelazione accordata al promissario acquirente dall’art. 2775 bis c.c., comma 1, non si sottrae al
principio generale enunciato dall’art. 2748 c.c.,
comma 2, in forza del quale i crediti muniti di
privilegio speciale immobiliare prevalgono su
quelli ipotecari, se la legge non dispone diversamente. Ha, tuttavia, ravvisato una tale diversa disposizione (idonea, appunto, ad invertire
l’anzidetto criterio di priorità) nel combinato
disposto degli artt. 2775 bis e 2825 bis c.c., reputando che dette norme siano da interpretare
nel senso della prevalenza delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui fondiari erogati a norma
del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 38 e ss.,
T.U. bancario, rispetto al privilegio immobiliare accordato al promissario acquirente, indipendentemente dall’esservi stato o meno accollo del mutuo da parte dell’acquirente. Così ragionando ha, dunque, ritenuto irrilevante nella
fattispecie la precedente affermazione resa sul
tema da questa Corte (Cass. 14 novembre
2003, n. 17197, della quale si dirà in seguito),
considerando che questa non decidesse riguardo ad un istituto di credito garantito da ipoteca ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 38 e
segg., ovvero in altro modo garantito da ipoteca.
Avverso il decreto del Tribunale di Forlì il B.
ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad
un unico motivo.
NGCC 2010 - Parte prima
Obbligazioni
Ha resistito con controricorso la Cassa dei
Risparmi, la quale ha depositato successivamente memoria. Non ha svolto difese la curatela del fallimento.
Con ordinanza interlocutoria del 20 ottobre
2008, la Prima Sezione Civile, ritenuta la sussistenza di una questione di massima di particolare importanza, avente ad oggetto la prevalenza del privilegio di cui all’art. 2775 bis c.c., sulle ipoteche per mutui fondiari iscritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, il
quale ha disposto l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite.
I motivi. (Omissis) Il ricorrente, nel dedurre
la violazione degli artt. 2645 bis, 2775 bis,
2748, 2o comma, e 2825 bis cod. civ., sostiene
che il secondo comma dell’art. 2775 bis individua due soli casi di ipoteche che non soccombono al privilegio di cui al primo comma, e
precisamente quelle iscritte a garanzia del mutuo erogato al promissario acquirente per l’acquisto dell’immobile e quelle iscritte a garanzia
del credito edilizio nei limiti della quota che il
promissario stesso si sia accollato; benché l’art.
2825 bis faccia riferimento esclusivamente alle
ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare, è ovvia la prevalenza anche di quelle iscritte in epoca anteriore, ma
sempre nei limiti della quota di debito che il
promissario si sia accollato, non avendo egli altrimenti alcun ruolo nel rapporto tra il finanziatore ed il costruttore.
Secondo il ricorrente, il decreto impugnato
contrasta, oltre che con l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità, che subordina la
prevalenza dell’ipoteca all’accollo da parte del
promissario del debito contratto dal costruttore, anche con lo spirito della legge, che mira a
tutelare i promissari acquirenti di fabbricati in
corso di costruzione in caso di mancata esecuzione del preliminare o fallimento del promittente venditore.
Nella specie, pertanto, non essendo intervenuto l’accollo della quota di mutuo gravante
sull’immobile promesso in vendita, troverebbe
applicazione il principio generale di cui all’art.
2748, 2o comma, secondo cui il privilegio immobiliare prevale sulle ipoteche iscritte anche
anteriormente, non potendo individuarsi nel267
Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045
l’art. 2825 bis la diversa disposizione di legge
che, ai sensi dell’ultimo inciso dell’art. 2748, 2o
comma, consente di derogare a tale principio.
Preliminare rispetto al vaglio delle doglianze
prospettate nel ricorso è l’esame della premessa giuridica dalla quale muove l’impugnato
provvedimento, secondo cui il privilegio del
credito del promissario acquirente per mancata esecuzione del contratto preliminare prevale, ai sensi dell’art. 2748 cod. civ., 2o comma,
sui crediti ipotecari, anche se l’ipoteca è stata
iscritta prima della trascrizione del preliminare, salvo soltanto che si tratti di ipoteche relative a mutui erogati per l’acquisto del medesimo
immobile promesso in vendita o iscritte a favore dei creditori garantiti ai sensi dell’art. 2825
bis cod. civ. Solo ove, infatti, tale premessa fosse da condividere occorrerebbe valutare se reggono o meno alla critica le conseguenti considerazioni in base alle quali il tribunale ha ravvisato la prevalenza sul privilegio speciale spettante al promissario acquirente dell’ipoteca
iscritta a garanzia del mutuo fondiario erogato
dalla cassa di risparmio; qualora, viceversa,
quella premessa fosse da disattendere, s’imporrebbe la correzione della motivazione del provvedimento impugnato, ma il ricorso dovrebbe
essere rigettato.
La suaccennata premessa, dalla quale il tribunale prende le mosse (e la cui fondatezza è
contestata dalla controricorrente), è in effetti
conforme a quanto affermato nel già menzionato precedente di questa Corte (Cass. n.
17197 del 2003), secondo cui, appunto, in forza del disposto dell’art. 2748, 2o comma, cod.
civ. (per il quale i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori
ipotecari, se la legge non dispone diversamente), anche il privilegio speciale immobiliare,
previsto dal citato art. 2775 bis, prevale rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile,
pur se trascritte anteriormente alla trascrizione
del contratto preliminare da cui il privilegio
scaturisce, non rilevando in contrario la natura
“iscrizionale” (o “trascrizionale”) di siffatto
privilegio, giacché questa non basta a rendere
applicabile, in simili casi, il principio della prevalenza dei diritti secondo l’ordine delle trascrizioni e delle iscrizioni dal quale è regolata
la pubblicità immobiliare.
L’ordinanza che ha rimesso la soluzione del268
Obbligazioni
la questione alle sez. un. ritiene che le conclusioni alle quali è pervenuta la citata sentenza n.
17197 del 2003 non abbiano placato il dibattito che già prima era insorto in dottrina in ordine alla corretta interpretazione da dare alle disposizioni dettate dal codice a tutela del promissario acquirente di immobili (introdotte,
com’è noto, con il D.L. 31 dicembre 1996, n.
669, convertito con modificazioni dalla L. 28
febbraio 1997, n. 30). Dibattito che, piuttosto,
ne è stato rinfocolato. Viene, allora, chiesto
l’approfondimento dei seguenti punti:
a) il privilegio accordato al promissario acquirente non si ricollega esclusivamente alla causa
del credito, ma presuppone necessariamente la
trascrizione del contratto preliminare, alla quale pare pertanto ragionevole assegnare, in ragione della sua efficacia costitutiva, anche la
funzione, ad essa connaturata, di risolvere i
possibili conflitti tra titolari di diritti assoggettati al medesimo regime di pubblicità;
b) poiché nella graduazione prevista dall’art.
2780 cod. civ. il privilegio in questione è collocato dopo quelli che assistono i crediti per concessione di acque e per tributi indiretti, i quali
non possono essere esercitati in pregiudizio dei
diritti anteriormente acquisiti dai terzi sui medesimi immobili, la prevalenza di tale privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente renderebbe impossibile stabilire l’ordine di collocazione dei crediti;
c) detta prevalenza risulterebbe inoltre scarsamente razionale, dal momento che le ipoteche
iscritte anteriormente sono certamente opponibili all’acquirente, in caso di perfezionamento del contratto definitivo di acquisto dell’immobile;
d) l’art. 2825 bis cod. civ., prevedendo eccezionalmente che, in caso di accollo del mutuo
fondiario da parte del promissario acquirente,
l’ipoteca iscritta a garanzia dello stesso prevalga sulla trascrizione anteriore del contratto
preliminare, fa supporre, a maggior ragione,
l’operatività del medesimo criterio in presenza
di una trascrizione posteriore di tale contratto,
trovando applicazione, in tal caso, i principi
generali in materia di pubblicità immobiliare.
In conclusione, la questione sottoposta alle
Sez. un. consiste nello stabilire se, ai fini della
distribuzione del ricavato della vendita, disposta in sede fallimentare, di un immobile già
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045
promesso in vendita dal fallito con contratto
preliminare trascritto, il privilegio che, a norma dell’art. 2775 bis cod. civ., assiste il credito
del promissario acquirente per la mancata esecuzione del preliminare prevalga (o meno), ai
sensi dell’art. 2748, 2o comma, cod. civ., sulle
ipoteche iscritte sul medesimo immobile in data anteriore alla trascrizione del contratto preliminare (Omissis).
L’orientamento quasi unanime affermatosi
nella giurisprudenza di merito sostiene che le
ipoteche delle quali s’è detto siano comunque
destinate a cedere in caso di concorso con il
privilegio spettante al promissario acquirente.
Esso muove dal rilievo secondo cui il concorso tra privilegi ed ipoteche sarebbe regolato
esclusivamente dall’art. 2748, 2o comma, non
potendo trovare applicazione l’art. 2644, il
quale disciplinerebbe, invece, il conflitto tra
cause di prelazione e diritti reali di godimento;
ciò posto, esso afferma che al principio della
prevalenza dei privilegi, sancito dalla predetta
disposizione, potrebbe derogarsi soltanto in
presenza di un dato normativo chiaro ed inequivocabile, non ravvisabile né nell’art. 2775
bis (il quale, nella parte in cui subordina la nascita del privilegio del promissario acquirente
alla trascrizione del preliminare, non introdurrebbe elementi di novità rispetto ad altre fattispecie previste dalla normativa vigente), né
nell’art. 2825 bis (il quale, riferendosi alle sole
ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare, non sarebbe applicabile
a quelle iscritte in data anteriore).
L’indirizzo in esame riflette l’opinione
espressa dai primi commentatori del decretolegge n. 669 del 1996, i quali avevano ritenuto
insuperabile il dato normativo emergente dall’interpretazione letterale degli artt. 2748, 2o
comma, e 2825 bis cod. civ., escludendo così
che le ipoteche iscritte in epoca anteriore alla
trascrizione del contratto preliminare potessero prevalere sul privilegio che assiste il credito
del promissario acquirente.
All’obiezione secondo cui l’ipoteca prevale
sui diritti dei terzi trascritti in epoca successiva
all’iscrizione, essi replicavano che ciò accade
perché il rapporto tra le cause di prelazione e i
diritti reali di godimento è regolato dal principio prior in tempore, potior in jure, esaltato, nel
caso di immobili, dalla priorità della relativa
NGCC 2010 - Parte prima
Obbligazioni
pubblicità; nella fattispecie in esame, tuttavia,
non vi è un conflitto tra il diritto del promissario di ottenere l’esecuzione specifica del contratto e l’ipoteca del terzo sullo stesso bene oggetto del preliminare, ma un conflitto tra il privilegio speciale del promissario (conseguente
alla risoluzione o allo scioglimento del contratto preliminare) e l’ipoteca iscritta sullo stesso
bene: si tratterebbe di un conflitto tra cause di
prelazione, la cui prevalenza sarebbe disciplinata dalla legge in base ad un principio diverso
da quello della priorità cronologica. Ciò spiegherebbe, tra l’altro, perché le ipoteche iscritte
in data anteriore alla trascrizione del preliminare siano opponibili all’acquirente in caso di
stipulazione del contratto definitivo, mentre risultano inopponibili in caso di mancata esecuzione del preliminare.
Secondo tale orientamento, la deroga al
principio della prevalenza dei privilegi, richiesta dall’art. 2748, 2o comma, ai fini dell’opponibilità dell’ipoteca al creditore privilegiato,
non può essere desunta dall’art. 2825 bis: tale
disposizione, infatti, non ha nulla a che fare
con il privilegio di cui all’art. 2775 bis, previsto
per il caso di mancata esecuzione del preliminare, in quanto si limita a regolare gli effetti
dell’ipoteca fondiaria edilizia sulla trascrizione
del preliminare che venga regolarmente eseguito; il 2o comma dell’art. 2775 bis, inoltre, limitando la prevalenza delle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare a
quelle concesse a garanzia di mutui contratti
per la costruzione o per l’acquisto dell’immobile, presupporrebbe che, al di fuori di tali ipotesi, dette ipoteche siano destinate a cedere nel
concorso con il privilegio, e sarebbe quindi applicabile, a maggior ragione, alle ipoteche
iscritte in data anteriore.
All’obiezione secondo cui tale opinione, favorendo il promissario acquirente a scapito degli interessi dei creditori ipotecari, si sarebbe
ripercossa negativamente sui rapporti tra le imprese costruttrici e le aziende di credito, scoraggiando queste ultime dal concedere finanziamenti per la costruzione di immobili, in
contrasto con le finalità che la legge intendeva
perseguire, si replica che il senso della nuova
disciplina consisteva anche nel responsabilizzare il ceto bancario, dissuadendolo da un’eccessiva disinvoltura nell’erogazione del credito
269
Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045
fondiario. Troppo spesso, infatti, le banche,
nel concedere finanziamenti per la costruzione
di immobili, fanno affidamento, ai fini della restituzione, più sul valore dei beni concessi in
garanzia che sulla solidità complessiva dell’impresa mutuataria, confidando di poter agevolmente procedere al recupero del credito anche
in caso di fallimento della stessa, con evidente
pregiudizio per le ragioni degli altri creditori.
La postergazione dei crediti ipotecari a quello
del promissario acquirente le costringerebbe
invece a verificare preventivamente la capacità
dell’impresa di far fronte alle proprie obbligazioni, avvalendosi di quegli strumenti di controllo di cui esse dispongono in misura più ampia ed incisiva di ogni altro creditore.
Sotto un diverso profilo, si riconosce che,
una volta ovviatosi, mediante la previsione della trascrivibilità del preliminare, al pericolo che
il diritto al trasferimento dell’immobile sia vanificato da atti dispositivi compiuti dal promittente venditore o da atti di aggressione del suo
patrimonio posti in essere da terzi prima della
stipulazione del definitivo, l’attribuzione di un
rango privilegiato ai crediti del promissario nascenti dalla mancata esecuzione del contratto si
traduce in una tutela eccessiva, quanto meno
in riferimento all’ipotesi in cui, pur potendo
ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, egli abbia optato per la
tutela risarcitoria.
In ogni caso, anche coloro i quali sono disposti ad ammettere che la prevalenza del privilegio determina un’ingiustificata disparità di
trattamento nei confronti dei creditori che abbiano iscritto ipoteca in data anteriore alla trascrizione del preliminare, ritengono che a tale
inconveniente possa ovviarsi esclusivamente
attraverso una declaratoria di incostituzionalità
della norma in esame, o mediante un intervento chiarificatore del legislatore.
La dottrina più recente ritiene invece che la
questione possa essere risolta anche in via interpretativa, avvalendosi dei principi sui cui si
fonda la pubblicità immobiliare e di una pluralità di elementi emergenti dalla stessa disciplina in materia. Essa sottolinea la natura “iscrizionale” o “trascrizionale” del privilegio in
questione, il cui concorso con le ipoteche
iscritte sull’immobile promesso in vendita deve
considerarsi disciplinato dall’art. 2644 cod.
270
Obbligazioni
civ., non essendo il privilegio accordato esclusivamente in ragione della causa del credito,
ma essendo condizionato alla trascrizione del
contratto preliminare ed alla sua perdurante
efficacia. A sostegno di tale orientamento, sono
state sottolineate anche le anomalie che l’opposta tesi introdurrebbe nel sistema delle cause di
prelazione, osservandosi da un lato che in caso
di stipulazione del contratto definitivo le ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione
del preliminare sono opponibili all’acquirente,
dall’altro che nell’ordine dei privilegi quello
previsto dall’art. 2775 bis è collocato successivamente a quelli di cui agli artt. 2772 e 2774
cod. civ., i quali non sono esercitabili in pregiudizio dei diritti precedentemente acquisiti
dai terzi. Sono stati infine evidenziati i gravi
abusi cui potrebbe condurre una rigida applicazione dell’art. 2748 cit., la quale consentirebbe al promittente venditore di sottrarre l’immobile alla garanzia dei propri creditori ipotecari, mediante la simulazione di un preliminare
di compravendita con un promissario compiacente, cui potrebbe far seguito la risoluzione
del contratto, con la conseguenza che, in sede
di esecuzione forzata, i crediti restitutori e risarcitori del promissario dovrebbero essere
soddisfatti con precedenza rispetto a quelli dei
creditori ipotecari.
Alle medesime conclusioni un’autorevolissima dottrina è pervenuta sulla base di un diverso percorso argomentativo, che muove dalla
qualificazione del preliminare di compravendita come vendita ad effetti obbligatori, dalla
quale sorge a carico del promittente un’obbligazione di dare e dall’affermazione dell’autonomia di tale contratto rispetto al definitivo, ricollegando alla sua trascrizione l’efficacia tipica di cui all’art. 2644 cod. civ., per sostenere
che tale efficacia si estende anche al privilegio
che assiste i crediti del promissario acquirente,
il cui concorso con le ipoteche iscritte in data
anteriore deve pertanto ritenersi disciplinato
dal principio della priorità cronologica.
L’aspetto più suggestivo di questa dottrina è
rinvenibile nell’attribuzione al promissario acquirente di un jus ad rem (non di un mero jus
in persona) e nella riconduzione del rapporto
tra preliminare e definitivo (non come rapporto tra due contratti distinti ed autonomi, ciascuno dotato di una propria causa) al modello
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045
tedesco della distinzione tra titulus e modus
adquirendi, con la conseguenza che la stipulazione del definitivo non comporta l’assorbimento del preliminare né rende irrilevanti i vizi
che lo inficiano, i quali risultano anzi idonei ad
incidere, attraverso la caducazione del contratto cui afferiscono, sulla stessa trascrizione del
contratto definitivo. La riprova sarebbe costituita proprio dalla trascrivibilità del preliminare, il cui effetto di opponibilità trova giustificazione nella natura del diritto che da esso scaturisce per il promissario acquirente, mentre la limitazione temporale di tale effetto si giustificherebbe con l’efficacia obbligatoria del contratto (Omissis).
Sulla scorta di tutto quanto premesso è ora
possibile passare alla soluzione del quesito, subito anticipando che le sez. un. intendono disattendere il precedente orientamento espresso
dalla menzionata Cass. n. 17197 del 2003, attraverso una trattazione concernente il generale problema della regola di conflitto tra cause
di prelazione, al di là della specifica ipotesi
(della quale pure si dirà) del credito fondiario,
disciplinata dagli artt. 2775 bis, 2o comma, e
2825 bis cod. civ.
Il ragionamento parte dalla premessa che
l’art. 2748 cod. civ., allorquando nel secondo
comma stabilisce che i creditori muniti di privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari “se la legge non dispone diversamente”, fa riferimento ad una deroga non
necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può e deve essere individuata
nell’ordinamento nel suo complesso, attraverso
la lettura e l’interpretazione normativa che tenda all’armonioso coordinamento dello specifico istituto in trattazione con l’intero sistema;
così da evitare applicazioni ermeneutiche settoriali che, sebbene compatibili con il microsistema nel quale le disposizioni sono inserite, finiscano con lo stridere rispetto al complesso
della materia nelle quali le norme stesse esplicano il proprio effetto. Siffatto sforzo interpretativo si impone con ancora maggior impegno
quando (come nel caso di specie) le norme esaminate non appartengono all’originaria impostazione codicistica, ma sono frutto di una successiva interpolazione legislativa, mossa da esigenze sociali ed economiche via via emerse nella realtà giuridica dei commerci.
NGCC 2010 - Parte prima
Obbligazioni
Espresse norme derogatrici alla regola del
secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. sono
rinvenibili nel quarto comma dell’art. 2772 e
nel secondo comma dell’art. 2774: il privilegio
che assiste i crediti dello Stato per tributi indiretti o per canoni di concessione di acque non
si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i
terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili. Deroga ispirata, dunque, alla diversa
regola della prevalenza in base alla data di trascrizione o di iscrizione.
Nel nostro caso una espressa norma derogatoria al precetto stabilito dalla prima parte del
secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. non
esiste, ma, come si vedrà, l’organica analisi dell’intero quadro normativo disciplinante la materia consente di affermare che i creditori muniti dello speciale privilegio del quale trattiamo
non sono preferiti ai creditori muniti di ipoteca
iscritta precedentemente al sorgere del privilegio stesso, secondo una ricostruzione che, come s’è detto, prescinde dalla specifica ipotesi
(disciplinata dal secondo comma dell’art. 2275
bis, in relazione all’art. 2825 bis) del privilegio
che assiste il credito per il finanziamento dell’intervento edilizio.
Occorre innanzitutto porre nel giusto rilievo
che il privilegio che assiste il credito del promissario acquirente, conseguente alla (eventuale) mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto, non si ricollega esclusivamente
alla causa del credito (come prescrive la prima
parte dell’art. 2745 cod. civ.) ma la sua costituzione necessariamente presuppone la trascrizione del contratto preliminare ai sensi dell’art.
2645 bis; rientrando, dunque, nella categoria
dei privilegi la cui costituzione, come consentito dalla seconda parte dell’art. 2745 cod. civ., è
subordinata ad una particolare forma di pubblicità. Peraltro, esso assiste il credito a condizione che gli effetti della menzionata trascrizione non siano cessati a determinati momenti
(quello della risoluzione del contratto, oppure
della domanda giudiziale della risoluzione, oppure della trascrizione del pignoramento, oppure ancora dell’intervento nell’esecuzione
promossa da terzi).
Siffatto privilegio (come molti altri introdotti
nel tempo dal legislatore in specifici settori) si
aggiunge ai privilegi speciali immobiliari previsti dal codice agli artt. da 2770 a 2775, ma se ne
271
Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045
differenzia perché non è posto, come questi, a
tutela di interessi pubblici, bensì a tutela dell’interesse meramente privato del promissario
acquirente.
Occorre a riguardo ricordare che gli originari privilegi speciali codicistici costituiscono il
retaggio delle antiche ipoteche privilegiate, le
quali venivano preferite alle ipoteche normali
in ragione della particolare natura pubblica degli interessi protetti in via preferenziale. Di qui
la regola di conflitto secondo cui siffatti privilegi prevalgono sulle ipoteche, anche se iscritte
prima del loro sorgere. Regola oggi consacrata
nel secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e
già contenuta nell’art. 1953 del codice del 1865
(benché senza l’espressa riserva che prevede il
vigente testo normativo).
Autorevolissima dottrina spiega che la via
scelta dal legislatore nel secondo comma dell’art. 2748 è la più conforme all’indole del privilegio, che, assistendo crediti normalmente incidenti sul processo di produzione o di valorizzazione di una cosa, deve necessariamente essere anteposto all’ipoteca. In altri termini, la
ragione della maggior parte dei privilegi va ricercata nella particolare inerenza economica di
alcuni crediti alla cosa gravata, la quale spiega
anche la preferenza dei creditori privilegiati sui
creditori forniti di garanzia reale: poiché questi
ultimi acquistano un diritto al valore di scambio della cosa, sono necessariamente posposti a
coloro i quali, mediante l’erogazione di energie
di lavoro o di utilità dal cui corrispettivo sorge
il credito, hanno contribuito alla creazione, alla
conservazione o all’incremento del valore medesimo.
La stessa dottrina avvisa pure che queste
considerazioni rilevano ai fini interpretativi
della concreta applicazione delle norme positive e che sarebbe assurdo escludere dal novero
dei privilegi le figure che hanno il presupposto
in forme di pubblicità, solo perché ad esse non
si applica il brocardo secondo cui privilegia
non ex tempora estimantur (ossia la regola trasfusa nel secondo comma dell’art. 2748). Ponendo, così, in evidenza che, per un verso, la
qualifica di “privilegio” non necessariamente
comporta l’applicazione del principio secondo
cui esso prevale sull’ipoteca precedentemente
iscritta e che, per altro verso, l’applicazione
delle ordinarie regole sulla pubblicità non con272
Obbligazioni
sente di escludere la particolare qualifica di
“privilegio” al tipo di prelazione trattato.
Il privilegio del quale si discute esplica i suoi
effetti in una vicenda specularmente opposta a
quella summenzionata. Esso non assiste un
credito che incide sul processo di produzione
o di valorizzazione della cosa (piuttosto, siffatta incidenza appartiene al credito del finanziatore dell’opera), bensì il credito del promissario acquirente che acquista il diritto al valore di
scambio della cosa, e la sua costituzione è subordinata ad un preciso onere pubblicitario,
così come la sua esistenza è collegata al perdurare degli effetti della pubblicità.
Ne consegue che, relativamente ad esso, non
vige la regola della prevalenza dei privilegi sulle ipoteche, bensì quella del prior tempore potior in jure che pervade di sé l’intero sistema
della pubblicità, facendone conseguire che
l’ipoteca trascritta prima della costituzione del
privilegio debba su quest’ultimo prevalere.
Alcuni autori hanno rilevato l’assimilabilità
di siffatto tipo di prelazione all’ipoteca legale,
ponendo in evidenza che, nella materia trattata, sarebbe stato preferibile che il legislatore
avesse previsto non un privilegio speciale, bensì un’ipoteca legale; tant’é che in altre esperienze normative (come quella francese: cfr. l’art.
2106 code civil) è previsto che i privilegi speciali sugli immobili sono opponibili agli altri creditori solo dopo che siano stati iscritti nella
conservatoria delle ipoteche e secondo le modalità previste per quella forma di pubblicità.
Le caratteristiche del privilegio in esame assumono un rilievo determinante, distinguendolo tanto dagli altri privilegi speciali immobiliari, la cui nascita non è condizionata ad un
adempimento pubblicitario avente efficacia costitutiva, quanto dagli altri privilegi iscrizionali,
che hanno ad oggetto beni mobili; rispetto a
questi ultimi, ovviamente, il problema del concorso con altre cause di prelazione aventi natura trascrizionale non si pone, ma per il caso in
cui concorrano più privilegi la legge prevede
espressamente che il conflitto vada risolto in
base alla regola della priorità della trascrizione
(art. 2762, ultimo comma, cod. civ.); per i primi, invece, pur valendo la regola secondo cui il
privilegio prevale sulle ipoteche, la legge stabilisce, in riferimento a casi in cui la prelazione è
accordata per un interesse non individuale, che
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045
essa non possa essere esercitata in pregiudizio
dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili (si tratta dei già menzionati artt. 2772, quarto comma, e 2774, secondo comma, cod. civ.). A maggior ragione
deve, quindi, affermarsi che un privilegio accordato in funzione di un interesse individuale,
la cui nascita è subordinata all’adempimento di
una formalità pubblicitaria, sia destinato a cedere, nel concorso con cause di prelazione precedentemente iscritte.
In quest’ordine di idee è riduttivo ed avulso
dalla visione sistematica dell’istituto fare una
formalistica applicazione della regola di conflitto dettata nel secondo comma dell’art. 2748
cod. civ., per ammettere categoricamente che
qualunque genere di privilegio speciale immobiliare (compreso quello previsto a favore del
promissario acquirente) prevalga sull’ipoteca
(qualunque ipoteca, non solo quella che assiste
il credito del finanziatore), benché questa sia
stata iscritta prima del nascere del privilegio.
A questo punto occorre fare alcune precisazioni in ordine ad una serie di ricostruzioni che
sono state operate per pervenire al medesimo
risultato al quale qui si perviene.
In primo luogo occorre chiarire che la regola
di conflitto tra privilegio ed ipoteca precedentemente iscritta non può essere rinvenuta nell’art. 2645 bis, 2o comma, cod. civ., il quale stabilisce la prevalenza del contratto definitivo
sulle trascrizioni e le iscrizioni eseguite contro
il promittente alienante dopo la trascrizione
del contratto preliminare. Espressione, questa,
del già menzionato effetto prenotativo della
trascrizione del contratto preliminare ed attuazione della generalissima regola dell’art. 2644
cod. civ.
Neppure giova il richiamo alla specifica regola di conflitto tra cause di prelazione contenuta nel secondo comma dell’art. 2775 bis, il
quale prevede due categorie di creditori ai quali il privilegio concesso in favore del promissario acquirente non è opponibile: a) quelli garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al
promissario acquirente per l’acquisto del bene
immobile; b) quelli garantiti da ipoteca ai sensi
dell’art. 2825 bis.
Quanto all’ipotesi sub a) non è il caso di dilungarsi, pur dovendosi segnalare che tutti i
commentatori hanno rilevato l’oscurità di una
NGCC 2010 - Parte prima
Obbligazioni
disposizione che sembrerebbe ammettere che
il promissario, per effetto del preliminare, possa iscrivere ipoteca a garanzia dei suoi debiti su
un bene non ancora di sua proprietà, in deroga
dunque all’art. 2822 cod. civ. Sta di fatto, comunque, che, nell’ipotesi delineata, il conflitto
è risolto nel senso che l’ipoteca a favore del
mutuante prevale sul privilegio a favore del
promissario acquirente, a prescindere dalla circostanza che la garanzia reale sia stata iscritta
prima o dopo la costituzione del privilegio.
Quanto alla ipotesi sub b) – quella che maggiormente interessa – occorre tener conto della
disposizione dell’art. 2825 bis, richiamata dall’art. 2775 bis. Essa prevede (come s’è già visto
in precedenza) che l’ipoteca iscritta sull’edificio (costruito o costruendo) a garanzia del finanziamento dell’intervento edilizio (ai sensi
degli artt. 38 e segg. del D.Lgs. n. 385 del
1993) prevale sulla trascrizione anteriore del
contratto preliminare, limitatamente alla quota
accollatasi dal promissario acquirente. In altri
termini, benché iscritta successivamente alla
trascrizione del preliminare, siffatta ipoteca
prevale sul privilegio concesso a garanzia dei
crediti vantati dal promissario acquirente nei
confronti del promittente venditore. Risultando, così, risolto il problema del frazionamento
del credito fondiario assistito da ipoteca che
s’era posto nella precedente giurisprudenza ed
attuato il favore del legislatore (del quale prima
s’è detto) per i crediti incidenti sul processo di
produzione o di valorizzazione della cosa.
Ora, le disposizioni correlate costituiscono
un ulteriore sottosistema nell’ambito del sottosistema della trascrizione del contratto preliminare. Nel senso che l’art. 2775 bis, 2o comma,
non si occupa dei problema di ordine generale
del rapporto tra privilegio a favore del promissario ed ipoteca iscritta contro il promittente,
ma solo del rapporto tra privilegio ed ipoteca
inerenti all’operazione di credito fondiario, disponendo l’inopponibilità del privilegio a due
specifiche categorie di creditori ipotecari.
Ne consegue che il richiamo a queste disposizioni non è utile a fondare la più generale regola di conflitto della quale s’è detto e che, soprattutto, le disposizioni stesse non possono
essere indicate né come la deroga al principio
del secondo comma dell’art. 2748 (da parte di
chi ritiene che l’inopponibilità del privilegio al273
Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045
le ipoteche successive presuppone, a maggior
ragione, l’inopponibilità a quelle precedenti),
né come la conferma al principio stesso (da
parte di chi ritiene che il legislatore abbia voluto limitare l’inopponibilità del privilegio alle
sole ipoteche successive e non anche alle precedenti).
L’interpretazione sin qui offerta, nel ricondurre la normativa speciale nell’alveo del sistema, risolve anche una serie di discrasie segnalate da quella dottrina che ha contrastato l’opposta soluzione.
Affermare la prevalenza del privilegio sulle
ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione
del preliminare comporterebbe, infatti, un’ingiustificata disparità di trattamento a seconda
che il preliminare abbia o meno esecuzione: tali ipoteche, che in caso di stipulazione del contratto definitivo sono opponibili all’acquirente
(in base al principio dell’anteriorità stabilito
dall’art. 2644 cod. civ.), in caso di inadempimento dell’obbligo di contrarre diverrebbero a
lui inopponibili, per effetto del privilegio nascente dalla stessa trascrizione del preliminare,
con evidente sovvertimento della regola posta
dall’ultima menzionata disposizione. Tenuto,
altresì, conto di un’altra praticissima ma per
nulla irrilevante considerazione: ossia, che il
promissario, nel momento in cui stipula il preliminare ha contezza dell’esistenza dell’iscrizione ipotecaria sul bene che va ad acquistare; diversamente, il creditore (nel caso nostro il finanziatore) che abbia sin dall’inizio dell’operazione iscritto ipoteca a garanzia del suo credito
sul medesimo immobile finirebbe (seguendo
l’opposta tesi) con il vedere il suo credito posposto rispetto ad una serie indefinita ed indefinibile di crediti di promissari acquirenti (muniti di crediti privilegiati) susseguitisi nel commercio dello stesso bene.
Tant’è che non è infondato l’allarme lanciato
da chi ha rilevato che l’asserita prevalenza del
privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente
alla trascrizione del contratto preliminare potrebbe costituire fonte di gravi abusi e di accordi fraudolenti tra il promittente venditore e
il promissario acquirente, volti a vanificare la
possibilità di soddisfacimento dei crediti garantiti dalle predette ipoteche.
Il proprietario di un immobile gravato da
ipoteca potrebbe, infatti, agevolmente sottrar274
Obbligazioni
re il bene alla garanzia del proprio creditore,
simulando un preliminare di compravendita
con un soggetto compiacente, dichiarando di
aver ricevuto l’intero corrispettivo e poi risolvendo il contratto, in quanto in sede di esecuzione forzata il credito del promissario acquirente per la restituzione del prezzo versato sarebbe collocato con grado poziore rispetto a
quello ipotecario del creditore, che rimarrebbe
pertanto insoddisfatto.
Infine, essendo il privilegio in questione collocato all’ultimo posto nell’ordine stabilito dall’art. 2780 (e quindi dopo quelli riconosciuti ai
crediti dello Stato per concessioni di acque e
tributi indiretti, i quali non possono essere
esercitati in pregiudizio delle ipoteche precedentemente iscritte da terzi), l’accoglimento
della diversa opinione determinerebbe un circolo vizioso, rendendo impossibile stabilire
l’ordine delle cause di prelazione in caso di
concorso dei privilegi di cui agli artt. 2772 e
2774 con quello di cui all’art. 2775 bis e con
ipoteche anteriori.
In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio:
Il privilegio speciale sul bene immobile, che
assiste (ai sensi dell’art. 2775 bis cod. civ.) i
crediti del promissario acquirente conseguenti
alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis cod.
civ., siccome subordinato ad una particolare
forma di pubblicità costitutiva (come previsto
dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. civ.), resta
sottratto alla regola generale di prevalenza del
privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art.
2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi
in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue
che, nel caso in cui il curatore del fallimento
della società costruttrice dell’immobile scelga
(come nella specie) lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 legge fall.),
il conseguente credito del promissario acquirente (nella specie, per la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del
contratto preliminare), benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente
alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a gaNGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 - Commento
ranzia del finanziamento concesso alla società
costruttrice.
Siccome il dispositivo del provvedimento
impugnato risulta conforme a diritto, correttane la motivazione nei sensi sopra enunciati (art.
384 c.p.c.), il ricorso deve essere respinto.
La particolare importanza della questione
trattata consiglia l’integrale compensazione, tra
le parti, delle spese del giudizio di cassazione.
(Omissis)
[Carbone Presidente – Spirito Estensore – Iannelli P.M. (concl. conf.). – B. (avv.ti Winkler e Raffi) – Cassa dei Risparmi di Forlì (avv.ti Stella Richter
e Volpi) – Fallimento Nu.Na. s.n.c.]
Nota di commento: «L’intervento delle sezioni
unite: l’ipoteca, iscritta in data anteriore, prevale
sul privilegio del promissario acquirente»
I. Il caso
In sede fallimentare, si rendeva necessario predisporre un piano di riparto parziale relativo alla somma risultante dalla vendita di un appartamento. Il
credito vantato dal promissario acquirente, a fronte
della caparra versata nell’ambito di un contratto
preliminare trascritto, veniva anteposto rispetto al
credito di una banca; quest’ultimo era garantito da
ipoteca, iscritta sul bene in data anteriore a quella
della trascrizione del preliminare.
La banca proponeva quindi opposizione al piano
di riparto; tale opposizione veniva accolta dal tribunale in considerazione della natura fondiaria del credito bancario.
Il promissario acquirente ricorreva quindi in Cassazione e la causa veniva rimessa alle sezioni unite le
quali erano chiamate a pronunciarsi in merito all’applicabilità della regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, con riferimento al privilegio speciale sul bene immobile, che assista (ai sensi dell’art. 2775 bis cod. civ.) i
crediti del promissario acquirente conseguenti alla
mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis cod. civ.
II. Le questioni
1. La l. 28.2.1997, n. 30. La l. 28.2.1997, n. 30
(Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a
completamento della manovra di finanza pubblica per
l’anno 1997), conversione del d.l. 31.12.1996, n.
669, all’art. 3 ha introdotto una serie di modifiche al
NGCC 2010 - Parte prima
Obbligazioni
codice civile ed all’art. 72 del r.d. 16.3.1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa, c.d. legge fallimentare), incentrate sulla trascrivibilità del contratto preliminare.
La ratio della novella legislativa va individuata
nella volontà di incrementare la tutela dei promissari acquirenti degli immobili, spesso coinvolti nell’insolvenza delle imprese di costruzioni, con risultati
economici particolarmente negativi nel caso in cui si
fosse posto in essere un preliminare con effetti anticipati in forza del quale il promissario acquirente otteneva la detenzione del bene ed il promissario venditore parte del prezzo, il tutto prima della stipula
del contratto definitivo (in materia si veda Cass.,
27.3.2008, n. 7930, infra, sez. III).
Circa l’avvenuto conseguimento dell’obiettivo del
legislatore è lecito nutrire dei dubbi, come si evince
sia dal limitato numero di precedenti giurisprudenziali (v. infra, sez. III), sia dal successivo intervento
normativo di cui al d. legis. 20.6.2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della l. 2
agosto 2004, n. 210), che, pur con il medesimo fine
della l. n. 30/1997, ha seguito la diversa via dell’assicurazione obbligatoria da parte del costruttore e
della prelazione a favore del promissario acquirente.
In dettaglio la l. n. 30/1997 introduce l’art. 2645
bis cod. civ., che consente la trascrivibilità dei contratti preliminari relativi alla costituzione ed al trasferimento di diritti reali su immobili (i primi quattro punti dell’art. 2643 cod. civ.); i preliminari possono essere trascritti anche se relativi ad immobili
da costruire o in costruzione oppure se sottoposti a
condizione.
La rilevanza della novella si apprezza considerando che la dottrina reputava, pressoché pacificamente, che il contratto preliminare non potesse essere
trascritto, stanti gli effetti obbligatori del medesimo
ed il numero chiuso dettato dall’art. 2643 cod. civ.
Circa la nota vicenda della natura del contratto
preliminare e del suo rapporto con il contratto definitivo, la novella, come rilevato sin dai primi commenti alla legge, non apporta contributi per risolvere la problematica, ampiamente dibattuta in dottrina.
Ai sensi del comma 2o dell’art. 2645 bis cod. civ.,
la trascrizione del preliminare, introdotta dalla legge
in oggetto, produce un effetto prenotativo, alla medesima stregua della domanda giudiziale. Ne consegue che la successiva trascrizione del contratto definitivo, di un atto che comunque costituisca esecuzione del preliminare oppure di una sentenza che
dia esecuzione in forma specifica del preliminare
stesso, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni esegui275
Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 - Commento
te successivamente alla trascrizione del preliminare.
Al fine di evitare un vincolo a tempo indeterminato sul bene, il comma 3o dello stesso art. 2645 bis
cod. civ., limita gli effetti della trascrizione ad un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del definitivo e comunque a tre anni dalla data
della trascrizione del preliminare.
La l. n. 30/1997 ha inoltre introdotto nel codice
civile l’art. 2825 bis che statuisce il prevalere dell’ipoteca sulla trascrizione del preliminare, anche se
iscritta successivamente alla trascrizione, purché
l’ipoteca stessa abbia per oggetto l’edificio o il complesso condominiale, anche da costruire o in corso
di costruzione, e sia posta a garanzia di finanziamento dell’intervento edilizio, ai sensi degli artt. 38 d. legis. 1o.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); la prevalenza dell’ipoteca
è limitata alla quota di debito derivante dal finanziamento che il promissario acquirente si sia accollato
con il contratto preliminare o con altro atto successivo.
Nel codice civile, la struttura dell’intervento legislativo si completa con l’inserimento dell’art. 2775
bis che attribuisce al promissario acquirente un privilegio speciale, sull’immobile oggetto del preliminare, relativamente ai crediti vantati dallo stesso per
la mancata esecuzione del contratto preliminare;
viene fatto salvo il caso in cui gli effetti della trascrizione siano cessati al momento della risoluzione del
contratto risultante da atto avente data certa, ovvero
al momento della domanda giudiziale di risoluzione
del contratto o di condanna al pagamento ovvero al
momento della trascrizione del pignoramento oppure dell’intervento nella esecuzione promossa da terzi.
Il medesimo articolo indica due casi nei quali il
privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da
ipoteca: qualora il mutuo sia stato erogato al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile, previsione tacciata di oscurità e di remota applicabilità pratica dalla pressoché totalità dei commentatori; nonché nel caso in cui i creditori siano garantiti da ipoteca ai sensi del sopra citato art. 2825 bis.
2. Il conflitto tra ipoteca e privilegio a favore del promissario acquirente. La l. n.
30/1997 ha suscitato grande attenzione tra gli studiosi della materia ed ha animato un vivace dibattito
circa diversi aspetti della novella legislativa.
La sentenza che qui si commenta prende decisamente posizione in ordine ad uno dei nodi più controversi che peraltro riveste un indubbio rilievo pratico.
L’art. 2775 bis cod. civ., come sopra sinteticamente illustrato, attribuisce al promissario acquirente insoddisfatto un privilegio speciale sull’immobile oggetto del preliminare. In forza dell’art. 2748, comma
276
Obbligazioni
2o, cod. civ. il privilegio sui beni immobili prevarrebbe sull’ipoteca, si noti bene aldilà del momento
in cui l’ipoteca sia stata iscritta.
Questo aspetto è stato oggetto, sin dall’origine, di
due diverse ed opposte letture.
Secondo parte della dottrina, ed in conformità all’unico precedente della Cassazione in materia (v.
infra, sez. III), la lettura combinata dei due sopra citati articoli porta a reputare che il privilegio del promissario acquirente debba essere preferito rispetto
all’ipoteca, anche nel caso in cui l’ipoteca sia stata
iscritta in data anteriore rispetto alla trascrizione del
preliminare.
Questa tesi privilegia le ragioni dei promissari acquirenti principalmente in forza di una interpretazione letterale dei due articoli che, ad avviso di chi
concorda con tale ricostruzione, appaiono univoci
nella conclusione della natura privilegiata del credito del promissario acquirente e quindi del prevalere
del privilegio rispetto all’ipoteca, secondo la regola
generale dettata dall’art. 2748 cod. civ.
L’interpretazione letterale dei due articoli costituisce il maggior punto di forza della posizione in
oggetto ma si sono rappresentate altre argomentazioni a sostegno.
È stata infatti rilevata la presenza di due eccezioni, dettate dall’art. 2775 bis cod. civ., al principio
della prevalenza della trascrizione, in dettaglio:
l’ipoteca a tutela dei mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene, e l’ipoteca relativa
alla quota del finanziamento edilizio, ai sensi dell’art. 38 t.u.b., accollata al promissario acquirente.
Si afferma quindi che se il legislatore ha espressamente indicato due eccezioni, conseguentemente in
tutti gli altri casi il privilegio, secondo il principio
generale di cui all’art. 2748, prevale sull’ipoteca.
Non è mancato chi ha giustificato la sopra esposta
interpretazione richiamando la ratio della legge,
esplicitamente rivolta alla tutela della posizione del
promissario acquirente; considerazione valutata
quale convincente argomento a favore della prevalenza del privilegio a favore del promissario acquirente.
Un ulteriore supporto a detta tesi viene ravvisato
nella supposta volontà del legislatore di incentivare
il sistema bancario a seguire attentamente le iniziative immobiliari, così da evitare di confidare sulla sola
garanzia reale; il monitoraggio bancario sull’intervento edilizio assicurerebbe quindi una maggiore
tutela per i promissari acquirenti.
Le motivazioni sinteticamente tratteggiate non sono state reputate convincenti dalla dottrina ove risulta maggioritaria la tesi, diametralmente opposta,
secondo la quale l’ipoteca iscritta in data anteriore
prevale rispetto alla successiva trascrizione del preliminare secondo il principio generale che regge la
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 - Commento
pubblicità immobiliare (prior tempore potior in jure).
Un primo rilievo evidenzia quindi che risulta irrazionale tutelare in misura maggiore la situazione del
promissario acquirente insoddisfatto rispetto a quella del promissario acquirente soddisfatto, come accadrebbe accettando l’opposta tesi; va infatti sottolineato come, rispetto al promissario acquirente soddisfatto, l’ipoteca risulti pienamente opponibile.
Appare quindi difficilmente giustificabile come
l’inadempimento del preliminare, che può anche dipendere dalla volontà delle parti, possa modificare
in misura così significativa la posizione del promissario acquirente; aspetto che ha portato un autorevole autore a sollevare dubbi di incostituzionalità
della norma per violazione del principio di eguaglianza (Gabrielli, infra, sez. IV).
Un ulteriore risultato inaccettabile della tesi della
prevalenza del privilegio sull’ipoteca anteriore è dato dall’impossibilità di stabilire l’ordine dei privilegi.
L’art. 2780 cod. civ. inserisce infatti il privilegio del
promissario acquirente al punto 5 bis, dopo i crediti
per la concessione delle acque, ai sensi dell’art. 2774
cod. civ., e per i tributi, dell’art. 2772. Questi ultimi
due privilegi non sono però preferiti rispetto ai crediti ipotecari anteriori e quindi, accettando l’ipotesi
del prevalere del privilegio del promissario acquirente, si creerebbe una situazione nella quale non vi
è possibilità di determinare l’ordine dei privilegi.
È stato inoltre sottolineato che l’opposta interpretazione consente facilmente di porre in essere accordi fraudolenti tra venditore ed acquirente, in danno
del creditore ipotecario. La considerazione, eminentemente pratica ma certo non irrilevante, motiva le
perplessità del ceto bancario che usualmente svolge
il ruolo di creditore ipotecario, come peraltro si
evince agevolmente dai precedenti giurisprudenziali
in materia. È infatti chiaro che il creditore ipotecario, qualora si accetti la tesi della prevalenza del privilegio, rischia di vedere lesa la propria garanzia reale a fronte di una trascrizione successiva e quindi,
ovviamente, a lui ignota nel momento dell’iscrizione
dell’ipoteca.
Il rilievo di maggior spessore, ad avviso di chi
scrive, va però rintracciato nella natura del privilegio del promissario acquirente, aspetto centrale anche nella motivazione della sentenza che qui si commenta.
La prevalenza del privilegio sull’ipoteca sancita
dall’art. 2748 cod. civ., quale che sia il momento nel
quale questa ultima è stata iscritta, trova la propria
giustificazione nell’importanza attribuita dal legislatore alla causa del credito; in questo senso infatti il
privilegio costituisce l’evoluzione, nell’ambito del
nostro ordinamento, delle ipoteche privilegiate. Nel
caso del privilegio di cui all’art. 2775 bis cod. civ.
NGCC 2010 - Parte prima
Obbligazioni
l’interesse tutelato è prettamente privato ed è lecito
dubitare che esso giustifichi l’applicazione dell’art.
2748 cod. civ. Non è infatti mancato chi (Tucci, infra, sez. III) ha evidenziato come «l’operatività del
privilegio immobiliare, al di là dello specifico nomen
juris adottato, finisce con l’assimilarsi moltissimo
proprio a quello dell’ipoteca legale di cui all’art.
2817 cod. civ.».
Va inoltre rilevato come il privilegio a favore del
promissario acquirente necessiti della trascrizione,
quale forma di pubblicità dalla quale dipende la sua
stessa esistenza. È quindi assai difficile conciliare la
natura iscrizionale del privilegio con il mancato rispetto della regola prior tempore potior in jure che
regge il sistema della pubbilicatà immobiliare.
3. La soluzione accolta dalle sez. un. Le
sez. un. intervengono con una decisione, ampiamente e pregevolmente motivata, nella specifica materia
del conflitto tra privilegio del promissario acquirente ed ipoteca iscritta in data anteriore.
La sentenza che qui si commenta assume consapevolmente una posizione diametralmente opposta
a quella accolta dalla sez. I della Cassazione (v. infra,
sez. III), nell’unico precedente in sede di legittimità
circa detta materia.
Perno del ragionamento svolto dalle sez. un. è il
testo dell’art. 2748, comma 2o, cod. civ. il quale recita che il prevalere del privilegio dell’ipoteca si ha
solo nel caso in cui «la legge non dispone diversamente». La Supr. Corte opera una lettura sistemica
dell’art. 2748 cod. civ. opinando che la deroga alla
prevalenza del privilegio non deve risultare necessariamente da una norma ma «può e deve essere individuata nell’ordinamento nel suo complesso».
La conclusione raggiunta viene motivata principalmente sulla base di due elementi. In primo luogo
la natura privatistica dell’interesse tutelato, quello
specifico del promissario acquirente, che non giustifica l’applicazione del principio di cui all’art. 2748
cod. civ., il quale storicamente è volto a proteggere
interessi pubblici, evidentemente assenti nella fattispecie di cui si tratta.
Il secondo elemento è costituito dal ruolo essenziale svolto dalla pubblicità immobiliare nell’istituto
del privilegio a favore del promissario acquirente.
La natura iscrizione del privilegio impedisce di considerare irrilevante il principio prior tempore potior
in jure che informa tutto il sistema di pubblicità immobiliare.
Il privilegio a favore del promissario acquirente è
quindi pienamente un privilegio ma ciò non comporta necessariamente il prevalere sull’ipoteca, così
come l’applicazione delle norme sulla pubblicità immobiliare non esclude la qualifica di privilegio al tipo di prelazione in oggetto.
277
Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 - Commento
La Cassazione afferma quindi che «non vige la regola della prevalenza dei privilegi sulle ipoteche, bensì
quella del prior tempore potior in jure che pervade di
sé l’intero sistema della pubblicità».
La sentenza assume una esplicita posizione in linea con la dottrina maggioritaria, alle cui tesi la motivazione della decisione fa chiara eco. L’opposta
posizione, pur reputata sostenibile nell’ambito del
microsistema tracciato dalla l. n. 30/1997, viene tacciata di costituire un approccio «riduttivo ed avulso
dalla visione sistemica dell’istituto».
La parte finale della motivazione evidenzia che le
due espresse deroghe alla prevalenza del privilegio,
indicate dall’art. 2775 bis cod. civ., costituiscono un
sottosistema nell’ambito del sottosistema della trascrizione del preliminare; tali previsioni, secondo la
Supr. Corte, non rivestono alcun valore per la soluzione del conflitto tra privilegio ed ipoteca.
La Cassazione si preoccupa inoltre di sottolineare
come la soluzione adottata consenta di risolvere una
serie di discrasie, quali la disparità di trattamento tra
promissario acquirente insoddisfatto e promissario
acquirente soddisfatto, riduce la possibilità di accordi fraudolenti in danno del creditore ipotecario ed
evita il crearsi di una situazione nella quale non è
possibile determinare l’ordine dei privilegi.
Ad avviso di chi scrive, la sentenza delle sez. un. è
condivisibile in quanto consente di ricondurre ad
unità il sistema della pubblicità immobiliare, lacerato da un intervento legislativo poco attento a coordinare una norma settoriale rispetto alla trama del codice civile. L’opposta soluzione inoltre appare eccessivamente penalizzante per il creditore ipotecario
a fronte di interessi privati che, in quanto tali, non
sembrano giustificare pienamente una così significativa variazione del regime delle garanzie.
III. I precedenti
Il numero di precedenti nella specifica materia
del conflitto tra ipoteca anteriore e privilegio del
promissario acquirente risulta essere limitato. In
dettaglio si ricordano Trib. Reggio Emilia,
18.11.2002, in Fallimento, 2003, 1321, con nota di
Tanzariello, e Trib. Lucca, 23.11.2002, in Arch.
civ., 2003, 416, ma, soprattutto, la prima pronuncia
edita, Trib. Genova, 25.1.1991: quest’ultima risolse il conflitto tra privilegio ed ipoteca anteriore a favore del primo ed è stata oggetto di diversi commenti, caratterizzati da accenti critici (in particolare,
in Banca, borsa, tit. cred., 2001, II, 476, con note di
Tucci, Patroni Griffi e Presti; in Giur. comm.,
2001, II, 656, con nota di Rellini).
La sentenza Cass., 14.11.2003, n. 17197, conclude la vicenda genovese con l’unico precedente della
Supr. Corte specificatamente rivolto alla tematica in
278
Obbligazioni
oggetto, confermando quanto deciso dal Tribunale.
L’accoglienza incontrata dalla decisione è stata assai
critica, anche a causa della scarne motivazioni: si veda Gabrielli, Conflitto fra privilegio del promissario
acquirente ed ipoteca iscritta prima della trascrizione
del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 2004, I,
793, che si duole dell’assenza di riscontri al dibattito
sviluppatosi nella dottrina; in Giur. it., 2005, 286,
con nota di Sicchiero; Zaccaria, Il conflitto fra il
creditore privilegiato ex art. 2775 bis codice civile ed
il creditore ipotecario, in Contratti, 2004, 547; Vocaturo, La trascrizione del preliminare: una mina in
danno dei creditori ipotecari precedenti, in Riv. notar., 2004, 537; Villani, Privilegio del promissario
acquirente e creditori ipotecari, in Dir. fall., 2004, 20.
L’ordinanza di rinvio da parte della prima sez.
della Supr. Corte (Cass., 20.10.2008, n. 25442), che
ha portato alla sentenza qui commentata, si trova
pubblicata in Corr. giur., 2009, 173, con nota di
Agnino.
Circa la configurazione giuridica del contratto
preliminare ad effetti anticipati, quale nota a commento di Cass., 27.3.2008, n. 7930, in questa Rivista, 2008, I, 1046, con nota di Scaliti, ma anche le
osservazioni di Patti, Consegna del bene al momento del preliminare e acquisto della detenzione, ibidem,
II, 284.
IV. La dottrina
Per una prima analisi della l. n. 30/1997, v. Delle
Monache, La trascrizione del contratto preliminare;
Maltone, Trascrizione del preliminare e fallimento,
e Pellegrini, La pubblicità del contratto preliminare nel sistema tavolare, tutti in Nuove leggi civ.
comm., 1998, 3 ss.
Il conflitto tra privilegio a favore del promissario
acquirente ed ipoteca anteriore ha diviso la dottrina
sin dall’apparire della novella legislativa.
La maggioranza della dottrina si è schierata a favore del prevalere dell’ipoteca; in particolare si segnalano: Tucci, Trascrizione del contratto preliminare e privilegio a tutela dei crediti del promissario acquirente, in Riv. crit. dir. priv., 1997, 163; Guglielmucci, Privilegio del credito del promissario acquirente, in Fallimento, 1997, 229; Caccavale-Tassinari, L’ipoteca anteriore non teme la trascrizione del
preliminare, in Notariato, 1997, 106; Luminoso-Palermo, La trascrizione del contratto preliminare: regole e dogmi, Cedam, 1998; Gazzoni, La trascrizione immobiliare, I, nel Commentario Schlesinger,
Giuffrè, 1998, sub art. 2645 bis; Nivarra, La trascrizione del contratto preliminare, in Vita not., 1998,
1382.
A sostegno dell’opposta tesi della prevalenza della trascrizione ricordiamo: Bozza-Canzio, Il priviNGCC 2010 - Parte prima
Cass., 22.9.2009, n. 20409
legio che assiste i crediti del promissario acquirente, in
Dir. fall., 1997, 317; Cian, Alcune questioni in tema
di trascrizione del contratto preliminare, in Riv. dir.
civ., 1997, II, 389. In particolare Delle Monache,
reputa che la legge non introduca alcuna eccezione
al principio fissato dall’art. 2748, comma 2o, e quindi afferma la prevalenza del preliminare trascritto rispetto all’ipoteca anteriore. L’a. peraltro, in attesa di
c CASS. CIV., II sez., 22.9.2009, n. 20409
Conferma App. Napoli, 19.3.2004
Proprietà e diritti reali - Servitù - Servitù di parcheggio - Configurabilità Esclusione (cod. civ., artt. 1027, 1028, 1061)
Il parcheggio dell’auto non rientra nello
schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la «realità» (inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l’auto per specifiche
persone che accedono al fondo non può
valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del
tutto personale dei proprietari.
dal testo:
Il fatto. Con atto di citazione notificato il 28
dicembre 1995 D.P., proprietario di un appartamento in un fabbricato e di un locale deposito posto a destra della rampa d’accesso ai locali
cantinati dello stesso fabbricato, conveniva in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, P.G.
chiedendo che fosse condannato a rimuovere
le autovetture di sua proprietà lasciate in sosta
dinnanzi alla porta d’accesso del locale terraneo di proprietà di esso attore e al risarcimento
dei danni.
Si costituiva il P. opponendo l’esistenza di
una servitù costituita con atto del 28 maggio
1980 a beneficio dell’appartamento della figlia
NGCC 2010 - Parte prima
Proprietà e diritti reali
un intervento del legislatore, auspica che il «diritto
vivente» recepisca l’opposto indirizzo, come peraltro accaduto nella sentenza che qui si commenta,
anche se tale indirizzo «non appare sostenuto da un
apparato argomentativo scevro da forzature».
Luca Ruggeri
A., sita nello stesso edificio, consistente nel diritto di mantenere in sosta un’auto su di una
zona della rampa di circa 15 mq, posta in posizione antistante ai locali seminterrati contraddistinti con i nn. 4 e 5.
Il giudice istruttore disponeva la chiamata in
causa di P.A. e, non avendo alcuna delle parti a
tanto provveduto, disponeva la cancellazione
della causa dal ruolo.
Il D. conveniva quindi nuovamente in giudizio P.G. e P.A. chiedendo che venisse accertata e dichiarata l’inesistenza del preteso diritto
di servitù, sia perché il viale indicato come fondo servente era di proprietà condominiale, sia
perché detta servitù sarebbe stata lesiva dei diritti già acquisiti dal proprietario del box-garage destinato sin dal 1958 al ricovero di autovetture, sia infine perché con la scrittura del 1980
sarebbe stata posta in essere una obbligazione
personale e non sarebbe stato costituito un diritto reale, con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione delle autovetture di loro
proprietà e di ogni ostacolo all’accesso al locale
terraneo.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali
eccepivano in primo luogo la litispendenza con
la causa inizialmente proposta dal D., cancellata dal ruolo, e nel merito deducevano la sussistenza di idoneo titolo di acquisto della servitù
costituito dalla scrittura in data 28 maggio
1980, con la quale, appunto, in favore della loro dante causa era stata trasferita la servitù di
sosta di un’autovettura sulla rampa di accesso
al fabbricato; deducevano altresì che l’attore
non aveva alcun diritto ad utilizzare come garage il locale terraneo, perché non destinato a
tale utilizzazione. Precisavano inoltre che l’ap279
Cass., 22.9.2009, n. 20409
partamento era stato acquistato dalla sola P.A.
e chiedevano l’estromissione dal giudizio di
P.G. e l’autorizzazione alla chiamata in causa
della venditrice G.T.M.N. per essere P.A. garantita dalla evizione anche parziale del diritto
reale trasferitole.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la G.T. eccependo l’inammissibilità della
chiamata e la prescrizione della domanda di riduzione del prezzo. Nei confronti dell’attore
deduceva invece che la rampa non era di proprietà condominiale ma di proprietà esclusiva
di B.L., che con la scrittura del 28 maggio 1980
aveva concesso alla sua dante causa una servitù
di sosta per una sola autovettura su uno spazio
della rampa stessa di 15 mq antistante il locale
seminterrato n. 5 di proprietà del D., lasciando
un corridoio libero della lunghezza di un metro innanzi a detto locale, per consentire il solo
accesso pedonale allo stesso.
Chiedeva quindi che la domanda del D. venisse dichiarata inammissibile per non essere
egli il proprietario del suolo sul quale era esercitata la servitù oggetto di negatoria in subordine, che il difetto di legittimazione del D. venisse dichiarato per non essere condominiale la
rampa in questione e che venisse dichiarato anche il proprio difetto di legittimazione passiva
e quello dei convenuti, giacché la domanda andava proposta nei confronti del B.; in ulteriore
subordine, che venisse dichiarato l’acquisto
della servitù per usucapione, essendo stato
esercitato pacificamente il possesso per oltre
sedici anni.
Disposta ed espletata una ctu, il Tribunale di
Napoli, con sentenza non definitiva in data 17
aprile 2000, accoglieva la domanda e per l’effetto dichiarava la natura condominiale della
rampa d’accesso ai locali seminterrati del fabbricato sito in (Omissis), e dichiarava l’inefficacia nei confronti del D. della scrittura 28 maggio 1980 tra B.L. e P.E., condannando P.A. e
P.G. alla rimozione delle autovetture che impedivano l’accesso al locale terraneo di proprietà dell’attore) condannava i P. al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio; accoglieva la domanda di garanzia proposta nei confronti della G.T., che condannava
a rivalere i P. di quanto da loro dovuto al D. a
titolo di danni.
Proponeva appello G.T.M.N.; si costituiva280
Proprietà e diritti reali
no C.A., vedova D., D.L. e D. A., quali eredi di
D.P., proponendo appello incidentale condizionato; si costituivano altresì G. e P.A., facendo propri tutti i motivi dell’appello principale,
di cui chiedevano l’accoglimento; chiedevano
poi che fosse rigettata la domanda proposta nei
confronti di G., estraneo ai fatti.
Con sentenza depositata il 19 marzo 2004, la
Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello
proposto dall’appellante principale e dai P., dichiarava assorbito l’appello incidentale condizionato e condannava gli appellanti soccombenti al pagamento delle spese del grado.
La Corte riteneva che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione dell’art. 1061 c.c.,
comma 1, giacché il requisito dell’apparenza,
all’esistenza del quale è subordinata la stessa
usucapibilità di una servitù, doveva ravvisarsi
nella presenza di opere permanenti, artificiali o
naturali, obiettivamente destinate all’esercizio
della servitù, visibili, in modo da escludere la
clandestinità del possesso e da farne presumere
la conoscenza da parte del proprietario del
fondo asservito. Il semplice fatto della sosta
dell’autovettura, senza la presenza delle opere
suddette, non poteva quindi ritenersi idoneo
all’acquisto della servitù per usucapione.
La Corte rigettava altresì il motivo di appello
concernente il dedotto difetto di legittimazione
passiva dell’appellante principale, legittimato
essendo B.L., nei confronti del quale, a detta
dell’appellante, si sarebbe dovuta disporre l’integrazione del contraddittorio ai fini dell’accertamento della condominialità o meno della
zona ove veniva lasciata in sosta l’auto. In proposito, la Corte, premesso che nell’actio negatoria servitutis la legittimazione attiva e passiva
compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente,
svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, rilevava che P.A. era certamente legittimata passiva, avendo ella dedotto di essere titolare del diritto di servitù di cui era stato richiesto il riconoscimento. Per altro verso, l’accertamento
della legittimazione del D. ad agire per negatoria servitutis non implicava affatto la partecipazione al giudizio del B., non essendo stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda e non
essendo stato effettuato alcun accertamento.
L’accertamento fatto dal Giudice di primo grado sulla natura condominiale della rampa d’acNGCC 2010 - Parte prima
Cass., 22.9.2009, n. 20409
cesso ai locali seminterrati costituiva poi la
conseguenza di una molteplicità di valutazioni
e argomentazioni tecnico-giuridiche mentre gli
accertamenti del ctu, che secondo l’appellante
sarebbero stati erronei, erano stati recepiti dalla sentenza impugnata solo come analitica descrizione dello stato dei luoghi e degli elaborati
grafici e fotografici.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono A. e P. G. sulla base di tre motivi; resistono,
con controricorso C.A. vedova D., L. e D.A.;
non ha svolto attività difensiva l’intimata
G.T.M. A.
I motivi. Deve preliminarmente essere esaminata e rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dai controricorrenti sul
rilievo che gli attuali ricorrenti avrebbero sostanzialmente prestato acquiescenza alla sentenza definitiva del Tribunale di Napoli, intervenuta ancor prima della sentenza di appello
oggetto del ricorso per cassazione, avendo essi
posto in esecuzione la sentenza definitiva e riscosso, a seguito di intimazione di precetto di
pagamento, l’intero importo liquidato in loro
favore a titolo di garanzia per evizione.
Invero, dalla esecuzione di una sentenza definitiva non può discendere l’effetto di ritenere
venuto meno l’interesse della parte a coltivare
l’impugnazione dalla stessa proposta avverso la
sentenza non definitiva. È noto, infatti, che la
cassazione della sentenza non definitiva, che
abbia pronunciato positivamente sull’an debeatur, comporta la caducazione della sentenza sul
quantum, dipendendo quest’ultima totalmente
alla prima e tenendo conto che essa, una volta
annullata la pronunzia sull’an, viene ad essere
privata del proprio fondamento logico-giuridico, che non può essere sostituito ex post dalla
nuova pronuncia eventualmente emessa in sede di rinvio (Cass. n. 1720 del 2001; Cass. n.
8440 del 2003; Cass. n. 1679 del 2004; Cass. n.
2125 del 2006).
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono
violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e
354 c.p.c.
La sentenza impugnata sarebbe nulla perché
resa in un procedimento che si è svolto con un
contraddittorio non integro. La Corte d’appello ha confermato, dal punto di vista della legittimazione attiva, la legittimazione del D., pur
NGCC 2010 - Parte prima
Proprietà e diritti reali
avendo ribadito la natura condominiale della
rampa d’accesso ai locali terranei. In tal modo,
la Corte d’appello avrebbe violato il principio
per cui, nel caso in cui la domanda sia diretta
all’accertamento della proprietà comune di un
bene e alcuni condomini eccepiscano di essere
proprietari esclusivi in base a titoli ovvero per
intervenuta usucapione, si configura un’ipotesi
di litisconsorzio necessario e il contraddittorio
deve essere integrato nei confronti di tutti i
comproprietari dello stabile. Né potrebbe costituire ostacolo alla deduzione della nullità
della sentenza il fatto che nei precedenti gradi
la questione non sia stata eccepita o rilevata, atteso che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso deve essere rilevata d’ufficio in
ogni stato e grado del giudizio, anche quando
la parte interessata non abbia sollevato la relativa eccezione.
Da qui, la nullità della sentenza d’appello e
di quella di primo grado, con rimessione delle
parti dinnanzi al Tribunale di Napoli.
Il motivo è inammissibile.
È noto, infatti, che “la parte che eccepisce la
non integrità del contraddittorio ha l’onere
non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche
quello di indicare, se l’eccezione è proposta
per la prima volta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la
prova dei presupposti di fatto che giustificano
l’eccezione” (Cass. n. 3688 del 2006; Cass. n.
1632 del 1996). La non integrità del contraddittorio, infatti, “è rilevabile, anche d’ufficio,
in qualsiasi stato e grado del procedimento e,
quindi, anche in sede di giudizio di legittimità,
nel quale la relativa eccezione può essere proposta, anche per la prima volta, nel solo caso in
cui il presupposto e gli elementi di fatto posti a
fondamento della stessa emergano ex se dagli
atti del processo di merito, senza la necessità di
nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività; in tal caso, tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha
l’onere non soltanto di indicare le persone che
debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di
merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei
281
Cass., 22.9.2009, n. 20409
presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione” (Cass. n. 25305 del 2008).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza del motivo,
osta alla ammissibilità dello stesso il rilievo che
i ricorrenti si sono limitati a dedurre la nullità
della sentenza per mancata integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri condomini dell’edificio sito in (Omissis), senza peraltro offrire alcuna indicazione in ordine alla
identificazione dei condomini stessi e, avendo
posto la relativa questione solo in sede di legittimità, senza indicare gli atti del processo di
merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei
presupposti di fatto che giustificano la loro eccezione.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello illegittimamente ritenuto superflua la partecipazione
al giudizio del sig. B.L. (presunto proprietario
delle aree oggetto di causa), sul presupposto
che nei suoi confronti nessuna domanda è stata
proposta e nessun accertamento è stato fatto.
Al contrario, in sede di accertamento della titolarità del suolo oggetto di causa, sarebbe stato
necessario integrare il contraddittorio nei confronti di chi, nelle dichiarazioni dei convenuti e
dal regolamento di condominio, risultava essere l’esclusivo proprietario delle aree stesse. Per
due gradi di giudizio, osservano i ricorrenti, si
è dibattuto sulla natura condominiale di una
porzione di suolo ovvero sulla esclusiva proprietà su di essa in capo ad un singolo condomino, senza disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questo condomino.
Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti fondano la esigenza della integrazione del contraddittorio su una ragione contraddittoria sia rispetto a quanto accertato dalla sentenza impugnata (natura condominiale
della rampa), sia rispetto a quanto da essi stessi
ritenuto nella formulazione del primo motivo
(condominialità dell’area, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio),
laddove, con il motivo in esame, muovono da
una ricostruzione in fatto del tutto contrastante con tali premesse, assumendo che il B. fosse
proprietario esclusivo dell’area in questione.
282
Proprietà e diritti reali
Peraltro, una simile affermazione evoca, per la
sua stessa scrutinabilità, la conoscenza di dichiarazioni e di atti ai quali i ricorrenti fanno
generico riferimento nel motivo di ricorso (in
particolare, il regolamento di condominio), ma
che non riproducono in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Del resto, posto che la Corte d’appello, e
prima il Tribunale, hanno qualificato la domanda proposta dagli attori in termini di actio
natatoria servitutis, e su tale base hanno escluso la legittimazione del B. ad essere parte del
giudizio, e quindi la stessa necessità della integrazione del contraddittorio nei suoi confronti,
il motivo di ricorso presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, non risultando in alcun
modo contestata la premessa sulla base della
quale il Giudice del merito ha escluso la necessità della integrazione del contraddittorio nei
confronti del B.
Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono
violazione e falsa applicazione dell’art. 1061
c.c., nonché vizio di motivazione, censurando
la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse suscettibile di usucapione
la servitù di sosta o di parcheggio, perché non
apparente. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe insufficiente la motivazione della
sentenza impugnata, laddove ha affermato che
il semplice fatto della sosta dell’autovettura
non integrava i requisiti tipici delle servitù apparenti. In tal modo, la Corte d’appello avrebbe anche erroneamente e falsamente interpretato il concetto di apparenza. Con riferimento
alle servitù, infatti, l’apparenza si basa sull’esistenza di indici oggettivi ed evidenti del peso
gravante sul fondo servente; non si comprenderebbe quindi la ragione per la quale la Corte
d’appello non ha riconosciuto l’apparenza di
una servitù di parcheggio esercitata per sedici
anni pacificamente dalla originaria titolare e
poi dai suoi aventi causa. Il semplice fatto della
sosta dell’autovettura, sostengono i ricorrenti,
non può non identificarsi nella presenza di
un’opera visibile, per giunta costantemente
protrattasi per svariati anni e idonea, per struttura e consistenza a testimoniare in modo inequivoco l’esercizio della servitù vantata: l’attività di parcheggio era invero chiaramente visibile da tutti i condomini.
Inoltre, l’esercizio del diritto da parte dei P.
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 22.9.2009, n. 20409
era coerente con la destinazione tipica dell’area, interamente utilizzata proprio per il parcheggio delle autovetture.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, confermando quanto già
affermato dal Tribunale, ha ritenuto che la servitù oggetto di causa non era apparente, rilevando come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il requisito dell’apparenza – senza
del quale, ai sensi dell’art. 1061 c.c., la servitù
non può essere usucapita – consiste nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, così da rivelare per la loro struttura e funzionalità
l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, e – e visibili, in modo da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la
conoscenza al proprietario del fondo asservito.
Ne consegue che questo elemento costitutivo
del diritto reale in re aliena deve interessare
detto fondo e non necessariamente anche altri
luoghi” (Cass. n. 1043 del 2001).
Ha quindi rilevato che “il semplice fatto della sosta dell’autovettura, senza la presenza delle suddette opere, non è idoneo all’acquisto del
diritto di servitù per usucapione”.
Orbene, premesso che “l’accertamento dell’apparenza della servitù, al fine di stabilire se
questa possa essere acquistata per usucapione
o per destinazione del padre di famiglia, è
una quaestio facti rimessa alla valutazione del
giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. n. 1043 del 2001, cit. Cass. n.
3273 del 2005), ritiene il Collegio che la sentenza impugnata sia immune dalle proposte
censure.
Non si presta, ovviamente, a rilievi critici
l’affermazione della Corte d’appello in ordine
ai requisiti dell’apparenza di una servitù, giacché in pronunce ulteriori rispetto a quella citata nella sentenza impugnata, si è ribadito che
“il requisito dell’apparenza, senza del quale, ai
sensi dell’art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita né acquistata per destinazione del
padre di famiglia, deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice
dell’assoggettamento di un fondo ad un altro
per la presenza di opere inequivocamente destinate all’esercizio della servitù e deve conseNGCC 2010 - Parte prima
Proprietà e diritti reali
guentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell’opera e non dal modo in cui questa è stata utilizzata. (In base a questo principio, la Corte di Cassazione ha negato che
l’apertura munita di cancello nel muro di recinzione di un fondo possa astrattamente costituire, di per se, opera visibile e permanente destinata all’esercizio di una servitù di parcheggio)” (Cass. n. 3370 del 1995; Cass. n. 2994 del
2004).
Con riferimento, poi, alla specifica questione
della configurabilità di una servitù di parcheggio, si è precisato che “il parcheggio di autovetture su di un’area può costituire legittima
manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione
di un potere di fatto riconducibile al contenuto
di un diritto di servitù, diritto caratterizzato
dalla cosiddetta realitas, intesa come inerenza
al fondo dominante dell’utilità così come al
fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l’auto per specifiche
persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo
stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio
affatto personale dei proprietari” (Cass. n.
8137 del 2004).
Con l’ulteriore specificazione che “in tema
di possesso, l’utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un’area condominiale ai
fini di parcheggio, non è tutelabile con l’azione
di reintegrazione del possesso di servitù, nei
confronti di colui che – come nel caso di specie
– l’abbia recintata nella asserita qualità di proprietario. Per l’esperimento dell’azione di reintegrazione occorre infatti un possesso qualsiasi
anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i
caratteri esteriori di un diritto reale, laddove il
parcheggio dell’auto non rientra nello schema
di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la “realità” (inerenza al fondo dominante dell’utilità
così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedono al fondo non può
valutarsi come una utilità inerente al fondo
stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto
personale dei proprietari” (Cass. n. 1551 del
2009).
Sotto altro profilo, si è affermato che “il no283
Cass., 22.9.2009, n. 20409 - Commento
stro sistema giuridico non prevede la facoltà,
per i privati, di costituire servitù meramente
personali (cosiddette “servitù irregolari”), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo
finitimo, bensì del singolo proprietario di quest’ultimo, si che siffatta convenzione negoziale,
del tutto inidonea alla costituzione del diritto
reale limitato di servitù, va inquadrata nell’ambito del diritto d’uso, ovvero nello schema del
contratto di locazione o dei contratti affini,
quali l’affitto o il comodato. In entrambi i casi,
il diritto trasferito, attesane la natura personale
ed il carattere obbligatorio, non può ritenersi
ipso facto trasmissibile, in assenza di una ulteriore, apposita convenzione stipulata dall’avente diritto con il nuovo proprietario del bene
“asservito”. (Nella specie, il giudice di merito
aveva qualificato come costitutiva di una duplice servitù, di passaggio e di parcheggio, una
convenzione tra privati con la quale il venditore di un appartamento aveva altresì concesso
all’acquirente, in sede di stipula dell’atto pubblico di alienazione, il diritto d’uso di uno
scantinato al fine di parcheggiarvi un’autovettura – nonché il diritto di passaggio sull’area
che ne consentiva l’accesso –, diritto non riconosciuto, in seguito, dagli eredi dello stesso
venditore. La S.C., nel cassare la pronuncia, ha
sancito il principio di diritto di cui in massima)” (Cass. n. 190 del 1999).
Nel quadro di tali principi, deve quindi
escludersi la sussistenza sia della denunciata
violazione di legge, sia del dedotto vizio di motivazione, atteso che l’affermazione secondo cui
il semplice fatto della sosta dell’autovettura,
senza la presenza di opere permanenti destinate all’esercizio della servitù non è idoneo all’acquisto del diritto di servitù per usucapione, fa
corretta applicazione degli indicati principi in
tema di apparenza e integra idonea motivazione della reiezione del gravame.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti,
in solido tra loro, al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, nella misura indicata in
dispositivo. (Omissis)
[Triola Presidente – Petitti Estensore – Pratis
P.M. (concl. conf.). – P.A. e P.G. (avv. D’Amato) –
C.A., ved. D., D.L. e D.A. (avv. Pizzolla)]
284
Proprietà e diritti reali
Nota di commento: «Considerazioni sull’ammissibilità della servitù di parcheggio»
I. Il caso
Questione controversa e dai risvolti pratici rilevanti, – oltre che di indubbia attualità, nelle relazioni condominiali – concerne la configurabilità, nel
nostro ordinamento, di una c.d. servitù di
parcheggio.
In particolare, il problema posto all’attenzione della Supr. Corte nella pronuncia in esame è rappresentato dallo stabilire se il parcheggio di un’autovettura in uno spazio condominiale sia da inquadrare nell’ambito di una servitù e, in caso di risposta affermativa, se tale servitù di sosta o parcheggio sia suscettibile di usucapione.
Nel caso in discussione, il Tribunale dichiarava la
natura condominiale del fondo su cui veniva esercitata la sosta dell’autovettura e l’inefficacia del titolo
di acquisto con cui sarebbe stata trasferita la (pretesa) servitù e, quindi, condannava alla rimozione dell’autovettura, oltre che al risarcimento dei danni, negando, così, anche l’acquisto della servitù di parcheggio per usucapione.
La Corte d’appello, poi, confermando quanto già
affermato, riteneva che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione dell’art. 1061, comma 1o, cod.
civ., in quanto il semplice fatto della sosta dell’autovettura, senza la presenza di opere permanenti,
obiettivamente destinate all’esercizio della servitù e
visibili, non poteva ritenersi idoneo all’acquisto del
diritto per usucapione.
La Corte di cassazione, infine, rigetta il ricorso e,
dunque, sostanzialmente conferma le pronunce di
merito: in primo luogo – sulla scia di recenti pronunce della Cassazione – negando la possibilità di
configurare una servitù di parcheggio, difettando la
c.d. realitas; in secondo luogo – in aderenza a principi già affermati (Cass., 23.3.1995, n. 3370 e Cass.,
17.2.2004, n. 2994, infra, sez. III) – del pari escludendo la possibilità di un acquisto del diritto di servitù per usucapione, non integrando il semplice fatto della sosta dell’autovettura senza la presenza delle
opere suddette, il requisito dell’apparenza.
La sentenza in esame offre spunti di riflessione
interessanti, consentendo di soffermarsi innanzitutto sul concetto di servitù, quindi sul modo di costituzione del diritto di servitù non apparente, nonché
sugli elementi che valgono a caratterizzare l’apparenza o meno di una servitù e, in particolare, sulla ammissibilità o meno di una c.d. servitù di parcheggio.
È opportuno segnalare fin d’ora che a tale ultima
questione la Cassazione dà risposta negativa, in linea
con l’orientamento giurisprudenziale oggi prevalente (cfr. Cass., 28.4.2004, n. 8137, nonché, più di reNGCC 2010 - Parte prima
Cass., 22.9.2009, n. 20409 - Commento
cente, Cass., 21.1.2009, n. 1551, infra, sez. III, richiamate dalla pronuncia in commento), il quale afferma che «il parcheggio di autovetture su di un’area
può costituire legittima manifestazione di un possesso
a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla
cosiddetta realitas, [...]; in tal caso, invece, ciò che
viene in rilevo è «la mera commoditas di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedano al fondo
(anche numericamente limitate)» che «non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al
fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio
affatto personale dei proprietari».
II. Le questioni
1. Definizione di servitù e ammissibilità di
una servitù di parcheggio. Il primo aspetto da
analizzare è quello relativo alla esatta individuazione
del diritto di servitù.
La servitù è definita dal codice come il «peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo
appartenente a diverso proprietario» (art. 1027 cod.
civ.).
Tuttavia, per comprendere appieno la problematica sottesa al caso in esame, è opportuno precisare
che lo schema risultante dalla definizione codicistica
è da intendere nel senso che la situazione obiettiva
instaurata dalla servitù fra i due fondi si riflette e si
traduce, giuridicamente, in una situazione di vantaggio per il proprietario del fondo dominante ed in una
di svantaggio per il proprietario del fondo servente
(Comporti; Quadri, infra, sez. IV), con rapporto
immanente alla cosa (Messineo, infra, sez. IV).
Caratteristica dello schema legale della servitù è
quella di lasciare largo margine all’autonomia privata nella fissazione del relativo concreto contenuto,
dovendo i privati solo rispettare il «tipo» della servitù, così come delineato dall’art. 1027 cod. civ. (Gazzoni, infra, sez. IV). In sostanza, come si vedrà,
spetta alle parti stabilire in che cosa consista il peso
(Cass., 27.1.1998, n. 791, infra, sez. III). Sotto questo profilo, ben può dirsi che la servitù, come gli altri
diritti reali è tipica, ma soltanto con riguardo alla generica determinazione dei suoi elementi costitutivi
fondamentali, poiché, nel definire i contenuti concreti delle facoltà e dei poteri spettanti al titolare di
una servitù volontaria, i privati godono di ampi margini di libertà, e – non essendo affatto tenuti ad attenersi agli schemi tipici previsti dalla legge (come avviene per le servitù coattive) – possono elaborare figure di servitù sempre diverse e nuove, per adattare
l’istituto alle mutevoli esigenze connesse all’utilizzazione dei fondi, onde da questo punto di vista deve,
piuttosto, reputarsi vigente un profilo di atipicità.
NGCC 2010 - Parte prima
Proprietà e diritti reali
Due sono, peraltro, le condizioni e i limiti posti
dalla norma e cioè, innanzitutto, che i fondi, anche
se non confinanti, siano almeno vicini, così da permettere l’esercizio della servitù (Cass., 10.11.1976,
n. 4142, infra, sez. III); inoltre, che sia ravvisabile
una effettiva utilità, pur se non perpetua ma provvisoria, con il solo limite dell’effimero (Cass.,
22.1.2001, n. 883, infra, sez. III). L’art. 1028 cod.
civ., poi, precisa che tale utilità può consistere anche
nella maggiore comodità, amenità del fondo dominante (Cass., 16.10.2002, n. 14693 e Cass.,
20.10.1997, n. 10250, infra, sez. III) o, per la giurisprudenza, abitabilità (Cass., 20.7.1979, n. 4333, infra, sez. III) o nella sua destinazione industriale.
Ciò significa che la servitù deve tradursi in un
vantaggio, anche di natura non economica, del fondo, in un incremento della utilizzazione di esso
(Comporti). È pertanto necessaria l’esistenza di un
legame strumentale (Branca, infra, sez. IV) e oggettivo, diretto ed immediato fra il peso imposto al fondo servente ed il (godimento del) fondo dominante
(Palazzolo, infra, sez. IV). Proprio un simile carattere di «realità» – correttamente inteso dalla Supr.
Corte come «inerenza al fondo dominante dell’utilità
così come al fondo servente del peso» – è stato escluso dalla pronuncia in commento.
È comune affermazione, inoltre, quella secondo
cui l’utilità non può avere una connotazione soggettiva, ma deve avere un fondamento oggettivo, essa
va riferita, cioè, al fondo nella sua concreta destinazione e conformazione (Comporti; Gazzoni). In
sostanza, l’utilitas, che è lo scopo dell’istituto, caratterizza i limiti, oltre i quali non c’è servitù (Branca),
con la conseguenza che essa deve poter essere tratta
da qualsivoglia proprietario e non essere legata ad
un’attività personale del proprietario del fondo dominante – come ritenuto dalla Supr. Corte nel caso
in esame –, in ciò consistendo la caratteristica della
realità e del riferimento della servitù al fondo e non
al suo proprietario (Cass., 29.8.1991, n. 9232, infra,
sez. III).
Tale indagine può non essere facile, quando si
tratta di stabilire i criteri della comodità e della amenità, normalmente collegati a giudizi soggettivi di
valore: anche in questo caso, però, il giudizio dovrebbe essere dato oggettivamente (Quadri).
Su questa base sono state riconosciute ammissibili, ad es., la servitù che attribuisca al suo titolare il
diritto di mantenere i rami di un albero protesi verso il fondo del vicino (Cass., 15.6.1999, n. 5928, infra, sez. III), ovvero il diritto a non vedere destinate
ad una determinata utilizzazione le costruzioni edificate sul fondo vicino (Cass., 14.8.1997, n. 7614, infra, sez. III), nonché la servitù altius non tollendi
(Cass., 12.4.2006, n. 8572, infra, sez. III) e la servitù
non aedificandi (Cass., 10.4.2000, n. 4499, infra, sez.
285
Cass., 22.9.2009, n. 20409 - Commento
III). Si è, invece, costantemente escluso, come nella
pronuncia in commento, che possa integrare gli
estremi della utilità per il fondo la mera commoditas
di parcheggiare l’auto per singole, determinate persone autorizzate ad accedere al fondo, in base al rilievo che tale commoditas si risolve in un vantaggio
meramente personale per i soggetti che ne godono
(c.d. servitù irregolare o personale).
Ma proprio in applicazione di tali principi di carattere generale, sembra non convincere nella sua
perentorietà l’affermazione della Cassazione, di negare, in via di principio, il carattere della realità alla
possibilità di parcheggiare l’auto su un fondo di un
vicino. Pare, cioè, che in alcuni casi, la concreta
estrinsecazione di tale facoltà possa non costituire
solo una utilità del singolo, ma anche un vantaggio
oggettivo per il fondo.
L’autonomia delle parti potrebbe dar luogo, infatti, ad una atipica (nel contenuto) servitù di parcheggio che insista su un fondo (anche condominiale) per il migliore godimento di altro fondo con particolare destinazione (in ipotesi, ad abitazione) e per
facilitare la sua utilizzazione.
Per individuare quando ciò, in concreto, possa
accadere, pare necessario prendere in considerazione proprio la destinazione economica del fondo: se
esso è un fondo con destinazione abitativa, il vantaggio risulta evidente, se non altro in termini di
valorizzazione economica dello stesso (Acri, infra,
sez. IV). Se esso, invece, è un fondo rustico, l’utilità
sarebbe realmente del singolo proprietario e, allora,
l’eventuale servitù nata in seguito all’accordo andrebbe effettivamente qualificata come irregolare.
Peraltro, l’aumento in quanto tale del valore del
fondo come conseguenza dell’attribuzione di un diritto al proprietario di questo, non si presenta quale
criterio univoco per concludere che si tratti di una
servitù: una cosa è infatti l’incremento del prezzo ed
altra è la migliore utilizzazione dell’immobile, poiché il primo può esserci in casi in cui manca la seconda (benché ciò sia raro) e può ipotizzarsi anche il
caso inverso, in cui l’utilitas non abbia valore economico (Branca).
Un punto è certo: e cioè che si guarda al valore di
uso, non al valore di scambio. Ebbene, stabilire se
v’è aumento del primo è assai più difficile di quello
che non sia per il secondo (Branca). Siccome, a rigore, come detto, non può parlarsi di utilità pura e
semplice di un fondo, indipendentemente da quella
delle persone che usano e godono di esso, in molti
casi, primo fra tutti quello della servitù di parcheggio, è indubbiamente difficile discriminare il vantaggio personale, momento teleologico d’una obbligazione, dal vantaggio conseguito come titolare di una
cosa, scopo del diritto reale. Sarà solo l’indagine del
caso per caso a stabilire quando ciò accada.
286
Proprietà e diritti reali
Una soluzione diversa da quella accolta dalla sentenza in esame, del resto, è stata espressa in passato
dalla stessa Cassazione (Cass., 23.3.1995, n. 3370,
infra, sez. III), che ha qualificato l’uso di un fondo
per sosta e parcheggio di autovettura come esercizio
del possesso corrispondente ad una servitù (di sosta
e di parcheggio, appunto), escludendo, però, la possibilità di acquisto per usucapione della stessa servitù, atteso il suo carattere non apparente.
2. L’apparenza delle servitù. La Supr. Corte,
ribadendo principi già espressi da precedenti pronunce (Cass., 23.3.1995, n. 3370 e Cass., 17.2.2004,
n. 2994, infra, sez. III), afferma che «il requisito dell’apparenza, senza del quale, ai sensi dell’art. 1061
c.c., la servitù non può essere usucapita» [...], «deve
essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di
per sé rivelatrice dell’assoggettamento di un fondo ad
un altro per la presenza di opere inequivocamente destinate all’esercizio della servitù e deve conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell’opera e non dal modo in cui è stata utilizzata».
In base a questo principio, la Corte di cassazione
ha negato che il semplice fatto della sosta dell’autovettura – pur esercitato per sedici anni pacificamente dalla originaria titolare e poi dai suoi aventi causa
e pur trattandosi di un’attività chiaramente visibile
da tutti i condomini – possa astrattamente costituire, di per sé, opera visibile e permanente destinata
all’esercizio di una servitù di parcheggio, idoneo all’acquisto del diritto stesso per usucapione.
Di tale questione la Supr. Corte si occupa in un
passaggio logico precedente a quello in cui nega la
stessa realità del diritto in esame: ciò in coerenza
con la giurisprudenza (Cass., 25.1.2001, n. 1043, infra, sez. III), la quale espressamente afferma che
«l’accertamento dell’apparenza della servitù, al fine di
stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è una
quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice del
merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità quando in proposito detto giudice abbia reso sufficiente ragione immune da vizi logici e giuridici».
Quanto al concetto di apparenza, è noto che l’art.
1061, comma 2o, cod. civ. individua tale requisito in
termini negativi, con la conseguenza che può dirsi,
con la giurisprudenza dominante (v., in senso conforme a Cass., 25.1.2001, n. 1043; Cass.,
17.12.1999, n. 14220 e Cass., 5.3.1987, n. 2323, infra, sez. III), che esso «consiste nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente
destinate al suo esercizio, così da rilevare per la loro
struttura e funzionalità l’esistenza del peso gravante
sul fondo servente e visibili, in modo da escludere la
clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito».
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 22.9.2009, n. 20409 - Commento
In particolare, la permanenza indica che non si
tratta di un’attività di natura precaria e provvisoria,
ma di un onere preciso, a carattere stabile, e ne
esclude la mera tolleranza da parte del titolare del
fondo gravato. La visibilità, come è intuibile, esclude la clandestinità del possesso (Branca), con la
precisazione, però, che non basta la presenza di segni visibili (come, ad es., una scritta o un cartellone),
ma è necessario che essi abbiano un carattere, per
così dire, funzionale o strumentale e che si concretino in opere dirette ad esercitare la servitù.
La giurisprudenza, pur avendo adottato un criterio piuttosto elastico per l’individuazione dell’apparenza o meno di una servitù, sostenendo, ad esempio, che non è necessario che l’apparenza si estenda
all’opera nel suo complesso, che la apparenza va verificata caso per caso in relazione al concreto stato
dei luoghi (Cass., 24.4.1990, n. 3441, infra, sez. III),
che l’opera può essere ubicata anche nel fondo dominante, purché sia visibile dal fondo servente
(Cass., 11.8.1989, n. 3695, infra, sez. III), ha comunque affermato che il requisito dell’apparenza
deve risultare in modo chiaro e certo, senza bisogno
di particolari indagini o ricerche da parte di colui
che subisce la servitù. In applicazione di tali principi, la Supr. Corte ha così escluso, ad es., l’apparenza
nella servitù di riscaldamento, correlandosi la stessa
alla installazione di tubi e di impianti non visibili dal
presunto immobile servente (Cass., 16.1.1998, n.
321, infra, sez. III), così come ha escluso l’apparenza
nella servitù di immissioni (App. Catania,
14.1.1992, infra, sez. III).
Alla luce di quanto accennato, allora, si ritiene di
poter condividere, sul punto, la decisione della Supr. Corte che esclude, come si è già avuto modo di
sottolineare, l’apparenza della pretesa servitù. Anche tale affermazione, tuttavia, non deve essere intesa in senso assoluto, in quanto non sembra potersi
escludere, nel caso concreto, la presenza di opere visibili e permanenti denotanti l’effettivo esercizio di
una servitù di parcheggio, suscettibile, perciò di acquisto per usucapione.
In assenza del requisito indispensabile dell’apparenza e della relativa possibilità di acquisto per usucapione può, semmai, discutersi se gli atti posti in
essere dal proprietario del fondo preteso dominante
possano integrare un comportamento semplicemente tollerato iure familiaritatis da parte del proprietario servente e, dunque, esercitati soltanto sulla base
dei cosiddetti rapporti di buon vicinato.
A tale conclusione, come visto, però, la Corte non
approda, negando, nella specie, il carattere stesso
della realità proprio di ogni diritto di servitù e configurando in tali ipotesi – sulla scia di una precedente pronuncia (Cass., 11.1.1999, n. 190, infra, sez.
III) – una «convenzione negoziale», inquadrabile
NGCC 2010 - Parte prima
Proprietà e diritti reali
«nell’ambito del diritto d’uso, ovvero nello schema
del contratto di locazione o dei contratti affini, quali
l’affitto o il comodato».
III. I precedenti
La decisione in esame si legge anche in Dir. e
giust., 2009, con nota di Gallucci.
In senso conforme alla sentenza annotata, negano
carattere di realità alla possibilità di parcheggiare
l’auto sul fondo altrui, Cass., 28.4.2004, n. 8137, in
Rep. Foro it., 2004, voce «Servitù», n. 9 e, più di recente, Cass., 21.1.2009, n. 1551, in Dir. e giust.,
2009, la quale, al riguardo, afferma che «se il parcheggiare l’auto può essere una delle tante manifestazioni di un possesso a titolo di proprietà, non può, invece, dirsi che tale potere di fatto sia inquadrabile nel
contenuto di un diritto di servitù, posto che caratteristica tipica di detto diritto è la “realità”, e cioè l’inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso». Nella specie, invero, il fatto
che un certo numero di condomini acceda all’area
per parcheggiare l’auto non si può valutare come
utilità che riguarda il fondo: rappresenta invece una
comodità e un vantaggio personale per i proprietari
degli immobili.
In senso contrario, configura la possibilità di un
possesso (anche se non utile ai fini dell’usucapione)
della servitù di parcheggio, Cass., 23.3.1995, n.
3370, in Mass. Foro it., 1995 e in Rep. Foro it., 1995,
voce «Servitù», n. 22, che dichiara essere «senz’altro
corretta l’affermazione che l’accoglimento dell’azione
di reintegra limitatamente al parcheggio di un’autovettura sul tratto di terreno, per cui è causa, dimostra
la sussistenza del possesso del parcheggio, ma non dimostra affatto l’intervenuta usucapione del diritto di
proprietà sull’intero terreno». Sulla teorica ammissibilità del possesso di una servitù di parcheggio, a
prescindere dalla problematica relativa all’apparenza di questa, v., anche, Trib. Nola, ord. 27.9.2005,
ined., che espressamente richiama Cass., 23.3.1995,
n. 3370, il quale sottolinea che la «rilevanza che è venuta ad assumere nell’epoca moderna la possibilità di
disporre di spazi a parcheggio “connessi” al diritto di
proprietà – tanto che si sono succeduti diversi interventi normativi volti a “legare” imprescindibilmente
le aree a ciò destinate, al diritto di proprietà sull’immobile, quali accessioni del diritto stesso –» fa comprendere «come non possa revocarsi in dubbio che
l’utilizzazione di tali porzioni rivesta il carattere della
realità, a vantaggio del fondo dominante». Su tale ultimo aspetto, infatti, giova sottolineare che la giurisprudenza ha ribadito che le aree di parcheggio possono essere validamente alienate separatamente solo
se rimangono a servizio delle costruzioni mediante
un vincolo reale di destinazione, che può consistere
287
Cass., 22.9.2009, n. 20409 - Commento
in una servitù di parcheggio: cfr., ad es., Cass.,
9.5.1991, n. 5180, in questa Rivista, 1992, I, 663,
con nota di Fusaro.
Sui caratteri, in generale, delle servitù, Cass.,
10.11.1976, n. 4142, in Giust. civ., 1977, I, 1608;
Cass., 22.1.2001, n. 883, in Riv. notar., 2001, 1469.
Sulla costituzione della servitù volontaria, Cass.,
14.8.1997, n. 7614, in Giur. it., 1998, 2289. In riferimento all’atipicità contenutistica delle servitù, v.
Cass., 27.1.1998, n. 791, ibidem, 2038. Sull’utilità,
Cass., 16.10.2002, n. 14693, in Riv. notar., 2003,
1012; Cass., 20.10.1997, n. 10250, in questa Rivista,
1998, I, 605; Cass., 20.7.1979, n. 4333, in Rep. Foro
it., 1979, voce «Servitù», n. 4; Cass., 29.8.1991, n.
9232, ivi, 1991, voce cit., n. 4. Sui «tipi» di servitù,
Cass., 15.6.1999, n. 5928, ivi, 1999, voce cit., n. 25;
Cass., 10.4.2000, n. 4499, ivi, 2000, voce cit., n. 20;
Cass., 12.4.2006, n. 8572, ivi, 2006, voce cit., n. 12.
Sulle servitù irregolari, Cass., 11.1.1999, n. 190, in
Studium iuris, 1999, 570 ss., afferma espressamente
che «nel nostro sistema giuridico non sono ammissibili
servitù personali (ovvero irregolari), intese come limitazioni al diritto di proprietà su una cosa a vantaggio di
una persona. Pertanto, la convenzione attraverso la quale si raggiunge il detto risultato, o è costitutiva di un diritto d’uso oppure rientra nello schema della locazione o
dei contratti affini, quali l’affitto o il comodato. In entrambi i casi, il diritto trasferito è di natura personale, il
suo contenuto ha carattere obbligatorio, e pertanto non
è trasferibile», in assenza di una ulteriore, apposita
convenzione stipulata dall’avente diritto con il nuovo
proprietario del bene «asservito».
Sul punto, la sentenza conferma, in sostanza, l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, al fine di costituire validamente il diritto
di servitù, occorre che sussista un’obiettiva utilità,
ossia un vantaggio riconducibile alla situazione ed
alla destinazione obiettiva del fondo dominante. In
tal senso, v., anche, Cass., 22.10.1997, n. 10370, in
Mass. Giust. civ., 1997; Cass., 25.1.1993, n. 832, in
Rep. Foro it., 1993, voce «Servitù», nn. 37-38; Cass.,
29.8.1991, n. 9232, ivi, 1991, voce cit., n. 4, nella cui
massima si precisa che il criterio da utilizzare per distinguere il rapporto reale da quello obbligatorio va
individuato nel vantaggio, che deve essere voluto
non come risultato di una prestazione, bensì come
peso imposto al fondo.
Sul concetto di apparenza delle servitù, in generale, cfr. Cass., 25.1.2001, n. 1043, in Mass. Giust. civ.,
2001, dove si afferma, in massima, che «il requisito
dell’apparenza – senza del quale, ai sensi dell’art. 1061
c.c., la servitù non può essere usucapita – consiste nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali,
obiettivamente destinate al suo esercizio, così da rivelare per la loro struttura e funzionalità l’esistenza del
peso gravante sul fondo servente, e visibili, in modo da
288
Proprietà e diritti reali
escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito.
Ne consegue che questo elemento costitutivo del diritto reale “in re aliena” deve interessare detto fondo e
non necessariamente anche altri luoghi». In senso
conforme, anche in riferimento all’acquisto del diritto per usucapione, Cass., 17.12.1999, n. 14220, in
Rep. Foro it., 1999, voce «Servitù», n. 24 e Cass.,
5.3.1987, n. 2323, ivi, 1987, voce cit., n. 30; nonché,
di recente, Cass., 4.9.2003, n. 12898, in Giur. it.,
2005, 287 ss., con nota di Manuli. Cfr., inoltre,
Cass., 24.4.1990, n. 3441, in Rep. Foro it., 1990, voce
cit., n. 13; Cass., 11.8.1989, n. 3695, ivi, 1989, voce
cit., n. 8; nonché, Cass., 17.2.2004, n. 2994, ivi,
2004, voce cit., nn. 21, 24 a 26, interessante laddove
sottolinea, tra l’altro, la necessità, per la configurazione del requisito dell’apparenza, di un «quid pluris» che dimostri la specifica destinazione delle opere visibili e permanenti all’esercizio della servitù. Infine, v. Cass., 23.2.1987, n. 1912, ivi, 1987, voce cit.,
n. 28, che, in relazione alla servitù di passaggio, accoglie un concetto elastico di apparenza, affermando
che «ai fini della sussistenza del requisito dell’apparenza, richiesto dall’art. 1061 c.c., per l’acquisto delle
servitù prediali per usucapione (o per destinazione del
padre di famiglia), non occorre necessariamente, in
materia di servitù di passaggio, un opus manufactum
(ossia un tracciato dovuto all’opera dell’uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti
un tracciato tale da denotare la sua funzione – visibile,
non equivoca e permanente – di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente».
Non ritiene apparente la servitù di riscaldamento,
Cass., 16.1.1998, n. 321, in Corr. giur., 1998, 1056
ss., con nota di Cesare; del pari, si nega l’apparenza
della servitù di immissioni in App. Catania,
14.1.1992, in questa Rivista, 1992, I, 888 ss., con nota di Maugeri.
Sull’apparenza della servitù di parcheggio, v. Cass.,
23.3.1995, n. 3370, la quale ha negato che l’apertura
munita di cancello nel muro di recinzione di un fondo
possa astrattamente costituire, di per sé, opera visibile e permanente destinata all’esercizio di una servitù di
parcheggio; nonché, Trib. Trieste, 13.10.1992, in
Giur. it., 1993, I, 2, 520 e Trib. Nola, ord. 27.9.2005,
che, più in generale, in relazione al possesso di servitù
non apparenti precisa che «nonostante una parte della
dottrina affermi che non sia possibile il radicamento del
possesso di una servitù nel caso in cui questo non sia suscettibile di evolversi in possesso valido ai fini dell’usucapione per difetto dell’elemento dell’apparenza (ed anche una servitù di parcheggio per la sua usucapibilità richiede l’esistenza di opere stabili che la connotino, non
essendo sufficiente, ovviamente, il mero posizionamento del veicolo che costituisce l’oggetto e non il mezzo del
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 22.9.2009, n. 20409 - Commento
suo esercizio), l’unanime giurisprudenza è incline, invece, a riconoscere il mero possesso di fatto anche delle servitù non apparenti, sulla scorta del rilievo difficilmente
contestabile che i profili sono distintamente trattati in
ambito codicistico e che la tutela di fatto del possesso è
cosa diversa da quella volta all’accertamento dell’usucapione».
Sul principio di solidarietà nel condominio, Trib.
Milano, 7.5.1992, in Arch. loc., 1994, 139, che si riferisce espressamente alle esigenze particolarmente
rilevanti connesse ai principi di uguaglianza e di solidarietà anche costituzionalmente protetti; Cass.,
18.11.1975, n. 3872, in Giust. civ., 1976, I, 1140, che
dal principio di solidarietà spiega come «nei rapporti
tra il gruppo ed i singoli siano possibili limitazioni e
tutele più estese – ancorché di applicazione relativamente elastica – di quelle – di applicazione rigida –
che operano nei rapporti di vicinato».
IV. La dottrina
Sulla definizione e i caratteri della servitù, in generale, cfr. Messineo, Le servitù, Giuffrè, 1949, 7;
Comporti, Diritti reali in generale, nel Trattato Cicu-Messineo, VIII, Giuffrè, 1980, 55, 207, 220, 239;
Id., Le servitù prediali, nel Trattato Rescigno, 8,
Utet, 1982, 153 ss.; Branca, Proprietà, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1987, 7 ss.;
Palazzolo, voce «Servitù», in Enc. giur. Treccani,
XXVIII, Ed. Enc. it., 1992, 1 ss.; Bianca, Diritto civile, 6, La proprietà, Giuffrè, 1999, 637 ss.; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Esi, 2007, 261 ss.;
Quadri, in Bocchini-Quadri, Diritto privato,
Giappichelli, 2008, 444 ss.
Per l’astratta ammissibilità di una servitù di parcheggio, Acri, È ammissibile il possesso di una servitù di parcheggio?, in Giurisprudenza civile, a cura
di Caringella-Garofoli-Giovagnoli, Giuffrè,
2005, 647 ss.
Sull’utilità, v. Quadri, 444, che ne sottolinea il carattere obiettivo, affermando che «l’esistenza della
servitù deve valere a conferire ai fondi una vera e propria qualità [...], inerendo l’utilità da essa offerta, insomma, al fondo di cui viene ad accrescere il valore»,
criterio questo da utilizzare anche «per distinguere la
ricorrenza di una servitù prediale da un rapporto di
natura esclusivamente personale tra le parti».
Sul possesso e l’usucapibilità delle servitù, v.
Branca, 302 ss., il quale afferma che «qualunque
servitù, purché sia apparente, può acquistarsi per
usucapione e per destinazione del padre di famiglia:
il codice ha accolto la dottrina migliore secondo la
quale anche le servitù per il cui esercizio è necessario il fatto dell’uomo (discontinue) ammettono un
possesso vero e proprio ed è, invece, questione di
merito il vedere se gli atti d’esercizio corrispondenti
NGCC 2010 - Parte prima
Proprietà e diritti reali
si debbano considerare, semmai, come atti di semplice tolleranza, che non conducono all’usucapione.
Per quest’ultima, [...], il codice si accontenta del requisito dell’apparenza». Tuttavia, continua Branca,
«la presunzione di precarietà o clandestinità (in caso
di servitù non apparenti) basta a giustificare il principio con cui si nega l’acquisto per usucapione, ma
non a escludere il possesso e la sua tutela». Infatti,
«una cosa è l’apparenza ed altra è l’esercizio effettivo del potere di fatto: vi possono essere sui fondi
opere visibili ecc., eppure non esserci il possesso
con l’animus utendi jure servitutis: e allora (se si tratta di due fenomeni distinti) come pretendere l’inverso e cioè che il possesso ad ogni modo non vi sia
quando tali opere mancano?». Ancora, significativo
Branca, 306, laddove sottolinea il fondamento del
requisito dell’apparenza richiesto dall’art. 1061 cod.
civ., al pari del cod. civ. 1865, ricavabile dalla Relazione al re (n. 504): a differenza che negli altri diritti
reali, «nelle servitù, non solo il contenuto ha normalmente un’estensione limitata, in modo tale che
gli atti d’esercizio corrispondenti, anche se compiuti
alla luce del sole possono sfuggire; ma in esse si utilizzano i fondi a vantaggio di altri fondi, normalmente vicini, per esigenze determinate dalla stessa
posizione o situazione di questi: vale a dire che, con
la costituzione del diritto reale, si va incontro a bisogni o si realizzano utilità a cui sopperiscono talora
anche senza convenzione i normali e reciproci rapporti di buon vicinato: ciò che si impedirebbe a un
estraneo non si nega al vicino, tanto più in quanto
gli si dovranno chiedere eventualmente analoghi
servigi. Sorge, dunque il sospetto o il dubbio che
certe utilizzazioni parziali d’un fondo a favore d’un
altro debbano considerarsi, invece che come un possesso d’un diritto di servitù, come atto o serie di atti
tollerati jure familiaritatis». [...] «Per eliminare questo dubbio, il legislatore esige espressamente la presenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù».
Sulla questione se si applichino le norme sulle servitù nel caso di costituzione di un peso sulla proprietà comune condominiale a favore della proprietà esclusiva di un condomino nell’ambito del condominio, cfr. Salis, Il condominio negli edifici, Utet,
1959, 95, il quale afferma che costituisce imposizione di una servitù e, quindi, innovazione l’imposizione a vantaggio di una proprietà esclusiva di un peso
sulla cosa comune che la destinazione della cosa in
sé non consentirebbe. Non costituisce servitù prediale e, quindi, non si richiede il consenso degli altri
condomini, quando, a vantaggio di un alloggio, si è
costituito un peso sulla cosa comune che risponda,
però, alla destinazione della cosa stessa.
Floriana Esposito
289
Cass., 28.8.2009, n. 18805
c CASS. CIV., III sez., 28.8.2009, n. 18805
Responsabilità civile / Danni civili
dal testo:
Cassa App. Milano, 28.11.2003
Responsabilità civile - Prestazione
sanitaria complessa - Disciplina Contratto con la clinica relativo
alla sola degenza - Contratto con il
chirurgo relativo all’atto medico Ammissibilità - Prova certa e rigorosa dei due contratti e del loro contenuto - Necessità (cod. civ., artt. 1176,
1218, 2236; cod. proc. civ., art. 189) (a)
Responsabilità civile - Prestazione
sanitaria complessa - Esito negativo
imputabile ad una molteplicità di
fattori - Soggetto imputabile - Assunzione dell’organizzazione e del
coordinamento dell’attività - Soggetto responsabile (cod. civ., artt. 1228,
2043, 2049) (b)
Danni civili - Risarcimento in via
equitativa - Liquidazione - Indicazione dei criteri utilizzati - Necessità
(cod. civ., artt. 1226, 2043, 2059) (c)
(a) Qualora una prestazione sanitaria sia
concordata attraverso due separati accordi, è richiesta la prova certa e rigorosa
dell’esistenza dei due contratti, con
espressa specificazione delle prestazioni
incluse nell’uno e nell’altro e dei soggetti
su cui gravano le conseguenti responsabilità.
(b) Qualora il risultato negativo dell’intervento o della cura sia o possa essere il
frutto del concorso di una molteplicità di
fattori, non sempre agevolmente distinguibili fra loro, va imputata la responsabilità a chi, avendone assunti l’organizzazione e il coordinamento, sia in grado di individuare gli effettivi responsabili ben più e
meglio che non il paziente danneggiato.
(c) Il giudice, pur quando decida in via
equitativa, deve indicare i criteri ai quali
ha voluto fare riferimento per determinare la somma dovuta.
290
Il fatto. Con atto di citazione notificato il 2 e
il 12.10.1995 B. S. ha convenuto davanti al Tribunale di Monza la s.p.a. Clinica (Omissis), di
(Omissis), e il Dott. D.C.P. F.I., chirurgo estetico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti
a seguito di un intervento di ingrandimento del
seno, liposuzione delle cosce e rinoplastica, il
primo dei quali aveva dato risultati negativi, residuando cicatrici deturpanti, che non era stato
possibile eliminare, nonostante due successivi
interventi chirurgici riparatori.
Ciò le aveva provocato gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali, considerato che essa,
appena ventenne all’epoca del fatto, aveva iniziato l’attività di indossatrice e di dimostratrice
di capi d’abbigliamento prodotti dall’azienda
di famiglia.
I convenuti si sono costituiti, il D.C. negando la sua responsabilità e la Clinica (Omissis)
eccependo la sua carenza di legittimazione passiva, poiché il chirurgo non era suo dipendente
o collaboratore, ma utilizzava episodicamente
la Clinica per gli interventi sui suoi pazienti.
Esperita l’istruttoria anche tramite CTU, con
sentenza n. 1630 del 2001, il Tribunale di
Monza ha condannato i convenuti, in via solidale, a pagare in risarcimento dei danni la somma complessiva di L. 229.993.000, oltre interessi dalla data della sentenza.
Proposto appello principale dalla B. e incidentale dalla Casa di cura, e rimasto contumace il
D.C., con sentenza 28 ottobre-28 novembre
2003 n. 3273 la Corte di appello di Milano, in
parziale riforma, ha condannato gli appellati a
pagare, in aggiunta alle somme liquidate dal Tribunale, Euro 15.000,00 in risarcimento dei danni patrimoniali ed Euro 5.834,00, in rimborso
dei costi di un intervento chirurgico riparatore,
non liquidati in primo grado; oltre rivalutazione
monetaria ed interessi su entrambe le somme.
Con atto notificato il 7.1.2005 la B. propone
un motivo di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso la Clinica, proponendo quattro motivi di ricorso incidentale.
La ricorrente ha depositato memoria.
I motivi. 1. – Va preliminarmente disposta la
riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 28.8.2009, n. 18805
2. – Premesso che risulta definitivamente accertata la responsabilità personale del chirurgo, non essendo stata impugnata sul punto la
sentenza del Tribunale, conviene prendere anzitutto in esame il primo motivo del ricorso incidentale, che concerne l’estensibilità alla Clinica (Omissis) della responsabilità per i danni
subiti dalla B., mentre gli altri motivi, principali e incidentali, riguardano la quantificazione
dei danni.
Denunciando violazione degli artt. 1176,
1228, 2043, 2049 e 2236 cod. civ., art. 189
c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della
controversia, la Clinica (Omissis) assume di
non dover rispondere personalmente e solidalmente dell’operato del chirurgo, come ha disposto la Corte di appello, poiché la B. ebbe a
concordare l’esecuzione dell’intervento esclusivamente e direttamente con il Dott. D.C. P.,
e fu quest’ultimo, non la paziente, a scegliere
la clinica nella quale eseguire l’intervento, a
prenotare la camera e la sala operatoria ed a
riscuotere direttamente dalla cliente il proprio
onorario.
Rileva la ricorrente che il chirurgo non era
legato da alcun rapporto di lavoro dipendente
o di collaborazione stabile con la Clinica,
presso la quale eseguiva solo sporadicamente
interventi chirurgici per la sua personale clientela; che la B. pagò alla Clinica solo le fatture
relative alla degenza, mentre i compensi per
l’intervento chirurgico e per le prestazioni dell’anestesista erano stati da lei direttamente pagati al D.C.; che il rimanente personale della
Clinica non ha svolto alcuna attività in favore
della B.
Assume che la responsabilità dell’ente ospedaliero può essere affermata solo in relazione
all’inadempimento di obbligazioni proprie
dell’ente stesso, obbligazioni non sussistenti
nel caso di specie, ove non è prospettabile alcuna sua responsabilità contrattuale, per mancanza di accordo diretto fra essa e la B.; né alcuna responsabilità extracontrattuale, essendo
la colpa dell’accaduto da ascrivere solo al chirurgo.
Richiama la giurisprudenza di questa Corte
secondo cui – ove la prestazione medica sia stata direttamente concordata fra medico e paziente – la responsabilità dell’ospedale può esNGCC 2010 - Parte prima
Responsabilità civile / Danni civili
sere affermata solo per l’inadempimento delle
obbligazioni a carico dello stesso (Cass. civ. n.
9556/2002).
2.1. – Il motivo non è fondato.
La ricorrente assume, nella sostanza, che la
B. avrebbe concluso un contratto con la Clinica, relativo alla degenza, ed altro separato contratto con il chirurgo, avente ad oggetto l’intervento operatorio.
Essendosi i danni verificati solo per errore
del chirurgo, la Clinica non dovrebbe risponderne.
Premesso che non si può escludere, in linea
di principio ed in astratto, che le parti liberamente assumano accordi di tal genere, è indubbio che una tale, inconsueta regolamentazione
richiederebbe quanto meno la prova certa e rigorosa dell’esistenza dei due separati contratti,
con espressa specificazione nelle relative clausole – approvate dal paziente in piena libertà e
consapevolezza – delle prestazioni incluse nell’uno e nell’altro e dei soggetti su cui gravano
le conseguenti responsabilità (nei limiti in cui
la legge permette l’esplicarsi dell’autonomia
privata in materia), considerato che non è sempre agevole parcellizzare e separare fra loro i
diversi contributi inerenti ad una prestazione
sanitaria complessa quale un intervento chirurgico (quali sono le prestazioni incluse nella degenza? Solo il vitto e l’alloggio? Chi risponde
delle prestazioni pre e post operatorie? Chi è
responsabile delle medicazioni e delle terapie,
quanto alla prescrizione e quanto all’esecuzione e somministrazione dei medicamenti? come
si valuta il concorso fra le ipotetiche negligenze? ...).
Nella specie nulla di tutto ciò risulta dimostrato ed è chiaro che si tratta di un modello a
dir poco inconsueto e difficilmente praticabile.
La Corte di appello ha assunto la sua decisione sul presupposto che i fatti si siano svolti
in modo diverso, cioè secondo il modello consueto, nel senso che la B. ha preso per la prima volta contatto con il D.C.P. e – una volta
deciso di sottoporsi all’intervento chirurgico –
si è rivolta alla Clinica alla quale il chirurgo
l’ha indirizzata, per ottenere la prestazione
chirurgica unitamente a tutte le prestazioni accessorie, mediche e non, senza alcuna separazione o delimitazione di competenze e responsabilità.
291
Cass., 28.8.2009, n. 18805
La Corte di appello ha altresì accertato che
all’intervento chirurgico ha partecipato anche
personale medico alle dipendenze della Clinica: vi hanno partecipato, in particolare, il direttore del reparto con mansioni di aiuto chirurgo, e l’anestesista.
Su questi presupposti, giustamente ha affermato la responsabilità solidale della Clinica per
l’esito infausto dell’intervento.
Ed invero, ove un istituto ospedaliero autorizzi un chirurgo od un medico ad operare al
suo interno, mettendogli a disposizione le sue
attrezzature e la sua organizzazione, e con esso
cooperi, concludendo con il paziente il contratto per la degenza e le prestazioni accessorie, esso viene ad assumere contrattualmente,
rispetto al paziente, la posizione e le responsabilità tipiche dell’impresa erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa
l’attività del chirurgo.
La circostanza che il paziente sia pervenuto
alla clinica solo attraverso il medico e per sua
indicazione rimane irrilevante (cfr., fra le altre,
Cass. civ. S.U., 1 luglio 2002 n. 9556; Cass. civ.
Sez. III, 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. civ.
Sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698).
Ed invero, il medico non avrebbe potuto operare se non nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera ed, accettandone l’attività, la casa di cura
ha assunto le conseguenti responsabilità.
Non si può certo ammettere che un ente
ospedaliero dia accesso a chiunque si presenti,
senza averne previamente verificati i titoli di
abilitazione, la serietà, la competenza e affidabilità, anche in relazione alle esperienze pregresse, per poi trasferire sui pazienti gli effetti
dannosi dell’eventuale imperizia dell’operatore, adducendo a motivo di averlo solo estemporaneamente ospitato.
Si consideri, ancora, che la suddetta ospitalità non è prestata a titolo gratuito, in quanto la
casa di cura trae vantaggio quanto meno dalle
rette di degenza pagate dai clienti introdotti
dal medico esterno, se non anche dall’eventuale corrispettivo versato dallo stesso. Traendo
un utile dall’attività, l’impresa ospedaliera non
può poi sottrarsi ai conseguenti rischi.
Infine, il risultato dell’intervento o della cura
è o può essere il frutto del concorso di una
molteplicità di fattori, non sempre agevolmente distinguibili fra loro, di cui va imputata la re292
Responsabilità civile / Danni civili
sponsabilità a chi, avendone assunti l’organizzazione ed il coordinamento, sia in grado di individuare gli effettivi responsabili ben più e
meglio che non il paziente danneggiato.
Sotto ogni profilo, pertanto, la decisione della Corte di appello di estendere alla Clinica
(Omissis) la responsabilità per l’operato del
D.C.P. appare conforme alla legge.
3. – Con l’unico motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 2043 e
2059 c.c. e l’omessa o insufficiente motivazione, quanto alla liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’invalidità temporanea e permanente.
3.1. – Quanto ai danni patrimoniali, deve essere preliminarmente disatteso il terzo motivo
del ricorso incidentale – che viene congiuntamente esaminato – che denuncia l’insufficiente
e contraddittoria motivazione sul punto, poiché la danneggiata non avrebbe fornito la prova di avere svolto attività remunerata come
modella, né la prova della diminuita capacità
lavorativa.
La sentenza appare sul punto adeguatamente motivata, con il richiamo degli elementi di
prova da cui la Corte ha tratto il suo convincimento e pertanto non appare censurabile, essendo la valutazione delle prove rimessa alla
discrezionalità del giudice di merito, con il solo
limite dell’adeguata motivazione.
3.2. – La ricorrente principale contesta invece il medesimo capo della decisione sotto il
profilo dell’entità della liquidazione, sul rilievo
che la Corte di appello – pur avendo riconosciuto che le lesioni le causeranno la perdita di
chances lavorative, tenuto conto della documentazione acquisita agli atti circa la sua attività di modella e fotomodella – ha quantificato il
danno in termini sostanzialmente arbitrari,
senza indicare i parametri ai quali ha voluto fare riferimento.
È incorsa poi in palese contraddizione,
quantificando i danni patrimoniali in Euro
30.000-000,00 nella motivazione, ed in Euro
15.000,00 nel dispositivo.
La Clinica (Omissis) ha chiesto la correzione
della sentenza, assumendo che la somma di 30
milioni va letta come Lire, anziché come Euro,
e che – avendo il Tribunale già liquidato L. 20
milioni per i danni patrimoniali da perdita di
chances – il dispositivo va inteso come condanNGCC 2010 - Parte prima
Cass., 28.8.2009, n. 18805
na al pagamento della differenza, pari ad Euro
5.164,57.
L’istanza di correzione è stata respinta, non
trattandosi di semplice errore materiale, e la ricorrente, alla luce delle considerazioni contenute nella motivazione, assume che deve escludersi che la Corte di appello volesse incrementare la somma da liquidare solo di tale minimo
importo, per di più comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
4. – Le censure sono fondate.
Giustamente rileva la ricorrente che il giudice, pur quando decida in via equitativa, deve
indicare i criteri ai quali ha voluto fare riferimento per determinare la somma dovuta. Nel
caso di danno patrimoniale da perdita di chances tali criteri consistono, in linea di massima,
nell’entità dei guadagni percepiti dal danneggiato al momento dell’illecito; nella concreta
prevedibilità di un loro incremento in futuro;
nella misura in cui le lesioni possono pregiudicare la capacità di guadagno e l’incremento
della stessa. (Fermo restando peraltro che è
onere della danneggiata offrire al giudicante la
prova dei dati di fatto rilevanti allo scopo).
Inoltre, risulta effettivamente incomprensibile quale somma la Corte di appello abbia voluto liquidare in risarcimento dei danni patrimoniali.
È presumibilmente da escludere che abbia
voluto attribuire la somma di Euro 30 milioni,
che figura nella motivazione.
Non è dato comprendere, tuttavia, se l’errore debba essere corretto in L. 30 milioni, oppure in Euro 30.000. Né risulta se la quantificazione del danno – qualunque essa sia – si riferisca al danno globale, e vada quindi intesa al
lordo delle somme già liquidate dal Tribunale,
o se sia da attribuire in aggiunta a quanto già liquidato.
La sentenza impugnata deve essere per questa parte annullata con rinvio, per l’integrazione della motivazione, nella parte in cui è lacunosa, e per la decisione circa la somma dovuta
in risarcimento dei danni patrimoniali.
5. – La ricorrente lamenta poi che la Corte di
appello abbia confermato la sentenza di primo
grado nella parte in cui le ha attribuito un’unica somma in risarcimento dei danni fisici – le
lesioni subite, la malattia, tre interventi operatori, la protesi ad un seno e un’infezione sviNGCC 2010 - Parte prima
Responsabilità civile / Danni civili
luppatasi nell’altro seno, con fenomeni di rigetto) – senza tenere conto dei danni “non fisici”, cioè dei danni alla vita di relazione, ivi inclusi i gravi turbamenti della sfera affettiva e
sessuale, sebbene essa ne avesse chiesto con
l’atto di appello il separato conteggio.
La motivazione della Corte di appello è gravemente lacunosa e contrastante con i rilievi
del CTU – a cui la sentenza ha dichiarato di
volersi uniformare – nella parte in cui ha dichiarato che le lesioni al seno non hanno carattere funzionale e che i problemi di depressione
avrebbero potuto essere agevolmente superati.
Il CTU ha infatti valutato l’incidenza delle lesioni nella misura del 50% del totale, ed ha ritenuto necessario un trattamento psicoterapeutico per il superamento dello stato depressivo.
5.1. – La censura è fondata.
La motivazione con cui la Corte di appello
ha confermato sul punto la sentenza di primo
grado appare insufficiente e contraddittoria.
Da un lato essa ha fatto riferimento all’asserito carattere non funzionale delle lesioni, concetto che non appare in termini con riferimento ai danni fatti valere nel caso di specie. Il
concetto di funzionalità va posto in relazione
con la natura del danno di cui si chiede il risarcimento, e la presenza di cicatrici deturpanti
sul seno non può considerarsi “non funzionale”, allorché vengano in considerazione l’estetica e la sfera sessuale della persona.
Appare poi intrinsecamente contraddittorio
il rilievo che il danno da depressione è di scarso momento perché potrebbe essere superato
tramite cure psicoterapiche.
Il fatto stesso che si debba ricorrere ad una
psicoterapia manifesta la presenza di un turbamento grave.
Manca inoltre nella motivazione ogni riferimento alla specificità delle voci di danno non
patrimoniale a cui si è inteso dare riparazione
mediante la somma liquidata.
La più recente giurisprudenza di questa Corte ha precisato che i danni non patrimoniali di
cui all’art. 2059 cod. civ. comprendono tutti i
pregiudizi non connotati dalla patrimonialità, e
che la categoria non può essere suddivisa in diverse sottovoci suscettibili di autonomo risarcimento (danno esistenziale, alla vita di relazione, estetico, morale, biologico, ecc.), come si è
293
Cass., 28.8.2009, n. 18805
spesso verificato in passato nella prassi giurisprudenziale. Sicché va liquidata un’unica
somma in risarcimento di tutti i danni non patrimoniali (cfr. Cass. civ. S.U. 11 novembre
2008 n. 26972, n. 26973).
La sentenza impugnata non appare meritevole di censura, pertanto, nella parte in cui non
ha attribuito somme diverse a titolo di risarcimento dei danni che la ricorrente definisce fisici (tradizionalmente, danni biologici) e dei
danni morali veri e propri.
La Corte di appello non ha però tenuto conto che i diversi aspetti che il danno non patrimoniale presenta nel singolo caso debbono essere tenuti in considerazione, nel quantificare
l’unica somma da attribuire in risarcimento, ed
ha confermato la liquidazione del Tribunale,
senza verificare se essa fosse adeguata alla reale
consistenza dei danni non patrimoniali nel caso di specie, in considerazione della loro attinenza all’integrità fisica, alla sfera relazionale,
psichica, sessuale, emotiva, ecc.
È chiaro infatti che l’unica somma da attribuire in risarcimento dei danni non patrimoniali può e deve essere diversamente quantificata nei diversi casi, in relazione alle natura
delle conseguenze lesive prodotte dall’illecito,
secondo che esse attengano prevalentemente
ad uno o ad altro aspetto, od a più aspetti congiuntamente, sì da attribuire in ogni caso concreto ed effettivo ristoro dell’intero danno, in
tutti i suoi aspetti.
Sotto questo profilo la sentenza impugnata
appare del tutto carente di motivazione, sebbene l’appellante avesse espressamente sollecitato, con i motivi di appello, la considerazione di
tutti i peculiari aspetti che i danni non patrimoniali hanno assunto nel caso particolare e
sebbene l’esigenza che la liquidazione sia accompagnata da congrua e specifica motivazione assuma particolare rilievo, con riguardo alla
liquidazione globale e onnicomprensiva, al fine
di evitare sia eccessive disparità di trattamento
fra i diversi casi; sia l’attribuzione di somme
inadeguate, per difetto o per eccesso, rispetto
alla reale consistenza dei danni.
6. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale la Clinica (Omissis) deduce omessa e
contraddittoria motivazione, per avere la Corte
di appello erroneamente ritenuto che la sua
domanda di rinnovazione della CTU non fosse
294
Responsabilità civile / Danni civili
stata proposta in appello e per avere quindi
omesso di decidere in proposito.
Afferma che nella comparsa di risposta in
appello essa aveva rilevato che l’istruttoria
svolta in primo grado aveva accertato la falsità
di alcune affermazioni contenute nell’elaborato peritale, ed in particolare di quelle secondo
cui essa Clinica sarebbe priva del reparto di terapia intensiva, ed il suo dipendente, dott. T.,
sarebbe entrato in camera operatoria con gli
abiti inquinati; che pertanto il perito ed i suoi
accertamenti non potevano essere ritenuti affidabili.
7. – Il motivo è inammissibile perché relativo
alla valutazione delle prove, valutazione che
spetta esclusivamente al giudice di merito, con
decisione non censurabile in sede di legittimità, ove sia congruamente e correttamente motivata, come nel caso di specie.
La ricorrente non ha posto in evidenza lacune o contraddizioni nell’iter logico in base al
quale la Corte di appello è pervenuta alla sua
decisione, né la conclusione da essa raggiunta,
secondo cui la rinnovazione della CTU era irrilevante, non avendo l’appellante impugnato
l’accertamento della responsabilità del chirurgo.
Le sue censure si rivolgono esclusivamente al
merito della decisione, né si può prendere in
esame in questa sede la questione relativa alla
rispondenza al vero delle circostanze di fatto
che avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere inattendibile la CTU.
8. – Con il quarto motivo la Clinica (Omissis) lamenta la violazione degli artt. 112, 329 e
346 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello liquidato all’appellante le spese del giudizio
di primo grado, sebbene il capo relativo non
fosse stato specificamente impugnato dall’attrice.
8.1. – Il motivo non è fondato.
Solo nel caso di rigetto del gravame il giudice di appello non può modificare la statuizione
sulle spese del giudice di primo grado.
Ove invece accolga l’impugnazione, egli deve procedere ad una nuova regolamentazione
delle spese dell’intero processo, ivi incluso il
giudizio di primo grado, anche d’ufficio e a
prescindere da specifica richiesta, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata.
L’onere delle spese, infatti, deve essere attriNGCC 2010 - Parte prima
Cass., 28.8.2009, n. 18805 - Commento
buito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della controversia (Cass. civ. S.U. 17
ottobre 2003 n. 15559; Cass. civ. Sez. III, 4
giugno 2007 n. 12963; Cass. civ. Sez. III, 11
giugno 2008 n. 15483). (Omissis)
[Varrone Presidente – Lanzillo Estensore – De
Nunzio P.M. (concl. diff.). – B.S. (avv.ti De Dominicis e Coppedé) – Clinica (Omissis) s.p.a. (avv.ti
Gelli e Mangano)]
Nota di commento: «La chirurgia estetica tra
consumerismo e valore della persona»
I. Il caso
A seguito di una serie di interventi di chirurgia
estetica, effettuati presso una clinica privata rivelatisi in parte deturpanti, S.B., aspirante modella, intentò un’azione in risarcimento dei danni nei confronti
del chirurgo e della struttura ospedaliera.
In primo grado, questi furono condannati in via
solidale nonostante la clinica avesse eccepito la sua
carenza di legittimazione passiva, poiché il chirurgo
non era suo dipendente. La Corte d’appello, in parziale riforma, aggiunse all’ammontare da liquidare
una somma destinata a coprire il costo dell’intervento chirurgico riparatore, senza tuttavia specificare le
voci di danno risarcite. La quantificazione delle lesioni fu ulteriormente oggetto di un ricorso in Cassazione da parte di B.C., mentre la clinica resistette,
adducendo la sua estraneità rispetto all’evento lesivo.
La sentenza della Supr. Corte si caratterizza, da
un lato, per aver applicato tout court, agli atti
di chirurgia estetica, le soluzioni accolte in
materia di responsabilità sanitaria; dall’altro,
diversamente da quanto deciso dalla Corte d’appello, per aver «personalizzato», stante la peculiarità dell’intervento, le voci di danno da risarcire.
Due questioni verranno quindi prese in considerazione: i criteri di responsabilità della clinica (infra,
sez. II, sub 1) e la valutazione dei pregiudizi (infra,
sez. II, sub 2).
II. Le questioni
1. I criteri di responsabilità della clinica.
Dalla sentenza traspare un orientamento favorevole
alla prospettiva «aziendalista» dell’attività sanitaria,
ivi comprese le prestazioni di chirurgia estetica; il
soggetto responsabile dell’evento dannoso non è solo il medico inadempiente ma, soprattutto, la struttura sanitaria che, avendo concorso a creare il riNGCC 2010 - Parte prima
Responsabilità civile / Danni civili
schio clinico, è gravata da un particolare obbligo di
protezione nei confronti della paziente.
La soluzione appare coerente sotto vari profili.
Anzitutto, la decisione non distingue, per quanto
attiene alla regola di responsabilità civile, la natura
degli atti lesivi – terapeutica/estetica – né tantomeno la natura privata o pubblica della struttura sanitaria. L’approccio, ormai consolidato, si avvale del
carattere fondamentale e trasversale del diritto alla
salute (e/o libero sviluppo della personalità) e non
ammette distinzioni giuridiche «superflue», legate
alle modalità di tutela del diritto a prestazioni sanitarie (partenariato pubblico/privato) o al suo contenuto; nella veste di diritto al benessere – fisico, psichico – la salute si estende alla percezione che l’individuo ha della propria identità (Zatti, 3, infra, sez.
IV); o almeno così traspare dalla giurisprudenza in
materia di responsabilità sanitaria, dove la tutela
concessa alla persona presuppone tradizionalmente
una lesione al diritto alla salute costituzionalmente
garantito.
La peculiarità della fattispecie, gli atti di chirurgia estetica, poteva comunque far sorgere, anche in
questa prima parte della sentenza, qualche dubbio
sulla valorizzazione del legame con il corpo: la ricerca dell’estetismo può ragionevolmente portare
una ventenne a rinnegare, anche per scopi lavorativi, la propria fisicità? La Corte, senza citare l’art.
32 Cost., considera il punto irrilevante per la prospettiva privilegiata: tutelare la persona che ha legittimamente confidato nella competenza, diretta o
mediata, di un esperto, persona fisica o giuridica
che sia.
Il perseguimento dell’obiettivo – e si tratta della
seconda considerazione – è assicurato dall’esistenza
di particolari doveri di diligenza, di matrice precauzionale, inerenti alla prospettiva di un adempimento
futuro: prerequisiti minimi, sottostanti l’interesse alla salute, «preparatori» all’esatta esecuzione della
prestazione.
La Corte conferma così l’indirizzo giurisprudenziale favorevole alla previsione dei cc.dd. «obblighi
di messa a disposizione» di personale qualificato
(nonché di «apprestamento di tutte le attrezzature
necessarie nonché di quelle, lato sensu, alberghiere»:
Cass., 13.4.2007, n. 8826, infra, sez. III) quale fonte
di abilitazione allo svolgimento dell’attività sanitaria, ivi compresa la gestione del rischio clinico collegato al valore della persona. Tale dovere di cautela
antecedente l’esecuzione dell’obbligazione (la Corte
è esplicita in questo senso: «(...) non si può certo ammettere che un ente ospedaliero dia accesso a chiunque si presenti, senza averne verificati i titoli di abilitazione, la serietà, la competenza e affidabilità, (...)»)
persegue due obbiettivi strettamente correlati: ascrivere, al soggetto meglio in grado di gestirlo, il ri295
Cass., 28.8.2009, n. 18805 - Commento
schio derivante dall’attività sanitaria (in senso lato) e
agevolare la posizione probatoria dei pazienti che si
sono affidati alla «professionalità» altrui.
La prospettiva che pone l’accento sulla funzione
preventiva – e non solo risarcitoria – della responsabilità civile, si rivela favorevole ad una «oggettivazione» della relazione tra paziente ed ente ospedaliero: non solo le regole di tutela sono modellate
sullo schema della responsabilità oggettiva tramite
il riconoscimento di una «garanzia» di competenza
della clinica, prescindendo così dall’onere della
prova; ma soprattutto, e logicamente, la Corte
prende in considerazione l’oggetto economico dell’attività svolta dalla struttura, l’erogazione delle
prestazioni sanitarie, per «creare» – poiché fuoriescono formalmente dall’oggetto contrattuale – obblighi derivanti dalla reputazione, come impresa,
dell’ente ospedaliero, ossia – appunto – la verifica
degli input (acquisizione e impiego delle risorse) di
produzione.
Secondo tale approccio, il contenuto terapeutico
o meno dei servizi prestati risulta – va ribadito – irrilevante poiché viene assorbito dal criterio della
qualità richiesta ai fini dell’attività di produzione,
«complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa
l’attività del chirurgo»; quasi a voler promuovere
(tanto più che la fattispecie riguarda l’attività di
chirurgia estetica) una relazione consumeristica tra
clinica e cliente, terminologia peraltro adottata dalla stessa Corte. I riferimenti alle rette di degenza,
all’utile/assenza di gratuità dell’attività sanitaria,
confermano il taglio patrimoniale della relazione: le
regole del «mercato» sanitario evidenziano criteri
di efficienza nello scambio tra prestazione e controprestazione, tanto più che nel caso della chirurgia
estetica è rintracciabile una corrispondenza tra
l’utilità procurata dalla prestazione ed il relativo
spostamento patrimoniale di profitto, corrispondenza altrimenti assente nelle prestazioni di cura
(Klesta Dosi, 3, infra, sez. IV). Nell’affermare la
responsabilità da affidamento nella qualità dei servizi, inerente alla governance del rischio clinico, la
Corte opera un’analisi costi-benefici del «prodotto
ospedaliero», inteso come il risultato/outcome del
processo produttivo rispetto alle legittime aspettative del cliente/consumatore.
Logicamente, e in terzo luogo, va sottolineato l’effetto principale dell’adesione all’approccio «aziendalistico», ossia il riconoscimento di una tutela risarcitoria basata sulla capacità del soggetto più idoneo
a sopportare/gestire i rischi del processo produttivo.
Nel caso di specie, l’accertata responsabilità personale del chirurgo giustifica, ai fini della solidarietà
passiva, la sua estensione alla clinica: viene rafforzata la garanzia del danneggiato nel caso in cui più
azioni abbiano concorso alla realizzazione del danno
296
Responsabilità civile / Danni civili
(Cass., 9.8.2007, n. 17475, infra, sez. III). L’ente è,
tuttavia, anche debitore – inadempiente – di obblighi distinti, quelli di messa a disposizione di personale qualificato. Al riguardo, l’irrilevanza tanto del
legame giuridico tra il chirurgo e la clinica, quanto
dei rapporti personali tra il primo e la cliente, avrebbero potuto implicare una responsabilità autonoma
tout court, senza riferimento alla colpa del medico,
oppure una responsabilità indiretta fondata su una
forma di un collegamento, ex art. 1228 cod. civ., tra
la prestazione altrui e l’organizzazione aziendale del
debitore principale (Cass., 14.7.2004, n. 13066, infra, sez. III).
La Corte non si pronuncia esplicitamente sul
punto (applicazione dell’art. 2055 cod. civ. oppure
della disposizione riguardante la responsabilità –
contrattuale – per fatto degli ausiliari), privilegiando
l’indivisibilità della fonte dell’inadempimento: il
contratto di spedalità come vincolo negoziale comprensivo di tutte le prestazioni riguardanti la degenza, concluso al momento dell’accettazione nella clinica. La scelta, nonostante qualche dubbio, sembra
quindi avvalorare la tesi della responsabilità – personale – autonoma della casa di cura; la Corte nega infatti ogni rilevanza allo statuto giuridico del diretto
danneggiante senza ricorrere alla teoria del contatto
sociale (in verità applicabile solo al medico – pubblico – ospedaliero: Cass., 8.10.2008, n. 24791, infra, sez. III).
Sotto il profilo comparatistico, il favor per un unico centro di responsabilità è in linea con la prassi tedesca, in cui la relazione di assistenza sanitaria, disciplinata secondo tre modelli negoziali, comprende
il c.d. «totale Krankenhausaufnahmevertrag»; in virtù di tale vincolo contrattuale tra il paziente e l’ente
sanitario, quest’ultimo è tenuto ad erogare tutta l’assistenza appropriata, ivi compresa quella strettamente medica. Le altre due modalità prevedono invece una «scissione» di responsabilità (c.d. gespaltene Krankenhausaufnahmevertrag) a seconda dell’inquadramento del debitore della prestazione medica
all’interno della struttura; oppure una fattispecie di
responsabilità solidale tra ente e medico (c.d. totale
Krankenhausaufnahmevertrag mit Arztzuvertrag)
tramite stipula di un contratto aggiuntivo e distinto
con il medico nel caso di inadempimento da parte di
quest’ultimo (Genzel, 897, infra, sez. IV), ipotesi
che, a rigore, avrebbe potuto realizzarsi nella fattispecie qui in discussione, ma che è stata respinta
dalla Corte.
In effetti, l’individuazione di due contenuti distinti del medesimo rapporto – eccezione sollevata
dalla parte convenuta – si rivela spesso artificiale e
fonte di incertezza; al riguardo, il confronto con un
altro Paese, la Francia, pone in luce due tendenze
(Harichaux, 3, infra, sez. IV): da un lato, il caratteNGCC 2010 - Parte prima
Cass., 28.8.2009, n. 18805 - Commento
re démodé della dualità negoziale, largamente sostituita nella prassi da un unico contratto tra paziente e
clinica (c.d. «contrat d’hospitalisation et de soins»);
dall’altro tuttavia, il riconoscimento, nel caso di inadempimento della prestazione di cura, dell’obbligo
risarcitorio a carico dell’ente, vincolato dal legame
di dipendenza con il medico coinvolto (fattispecie
del salariat médical con eventuale clausola di esclusività). Tale approccio non è stato accolto dalla Corte
che, interpretando la fattispecie alla stregua di un
rapporto di consumo ex art. 1370 cod. civ., ha tutelato tout court gli interessi della parte debole di fronte al «professionista».
2. La valutazione dei pregiudizi. La prospettiva «globale», basata sulla funzione economica
svolta dalla struttura, e privilegiata per accertare la
responsabilità della clinica, non sembra essere stata
invece coerentemente adottata per valutare i pregiudizi sofferti. Con l’obbiettivo di risarcire al meglio la danneggiata, la Corte ha individuato una serie di interessi lesi meritevoli di tutela, correndo il
rischio di non rispettare l’assetto probatorio introdotto da Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533 (infra, sez. III), e di avvalorare la tesi che la posizione
assunta dalle sezioni unite nel 2008 (Cass., sez. un.,
11.11.2008, nn. 26972 e 26975, infra, sez. III), in
materia di risarcibilità del danno non patrimoniale,
sia suscettibile di generare alcune ambiguità interpretative.
La censura ha riguardato la determinazione dei
criteri di quantificazione del danno – patrimoniale –
da perdita di chance, e di quelli «non fisici» relativi
alla vita di relazione, affettiva e sessuale.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, va sottolineato che il carattere incomprensibile della somma liquidata dai giudici del merito, ha certamente
contribuito alla sanzione; e in effetti, l’ambiguità su
alcuni parametri essenziali, come la valuta usata (lire
o euro?) e l’importo effettivo (lordo o netto delle
somme liquidate in prima istanza?) risultava così
eclatante da lasciare non pochi dubbi non solo sulla
scelta dei criteri di quantificazione del danno patrimoniale in toto ma anche sul fatto che questo comprendesse davvero la perdita di chance.
Le facilità probatorie inaugurate dalla Supr. Corte nel 2001, ossia la dimostrazione del titolo e la
mera allegazione dell’inadempimento «astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato» (di recente ancora Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 577, infra,
sez. III), rendono sovrabbondante la prova, anche
presuntiva, dell’esistenza del pregiudizio economico, richiesta ai fini della risarcibilità della perdita di
chance. Con lo «stratagemma» della mera allegazione, le tecniche per rendere più probabile il nesso di
causalità tra l’evento dannoso e il danno sofferto si
NGCC 2010 - Parte prima
Responsabilità civile / Danni civili
rivelano superflue nella misura in cui l’ostacolo viene aggirato: provato il contratto di spedalità (è sufficiente l’accettazione, da parte della struttura sanitaria, per il ricovero del paziente), la presenza di cicatrici sarebbe già comprensiva, attraverso – appunto – lo schema della mera allegazione, della
condotta illecita del debitore. Anzi, il rimedio della
risarcibilità della chance potrebbe costituire un
mezzo a tutela della clinica – come sembra risultare
dalla memoria difensiva – nella misura in cui l’obbligo risarcitorio sarebbe circoscritto al valore dell’altrui chance perduta (Pucella, 147 s., infra, sez.
IV).
Va inoltre aggiunto che, a fortiori nel caso di specie, l’esistenza del danno futuro – e non della semplice perdita di chance – non era oggettivamente
contestabile, essendo la mancanza di guadagni, nel
senso di utilità non conseguita, già riscontrata; l’intervento di chirurgia estetica perseguiva un evidente
scopo lavorativo, tanto più che l’attività di indossatrice avrebbe dovuto svolgersi all’interno dell’impresa familiare, il che avrebbe posto l’aspirante modella al riparo da eventuali concorrenti.
Essendo già acquisita la riparazione integrale del
danno, l’eventuale rilevanza della perdita di chance
avrebbe potuto riguardare la violazione, da parte del
medico, del dovere di informazione; nella sentenza
non vi è tuttavia – a priori paradossalmente, essendo
una fattispecie di chirurgia estetica – alcuna traccia;
tale assenza, stante la prevedibilità delle cicatrici,
conforta la tesi che un’eventuale ammissione della
perdita di chance, intesa come chance di non andare
incontro ad un pericolo sulla base di una corretta informazione, avrebbe compromesso l’integralità del
risarcimento. Un rapido sguardo alla prassi francese, dove pure la nozione non è esente da ambiguità
interpretative rivela i limiti posti alla risarcibilità
della perte de chance di sottrarsi al rischio poi avveratosi: viene infatti presa in considerazione solo
l’eventualità che, qualora il paziente fosse stato informato, avrebbe rinunciato all’intervento laddove
invece la perdita di chance collegata ad un errore di
diagnosi o ad un ritardo tale da pregiudicare le probabilità di successo dell’intervento, comporta la riparazione integrale del préjudice corporel, a prescindere dalla quantificazione della chance perduta
(Maugüe, 60 ss., infra, sez. IV).
I dubbi riguardanti la pertinenza del riferimento
alla perdita di chance non vengono sciolti dalla successiva presa di posizione della Corte in materia di
«danni non fisici». Senza addentrarsi in una questione che meriterebbe ben più ampi sviluppi, ci limiteremo a qualche breve considerazione. Secondo il
S.C., in base al principio applicabile ai danni non
patrimoniali, la tipologia di pregiudizi, meglio definita come «danni alla vita di relazione, ivi inclusi i
297
Cass., 28.8.2009, n. 18805 - Commento
gravi turbamenti della sfera affettiva e sessuale» merita tutela, nella misura in cui viola un diritto costituzionale garantito. Nella fattispecie, possono richiamarsi l’art. 2 Cost., oppure, e più verosimilmente, l’art. 35 in materia di tutela del lavoro «in tutte le
sue forme e applicazioni»; quanto all’art. 32, implicitamente acquis nelle fattispecie di responsabilità
sanitaria, non è nemmeno citato nella seconda parte
della sentenza: gli interventi di chirurgia estetica,
pur avendo par ricochet occasionato un pregiudizio
da depressione, non perseguivano alcuna finalità riguardante la salute, nemmeno quella psicologica.
Nella fattispecie non vi era alcun tipo di danno biologico, l’evento fonte del danno era motivato dall’impiego lavorativo.
Perché allora risarcire «“i gravi turbamenti della
sfera affettiva e sessuale” riguardanti la componente
psichica delle lesioni sofferte, le quali ancorché legate alla natura oggettiva dei pregiudizi risarcibili di tipo esistenziale – poiché avevano indotto la ragazza a
scelte diverse rispetto all’ambito mestiere di modella
– non erano conseguenti alla violazione di un diritto
inviolabile della persona diverso da quello all’integrità psicofisica?» (Monateri, 57 s., infra, sez. IV).
Il nodo spinoso della fattispecie sembra essere costituito da un lato, dall’impossibilità di includere i
«turbamenti alla sfera affettiva e sessuale» nell’ambito del danno biologico, poiché non vi era stata alcuna lesione del diritto alla salute, dall’altro dalla
difficoltà di monetizzare questa tipologia di sofferenze (morali/fisiche, legate al valore della persona?) attingendo alla nebulosa delle categorie meramente descrittive di pregiudizi.
Ma così l’accento posto giustamente sull’oggettivazione della relazione sanzionata nella scelta dei
criteri di responsabilità, viene spostato, e la coerenza della soluzione intaccata; in particolare, l’approccio consumerista, adottato in precedenza, giustificava la tutela dei soli interessi patrimoniali lesi, quelli
legati alla funzione economica svolta dall’evento rivelatosi dannoso, non quelli emotivi da depressione,
peraltro anche esclusi dal quadro di risarcibilità delineato dalle sentenze dell’11.11.2008 (Monateri,
58).
Infine, l’uso del concetto di «funzionalità» delle
lesioni non convince nella misura in cui si riferisce
all’estetica, interesse la cui lesione era già stato risarcito (danno patrimoniale) e alla sfera sessuale, ossia,
e nuovamente, ad un aspetto del diritto alla salute,
irrilevante nel caso in commento. Qualche legittimo
dubbio poteva anche sorgere sul valore alla persona
rappresentato da una serie di interventi di chirurgia
estetica richiesti da una ventenne aspirante modella.
In effetti, la fattispecie si discosta decisamente da alcuni esempi «tipici»: l’uccisione del cane del non vedente o la necessità di vendere un appartamento per
298
Responsabilità civile / Danni civili
sfuggire ad immissioni tossiche (Navarretta, 67,
infra, sez. IV).
III. I precedenti
Sul contratto di spedalità/responsabilità sanitaria: da ultimo, Cass., 8.10.2008, n. 24791, in questa
Rivista, 2009, I, 550, con nota di Klesta Dosi e,
in Danno e resp., 2009, 414, con nota di Gagliardi; Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 577, in questa Rivista, 2008, I, 612, con nota di De Matteis; in Foro it., 2008, I, 455, con nota di Palmieri e in Danno e resp., 2008, 788, con nota di Vinciguerra;
Cass., 13.4.2007, n. 8826, in questa Rivista, 2007,
I, 445, con nota di Pucella e in Resp. civ. e prev.,
2007, 1824, con nota di Gorgoni; Cass.,
26.1.2006, n. 1698, in Rep. Foro it., 2006, voce
«Contratto in genere», n. 360; Cass., 14.7.2004, n.
13066, in Danno e resp., 2005, 537, con nota di
Agnino e in Giust. civ., 2005, I, 2703, con nota di
Flammini; Cass., 28.5.2004, n. 10297, in questa
Rivista, 2004, I, 783, con nota di Palmerini; in
Danno e resp., 2005, 26, con nota di De Matteis e
in Giur. it., 2005, 1413, con nota di Perugini;
Cass., sez. un., 1o.7.2002, n. 9556, in Rep. Foro it.,
2002, voce «Contratto in genere», n. 299; Cass.,
sez. un., 22.1.1999, n. 589, in Danno e resp., 1999,
294, con nota di Carbone, e ibidem, 781, con nota
di De Matteis; in Corr. giur., 1999, 441, con nota
di Di Majo e, in Resp. civ. e prev., 1999, 652, con
nota di Forzati.
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione: Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533, in
questa Rivista, 2009, I, 349, con nota di Meoli; in
Foro it., 2002, I, 769, con nota di Laghezza; in
Contratti, 2002, 113, con nota di Carnevali e in Temi rom., 2001, 108, con nota di Merlino.
In materia di solidarietà nel risarcimento: Cass.,
9.8.2007, n. 17475, in Mass. Giur. it., 2007, e in Arch. circolaz., 2008, 244.
Sul legame tra assistenza sanitaria e tutela del
consumatore: Cass., ord. 2.4.2009, in questa Rivista, 2009, I, 1069, con nota di Klesta Dosi, in Resp. civ. e prev., 2009, 1269, con nota di Chindemi e
in Danno e resp., 2009, 945, con nota di Garatti.
Sul danno da perdita di chances lavorative: Cass.,
17.1.2009, n. 24220, e Cass., 19.2.2009, n. 4052, reperibili sul sito: http://dejure.giuffre.it.
Sul danno non patrimoniale: Cass., sez. un.,
11.11.2008, n. 26972 e n. 26975, in questa Rivista,
2009, I, 102, con nota di Navarretta e Ponzanelli, in Guida al dir., 2008, n. 47, 18, con nota di Dalia e Comandé, in Assicurazioni, 2008, II, 2, 439
con nota di Gussoni e Rossetti, in Imm. e dir.,
2009, n. 1, 36, con nota di Celeste, in Danno e resp., 2009, 19, con nota di Procida Mirabelli di
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., 28.8.2009, n. 18805 - Commento
Lauro, Landini e Sganga, in Giur. it., 2009, 1380,
con nota di Vizioli, e in Riv. it. med. leg., 2009, con
nota di Barni, Fiori, Bona.
IV. La dottrina
Sulla componente psicologico-identitaria del diritto alla salute: Zatti, Il diritto a scegliere la propria
salute (in margine al caso S. Raffaele), in questa Rivista, 2000, II, 3; Durante, Dimensioni della salute:
dalla definizione dell’OMS al diritto attuale, in questa Rivista, 2001, II, 132 ss., anche Il seminario di
studi, L’identità nell’orizzonte del diritto privato, in
questa Rivista, 2007, suppl. al n. 4.
Sulla responsabilità sanitaria nel diritto italiano:
Aa.Vv., La responsabilità sanitaria, diretto da Pecceini, Zanichelli, 2007; Breda, La responsabilità autonoma delle strutture sanitarie, in questa Rivista,
2007, II, 103 ss.; De Matteis, Responsabilità e servizi sanitari, nel Trattato dir. comm. e dir. pubbl.
econ., a cura di Galgano, XXXXVI, Cedam, 2007;
Problemi di responsabilità sanitaria, a cura di Farneti-Cucci-Scarpati, Giuffrè, 2007; Visintini, Trattato breve della responsabilità civile – Fatti illeciti.
Danno risarcibile, 3a ed., Cedam, 2005, 277 ss.;
Aa.Vv., La responsabilità sanitaria: valutazione del
rischio e assicurazione, a cura di Comandè-Turchetti, Cedam, 2004.
Sulla responsabilità sanitaria nel diritto tedesco:
K.A. von Sachsen Gessaphe, La responsabilità
delle aziende ospedaliere private nel diritto tedesco, in
Resp. civ. e prev., 2001, 536; e nel diritto francese:
Harichaux, La responsabilità médicale et les établissements d’hospitalisation privée, in Traité de droit
médical et hospitalier, fasc. 19-1, in LexisNexis,
2000; anche Maugüe, La Responsabilité des établissements publics de santé, ivi, fasc. 19-3, 2005.
Sul contratto di spedalità/assistenza sanitaria: sia
consentito il rinvio a Klesta Dosi, Assistenza sanitaria e tutela del cittadino, Modelli privatistici e orizzonte europeo, Giappichelli, 2008; Faccioli, Il con-
NGCC 2010 - Parte prima
Responsabilità civile / Danni civili
tratto tra il paziente e la struttura sanitaria: natura,
oggetto e disciplina applicabile, in Studium iuris,
2003, 519 ss.
Sul contratto come «sede di responsabilità» negli
Stati Uniti e in Francia: Epstein, Rebuilding the
citadel: privity, causation, and Freedom of Contract,
in Exploring Tort Law, ed. M. Stuart Madden, Cambrige University Press, 2005, anche O. Debat, Le
contrat, source de responsabilité envers les tiers, reperibile sul sito: http://www.lextenso.com/lextenso/archives/Apw.fcgi.
Sul nesso di causalità: tra gli altri Pucella, La
causalità «incerta», Giappichelli, 2007.
Sul risarcimento dei danni collegati all’attività sanitaria nel diritto francese: Cour de cassation,
Rapport annuel 2007, La santé dans la jurisprudence
de la Cour de cassation, 275 ss., reperibile sul sito:
www.courdecassation.fr/rapport-annuel-36.
Sul danno non patrimoniale nella letteratura offerta da Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26975: Cendon, A proposito di Cass., sez. un., 26972/2008.
L’urlo e la furia, in questa Rivista, 2009, II, 71 ss.;
Navarretta, Danni non patrimoniali: il compimento della Drittwirkung e il declino delle antinomie,
ibidem, 79 ss.; Ponzanelli, La prevista esclusione
del danno esistenziale e il principio di integrale riparazione del danno: verso un nuovo sistema di riparazione del danno alla persona, ibidem, 88 ss.; Monateri, Il pregiudizio esistenziale come voce del danno
non patrimoniale, in Resp. civ. e prev., 2009, 56 ss.;
Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali,
ivi, 63 ss.; Poletti, La dualità del sistema risarcitorio e l’unicità della categoria dei danni non patrimoniali, ivi, 76 ss.; Ziviz, Il danno non patrimoniale:
istruzioni per l’uso, ivi, 94 ss.; Ponzanelli, Dopo le
decisioni delle sezioni unite: le «reali» divergenze tra
esistenzialisti ed antiesistenzialisti, ivi, 2419.
Laurence Klesta Dosi
299
Cons. Stato, 8.9.2009, n. 5266
c CONS. STATO, VI sez., 8.9.2009, n. 5266
Annulla T.A.R. Marche, 19.9.2008
Responsabilità civile - Provvedimento illegittimo della Pubblica Amministrazione - Danno esistenziale Configurabilità - Oggetto - Risarcibilità (Cost., artt. 2, 4, 36, 41; cod. civ., artt. 1226,
2043, 2059)
L’illegittima revoca dell’autorizzazione di
polizia per la gestione di un istituto di vigilanza privata, con conseguente cessazione
dell’azienda, cagiona all’imprenditore un
danno esistenziale risarcibile, identificabile in una compromissione dell’autostima,
del benessere e della sfera relazionale del
danneggiato, in termini suscettibili di apprezzamento presuntivo e di liquidazione
in via equitativa. In particolare, la lunga
interruzione subita dall’azienda, sulla quale il professionista ha concentrato i propri
interessi professionali e la propria posizione, in termini economici e sociali, determina la lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, con particolare riguardo agli artt. 2, 4, 36 e 41 Cost.
dal testo:
Il fatto. Con atto di appello, notificato in data 12.11.2008, l’Istituto di Vigilanza privato
(Omissis), nella persona del titolare L.C., impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Ancona, sez.
I, n. 1306/08 del 19.9.2008 (che non risulta notificata), con la quale veniva accolto in parte il
ricorso dal medesimo proposto per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno,
con riferimento ad illegittima revoca dell’autorizzazione di Polizia per l’esercizio dell’impresa, revoca disposta dal Prefetto di Macerata
con provvedimento n. 4669 del 22.1.1990 ed
annullata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con
sentenza n. 6207/04 del 23.9.2004 (dopo difforme pronuncia del TAR delle Marche, Ancona, n. 318/92 del 15.5.1992). Nella sentenza
appellata – superata una eccezione di difetto di
giurisdizione – si riepilogavano i più recenti
300
Responsabilità civile
sviluppi della giurisprudenza nella materia dedotta in giudizio e si sintetizzavano le richieste
risarcitorie del citato signor C. (richieste quantificate – sulla base di perizia tecnico-contabile
asseverata di un dottore commercialista – in
Euro 1.842.038,00 per l’attività di impresa non
esercitata in pendenza di giudizio, nonché in
Euro 200.000,00 per danno morale ed esistenziale). Nel merito, veniva riconosciuta la fondatezza, in linea di principio, delle richieste anzidette (in quanto non avrebbe potuto essere
“revocata in dubbio la sussistenza della piena
capacità di intendere e di volere in capo al funzionario”, cui fosse “imputabile l’avvenuta
adozione del provvedimento”, mentre l’antigiuridicità dell’atto sarebbe stata insita nel fatto che “lo stesso è stato annullato dal giudice
amministrativo”); quanto sopra, tuttavia, limitatamente al danno riconducibile alla cessata
attività di impresa e per importi inferiori a
quelli in precedenza indicati. Secondo il giudice di primo grado, infatti, il danno avrebbe dovuto essere ridotto in presenza di culpa levis
dell’amministrazione, ravvisabile nel caso di
specie anche perché il ricorrente (e attuale appellante) avrebbe concorso con il proprio comportamento alla concretizzazione dei presupposti del provvedimento repressivo. Per la
quantificazione del danno stesso, derivante
dalla perdita dell’autorizzazione di polizia, sarebbe stato poi necessario ricorrere a criteri
equitativi, tenuto conto del fatto che nel 1989
il medesimo ricorrente aveva denunciato un
reddito di impresa negativo, ma dovendo comunque presumersi che il titolare percepisse
un reddito non inferiore “alla retribuzione
spettante ad una guardia giurata, dipendente
dell’Istituto di vigilanza”: un importo, quello
appena indicato, da ridurre del 25% ex art.
1227 cod. civ., per concorso di colpa del signor
C. in ordine all’evento dannoso; non riconoscibile, invece, sarebbe stato il danno morale ed
esistenziale, in quanto non legato, come previsto ex art. 185 c.p.p., alla commissione di reati
e comunque non adeguatamente provato. In
sede di appello, la quantificazione del danno
operata dal giudice di primo grado era contestata dal soggetto interessato, sia sotto il profilo del concorso di colpa, sia per omessa considerazione del reale volume d’affari dell’impresa e della successiva dissoluzione dell’intero
NGCC 2010 - Parte prima
Cons. Stato, 8.9.2009, n. 5266
complesso aziendale, col relativo avviamento,
sia infine per il più attuale indirizzo in tema di
danni morali, da riconoscere in rapporto a 15
anni di inattività lavorativa, con conseguenze
per l’interessato sul piano non solo economico,
ma anche psicologico e delle relazioni umane.
Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio anche nella presente sede di appello, resisteva all’accoglimento del gravame, sottolineando la piena condivisibilità della pronuncia
in esame.
I motivi. La questione sottoposta all’esame
del Collegio concerne esclusivamente la quantificazione della pretesa risarcitoria, rapportata
alla revoca – ritenuta illegittima in sede giudiziale (Cons. St., sez. IV, 23.9.2004, n. 6207) –
dell’autorizzazione di polizia per la gestione di
un istituto di vigilanza privata; quanto sopra,
non essendo stato proposto appello incidentale
avverso gli altri capi della decisione in questa
sede appellata (TAR delle Marche, 15.5.1992,
n. 318), con particolare riguardo alla sussistenza dei presupposti giustificativi della pretesa risarcitoria stessa, con conseguente formazione
al riguardo di giudicato parziale, tenuto conto
del principio di cui all’art. 329, comma 2, cod.
proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo (tantum devolutum quantum appellatum: cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez.
IV, 13.10.2003, n. 6195, e Cons. St. sez. V,
18.2.2003, n. 856).
In primo grado di giudizio è stata ritenuta
“acclarata la colpevolezza dell’apparato amministrativo”, con conseguente accoglimento della domanda di risarcimento del danno, riferita
al pregiudizio economico subito dalla parte ricorrente “in conseguenza della perdita dell’autorizzazione, che la abilitava alla gestione dell’Istituto di vigilanza privata denominato
L.F.”, per il periodo di piena operatività del
provvedimento di revoca (prima del relativo
annullamento da parte del giudice amministrativo e della conseguente restituzione del titolo
abilitativo, ovvero dal 3.2.1990 al 15.11.2005);
non è stata accolta invece la domanda, finalizzata al ristoro del danno morale ed esistenziale:
il primo, in quanto riconducibile in via esclusiva a fatti illeciti integranti reato, ex art. 185
c.p.p. (non applicabile nel caso di specie), il secondo, per mancanza di qualsiasi allegazione
NGCC 2010 - Parte prima
Responsabilità civile
probatoria al riguardo. Il danno ritenuto risarcibile poi, risultando di difficile quantificazione, è stato determinato nella sentenza in esame
in base a criteri equitativi, previa verifica della
dichiarazione dei redditi del soggetto interessato per gli anni 1989 e 1990 (prima e dopo la
forzata cessazione dell’attività): una volta evidenziato, infatti, come il reddito da impresa
denunciato ai fini dell’Irpef per il 1989 risultasse negativo, si è ritenuto – con valutazione ex
art. 1226 cod. civ. – che dovesse presumersi
percepito dall’imprenditore un reddito pari,
almeno, a quello “spettante ad una guardia
giurata dipendente dall’istituto di vigilanza” di
cui trattasi.
Il risarcimento dovuto – in termini di danno
emergente e di lucro cessante – è stato quindi
determinato in misura corrispondente allo stipendio annuo spettante nel 1990, al netto delle
imposte sul reddito, ad una guardia giurata, secondo il contratto collettivo di lavoro della categoria, per ogni anno di inoperatività dell’azienda; in rapporto alla somma così determinata, inoltre, è stata prevista una detrazione del
25%, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., per “riconosciuto concorso di colpa del signor C. nella
causazione del danno”.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene in
parte condivisibili le argomentazioni difensive,
prospettate in sede di appello avverso le modalità di quantificazione del danno, in astratto dichiarato risarcibile, ma in concreto non valutato in base a parametri, che possano ritenersi
corretti.
Al fine di valutare i presupposti della valutazione, da effettuare nel caso di specie, sembra
opportuno ricordare che la vicenda dedotta in
giudizio trae origine, sul piano giuridico, dalla
storica pronuncia delle sez. un. della Corte di
Cassazione 22.7.1999, n. 500 (che ha riconosciuto la risarcibilità del danno per lesione di
interessi legittimi) e dalla successiva disposizione legislativa (art. 7 L. n. 205/2000, modificativo dell’art. 7, comma 3 L. n. 1034/71), che ha
trasferito al giudice amministrativo la cognizione sui giudizi risarcitori, avviati in dipendenza
di questioni sostanziali rimesse al medesimo
giudice. La nuova dimensione del risarcimento
del danno, rapportata all’emanazione di atti
amministrativi illegittimi, presenta alcune peculiarità che rilevano nella situazione in esame:
301
Cons. Stato, 8.9.2009, n. 5266
quanto sopra, non tanto sotto il profilo dell’accertamento della colpa (già valutata in primo
grado di giudizio, secondo criteri – non contestati nella presente sede di appello – in ordine
ai quali cfr. comunque, da ultimo, Cons. St.,
Ad. Plen., 3.12.2008, n. 13), quanto piuttosto
nell’ottica della prova di tale colpevolezza e del
danno conseguente. Si deve tenere conto, infatti, dei caratteri peculiari della responsabilità
dell’Amministrazione per lesione di interessi
legittimi, responsabilità che l’elaborazione giurisprudenziale rende non del tutto coincidente
con quella aquiliana, sussistendo anche profili
(rilevanti, in particolare, sul piano probatorio)
assimilabili a quelli della responsabilità contrattuale, in considerazione dell’interesse protetto di chi instauri un rapporto procedurale
con l’Amministrazione al cosiddetto “giusto
procedimento”, implicante appunto corretto
sviluppo dell’iter procedimentale e – salvo errore scusabile – legittima emanazione del provvedimento finale (cfr., per il principio, Cons.
St., sez. V, 2.9.2005, n. 4461).
Ricade in tale ottica l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui al privato, danneggiato da
un provvedimento amministrativo illegittimo,
non è richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa della pubblica
amministrazione, operando al riguardo, una
volta accertata l’illegittimità dell’atto causativo
del danno, la presunzione semplice di cui all’art. 2727 cod. civ., con onere per l’Amministrazione di comprovare – in sostanziale analogia con quanto prescritto in tema di responsabilità contrattuale – la scusabilità dell’errore
(per complessità del quadro normativo di riferimento, o contrasti interpretativi sussistenti al
riguardo; cfr. in tal senso, per il principio,
Cons. St., sez. VI, 5.12.2008, n. 6035, nonché
artt. 1218 e 2697 cod. civ.).
In linea con quanto appena indicato, per
quanto riguarda la prova del danno subito è ragionevole chiedersi, quindi, se il risarcimento
in questione riguardi i soli danni prevedibili (in
linea con quanto previsto dall’art. 1225 cod.
civ.) o anche quelli non prevedibili (tipici della
responsabilità aquiliana, in rapporto alla quale
risulta applicabile l’art. 2056 cod. civ. – che
non richiama il predetto art. 1225 – mentre sono comuni ai due tipi di responsabilità l’estensione del risarcimento sia al danno emergente
302
Responsabilità civile
che al lucro cessante, la possibile valutazione
equitativa ed il fattore riduttivo, conseguente
ad eventuale concorso del fatto colposo del
creditore: artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ.). Ad
avviso del Collegio, la prevedibilità del danno è
fattore che ben si ascrive alla tipologia di responsabilità in esame, essendo l’interesse legittimo correlativo a norme di azione, che circoscrivono l’operato dell’Amministrazione in vista di risultati, alle cui modalità di perseguimento l’Amministrazione stessa è vincolata, o
che – in presenza di margini di discrezionalità
– debbono comunque comportare il migliore
possibile soddisfacimento dell’interesse, sia
pubblico che privato, nel caso concreto: una
differenza evidente dal mero comportamento
doloso o colposo, che è fonte di danno risarcibile ex art. 2043 cod. civ.
Nella situazione in esame la revoca della licenza, relativa all’attività di vigilanza e sicurezza privata svolta dall’appellante, non poteva
che implicare cessazione dell’azienda, con conseguente rapportabilità del danno al valore dell’attività economica in questione, non essendo
ipotizzabile alcun risarcimento in forma specifica, per il periodo antecedente alla restituzione della licenza stessa (restituzione avvenuta
dopo un lasso di tempo sufficientemente lungo, per determinare la perdita non solo dei
redditi prodotti dall’impresa, ma anche del relativo avviamento).
Il risarcimento per equivalente, che deve essere nella fattispecie determinato, consiste
dunque nella differenza fra il valore del bene
della vita, nello stato in cui si sarebbe trovato
in assenza dell’evento dannoso, e il valore del
bene stesso per effetto della lesione intervenuta.
Secondo i principi comunemente noti in tema di danno risarcibile, inoltre, alla diminuzione patrimoniale può aggiungersi, ove ne sussistano i presupposti, il pregiudizio subito dall’individuo, in termini di danno morale, biologico o esistenziale.
Premesso quanto sopra, il Collegio non può
non rilevare, in primo luogo, l’insufficienza dei
parametri di determinazione del danno di cui
trattasi, così come recepiti nella sentenza appellata.
Per quanto riguarda, infatti, il danno patrimoniale, non poteva prescindersi nel caso di specie
NGCC 2010 - Parte prima
Cons. Stato, 8.9.2009, n. 5266
dalla consapevolezza del carattere complesso e
articolato del “bene-azienda”, quale strumento
produttivo di ricchezza per l’imprenditore, ma
anche come fattore propulsivo per l’economia,
suscettibile di positiva valutazione e quantificazione di valore anche ove tecnicamente in pareggio o in perdita, sul piano del rapporto costi/ricavi. Un valore, quello appena indicato, che presupponeva l’applicazione di criteri complementari a quelli della produzione, o meno, di utili
nell’ultimo anno di riferimento, con conseguente più ampia necessità di apprezzamento della
quotazione di mercato dell’azienda stessa, nonché del relativo avviamento, nel medesimo anno
e potenzialmente in quelli successivi.
Del tutto inadeguato appare il criterio equitativo, riferito al reddito contrattualmente previsto per le guardie giurate, dipendenti dall’impresa: queste ultime non partecipavano infatti
agli utili, che potevano essere mancati – in un
determinato periodo – anche in corrispondenza della scelta imprenditoriale di effettuare
maggiori investimenti, al fine di accrescere le
future potenzialità produttive, né comunque
un passivo – benché corrispondente, in ipotesi,
a fattori di crisi aziendale – avrebbe implicato
di per sé azzeramento del valore (anche quantificabile in sede di vendita) della medesima
azienda, ove sostanzialmente sana sul piano del
capitale investito e del fatturato.
Sotto il profilo in questione, pertanto, la sentenza appellata appare da riformare.
Ugualmente non condivisibile, inoltre, deve
ritenersi la preclusa valutazione del danno esistenziale dell’imprenditore, conseguente alla
imposta chiusura della propria attività: correttamente, a tale riguardo, nell’atto di appello si
sottolinea come la più recente giurisprudenza
abbia operato una lettura costituzionalmente
orientata dell’art. 2059 cod. civ., superando –
in materia di danni non patrimoniali – il limite
della riserva di legge, correlata all’art. 185 cod.
pen. (Cass. Civ., sez. III, 14.2.2006, n. 3181;
Corte Cost., 11.7.2003, n. 233; Cass. Civ., sez.
III, 31.5.2003, nn. 8827 e 8828; Cons. St., sez,
VI, 16.3.2005, n. 1096; TAR Sardegna, sez. II,
30.1.2006, n. 95). In conformità all’indirizzo
sopra ricordato, deve ritenersi comunque risarcibile – anche in via equitativa – l’ingiusta lesione di interessi inerenti alla persona, con riferimento ai diritti inviolabili, di cui all’art. 2 delNGCC 2010 - Parte prima
Responsabilità civile
la Costituzione. In particolare deve ritenersi
che l’imprenditore, privato della propria attività a seguito di un provvedimento illegittimo,
non possa non essere ritenuto leso sul piano
dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, con particolare riguardo agli articoli 4,
36 e 41 della Costituzione: tale danno, di tipo
esistenziale, si identifica con una compromissione dell’autostima, del benessere e della sfera
relazionale del danneggiato, in termini suscettibili di apprezzamento presuntivo e di liquidazione in via equitativa; in assenza di qualsiasi
principio di prova, invece, non possono ravvisarsi i presupposti del danno biologico in senso
stretto (ovvero del danno all’integrità fisica e
psichica, riconducibile all’art. 32 della Costituzione).
Per quanto interessa nel caso di specie, il
Collegio ritiene che possa riconoscersi, ex art.
1226 cod. civ., un danno non patrimoniale di
tipo esistenziale, per effetto della lunga interruzione subita dall’attività imprenditoriale dell’appellante, che detta attività aveva esercitato
per svariati anni, con presumibile concentrazione nella stessa dei propri interessi professionali e della propria posizione, in termini economici e sociali. La quantificazione, in via
equitativa, della lesione al riguardo subita dall’interessato appare tuttavia suscettibile – ad
avviso del Collegio – di compensazione con il
coefficiente diminutivo del danno ex art. 1227
cod. civ., valutato pure equitativamente, in primo grado di giudizio, nella misura del 25% del
danno patrimoniale.
La predetta valutazione è ritenuta congrua
dal Collegio, che non condivide le argomentazioni difensive, a quest’ultimo riguardo prospettate nell’atto di appello.
Tali argomentazioni investono infatti l’assenza di qualsiasi colpevolezza dell’appellante, a
fronte del provvedimento repressivo adottato
dall’Amministrazione: nella pur favorevole
sentenza del giudice amministrativo (Cons. St.,
sez. IV, n. 6207/04 cit.), tuttavia, non manca
una elencazione di comportamenti censurabili
(rimostranze di clienti dell’azienda, conflittualità con alcuni dipendenti, irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro ed altre segnalazioni); detti comportamenti, pur senza concretizzare “gravi motivi di ordine e di sicurezza
pubblica”, tali da giustificare la revoca della li303
Cons. Stato, 8.9.2009, n. 5266
cenza, sono stati ritenuti dal giudice di primo
grado – ragionevolmente – idonei a concorrere
alla determinazione dell’Amministrazione di
emettere un provvedimento repressivo, pur
potendo ritenersi la predetta revoca eccessiva,
rispetto alla gravità delle condotte sanzionate.
Ritenuto pertanto – in base a quanto sinora
esposto – che il danno da liquidare sia commisurabile in via esclusiva alla perdita economica
subita dall’appellante, per effetto della cessazione della propria attività (data la ritenuta pari
incidenza del danno esistenziale e del concorso
di fatto colposo del creditore, ex art. 1227 cod.
civ., con conseguente compensazione dei titoli
di credito e di debito relativi), non resta al Collegio che valutare il danno in questione: quanto
sopra, in parziale riforma della sentenza appellata (i cui parametri applicativi sono già stati ritenuti non condivisibili, nell’ambito della presente pronuncia), ma anche senza che possa ritenersi condivisibile la quantificazione, contenuta nella perizia tecnico-contabile di parte, asseverata in data 17.10.2006.
Tale perizia appare basata, infatti, esclusivamente sul pregresso volume d’affari dell’azienda di cui trattasi, senza alcuna valutazione del
capitale, dell’organizzazione e dei costi, che
avevano determinato perdite nell’ultimo esercizio, né della sussistenza, o meno, di utili negli
esercizi precedenti, di modo che non risulta
agevole comprendere come sia stato determinato il “fisiologico incremento del volume d’affari, nel corso degli esercizi successivi al 1990”,
in misura pari al 10% annuo”, con ulteriore
“percentuale di redditività (al netto del carico
fiscale) del fatturato (...) nell’ordine del 20%”,
nonché con valutazione del “rendimento monetario degli utili non conseguiti (...) ad un tasso di riferimento annuo del 2%”. Del tutto
omessa, inoltre, risulta la valutazione delle possibilità di guadagno alternative, (aliquid perceptum) di cui appare ragionevole che l’appellante
si sia avvalso, nel periodo di forzata interruzione dell’attività connessa all’impresa di vigilanza
“L.F.”.
Nella situazione indicata, in ogni caso, pur
non avendo l’interessato fornito compiuta prova del danno subito, il Collegio ritiene che la
domanda risarcitoria possa essere accolta, con i
limiti già in precedenza specificati, per quanto
riguarda l’an, senza però immediata definizio304
Responsabilità civile
ne del quantum, risultando necessario e sufficiente – a norma dell’art. 35 del D.Lgs.
31.3.1998, n. 80, nel testo introdotto dall’art. 7
della legge 21.7.2000, n. 205 – che si forniscano al riguardo i criteri, a cui l’Amministrazione
dovrà attenersi nella successiva fase di liquidazione. Viene normalmente escluso infatti, in assenza di esplicita disciplina normativa in tal
senso, che sia stata introdotta nel processo amministrativo l’azione di condanna generica,
prevista dall’art. 278 cod. proc. civ., ma è la
stessa norma di riferimento (art. 35 D.Lgs. n.
80/98 cit.) a rendere possibile – sulla base del
mero principio di prova fornito dalla parte interessata – la fissazione di parametri, in base ai
quali sia possibile pervenire ad un accordo fra
le parti, fatto salvo “il ricorso previsto dall’art.
27, comma 1, n. 4 del T.U. approvato con R.D.
26.6.1924, n. 1054” (cfr. in tal senso Cons. St.,
sez. IV, 2.3.2004, n. 942, 28.4.2006, n. 2408, e
11.10.2006, n. 6063; Cons. St., sez. V,
27.4.2006, n. 3229 e 20.3.2007, n. 1346).
Detti parametri vengono quindi fissati, con
l’attuale pronuncia, nei seguenti termini:
a) accertamento degli utili realizzati dall’impresa di cui trattasi negli ultimi cinque anni,
antecedenti alla revoca della licenza, e proiezione del valore medio di tali utili, maggiorato
degli oneri accessori, per il periodo di interruzione dell’attività;
b) valutazione alternativa – in base ai criteri di
apprezzamento, normalmente utilizzati nel
mondo finanziario – della redditività e del valore riconducibili all’azienda in questione in
rapporto al fatturato, al capitale investito e all’organizzazione esistente, anche con riferimento suppletivo ai parametri, di cui all’art. 11
del D.L. 2.3.1989, n. 69, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 L.
27.4.1989, n. 99 (soltanto però, a quest’ultimo
riguardo, ove l’interessato sia in grado di accostare ai dati presuntivi adeguati supporti probatori);
c) detrazione, in ogni caso, dei redditi percepiti dall’appellante, per attività alternative a
quelle dell’impresa di vigilanza in questione,
tenuto conto dei dati forniti dal medesimo interessato e delle relative dichiarazioni dei redditi;
d) aggiunta, in ogni caso, della somma ritenuta
corrispondente all’avviamento dell’azienda, da
NGCC 2010 - Parte prima
Cons. Stato, 8.9.2009, n. 5266 - Commento
valutare in base ai parametri, di cui al precedente punto b).
Nei termini in precedenza illustrati, in conclusione, l’appello viene in parte accolto, con
conseguente annullamento della quantificazione del danno, operata nella sentenza appellata
e previsto rinnovo di tale quantificazione, in
contraddittorio fra le parti, al fine di pervenire
ad una proposta di liquidazione del danno, da
parte dell’Amministrazione appellata, entro
120 giorni dalla data di comunicazione in via
amministrativa della presente pronuncia, o di
notifica della stessa ad opera della parte più diligente, se anteriore. Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa l’integrale compensazione fra le parti in causa, tenuto conto della complessità della vicenda dedotta in giudizio. (Omissis)
[Varrone Presidente – De Michele Estensore. –
C.L. e L.F. (avv.ti Cercaci e Ciaschi) – Ministero
dell’Interno (avv. gen. Stato)]
Nota di commento: «Il danno esistenziale causato all’imprenditore dal provvedimento illegittimo della p.a.»
I. Il caso
A seguito di illegittima revoca dell’autorizzazione
di polizia, il titolare di un istituto di vigilanza privata
era costretto a cessare la propria attività imprenditoriale.
L’atto di revoca veniva in seguito annullato ed il
titolare adiva la giustizia amministrativa per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno. Il
T.A.R. accoglieva solo in parte il ricorso e l’imprenditore proponeva appello al Consiglio di Stato contestando la quantificazione del danno sia sotto il
profilo patrimoniale, sia sotto il profilo non patrimoniale in connessione ai quindici anni di inattività
lavorativa con conseguenze sul piano non solo economico, ma anche psicologico e delle relazioni umane.
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato, riconosce la risarcibilità del danno esistenziale
richiamando l’orientamento della Corte di cassazione di cui alle sentenze del 31.5.2003, nn. 8827-8828,
e ribadendo la risarcibilità della lesione di
diritti della persona costituzionalmente garantiti, con particolare riguardo agli artt. 2, 4, 36 e
41 Cost.
NGCC 2010 - Parte prima
Responsabilità civile
II. Le questioni
1. Dall’ammissione dell’azione di risarcimento al riconoscimento del danno esistenziale. La sentenza in commento compendia il percorso compiuto in ambito amministrativo in tema di
responsabilità dall’ammissione dell’azione di risarcimento sino ad approdare al riconoscimento della tutela risarcitoria del danno esistenziale. Storicamente
restie persino ad ammettere la possibilità di esperire
l’azione di risarcimento danni contro la pubblica
amministrazione per illegittimo provvedimento, la
dottrina e la giurisprudenza amministrative sono
giunte all’ammissione di quella tipologia di danno, il
danno esistenziale, che in ambito privatistico suscita
ancora incertezze e tentennamenti.
L’ammissibilità e la risarcibilità del danno esistenziale sembrano ormai stabilizzate e ancorate alle
sentenze della Cassazione del 31.5.2003, nn. 88278828 (infra, sez. III).
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato accoglie la
richiesta di risarcimento del danno esistenziale rigettata in primo grado. Occorre subito precisare che il
T.A.R. ha negato, pur ritenendola legittima, la tutela
risarcitoria di tale pregiudizio esclusivamente per
mancanza di qualsiasi allegazione probatoria. In
particolare, il giudice di primo grado non ha tenuto
in considerazione che dal prolungato periodo (quindici anni) di inattività lavorativa sono derivate inevitabili conseguenze di ordine psicologico e relazionale, oltre che economico.
È, ormai, noto che l’attività della p.a. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche
della norma primaria del neminem laedere: ciò significa che, in considerazione dei principi di legalità,
imparzialità e buona amministrazione dettati dall’art. 97 Cost., l’amministrazione è tenuta a subire le
conseguenze stabilite dall’art. 2043 cod. civ. (Cass.,
17.10.2001, n. 12672, infra, sez. III).
Infatti, a seguito della sentenza del 22.7.1999, n.
500 delle sez. un. della Corte di cassazione, la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere che la lesione di un interesse legittimo può essere fonte di responsabilità aquiliana e, quindi, dar luogo a risarcimento del danno ingiusto a condizione che risulti
danneggiato il bene della vita al quale il primo si
correla e che detto interesse sia meritevole di tutela
secondo l’ordinamento (Cass., sez. un., 22.7.1999,
n. 500, infra, sez. III).
Per quanto concerne il caso di cui alla sentenza in
commento:
1) l’attività di polizia esercitata in forma privata è
certamente meritevole di tutela in quanto tutelata
sia a livello costituzionale dall’art. 36 (diritto al lavoro) e dall’art. 41 (libertà di iniziativa economica
privata), sia a livello di legge ordinaria essendo pre305
Cons. Stato, 8.9.2009, n. 5266 - Commento
visto per il suo esercizio l’autorizzazione amministrativa;
2) la lesione al bene della vita si è verificata dato che,
a causa della revoca illegittima di quella autorizzazione, l’attività economica è cessata per 15 anni con
notevole danno patrimoniale e non patrimoniale.
In casi come quello in esame, ben si nota che il
potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto
costituisce uno strumento di tutela ulteriore rispetto
a quello demolitorio da utilizzare per rendere giustizia nei confronti della p.a. Infatti, il mero annullamento dell’atto di revoca dell’autorizzazione e,
quindi, il ripristino della situazione di diritto, non
ha evitato il pregiudizio in quanto il danneggiato,
per il periodo considerato, non ha potuto esercitare
la propria attività imprenditoriale con notevoli ripercussioni anche sulla sfera relazionale.
Ciò che sorprende è che, se da un lato c’è stata
difficoltà ad ammettere la tutela risarcitoria contro
un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, il passo successivo di affiancamento al
danno patrimoniale del danno non patrimoniale e,
in particolare, del danno esistenziale è stato assai
breve. Ad oggi, addirittura, la giurisprudenza amministrativa dimostra di avere le idee abbastanza chiare in materia di danno esistenziale anche in un contesto nel quale si è generata parecchia confusione a
seguito dell’intervento delle sez. un. della Cassazione dell’11.11.2008. I giudici amministrativi, ancor
più dei giudici ordinari, si mostrano sostanzialmente
d’accordo nel risarcire il danno esistenziale quale lesione di ineressi di rango costituzionale richiamando
sempre più spesso nelle loro decisioni l’orientamento espresso dalle ricordate sentenze della Cassazione
del 31.5.2003, nn. 8827-8828.
2. Il danno esistenziale nella giurisprudenza amministrativa. In materia di responsabilità, è noto, al risarcimento del danno patrimoniale
(nella specie, causato da un atto illegittimo della
p.a.) si affianca il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 cod. civ.
È stato osservato (Garri-Garri, 61, infra, sez.
IV) che oggi non si può prescindere da una lettura
costituzionalmente orientata di tale norma per evidenti ragioni di allineamento dell’interpretazione
normativa a principi di civiltà giuridica: è compito
di tale norma assicurare la riparazione anche a quelle lesioni che incidono su valori e prerogative della
persona.
In quest’ottica, dunque, la sentenza in esame, definisce «danno esistenziale» il pregiudizio subito dall’imprenditore privato della propria attività per oltre
quindici anni a seguito di un provvedimento illegittimo. Il danno de quo trova fondamento nei principi
costituzionali di cui agli artt. 4, 36 e 41 Cost.
306
Responsabilità civile
Si noti che la sentenza non menziona affatto le
sentenze della Cass. a sez. un. dell’11.11.2008, ma si
riporta a quanto affermato dalla Supr. Corte con le
sentenze nn. 8827-8828/2003, secondo le quali deve
ritenersi comunque risarcibile l’ingiusta lesione di
interessi inerenti la persona di rango costituzionale,
fra cui rientra senza ombra di dubbio l’iniziativa
economica privata ed il diritto al lavoro.
Secondo il Consiglio di Stato, il pregiudizio agli
interessi inerenti la persona dovuto al provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione si è
manifestato in una «compromissione dell’autostima,
del benessere e della sfera relazionale del danneggiato
(...) per effetto della lunga interruzione subita dall’attività imprenditoriale che era stata esercitata per svariati anni con presumibile concentrazione sulla stessa
dei propri interessi professionali e della propria posizione in termini economici e sociali».
La sentenza in commento costituisce un’ulteriore
conferma all’orientamento della giurisprudenza amministrativa fiorita nel corso del 2009 favorevole al
riconoscimento ed alla risarcibilità del danno esistenziale.
In particolare, emerge dalle pronunce che il diritto al lavoro ha «una forte valenza esistenziale» in
quanto è in ambito lavorativo, più che in altri ambiti, che si esplica la personalità dell’individuo ai
sensi dell’art. 2 Cost. Ne consegue che ogni lesione
di tale diritto incide inevitabilmente sulla dignità
personale e sulla vita di relazione del lavoratore in
termini di benessere e autostima. E il danno esistenziale consiste propriamente nei riflessi esistenziali negativi che ogni violazione di un diritto della
personalità produce, in un peggioramento della
qualità della vita derivante dalla lesione del valore
costituzionale uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità
(Zappia, 1394, infra, sez. IV).
La forte valenza esistenziale del diritto al lavoro,
anche nelle forme dell’attività imprenditoriale,
emerge anche dalla considerazione, presente in alcune decisioni, che la prospettiva di riconoscimento delle capacità e di rendimento in ambito lavorativo costituisce un elemento di forte motivazione in
virtù del prestigio personale e professionale di cui
gode nella propria vita di relazione anche al di fuori dell’ambiente strettamente lavorativo. Ne consegue che la cessazione illegittimamente coartata dell’attività lavorativa può avere, come nel caso concreto ha avuto, riflessi negativi sulla vita di relazione intesi quale perdita di compiacimento e di benessere e peggioramento della qualità della vita per
il danneggiato in conseguenza della violazione di
un diritto alla personalità.
La forte valenza esistenziale del diritto al lavoro è
stata sancita anche dalla sentenza della Cass.,
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238
5.10.2009, n. 21223 (infra, sez. III) che, omettendo
richiami alle sez. un. dell’11.11.2008, ribadisce che il
danno esistenziale «è quel pregiudizio provocato sul
fare aredittuale del soggetto che altera le sue abitudini
e gli assetti relazionali propri inducendolo a scelte di
vita diverse quanto alla espressione e realizzazione
della sua personalità nel mondo esterno».
Tale definizione ben si attaglia al caso di specie
ove la revoca della autorizzazione ha comportato la
cessazione dell’attività esercitata per svariati anni
con concentrazione nella stessa dei propri interessi
professionali e della propria posizione in termini
economici e sociali.
III. I precedenti
1. Dall’ammissione dell’azione di risarcimento al riconoscimento del danno esistenziale. Cass., sez. un., 22.7.1999, n. 500, in Foro
amm., 2000, 349; Cass., 17.10.2001, n. 12672, in
Mass. Giur. it., 2001.
2. Il danno esistenziale nella giurisprudenza amministrativa. Cass., 31.5.2003, nn. 88278828, in Resp. civ. e prev., 2003, 685; Cass., 5.10.2009
n. 21223, in www.personaedanno.it; T.A.R. Lombardia, 10.8.2009, ibidem; T.A.R. Veneto, 2.2.2009, ibidem; T.A.R. Campania, 8.5.2009, ibidem.
c CASS. CIV., sez. un., 21.10.2009, n. 22238
Cassa App. Roma, decr. 23.7.2008
Separazione dei coniugi
IV. La dottrina
1. Dall’ammissione dell’azione di risarcimento al riconoscimento del danno esistenziale. Garri-Garri, La responsabilità della Pubblica
Amministrazione, nella Giurisprudenza Bigiavi, Utet,
2007, 61; Perfetti, Manuale di diritto amministrativo, Cedam, 2007, 645; Aa.Vv., voce «La responsabilità civile della P.A.», in Enc. giur. Sole 24 ore.
2. Il danno esistenziale nella giurisprudenza amministrativa. Aa.Vv., I singoli danni, in
I danni risarcibili nella responsabilità civile, 5, in Il
diritto civile nella Giurisprudenza, a cura di Cendon, Utet, 2005, 93 ss.; Cendon, Anche se gli
amanti si perdono l’amore non si perderà: impressioni
di lettura su Cass. 8828/2003, in Resp. civ. e prev.,
2003, 685; Forlenza, La prescrizione del diritto all’indennizzo decorre dalla sentenza di annullamento,
in Guida al dir., 2006, n. 42, 87; Zappia, Il danno esistenziale causato dall’attività provvedi mentale illegittima della p.a., in Resp. civ. e prev., 2005, 1394; F.
Garri-G. Garri, La responsabilità civile della pubblica amministrazione, nella Giurisprudenza Bigiavi,
Utet, 2007.
Elisa Bucci
la U.E. - Connessione e litispendenza
internazionale (l. 15.1.1994, n. 64; reg. CE n.
2201/2003, art. 10) (b)
Separazione dei coniugi - Affidamento
dei figli - Ascolto dei figli minorenni
- Limiti all’ascolto - Conseguenze
processuali del mancato ascolto (cod.
civ., art. 155 sexies; Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, art. 6) (a)
Separazione dei coniugi - Affidamento dei figli - Trasferimento all’estero ovvero mancato rientro in Italia
di minori a opera del genitore affidatario - Inosservanza delle condizioni di separazione da parte del genitore affidatario - Ripartizione della giurisdizione in ordine ai provvedimenti «de potestate» tra Stati delNGCC 2010 - Parte prima
(a) L’audizione dei minori, già prevista
nell’art. 12 della Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo, è divenuta un
adempimento necessario, nelle procedure
giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento
ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell’art.
155 sexies cod. civ., introdotto dalla legge
n. 54 del 2006, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori
del minore. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei
principi del giusto processo il mancato
307
Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238
ascolto che non sia sorretto da espressa
motivazione sull’assenza di discernimento
che ne può giustificare l’omissione, in
quanto il minore è portatore d’interessi
contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita
e, per tale profilo, è qualificabile come
parte in senso sostanziale.
(b) In tema di giurisdizione sui provvedimenti «de potestate», il trasferimento all’estero o il mancato rientro in Italia di
minori figli di genitori separati non è qualificabile come illecita sottrazione all’altro
genitore, allorché l’allontanamento avvenga ad opera dell’affidatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è inapplicabile
la Convenzione dell’Aja del 25.10.1980
sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, resa esecutiva in Italia
con la legge n. 64 del 1994; tuttavia, qualora la mobilità internazionale e la mutabilità della residenza abituale sia stata
convenzionalmente esclusa dai coniugi
nelle condizioni di separazione, trova applicazione l’art. 10 del regolamento CE n.
2201 del 27.11.2003, con la conseguenza
che competente a decidere della responsabilità genitoriale resta il giudice della pregressa residenza abituale, finché non sia
decorso un anno da quando chi aveva diritto a chiedere il ripristino del diritto di
visita o il rientro ha avuto conoscenza del
cambio di residenza.
dal testo:
Il fatto. Il Tribunale di Rieti, con decreto del
17 aprile 2007, sui ricorsi riuniti del 15 settembre e del 13 ottobre 2006 di A.K.A. e C.G., coniugi consensualmente separati con omologa
del (Omissis), affermata la propria giurisdizione in luogo di quella dei giudici finlandesi, s’è
dichiarato incompetente sulle istanze di modifica delle disposizioni accessorie alla separazione, presentate dalla donna in rapporto al diritto di visita del padre ai due figli M. e M.C., nati
ad (Omissis) il (Omissis) 1996 e il (Omissis)
1998, affidati nell’accordo omologato alla ma308
Separazione dei coniugi
dre che, per ragioni di lavoro, si era trasferita
in Finlandia con loro, domandando in quel
paese pure il divorzio dal marito in data successiva, e sulla richiesta del C. di affidamento
esclusivo a lui dei figli condotti all’estero contro la sua volontà, con ogni altra statuizione
consequenziale.
La Corte d’appello di Roma, sui reclami di
entrambe le parti, con il decreto di cui in epigrafe, ha riaffermato la giurisdizione del giudice italiano impugnata dalla A., in base alle regole sulla litispendenza tra giudizi in materia di
affidamento di minori pendenti in più Stati
membri della CE, per essere stato adito il giudice italiano prima di quello finlandese, che,
nel suo provvedimento interinale del 18 gennaio 2007, aveva disposto provvisoriamente incontri in quel paese tra padre e figli, “in attesa
della decisione” della predetta Corte di merito.
È stato invece accolto l’appello del C. sulla
competenza del primo giudice, da questo denegata a favore del tribunale per i minorenni,
per essere stati i due figli sottratti e trattenuti
illecitamente all’estero (Convenzione de L’Aja
del 28 maggio 1970 e L. 15 gennaio 1994, n.
64), affermandosi che in primo grado si erano
chieste modifiche di patti accessori alla separazione, su cui doveva decidere il tribunale, ai
sensi dell’art. 710 c.p.c. La Corte di merito, ha
affidato al C. i due minori, senza disporre la loro audizione chiesta con le conclusioni dal
P.G. assegnandogli la casa familiare in (Omissis) e confermando la sanzione irrogata alla
donna di Euro 5000,00 ai sensi dell’art. 709 ter
c.p.c., per aver violato le disposizioni concordate in sede di separazione consensuale.
In secondo grado è stata invece respinta la richiesta del C. di un contributo a carico della moglie per il mantenimento dei figli, ritenendosi
non provata la capacità contributiva di lei, condannata alle spese del grado per la soccombenza.
Per la cassazione di tale decreto propone ricorso principale di dodici motivi la A., cui resiste il C. con controricorso e ricorso incidentale
di due motivi, cui controparte replica con altro
controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
I motivi. (Omissis) 2.1. I primi quattro motivi del ricorso principale propongono la questione di giurisdizione, denunciando il primo
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238
violazioni di legge e gli altri tre vizi motivazionali del decreto. (Omissis)
Il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c., è il seguente: “Dica la Cassazione se la
Corte di appello di Roma, avendo dichiarato in
motivazione che i minori erano stati trasferiti
in (Omissis) pochi giorni prima dell’inizio del
procedimento italiano promosso dal C. dinanzi
al Tribunale di Rieti, per ottenere l’affido
esclusivo dei figli, abbia errato nell’affermare
la propria giurisdizione in luogo di quella del
giudice finlandese, disapplicando l’art. 8 del
Regolamento CE n. 2201/2003, non essendo
più l’Italia il paese di residenza abituale dei figli minori”.
Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso
denunciano carenze motivazionali del decreto
impugnato in ordine ai presupposti di fatto
della rilevata giurisdizione del giudice italiano.
Dalla Corte di merito si afferma che nessuna
delle parti ha chiesto l’affidamento dei minori
“in forza della Convenzione dell’Aja”, essendosi domandata “più semplicemente, una modifica delle condizioni della separazione”, ma
così non si giustifica la giurisdizione del giudice italiano, per il citato art. 8 che collega il potere di decidere al luogo ove risiede il minore
al momento della domanda che nel caso era
quello finlandese.
Il terzo motivo di ricorso censura il decreto
d’appello, per avere fondato la affermazione
della propria giurisdizione sul fatto che la stessa ricorrente si era rivolta “al Tribunale di Rieti
per poi scoprire che questo non aveva giurisdizione”; in realtà la A. ha chiesto il 15 settembre
2006, nei tre mesi dal trasferimento dei figli, al
giudice italiano la modifica del solo diritto di
visita ai figli del padre, in ragione della ultrattività della residenza per tale tempo prevista nell’art. 9 del citato Regolamento CE. Dopo oltre
tre mesi dal cambio di residenza dei figli, il C.
ad ottobre ha richiesto l’affidamento esclusivo
dei figli, sul quale poteva decidere solo l’autorità giudiziaria finlandese e il decreto non giustifica la giurisdizione del giudice italiano.
Il quarto motivo di ricorso censura le carenze motivazionali del decreto in ordine alla circostanza in esso riportata che i giudici finlandesi avrebbero riconosciuto la giurisdizione
dei giudici italiani, adottando solo provvedimenti urgenti e provvisori sugli incontri padreNGCC 2010 - Parte prima
Separazione dei coniugi
figli, fino alla decisione dei giudici italiani.
(Omissis)
2.2. La questione della mancata audizione dei
minori nel procedimento di merito è dedotta nel
quinto e sesto motivo del ricorso principale; anzitutto si denuncia violazione dell’art. 12 della
Convenzione di New York del 20 novembre
1989, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991,
n. 176, dell’art. 6 capo B della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, aperta
alla firma a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia con L. 20 marzo 2003, n. 77, dell’art. 23 del citato Regolamento CE n. 2001/
2003, dell’art. 155 sexies c.c., applicabile in via
estensiva o almeno analogica al procedimento di
modifica delle condizioni di separazione, nonché
degli artt. 3, 21 e 111 Cost. (Omissis)
4.1. I primi quattro motivi del ricorso principale, attinenti alla questione di giurisdizione
sono infondati e da rigettare.
Effettivamente il criterio di collegamento su
cui si fonda il riparto di giurisdizione tra autorità giurisdizionali di Stati membri della U.E.,
in ordine alle decisioni sull’affido e le modalità
di visita a figli minori, in base all’art. 8 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, è quello della
residenza abituale del figlio, per il rapporto di
prossimità del minore al giudice che deve decidere sulle modalità di vita di lui (su tale criterio
cfr. S.U. 24 marzo 2006 n. 6585 e 7 marzo
2005 n. 4807 e sul principio di prossimità, utile
per individuare il giudice territorialmente competente in rapporto all’affidamento di minori,
cfr. la recente S.U. 9 dicembre 2008 n. 28975).
La Corte d’appello – si afferma nel ricorso
principale – non avrebbe tenuto conto che i
minori si erano trasferiti in (Omissis) dal
(Omissis), prima dell’inizio dell’azione della A.
per la modifica del diritto di visita del C. ai figli, per cui esattamente ella aveva adito il Tribunale di Rieti nel settembre successivo, cioè
nei tre mesi dal mutamento di residenza abituale dei minori, come consentito dall’art. 9 del
Regolamento CE citato, che sancisce, per tale
limitato periodo di tempo, la ultraattività della
preesistente residenza abituale dei minori, come criterio di collegamento per individuare tra
le autorità giudiziarie degli Stati della U.E.,
quella avente giurisdizione in caso di trasferimento di uno dei coniugi con i figli in altro Stato membro della comunità.
309
Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238
Peraltro, il concetto di residenza abituale dei
minori, come centro di vita e di relazioni degli
stessi, corrisponde a fatti accertabili dal solo
giudice del merito la cui decisione non è censurabile per cassazione se motivatamente accertata, (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22507 e 10 ottobre 2003 n. 15145): la Corte d’appello ha ricostruito le circostanze relative alla vita di C.M. e
Mi., evidenziando che essi avevano sempre vissuto a (Omissis) fino alla separazione dei genitori e solo nel (Omissis) erano stati condotti in
(Omissis) dalla madre, che si era impegnata in
sede di separazione a rimanere in (Omissis) e a
risiedervi con i figli.
Ad avviso dei giudici di merito, la A. aveva
dedotto, nel ricorso introduttivo dell’azione da
lei iniziata dinanzi al Tribunale di Rieti nel settembre 2006 che, a quella data, ella aveva intenzione di trasferire la residenza propria e dei
figli in (Omissis) e non che il trasferimento era
già avvenuto.
In sostanza, alla data di tale ricorso (5 - 15
settembre 2006), poteva presumersi sussistere
ancora lo stabile rapporto dei minori con la casa familiare in (Omissis), la quale nel giugno
precedente, con la omologazione, era stata assegnata alla madre, perché continuasse a vivervi con i figli.
Alla data della domanda di modifica dell’affidamento dei figli da parte del C. (Omissis), lo
stesso, avendo appreso, dal ricorso della moglie per la prima volta la intenzione di lei di trasferirsi con i figli in (Omissis), ben poteva ritenere sussistere la giurisdizione del Tribunale di
Rieti, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento
CE 2201/2003, potendo egli escludere, in base
alle notizie fornite dalla controparte, che fossero già decorsi tre mesi dal cambio di residenza
abituale dei minori, per cui egli pure poteva
fruire della ultraattività della giurisdizione italiana di cui al citato art. 9 del Regolamento CE,
facendo decorrere il termine trimestrale, per i
principi del giusto processo e del contraddittorio, dalla intervenuta comunicazione a lui della
mutata abituale residenza dei minori, ancora
non avvenuta secondo le deduzioni del ricorso
della A. all’inizio del mese di (Omissis).
A tale conoscenza fa del resto chiaro riferimento l’art. 10 del medesimo Regolamento
CE, per il caso di “illecito” trasferimento all’estero dei minori, che, per tale sua natura, de310
Separazione dei coniugi
ve presumersi non conosciuto da chi agisce per
la modifica delle condizioni della separazione
consensuale ex, artt. 711 e 710 c.p.c.
Correttamente quindi il C. ha chiesto al giudice italiano, l’affidamento in via esclusiva dei
figli M. e Mi., a rettifica di quanto concordato
con la moglie nella separazione consensuale,
nel termine di tre mesi dalla data in cui egli ha
avuto consapevolezza del possibile trasferimento della residenza abituale dei minori in
(Omissis), ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
CE, indipendentemente dalla illiceità del mutamento della dimora abituale operato da controparte in violazione degli accordi di separazione, come accertato in sede penale.
Se l’autonomia dei due ricorsi delle parti, riuniti dal Tribunale di Rieti, esclude che la donna
abbia accettato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di affidamento esclusivo
del C., sulla quale anzi ella ha sollevato subito
l’eccezione di difetto di giurisdizione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 12 del Regolamento per radicare i poteri cognitivi sulla domanda nel giudice italiano, certamente sussiste
la connessione e litispendenza delle due cause
riunite dinanzi al giudice italiano con quella di
divorzio iniziata dal A. successivamente dinanzi al Tribunale di Helsinki, che ha espressamente riconosciuto detta connessione.
L’art. 19 del Regolamento CE più volte citato chiarisce che nei casi di litispendenza e/o
connessione, l’autorità giudiziaria adita successivamente, deve dichiarare la propria incompetenza a favore di quella investita della stessa
questione o di questione connessa, anche se
può emettere i provvedimenti urgenti di cui all’art. 20 nell’interesse dei minori.
Nel caso, correttamente il Tribunale di Helsinki ha dato le disposizioni urgenti relative ai
minori C., riconoscendo però la giurisdizione
del giudice italiano preventivamente adito sull’affidamento oggetto della domanda del padre
e sul diritto di visita oggetto dell’azione della
madre, non potendosi accogliere la deduzione
di cui al ricorso principale sulla differenza tra
le questioni proposte ai due giudici dei diversi
Stati membri, apparendo esse almeno strettamente connesse se non identiche in rapporto al
carattere accessorio di esse nel processo di divorzio, con conseguente applicabilità della disciplina che precede, per cui competente è coNGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238
munque il giudice adito per primo e quindi
quello italiano.
Se è vero che si è esattamente tenuto distinto
il diritto di visita dall’istituto dell’affidamento,
in rapporto al trasferimento all’estero o al mancato rientro di minori, che non si ritengono sottratti illecitamente all’altro genitore allorché
l’allontanamento avviene ad opera dell’affidatario con il quale i minori devono convivere come nel caso (Cass. 2 luglio 2007 n. 14960, 14 luglio 2006 n. 16092 e 5 maggio 2006 n. 10374),
non è però contestato che tale mobilità internazionale e mutabilità della residenza abituale,
era stata convenzionalmente esclusa dai coniugi nelle condizioni da loro concordate della separazione, tanto che la ricorrente, come già detto, è stata anche condannata penalmente per
mancata esecuzione dell’accordo omologato dal
Tribunale di Rieti e ai sensi dell’art. 388 c.p.
Esattamente la Corte d’appello ha qualificato “illecito” il mancato rientro dei minori in
(Omissis), rilevando come il C. non avesse agito nella fattispecie in base alle Convenzioni
dell’Aja del 1970 e 1980, per ottenere il ritorno
dei figli nella casa familiare, con il ripristino del
suo diritto di visita a mezzo dell’Autorità centrale di cui a tali accordi e ai sensi della L. 15
gennaio 1994, n. 64, di ratifica di essi, per cui
la presente azione ha potuto continuare e non
s’è dovuta sospendere in attesa dell’esito del
procedimento di rientro dei figli (Cass. 15 ottobre 1997 n. 10090).
La rilevata violazione degli accordi di separazione, per effetto del trasferimento in (Omissis) della residenza propria e dei minori ad
opera della madre, in rapporto alla giurisdizione, comporta l’applicabilità dell’art. 10 del Regolamento più volte citato, per cui resta competente a decidere della responsabilità genitoriale sui minori il giudice della pregressa residenza abituale dei minori fino alla data dell’acquisizione della nuova residenza, finché non
sia decorso “un anno” da quando chi aveva diritto a chiedere il ripristino del diritto di visita
o il rientro, ha avuto conoscenza del cambio di
residenza, per cui, anche per tale profilo, va affermata la giurisdizione del giudice italiano, da
confermare in questa sede, con il rigetto del ricorso principale sulla questione relativa.
È infatti infondata anche la censura di cui al
secondo motivo di ricorso principale, avendo
NGCC 2010 - Parte prima
Separazione dei coniugi
esattamente la Corte di merito richiamato le citate Convenzioni de L’Aja, ratificate con la legge n. 64 del 1994, per riaffermare la sua giurisdizione, anche se non in collegamento all’art.
10 del Regolamento CE citato, essendo rilevante la circostanza che l’A. si fosse rivolta al giudice italiano nel (Omissis), informando della sua
intenzione di trasferirsi all’estero solo in questa
data e così rimettendo in termini il C. per proporre al giudice italiano la domanda di affidamento esclusivo (terzo motivo di ricorso), fermo restando il corretto richiamo alla decisione
interlocutoria dei giudici finlandesi sui minori e
alla litispendenza e connessione rilevata da costoro, che ancora una volta comporta il potere
di decidere dei giudici italiani (quarto motivo).
4.2. Il quinto e sesto motivo di ricorso sono
da ritenere invece fondati nei limiti che seguono, in rapporto alla mancata audizione dei figli
nel presente procedimento, destinato a regolare in via esclusiva o prevalente interessi primari
degli stessi minori, anche se M. ha compiuto
dodici anni nel periodo tra la riserva della decisione e la pubblicazione del decreto impugnato (marzo 2008), mancando in questo atto
ogni pronuncia motivata, anche di rigetto, sulla
richiesta del P.G. del luglio 2007 di audizione
dei due adolescenti e di ulteriore istruzione
della causa, prima di decidere sulla modifica
dello affidamento esclusivo alla madre concordato a giugno del 2006, riconoscendolo in favore del solo padre nel luglio 2008 dopo soli
due anni dalla precedente soluzione (sull’obbligo di motivazione in ordine alla richiesta di
audizione dei minori e al rigetto di essa, cfr.
Cass. 23 luglio 2007 n. 6899).
Invero i minori che, ad avviso di questa Corte non possono considerarsi parti del procedimento (in tal senso sembra, sia pure con aperture, Cass. 10 ottobre 2003 n. 15145), sono stati esattamente ritenuti portatori di interessi
contrapposti o diversi da quelli dei genitori, in
sede di affidamento o di disciplina del diritto
di visita del genitore non affidatario e, per tale
profilo, qualificati parti in senso sostanziale
(così C. Cost. 30 gennaio 2002 n. 1).
Costituisce quindi violazione del principio
del contraddittorio e dei principi del giusto
processo il mancato ascolto dei minori oggetto
di causa, censurato in questa sede, nella quale
emergono chiari gli interessi rilevanti dei mino311
Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 - Commento
ri che sono in gioco nella vertenza e avrebbero
resa necessaria la loro audizione (sul rilievo di
tali interessi per la denuncia del vizio processuale del mancato ascolto dei minori cfr. Cass.
12 giugno 2007 n. 13761 e 18 giugno 2005 n.
13173, non rilevando i principi di insindacabilità della decisione di non procedere all’ascolto
dei minori, in caso di potenziale dannosità di
essa per i soggetti non sentiti, di cui a Cass. 27
luglio 2007 n. 16753, in difetto di qualsiasi
pronuncia dei giudici di merito in tal senso).
L’audizione dei minori che, nel procedimento per il mancato illecito rientro nella originaria residenza abituale, non è imposta per legge,
in ragione del carattere urgente e meramente
ripristinatorio della situazione di tale procedura (Cass. 4 aprile 2007 n. 8481 e 19 dicembre
2003 n. 19544), anche in tale procedura si è però ritenuta in genere opportuna, se possibile
(Cass. 4 aprile 2007 n. 8481 e la citata n. 15145
del 2003).
Tale audizione era prevista dall’art. 12 della
Convenzione sui diritti del fanciullo di New
York del 1991 che ritiene sussistere, in caso di
riconoscimento della capacità di discernimento
del minore, il diritto di questo “di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione
che lo interessa”, dandogli la possibilità “di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o
amministrativa che lo riguarda”.
In base a tale norma sovranazionale l’ascolto
dei minori oggetto del procedimento nelle opposizioni allo stato di adottabilità si è ritenuto
di regola necessario (Cass. 9 giugno 2005 n.
12168, 26 novembre 2004 n. 22235, 21 marzo
2003 n. 4124, 16 luglio 2000 n. 9802, tutte al
seguito di Cass. 13 luglio 1997 n. 9802).
L’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l’art. 6 della Convenzione di
Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del
2003 (Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo
2006 n. 6081), per cui ad essa deve procedersi,
salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte
(la citata Cass. n. 16753 del 2007).
La citata Convenzione di Strasburgo prevede che ogni decisione relativa ai minori indichi
312
Separazione dei coniugi
le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento
adottato anche in forma di decreto, nel quale
deve tenersi conto della opinione espressa dai
minori, previa informazione a costoro delle
istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l’ascolto o l’audizione
siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi (in tal senso Cass. ord. 26 aprile
2007 n. 9094 e la giurisprudenza sopra richiamata).
In conclusione, il quesito conclusivo del
quinto motivo di ricorso può avere risposta positiva, in rapporto alla dedotta violazione dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge n. 77 del 2003 e dell’art. 155
sexies c.c., introdotto dalla L. 8 febbraio 2006,
n. 54, dovendosi ritenere necessaria l’audizione
del minore del cui affidamento deve disporsi,
salvo che tale ascolto possa essere in contrasto
con i suoi interessi fondamentali e dovendosi
motivare l’eventuale assenza di discernimento
dei minori che possa giustificarne l’omesso
ascolto, con conseguente fondatezza anche del
sesto motivo d’impugnazione nei limiti ora indicati e necessità di cassare l’intero decreto in
rapporto alla dedotta omissione dei giudici di
merito.
Neppure rileva in questa sede il tentativo del
tribunale di Rieti di ascoltare i minori non andato a buon fine in un contesto nel quale però
il primo giudice si è dichiarato incompetente a
provvedere sull’affido dei figli al padre.
4.3. Restano quindi assorbiti tutti gli altri
motivi del ricorso principale e quello incidentale. (Omissis)
[Carbone Presidente – Forte Estensore – Jannelli P.M.(concl. diff.). – A. (avv.ti M. Martignetti e G.
Martignetti) – C. (avv. Mattoni)]
Nota di commento: «Ascolto dei figli contesi e
individuazione della giurisdizione nel caso di
trasferimento all’estero dei figli da parte del genitore affidatario»
I. Il caso
Con la sentenza in commento le sezioni unite civili intervengono autorevolmente su due rilevanti queNGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 - Commento
stioni relative all’affidamento dei figli nella scissione
della coppia genitoriale. La prima è quella delle
conseguenze del mancato ascolto del minorenne: secondo la Supr. Corte, la mancata audizione del figlio minore determina la nullità del provvedimento impugnato per violazione dei principi del
contraddittorio e del giusto processo. Il secondo
profilo di interesse è l’individuazione della giurisdizione per i provvedimenti di modifica delle
condizioni della separazione nel caso di trasferimento all’estero dei figli da parte del genitore affidatario. Essendo nel caso di specie la coppia genitoriale
italo-finlandese, la fonte normativa pertinente è il
reg. CE n. 2201/2003 del 27.11.2003 relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale.
II. Le questioni
1. L’ascolto del minore. Fino alla riforma sull’affidamento condiviso, com’è noto, la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie ritenevano che
l’ascolto dei figli minori nei procedimenti di rottura
della relazione coniugale fosse un mezzo istruttorio
essenzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice sia nell’an sia nel quomodo (Graziosi, Note sul
diritto del minore, 1291, infra, sez. IV). In questo
senso militava anche la lettera dell’art. 6, comma 9o,
l. div., secondo cui i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli devono essere «emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice, ivi compresa l’audizione
dei figli minori, qualora sia strettamente necessario
anche in considerazione della loro età». Logica conseguenza dell’interpretazione dell’ascolto in chiave
istruttoria era che la mancata audizione potesse al
più determinare un mero vizio di motivazione della
decisione (cfr. mutatis mutandis Cass., 9.1.2005, n.
12168, e Cass., 23.7.1997, n. 6899, infra, sez. III. In
dottrina Graziosi, Note sul diritto del minore, 1291,
infra, sez. IV).
In dottrina si era tuttavia andata progressivamente affermando la tesi secondo cui l’ascolto non sarebbe un mezzo di prova in senso stretto, ma uno
strumento di attuazione della libertà di opinione e
di espressione che deve essere riconosciuta a ogni
essere umano e quindi anche al minorenne capace di
discernimento (Moro-Fadiga, 329, infra, sez. IV).
In quest’ottica, l’audizione dei cc.dd. «grandi minori» sarebbe necessaria in tutti i procedimenti volti
sostanzialmente a regolare interessi primari dei minori stessi, e dunque anche nei procedimenti di affidamento (ritiene l’esistenza nel nostro ordinamento
di un principio generale che impone l’ascolto del
minore capace di discernimento Ruscello, 943, inNGCC 2010 - Parte prima
Separazione dei coniugi
fra, sez. IV). A favore di tale tesi, si invocano l’art.
12, comma 2o, della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti dell’infanzia (aperta alla firma a
New York il 20.11.1989 e ratificata dall’Italia con l.
27.5.1991, n. 176) e gli artt. 3 e 6 della Convenzione
europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (aperta
alla firma a Strasburgo il 25.1.1996 e ratificata dall’Italia con l. 20.3.2003, n. 77). Entrambi questi strumenti internazionali, infatti, inquadrano l’ascolto
del minore nella libertà di espressione, che deve essere riconosciuta a ogni essere umano, e dunque anche al minorenne. L’art. 12 della Convenzione delle
Nazioni Unite è stato autorevolmente ritenuto autoapplicativo dalla Corte costituzionale (Corte
cost., 30.1.2002, n. 1, infra, sez. III) che, pur inascoltata dalla giurisprudenza maggioritaria, ne ha
derivato l’obbligo di ascolto del minorenne capace
di discernimento in tutti i procedimenti il cui esito
sia suscettibile di influire sulla sua vita futura (affermano invece la natura essenzialmente programmatica della norma convenzionale Moro-Fadiga, 331 e
Manera, 1551, infra, sez. IV). Con specifico riferimento all’audizione dei figli nella scissione della
coppia genitoriale, non appare invece condivisibile
il riferimento alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (pur richiamata dai giudici
di legittimità nel provvedimento in commento):
questa Convenzione, infatti, si applica solo ai procedimenti in materia familiare che siano espressamente indicati da ciascuno Stato contraente; il Governo
italiano tuttavia ne ha elencati alcuni di scarsissima
applicazione pratica, tra i quali non è compreso l’affidamento (la dichiarazione italiana è pubblicata anche in Fam. e dir., 2006, 531). A favore di una valenza universale della Convenzione di Strasburgo del
1996, si è invece espressa Cass., 27.7.2007, n. 16753
(infra, sez. III), che ha riconosciuto che le sue disposizioni «relative all’ascolto del minore per la loro valenza di principio e per il loro significato promozionale sono suscettibili di influenzare l’attività interpretativa anche nei procedimenti che si collocano al di fuori del’elenco delle categorie di controversie».
La l. 8.2.2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) ha statuito che in tutti i procedimenti di affidamento della prole minorenne in occasione della rottura della relazione di coppia (e dunque anche in
deroga a quanto stabilito dalla legge divorzio, che
deve ritenersi sul punto implicitamente abrogata) «il
giudice», prima dell’emanazione dei provvedimenti
di cui all’art. 155 cod. civ., «dispone [...] l’audizione
del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici
e anche di età inferiore ove capace di discernimento» (art. 155 sexies cod. civ.). Secondo l’opinione
maggioritaria, questa nuova norma esclude la discrezionalità del giudice, imponendogli l’audizione
313
Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 - Commento
del minore ultradodicenne, nonché quella dell’infradodicenne che non risulti incapace di discernimento
(M. Finocchiaro, 45; de Filippis, 134; Fadiga,
138 s.; Graziosi, Profili processuali della l. n. 54 del
2006, par. 3; Tommaseo, 397, tutti infra, sez. IV).
L’obbligo di audizione riguarda tutti i procedimenti
di affidamento e deve dunque essere assolto ogni
qual volta si pronuncino provvedimenti riguardo ai
figli, in via provvisoria e in via definitiva (così Tommaseo, 396), ivi compreso naturalmente il procedimento di modifica delle condizioni inizialmente disposte dal giudice (nel caso in esame si trattativa appunto delle modifiche alle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale). Secondo un’altra tesi, invece, l’ascolto anche dell’ultradodicenne potrebbe essere escluso «quando ciò non sia
necessario od opportuno» secondo il prudente apprezzamento del giudice (così M.A. Lupoi, infra,
sez. IV) o quantomeno nei casi di procedimenti consensuali o comunque qualora i genitori concordino
sull’affidamento della prole ad entrambi (così Trib.
Genova, 22.3.2007, infra, sez. III nonché il Protocollo sull’interpretazione e applicazione della l.
8.2.2006, n. 54 in tema di ascolto del minore elaborato dall’Osservatorio per la giustizia civile di Milano. In dottrina cfr. Casaburi, 39 e Balena, 418, infra, sez. IV).
In mancanza di una precisa indicazione normativa sul punto, si è aperto il dibattito sulle conseguenze della mancata audizione del minore.
Secondo la dottrina maggioritaria, che appare ancora strettamente legata alla tradizionale visione essenzialmente probatoria dell’ascolto, la mancata audizione del minore comporterebbe la nullità per violazione di legge solo nei casi in cui il giudice non abbia debitamente motivato in relazione alla contrarietà in concreto dell’ascolto all’interesse del minore o,
nel caso di minori infradodicenni, in relazione alla
mancanza in questi ultimi della capacità di discernimento (De Filippis, 134; Tommaseo, 397; Bugetti, 189; cfr. anche Casaburi, 39 e Balena, 418).
Secondo un’interpretazione minoritaria, invece,
l’omessa audizione del minore capace di discernimento determinerebbe sia la violazione dell’art. 155
sexies cod. civ., sia un «vizio per certi versi assimilabile alla violazione del contraddittorio; e non perché
il minore ascoltato possa essere considerato come
parte pretermessa, ma perché viene omesso l’unico
atto in cui il minore è chiamato a fare sentire la sua
voce» (così Trib. Genova, 23.3.2007, cit.).
Il provvedimento in esame accoglie questo secondo orientamento. Le sezioni unite, infatti, ricostruiscono l’ascolto quale espressione del diritto dei minori di manifestare la propria opinione in quanto
«parti in senso sostanziale» del procedimento e arrivano a qualificarlo quale requisito per la corretta in314
Separazione dei coniugi
staurazione del contraddittorio anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione. Logica conseguenza di questa impostazione è che la mancata audizione determini una nullità insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento per violazione del principio del contraddittorio (in questo
senso in dottrina si consenta il rinvio a Long, Il diritto italiano della famiglia, 126, infra, sez. IV).
L’analisi della pronuncia dimostra peraltro che le
sezioni unite si pongono in controtendenza rispetto
alla dottrina e alla giurisprudenza maggioritarie non
solo nella ricostruzione del vizio quale violazione del
contraddittorio, ma anche nella scelta di non distinguere tra il fratello che ha compiuto dodici anni nel
periodo tra la riserva della decisione e la pubblicazione del decreto impugnato e quello di dieci anni,
dettando così principi unitari applicabili a tutti i minori, indipendentemente dalla loro condizione di ultra o di infradodicenne. Ugualmente significativa è
la decisione di fondare la ratio decidendi su principi
di rango costituzionale e internazionale che trascendono le singole norme di origine nazionale eventualmente prescriventi l’obbligo di ascolto (il riferimento all’art. 155 sexies cod. civ. è, infatti, relegato in
posizione assolutamente marginale), senza distinzione tra i procedimenti civili in cui l’ascolto è espressamente previsto da una fonte normativa di origine
nazionale e tra quelli sui quali la legge tace.
A sostegno della propria interpretazione, le sezioni unite invocano la già citata sentenza n. 1/2002
della Corte costituzionale: il giudice delle leggi, infatti, pur limitandosi ad affermare che «compete al
rimettente stabilire, applicando le norme generali sulle nullità processuali civili, quali conseguenze esplichi
sul provvedimento reclamato l’inosservanza dell’art.
336, comma 2o, interpretato nel senso sopra precisato» (Corte cost., 30.1.2002, n. 1, cit.), afferma che
l’ascolto della «parte» minorenne è funzionale alla
realizzazione del contraddittorio nei suoi confronti.
A favore della nullità rilevabile d’ufficio si era peraltro espressa nell’ordinanza di rimessione la Corte
d’appello di Torino, che, dubitando della conformità agli artt. 2, 3, comma 2o, 24, comma 2o, 30, comma 1o, e 111, commi 1o e 2o, Cost. dell’art. 336,
comma 2o, cod. civ. «nella parte in cui non prevede a
pena di nullità rilevabile d’ufficio che i genitori e il
minore che abbia compiuto i dodici anni siano sentiti», così argomentava: «se infatti si afferma che il
principio del contraddittorio di cui all’art. 111 della
Costituzione vale anche per i procedimenti camerali o
limitativi della potestà, il solo modo di assicurarne
l’attuazione è la previsione della nullità del provvedimento nell’ipotesi di inadempimento» (App. Torino, 18.12.2000, par. 7. A favore della nullità anche
App. Torino, 3.4.1991; App. Roma, 27.6.2005 e
Trib. Genova, ord. 23.3.2007, tutte infra, sez. III).
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 - Commento
Contro la configurabilità di una nullità per violazione del principio del contraddittorio milita evidentemente l’impossibilità di riconoscere al minore la
qualità di «parte» in senso formale (nel diritto previgente Graziosi, Note sul diritto del minore ad essere
ascoltato nel processo, 1290, escludeva «che la mancata audizione del figlio minorenne determini la nullità della pronuncia per violazione del principio del
contraddittorio», citando la consolidata giurisprudenza che esclude la configurabilità dei minori quali
parti necessarie del processo).
Nell’ottica proposta dalle sezioni unite nel provvedimento in commento, gli unici limiti all’ascolto
sarebbero la contrarietà in concreto dell’audizione
all’interesse del minore ovvero un’età del minore tale da configurare una presunzione assoluta di incapacità dello stesso.
Per quanto concerne il primo aspetto, appare interessante rilevare che il riferimento nella sentenza
in esame alla possibilità per il giudice di merito di
escludere l’ascolto (dell’infradodicenne ma – sembrerebbe di capire – anche dell’ultradodicenne) dimostrando la sua potenziale dannosità per il minore
(riferimento confluito nella massima ufficiale e dunque a parere di chi scrive foriero di equivoci sulla
portata sostanzialmente innovativa della pronuncia
in esame) ha (e deve avere) natura di extrema ratio:
nella grande maggioranza dei casi, infatti, un ascolto
che sia nei tempi e nei modi adeguato alle esigenze
del minore appare idoneo ad escludere il rischio di
pregiudizio per il minore.
Il secondo limite deriva, pur nel silenzio delle sezioni unite sul punto, dal criterio di ragionevolezza,
in forza del quale pare opportuno limitare l’operatività dei principi individuati ai minori che siano almeno in età scolare, escludendo cioè quei bambini che,
a causa della loro età, siano ex se incapaci di intendere il senso della comunicazione con il giudice (così P.
Pazé, infra, sez. IV). Sulla base di studi psicologici e
psicoanalitici sul tema, infatti, si ritiene che nell’epoca attuale il minore sia in grado di comunicare con il
giudice (si ricordi che l’obiettivo dell’ascolto è la comunicazione in sé e non l’attendibilità delle informazioni date dal minore!) già a partire dai sei-sette anni: un’età dunque ben più ridotta del limite dei dodici anni posto in molti casi dalla legge italiana come
spartiacque. La giurisprudenza relativa al controllo
giudiziario sull’esercizio della potestà genitoriale e,
in particolare, ai trattamenti sanitari sul minore ha riconosciuto nei fatti un ruolo centrale all’opinione
dei minori anche prima dei dodici anni.
2. La giurisdizione. La seconda questione di
diritto affrontata dalle sezioni unite nel provvedimento in esame è quella dell’individuazione della
giurisdizione per la modifica delle condizioni della
NGCC 2010 - Parte prima
Separazione dei coniugi
separazione consensuale che stabiliva l’affidamento
esclusivo dei minori alla madre. Tale modifica era
stata richiesta disgiuntamente da entrambi i genitori
al giudice italiano e dalla madre anche al giudice finlandese, a pochi giorni dal trasferimento in Finlandia della donna con i figli. Il giudice finlandese dichiara la litispendenza internazionale in applicazione della regola fissata dall’art. 19 del reg. CE n.
2201/2003, in forza della quale il giudice successivamente adito deve sospendere d’ufficio il procedimento innanzi a sé finché non sia stata accertata la
competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
Le sezioni unite confermano la correttezza delle
argomentazioni dei giudici di merito, affermando
l’esistenza della giurisdizione italiana in applicazione dell’art. 10 del reg. CE n. 2201/2003. Tale norma
concerne i cc.dd. «trasferimenti illeciti» di minorenni (più noti come sottrazioni internazionali) e prevede che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro
nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento conservi la
competenza fino a che il minore non abbia acquisito
la residenza in un altro Stato membro e comunque
per un anno dalla conoscenza del trasferimento da
parte dell’altro genitore che avrebbe il diritto di
chiedere il ripristino del diritto di visita o di rientro
(fatti da escludersi nel caso di specie visto il brevissimo lasso di tempo intercorso tra il trasferimento e
la domanda paterna di modifica delle condizioni
della separazione). La natura illecita del trasferimento operato dalla madre nel caso di specie deriva inequivocabilmente dal fatto che esso sia stato effettuato in violazione di una specifica clausola di divieto
di trasferimento all’estero inserita nell’accordo di separazione consensuale. Il reg. CE n. 2201/2003, infatti, ritiene «illecito» il trasferimento effettuato «in
violazione dei diritti di affidamento derivanti da una
decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il
minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro», precisando che «l’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o
al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza
del minore senza il consenso dell’altro titolare della
responsabilità genitoriale» [art. 2, n. 11, lett. b].
Proprio l’autonomia rispetto al diritto interno della
nozione di «diritto di affidamento» (custody) e di
«genitore affidatario» di cui al reg. CE n. 2201/2003
consente di ritenere che – ai fini del regolamento –
l’affidamento disposto nel provvedimento di separazione consensuale dovesse ritenersi esercitato congiuntamente da entrambi i genitori e che quindi il
315
Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 - Commento
trasferimento materno integrasse un trasferimento
illecito.
III. I precedenti
1. L’ascolto del minore. Secondo l’opinione
tradizionale, l’ascolto del minore avrebbe finalità essenzialmente istruttorie e come tale sarebbe rimesso
in gran parte alla discrezionalità del giudice, che potrebbe sempre escluderlo, essendo tenuto a motivare tale scelta solo se il relativo adempimento fosse
stato a lui richiesto dalla legge o dalle parti o comunque qualora il mancato ascolto fosse stato eccepito (cfr. con riguardo al procedimento di opposizione al secondo riconoscimento del figlio naturale,
per il quale l’art. 250, comma 4o, prevede l’ascolto
del minore senza requisiti minimi di età, da ultimo
Cass., 11.1.2006, n. 395, in Foro it., 2006, I, 2356;
per l’audizione di minori infradodicenni in materia
di stato di adottabilità Cass., 9.6.2005, n. 12168 e
Cass., 27.11.1999, n. 13262, in dejure.giuffre.it; con
riferimento all’ascolto del minore infradodicenne
nella procedura per l’adozione in casi particolari,
Cass., 26.11.2004, n. 22350, ibidem). Logico corollario di tale impostazione è che il mancato ascolto
non sia causa di nullità rilevabile d’ufficio, ma possa
al più comportare un difetto di motivazione che in
quanto tale deve essere eccepito dalla parte (cfr. con
riguardo al procedimento di opposizione al secondo
riconoscimento del figlio naturale, Cass., 10.5.2001,
n. 6470, in questa Rivista, 2002, I, 294, con nota di
Lena e in Fam. e dir., 2001, 562; Cass., 24.5.2000,
n. 6784, ivi, 2000, 508; Cass., 29.12.1994, n. 11263,
in Giur. it., 1995, I, 1, 1472; con riguardo al riascolto in appello di minori già sentiti durante il procedimento di primo grado per la dichiarazione dello stato di adottabilità v. Cass., 21.3.2003, n. 4124, in Foro it., 2003, I, 3063). I casi in cui tale difetto è stato
in concreto ritenuto sussistente sono rarissimi: i giudici di legittimità hanno, per esempio, cassato una
sentenza di conferma dello stato di adottabilità di
un infradodicenne perché sorretta da motivazione
meramente apparente, in considerazione del fatto
che il giudice di merito, tra l’altro, non aveva proceduto all’ascolto della minore che si opponeva nettamente ad abbandonare la famiglia di origine (Cass.,
23.7.1997, n. 6899, in Fam. e dir., 1997, 523).
Alcune isolate pronunce hanno invece ritenuto
affetti da nullità insanabile e rilevabile d’ufficio i
provvedimenti emessi senza il preventivo ascolto di
minori la cui audizione fosse invece espressamente
prevista per legge. In una pronuncia ormai risalente,
la Corte d’appello di Torino ha dichiarato nullo il
provvedimento del Tribunale per i minorenni di
proroga dell’affidamento familiare di tre fratellini
senza preventiva audizione del fratello ultradodi316
Separazione dei coniugi
cenne (App. Torino, 3.4.1991, in Dir. fam. e pers.,
1991, 577). Assai più recentemente, la Corte di appello di Roma (App. Roma, 27.6.2005, ivi, 2006,
1084) ha ritenuto nullo il provvedimento di primo
grado che disponeva l’affidamento extrafamiliare di
un gruppo di fratellini senza sentire direttamente
due fratelli di dodici e sedici anni. Con specifico riferimento alla materia de qua, si segnala un’isolata
pronuncia del Tribunale di Genova che ha dichiarato la nullità dell’ordinanza attinente all’affidamento
pronunciata dal giudice istruttore senza la previa audizione dei figli minori: i minori erano invece stati
sentiti, motu proprio e non su specifica delega del
giudice, dal consulente tecnico d’ufficio (Trib. Genova, 22.3.2007, in Foro it., 2007, I, 1601).
Questo orientamento minoritario appare, da un
punto di vista teorico, perfettamente in linea con la
notissima pronuncia della Corte costituzionale, che
ha riconosciuto la natura di diritto soggettivo dell’ascolto del minore, affermando che il minore deve
essere considerato «parte» dei procedimenti limitativi e ablativi della potestà genitoriale, «con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti», e quindi
innanzitutto che sia ascoltato dal giudice (Corte
cost., 30.1.2002, n. 1, in Fam. e dir., 2002, 229. Una
delle ordinanze di rimessione è App. Torino,
3.1.2001, ivi, 315).
La giurisprudenza sull’ascolto successiva alla riforma del 2006 è scarsa. Una timida apertura si è
avuta in un caso di sottrazione internazionale di minorenni, in cui i giudici di legittimità hanno affermato che l’ascolto del minore capace di discernimento
costituisce atto istruttorio necessario che può essere
escluso solo qualora manifestamente in contrasto
con l’interesse del minore stesso (Cass., 27.7.2007,
n. 16753, in questa Rivista, 2008, I, 381, con nota di
P. Pazé). Con specifico riferimento all’ascolto del
minore in sede di scissione della coppia genitoriale
cfr. Trib. Genova, 22.3.2007, cit.
La pronuncia in commento è pubblicata in massima anche in Guida al dir., 2009, n. 48, 44, con nota
di M. Finocchiaro.
2. La giurisdizione. Nella prassi sono sempre
più frequenti i divieti convenzionali di espatrio stabiliti in occasione della rottura della relazione di
coppia tra i genitori. Il S.C. ha, per esempio, ritenuto valida la clausola di un accordo di separazione
consensuale con cui i coniugi avevano stabilito che,
nel caso in cui la madre affidataria avesse deciso di
trasferirsi all’estero con il bambino, il padre si riservava di dare il proprio assenso in considerazione del
perseguimento dell’effettivo bene di quest’ultimo
affermando espressamente che essa costituiva «una
libera regolamentazione dei rapporti tra il bambino
ed ognuno dei genitori e, come già rilevato, realizza
NGCC 2010 - Parte prima
Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 - Commento
un coinvolgimento del padre non affidatario in una
decisione di particolare interesse per il figlio» (v.
Cass., 30.12.2004, n. 24265, in Foro it., 2005, I,
2425). Un’isolata pronuncia di merito ha invece affermato la nullità di un divieto convenzionale di
espatrio dei figli minori fino alla maggiore età, ritenendo tale divieto in contrasto con il diritto di espatrio riconosciuto a tutti i cittadini italiani dall’art.
16, comma 2o, Cost. (App. Caltanissetta, decr.
12.4.2005, in Giur. merito, 2005, 1509, con nota di
Campione e in Fam. e dir., 2006, 190, con nota di
De Feis).
Le sezioni unite si erano già espresse in senso conforme alla pronuncia in esame, sia pure quale obiter
dictum. In un’autorevole pronuncia, infatti, esse avevano ritenuto la competenza del giudice italiano adito dal padre ben prima del decorso del termine annuale proprio in applicazione dell’art. 10 del regolamento n. 2201/2003, affermando che in un caso «di
trasferimento illecito (...), l’autorità giurisdizionale
dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza
giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e (...) se il
minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno» (Cass., sez. un., 20.12.2006, n.
27188, in questa Rivista, 2007, I, 971, con nota di
Long).
Separazione dei coniugi
IV. La dottrina
persona e ascolto del minore, in Familia, 2002, 933;
Sergio, L’ascolto del minore e la giustizia, in Fam. e
dir., 1999, 590.
Con specifico riferimento all’ascolto nella scissione della coppia genitoriale dopo la riforma del 2006,
si segnalano Balena, Il processo di separazione dei
coniugi, in Le riforme più recenti del processo civile, a
cura di Balena e Bove, Cacucci, 2006, 418; Bugetti, in Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, nel Commentario a cura di M. Mantovani, in Nuove leggi civ.
comm., 2008, sub art. 155 sexies cod. civ.; Casaburi,
I nuovi istituti di diritto di famiglia (norme processuali ed affidamento condiviso): prime istruzioni per
l’uso, in Giur. merito. Speciale riforma del diritto di
famiglia, 2006, 9; Ceccarelli, L’ascolto del minore
nei procedimenti di separazione e divorzio, 2006, in
www.minoriefamiglia.it; Cesaro, L’ascolto del minore nella separazione dei genitori: le riflessioni della
difesa, in Minori giust., 2006, n. 3, 155; de Filippis,
Affidamento condiviso dei figli nella separazione e
nel divorzio, Cedam, 2006, 134; Fadiga, Problemi
vecchi e nuovi in tema di ascolto del minore, in Minori giust., 2006, n. 3, 132; M. Finocchiaro, Un
adempimento ritenuto inderogabile da assolvere con
le modalità convenienti, in Guida al dir., 2009, n. 48,
44; M.A. Lupoi, Aspetti processuali della normativa
sull’affidamento condiviso, in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 2006, 1063; Tommaseo, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: b) profili processuali, in
Fam. e dir., 2006, 388.
1. L’ascolto del minore. La letteratura sull’ascolto è vasta. Tra i tanti si segnalano: Dell’Antonio, Ascoltare il minore. L’audizione dei minori
nei procedimenti civili, Giuffrè, 1990; A. Finocchiaro, L’audizione del minore e la convenzione sui
diritti del fanciullo, in Vita not., 1991, 834; Graziosi, Note sul diritto del minore ad essere ascoltato nel
processo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, 1281;
Id., Profili processuali della l. n. 54 del 2006 sul c.d.
affidamento condiviso, in Dir. fam. e pers., 2006, II,
1856 ss.; Liuzzi, L’ascolto del minore tra convenzioni internazionali e normativa interna, in Fam. e dir.,
2001, 675; Long, Il diritto italiano della famiglia alla
prova delle fonti internazionali, Giuffrè, 2006, spec.,
113 ss.; Martinelli, Il diritto del minore all’ascolto
come diritto fondamentale eventuale, in Minori
giust., 2003, n. 4, 16; Manera, L’ascolto dei minori
nelle istituzioni, in Dir. fam. e pers., 1997, 1551; Moro-Fadiga, Manuale di diritto minorile, Zanichelli,
2008, 329 e 466; P. Pazé, L’ascolto del bambino nel
procedimento civile minorile, in Dir. fam. e pers.,
2006, 1334; Ruscello, Garanzie fondamentali della
2. La giurisdizione. Per un’introduzione al reg.
CE n. 2201/2003 si rinvia a Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull’efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori. Commento a Reg. CE 2201/
2003, in Riv. dir. int., 2004, 991; Conti, Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di
potestà parentale, in Fam. e dir., 2004, 291; Magrone, La disciplina del diritto di visita nel regolamento
(CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. int. priv. e proc.,
2005, 339; Rimini, La responsabilità genitoriale nel
Reg. CE n. 2201/2003, in Fam., pers. e succ., 2008,
542.
Sulla nozione di trasferimento illecito, con specifico riferimento alla violazione dei divieti convenzionali di espatrio, si consenta il rinvio a Long, Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri de
potestate alla luce del regolamento (CE) n. 2201/
2003 (con cenni al tema della validità dei divieti di
espatrio e degli obblighi di soggiorno), in questa Rivista, 2007, I, 974.
Joëlle Long
NGCC 2010 - Parte prima
317
Discussioni
A PROPOSITO DI
CASS., SEZ. UN., 18.9.2009, N. 20106
Discussioni
CONTRO L’ABUSO DEL DIRITTO
(in margine a Cass., 18.9.2009, n. 20106) (*)
di Mauro Orlandi
Sommario: 1. Usare un diritto. – 2. Titolarità ed
esercizio del diritto. – 3. Concetto di fonte. – 4.
Segue: validità della fonte. Efficienza ed efficacia.
– 5. Ambiguità del concetto di abuso. Teoria
dell’irrilevanza e teoria della doppia qualifica. –
6. Segue: combinazione e contraddizione di effetti. – 7. Carattere estrinseco dell’abuso. – 8.
Negazione dommatica dell’abuso.
1. Usare un diritto. Qui iure suo utitur
neminem laedit. Leggiamo ancor’oggi nei manuali istituzionali la massima, che con solenne
nitore fissa nelle menti un principio tanto semplice quanto intuitivo. A un torno di tempo,
sùbito conseguita la laurea e progrediti negli
studi, ci ravvediamo come tempi e mondi declinino; e altri tempi e altri mondi ne traggano
il luogo, sovvertendo costumi e principi del
passato. Anche questa massima, semplice e
netta, ci si svela allora come un relitto storiografico.
Innanzitutto, verrebbe da riflettere, nel predicato utitur essa stessa introduce il germe della propria dissoluzione: quasi che il diritto si
«usi», alla stregua di un oggetto, e si faccia così
pensabile una valutazione ex post di tale uso; e
si rendano concettualmente separabili usi corretti e usi scorretti.
Il titolare usa il diritto come un utensile; egli
cerca il proprio vantaggio, profittando della
protezione armata dello Stato (o dell’ordinamento, se si vuole). Così intuita (più che ricostruita) la logica del fenomeno, emerge con naturale semplicità il problema dello scopo, ossia
del fine che l’uso lasci ricavare ab externo. E
dunque potremmo separare scopi meritevoli e
(*) La sentenza è pubblicata supra, Parte Prima,
239.
NGCC 2010 - Parte seconda
scopi immeritevoli, secondo che lo scopo al
quale l’uso tende debba includersi od escludersi dal catalogo delle finalità secundum legem.
Qui emergono le prime perplessità. Innanzitutto il problema della rilevanza diremo esterna degli scopi, ossia dei criteri attraverso i quali
essi trascorrano dalle solitarie pieghe dell’anima alla luce del diritto. Problema di poca o
nulla importanza, ci si sente opporre: dacché,
ovviamente (ma l’avverbio cela l’insidia), non
si tratterà qui di motivi individuali ma di scopi
obiettivi. «Oggettivo», e i suoi derivati, è la parola magica, il passepartout logico che spazza
via ogni indugio intellettuale.
Scopo oggettivo dunque; che l’interprete – e
cioè il giudice – ricaverà dalle circostanze. Esso
colora l’uso del diritto, rendendone logicamente ammissibile la valutazione secondo le categorie della meritevolezza.
Fin qui la schermaglia è ancora in superficie;
e il problema si lascia superare con qualche
umbratile resistenza. Ma l’entrata in scena dello scopo apre l’adito a ulteriori interrogativi e
spazi di ricerca, i quali mettono a nudo le aporie del discorso e finiscono per svelarne la circolarità.
Lo scopo postula infatti il – non nuovo e non
banale – dualismo titolarità-esercizio. Non si
tratta qui di sindacare la titolarità del diritto, la
quale costituisce la stessa premessa della valutazione teleologica; bensì l’esercizio del diritto,
ossia il modo in cui esso è diremo pure fruito
dal titolare. Un abuso del diritto, inteso quale
deviazione dallo scopo ammesso, è pensabile
soltanto muovendo dalla titolarità di esso (ed
anzi dalla titolarità di un strictum ius, come bene avverte Aurelio Gentili) ( 1 ); l’agente è bensì
( 1 ) Gentili, Abuso del diritto, giurisprudenza tri129
Discussioni
titolare del diritto, del quale tuttavia egli abusa
esercitandolo secondo scopi difformi da quelli
meritevoli.
Cosa significa dunque essere titolari del diritto? In questo scorcio d’anni sempre più numerosi appaiono nelle pagine di libri e riviste
gli appelli alla razionalità del giurista; che, nel
naufragio dei tempi – per dirla con un grande
contemporaneo ( 2 ) –, riconduca all’unità del
pensiero le disperse e caduche leggi, le quali
più che la necessità di conferire ordine alle cose parrebbero nichilisticamente inseguire il bisogno di visibilità politica. È un appello alla razionalità dei concetti, che potremmo forse convertire e risolvere non senza suggestioni intellettuali in appello neodogmatico. Al di là delle
formule, il fenomeno dell’abuso mette capo
per definizione a categorie generali.
Muoviamo dunque alla ricostruzione analitica della titolarità.
2. Titolarità ed esercizio del diritto.
L’insidia è sempre la stessa: di scambiare diritti
con cose.
Soltanto un ingenuo naturalismo ci conduce
butaria e categorie civilistiche, in Ianus, 1, 2009, 2, 10;
ed in Riv. dir. comm., 2009, 403 ss. I moderni studi sul
fenomeno dell’abuso sono ampiamente tributari dalle pagine di Rescigno, L’abuso del diritto, in Riv. dir.
civ., 1965, I, 205 ss., il quale colloca il problema nella
più ampia riflessione intorno ai corpi intermedi tra
Stato e persona. Per una ricostruzione del clima metodologico e gius-politico di questa corrente culturale v.
Tarello, Orientamenti della magistratura e della dottrina sulla funzione politica del giurista-interprete
(1972), in Metodologia nello studio della giurisprudenza civile e commerciale. Antologia di saggi, a cura di Visintini, Giuffrè, 1999, 17 ss. (spec. 38-40). Per alcuni cenni sulla stagione della «costituzionalizzazione»
della cultura giuridica italiana, v. Pino, Il diritto all’identità personale. Interpretazione costituzionale e
creatività giurisprudenziale, Il Mulino, 2003, cap. I.
Ancora nel 1997 appare un volume monografico della Rivista di diritto privato dedicato all’abuso del diritto; del 1998 è la ripubblicazione in volume, con una
postfazione, del saggio di Rescigno, L’abuso del diritto, Il Mulino, 1998, 11 ss. Imprescindibile per la teorica e gli svolgimenti del movimento di costituzionalizzazione dei principi Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Esi, 2008, passim.
( 2 ) Irti, Il salvagente della forma, Laterza, 2007, 6.
130
all’erroneo (non mi par di esagerare dicendo
grossolano) scambio tra titolarità di un diritto
e possesso di una cosa. Evocando con forza subliminale false prospettive naturalistiche, la
metafora offusca la ricostruzione giuridica e distoglie lo sguardo dalla sostanza dommatica
del fenomeno. La quale sta in ciò: che il diritto
(come l’obbligo, e così pure ogn’altra situazione) non esiste (in natura); e che esso si converte e risolve in uno statuto giuridico ( 3 ) dei comportamenti, propri o altrui ( 4 ).
«Avere» un diritto è non già usare una cosa,
bensì prestabilire gli effetti giuridici di una data condotta. E così il diritto di recesso rende rilevante ed efficace la condotta del recedere, ossia del dichiarare il recesso. Esercitare è tenere
la condotta conforme al diritto. Su questa linea, titolarità ed esercizio sono concetti complementari: l’esercizio postula la titolarità.
Dov’è allora lo spazio (logico prima che giuridico) dell’abuso?
Ancora un dualismo analitico: o la condotta
è conforme al diritto (ossia alla sfera di applicazione dello statuto giuridico, che chiamiamo
«diritto») ed allora si produrranno gli effetti
prestabiliti; o la condotta è difforme, ed allora
gli effetti non si produrranno. Qui sta il punto:
gli effetti non si producono perché l’agente
non ha esercitato il diritto; ossia – per passare
alla grossolanità della metafora – perché egli
( 3 ) La formula «statuto giuridico», in cui viene risolto il rapporto, è coniata da Irti, La teoria delle vicende del rapporto giuridico (per la ristampa di un libro di Mario Allara), in prefazione alla ristampa,
Giuffrè, 1996; e in Riv. dir. civ., 1999, 420 s. Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico,
Giuffrè, 1941, 36, distingue nella fattispecie elementi necessarî per la produzione degli effetti e per la
determinazione del contenuto, isolando la volontà
come mediazione necessaria con il reale. Cammarata, Il significato e la funzione del fatto nell’esperienza
giuridica, Tolentino, 1929; ora in Formalismo e sapere giuridico, Studi, Giuffrè, 1963, 291 ss., avverte la
necessità razionale del momento del fatto.
( 4 ) La nozione di statuto giuridico riconduce il
fenomeno della concreta disciplina delle situazioni
nel campo della gnoseologia delle relazioni intersoggettive. Qui, debito e credito ci appaiono come significati di testi (scritti o detti), racchiusi nelle proprie fonti, e ricostruibili attraverso i consueti mezzi
ermeneutici. Infra, ntt. succ.
NGCC 2010 - Parte seconda
Abuso del diritto
non ha il diritto di tenere quella condotta. La
condotta non ricade sotto la sfera del diritto;
fenomeno che, sul piano concettuale, deve
convertirsi e risolversi in assenza del diritto.
Tertium non datur ( 5 ).
Si può ben dire sul piano descrittivo che
l’esercizio del diritto è difforme dallo scopo, e
che l’abuso «delinea l’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore» ( 6 ).
Tale utilizzazione alterata si converte e risolve all’esito dell’analisi in estraneità alla sfera di applicazione del diritto. Il risultato cui si
mette capo è sul piano logico identico al difetto del diritto: che il comportamento del titolare è non iure, e cioè non rileva quale esercizio
di un diritto ( 7 ). L’abuso del diritto, – ma meglio vedremo nelle prossime pagine – finisce
sotto questa luce per descrivere un difetto del
diritto, e più precisamente l’irrilevanza della
condotta (abusiva) quale esercizio di un diritto.
3. Concetto di fonte. Qui giova introdurre un ulteriore concetto, che spiega e precisa il fenomeno e che tornerà utile nella analisi
ricostruttiva di alcune figure di c.d. abuso.
Fonte. Parola che, con plastica evidenza,
( 5 ) Lo stesso dubbio radicale colgo in Gentili,
A proposito de «Il diritto soggettivo», in Riv. dir. civ.,
II, 2004, 351 ss. il quale segnala la debolezza del modus linguistico «aver diritto a». Egli suggerisce l’inversione logica: non già «si può perché si ha un diritto»; bensì «si ha il diritto, ossia si può». Da leggere le sempre acute riflessioni di Nivarra, Un dibattito palermitano su illeciti atipici, in Eur. e dir. priv.,
2006, 1032, il quale concepisce il diritto come spazio di libertà, nel quale il titolare agirà indisturbato
«sino a quando non incontrerà un altro spazio giuridicamente pieno».
( 6 ) Cass., 18.9.2009, n. 20106, cit., 7.
( 7 ) Leggiamo nella sentenza, loc. cit.: «esercizio
concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione
giuridico od extragiuridico». Parole che la Corte trae
da Pino, L’abuso del diritto tra teoria e dogmatica
(precauzioni per l’uso), in Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica, a cura di Maniaci, Giuffrè,
2006, 115 ss., spec. 125.
NGCC 2010 - Parte seconda
evoca la dinamica della disciplina concreta del
rapporto, e cioè lo scaturire ed il fissarsi dei diritti e degli obblighi nella realtà storica ( 8 ) (in
senso lato: modalità; tempi; persone; luoghi). Il
rapporto non può logicamente prescindere
dalla singolarità ed irripetibilità delle persone e
delle cose reali ( 9 ); ogni disciplina giuridica
sempre attende un riferimento storico ( 10 ) che
ne renda possibile l’applicazione ( 11 ).
( 8 ) Avvertendo che «... il contratto determina il
contenuto dei poteri e degli obblighi assunti dalle
parti, ma il titolo, o, se si preferisce un’altra espressione, la fonte di tali poteri ed obblighi è sempre
nella norma che rende giuridicamente valido il contratto»: Cammarata, Il significato e la funzione del
fatto nell’esperienza giuridica, ora in Formalismo e
sapere giuridico, cit., 279. Cfr. anche Falzea, Efficacia giuridica, in Voci di teoria generale del diritto,
Giuffrè, 1970, spec. 291 ss.
( 9 ) V. Irti, La teoria delle vicende del rapporto,
cit., 421: «non più astratto dovere ed astratto diritto,
ma, ad esempio, l’obbligo di consegnare questa cosa
e il potere di pretendere la consegna di questa cosa»;
oltre: «il rapporto giuridico non è altro dalla soggettivante trascrizione di un contenuto di disciplina. Il
rapporto non può costituirsi modificarsi estinguersi
fuori dalla disciplina (legislativa o negoziale) che lo
prevede e istituisce» (corsivi nel testo). Il fenomeno
è assai diffuso: si pensi al tempo dell’adempimento
(«se non è determinato il tempo della prestazione...»: art. 1183 cod. civ. – «quod sine die...»); al luogo («se il luogo nel quale la prestazione deve essere
eseguita non è determinato...»: art. 1182 cod. civ.).
( 10 ) Di «procedimento indiretto», secondo cui la
norma determina «... gli effetti giuridici, che essa
collega ad un dato fatto, mediante... un riferimento
al fatto stesso» scrive Morelli, Nozioni di diritto internazionale, Cedam, 1958, 270.
( 11 ) Si aprirebbe, a questo punto, il dilemma circa la latitudine del termine «effetto», se cioè esso si
restringa a vicenda del rapporto (Allara, Vicende
del rapporto giuridico; fattispecie, fatti giuridici,
Giappichelli, 1941, 125; sul quale v. ora i rilievi di
Irti, op. loc. cit.), ovvero debba espandersi ad ogni
qualifica, applicata a termini della realtà (cose o persone: Betti, Diritto romano, I, Parte generale, Cedam, 1935, 73). La risposta sembra derivare dalla
stessa logica interna del discorso. Risolto l’effetto in
una categoria del giudizio, appunto in una qualifica,
la limitazione alle qualifiche proprie del rapporto
(obbligo e diritto) appare estrinseca ed infondata,
mancando per definizione un criterio discriminante,
che permetta di ridurre alla sola sfera del rapporto
131
Discussioni
Sembra emergere la debolezza delle metafore dell’appartenenza e della causalità, secondo
cui il diritto o l’obbligo «ha» una fonte, o «discende» da una fonte ( 12 ); mentre si direbbe, a
rigore, come l’obbligo – e così il diritto, ed
ogni altra situazione che reputi rilevante – sia
la propria fonte, ed interamente si risolva nella
propria disciplina, nelle concrete e singolari
modalità del contegno descritte dalla fonte ( 13 ).
Soltanto un inconsapevole realismo, entificando
i concetti di fonte e di rapporto, può separarli
l’uno dall’altro, ed evocare la metafora di un nesso di materiale produzione; una volta «prodotto», il rapporto vivrebbe un’autonoma esistenza,
così come l’acqua abbandona la sorgente seguendo il proprio corso. Il nesso tra fonte e rapporto appare, non come derivazione o causalità,
bensì come continenza: risolto il rapporto in un
insieme di qualifiche ( 14 ), la fonte si pone come il
codesta qualificazione normativa. In altre parole,
che una qualifica si risolva in «effetto» soltanto ove
determini modifichi od estingua un rapporto giuridico (e così determini un obbligo, o lo estingua, o ne
immuti il contenuto) potrà costituire un postulato
dell’interprete, ma non un dato della realtà normativa; la quale, accanto a quelle di obbligo e diritto, conosce pure qualifiche diverse, «qualità di persone e
di cose» previste ed assegnate dalla legge.
( 12 ) Metafora della causalità, cui pure si ricorre
per descrivere il nesso tra fattispecie ed effetto. Una
serrata critica leggiamo in Cammarata, Il significato
e la funzione del fatto nell’esperienza giuridica, cit.
267: «è assurdo parlare di connessione causale tra
un fatto e una serie di fatti e qualcosa che, nella relazione in esame, ben lungi dall’atteggiarsi come fatto, si pone in un ordine di valutazioni, o qualificazioni che si dica, dell’attività umana. La causalità è
ammissibile tra due fatti, cioè tra due elementi appartenenti ad un medesimo ordine di fenomeni, non
tra due entità che risultano prima facie irriducibili ad
un unico genus proximus»; v. pure De Giovanni,
Fatto e valutazione nella teoria del negozio giuridico,
Jovene, 1958, 137 ss.; Cataudella, voce «Fattispecie», in Enc. del dir., XVI, Giuffrè, 1967, 926 ss.
( 13 ) Bianca, Diritto civile, 4, L’obbligazione,
Giuffrè, 1991, 13, scrive d’integrazione necessaria
tra disciplina dell’obbligazione e della fonte.
( 14 ) Perassi, Introduzione alle scienze giuridiche,
Cedam, 1990 (rist.), 41, reputa che «ogni qualifica
giuridica si concreta in certi effetti giuridici». Irti
torna ora sul tema con La teoria delle vicende del
rapporto giuridico (per la ristampa di un libro di Ma132
testo che contiene e descrive una concreta disciplina, soggetti storicamente determinati, modalità, tempi, luoghi; se qualificare significa «predicare» ( 15 ), la fonte è – appunto – il predicante, attraverso cui le qualifiche sono applicate a termini concreti ed attuali ( 16 ).
Il rapporto fuori della propria fonte è logicamente impensabile, perché esso si risolve nella
descrizione degli effetti ( 17 ), formulata dalle
rio Allara), cit., ove si legge (ivi, 420): «non meno
minacciante e sterile, l’insidia (sempre denunciata
dal Betti) di distacco e separazione. Il rapporto,
eretto a “cosa” e risultato di una produzione, è
strappato dalla sua fonte, dalla fattispecie generatrice e dalle norme che lo prevedono e disciplinano».
Oltre, con limpida coerenza: «Le vicende del rapporto si risolvono in vicende di statuti giuridici, che
toccano i contegni di soggetti e su oggetti, individuati dalle fonti generatrici. ... La concreta conformazione del rapporto non si lascia ridurre al mero
legame di dovere e diritto; essa involge tutta intera
la disciplina, che non è del rapporto ma è il rapporto» (corsivi nel t.).
( 15 ) Carnelutti, Diritto e processo, Morano,
1958, 15 («il fatto è soggetto e la fattispecie è predicato»). Cordero, voce «Giudizio», nel Noviss. Digesto it., VII, Utet, 1975, 882, segnala la necessaria
«premessa di una successiva valutazione, destinata a
svolgersi non più in ipotesi ma sul terreno di un dato reale, storicamente apprezzabile». Irti, voce «Rilevanza giuridica», nel Noviss. Digesto it., XX, Utet,
1968, 1105 ss., ora in Norme e fatti, Giuffrè, 1984,
23, segnala la «rilevanza dei dati, che vengono pensati secondo i criteri normativi».
( 16 ) Per una veduta storicizzante del fenomeno
obbligatorio ed un attento richiamo alla disciplina
concreta della fonte v. Perlingieri, Dei modi di
estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, Zanichelli-Foro it., 1975, 42 s.; Id., Recenti prospettive nel diritto delle obbligazioni, in Vita not.,
1976, 1027 ss.; Id., Le obbligazioni: tra vecchi e nuovi dogmi, in Rass. dir. civ., 1989, 83 ss.
( 17 ) Il termine programma, come previsione e definizione del contenuto (non già di «un», ma) di
«quel» rapporto, accomuna dottrine italiana e germanica. Di sicuro rilievo pare Pugliatti-Falzea, I
fatti giuridici, revisione e aggiornamento di Falzea,
nell’edizione curata da Irti per Giuffrè, 1996 (v. in
prefazione, Irti, La scuola di Messina in un libro sui
fatti giuridici, XIV-XV, che sottolinea come il concetto di «programma» segni una estrema depsicologizzazione dell’atto); come pure i più vicini contributi di Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obNGCC 2010 - Parte seconda
Abuso del diritto
parti o dalla legge. L’essere creditore o debitore non è stralciabile dalla relativa disciplina, attraverso la quale è dato di conoscere i requisiti
e le modalità dei contegni, e di valutarne la
conformità o difformità; non si è creditori, o
debitori, se non di questa prestazione, secondo
certi termini e determinate modalità.
Diritto e obbligo si riducono e risolvono a
modelli di condotta, descritti dalla o dalle fonti
applicabili. Esercitare un diritto o adempiere
un obbligo si spiega nel circuito della conformità al modello: il titolare ha tenuto il comportamento previsto come diritto o come obbligo.
E tale conformità genera effetti giuridici, i quali non altro configurano che ulteriori qualifiche
di diritto o di obbligo. In una dinamica senza
limiti intrinseci.
Il realizzarsi del modello «rompe la neutralità della storia futura», poiché il diritto «attende che, in un istante o periodo di tempo avvenire, il soggetto indicato dal fatto adegui il proprio contegno ad una descrizione normativa»
( 18 ). Non altro l’obbligo esprime che questa valutazione dei comportamenti; esso prevede o
prescrive condotte e così consente di valutare
(in questo senso, esso si costituisce a canone
valutativo) ( 19 ) conformità o difformità del futuro contegno rispetto a quello dovuto, o a
bligazioni, cit., 29 ss.; Id., Il diritto civile nella legalità costituzionale, Esi, 1991, 437 ss.; Di Majo, Obbligazioni in generale, Zanichelli-Foro it., 1985, 87; anche Cannata, Le obbligazioni in generale, nel
Trattato Rescigno, 9, I, Utet, 1984, pone l’accento
sul programma obbligatorio, ricavabile dalla fonte.
D’altro lato, come ben segnalato da Romano, Interessi del debitore e adempimento, Esi, 1995, 370, nt.
167, non sfugge alla letteratura tedesca il profilo
programmatico del rapporto: v. Gernhuber, Bürgerliches Recht, München, 1991, 131 ss.; Schlechtriem, Schuldrecht. Allgemeiner Teil, Tübingen,
1992, 41 ss. Altri riff. in Romano, op. loc. citt.
( 18 ) Irti, Introduzione allo studio del diritto privato, Cedam, 1990, 24.
( 19 ) Perassi, cit., 31 ss.; Pekelis, Il diritto come
volontà costante, Cedam, 1931, 70 ss.; Scognamiglio, Fatto giuridico e fattispecie complessa (considerazioni critiche intorno alla dinamica del diritto), in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, I, 350; Esposito, Lineamenti di una dottrina del diritto, in Annali Un.
Camerino, IV (1930), 5 ss.; Allorio, L’ordinamento
giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale, in
NGCC 2010 - Parte seconda
quello dedotto come diritto. A seconda di tale
conformità o difformità allo schema del diritto
(o dell’obbligo) si daranno altri effetti: per modo d’esempio, ove ad un dover consegnare
(una res all’acquirente) corrisponda l’effettiva
dazione, la condotta sarà conforme all’obbligo,
e implicherà il costituirsi del diritto reale nella
sfera del creditore; ove manchi la consegna,
nelle previste modalità spaziali e temporali, allora il contegno difforme produrrà nella sfera
del debitore il nuovo obbligo di risarcire il
danno, e, nella sfera del creditore il nuovo diritto al risarcimento del danno.
4. Segue: validità della fonte. Efficienza ed efficacia. I fatti della natura e della storia hanno agli occhi del giurista l’opaca impenetrabilità della materia. Essi sono sempre valutati, e così agguagliati in un metro di conformità o difformità dallo schema di pensiero che
li rende visibili.
La fonte è l’occhiale del giurista-giudice, il
quale sempre e solo è chiamato a riconoscere
fatti conformi al modello, e a declinarne la correlativa rilevanza per il diritto. La consegna di
una cosa, il pagamento di una somma, la dichiarazione di recesso sono fatti in sé neutri ed
insignificanti. I quali assumono senso filtrati
attraverso gli occhiali delle fonti; fuor di metafora, attraverso i modelli di condotta posti dalla fonte, e così qualificati secondo il rispettivo
titolo giuridico (sicché avremo il pagamento a
titolo di adempimento, la consegna a titolo di
donazione, e così altro).
Riaffermata di recente dalle pagine del Foro
amministrativo ( 20 ), la «validità» sta come un
carattere genetico della fonte, la quale si lascia
giudicare secondo un primo schema binario: la
fonte è prima di tutto (un prima logico e cronologico) valida o invalida.
La validità niente altro esprime che esistenza
per il diritto. Neppure vi sarebbe il bisogno di
norme sulla nullità testuale dei contratti privi
di requisiti. Il requisito – ciò che è richiesto
Problemi del diritto, I, Giuffrè, 1957, 14 ss.; Ago,
Scienza giuridica e diritto internazionale, Giuffrè,
1950, 67 ss.
( 20 ) Irti, Concetto giuridico di «comportamento»
e invalidità dell’atto, in Foro amm., 2004, 9, 2765 ss.;
ed in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 1054 ss.
133
Discussioni
perché il contratto esista al diritto – c’è o non
c’è ab origine ( 21 ). Diremo che si tratta di una
verità dommatica elementare, nel senso letterale d’un elemento primo: ogni «valere per» implica un giudizio di esistenza relativa, un esserci da un punto di vista ( 22 ).
Guadagnata che sia la qualifica di validità essa non si muta, e non è suscettibile di vicende
empiriche, ossia legate al correre del tempo.
L’atto (valido) segue l’ineluttabilità degli accadimenti storici. Factum infectum fieri non potest. Le successive vicende, che elidessero gli
effetti dell’atto sono sempre e solo vicende degli effetti e non mai della validità ( 23 ).
( 21 ) Irti, Concetto giuridico, cit., 2766: «“requisiti”, parola trasparente: ciò che viene chiesto affinché
un certo comportarsi sia riconosciuto come atto giuridico, come atto nel diritto e per il diritto. Queste
sono le condizioni di validità dell’atto, anzi della sua
vera esistenza. In difetto di una di esse, grave o non
grave che ci appaia, il comportarsi non assurge ad
atto giuridico: l’atto nullo è un non-atto. L’atto nullo è, propriamente e rigorosamente, l’invalido, ciò
che non riceve alcuna impronta di giuridicità. Non
c’è una gerarchia dei requisiti: da lungo tempo è stato enunciato il principio di equivalenza, onde l’uno
vale, e conta, al pari dell’altro».
( 22 ) Irti, Concetto giuridico, loc. cit.: «invalido è
ciò che non è valido, ciò che non è in grado di valere
nel diritto, in un diritto storicamente dato. Questo
valere trova misura e criterio nello stesso diritto: il
valere sociale storico etico non ci riguarda; ci riguarda soltanto il valere nel diritto e secondo il diritto.
Qui opera una cogente e radicale alternativa: l’atto
giuridico o è o non è. L’aut-aut è ineludibile; non ci
sono vie di mezzo o transazioni logiche». Femia,
Classificare il divenire: autonomia cognitiva del contratto e plusvalore politico dello scambio, ined. letto
grazie allo cortesia dell’a., 43 (del datt.) scrive – con
preziosa intuizione – di «destituzione semantica della fonte», la quale non vale come statuto giuridico
applicabile. «è o non è – spiega F. – qui rappresenta
il dilemma non dell’essere o non essere ma la descrizione del valere o non valere (cioè dell’essere o non
essere per un sistema culturale: il diritto); e valere o
non valere sta per essere o non essere segno del sistema di riferimento, significare o non significare
giuridicamente».
( 23 ) Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto
giuridico, cit., 185 ss. la quale si svolge attraverso la
distinzione tra «ciclo formativo esterno» e «ciclo
formativo interno»: il primo ha riguardo al c.d. «nu134
Una vicenda della validità è logicamente inconcepibile.
Non nuova all’orizzonte degli studi è la distinzione tra efficienza ed efficacia della fonte.
Il lemma efficienza esprime sotto questa luce
un concetto di potenza: l’attitudine della fonte
a produrre gli effetti prestabiliti (dall’atto stesso o dalla legge). L’atto valido è sempre efficiente; esso d’altro canto ben può pensarsi
inefficace, ossia concretamente improduttivo
di effetti.
La distinzione tra efficienza ed efficacia è penetrata nella teoria generale, e si risolve in ciò:
che la prima ha carattere astratto, e riguarda la
interna (al congegno normativo) connessione
tra fatto e conseguenze giuridiche; la seconda,
ha carattere concreto, e riguarda lo storico verificarsi del fatto, ed il prendere vigore delle
conseguenze, hic et nunc. Donde la critica alla
deviante e comune formula di «fatto efficace»,
che immette nel circuito normativo la spuria
idea di una produzione eziologica: «il fatto
concreto produce effetti nel proprio ordine
(che è la natura o la storia); ma, per definizione, è inidoneo a produrre effetti nell’ordine
giuridico» ( 24 ). L’efficienza appare nota intrinseca, ed esprime il giudizio sull’astratta idoneità del fatto a determinare gli effetti previsti;
l’efficacia è invece una nota estrinseca, ed attie-
cleo centrale della fattispecie», cioè alla «cerchia degli elementi essenziali del negozio»; la seconda, a
quella degli elementi estrinseci ed inessenziali. Altro
– si direbbe su questa linea – è l’invalidità come fenomeno intrinseco alla struttura della fonte; altro, il
conflitto estrinseco tra effetti, derivanti tra fonti parimenti valide e applicabili, che potrebbe condurre
alla prevalenza dell’un effetto sull’altro.
( 24 ) Irti, Rilevanza giuridica, cit., 60 s. V. Scognamiglio, Fatto giuridico e fattispecie complessa
(Considerazioni critiche intorno alla dinamica del diritto), in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, 352; Falzea, voce «Efficacia giuridica», cit., 482 s.; Id., La
condizione e gli elementi dell’atto giuridico, cit., 27
(ove si legge di «efficacia potenziale»). Sotto questa
luce è pure enucleato il c.d. «principio di giuridicità
funzionale del fatto» (segnatamente da Pagliaro, Il
fatto di reato, Priulla, 1955, 51, 55, 61. Pugliatti,
La trascrizione, nel Trattato Cicu-Messineo, Giuffrè,
vol. XIV, 1957, 406, nt. 22 («fatto come antecedente
dell’effetto»); altri riff. in Irti, Rilevanza giuridica,
cit., 12 s., ntt. 39 ss.
NGCC 2010 - Parte seconda
Abuso del diritto
5. Ambiguità del concetto di abuso.
Teoria dell’irrilevanza e teoria della
doppia qualifica. Cosa significa dunque sul
piano logico che la condotta abusiva sia conforme allo schema formale del diritto (per
dirla con la nostra sentenza)? Delle due l’una:
o è conforme, ed allora rileva quale esercizio
del diritto, e così implica gli effetti producibili; o è difforme, ed allora non rileva come
esercizio.
Nel tentativo di ordinare le pagine sparse intorno al fenomeno dell’abuso, parrebbe qui
d’imbattersi in due scuole di pensiero. La prima, che concepisce l’abuso come un figura dell’irrilevanza, ossia di difformità del concreto
atto d’esercizio dal modello applicabile. Su
questa linea l’abuso mette capo se non m’inganno alla previa definizione della sfera di applicazione del diritto: cadendo fuori da tale
sfera, in uno spazio vuoto, le condotte abusive
perdono la protezione armata della legge e divengono inefficaci. Questa logica passa per
una delimitazione degli spazi giuridici applicativi del modello (ossia del diritto, come descritto dalla fonte). Ed i criteri di tale delimitazione
saranno più o meno rigorosi – par d’intendere
– secondo l’umore e la tempra culturale dell’interprete.
Poco o punto interessa qui esaminare nel
dettaglio le tecniche di delimitazione del diritto (rectius, della relativa sfera di applicazione).
Si tratta di stabilire, prima e sopra, il significato della fonte descrittiva del diritto. Quale che
sia la latitudine delle opinioni, tutte convergeranno intorno alla necessità d’interpretare la
fonte, ossia di attribuire un senso alle parole
che descrivono il ius «abusato».
L’abuso non sta prima ma dopo l’interpretazione della fonte; e postula come già definita la
sfera di applicazione del diritto e così il criterio
di rilevanza delle condotte. L’esercizio abusivo
finisce qui per metter capo alla irrilevanza della
condotta difforme dal diritto; e per condurre al
medesimo risultato – ancora una volta logico
prima che giuridico – dell’assenza radicale di
qualsiasi diritto. Irrilevanza, appunto ( 26 ).
Diversamente dalla prima, la seconda veduta
parrebbe muovere dall’esterno del diritto e
della relativa sfera di applicazione; e concepire
l’abuso come condotta riprovevole secondo
criteri «giuridici e non giuridici» (come si legge
per tabulas nella nostra sentenza), ancorché essa risulti conforme allo schema del diritto, ossia al modello di comportamento applicabile.
Qui dunque non si dà un problema di irrilevanza bensì di diversa e ulteriore rilevanza.
Sono vere entrambe le affermazioni: che la
condotta è esercizio di un diritto; che essa è
pure ed al contempo riprovata da altre norme
(giuridiche o non giuridiche). Traduciamo in
linguaggio analitico. La condotta abusiva rileva
quale esercizio del diritto, e così ne implica gli
effetti; essa al contempo vale secondo altra fon-
( 25 ) «La parentela semantica tra norma e normalità – leggiamo in Irti, In dialogo su «nichilismo giuridico», in Riv. int. fil. dir., 2006, 169 ss.; ora in Il salvagente della forma, cit., 2007, 54 – esprime che la vita
è normale, regolare nel suo corso quotidiano, se è
retta e governata da una norma, che la “squadra” e
ne fa misura».
( 26 ) Cfr. Müller Erzbach, L’abuso del diritto secondo la dottrina teleologica, in Riv. dir. comm.,
1950, I, passim. Romano, voce «Abuso del diritto:
c) diritto attuale», in Enc. del dir., I, Giuffrè, 1958,
166 ss.; Gambaro, voce «Abuso del diritto. II) Diritto comparato e straniero», in Enc. giur. Treccani,
I, Ed. Enc. it., 1988. Sul punto Gentili, op. cit., 17.
ne al giudizio sulla concreta determinazione
degli effetti previsti.
Ogni fonte reca dunque la descrizione degli
statuti giuridici applicabili alle parti, così che
i comportamenti delle parti si lascino ordinare secondo le qualifiche di diritto ed obbligo
e lascino seguire al loro esercizio i corrispondenti effetti. Per applicare il diritto o l’obbligo è necessario passare per la definizione delle relative estensioni, ossia della spettro delle
condotte che ricadono sotto la previsione della fonte.
Il lettore avrà già svolto a questo punto
l’equivalenza: giudizio normativo e giudizio
applicativo hanno la medesima natura logica,
entrambi risolvendosi in sussunzioni del fatto
concreto in uno schema del pensiero. La fonte
normalizza ( 25 ) i fatti, li ordina sotto il proprio
euristico schema sicché possa dirsi: ho esercitato un diritto. Nessun atto di esercizio è pensabile fuori del proprio (nel senso di corrispondente) schema.
NGCC 2010 - Parte seconda
135
Discussioni
te come condotta illecita, cioè lesiva di un altro
diritto, e così implica il risarcimento del danno.
6. Segue: combinazione e contraddizione di effetti. Il discorso entra a questo punto
nel vivo. Poco o punto nella teoria della irrilevanza, che finisce per far coincidere abuso e assenza del diritto, determinando il dissolvimento del primo nel secondo fenomeno. Quanto
piuttosto nella teoria della doppia rilevanza, la
quale parrebbe generare un conflitto tra due
qualifiche diverse e (apparentemente) opposte.
Se infatti la condotta abusiva è conforme al diritto, ossia è esercitata entro i confini dello
«schema formale del diritto» (ancora la formula dei giudici), l’atto di esercizio è rilevante ed
efficace; solo che, dinanzi ad esso, si staglia altra rilevanza ed efficacia, secondo un diverso e
parimenti applicabile schema formale. Oltre a
determinare scioglimento del vincolo, e fors’anche perciò stesso, l’atto si dimostra lesivo
dell’altrui interesse (di eccessivo «sacrificio cui
è soggetta la controparte» dice la sentenza).
L’atto vale in una come esercizio di un diritto e anche come fatto illecito.
Donde l’imbarazzante interrogativo: si può
essere titolari di un diritto a compiere atti illeciti ( 27 )?
Confesso che anch’io a tutta prima ho intuitivamente e frettolosamente rifiutato questo, che
mi appariva come un paradossale ossimoro. Delle due l’una: o sono titolare di un diritto, e dunque non potrò che compiere atti leciti d’esercizio; oppure sono titolare di un divieto (per convertire in tal qualifica il neminem laedere), ed allora sarà concepibile un illecito, ma anche e perciò dovrà escludersi ogni diritto ( 28 ).
( 27 ) Analoga domanda trovo in Pino, L’esercizio
del diritto soggettivo e i suoi limiti. Note a margine
della dottrina dell’abuso del diritto, in Ragion pratica,
24, 2005, 161 ss., spec. 161: «Esiste un diritto soggettivo a fare qualcosa di (giuridicamente) sbagliato? Così potrebbe essere riformulata, con specifico
riferimento alla dimensione giuridica, la problematica del “right to do wrong”».
( 28 ) Da segnalare come nella logica del testo nulla
incide la distinzione tra illecito contrattuale ed extracontrattuale. Poiché entrambi postulano il ricorrere di altra e diversa fonte di qualificazione.
136
Non è così.
Il laboratorio di maggior interesse in materia
rimane il dolo incidente. L’art. 1440 cod. civ. si
rivela come fenomeno emblematico di doppia
qualifica. Il raggiro incidente non determina
per espressa previsione la invalidità della fonte,
sicché essa continua a sorreggere il diritto del
contraente in mala fede. Dunque – diremo pure per definizione – questi potrà esercitare il
diritto estorto con dolo (ognuno potrà svolgere
esempi i più acconci), così cagionando alla
controparte in buona fede un danno ingiusto.
E poi – e perciò stesso – lui medesimo risponderà del danno, ossia sarà tenuto al risarcimento.
Non cadrò nella trappola della inspiegabilità, sicché tutto si ferma dinanzi ad un legislatore qui facit de albo nigro, decidendo di combinare i due effetti per mero e capriccioso e a-razionale arbitrio. L’art. 1440 cod. civ. non soltanto ha un senso rigoroso, ma esso dispiega
un principio che riposa sulla forza della coerenza: che la contraddizione non si misura in
base alle fonti ma agli effetti, e più precisamente alle prestazioni. Gli effetti non si valutano ex
ante, quasi che le conseguenze giudiziarie possano predicarsi a prescindere dall’accertamento del giudice. Sapremo solo all’esito del giudizio distribuire torto e ragione, o – spostandoci
all’angolatura sostanziale – conosceremo all’esito del giudizio la dinamica degli effetti sottesi alla condotta «abusiva» ( 29 ).
Non è questa la sede per indugiare nell’analisi. Qui basterà dire che se – come è in ipotesi
– si danno due fonti valide ed efficienti, esse
mettono capo a due pretese contrapposte. Che
sarà il giudice a combinare nella sintesi unitiva
del giudizio e della sentenza decisiva. La prevalenza dell’uno o dell’altro effetto non dipende
dalla efficienza della fonte, poiché essa è una
volta per tutte guadagnata in origine, con il
giudizio di validità. Dipende invece dalla disciplina degli effetti e delle prestazioni, i quali si
avvicendano e combinano proprio in ragione
( 29 ) Si pensi al dolo incidente. Convenuta per
l’esecuzione del contratto doloso, la parte in buona
fede potrebbe non esercitare il proprio diritto al risarcimento. E così rimanere vittima del dolo. Si tratta all’evidenza di una opaca quaestio facti.
NGCC 2010 - Parte seconda
Abuso del diritto
della contemporanea validità delle rispettive
fonti. E gli effetti possono combinarsi quando
risultino compatibili (come nel caso della nostra sentenza). O entrare in conflitto: applicandosi in tal caso i criteri di soluzione delle antinomie, ossia della contraddizione tra criteri di
rilevanza.
In altre parole, la contraddizione dell’art.
1440 cod. civ. è solo apparente, poiché è frutto
della conversione di una comparazione monca
e superficiale tra qualifiche astratte. Se mi tengo al piano della qualifica astratta, dovrò dire
ho un diritto ad una prestazione illecita; e così
cadrò nella insolubile contraddizione.
Ma l’avere un diritto è non l’effetto da valutare bensì la premessa logica dell’effetto; il
quale starà nell’apprestare la tutela coattiva
delle condotte propria e altrui. La comparazione scenderà allora al piano degli effetti della
condotta, e avrà riguardo alla compatibilità tra
gli effetti implicati dalle fonti. Nel nostro caso:
tra effetto estintivo del recesso, ed effetto costitutivo dell’obbligo risarcitorio.
Sul piano degli effetti si misurerà la compatibilità delle fonti. Sicché delle due l’una: o gli
effetti risulteranno compatibili ed allora troveranno entrambi applicazione finendo il giudice
per combinarli; o essi risulteranno incompatibili, ed allora il giudice dovrà lasciar prevalere
l’una o l’altra fonte.
Segnatamente si tratterà di valutare la prevalenza dell’una o dell’altra fonte secondo i tre
consueti principi: principio di gerarchia; principio di competenza; principio di non contraddizione (fons posterior). La prevalenza sarà appena da precisare non implica nullità bensì disapplicazione della fonte perdente. È un fenomeno estrinseco, il quale mette capo all’esogeno prevalere di altra fonte e non già ad un vizio
o ad un’insufficienza endogena della fonte disapplicata ( 30 ).
7. Carattere estrinseco dell’abuso.
«Criterio rivelatore – si legge nella sentenza –
( 30 ) Si tratta per dirla con Falzea, del ciclo formativo non già interno bensì esterno. Non è un difetto
strutturale della fonte, ma il nesso di compatibilità o
incompatibilità tra due fonti, parimenti valide ed
applicabili.
NGCC 2010 - Parte seconda
della violazione dell’obbligo di buona fede oggettiva è quello dell’abuso del diritto».
Questa notazione, che parrebbe naturale
nello svolgimento delle pagine della Supr. Corte, si svela intimamente contraddittoria. Se infatti l’abuso non sta nella irrilevanza della condotta, cioè nella estraneità alla sfera di applicazione del diritto, nessun abuso sarà pensabile
dal di dentro, ossia svolgendo il giudizio di
conformità tra condotta e diritto. Tale esame
lascia sempre e per definizione emergere la rilevanza formale (diremo senza timore) della
condotta, quale corrispondenza al modello.
Tecnicamente conforme, la condotta non
potrà che cercare fuori del diritto, ossia dello
schema formale al quale essa risulta corrispondere, altra e diversa fonte che ne consenta di
valutare il carattere abusivo. Nella teoria della
doppia qualifica l’abuso si risolve appunto in
altra e ulteriore qualificazione, rispetto al giudizio di conformità condotta-diritto. Se anche
volessimo isolare nella norma sulla esecuzione
in buona fede la fonte di tale ulteriore qualifica, dovremmo allora concludere che non già
l’abuso, bensì proprio la mala fede si dimostri
criterio rivelatore. L’abuso non rivela nulla ma
attende di essere rivelato; conforme al modello, la condotta esige un altro e diverso giudizio
di riprovazione; che nella linea del Collegio
parrebbe risolversi in un inadempimento all’obbligo di buona fede oggettiva.
Ragioniamo ancora sul nostro caso. Titolare
del diritto di recedere, l’una parte recede efficacemente, ossia determina l’effetto estintivo.
Tuttavia, recedendo, il medesimo contraente
lede l’altrui diritto, e perciò cagiona (cagionerebbe) un danno ingiusto (al pari del danno
causato dall’esercizio di un diritto conseguito
con dolo incidente).
La doppia rilevanza genera doppia efficacia,
e così può condurre al risarcimento del danno
per l’esercizio di un diritto.
8. Negazione dommatica dell’abuso. A
questo punto si manifesta una catena di conseguenze, che non dobbiamo temere. Dove troviamo infatti il diritto violato? Qual è la fonte
di tal diritto? Non indugeremo oltre, lasciamo
all’ascoltatore una sola idea: che il diritto dovrà
pur riposare su una fonte suscettibile di accertamento, e non affetta da un grado di vaghezza
137
Discussioni
tale da annichilirla. Ragioniamo soltanto che il
dolo incidente implica illecito, poiché – attraverso il richiamo dell’art. 1440 cod. civ. – esso
coincide con il dolo aquiliano. I principi non
esistono in natura, ma si porgono alla mente
con la mediazione del strictum ius.
Ma concediamo pure di isolare la fonte del
diritto violato.
In che si risolverà l’abuso nella teoria della
doppia qualifica? Certamente non in una vicenda genetica della fonte, logicamente impossibile
( 31 ); la categoria dell’abuso non rimodella la fonte, la quale rimane ciò che è. Essa neppure evoca
l’irrilevanza (estraneità alla fonte) della condotta che diamo in ipotesi per conforme al diritto.
L’abuso finisce allora per risolversi nella
qualifica dell’illiceità dell’atto di esercizio; il
quale atto – in ragione di altra specifica fonte –
implicherà l’effetto risarcitorio ( 32 ).
Dov’è dunque l’abuso, nella teoria della
doppia qualifica?
Cade – dobbiamo pur concludere – sotto il
fatidico rasoio, poiché il lemma implica non
già un fenomeno nuovo e diverso, ma niente
altro che un illecito. La condotta è abusiva
perché illecita, e non illecita perché abusiva.
Essa, ledendo un (ipotetico) diritto della controparte, rifluisce sotto la specie dei fatti dolosi o colposi che cagionano un danno ingiusto.
Al postutto la categoria dell’abuso appare
come stritolata nella tenaglia di due contigui
spazi logici, in cui essa finisce per dissolversi:
da un lato lo spazio dell’irrilevanza, nel quale
cade e giace ogni condotta che non si lasci agguagliare alla fonte; d’altro lato lo spazio dell’illecito, che tutto attira nella propria sconfinata atipicità.
( 31 ) Supra, par. 4.
( 32 ) Sul piano più generale v. ora Restivo, Contributo ad una teoria dell’abuso, Giuffrè, 2007, passim. Il quale ancorché concepisca l’abuso come sviamento di potere privato (eccesso della condotta rispetto all’interesse tipico previsto dalla norma), mi
pare possa convenire sul carattere illecito e perciò
vietato della condotta abusiva.
138
NGCC 2010 - Parte seconda
ABUSO DEL DIRITTO, BUONA FEDE,
RAGIONEVOLEZZA (VERSO UNA RISCOPERTA
DELLA PRETESA FUNZIONE CORRETTIVA
DELL’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO?)
di Claudio Scognamiglio (*)
1. La sentenza della Corte di Cassazione,
terza sezione civile, 18.9.2009, n. 20106, ha subito dato vita ad un dibattito ricco e vivace ( 1 );
né poteva essere altrimenti, alla luce della abbondanza, se non della sovrabbondanza ( 2 ), di
spunti costruttivi e di riflessione che la sentenza offre, sia dal punto di vista della metodologia stessa dell’argomentare, e del decidere, sia
con specifico riferimento ad alcuni degli snodi
di maggiore importanza della riflessione attuale sull’autonomia privata, da essa toccati, anche se non sempre in maniera pienamente consapevole ed avvertita.
Infatti, e cominciando dalle questioni afferenti alla metodologia argomentativa della sentenza, è stato subito, correttamente, rilevato
che la sentenza «è emblematica del dilagare di
un modello argomentativo in cui il giudice at-
(*) Il presente scritto riprende e rielabora il testo
della relazione presentata al Convegno Autonomia
privata, recesso e abuso del diritto, tenutosi presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena il 20-21.11.2009 e costituisce parte di un
più ampio scritto dell’a.
( 1 ) Si segnalano, in particolare, ed allo stato, i
contributi di Macario, Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese: spunti da
una recente sentenza della Cassazione, in Corr. giur.,
2009, n. 12, 1577 ss.; D’Amico, Recesso ad nutum,
buona fede e abuso del diritto, in Contratti, 2010, 11;
Restivo, Abuso del diritto e autonomia privata. Considerazioni critiche su una sentenza eterodossa, in
corso di pubblicazione, in Contratti, 2010.
( 2 ) Si intende alludere non solo alla circostanza,
che sarà tra breve più ampiamente argomentata, della presenza nella sentenza di una manifesta sproporzione argomentativa tra la reale ratio decidendi ed i
diffusi obiter dicta, ma anche al rapporto tra il contenuto decisorio della sentenza e quello delle pronunce dei giudici di merito, e segnatamente della
Corte d’appello, annullata dalla Cassazione.
NGCC 2010 - Parte seconda
tinge direttamente la soluzione del caso concreto dalla dimensione dei principi, quasi disinteressandosi della mediazione delle regole,
così condannate ad un progressivo deperimento», sottolineandosi la pericolosità di tale «egemonia dei principi... perché vestita di pretese
moralizzanti, aggravata da un uso disinvolto e
grossolano degli stessi», come tale idonea ad
incidere «negativamente sul tasso di prevedibilità delle decisioni» ed a disvelare «una deriva
che – magari sotto le mentite spoglie della giustizia contrattuale – nasconde l’arbitrio del giudice» ( 3 ).
Un’altra notazione che si impone, sempre sul
versante della tecnica argomentativa, è quella
attinente alla molteplicità di obiter dicta dai
quali la sentenza è disseminata.
Infatti, ed a fronte di una ratio decidendi che
poteva essere abbastanza agevolmente circoscritta all’affermazione, di per sé tutt’altro che
eversiva ( 4 ), della sindacabilità del recesso dal
contratto secondo buona fede, ovvero alla stregua dello strumento concettuale dell’abuso del
diritto ( 5 ), anche nelle ipotesi in cui lo stesso
non sia normativamente, o pattiziamente, an( 3 ) Così Restivo, Abuso del diritto e autonomia
privata, cit.
( 4 ) Secondo quanto risulta, del resto, dalla stessa
giurisprudenza citata da Cass., 18.9.2009, n. 20106,
(pubblicata supra, parte prima, 239) ; ci si permetta
il rinvio, sul punto, a quanto osservavamo, sul tema
del controllo secondo buona fede dell’esercizio del
diritto di recesso dai contratti di durata, nel nostro
Il nuovo diritto dei contratti: buona fede e recesso dal
contratto, in Il nuovo diritto dei contratti: problemi e
prospettive, Giuffrè, 2004, 357 ss.
( 5 ) Prescindendo, in questa sede, dalle perplessità, motivatamente sollevate da D’Amico e Restivo,
nei due scritti citati alla nota 2, sulla sovrapposizione, e confusione, che la sentenza opera tra sindacato
dell’esercizio del diritto alla stregua del criterio del139
Discussioni
corato al presupposto di una giusta causa o di
un giustificato motivo, la Corte di Cassazione
ha ritenuto di spingersi, e forse sarebbe il caso
di dire di avventurarsi, su terreni eccentrici rispetto a quello che doveva costituire il termine
di riferimento della decisione e per di più decisamente scivolosi: dalle conseguenze del compimento di un atto in violazione della regola di
buona fede ( 6 ), alla, pur molto sintetica, riproposizione di un possibile ruolo operativo, quale tecnica di controllo degli atti di autonomia
privata, della regola della funzione sociale della
proprietà, ex art. 42 Cost. ( 7 ), all’affermazione
l’abuso del diritto e sindacato alla stregua del canone della buona fede.
( 6 ) La sentenza si occupa del tema nell’ambito di
una digressione di diritto societario, osservando che
«in materia societaria è stato sindacato, in una deliberazione assembleare di scioglimento della società,
l’esercizio del diritto di voto sotto l’aspetto dell’abuso
di potere, ritenendo principio generale del nostro ordinamento, anche al di fuori del campo societario,
quello di non abusare dei propri diritti – con approfittamento di una posizione di supremazia – con l’imposizione, nelle delibere assembleari, alla maggioranza,
di un vincolo desunto da una clausola generale quale
la correttezza e buona fede (contrattuale)» e pervenendo appunto alla conclusione che «la conseguenza
è quella della invalidità della delibera, se è raggiunta
la prova che il potere di voto sia stato esercitato allo
scopo di ledere gli interessi degli altri soci, ovvero risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli
di minoranza, in violazione del canone di buona fede
nell’esecuzione del contratto»: sotto questo profilo, è
appena il caso di notarlo, e proprio per la palese
esuberanza della digressione sul punto rispetto ai temi di causa, la sentenza pare voler apportare un sia
pure del tutto incidentale spunto critico al dibattito
sul principio di non interferenza tra regole di validità e regole di correttezza, che sembrava avere trovato una definitiva composizione con le note sentenze
della Cass., sez. un., nn. 26724/2007 e 26725/2007,
oggetto, soprattutto a seguito dell’intervento delle
Sezioni Unite, di un dibattito molto approfondito, ci
si permetta il rinvio al nostro Scognamiglio, Regole di validità e di comportamento: i principi e i rimedi,
in Eur. e dir. priv., 2008, 599 ss.
( 7 ) Regola che, secondo l’accenno che si legge
nella sentenza della Supr. Corte, parrebbe, dunque,
vedersi attribuire addirittura una portata generale e
tale da sporgere ben al di là della disciplina conformativa del diritto di proprietà: in termini giustamen140
di un necessario scrutinio di proporzionalità
dell’atto (nel caso di specie, il diritto di recesso) al fine (lo scioglimento del contratto di
concessione), scrutinio di proporzionalità in
grado di sfociare, secondo uno dei passaggi più
discutibili di tutta la sentenza «in una certa procedimentalizzazione nell’esercizio del diritto di
recesso (per es. attraverso la previsione di trattative, il riconoscimento di indennità)» ( 8 ), fino
all’enunciazione secondo la quale «la buona fede... serve a mantenere il rapporto giuridico nei
binari dell’equilibrio e della proporzione», che
si specifica, dall’angolo visuale dell’interpretazione del contratto (tema, a sua volta, totalmente estraneo al novero delle questioni di diritto che le parti avevano sottoposto alla Corte)
nell’enunciato secondo il quale «il criterio della
buona fede costituisce... uno strumento, per il
giudice, finalizzato al controllo – anche in senso
modificativo o integrativo – dello statuto negoziale; e ciò quale garanzia di contemperamento
dei contrapposti interessi», al punto che «il giudice, nell’interpretazione secondo buona fede
del contratto, deve operare nell’ottica dell’equilibrio fra i detti interessi».
L’obiettiva divaricazione tra le effettive esigenze argomentative, che richiedevano le questioni devolute all’attenzione della Supr. Corte
con i motivi di ricorso, ed apparato motivazionale della sentenza risulta ancora più marcata,
ove si consideri che – come è stato puntualmente dimostrato già in sede di primo commento alla sentenza ( 9 ) – la decisione della
Corte d’appello, oggetto dell’impugnativa, pute critici, su questo passaggio, della sentenza D’Amico, Recesso ad nutum, buona fede ed abuso del diritto, cit.
( 8 ) In altre parole, la Corte pare ritenere che, alla
stregua dell’oscuro, se non decisamente fumoso, criterio della proporzionalità, si potrebbe costruire, in
un contesto in cui la fonte legale o contrattuale disciplinatrice del rapporto attribuisce ad un contraente il diritto di recesso pure in difetto di giusta
causa o giustificato motivo, un obbligo di avviare
previamente (al recesso) trattative con controparte
ovvero un’obbligazione indennitaria, pur nell’assenza di qualsiasi regola, legale o pattizia, attributiva
del corrispondente diritto alla parte che abbia subito il recesso.
( 9 ) Il riferimento è al già menzionato scritto di
Macario, cit., 1579 s., nt. 4, dove si legge, appunto,
NGCC 2010 - Parte seconda
Abuso del diritto
re a sua volta caratterizzata da una certa indulgenza verso modalità argomentative sovrabbondanti, oltre che non sempre condivisibili,
recava, comunque, una motivazione, in punto
di fatto, sull’assenza di profili di abusività, o
contrarietà a buona fede, del recesso della parte convenuta in giudizio. Ed è evidente che tale
profilo motivazionale della sentenza d’appello
avrebbe consentito alla Corte di cassazione,
salvo il controllo sull’eventuale carenza o contraddittorietà della motivazione, di saltare
senz’altro tutta la parte, per così dire, ricostruttiva e teorica della propria decisione.
Sul piano del discorso relativo alle modalità,
ed alle tecniche, dell’argomentazione e della
decisione, dunque, la conclusione suggerita dal
raffronto tra la sentenza di appello e quella di
cassazione, che ha dato spunto a queste notazioni, è quella della (confermata) pericolosità
delle sentenze, che potremmo definire, manifesto, in questo caso, più che trattato: e cioè delle
sentenze che, cedendo alle suggestioni di temi
culturalmente accattivanti, quali sono quelli
del rapporto tra l’atto di autonomia privata (e
gli interessi attraverso di esso realizzati) e la valutazione che ne opera l’ordinamento, si avvolgano nelle spirali di un’impostazione fortemente ideologica di esso. E qui, infatti, ad una lettura fortemente ideologica, e per certi versi superata, del rapporto tra autonomia privata e
controllo giurisdizionale, proposta dalla Corte
d’appello (secondo le linee della motivazione
della quale si legge criticamente nella sentenza
della Supr. Corte), si è contrapposta subito una
risposta altrettanto ideologica di quest’ultima.
Le considerazioni fin qui svolte sembrerebbero dover costituire il prologo ad una riflessione sulla sentenza della cassazione in esame,
che, sfrondata senz’altro la motivazione della
stessa dalle incrostazioni degli obiter dicta, conduca al cuore del problema della sindacabilità
secondo buona fede, ovvero attraverso il prisma dell’abuso del diritto, dell’atto di esercizio
del diritto di recesso pure non condizionato
un’ampia esposizione del percorso argomentativo in
fatto prescelto dalla Corte d’appello (mentre nella
sentenza della Corte di cassazione ci si sofferma criticamente solo sugli svolgimenti in diritto della sentenza di merito).
NGCC 2010 - Parte seconda
dalla sussistenza di una giusta causa o di un
giustificato motivo.
Non è questo, tuttavia, l’approccio qui seguito, dato che le brevi considerazioni che saranno svolte saranno invece dedicate proprio
ad uno quei nuclei argomentativi della sentenza, poc’anzi assai agevolmente identificati come obiter dicta: e cioè la pretesa portata modificativa/integrativa dello statuto negoziale,
ascrivibile alla clausola di buona fede, nonché,
in particolare, l’obbligo del giudice, quando
proceda all’interpretazione secondo buona fede del contratto, di operare nell’ottica del contemperamento, ed anzi dell’equilibrio, degli interessi dei contraenti.
Né in questa impostazione deve essere ravvisata una contraddizione con l’operazione,
poc’anzi svolta, di selezione, all’interno della
motivazione della sentenza, tra ratio decidendi
ed obiter dicta: ed infatti anche un’argomentazione resa solo in via incidentale dalla Supr.
Corte, e fuori fuoco rispetto alle necessità decisorie che vengano in quel caso in considerazione, può essere in grado di assumere una valenza quanto meno suggestiva o persuasiva con riferimento ad altri casi, secondo quanto è dimostrato già dal rilievo empirico che la massimazione della sentenza, che si legge in una delle
banche dati giuridiche più consultate, esibisce
come massime anche enunciazioni rese palesemente obiter ( 10 ).
( 10 ) Si intende alludere alle massime nelle quali è
stata condensata la sentenza nella Banca dati Utet,
dove si leggono, tra le altre, queste massime: «Il
principio della buona fede oggettiva, ossia della reciproca lealtà della condotta delle parti, non solo vincola i contraenti nella fase dell’esecuzione del contratto
ed in quella della sua formazione, ma deve intendersi
riferito anche agli interessi sottostanti alla stipula del
regolamento negoziale, a tale conclusione pervenendosi sull’assunto che la clausola generale di correttezza e buona fede costituisce un autonomo potere giuridico espressione del generale dovere di solidarietà sociale e come tale è idonea ad imporre a ciascuna delle
parti del rapporto obbligatorio di agire preservando le
ragioni dell’altra» ed ancora «L’ordinamento giuridico, pur accordando al privato l’autonomia e la tutela
degli atti posti in essere per il perseguimento di interessi meritevoli, disconosce validità all’esercizio di poteri, diritti ed interessi in violazione del principio di
buona fede oggettiva. È devoluto al giudice il compito
141
Discussioni
D’altra parte, e ferma ovviamente la netta distinzione concettuale tra la ratio decidendi della
sentenza, e gli obiter dicta che a quest’ultima
possono fare corona, ben può accadere in effetti che la Corte di cassazione affidi ad enunciazioni pure non necessarie nell’economia della motivazione della singola sentenza, una sorta
di messaggio nella bottiglia: messaggio nella
bottiglia che, ove lo si ritenga latore di un pericolo per la coerenza e la funzionalità delle decisioni future, è allora opportuno intercettare e
disinnescare senz’altro nel suo dispositivo argomentativo.
2. La fisionomia che la regola di buona fede,
e le sue condizioni d’uso, paiono assumere all’interno dell’area del diritto privato europeo
dei contratti, costituiscono un primo elemento
di verifica critica dell’attendibilità della funzione che la sentenza, occasione di queste riflessioni, vorrebbe ascrivere a quella clausola generale sul piano dell’interpretazione del contratto: tanto più ove si consideri che un altro
appunto metodologico, che può muoversi alla
predetta sentenza, attiene proprio all’attenzione decisamente insufficiente, da essa riservata
ai dati di diritto privato europeo, dai quali, invece, un discorso davvero maturo, su questo,
così come sugli altri temi del diritto dei contratti, non può ormai prescindere ( 11 ).
di esaminare il regolamento negoziale posto liberamente in essere fra le parti al fine di verificare la rispondenza del contegno dei contraenti con il principio
della buona fede oggettiva»: e cioè appunto massime
che disegnano la funzione riequilibratrice e di controllo del contratto, che la buona fede, ad avviso
della sentenza, è in grado di espletare (e che costituirà, come si dirà nel testo, il termine di riferimento di
queste considerazioni).
( 11 ) È sorprendente, in particolare, che la sentenza non menzioni affatto l’unico dato normativo, che
positivizza il divieto di abuso del diritto: e cioè l’art.
II-114 della Costituzione europea, secondo il quale
«Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di
esercitare un’attività o compiere un atto che miri a
distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni
più ampie di quelle previste dalla presente Carta».
Al di là della formulazione decisamente infelice dell’enunciato, lo stesso è stato comunque ritenuto ido142
Portando subito l’attenzione su uno dei testi
che costituiscono, ovviamente, il termine di riferimento di ogni discorso sul punto, e cioè i
Principi di diritto privato europeo dei contratti
(PECL), è noto che il catalogo delle norme imperative dei Principi di diritto europeo esordisce con l’art. 1:201, secondo il quale le parti
devono agire nel rispetto della buona fede e
della correttezza, essendo appunto, ed espressamente, previsto dal comma 2o del medesimo
articolo che «le parti non possono escludere o
limitare quest’obbligo».
Tuttavia, secondo un’autorevole ricostruzione del senso che la clausola di buona fede assume all’interno del sistema disegnato dai PECL,
l’imperatività della stessa non esprime la tendenza del modello di regolamentazione che ne
emerge a comprimere gli spazi di esplicazione
dell’autonomia privata, operando, invece, sul
piano di quella che potrebbe definirsi l’autointegrazione del contratto ( 12 ): con il corollario
che la stessa deve venire in considerazione, sia
quando si tratti di colmare una lacuna regolamentare dell’operazione economica in senso
conforme al progetto di razionalità intrinseco
alla medesima, sia quando occorra invece intervenire in funzione correttiva sul regolamento contrattuale, costituendo allora, il parametro della buona fede, la garanzia del fatto che la
correzione del contratto non si trasformi in
un’integrale riscrittura del medesimo, tale da
tradirne la sua essenza di atto di autonomia
privata.
Il modello di diritto privato europeo dei
contratti, costituito dai PECL, fa emergere al-
neo ad imprimere alla disciplina della Costituzione
europea in materia di autonomia privata una «robusta iniezione contenutistica», così da legittimare la
conclusione che «l’abuso del diritto, l’idea di mercato regolato ed il primato della concorrenza, il richiamo alla protezione del consumatore, costituiscono
le nuove “formule magiche” di rango costituzionale
europeo che si sovrappongono a quella della nostra
tradizione costituzionale: la funzione sociale, l’utilità
sociale etc.» (così Mazzamuto, Note minime in tema di autonomia privata alla luce della Costituzione
europea, in Eur. e dir. priv., 2005, 51 ss.).
( 12 ) Cfr., in tal senso, Castronovo, Autonomia
privata e costituzione europea, in Eur. e dir. priv.,
2005, 29 ss.
NGCC 2010 - Parte seconda
Abuso del diritto
lora l’acquisizione da parte della buona fede di
un ruolo non solo persino più pervasivo rispetto al passato ma anche qualitativamente diverso ( 13 ).
Si è detto, infatti, che il richiamo continuo
alla buona fede, nell’ambito dei Principi di diritto europeo dei contratti, non è indice di una
sorta di incondizionata disponibilità del contratto a lasciarsi impregnare da valutazioni eteronome, affidate oltre tutto – per il mezzo della
clausola generale – all’esercizio della discrezionalità giudiziale, deponendo piuttosto «nel
senso del rispetto dell’atto così come le parti
dovrebbero o avrebbero dovuto porlo in essere
nell’esercizio corretto della loro autonomia»
( 14 ).
In altre parole, ed in sede di concretizzazione della clausola generale di buona fede, «il
convincimento del giudice non attiene a ciò
che esso ritiene giusto o no, bensì a quello che
esso ritiene giusto secondo la morale sociale,
che la clausola generale ha appunto la funzione
di richiamare» ( 15 ).
Troverebbe, allora, e finalmente, coronamento all’interno del sistema dei Principi quel
processo di sublimazione della clausola generale di buona fede dalle incrostazioni di precomprensioni ideologiche che ne aveva così a lungo
compromesso la più efficace utilizzazione ( 16 ),
risultando a tale stregua restituita la buona fede ad una funzione di amministrazione razionale, e non avulsa rispetto ai piani delle parti,
del rapporto discendente dalla regola contrattuale.
Se così stanno le cose, è evidente che i Principi abbiano inteso corazzare la buona fede
con la qualificazione di imperatività: ed infatti,
se fosse stato consentito alle parti del contratto
di derogare o disapplicare, in via preventiva e
generale il canone di buona fede, sarebbe stata
preclusa, in radice, ogni possibilità di salvaguardare, o recuperare, la funzionalità di un
regolamento contrattuale lacunoso o distorto.
Siamo, dunque, ben lontani dall’idea –
espressa, sia pure non troppo chiaramente,
dalla sentenza di Cass., n. 20106/2009, come si
è visto in precedenza – di una buona fede che
serva «a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell’equilibrio e della proporzione» e che
possa essere utilizzata come «uno strumento,
per il giudice, finalizzato al controllo – anche in
senso modificativo o integrativo – dello statuto
negoziale... quale garanzia di contemperamento
degli opposti interessi»: dunque, dall’angolo visuale dell’interpretazione del contratto, come
strumento che attribuisca al giudice il compito
di operare nell’ottica dell’equilibrio tra gli interessi dei contraenti ( 17 ), dopo avere – contrad-
( 13 ) Si vedano le fondamentali considerazioni di
Castronovo, Un contratto per l’Europa, in Principi
di diritto europeo dei contratti, I e II, a cura di Castronovo, Giuffrè, 2001, XXXIII ss., nonché,
Vettori, Buona fede e diritto europeo dei contratti,
in Eur. e dir. priv., 2002, 915 ss.
( 14 ) Così, testualmente, Castronovo, op. ult.
cit., XL.
( 15 ) È, ancora una volta, il pensiero di Castronovo, op. ult. cit., XLI.
( 16 ) Si veda, se si vuole, quanto osservavamo, con
riferimento al problema dell’interpretazione secondo buona fede, nel nostro Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti, Cedam, 1992, 364 s.:
«il criterio di buona fede consente di svolgere tutte
le conseguenze implicite – sulla base del più volte riferito criterio di normalità e regolarità sociali – nel
regolamento negoziale posto in essere: quelle che,
sebbene non esplicitate nell’assetto di interessi quale
delineato dai contraenti, sono coessenziali, per così
dire, alla natura di esso, così come concretamente
emerge»: sul punto si avrà modo di ritornare, infra,
in sede di critica agli orientamenti dottrinali in materia di interpretazione del contratto, che sembrano
costituire il referente argomentativo della ricostruzione del problema accreditata dalla Supr. Corte.
( 17 ) Sul punto, la sentenza richiama Cass., sez.
un., 15.11.2007, n. 23726, in questa Rivista, 2008, I,
458 ss., con note di Finessi, La frazionabilità (in giudizio) del credito: il nuovo intervento delle Sezioni
Unite, nonché con nota di Cossignani, Credito unitario, unica azione; il richiamo appare, tuttavia, non
del tutto pertinente rispetto al tema dell’interpretazione del contratto, dato che la sentenza delle sez.
un., peraltro a sua volta formulando un obiter, aveva
bensì posto l’accento sull’idoneità del criterio della
buona fede a costituire «strumento per il giudice, atto a controllare anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del
giusto equilibrio degli opposti interessi», ma senza
uno specifico riferimento al piano dell’interpretazione e richiamando precedenti (quali quelli di Cass.,
nn. 3775/1994 e 10511/1999), che si attestavano sul
versante dell’esecuzione del contratto.
NGCC 2010 - Parte seconda
143
Discussioni
dittoriamente – posto l’accento sul ruolo primario, e tendenzialmente preclusivo di altri significati ascrivibili al contratto, che assumerebbe invece la regola interpretativa fondata sulla
lettera della convenzione.
Del resto, anche una prima linea ricostruttiva alternativa sviluppatasi sul punto della ricostruzione della portata operativa del concetto
di buona fede all’interno dei modelli di regolamentazione di diritto privato europeo dei contratti, e che continua ad attribuire alla buona
fede la tradizionale funzione di etero-integrazione, paventando che la stessa, difettando
adeguati referenti ordinamentali, possa costituire la valvola attraverso la quale inserire nel
regolamento predisposto dalle parti standards
mercantili, «ossia il prezzo, l’equilibrio ottenibile in un mercato comparabile... ma perfettamente concorrenziale», tanto che «a tenere il
luogo della legge tra le parti, invece della volontà, è così la prassi mercantile» e perciò «la
“giustizia”, la “morale”, che sono chiamate a
sorreggere tale correzione consistono nel rendere inderogabile il mercato» ( 18 ).
Né pare che il modello operativo della clausola generale di buona fede in sede ermeneutica, sotteso alla sentenza della Supr. Corte
qui oggetto di esame, possa rinvenire un referente argomentativo più affidante nella posizione di chi, anche di recente, proprio con riferimento alla dimensione assunta dalla buona
fede nel diritto privato europeo dei contratti,
ha ritenuto «più corretto adottare una linea
ricostruttiva che veda nella buona fede un
tramite per una più accentuata tutela delle
parti nel senso di mantenere il regolamento
contrattuale in sintonia con le posizioni ed i
comportamenti concreti delle parti, con i
principi ai quali l’ordine giuridico lega la legittimità stessa dell’agire privato», sottolineando che «proprio le nuove fortune del
( 18 ) La ricostruzione cui si fa cenno nel testo è
quella di Barcellona, La buona fede e il controllo
giudiziale del contratto, in Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, a cura di Mazzamuto,
Giappichelli, 2002, 324 s. (dal quale sono tratti i
brani tra virgolette nel testo) nonché Id., Clausole
generali e giustizia contrattuale, Giappichelli, 2006,
257 ss.; sul punto, si veda anche Id., Note minime,
cit., 53.
144
contratto, l’accresciuto suo peso economico e
sociale, ne precludono una lettura chiusa,
quasi che le parti, rinserrandosi nei suoi confini, potessero negare la loro appartenenza al
mondo» ( 19 ). Qui, infatti, ci troviamo pur
sempre, e nel solco della ben nota impostazione data dal medesimo Autore cui si è appena
fatto riferimento al tema della costruzione del
regolamento contrattuale ( 20 ), sul piano della
individuazione delle fonti che concorrono alla
composizione del medesimo e non ancora su
quello di una riscrittura o correzione del punto di equilibrio dei contrapposti interessi, così
come fissato dalle parti contraenti.
Il discorso sugli elementi di riflessione che
emergono dal diritto privato europeo dei contratti, e dal ruolo che la clausola generale di
buona fede assume all’interno di essi, con specifico riferimento all’angolo visuale dell’interpretazione del contratto, non è destinato a mutare neppure ove si consideri il frutto più recente dei progetti intervenuti in materia: e cioè
i Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law ( 21 ). In essi, infatti, e pur
nel contesto di un’ampia attenzione dedicata
alla justice, la declinazione di questo valore (attraverso le direttive della parità di trattamento;
della preclusione a trarre vantaggio da proprie
condotte illegittime, disoneste o irragionevoli
ovvero da situazioni di debolezza particolare
dell’altra parte; della preclusione a pretese eccessive, fondate sull’inadempimento altrui, in
caso di mutamento di circostanze; dell’affermazione della responsabilità dei soggetti per le
conseguenze delle proprie azioni e della creazione dei rischi da parte loro) ( 22 ) non si spinge
fino ad attribuire ai criteri che presiedono al-
( 19 ) In questi termini, Rodotà, Le clausole generali nel tempo del diritto flessibile, in Lezioni sul contratto, raccolte da Orestano, Giappichelli, 2009,
101; in questa prospettiva, l’a. conclude nel senso
che «il diritto contrattuale europeo deve tener conto
dell’assiologia espressa dalla Carta, in particolare,
dei principi di dignità, eguaglianza e solidarietà, non
menzionati nei precedenti Trattati».
( 20 ) Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Giuffrè, 1969, ora ristampato, con integrazioni,
Giuffrè, 2004.
( 21 ) Vedine l’edizione del 2009.
( 22 ) Così l’apparato di commento che si legge in
NGCC 2010 - Parte seconda
Abuso del diritto
l’interpretazione del contratto la funzione di rimodellare il regolamento negoziale, sulla base
di criteri eteronomi ad esso. E tale conclusione
è confermata dal rilievo che l’art. II.-8:103, in
tema di interpretazione contro la parte che ha
predisposto la clausola o contro la parte sotto
la cui influenza dominante sia stata predisposta
la clausola, non abbandona l’impostazione secondo la quale soltanto in caso di dubbio sull’interpretazione di quella clausola sarà possibile privilegiare l’interpretazione della clausola
contra stipulatorem: ma qui non si tratta di attribuire all’interpretazione una funzione correttiva o di riequilibrio delle posizioni delle
parti, bensì, e semplicemente, di selezionare
uno dei possibili significati che alla clausola è
stato possibile assegnare sulla base degli altri
criteri ermeneutici.
3. Sarebbe tuttavia errato ritenere che la posizione assunta dalla Corte di cassazione sulla
funzione dell’interpretazione del contratto secondo buona fede sia del tutto stravagante o
priva di antecedenti culturali, che, tutt’al contrario, lo studioso attento ai temi dell’interpretazione del contratto non ha difficoltà ad individuare.
Vi è stata invero una lunga stagione, nell’ambito della riflessione sulla interpretazione del
contratto, durante la quale si è ritenuto di poter attribuire al procedimento ermeneutico, e
segnatamente a quello condotto sulla base del
canone di buona fede, una funzione affatto diversa rispetto a quella che gli era tradizionalmente assegnata.
È nota, in particolare, la proposta di chi ha
spostato lo specifico ambito di operatività del
canone di buona fede nel momento finale dell’attività ermeneutica, reputando possibile operare, attraverso di esso, una valutazione complessiva di rilevanza del negozio, con l’attribuzione al medesimo del significato che si impone avuto riguardo alla posizione delle parti, nel
quadro dei principi generali dell’ordinamento
giuridico ( 23 ).
Principles, Definitions and Model Rules of European
Private Law, cit., 84.
( 23 ) Cfr. Bigliazzi Geri, Note in tema di interpretazione secondo buona fede, Pacini, 1970, passim,
NGCC 2010 - Parte seconda
Si colloca in una prospettiva analoga anche il
contributo di chi ( 24 ) ha ritenuto che – attraverso l’art. 1366 cod. civ. – sarebbe possibile
attribuire rilievo in sede interpretativa ai principi generali dell’ordinamento, avuto altresì riguardo alle peculiari circostanze in cui il contratto si inserisce; così inteso, l’art. 1366 cod.
civ. consentirebbe di individuare quale tra gli
interessi dei contraenti debba essere ritenuto
preminente e di risolvere altresì il problema
della prospettiva nella quale si debba collocare
l’interprete nel prendere in esame il contratto
alla luce della disciplina dettata per il singolo
contratto e dei principi generali dell’ordinamento ( 25 ).
Il referente culturale più prossimo della lettura che la sentenza della Supr. Corte offre
quanto al tema dell’interpretazione del contratto secondo buona fede è peraltro quella che
emerge dall’impostazione ( 26 ) che pone l’accento sull’attitudine della buona fede interpretativa ad intervenire in tutti i casi in cui l’applicazione del primo gruppo di norme interpretative abbia portato all’individuazione «di un ree, in particolare, 46 s.; Id., voce «Buona fede nel diritto civile», nel Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ.,
II, Utet, 1988, 179 s.; Id., L’interpretazione del contratto, Giuffrè, 1991, 208 s.
( 24 ) È la posizione di Rizzo, Interpretazione dei
contratti e relatività delle sue regole, Esi, 1985, 293 s.
e, in particolare, 295, dove si sottolinea che l’art.
1366 cod. civ., considerato unitariamente all’art.
1362 cod. civ., indurrebbe ad attribuire rilevanza ad
una complessiva disciplina, ben armonizzata con i
principi fondamentali dell’ordinamento.
( 25 ) Per tale conclusione, cfr. Rizzo, cit., 299 s.
( 26 ) Cfr., sul punto, Costanza, Profili dell’interpretazione del contratto secondo buona fede, Giuffrè,
1989, 35 ss. Tale tesi si correla, all’evidenza, con
quella accreditata dalla medesima a. con riferimento
al tema dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali
(Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, in Contr. e impr., 1987, 432 s., in particolare,
433, dove si conclude che «al di fuori delle ipotesi
specificamente previste e disciplinate la realizzazione dell’equilibrio contrattuale rimane affidata alla
buona fede ed all’equità»; la differenza tra questi
due criteri consisterebbe, poi, in ciò che la buona fede servirebbe a modellare il contenuto negoziale secondo i canoni della correttezza e della lealtà, mentre l’equità sarebbe volta alla determinazione della
giustizia singolare).
145
Discussioni
golamento contrattuale poco equilibrato e non
giustificato dalle circostanze soggettive ed oggettive che lo accompagnano», dato che, in
questi casi, si potrebbe reputare permanere
uno stato di incertezza sul significato del contratto, superabile, appunto, attraverso l’utilizzazione del canone della buona fede e, all’occorrenza, dei successivi criteri ermeneutici. In
tale ordine di idee, la clausola di buona fede
conserverebbe, anche in sede interpretativa, la
sua peculiare attitudine a correggere le storture
del regolamento contrattuale, pur affermandosi, con un vistoso scarto di piani rispetto all’impostazione fin qui illustrata, che la buona fede
potrebbe venire anche in considerazione come
uno strumento utile per stabilire quali siano gli
interessi perseguiti col singolo, concreto contratto ovvero per cogliere le variabili individuali del contratto stesso ( 27 ).
È tuttavia possibile obiettare, a queste ricostruzioni, così come a quella accreditata dalla
sentenza oggetto delle nostre riflessioni, che il
criterio della buona fede in sede interpretativa è
quello che consente di svolgere tutte le conseguenze implicite – sulla base del più volte riferito criterio di normalità e regolarità sociali – nel
regolamento negoziale posto in essere: quelle,
cioè, che, sebbene non esplicitate, nell’assetto di
interessi, quale delineato dai contraenti, sono
coessenziali, per così dire, alla natura di esso, così come concretamente emerge. Pertanto, la specifica funzione del procedimento ermeneutico si
coglie, pur sempre, nella ricostruzione della portata della regola privata, ora attraverso schemi attenti alla concretezza ed individualità della stessa, ora per mezzo di schemi da essa più remoti,
direttamente fissati dalla norma ovvero mutuati
da standards sociali; mentre deve ritenersi ad esso tuttora estranea la funzione di adeguamento
del contratto a principi o regole eteronomi ovvero di verifica della congruità reciproca delle attribuzioni patrimoniali da realizzare con il contratto ( 28 ).
Se le argomentazioni fin qui svolte colgono nel
( 27 ) Così Costanza, Profili, cit., 130 e 133.
( 28 ) Si tratta dei risultati cui eravamo pervenuti in
L’interpretazione, in I contratti in generale, a cura di
E. Gabrielli, Utet, 2006, II, 1083 ss.: rinviamo a
quel luogo per la più ampia illustrazione dei passaggi argomentativi che conducono alla conclusione
146
segno, si conferma che il procedimento ermeneutico, anche se riferito all’area del contratto
asimmetrico o diseguale, resta strutturalmente
incompatibile, ed ontologicamente inidoneo, ad
espletare un’ipotetica funzione di controllo circa
i contenuti dell’atto di autonomia privata ovvero
di riequilibrio delle posizioni dei contraenti: funzione che resta assai più solidamente affidata agli
obblighi di informazione o alle regole di comportamento che costellano la fase di formazione
del vincolo contrattuale.
Dal canto suo, intesa nel senso fin qui tratteggiato, la buona fede si libera finalmente dai
contorni incerti, se non nebulosi, che ne avevano per lo più caratterizzato l’utilizzazione, soprattutto in materia ermeneutica, per innestarsi sul solido terreno dei criteri di ragionevolezza desunti dalla realtà dei traffici.
Qui si innesta un ultimo spunto di riflessione
circa i contenuti della sentenza, che, rileggendo criticamente gli snodi motivazionali della
sentenza d’appello, sembra ammettere, sia pure per implicito, un controllo di ragionevolezza
degli atti di autonomia privata.
Tuttavia, se si può convenire sul punto che,
dall’angolo visuale del requisito della causa del
contratto, il giudice è chiamato ad espletare un
controllo su quella che, in altra occasione, avevamo definito la razionalità minima dell’operazione economica sottesa al contratto, e, dunque, in particolare, dall’angolo visuale della
giustificazione delle vicende circolatorie della
ricchezza attuate attraverso l’operazione contrattuale ( 29 ), va pur sempre sottolineato che tale controllo si colloca pur sempre, ed appunto,
sul piano della razionalità minima dell’operazione economia realizzata e non può spingersi
fino a sindacarne, nel merito, la ragionevolezza.
Né tale esito deve apparire incompatibile
con le istanze di tutela che l’area della contrattazione disuguale sempre più palesa: tanto più
che, secondo quanto ormai da tempo è stato
chiarito in dottrina, il controllo sugli atti di ausintetizzata nel testo, che pare per molti versi affine
a quella, da ultimo, accreditata da Cataudella, I
contratti, Giappichelli, 2009, 159.
( 29 ) Ci si permetta il rinvio al nostro I problemi
della causa e del tipo, in Roppo, Trattato del contratto, II - Regolamento, a cura di Vettori, Giuffrè,
2006, 115 ss.
NGCC 2010 - Parte seconda
Abuso del diritto
tonomia privata e la stessa protezione della
parte che si trovi in posizione asimmetrica rispetto all’altra nella contrattazione diseguale si
realizza ormai sempre più sul versante del controllo contenutistico, come accade nella disciplina delle clausole abusive, ovvero dell’attribuzione ai contraenti di diritti e doveri accessori, quali quelli di recesso o di informazione;
NGCC 2010 - Parte seconda
mentre resta, come si è già visto, estranea anche ai progetti di diritto privato europeo l’idea
di una torsione dello strumento interpretativo
al raggiungimento di finalità di controllo degli
atti di autonomia privata, davvero incongruamente evocata dalla sentenza della Corte di
cassazione.
147
IL GIUDICE RISCRIVE IL CONTRATTO PER LE PARTI:
L’AUTONOMIA NEGOZIALE STRETTA TRA GIUSTIZIA,
BUONA FEDE E ABUSO DEL DIRITTO
di Filippo Viglione
Sommario: 1. Interpretare o riscrivere il contratto?
– 2. Interpretazione del contratto e abuso del diritto. – 3. Le antinomie nella costruzione giurisprudenziale del contratto e della sua ermeneutica. – 4. Quale ruolo per l’abuso del diritto tra regole di validità e di responsabilità? – 5. L’illegittima commistione tra piani diversi: abuso del diritto e interpretazione del contratto nella prospettiva comparatistica.
1. Interpretare o riscrivere il contratto? Con alcune recenti pronunce la Corte
di cassazione rafforza la linea interpretativa
che tende a valorizzare il ruolo della buona fede nel contratto, in ogni fase del rapporto contrattuale, giungendo a definirla come uno strumento finalizzato al controllo, anche in senso
modificativo o integrativo, dello statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. Sulla base di tale
premessa, si è così ritenuto sussistente il diritto
alla provvigione del mediatore derivante dalla
stipula di un contratto preliminare rimasto inadempiuto tra le parti, pur in presenza di una
clausola contrattuale che espressamente escludeva la provvigione in caso di mancata vendita
( 1 ); nella medesima prospettiva, la Supr. Corte
ha rilevato come l’esercizio di un diritto di recesso, previsto in un contratto di concessione
di vendita, possa in concreto delineare un’ipotesi di abuso del diritto e, come tale, sia suscettibile di essere considerato illegittimo ( 2 ). Entrambe le ipotesi descritte paiono accomunate
dalla circostanza che il titolare di un diritto
soggettivo, riconosciuto per legge o per contratto, esercita tale diritto cercando di perseguire finalità considerate non meritevoli di tu( 1 ) Cass., 5.3.2009, n. 5348, in Mass. Giust. civ.,
2009.
( 2 ) Cass., 18.9.2009, n. 20106, pubblicata supra,
I, 239.
148
tela da parte dell’ordinamento ( 3 ). Di fronte a
tali orientamenti, si pone tra gli altri l’interrogativo se ed in quale misura essi incidano sull’autonomia negoziale, a vantaggio di un più
penetrante intervento giudiziale a fini riequilibrativi del contenuto anche economico del
contratto, intervento ispirato in ultima analisi
ad un ideale di giustizia contrattuale.
La Corte di cassazione, in realtà, non utilizza
nelle richiamate decisioni il termine «giustizia
contrattuale», invalso nell’uso dottrinale ma
evidentemente reputato troppo diretto da parte dei giudici, e preferisce agganciare il ruolo
della buona fede agli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall’art. 2 Cost.; in tale
prospettiva, si rafforza l’idea del contratto quale luogo di incontro della volontà delle parti, le
quali debbono agire in modo tale da preservare
gli interessi anche della controparte, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da
singole norme di legge. Il ragionamento della
Cassazione conferma quanto va delineandosi
da tempo nell’intero sistema giuridico italiano,
nel quale i giuristi «sembrano occuparsi sempre meno di regole, e sempre più di princìpi o
valori» ( 4 ); e tra quest’ultimi, il principio di
buona fede appare certamente il più idoneo a
giustificare forme di creatività giurisprudenziale in ambito contrattuale. Non vi è dubbio che
la buona fede sia nel contempo principio che
informa il diritto dei contratti e regola positiva,
che compare ripetutamente nelle disposizioni
codicistiche e che peraltro trova ampi spazi anche nei progetti di codificazione europea. Oc( 3 ) Nello stesso senso, si colloca anche Cass., sez.
un., 15.11.2007, n. 23726, in questa Rivista, 2008, I,
4589, ove viene negata la frazionabilità in giudizio di
un credito unitario.
( 4 ) Barberis, Etica per giuristi, Laterza, 2006,
IX.
NGCC 2010 - Parte seconda
Abuso del diritto
corre, tuttavia, verificare se il richiamo alla
clausola generale della buona fede sia sempre
svolto in maniera rigorosa dalle corti o non ne
vengano piuttosto forzati i confini riempiendo
detta regola di un contenuto che non le è proprio.
Ci si limita, in questa sede, a porre l’attenzione sul richiamo all’interpretazione secondo
buona fede, che ad avviso della Cassazione si
connette ad un obiettivo di perseguimento dell’equilibrio tra gli opposti interessi dei contraenti, prospettato nella recente decisione in
tema di abuso del diritto (Cass., n. 20106/
2009); i giudici della Supr. Corte hanno censurato la decisione della Corte d’appello di Roma
(sent. 13.1.2005) rilevando come quest’ultima
«avrebbe dovuto valutare ed interpretare le clausole del contratto – in particolare quella che prevedeva il recesso ad nutum – anche al fine di riconoscere l’eventuale diritto al risarcimento del
danno per l’esercizio di tale facoltà in modo non
conforme alla correttezza ed alla buona fede». In
questo modo, tuttavia, sembra evidente una
commistione tra il piano dell’interpretazione e
quello dell’esecuzione del contratto, confondendosi la ricerca della volontà dei contraenti
con la valutazione di correttezza del comportamento in executivis. Non si comprende, infatti,
quale rilievo autonomo possa avere la clausola
di buona fede nell’interpretazione del contratto, laddove venga utilizzata per censurare
l’esercizio di una facoltà attribuita espressamente dal contratto stesso ma posta in essere
in modo non conforme a correttezza e buona
fede. In sostanza, così ragionando, le disposizioni contenute negli artt. 1366 e 1375 cod. civ.
rappresenterebbero una inutile duplicazione,
coprendo la medesima area di operatività.
Del resto, ritenere che l’interpretazione secondo buona fede debba tendere al contemperamento degli opposti interessi dei contraenti,
così come afferma la Cassazione, appare altresì
in contrasto con quanto dispone l’art. 1371
cod. civ., ove si prevede «l’equo contemperamento degli interessi delle parti» quale regola
finale di interpretazione valida per i contratti a
titolo oneroso da applicarsi quando il contratto, nonostante l’applicazione di tutte le norme
contenute nel capo IV del titolo II, compreso
dunque l’art. 1366 cod. civ., rimanga comunque di significato oscuro. Anche in questo caNGCC 2010 - Parte seconda
so, una lettura sistematica delle norme codicistiche avrebbe aiutato a comprendere che l’interpretazione secondo buona fede non può essere deputata ad una riscrittura del contratto
che lo renda più equilibrato, e ad essa va pertanto assegnata una differente funzione.
2. Interpretazione del contratto e
abuso del diritto. Nel tracciare i rapporti
tra abuso del diritto e dovere di buona fede, la
Corte di cassazione chiama in causa il concetto
di «criterio rivelatore», mostrando di aderire
alla tesi per cui l’abuso del diritto rappresenterebbe una figura sintomatica della violazione
del dovere di buona fede. Tale assunto rende
necessaria una riflessione in ordine al ruolo che
viene così consegnato al giudice nella valutazione del regolamento contrattuale predisposto dai contraenti nonché delle condotte poste
in essere in esecuzione del contratto. Al riguardo, il richiamo alla necessità di interpretare il
contratto secondo buona fede, in funzione di
equilibrio degli interessi delle parti, sembra offrire una diversa prospettiva per comprendere
appieno l’orientamento della Supr. Corte.
Infatti, ove si acceda all’idea che l’esercizio
del recesso previsto nel contratto rappresenti
una condotta abusiva, idea che discende dall’interpretazione del contratto stesso in funzione riequilibrativa, pare lecito dedurre che la
fattispecie concreta non corrisponda ad un atto di esercizio del modello applicabile, posto
che ragioni di coerenza o, meglio, di opportunità, indurrebbero l’interprete a restringere
l’area delle facoltà esercitabili dal recedente. In
tal modo, l’attività ermeneutica, che correttamente viene deputata alla delimitazione della
sfera di applicazione del diritto, si riempie di
un potere che con tutta evidenza rischia di
comprimere, in chiave paternalista, l’esercizio
degli atti di autonomia privata.
Anche laddove si volesse acconsentire ad
una simile eterogenesi dei fini dell’attività interpretativa, rimane aperto il dubbio circa
l’utilità del concetto stesso di abuso del diritto
così inteso. Appare intimamente contradditorio sostenere, infatti, che l’esercizio di una facoltà riconosciuta all’autonomia contrattuale
possa operare in chiave elusiva dei principi
espressione dei canoni generali di buona fede,
lealtà e correttezza e nel contempo far leva sui
149
Discussioni
criteri di interpretazione del contratto, ed in
particolare sull’art. 1366 cod. civ., proprio al
fine di escludere che la condotta abusiva rientri nel novero delle possibilità offerte dal testo
contrattuale. Così ragionando, dunque, si corre il rischio che l’interpretazione del contratto
non sia destinata alla ricerca della volontà dei
contraenti e nemmeno alla ricerca del significato oggettivamente ritraibile dal testo contrattuale, degenerando in una attribuzione di senso discrezionale ed, in buona misura, imprevedibile ad opera del giudice, il che naturalmente
compromette valori di certezza e affidamento
su cui si reggono le relazioni contrattuali.
Sulla base di tali rilievi, la tesi secondo cui
l’abuso del diritto rappresenterebbe un momento di emersione della violazione del dovere
di buona fede deve essere analizzata in una diversa luce. L’interpretazione del contratto potrebbe infatti essere chiamata a segnalare la
presenza di un abuso del diritto proprio in una
prospettiva capovolta, che non vede realizzarsi
l’abuso quando la condotta sia posta in essere
in modo difforme dal diritto interpretato secondo buona fede. Ed anzi, proprio la coincidenza tra esercizio concreto del diritto e astratto modello applicabile rappresenta una premessa della possibile deviazione dell’esercizio
del diritto in chiave elusiva della buona fede
nell’esecuzione del contratto. Solo questa costruzione consente di porre le basi per un discorso razionale sul concetto di abuso, che la
dottrina ha da tempo indagato e ricostruito sovente nei termini di una condotta eccedente
l’interesse tipico previsto da una norma o da
un regolamento di interessi contrattuale.
Sennonché, superato l’ostacolo ermeneutico,
la strada dell’abuso del diritto non è certo in
discesa. Occorre, infatti, rinvenire una giustificazione alla tesi per cui una condotta formalmente conforme al modello, sul quale le parti
fanno legittimo affidamento, sia suscettibile di
essere sanzionata in termini di invalidità dell’atto posto in essere in esecuzione del diritto
previsto o di risarcimento dei danni conseguente alla condotta conforme ma abusiva. E
tale fondamento non può certamente rinvenirsi
nel regolamento contrattuale disegnato dalle
parti, proprio in quanto esso è piuttosto destinato a legittimare la condotta abusiva; la sua rilevanza sembra cadere, allora, inevitabilmente
150
nell’area dell’illiceità, il cui giudizio non può
che legarsi ad un fatto doloso o colposo, che
ben può essere integrato dall’esercizio deviante
ammesso nel regolamento contrattuale, senza
che rilevi alcuno schema possibile interno all’assetto di interessi divisato dai contraenti ( 5 ).
3. Le antinomie nella costruzione
giurisprudenziale del contratto e della
sua ermeneutica. Non vi è dubbio che il
concetto di buona fede ha nel tempo mostrato
la propria idoneità a realizzare forme articolate di recezione dei valori all’interno dell’ordinamento; in tale prospettiva è stato ampiamente indagato dalla dottrina, ha trovato ambiti applicativi variegati in giurisprudenza ed
oggi vive pure la consacrazione a livello legislativo nei progetti di armonizzazione del diritto europeo dei contratti. Tuttavia, occorre
guardare con attenzione alle possibili implicazioni di sistema in un utilizzo disinvolto delle
clausole generali, in grado talora di sovvertire
surrettiziamente anche consolidati orientamenti, a volte in modo inconsapevole, e che in
ipotesi può condurre anche a contraddire feconde intuizioni applicative. Si fa riferimento
in particolare alle contraddizioni, che la sentenza su recesso e abuso del diritto solleva, rispetto ad un orientamento in tema di interpretazione secondo buona fede e rispetto alle
equilibrate decisioni che la Supr. Corte ha
adottato sulla buona fede nella fase precontrattuale, nell’ipotesi di violazione degli obblighi informativi nei contratti di investimento.
Vale la pena di ricordare, al riguardo, come la
Corte di cassazione abbia accolto e consolidato un modello di interpretazione del contratto
nel quale il criterio di cui all’art. 1366 cod.
civ. assume un ruolo meramente sussidiario,
destinato ad operare solo nell’ipotesi in cui le
regole di interpretazione soggettiva non con( 5 ) Come chiarisce Sacco, L’esercizio e l’abuso
del diritto, in Il diritto soggettivo, nel Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Utet, 2001, 348, una
ipotetica regola di responsabilità fondata su intenzionalità o contrarietà ai buoni costumi sarebbe indipendente dall’esercizio del diritto e «quest’ultimo,
e la conseguente qualificazione dell’atto in questione come abuso del diritto, sarebbero superflui ai fini
della configurazione della responsabilità».
NGCC 2010 - Parte seconda
Abuso del diritto
sentano il riconoscimento di un significato
certo delle clausole contrattuali. Le ragioni
per le quali le nostre corti, sia pure in modo
non univoco ( 6 ), si sono attestate su quest’ordine di posizioni, chiaramente di retroguardia,
sono molteplici, e vanno ricondotte in ultima
analisi alla convinzione che la buona fede operi quale criterio di interpretazione oggettivo,
appartenente al secondo blocco delle regole
interpretative (quello corrispondente agli artt.
1366-1371 cod. civ.), chiamate a funzionare
nel solo caso in cui non sia stato possibile ricostruire la volontà dei contraenti sulla base
dei criteri soggettivi d’interpretazione, e dunque per la mancata chiarezza o completezza
delle loro dichiarazioni. Contro le esplicite indicazioni della Relazione al Codice Civile, che
al riguardo parla come noto di «punto di sutura» tra i due momenti del procedimento ermeneutico, la giurisprudenza ha privilegiato
un approccio che, sulla base di una malintesa
esigenza di rispettare l’autonomia e la volontà
delle parti, ha finito per relegare l’interpretazione secondo buona fede ad un ruolo del tutto marginale.
Addirittura, recentemente ( 7 ) si è giunti ad
affermare che il principio gerarchico che connota i nostri canoni ermeneutici sia così rigoroso da far arrestare l’iter interpretativo ogni volta in cui il giudice di merito ritenga chiaro il
dato letterale, con una affermata autosufficien-
za dell’art. 1362, comma 1o, cod. civ. In questa
prospettiva, è sufficiente che il senso letterale
delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli chiaramente una volontà comune, per ritenere utilmente compiuta l’intera operazione
ermeneutica. In questo modo non soltanto viene consolidato il primato del criterio letterale
di interpretazione, già ripetutamente celebrato
dalla nostra Cassazione, ma viene condotto alle
estreme conseguenze il tradizionale principio
in claris non fit interpretatio. Nella prospettata
visione, l’autosufficienza dell’interpretazione
letterale comporta il carattere meramente sussidiario di tutti gli altri canoni di interpretazione, mentre l’orientamento tradizionale considerava sussidiari solamente i criteri di interpretazione cd. oggettiva (artt. 1366-1371 cod.
civ.), circostanza quest’ultima idonea a consentire il permanere di un momento di globalità
perlomeno nella fase di interpretazione cd.
soggettiva ( 8 ). Addirittura, la Cassazione delinea un ordine gerarchico al quale sottopone le
norme contemplate nello stesso art. 1362 cod.
civ., così da considerare necessaria la valutazione del comportamento complessivo delle parti
al fine di determinare la comune intenzione,
solo quando non si presenti chiaro ed inequivoco il dato testuale, così facendo emergere un
orientamento pur presente sotterraneamente
nelle decisioni precedenti, ma nettamente avversato dalla prevalente dottrina ( 9 ).
( 6 ) È infatti presente un indirizzo giurisprudenziale, fino ad ora minoritario, che ha affidato all’art.
1366 cod. civ. il ruolo di norma non sussidiaria d’interpretazione, così manifestando la preferenza per
un principio di globalità nell’applicazione delle regole ermeneutiche. Per un esempio di tale orientamento, si veda Cass., 25.1.2000, n. 805, in Rep. Foro
it., 2000, voce «Contratto in genere», 462, 871. Più
incisiva Cass., 17.2.2004, n. 2992, in Dir. e giust.,
2004, 13, 34, citata anche da Galgano, Libertà contrattuale e giustizia del contratto, in Contr. e impr.
Eur., 2005, 509, secondo la quale l’interpretazione
secondo buona fede dovrebbe trovare spazio «anche
quando l’interpretazione delle clausole che concorrono alla formazione del testo negoziale, compiuta sulla
base del senso letterale delle parole, conduca a risultati di certezza».
( 7 ) Si tratta di Cass., 12.6.2007, n. 13777, in questa Rivista, 2008, I, 106, con nota di Teti, Gerarchia
dei mezzi ermeneutici e in claris non fit interpretatio.
( 8 ) L’impostazione della Cassazione, dalla quale
traspare un richiamo all’ordine gerarchico delle regole di interpretazione prospettato da Cesare Grassetti, viene così in parte contraddetto dalla primazia
riconosciuta al solo criterio di cui all’art. 1362, comma 1o, cod. civ., rispetto a tutti gli altri criteri, salva
una «deroga» per l’art. 1363 cod. civ. che contempla
l’interpretazione complessiva delle clausole.
( 9 ) Tra i molti che esprimono un giudizio negativo sull’applicazione del brocardo in claris non fit interpretatio, si ricordano Betti, Teoria generale del
negozio giuridico, 2a ed., rist. 1960, Utet, 333; Bigliazzi Geri, L’interpretazione del contratto, nel
Commentario Schlesinger, Giuffrè, 1991, sub art.
1362 cod. civ., 94 ss.; Irti, Testo e contesto. Una lettura dell’art. 1362 cod. civ., Cedam, 1996, 65; Carresi, Dell’interpretazione del contratto (art. 13621371), nel Commentario Scialoja-Branca, ZanichelliForo it., 1992, 61 ss. Contrario al rapporto di sussidiarietà tra l’art. 1362, comma 1o, cod. civ., e tutti
NGCC 2010 - Parte seconda
151
Discussioni
Se è vero che tale posizione rappresenta un
indice di residua resistenza al cambiamento
( 10 ), il capovolgimento di prospettiva operato
oggi dalla Supr. Corte rischia di sovvertire anche quel che di buono c’era in tal orientamento. Infatti, nella sent. n. 20106/2009 l’interpretazione secondo buona fede non solo pare destinata a trovare rilievo nonostante il chiaro tenore della lettera del contratto, ma diviene
strumento utile a modificare il senso tratto dal
criterio letterale di ermeneutica contrattuale.
Non soltanto, dunque, si sovverte una posizione consolidata di criticabile ancoraggio al criterio testuale, ma la si ripudia in nome della ricerca di un equilibrio tra gli interessi dei contraenti, cui non dovrebbe essere deputato il
procedimento ermeneutico, volto semmai ad
individuare l’assetto degli interessi delineato
dai contraenti.
In questo senso, è la stessa nozione di abuso
del diritto a svelare la propria intima contraddittorietà o, quantomeno, la propria improduttività. L’interpretazione secondo buona fede
consente, infatti, di scegliere, tra più significati
possibili delle clausole contrattuali, quello che
meglio realizza l’equilibrato assetto degli interessi dei contraenti, ma sempre nella cornice
delle alternative offerte dall’inevitabile polisemia delle espressioni utilizzate dalle parti; ciò
consente di ancorare il parametro della buona
fede interpretativa ad uno standard di certezza
idoneo a tutelare le aspettative che ciascun
contraente può riporre sul contratto e la sua efficacia, senza cedere a logiche manipolative del
contratto medesimo. Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, in particolare, non è
certo fuori luogo sostenere la necessità di
un’interpretazione secondo buona fede, ed anche, al limite, ipotizzare che il procedimento
ermeneutico possa condurre ad intendere l’attribuzione del recesso come subordinata ad
una sua procedimentalizzazione, ad esempio
attraverso il riconoscimento di indennità; tutgli altri criteri ermeneutici è anche Grassetti, L’interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti, Cedam, 1938 (rist. 1983), 227.
( 10 ) Alpa, I Principi Unidroit 2004 e i Principi di
diritto europeo dei contratti, in Giustizia sociale e
mercato nel diritto europeo dei contratti, a cura di
Somma, Giappichelli, 2007, 37 s.
152
tavia, un simile ragionamento, operato dalla
Supr. Corte, non conduce affatto alla emersione di un abuso del diritto, essendo quest’ultimo caratterizzato da un formale rispetto del
contenuto contrattuale attuato con modalità e
per il perseguimento di fini diversi rispetto a
quelli consentiti, il che presuppone una compiuta attività interpretativa il cui esito fosse
formalmente conforme alla condotta delle parti.
Se l’obiettivo emerso nella sentenza qui esaminata è quello, apprezzabile, di arricchire il
tessuto contrattuale con la trama della solidarietà tra i contraenti, non pare adeguata la logica rimediale di correzione contrattuale operata
chiamando in causa, tra l’altro, l’attività interpretativa; la costruzione di un assetto di interessi equilibrato, raggiunto in sede giudiziale,
non è di per sé espressione di un attivismo
eversivo della giurisprudenza, e come tale non
va osteggiata da resistenze di matrice formalista, ma deve incanalarsi in un percorso razionale e coerente con la logica del nostro sistema
di diritto dei contratti.
4. Quale ruolo per l’abuso del diritto
tra regole di validità e di responsabilità? La categoria dell’abuso del diritto suggerisce la possibilità di operare un controllo sulle
modalità di svolgimento della condotta delle
parti, al di là dell’osservanza formale della regola, sia essa legislativa o convenzionale. Tale
operazione, nella prospettiva accolta dalla Corte di cassazione, impone una valutazione sull’atto di esercizio del diritto di recesso, che potrebbe apparire illegittimo ove posto in essere
da uno dei contraenti con modalità e per il perseguimento di fini diversi rispetto a quelli consentiti, pur in presenza di una clausola di recesso ad nutum.
Il punto di partenza di tali riflessioni va ricercato nel presupposto che la clausola attributiva del potere di recesso sia pienamente valida, così come sia efficace l’atto che costituisce
attuazione di un simile diritto. La conseguenza, infatti, dell’esercizio del diritto che contrasti con la buona fede può solamente consistere
in una pretesa a carattere risarcitorio o indennitario, non essendo possibile superare la distinzione chiarita in dottrina e recentemente
formalizzata anche dalla giurisprudenza tra reNGCC 2010 - Parte seconda
Abuso del diritto
gole di validità e di responsabilità. In tale prospettiva, la buona fede appare regola di valutazione del comportamento delle parti in sede
esecutiva del contratto, e la sua violazione non
può determinare invalidità o inefficacia ma responsabilità o, al limite, potrebbe porsi quale
causa di risoluzione del contratto per inadempimento.
Richiamando una equilibrata ed opportuna
presa di posizione della Cassazione sul tema
( 11 ), laddove la clausola contrattuale si manifesti in contrasto con una precisa disposizione
normativa, ci si trova «al di fuori di comportamenti afferenti alla fase di conclusione o di esecuzione»; all’opposto, la violazione di regole di
comportamento in fase esecutiva può determinare ragionevolmente una responsabilità per
chi si discosti dal generale dovere di buona fede, ed in tal senso è chiaro che qualsiasi atto
negoziale debba soggiacere ad una duplice valutazione, di validità dell’atto conseguente ad
una sua compiuta interpretazione che manifesti contrasto con le disposizioni normative, e di
ammissibilità dei comportamenti esecutivi alla
stregua di una «valutazione dinamica» che può
in ipotesi sfociare in una pronuncia di responsabilità ( 12 ).
Nel momento in cui, dunque, uno dei contraenti pone fine al rapporto contrattuale esercitando il potere di recesso attribuito dal contratto, è ancora logicamente possibile sostenere
che ciò rappresenti inadempimento del dovere
di buona fede, esponendo il recedente a responsabilità risarcitoria, ma in questo senso
nessun giovamento proviene dalla nozione di
abuso del diritto, che pertanto è inconferente
ove richiamata in connessione all’interpretazione del contratto, ed improduttiva se collegata
al dovere di buona fede in executivis. In altri
termini, il piano della validità della clausola attributiva del diritto di recesso e quello del
comportamento esecutivo non possono che essere nettamente distinti, e solo tale premessa
consente un sindacato giudiziale sulle modalità
( 11 ) Cass., 19.12.2007, n. 26724 e Cass.,
19.12.2007, n. 26725, in questa Rivista, 2008, I, 432,
con nota di Salanitro.
( 12 ) Vettori, Regole di validità e di responsabilità di fronte alle Sezioni Unite. La buona fede come
modello risarcitorio, in Obbl. e contr., 2008, 104 ss.
NGCC 2010 - Parte seconda
di attuazione del recesso; tale circostanza presuppone già concluso il procedimento interpretativo sul contratto, operato anche sulla
scorta del parametro della buona fede, il cui
esito si risolve inevitabilmente in un preliminare giudizio di validità della clausola contrattuale, senza che in tale fase possa avere sviluppo
alcuna tentazione riequilibrativa sul complessivo assetto di interessi dei contraenti.
Sulla scorta di simili considerazioni, dunque, la stessa nozione di abuso del diritto, privata di una sua supposta funzione di riscrittura del regolamento contrattuale, condotta per
il tramite dell’interpretazione secondo buona
fede, non appare destinata a godere di una autonoma funzione operativa, posto che le ipotesi che paiono concretizzarla coincidono con
l’area coperta dalla regola di correttezza nell’esecuzione del contratto, dando così ragione,
almeno per quanto concerne l’abuso del diritto nel contesto contrattuale, alla tesi di chi vi
individua una sovrastruttura aggiuntiva rispetto alla disciplina positiva, inidonea ad apportare significativi contributi operativi concreti
( 13 ). Il suo richiamo nella sent. n. 20106/2009
sembra allora nascondere una sorta di insoddisfazione per non rinvenire una espressa previsione normativa che sanzioni, nella fattispecie concreta, la condotta considerata abusiva,
pur in un panorama legislativo che offre oggi
numerose regole destinate a dare rilievo alla
condotta abusiva delle parti, come nella disciplina sui ritardi nei pagamenti o nella legislazione antitrust sull’abuso di posizione dominante, fino all’ipotesi di abuso di dipendenza
economica.
Mancando tuttavia i presupposti per l’applicazione di specifiche disposizioni normative, la
Corte di cassazione (che esplicitamente lamenta l’impossibilità di una riflessione sull’abuso
di dipendenza economica, non sollevata dai ricorrenti) non sembra avvedersi del carattere
eccezionale di tali disposizioni, le quali disattendono un principio cardine di intangibilità
dello scambio contrattuale. E tale misunder-
( 13 ) In tal senso, Salvi, voce «Abuso del diritto
(diritto civile)», in Enc. giur. Treccani, I, Ed. Enc. it.,
1988, 5. Penetrante, sotto il medesimo profilo, la
critica di Sacco, op. cit., 370.
153
Discussioni
standing si aggrava nella convinzione, assente
in precedenti applicazioni dell’abuso del diritto anche in ambito contrattuale ( 14 ), che non
sia da ricercare una condotta posta in essere al
solo fine di danneggiare la controparte, essendo innegabile che l’esercizio del diritto di recesso in un contratto di durata non può che rispondere ad un concreto interesse del recedente nonché ad un generale principio di temporaneità dei vincoli negoziali.
5. L’illegittima commistione tra piani
diversi: abuso del diritto e interpretazione del contratto nella prospettiva
comparatistica. Al di là del dubbio valore
euristico della nozione di abuso del diritto, pare dunque del tutto inopportuno l’accostamento che viene prospettato nella sent. n. 20106/
2009 con il tema dell’interpretazione secondo
buona fede. Al riguardo, anche alcune brevi riflessioni in chiave comparatistica confermano
la piena estraneità dei due piani del discorso, i
quali non sembrano intrecciarsi nelle riflessioni
dottrinali e nelle applicazioni giurisprudenziali
che correttamente inquadrano l’istituto dell’abuso del diritto.
Se, ad esempio, si prende in considerazione
l’ordinamento francese, in cui la figura dell’abuso del diritto ha conosciuto le prime moderne teorizzazioni, è facile riconoscere come
la giurisprudenza, in assenza di una espressa
previsione normativa, faccia leva unicamente
sull’art. 1134 code civil, che prevede un obbligo per i contraenti di agire secondo buona fede. È ben vero che manca, nella sistematica del
codice francese, una norma corrispondente al
nostro art. 1366 cod. civ. ed è pertanto pressoché inevitabile che l’abuso del diritto venga ancorato ad un fondamento normativo individuato nell’obbligo di buona fede in executivis.
Tuttavia, non viene offerto rilievo ad alcuno
dei canoni ermeneutici codificati, tanto meno
se ne invoca il possibile utilizzo riequilibrativo
dell’assetto di interessi dei contraenti e la funzione latamente correttiva del regolamento
contrattuale è affidata in via esclusiva all’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto
( 14 ) Cass., 16.10.2003, n. 15482, in Foro it., 2004,
I, 1845.
154
( 15 ). Del resto, l’estraneità della fase ermeneutica alla valutazione di abusività del comportamento dei contraenti emerge in modo manifesto ove si considerino gli orientamenti della
Cour de cassation, proprio in casi di recesso da
contratti di durata, in relazione ai quali i giudici escludono la necessità di un controllo sulla
giustificazione causale dell’atto di recesso ove
il diritto di recedere sia espressamente previsto
nel contratto non riconoscendovi così un’ipotesi di abuso del diritto ( 16 ); quest’ultimo ricorre invece nel caso in cui la condotta di una parte dia luogo a manovre fraudolente e disoneste,
il che rende evidente, per la sussistenza dell’abuso del diritto, la necessaria contrarietà del
comportamento di una parte alla buona fede
nell’esecuzione del contratto ( 17 ).
Ancor più significativa è l’esperienza tedesca, ove la figura del Rechtsmissbrauch si è rapidamente emancipata dall’immediato fondamento normativo costituito dal § 226 BGB
(«l’esercizio del diritto è inammissibile se può
avere il solo scopo di provocare danno ad altri») ( 18 ), per ancorarsi alla clausola generale di
buona fede del § 242 BGB, abbinata alla considerazione degli usi contrattuali (Verkehrssitte) di cui al § 157 BGB ( 19 ). Su tale base, si potrebbe essere indotti a credere che l’abuso del
diritto presupponga l’avvenuta interpretazione
delle clausole contrattuali sulla scorta di un criterio di buona fede, secondo un procedimento
( 15 ) Così già Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 1949, 157.
( 16 ) Cour de Cassation, 4 jan 1994, Sté Fiat
Auto France c/Cachia, in Jurisclasseur Périodique,
1991.I.3757.
( 17 ) Cour de Cassation, 5 Oct 1993, Renault
c/Rouvel Automobiles, in Jurisclasseur Périodique,
1994.II.22224.
( 18 ) Com’è noto, il codice tedesco non è l’unico a
contemplare espressamente una norma sull’abuso
del diritto, la quale si rinviene, tra gli altri, nel codice civile svizzero (art. 2, comma 2o), in quello spagnolo (art. 7, comma 2o) e nel codice olandese del
1992 (art. 3:13).
( 19 ) Larenz-Wolf, Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts, Monaco, 2004, 283. Nella
letteratura in lingua italiana, si può vedere Ranieri,
Norma scritta e prassi giudiziale nell’evoluzione della
dottrina tedesca del Rechtsmissbrauch, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 1972, 1216.
NGCC 2010 - Parte seconda
Abuso del diritto
analogo a quello ipotizzato dalla nostra giurisprudenza. In realtà, una semplice ricognizione
del ruolo che assume la buona fede interpretativa nel contesto del diritto tedesco è sufficiente a smentire questa prima impressione: la regola composita che emerge in Germania è infatti espressione privilegiata di tutela dell’affidamento del destinatario delle dichiarazioni
contrattuali e non si colora di istanze equitative
o riequilibrative del contenuto del contratto.
Non vi è dubbio, al riguardo, che la valorizzazione degli usi ai fini del processo ermeneutico
riconduce, in ultima analisi, l’operazione posta
in essere dall’interprete ad un parametro oggettivo, svincolato dalle intenzioni dei contraenti, e destinato a coincidere con il senso
che la generalità dei consociati potrebbe attribuire alle singole dichiarazioni di volontà ( 20 ).
In altre parole, la prospettiva in esame appare
volta a tutelare l’affidamento del destinatario
della dichiarazione contrattuale (c.d. objektiver
Empfängershorizont), identificandone il contenuto con quello che una persona, nella stessa
posizione del destinatario della dichiarazione,
avrebbe potuto ragionevolmente attribuire alle
clausole del contratto in conformità a buona
fede, oltre che alla luce degli usi contrattuali.
In questo modo, peraltro, è possibile porre un
limite preciso all’indagine sull’intenzione dei
contraenti, la quale trova spazio di esplicazione
fin tanto che essa non entra in collisione con le
ragionevoli aspettative del destinatario delle
dichiarazioni contrattuali, di modo che l’interprete sia posto in condizione di valutare positivamente sia elementi oggettivi che elementi
soggettivi, entro una cornice di regole definite
e prevedibili in anticipo ( 21 ).
Anche l’esperienza di common law porta al-
20
( ) Lo stretto collegamento tra interpretazione
secondo buona fede e rilevanza degli usi si può leggere già in Danz, Die Auslegung der Rechtsgeschäfte, Jena, 1911, 152 ss.
( 21 ) Tale visione rappresenta un tratto distintivo
dell’ermeneutica contrattuale tedesca, sul quale concorda consolidata dottrina: Flume, Allgemeiner
Teil des Bürgerlichen Rechts, Zweiter Band, Das
Rechtsgeschäft, Berlin-Heidelberg-New York, 1979,
307 ss.; Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit: unter besonderer Berücksichtigung der deutschen
Entwicklung, Gottingen, 1967, 517.
NGCC 2010 - Parte seconda
cune conferme al discorso fin qui condotto,
pur essendo assai noto che il concetto di abuso
del diritto è formalmente estraneo al dibattito
giuridico anglosassone, almeno nella forma assunta nella tradizione romanistica ( 22 ). Il discorso meriterebbe ben più ampi approfondimenti e la stessa idea di considerare unitariamente il modello di common law con riferimento a simili problematiche è certamente
fuorviante. Ad ogni modo, un principio generale che sanzioni l’abuso del diritto è assente
tanto in Inghilterra quanto negli Stati Uniti, ma
non mancano singoli istituti, destinati a regolare specifiche fattispecie non nella forma di una
clausola generale, i quali paiono strutturati in
maniera idonea ad assecondare la medesima
funzione (si pensi al tort of interference o alla
doctrine of unconscionability o all’undue influence). In ogni caso, dalla dottrina statunitense proviene una chiara indicazione di sovrapponibilità tra il concetto di abuso del diritto e
l’obbligo di comportamento secondo good faith, esplicitamente contemplato, com’è noto,
nello Uniform Commercial Code e nel Second
Restatement of Contracts, in perfetta simmetria
con la più incisiva critica continentale alla nozione di abuso del diritto, che pare sovrapporsi
all’area coperta dalla buona fede in executivis;
nella stessa prospettiva si colloca la particolare
caratteristica dell’esperienza di common law di
saper conciliare un modello di interpretazione
contrattuale ancorato al rispetto primario della
volontà espressa, con frequenti aperture alla
valutazione giudiziale di possibili manifestazioni di iniquità del contratto, operate attraverso
strumenti che vengono attivati in una fase successiva al processo ermeneutico ( 23 ).
( 22 ) Vi sono certamente talune significative eccezioni. Al riguardo, è interessante leggere le pagine di
Gutteridge, Abuse of Rights, in 1 Cambridge Law
J. (1933), 22, in cui l’a. lamenta l’indifferenza del diritto inglese del tempo a qualsiasi atteggiamento
«abusivo» nell’esercizio di un diritto, pur dubitando
della possibilità di elaborare una autonoma doctrine
dell’abuso del diritto, descritta quale «instrument of
dangerous potency in the hands of the demagogue and
the revolutionary» (ivi, 44).
( 23 ) La prevalente dottrina ritiene che una teoria
dell’abuso del diritto sia non necessaria nei Paesi di
common law e nemmeno compatibile con la tradi155
Discussioni
Il panorama del diritto inglese mostra, al riguardo, una maggiore impenetrabilità all’abuso del diritto, conseguenza di uno scarso rilievo tradizionalmente affidato alla buona fede
contrattuale, anche se è necessario rilevare come ciò che più «irrita» il diritto inglese non siano tanto i valori sottesi al principio stesso di
buona fede, quanto la possibile vaghezza nel
suo concreto utilizzo giurisprudenziale ed il
«forzato adattamento di uno schema non sempre idoneo per tutti i tagli e tutte le misure»
( 24 ). Certamente inaccettabile agli occhi del
common lawyer sarebbe inoltre la tesi per cui il
procedimento interpretativo, che in Inghilterra
è a tutt’oggi legato al rispetto della volontà delle parti così come tradotta nel testo contrattuale, possa consentire un ampio margine di discrezionalità giudiziale tale da permettere al
giudice di riscrivere il contratto al posto delle
parti. La logica del modello di ermeneutica
contrattuale inglese, pur soggetta nel corso degli ultimi anni ad una profonda rivisitazione
( 25 ), ha mantenuto costante la tesi per cui il
processo interpretativo conduce ad assegnare
al contratto il significato che vi potrebbe attribuire un reasonable man il quale si trovi nella
medesima condizione conoscitiva dei contraenti; da ciò emerge un quadro nel quale
massimo è il rilievo attribuito al concetto di reliance contrattuale, e cioè all’affidamento che
ciascun contraente ripone sulle dichiarazioni
negoziali, non idoneo a far penetrare per via
interpretativa istanze di riequilibrio degli assetti di interessi già delineati dai contraenti e conformati alla luce di un’interpretazione condotta secondo ragionevolezza.
zionale precisione definitoria dei diritti attribuiti per
legge o per contratto; così Catala-Weir, Delict and
Torts: A Study in Parallel, 38 Tul Law Review (1975)
1015. Di recente, il tema dell’abuso del diritto è stato oggetto di una nuova analisi da parte di Perillo,
Abuse of Rights: A Pervasive Legal Concept, in 27
Pac. L.J. (1997), 37, il quale ravvisa una possibile lettura di vari istituti del diritto americano accomunati
dal fil rouge del concetto di abuso del diritto. L’a.
sembra peraltro cadere in contraddizione quando
accosta la teoria dell’abuso del diritto, quale punto
di aggregazione di regole diverse, al procedimento
di interpretazione del contratto non ancorato al criterio letterale. Se si ritiene infatti che la condotta dei
contraenti sia abusiva ove si ponga in contrasto con
l’obbligo generale di comportamento secondo buona fede nella fase esecutiva (ivi, 69 ss.), non si può al
tempo stesso sostenere che il procedimento interpretativo può di per sé condurre a delimitare il significato contrattuale in modo tale da impedire condotte abusive.
( 24 ) In questi termini De Vita, Buona fede e common law (attrazione non fatale nella storia del contratto), in Riv. dir. civ., 2003, I, 267. Sull’effetto «irritante» del concetto di buona fede per il tessuto del
diritto inglese, il riferimento d’obbligo è a Teubner, Legal Irritants: Good Faith in British Law or
How Unifying Law Ends Up in New Divergences, in
61 Modern Law Review 11 (1998), trad. it. in Ars Interpretandi, 2007, 143 ss.
( 25 ) Una rielaborazione dei canoni di interpretazione del contratto in Inghilterra si può leggere nel
caso Investors Compensation Scheme Ltd. v West
Bromwich Building Society [1998] 1 All ER 98; si
rinvia, al riguardo, a Viglione, L’interpretazione del
contratto nel common law inglese. Problemi e prospettive, in Riv. dir. civ., suppl. 1, 2008, 134 ss. Il rinnovato interesse per il tema interpretativo nel quadro del diritto contrattuale inglese è testimoniato
oggi dalla recente pubblicazione di tre studi monografici ad esso dedicati: Lewison, The interpretation of contracts, Londra, 2004; McMeel, The Construction of Contracts. Interpretation, Implication
and Rectification, Oxford, 2007; Mitchell, Interpretation of contracts, Londra-New York, 2007.
156
NGCC 2010 - Parte seconda
Studi e Opinioni
«BEST INTERESTS OF THE CHILD»
O «BEST INTERESTS OF CHILDREN»? (*)
di Leonardo Lenti
Sommario: 1. Premessa. – 2. Alle origini della best
interests of the child doctrine e dell’affermazione
dei children’s rights. – 3. I best interests of the
child nel diritto italiano. – 4. I problemi nell’applicazione odierna dei best interests of the child.
– 5. I best interests of the child e il principio di legalità: il caso Serena. – 6. Il contenuto dei best
interests of the child, fra autodeterminazione e
paternalismo: il caso dei trattamenti oncologici
alternativi a quelli della medicina scientifica.
1. Premessa. Scopo di questo breve scritto
è sottolineare una confusione, una sovrapposizione di significati che si verifica frequentemente, almeno nei paesi dell’Europa continentale, nell’uso delle locuzioni «interesse del minore», «superiore interesse del minore», ovvero in lingua inglese (dalla quale la locuzione
italiana trae origine) «best interests of the child». Questa locuzione, posta al singolare («minore», «child»), si riferisce all’interesse del singolo minore, nel concreto del caso che lo riguarda; ma viene anche da tempo impiegata, e
sempre più spesso, come se fosse invece posta
al plurale («minori», «children»), cioè come se
si riferisse in via generale e astratta al bene
complessivo dell’età infantile e adolescenziale e
quindi all’affermazione e alla tutela in via
astratta e generale dei loro interessi, vale a dire
dei diritti di tale fascia di età.
(*) Lo scritto rielabora l’intervento omonimo tenuto al Convegno internazionale giuridico-linguistico Marginalized Identities in the Discourse of Justice:
Reflections on Children’s Rights, tenuto a Torino il 5
e 26.5.2008; gli atti in corso di pubblicazione presso
la casa editrice Polimetrica, ne contengono una versione in lingua inglese, avente un contenuto in gran
parte analogo.
NGCC 2010 - Parte seconda
2. Alle origini della best interests of
the child doctrine e dell’affermazione
dei children’s rights. L’affermazione del
principio della prevalenza dei best interests of
the child nelle questioni riguardanti i minori
nacque nel common law nordamericano. Gli
studi di Zainaldin e di Presser ( 1 ) – ormai datati ma non invecchiati – hanno descritto analiticamente la sua origine nel diritto degli Stati
Uniti nella prima parte del XIX secolo. La best
interests of the child doctrine nacque in contrapposizione con la rigidità che caratterizzava
i parental rights nel common law, immodificabili e intrasferibili: svolse la funzione di strumento per introdurvi eccezioni, fondate sulle
specifiche esigenze dei singoli casi concreti,
con lo scopo di raggiungere soluzioni corrispondenti nel massimo grado possibile a giustizia sostanziale e tali da aprire la strada all’affermazione di nuovi principi.
I due campi in cui si fece originariamente ricorso alla best interests of the child doctrine furono quello dell’adozione dei minorenni e quello dell’affidamento dei figli minorenni tra coniugi divorziati. In entrambi i campi l’accoglimento della best interests of the child doctrine
permise di dare soluzioni differenziate seciondo le peculiari esigenze del singolo caso; nella
loro genesi la persona del bambino o dell’adolescente, di quel detereminato bambino o adolescente, era al centro dell’attenzione; lo scopo
del giudizio era scegliere ciò che appariva me( 1 ) Zainaldin, The Emergence of a Modern
American Family Law: Child Custody, Adoption and
the Courts, 1796-1851, in 73 Nw. U. L. Rev., 1979,
1052 ss.; Presser, The Historical Background of the
American Law of Adoption, 11 J. Fam. L., 1971, 448
ss.
157
Studi e Opinioni
glio per lui, per la sua vita e per la sua crescita.
Al contrario, l’accoglimento della parental rights doctrine avrebbe portato il giudice a decidere inevitabilmente l’affidamento a favore del
padre legale: in caso adozione questi era preferito rispetto alla famiglia che aveva accolto il
minore (avendolo trovato non accompagnato,
oppure essendole stato affidato dal padre, che
aveva poi cambiato idea e ne aveva chiesto la
restituzione) ( 2 ); in caso di affidamento fra divorziati, invece, era preferito alla madre, in
quanto questa non era contitolare dei parental
rights, secondo il common law del tempo.
La best interests of the child doctrine nacque
dunque come regola per risolvere casi concreti.
L’idea stessa, però, che si pensasse di risolverli
evitando di applicare la stretta regola di common law, anzi contraddicendola e suparandola
in nome della felicità individuale (il diritto alla
felicità – ricordo – è menzionato nella costituzione federale degli Usa), costituiva una diretta
applicazione dell’eudemonismo settecentesco.
Come pure costituiva un’applicazione concreta
dei principi illuministici riguardanti i rapporti
fra genitori e figli, ben sintetizzati da Locke nel
suo secondo Trattato sul governo, i quali si ponevano all’opposto dell’ideologia proprietaria,
che tradizionalmente connotava i rapporti fra
padri e figli e faceva di questi ultimi una sorta
di bene, di oggetto di un diritto di tipo quasi
dominicale del padre. Il potere del padre sul figlio – scriveva Locke ( 3 ) – non si fonda tanto
sul fatto della generazione biologica quanto
piuttosto sul fatto della cura, dell’educazione e
del mantenimento del bambino. Pertanto il potere del padre, espresso nella patria potestà, è
indissolubilmente legato al fatto ch’egli allevi i
propri figli, li mantenga, li educhi, li istruisca:
ne consegue che lo perde qualora li abbandoni.
In quest’ultimo caso tale potere sui bambini
( 2 ) Nella dottrina italiana, per una ricostruzione
più ampia di questa vicenda, che costituisce una delle fonti originarie del modello contemporaneo di
adozione, mi permetto di rinviare a Lenti, Introduzione. Vicende storiche e modelli di legislazione in
materia adottiva, nel Trattato dir. fam., diretto da
Zatti, II, Filiazione, a cura di Collura-LentiMantovani, Giuffrè, 2002, 584 s.
( 3 ) Locke, Due trattati sul governo, trad. it, Utet,
1948, II, n. 65 s.
158
compete a chi li tiene con sé e li alleva, come se
ne fosse il padre genetico: dunque al padre
adottivo.
Il ricorso alla best interests of the child doctrine segnò l’avvio nel common law di una fase di
modificazione radicale dei principi stessi: da
un sistema costruito intorno al diritto del padre, ben rappresentato nel valore semantico
originario dell’espressione «parental rights»
( 4 ), si passò progressivamente a un sistema centrato sul diritto dei figli di essere amati, curati,
mantenuti, educati, istruiti. Proprio la struttura più profonda del common law – che è costruito sul precedente e per tradizione affida in
linea di principio l’innovazione anzitutto alle
corti e solo in subordine al legislatore – spiega
perché l’emersione del nuovo sia avvenuta soprattutto mediante un principio da applicare
in giudizio al singolo caso concreto, come eccezione a un principio giuridico consolidato di
segno opposto.
La best interests of the child doctrine non
nacque come applicazione dell’equity. A quest’ultima, infatti, si ricorreva e si ricorre in circostanze diverse e con esiti diversi: quando
l’applicazione di una regola giuridica rigida e
precisa porterebbe a risultati percepiti come
ingiusti nel caso singolo, ma non si intende affatto contraddire il principio che sta alla base
della regola stessa. Anzi, per via di equity si
cerca di applicare direttamente al caso di specie proprio quello stesso principio.
Nei paesi dell’Europa continentale, principalmente a causa della differente struttura del
sistema politico e giuridico, si ottenne un risultato simile a quello descritto sopra seguendo
una via diversa.
Insieme con le elaborazioni filosofiche dei
giusnaturalisti seicenteschi e settecenteschi –
cui si deve l’impostazione originaria del sistema dei diritti umani affermatosi poi largamente
nel mondo solo nella seconda metà del novecento – quegli stessi principi illuministici ri( 4 ) Tuttora utilizzata nei sistemi anglosassoni,
benché ormai dotata di un significato lontanissimo
da quello della tradizione, che corrispondeva al significato proprio della parola «right»: oggi i parental
rights, pur così chiamati, costituiscono infatti anzitutto un dovere e una responsabilità dei genitori nei
confronti dei loro figli minorenni.
NGCC 2010 - Parte seconda
«Best interests of the child» o «best interests of children»?
guardanti i rapporti fra genitori e figli non diedero tanto origine a un principio da applicare
in giudizio al singolo caso concreto, scegliendo
secondo i best interests of the child, quanto
piuttosto offrirono all’autorità legiferante indicazioni astratte e generali sulle finalità da perseguire. Così i minorenni vennero anzitutto riconosciuti come soggetti di un insieme di diritti
della persona, allo stesso modo in cui lo sono
gli adulti; per di più come soggetti specialmente preziosi per la società, poiché ne costituiscono il futuro; e come soggetti che si trovano in
una condizione di naturale debolezza e sono
quindi bisognosi dell’aiuto degli adulti. Tutti i
minorenni si videro attribuito il diritto di ricevere questo aiuto, sotto forma di amore, di cura, di mantenimento, di educazione, di istruzione.
Tra i fondamenti dell’intero sistema giuridico vi dovrebbero quindi essere la piena realizzazione dei loro diritti e la garanzia di un sistema che assicuri loro le migliori condizioni di
vita possibili; ovvero, per usare parole spesso
impiegate nel diritto d’oggi dell’Europa continentale, per perseguire i best interests of the
child; ma in realtà – mi sembra – per perseguire
piuttosto i best interests della categoria generale e astratta «children», senza alcuna particolare attenzione alle singolarità del caso di specie
da decidere.
La prospettiva puerocentrica, di matrice illuminista, emerse soprattutto nelle proposte di
politica legislativa in materia di adozione ( 5 ):
nel sistema allora più prestigioso in Europa per
la sua capacità di innovazione politica, la Francia, va ricordata la proposta di Berlier, elaborata in un’articolata bozza del 1792 e poi confluita nel progetto preliminare sull’adozione discusso al Conseil d’État nel 1802 in sede di preparazione del Code Napoléon ( 6 ), ma successivamente abbandonato ( 7 ). L’adozione era con( 5 ) Per una ricostruzione più ampia mi permetto
di rinviare ancora a Lenti, Introduzione, cit., 579 s.
( 6 ) I lavori preparatori del Code Napoléon sono
pubblicati in Fenet, Recueil complet des travaux
préparatoires du code civil, X, rist. anastatica, Zeller,
Osnabrück, 1968, spec. 247-340.
( 7 ) L’adozione ottocentesca del Code Napoléon
(come quella del codice italiano del 1865) fu tutt’altro: un istituto ibrido e mal riuscito, volto principalNGCC 2010 - Parte seconda
cepita come un istituto giuridico radicato nel
principio della solidarietà sociale, consistente
nel dare una famiglia a un bambino che ne fosse privo: era dunque volta esclusivamente alla
protezione del bambino, al suo benessere e alla
sua educazione.
Dopo una lunga fase, corrispondente a gran
parte del XIX secolo, nella quale la garanzia
dei children’s rights restò in ombra, come pure
molti dei principi illuministi in materia di relazioni familiari, i primi decenni del XX secolo
ne segnarono la rinascita: ciò avvenne in un
primo tempo soprattutto nel campo del diritto
penale e della procedura penale, con la nascita
delle Juvenile Courts e l’elaborazione di regole
diverse per trattare la delinquenza minorile rispetto a quelle impiegate per la delinquenza
degli adulti. Ma ben presto questo movimento
investì anche il campo del diritto civile con
l’introduzione, anzitutto in Inghilterra e in
Francia negli anni ’20 e ’30, delle prime leggi
che accolsero in Europa il modello contemporaneo di adozione: furono occasionate dalla
tragedia degli orfani della prima guerra mondiale, ma erano espressione di valori solidaristici di impronta illuminista la cui diffusione e
accettazione nella società andava rapidamente
crescendo ( 8 ).
Attraverso questi passaggi (sui versanti legislativo e giudiziario) l’atteggiamento puerocentrico uscì dal campo della pedagogia più innovativa, in cui era rimasto confinato fino all’inizio del XX secolo, e si affermò anche in molti
altri settori, come in quello della psicologia e –
ciò che qui interessa – in quello del diritto.
Nella seconda metà del XX secolo divenne il
principio guida in materia minorile, tanto negli
ordinamenti dei paesi di matrice culturale eu-
mente a dare un discendente a chi ne era privo, dunque prioritariamente nell’interesse dell’adottante,
nonostante qualche generica indicazione legislativa
di segno opposto, di valore meramente retorico ma
priva di efficacia operativa. Com’è noto, era riservata a chi aveva compiuto i 50 anni e non aveva figli legittimi; potevano essere adottati solo i maggiorenni
(Francia) o anche i minorenni ultradiciottenni (Italia); ma mai i bambini.
( 8 ) Sulla formazione del modello giuridico contemporaneo di adozione mi permetto ancora il rinvio a Lenti, op. loc. ult. citt.
159
Studi e Opinioni
ropea (continentale, anglosassone e – seppur
unicamente sul piano della declamazioni verbali, spesso assai altisonanti – dei paesi dell’area sovietica), quanto nel sistema giuridico
internazionale: tutti unanimi nell’affermare il
pieno riconoscimento dei diritti dei minori e la
necessità prioritaria di perseguire il loro bene.
La locuzione sotto la quale furono posti questi
principi fu reperita acriticamente nel linguaggio giuridico anglosassone, in quanto principale linguaggio degli organismi internazionali: fu
appunto quella dei best interests of the child.
In sintesi: la best interests of the child doctrine, nata all’inizio del XIX secolo come espressione di un principio nuovo, opposto a quelli
allora dominanti, che permetteva di decidere
un singolo caso concreto in modo difforme
dalle regole legislative e dai precedenti giudiziali del tempo, si trasformò – almeno nell’Europa continentale – in un principio generale secondo il quale l’intero sistema giuridico minorile era connotato dalla priorità dei children’s
rights. Così questi ultimi, indicati però con il
nome mentitorio di best interests of the child,
divennero il centro del sistema, il fondamento
di un insieme di regole astratte e generali, connotate da un certo grado di rigidità, com’è inevitabile. Divennero dunque proprio l’opposto
della flessibilizzazione delle regole giuridiche,
della loro adattabilità alle singolari esigenze
della giustizia nel caso concreto, che si intendeva perseguire con la best interests of the child
doctrine ai tempi della sua introduzione originaria. Da qui nasce la crescente esigenza di
prevedere eccezioni all’applicazione di tali regole ( 9 ): eccezioni finalizzate a rendere giustizia nel caso concreto a favore di un determinato minore proprio (paradosso apparente) contro regole di legge postulate come corrispondenti ai best interests of the child, ovvero al
massimo bene dell’età infantile e adolescenziale, considerato in modo generale e astratto.
Proprio qui riemerge un nuovo spazio
( 9 ) Emblematica è la nota vicenda della progressiva elasticizzazione della differenza massima di età
fra adottanti e adottato, dai primi interventi della
Corte di cassazione all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso fino all’attuale testo dell’art. 6 della l. n.
184/1983, introdotto dalla l. n. 149/2001, di riforma
dell’adozione.
160
d’azione per la best interests of the child doctrine, intesa nel suo significato originario. Tuttavia, a differenza di quanto accadde due secoli
fa, la sua applicazione oggi non esprime principi nuovi, che scardinano quelli vecchi, ma è
fondata piuttoso sull’equità: senza contraddire
in alcun modo i principi di favore per il minore
che reggono il sistema, può infatti servire a giustificare una soluzione diversa da quella imposta dai testi di legge o dai precedenti giudiziali
in tutti quei casi che presentano particolarità
tali per cui altrimenti si giungerebbe a decisioni ingiuste, cioè tali da ritorcersi contro il bene
di quel singolo determinato minore.
In conclusione: la locuzione «best interests of
the child» ha assunto e continua ad avere significati diversi secondo le epoche, gli ordinamenti e i casi specifici. Questa diversità fra i significati, oggetto di frequenti sovrapposizioni, è generatrice di confusione e di profonda ambiguità: fra gli studiosi e gli operatori del diritto,
quanto meno nell’Europa continentale, ne
manca però una sufficiente consapevolezza. I
brevi cenni storici che precedono sono intesi a
cercare di identificarne a grandi linee le ragioni.
3. I best interests of the child nel diritto italiano. Nel diritto civile italiano il
principio della prevalenza dei best interests of
the child ovvero del superiore interesse del minore – inteso nel suo significato originario, a
quanto mi sembra – ebbe le prime applicazioni
non sporadiche, ma ripetute con una certa costanza, negli anni ’50 del XX secolo, ben prima
di essere codificato nella riforma del diritto di
famiglia del 1975 (art. 155, comma 1o, cod.
civ.) ( 10 ): fu impiegato come criterio per deci-
( 10 ) L’art. 155, comma 1o, cod. civ., prima della
riforma del 2006, stabiliva che ogni provvedimento
giudiziario riguardante i figli dovesse essere preso
«con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale» dei figli stessi. La riforma del 2006 ha mantenuto la stessa formula nel nuovo art. 155, comma
2o. La precisazione dell’esclusività, assente negli altri ordinamenti europei, si spiega per il fatto che il
legislatore intendeva così vietare l’impiego di altri
criteri decisionali, quale soprattutto la colpa (e poi
l’addebito) nella separazione, che altrimenti avrebbero forse continuato a essere impiegati dalla giuriNGCC 2010 - Parte seconda
«Best interests of the child» o «best interests of children»?
dere l’affidamento in caso di separazione fra i
coniugi, al dichiarato scopo di motivare la preferenza per la madre, nonostante la separazione fosse stata pronunciata per sua colpa. Si capovolgeva così un’abitudine di interpretazione
e applicazione della legge da lungo tempo consolidata ( 11 ).
Anche qui dunque la best interests of the
child doctrine nacque come regola da applicare al caso concreto; anche qui nacque come
fattore di scardinamento di un sistema di
principi consolidati del diritto familiare, dal
patricentrismo – l’esercizio della potestà, non
a caso qualificata come «patria», spettava allora al solo padre – al moralismo, che recepiva ancora largamente (più che in altri paesi
europei) il codice etico dei doveri matrimoniali ereditato dalla tradizione ottocentesca e
tridentina, secondo il quale chi li avesse violati, e fosse quindi da qualificare come cattivo
coniuge, non potesse non essere anche un cattivo genitore.
Nello stesso periodo di tempo il principio
della protezione prioritaria dell’interesse del
minore venne anche posto alla base della riforma legislativa dell’adozione del 1967, che introdusse finalmente pure in Italia un’adozione
conforme al modello che si era ormai diffuso in
Europa occidentale e negli Usa: un’adozione
consistente, com’è noto, in una sorta di trapianto del bambino dalla sua famiglia d’origine, inesistente o inadatta, a una famiglia d’accoglienza, ove entrava come figlio a tutti gli effetti di legge; un’adozione dunque rigorosamente costruita per dare una famiglia stabile e
definitiva a un bambino che ne aveva bisogno.
sprudenza della Corte di cassazione; una giurisprudenza che, ricordo, nei primi anni di applicazione
della riforma del diritto di famiglia, e ancora fino all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, guardava
con palese nostalgia al diritto previgente.
( 11 ) Nel diritto italiano del XIX secolo e della
prima metà del XX secolo, fino agli anni ’60, era
frequente che i figli fossero affidati al padre per il
solo fatto che questi era l’unico esercente della patria potestà, oppure che fossero affidati al genitore
che non aveva colpa nella separazione; qualora
questi fosse il padre, era frequente che gli fosse
prescritto di tenerli presso la propria madre o presso un istituto.
NGCC 2010 - Parte seconda
I best interests del singolo bambino tolto da un
istituto e dato in adozione divennero così, per
una sorta di transizione tanto ovvia quanto implicita, i best interests di tutti i bambini, intesi
come categoria astratta e generale, cui la nuova
legge sull’adozione si riferiva.
Da allora le indicazioni di principio sulla
centralità nel sistema italiano del principio di
priorità dei best interests of the child, ovvero
del «superiore interesse del minore», si sono
moltiplicate a dismisura: ormai non vi è quasi
legge o provvedimento giudiziario riguardante
un minore che non le ripeta, a volte anche a
sproposito. Dinanzi a una simile inflazione, tali
riferimenti finiscono spesso con l’apparire retorici, svigoriti se non addirittura vuoti, quasi
fossero una semplice clausola di stile; oppure
sono trasformati in una sorta di contenitore
neutro dentro il quale, argomentando, si possono versare i contenuti più vari. L’interesse
del minore, come è stato osservato, si è ormai
trasformato in un’icona linguistica dal contenuto facilmente manipolabile ( 12 ). Inteso a questo
modo, l’interesse del minore mi sembra meriti
di essere qualificato piuttosto come best interests of children, ovvero come interesse della categoria generale dei minori.
4. I problemi nell’applicazione odierna dei best interests of the child. In
qualsiasi ordinamento giuridico è necessario
tenere sotto stretto e attento controllo l’impiego e i contenuti dei best interests of the child,
soprattutto per evitare che possano trovarvi
spazio principi e interessi che, configurati in
modo mentitorio, sono in realtà tali da favorire
gli adulti e non i minori, l’illegalità e non il
principio di legalità, fondamento dello stato di
diritto.
I problemi fondamentali da affrontare nella
discussione sul significato e sul valore attuale
nel diritto del principio dei best interests of the
child, intesi come modalità per superare una
( 12 ) Cfr. Gorassini, Allontanamento volontario
del minore. Variazioni ermeneutiche sull’art. 318
c.c., Esi, 1994; Zatti, Le icone linguistiche: discrezionalità interpretative e garanzia procedimentale, in
questa Rivista, 2004, suppl., Giustizia minore? La
tutela giurisdizionale dei minori e dei giovani adulti,
1 s.
161
Studi e Opinioni
specifica regola di legge al fine di rendere giustizia nel caso concreto, sono due:
– qual è il punto fino al quale può spingersi
la loro applicazione senza arrivare a intaccare il
principio di legalità?
– qual è il loro contenuto, ovvero come si
può arrivare a definire nel singolo caso concreto che cosa sia conforme ai best interests of the
child, di quel determinato minore.
Per trovare risposte adeguate, credo occorra
oggi seguire una linea diversa da quella che si
seguirebbe in altri settori del diritto, ove la posta in gioco è solo o principalmente patrimoniale: amministrare bene la giustizia in materia
minorile, come anche in generale in materia di
rapporti familiari, significa trovare soluzioni ai
conflitti che siano miti, duttili, nella massima
misura possibile accettate per effetto di persuasione anche da quella delle parti litiganti che in
altri settori del diritto si direbbe «perdente»,
cioè quella che ha visto respinta la maggior
parte delle proprie pretese o richieste.
5. I best interests of the child e il
principio di legalità: il caso Serena. La risposta alla prima domanda posta sopra comporta una valutazione comparativa estremamente delicata, ove non possono essere date risposte secche, rigide e univoche: ricordo brevemente un caso famoso, quale esempio paradigmatico in proposito.
Nel 1988 un italiano, sposato, aveva acquisito in qualche modo nelle Filippine una bambina (a nome Serena), riconoscendola falsamente
come figlia propria, e l’aveva portata in Italia,
ove insieme con la moglie aveva già adottato
(legalmente) un bambino; non è mai risultato
comprensibile perché l’interessato non avesse
seguito le regole di legge anche per il secondo
tentativo di adozione. Si trattava di un’evidente e indiscutibile violazione della legge sull’adozione internazionale, una legge posta nell’interesse di tutti i bambini, a garanzia del loro
diritto di avere una famiglia idonea, capace di
allevarli nel modo migliore possibile. Dopo
una serie di vicende processuali durate circa un
anno, caratterizzate da un comportamento di
forte ostruzionismo da parte dell’uomo, il tribunale per i minorenni ordinò l’allontanamento della bambina e la diede in affidamento
preadottivo (e poi in adozione) a una coppia
162
idonea, che nelle proprie richieste aveva seguito le regole di legge.
Il caso fu oggetto di un’enorme risonanza
mediatica. Occupò per mesi le cronache dei
giornali e i palinsesti televisivi; l’operato dei
giudici fu oggetto di furenti critiche da parte di
alcune fra le più alte cariche politiche istituzionali del paese e di una famosa scrittrice italiana
( 13 ); diede origine a gravi minacce nei loro confronti da parte di individui esaltati dalla campagna giornalistica, martellante e tutt’altro che
equanime. Fu davvero una brutta pagina nella
storia del giornalismo e delle istituzioni politiche italiane.
Il tono generale della discussione fu determinato dalla stampa e dalla televisione e può
essere sintetizzato così: le ragioni del cuore
contro le aride rigidità della legge. Quali erano
in una simile situazione, avvelenata dai mezzi
d’informazione, i best interests of the child?
Consistevano nella violazione di una legge posta a garanzia dei diritti dei bambini? Fino a
che punto è ammissibile legalizzare illegalità
per il bene di un singolo bambino? Quale effetto di esempio – data la risonanza mediatica
– avrebbe potuto derivarne, a detrimento del
rispetto di una legge posta nell’interesse dei
bambini?
La decisione dei giudici, che seppero coraggiosamente resistere alla denigrazione mediatica e politica, fu determinata da due fattori.
Il primo fattore, quello che risultò poi decisivo, fu la convinzione che lasciare la bambina
presso la coppia che l’aveva acquisita illegalmente sarebbe stata una ferita troppo grave
per il principio di legalità, troppo foriera di
future illegalità; la situazione, insomma, era
degenerata a tal punto, soprattutto a causa
del fragore mediatico ( 14 ), che nella valutazione comparativa fra il presumibile interesse di
quella bambina e il principio di legalità (una
legalità in questo caso posta a tutela del bene
dei bambini in generale), era il secondo a dover prevalere ( 15 ). Le parole della Corte d’ap( 13 ) Ginzburg, Serena o della vera giustizia, Einaudi, 1989.
( 14 ) Senza fragore mediatico è lecito supporre
che forse le cose sarebbero andate in un altro modo.
( 15 ) La vicenda giudiziaria si concluse con il deNGCC 2010 - Parte seconda
«Best interests of the child» o «best interests of children»?
pello di Torino, che prese la decisione finale,
di dolente intensità, meritano di essere ricordate con una citazione testuale. Scrisse la
Corte che in presenza della l. n. 184/1983 sull’adozione, una legge «provvida ed avanzata
che difende i bambini contro frodi, sfruttamenti, mercificazioni da parte degli adulti [...],
ogni sconfitta di questa legge è una sconfitta
dei bambini e della loro difesa»; e i tentativi di
frode erano (e forse ancora sono) molto frequenti. Aggiunse poi che la bambina «è sorella a molti bambini, il cui destino può essere
messo in questione proprio dalla soluzione di
questo caso». Infine osservò che «la legge difende le persone di tutti i bambini. Rifiutando
di tradire la legge e di “legalizzare” la frode ad
essa, i giudici operano a servizio dell’interesse
di tutti i bambini. Se tale rifiuto produce una
sofferenza per Serena, quella sofferenza non è
conseguenza dell’applicazione della legge, bensì
della prolungata frode» della famiglia che
l’aveva acquisita. Con queste chiare parole la
Corte giudicò dunque evidentemente prioritari gli interessi della categoria generale dei
bambini, non del singolo, almeno per il modo
in cui il caso si era in concreto sviluppato, soprattutto a causa della risonanza esemplare
che aveva avuto.
Il secondo fattore ebbe un’importanza assai
minore, ma servì comunque a rimuovere i dubbi che persistevano, almeno sul piano degli argomenti portati a sostegno della decisione, e fu
probabilmente utilizzato in un modo un po’
strumentale: una perizia psicologica sulla bambina, effettuata qualche settimana prima del
suo allontanamento – quindi ormai dopo un
anno da che era stata accolta dalla famiglia e
dopo alcuni mesi di tempesta mediatica – ne
aveva indicato uno stato di sofferenza crescente a causa della vicenda che la coinvolgeva; di
qui la conseguenza che il suo allontanamento,
creto di App. Torino, 21.4.1989, che fece seguito a
un precedente decreto della stessa Corte del
15.3.1989, entrambi in Giur. it., 1989, I, 2, 515 s.,
con nota adesiva di Lenti, Il caso Serena: i bambini
non si usucapiscono; cfr. inoltre il commento adesivo
di Pepino, Serena, i giudici e l’intervento pubblico
nel settore minorile, in Quest. giust., 1989, 434 s., e
quello dubbiosamente contrario di Zagrebelsky, Il
diritto mite, Einaudi, 1992, 192 s.
NGCC 2010 - Parte seconda
che vi avrebbe posto fine, sarebbe stato corrispondente anche ai suoi best interests individuali.
6. Il contenuto dei best interests of
the child, fra autodeterminazione e paternalismo: il caso dei trattamenti oncologici alternativi a quelli della medicina scientifica. La risposta alla seconda
domanda posta sopra – come si possa arrivare
a definire nel singolo caso concreto che cosa
sia conforme ai best interests of that child, ovvero di un determinato minore – pone un’infinità di problemi. Ne tratterò brevemente attraverso l’esempio offerto da una vicenda emblematica del recente passato, assai dolorosa,
oggetto anche di forte attenzione mediatica: la
questione del consenso ad autorizzare trattamenti sanitari a favore di minori e a realizzarli
nei fatti anche contro la volontà dei genitori
stessi e del minore, ove la questione giuridica
di principio è quella della difficile ricerca di
un punto di equilibrio fra l’autodeterminazione del minorenne e l’eterodeterminazione paternalistica da parte di adulti diversi dai suoi
genitori.
I trattamenti sanitari effettuati su un minorenne necessitano di regola dell’autorizzazione
dei genitori, in quanto suoi legali rappresentanti. Tuttavia, qualora i genitori rifiutino di
consentire a trattamenti giudicati necessari dai
medici, questi ultimi hanno il dovere di segnalare la situazione al pubblico ministero presso
il Tribunale per i minorenni, affinché attivi il
procedimento di cui all’art. 333 cod. civ.: nel
suo corso il Tribunale deciderà se emanare un
decreto con il quale limitare la potestà dei genitori, prescrivendo loro di non opporsi al trattamento, oppure sospenderli dall’esercizio della potestà proprio con riguardo esclusivo al loro mancato consenso, considerandoli in conflitto d’interessi con il figlio, e nominare contestualmente un curatore speciale che dia tale
consenso.
Il consenso del minore al trattamento sanitario che lo riguarda non è richiesto formalmente, anche se si tratta di un minore ormai dotato
di una sufficiente capacità di discernimento.
Tuttavia si ritiene di dover applicare il principio espresso nel finale dell’art. 6, comma 2o,
della Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uo163
Studi e Opinioni
mo e la biomedicina del 1997 ( 16 ), secondo il
quale «il parere di un minore è preso in considerazione come fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado
di maturità».
Nel 1998 si diffuse in Italia la credenza nell’efficacia di una terapia oncologica diversa da
quelle consigliate dalla medicina scientifica, la
cosiddetta multiterapia Di Bella; tale credenza
nacque da un’incredibile campagna mediatica
e politica, ma si dimostrò poi nel giro di pochi
mesi clamorosamente falsa. In alcuni casi
giunti all’attenzione della magistratura minorile, i genitori di bambini ammalati – di età fra i
9 e i 10 anni e considerati quindi dotati di una
sufficiente capacità di discernimento – negarono il loro consenso a proseguire nelle terapie consuete e scelsero di curarli con la terapia Di Bella. Su segnalazione dei medici che
avevano in cura i piccoli, intervenne la giustizia minorile, che prese decisioni diverse nei
vari casi ( 17 ): a volte sospese i genitori dall’esercizio della potestà e nominò un curatore
del minore, che desse il consenso formalmente
necessario per continuare i trattamenti oncologici ospedalieri; altre volte ritenne invece
opportuno non intervenire. Non giunse però
mai a decidere il ricorso all’esecuzione forzata
sul corpo del bambino, quando questi persisteva nell’opporvisi ( 18 ).
( 16 ) La l. 28.3.2001, n. 145, ha autorizzato la ratifica della Convenzione da parte dell’Italia; tuttavia,
per ragioni politiche non apertamente e ufficialmente dichiarate (lasciando così spazio a ogni malevola
supposizione), lo strumento di ratifica non è mai
stato depositato, sicché non può essere considerata
in vigore per l’Italia. Ciononostante i giudici ne applicano ormai costantemente i principi, considerandoli immanenti sia nell’ordinamento interno sia nell’ordinamento internazionale.
( 17 ) Cfr. Turri, Diritto alla salute, minorenni e libertà di cura, in Quest. giust., 1999, 473 s.; Id., Autodeterminazione, trattamenti sanitari e minorenni,
ivi, 2000, 1098 ss.; Vercellone, Il corpo del minorenne: i trattamenti sanitari, nel Trattato dir. fam.,
diretto da Zatti, II, La filiazione, cit., in particolare
999 s.
( 18 ) Trib. Brescia, 28.12.1998, App. Brescia,
13.2.1999 e Trib. Brescia, 22.5.1999, tutte in questa
Rivista, 2000, I, 204 ss., con nota di Grifasi; App. Brescia, 24.11.1999, in Minori giust., 2001, 2, 203 s.; App.
164
I principali fattori che i giudici presero in
considerazione nel bilanciare i valori e gli interessi contrapposti furono i seguenti: la necessità di un’effettiva «alleanza terapeutica» fra il
medico, il bambino e i suoi genitori, tanto più
importante quanto più i trattamenti sanitari si
protraggono nel tempo ( 19 ); la valutazione
comparativa fra le probabilità di guarigione
con il ricorso alla terapia oncologica della medicina scientifica e quelle che si sarebbero
presumibilmente avute senza ricorrervi; il grado di invasività di tale terapia (in un caso per
esempio avrebbe comportato, oltre alla chiemioterapia, anche l’amputazione di una gamba); la disponibilità dei genitori di ritornare
alle terapie della medicina scientifica, se la terapia Di Bella si fosse dimostrata inefficace
(sempre che ve ne fosse stato ancora il tempo)
( 20 ); il grado di comprensione da parte del
bambino della sua situazione e dei suoi possibili esiti.
Dinanzi ai persistenti rifiuti dei bambini, ovviamente sostenuti dai genitori, di sottoporsi alle terapie oncologiche della medicina scientifica
fu sempre esclusa l’esecuzione forzata, pur con
una differenza: in alcuni casi il provvedimento di
sospensione della potestà fu revocato, motivando con il fatto che mantenerlo nonostante la perdurante radicale opposizione del bambino sarebbe stato contrario al suo interesse, in quanto
lesivo della sua personalità; in un caso il provvedimento fu invece mantenuto, ma il giudice rifiutò di ordinarne l’esecuzione coattiva, in quanto
avrebbe costituito un’intollerabile violenza per-
Ancona, 26.3.1999, in Fam. e dir., 1999, 467 s., con
commento di Lena e in questa Rivista, 2000, I, 218 s.,
con nota di Grondona; Trib. Venezia, 7.10.1998, in
Dir. fam. e pers., 1999, 690 s. (pubblicato in nota alla richiesta del pubblico ministero; nella nota informativa
d’accompagnamento sono riassunti anche i decreti del
tribunale per i minorenni di Ancona, poi riformati in
appello dal decreto 26.3.1999, cit.).
( 19 ) Questo punto spiega la differenza fra le decisioni sui trattamenti oncologici e quelle sulle trasfusioni
di sangue (caso che riguarda soprattutto i Testimoni di
Geova), ove invece i giudici intervengono pressoché
sempre con la sospensione della potestà per il tempo
strettamente necessario per effettuare la trasfusione.
( 20 ) Nei casi citati non vi fu: tutti i bambini che
ne furono protagonisti morirono entro breve tempo.
NGCC 2010 - Parte seconda
«Best interests of the child» o «best interests of children»?
petrata sul bambino stesso; tale violenza, e solo
essa, sarebbe stata contraria al suo interesse, in
quanto lesiva della sua personalità.
Nella specificità di ciascuna di quelle circostanze dunque, il rispetto della persona del minore capace di discernimento e della sua signo-
NGCC 2010 - Parte seconda
ria sul proprio corpo fu considerato prioritario
in confronto all’affermazione, a fondo paternalistico, del suo diritto a vivere: è un’applicazione rigorosa del principio, oggi purtroppo gravemente periclitante, del consenso informato.
165
L’USO DEL DIRITTO COMPARATO
NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA SUL REGIME
PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA (*)
di Andrea Fusaro
Sommario: 1. Il riferimento ai modelli stranieri. – 2.
Segue: l’intervento della Corte cost. sull’art. 184
cod. civ. – 3. Segue: la Gemeinschaft zur gesamten Hand. – 4. La resistenza delle Corti nei
confronti dell’utilizzo dell’argomento comparatistico. – 5. Lo sdoganamento del trust ed il suo
accostamento al fondo patrimoniale.
1. Il riferimento ai modelli stranieri.
Sembra davvero difficile trovare nell’ambito
della giurisprudenza in materia casi di influenza del diritto comparato ( 1 ) così forte da determinare mutamenti di orientamenti esistenti ( 2 ).
Circa l’utilizzo del modello straniero da parte della giurisprudenza italiana in tema di rap(*) Testo della relazione presentata al «IV Congresso nazionale di aggiornamento professionale»,
organizzato a Roma nei giorni 19-21.3.2009 dal
Consiglio nazionale forense e dalla Scuola superiore
dell’Avvocatura.
( 1 ) Sull’utilizzo della comparazione da parte delle
Corti al lettore italiano si offrono i saggi raccolti in Il
giudice e l’uso delle sentenze. Modalità e tecniche della comparazione giuridica, a cura di Alpa, Quaderni
Rassegna Forense, Giuffrè, 2006, nel cui ambito si
segnalano quelli dello stesso Alpa, Il giudice e l’uso
delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della
comparazione giuridica. La giurisprudenza civile, 15
ss., nonché di Somma, Metodi e scopi della comparazione giuridica nelle decisioni delle corti, 97 ss. Si segnala, inoltre, la recente traduzione di MarkesinisFedtke, Giudici e diritto straniero. La pratica del diritto comparato, Il Mulino, 2009. In lingua CanivetAndenas-Fairgrieve, Comparative Law before the
Courts, British Institute of Internationaland Comparative Law, Londra, 2004 (rist. 2005); AndenasFairgrieve, There is a World Elsewere. Lord Bingham and Comparative Law, in Tom Bingham and the
Transformation of the Law, a cura di AndenasFairgrieve, Oxford Univ. Press, 2009, 831 ss.
( 2 ) Nonostante la dottrina abbondi di contributi
che utilizzano il metodo comparatistico. Tra i contributi più recenti si segnalano quelli di Oberto, e
166
porti patrimoniali tra coniugi è consueto citare
la sentenza della Corte costituzionale del 1988
sull’art. 184 cod. civ. la quale, seppur senza
rinviare espressamente al diritto tedesco, ha
adottato una costruzione appoggiata ad un archetipo proprio di quella cultura, la Comunione a mani unite cosicché si tratta – intanto – di
analizzare questa pronuncia e dar conto delle
ricadute operative, ossia delle regole che ne sono state ricavate, misurandone lo scarto rispetto a quelle anteriormente vigenti.
Preliminarmente occorre indagare i modelli
stranieri stratificatisi nel diritto italiano e poi
tenuti presenti durante i lavori preparatori della riforma del 1975, per verificare se davvero
fosse presente la comunione a mani unite, la
quale non è una figura esibita dalla legislazione
tedesca, bensì modello di quella cultura, cui
sono ritenuti ispirarsi parecchi istituti del diritto vigente.
Quella è, in ogni caso, una sentenza che ha
fatto giurisprudenza in molti campi. L’idea che
la comunione legale sia una comunione senza
quote, una sorta di proprietà solidale è stata
applicata alla soluzione dei problemi più diversi: dal preliminare di vendita di beni comuni,
all’esecuzione per debiti personali sui beni oggetto della comunione, consolidando l’orientamento maggioritario, ancorché non incontrastato.
Colpisce, poi, la resistenza delle Corti ad utilizzare il diritto straniero per risolvere il quesito relativo alla responsabilità dei coniugi per
obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, rispetto al quale il nostro ordinamento denuncia un vuoto normativo che è invece assente negli altri a noi più affini, i quali contemplano in proposito regole legislative. Merita scortra questi, I contratti di convivenza tra autonomia e
privata e modelli legislativi, in Contr. e impr. Eur.,
2004, 17 ss.
NGCC 2010 - Parte seconda
Uso del diritto comparato nella giurusprudenza italiana
rere queste sentenze per verificare se la consapevolezza delle soluzioni straniere – seppur
non menzionate – abbia influenzato in maniera
sotterranea le nostre Corti.
Riveste, ancora, qualche attinenza con il tema della presente relazione la giurisprudenza
sul trust familiare ( 3 ), dove ora si registra il percorso opposto, per cui ora si assimila l’istituto
straniero a quello interno per estendere a quello regole di questo (come in tema di trascrizione), ora invece si denuncia la lacunosità del diritto italiano onde propiziare l’importazione
dello strumento straniero.
Impieghi maggiori dell’argomento comparatistico sono, invece, registrabili al di fuori dei
rapporti patrimoniali: ad esempio in materia di
cognome ( 4 ), di affidamento condiviso, senza
considerare il caso Englaro ( 5 ).
2. Segue: l’intervento della Corte
cost. sull’art. 184 cod. civ. Circa un ventennio fa la Corte ( 6 ) dichiarò non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art.
184 cod. civ., laddove sancisce che «gli atti
compiuti da un coniuge senza il necessario
consenso dell’altro coniuge e da questo non
convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’art.
2683», che era stata sollevata ( 7 ) per contrasto
con gli artt. 3, 24, 29, comma 2o, 42, comma
2o, Cost.
L’addebito secondo cui la norma si pone
«in contrasto con l’art. 42, comma 2o, Cost.,
perché indebolisce il diritto di proprietà del coniuge sul bene comune a scapito della famiglia
e quindi con pregiudizio della proprietà» fu respinto rimarcando la distanza della struttura
normativa della comunione legale rispetto a
( 3 ) Ad esempio, il fondo patrimoniale che diviene trust in sede di separazione: Trib. Milano,
7.6.2006, in Trusts, 2006, 575.
( 4 ) Cass., 22.9.2008, n. 23934, in Dir. fam. e
pers., 2008, 4, 1931.
( 5 ) Cass., 16.10.2007, n. 21748, in Giust. civ.,
2007, 11, 2366 e in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008,
384.
( 6 ) Corte cost., 17.3.1988, n. 311, in questa Rivista, 1988, I, 561.
( 7 ) Trib. Bari, 14.1.1987, in Giur. cost., 1987, II,
2, 645.
NGCC 2010 - Parte seconda
quella ordinaria: «... questa è una comunione
per quote, quella è una comunione senza quote;
nell’una le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex art.
2825 c.c.) e delimitano il potere di disposizione
di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); nell’altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per
oggetto i beni della comunione (arg. ex art.
189, comma 2o). Nella comunione legale la
quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui
i beni della comunione possono essere aggrediti
dai creditori particolari (art. 189), la misura
della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei
coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l’attivo e
il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro
eredi (art. 194)» ( 8 ).
3. Segue: la Gemeinschaft zur gesamten
Hand. La dottrina ha ricondotto questa comproprietà solidale, assente non solo nel diritto
positivo italiano, ma pure nelle discipline legislative degli ordinamenti affini, all’archetipo
germanico della comunione a mani unite, identificata alla radice di alcuni istituti tedeschi (tra
i quali la comunione coniugale) ed a suo tempo
evocata da prestigiosi autori degli anni venti
per ricondurvi la comunione contemplata dalla
disciplina previgente ( 9 ).
( 8 ) Di qui la conclusione che «nei rapporti coi terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni
della comunione. Il consenso dell’altro, richiesto dal
modulo dell’amministrazione congiuntiva adottato
dall’art. 180, comma 2o, per gli atti di straordinaria
amministrazione, non è un negozio (unilaterale) autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma
piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all’esercizio di un potere. Esso è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio».
( 9 ) Ferrara, Teoria delle persone giuridiche,
Marghieri-Utet, 1915, 481; Chironi, Comunione
degli utili tra coniugi, in Saggi e questioni, III, Bocca,
1914, 494; Cicu, Il diritto di famiglia, Athenaeum,
1914, 101.
167
Studi e Opinioni
La Gemeinschaft zur gesamten Hand si porge
quale stampo della comunione germanica ( 10 ),
descritta nel suo lato interno quale forma di
proprietà collettiva priva del riferimento a
quote e – quanto al suo funzionamento – caratterizzata dalla circostanza che ciascun comunista è investito di tutte le facoltà di godimento
sull’intero patrimonio ( 11 ). La distinzione rispetto alla comunione romanistica si appunta
nel difetto di titolarità individuale di quote,
singolarmente alienabili, sinché la contitolarità
perdura, salvo il loro affiorare soltanto in sede
di scioglimento, senza tuttavia tendere alla divisione, a differenza di quella.
Agli inizi del novecento la G.H. fu considerata da taluni ( 12 ) adatta a sistemare la comunione tra coniugi contemplata dal diritto francese, laddove risultava già penetrato nei paesi
di diritto consuetudinario, ravvisando in essa
un principio condiviso in molte zone, anche
non germaniche; altri, tuttavia, eccepirono come essa fosse rimasta sullo sfondo, senza informare di sé puntualmente gli istituti ( 13 ), cosicché con il tempo nel diritto francese si sarebbe
persa nella comunione romana ( 14 ), anche a seguito dell’intreccio con le regole della dote,
che avrebbero introdotto regole contrastanti
con il principio collettivistico, con il che nelle
stesse aree francesi di diritto consuetudinario
( 10 ) Gierke, Deutsches privatrecht, I, Duncker &
Humblot, 1895, 664 ss.
( 11 ) Stobbe, Miteigentum und gesamte Hand, in
Zeitschrift fuer Rechtsgeschichte, IV, 1864, 219.
( 12 ) Masse, Du caractère juridique de la communauté entre époux dans ses précédents historiques,
Paris, 1902, 238.
( 13 ) Meynial, Le caractére juridique de la communauté entre époux, in Révue trimestrelle de droit civil, 1903, II, 811, secondo il quale la comunione risalirebbe al XII secolo, limitata ai mobili, mentre la
Gesamte Hand sarebbe apparsa successivamente, affiancandosi ad altri principi nell’organizzazione della comunione legale; inoltre nel secolo XIV sarebbe
ricomparso il diritto romano, con una caratterizzazione individualistica ed il riaffiorare della tesi dell’incapacità della donna per proteggere i suoi eredi
dagli atti di disposizione indotti dal marito.
( 14 ) Brissaud, Manuel d’Histoire du droit privé
français, Parigi, 1908, 247, il quale invece all’origine
della comunione indicava motivazioni economiche,
attinenti alla protezione della donna.
168
la comunione avrebbe ristretto il proprio oggetto agli acquisti.
Secondo questa seconda tesi, nella comunione coniugale del Code Civil i tratti della Gesamte Hand non sarebbero, quindi, più riconoscibili in ragione di un mutato ruolo della donna: era venuta meno sia la regola della disposizione necessariamente congiunta, sia quella
della permanenza dell’indivisione anche a seguito della morte di un coniuge; difettava la separazione dei debiti della comunione da quelli
dei coniugi ( 15 ).
Quanti adottavano tale prospettiva rigorosa,
circa il riscontro della persistenza del modello,
a maggior ragione l’hanno escluso nei confronti della comunione coniugale del diritto italiano preunitario ed unitario, considerando come
se alla base di ogni Gesamte Hand si colloca «la
salvaguardia e l’incremento del patrimonio
della famiglia», al contrario nella legislazione
italiana sembrava piuttosto sentita «la preoccupazione di rendere sicuri i beni della moglie
dal malgoverno del marito», lasciando nella
proprietà solitaria i beni capitali, secondo la
mentalità dell’indipendenza propria della dote;
inoltre nel nostro diritto la comunione era pur
sempre opzionale, mentre nella disciplina francese si presumeva ( 16 ); insomma troppa distanza si era venuta a creare da quel modello ( 17 ).
Diversa conclusione fu privilegiata per la comunione coniugale del BGB, in linea con la tradizione ( 18 ).
L’assimilabilità alla G.H. della comunione
coniugale italiana retta dal codice ottocentesco
( 15 ) Meynial, Le caractére juridique, cit., 820.
( 16 ) Una sintesi delle tesi avanzate dagli storici
del diritto sull’origine della comunione in Italia è offerta da Messineo, La natura giuridica della comunione coniugale dei beni, Athenaeum, 1919, 62 ss., il
quale concludeva che in Italia la comunione si presentava «come la nuda sopravvivenza di un’organizzazione patrimoniale estranea al fondo più originale
del nostro diritto storico» (ivi, 66).
( 17 ) L’estraneità della Gesamte Hand al nostro diritto era registrata, tra gli altri, da Bonelli, I concetti di comunione e personalità nella teorica delle società commerciali, in Riv. dir. comm., 1903, I, 285, spec.
303 e Barassi, Istituzioni di diritto civile, 1955,
Giuffrè, 85.
( 18 ) Stobbe, Handbuch des Deutschen Privatrechts,
IV, Berlin, 1885, 216.
NGCC 2010 - Parte seconda
Uso del diritto comparato nella giurusprudenza italiana
fu, perciò, revocata in dubbio, anche in considerazione della presenza di quote ideali, pur
registrandosi una derivazione da essa, a fianco
del modello romano ( 19 ). Successivamente l’accostamento è stato riproposto, peraltro intendendolo in termini tendenziali piuttosto che
puntuali.
La tesi della comunione legale senza quote
predicata dalla Corte nella pronuncia citata è
stata fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ne ha derivato l’indisponibilità della quota, quindi la sua intrasferibilità all’esterno della coppia, e l’ha applicata in
tema di oggetto ed amministrazione della comunione legale, di litisconsorzio necessario,
nonché di espropriazione di beni comuni.
La qualificazione è stata, invero, impiegata
quale premessa non solo per assegnare a ciascun coniuge il potere di disporre dell’intero
bene, relegando il consenso dell’altro a requisito di regolarità del procedimento formativo del
negozio ( 20 ), per affermare l’identità del titolo
di acquisto anche per il coniuge rimasto estraneo al contratto ( 21 ), per assecondare la facoltatività del contraddittorio nell’azione di esecuzione in forma specifica intentata ai sensi
dell’art. 2932 cod. civ. ( 22 ), per escludere che
l’esecuzione possa avere ad oggetto la quota
( 23 ), persino per sancire l’inammissibilità della
partecipazione di estranei ( 24 ), peraltro conclu( 19 ) Messineo, La natura giuridica della comunione coniugale dei beni, cit., 227, il quale affermava che
l’istituto della comunione coniugale «compete, per
quote intellettuali, di norma eguali, a ciascuno dei titolari in quanto singolo, cui, però, è inibita la disponibilità del diritto sulla quota stessa; ha per esclusivo
amministratore il marito ed è dissolubile e divisibile,
unicamente quando venga a sciogliersi o ad allentarsi
il vincolo personale tra i soggetti, per le cause e nei
modi riconosciuti tassativamente dalla legge».
( 20 ) Cass., 24.11.2000, n. 15177, in Riv. notar.,
2003, 958, con nota di Guglielmo.
( 21 ) Cass., 6.7.2004, n. 12313, in Giust. civ.,
2005, I, 705.
( 22 ) Cass., 7.3.2006, n. 4890, in Dir. e giust.,
2006, n. 19, 44.
( 23 ) Cass., sez. un., 4.8.1998, n. 7640, in Giur. it.,
1999, 741; Trib. Bari, 11.6.1998, in www.Judicium.it.
( 24 ) Cass., 14.1.1997, n. 284, in Fam. e dir., 1997,
285.
NGCC 2010 - Parte seconda
sione di più agevole approdo transitando per
itinerari alternativi.
Occorre, pertanto, avvertire che non tutti tali assunti appaiono corollari della qualificazione privilegiata dalla Corte e segnalare che altri
sono stati talora respinti; ad esempio, di recente le Sezioni Unite hanno rimarcato il carattere
necessario del contraddittorio ( 25 ).
L’evocazione di quel modello da parte della
Corte costituzionale italiana nel 1988 – ad opera di una sentenza scritta da un preclaro giurista, profondo conoscitore del diritto tedesco e
che aveva approfondito il regime patrimoniale
della famiglia in Germania ( 26 ) – rappresenta
una perspicua conferma dell’assunto circa la
persistenza di modelli – principi o crittotipi –
alla radice delle civiltà giuridiche, caratterizzati
da movenze carsiche, tali da farli affiorare anche a notevole distanza ed assumendo morfologie disparate – epifanie o regole giuridiche –
riconducibili ad essi in maniera sufficientemente riconoscibile.
4. La resistenza delle Corti nei confronti dell’utilizzo dell’argomento
comparatistico. La scarsa dimestichezza delle Corti con l’argomento comparatistico risalta
nella giurisprudenza maturata sulla questione
della rappresentanza reciproca dei coniugi in
ordine alle obbligazioni contratte nell’interesse
della famiglia, rispetto alla quale nel nostro ordinamento si registra un vuoto normativo, assente in altri ( 27 ), in specie nel diritto francese
ed in quello tedesco ( 28 ).
( 25 ) Cass., sez. un., 24.8.2007, n. 17952, in Giust.
civ., 2007, I, 2405, riprendendo Cass., 11.4.2002, n.
5191, in Giur. it., 2003, 1150.
( 26 ) Mengoni, Il regime patrimoniale della famiglia in Germania, in Riv. dir. matr., 1959, 174.
( 27 ) In Inghilterra fu a lungo – fino al 1970 – riconosciuta l’«Agency of necessity» – configurata anche
in assenza o addirittura contro la volontà del marito
– che permetteva alla moglie di riscuotere i crediti
del marito o di contrarre obbligazioni a suo nome
per far fronte alle proprie necessità; il dovere del
marito di provvedere al mantenimento fu sostanzialmente superato dalle leggi che hanno consentito alle
Corti in sede di separazione di ordinare a ciascun
coniuge di provvedere al mantenimento dell’altro.
( 28 ) La responsabilità solidale è regolata anche in
Spagna.
169
Studi e Opinioni
In Francia in origine il marito doveva mantenere la moglie; poi nel 1942 l’art. 214 fu modificato onde estendere l’obbligo di contribuzione alla moglie, seppure limitatamente alle sue
risorse; nel 1965 fu sancito il contributo della
moglie nei termini del contributo domestico o
la collaborazione all’attività del coniuge, ed il
potere di chiedere credito a nome del marito fu
sostituito dalla rappresentanza reciproca per i
bisogni familiari. La presunzione che la principale responsabilità per i bisogni della famiglia
gravasse sul marito cadde con la Riforma del
divorzio del 1975, che affermò l’obbligo di
contribuzione di entrambi.
L’art. 220 code civil ( 29 ) attribuisce espressamente a ciascun coniuge il potere di concludere contratti necessari per il sostentamento della
famiglia ed il mantenimento dei figli, impegnando anche l’altro, purché nei limiti del necessario ( 30 ).
In Germania occidentale la legge dei pari diritti del 18.7.1957 – rimasta in vigore sino alla
riforma del 1976 – al par. 136 sanciva il dovere
di entrambi i coniugi di contribuire al menage
familiare, la moglie lavorando in casa, fuori solo se necessario; inoltre introduceva la presunzione di non compensazione dell’eventuale
contributo eccedente le necessità. La riforma
del 1976 ha previsto l’adempimento delle prestazioni domestiche da parte di entrambi. Il
par. 1357 del BGB, rubricato «Negozi per il
soddisfacimento dei bisogni di vita» detta una
( 29 ) Frutto dei successivi interventi del legislatore: Loi du 17 mars 1803; Loi du 18 février 1938; Loi
du 22 septembre 1942; Loi du 13 juillet 1965, n. 65570, art. 1; Loi du 23 décembre 1985, n. 85-1372, art.
2.
( 30 ) Secondo l’art. 220: «Chacun des époux a
pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour
objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l’un oblige
l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu,
néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité
ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non
plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des
deux époux, pour les achats à tempérament ni pour
les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur
des sommes modestes nécessaires aux besoins de la
vie courante».
170
regola non troppo distante da quella contenuta
nel codice francese ( 31 ).
Il vuoto della legislazione italiana riformata
in tema di responsabilità solidale dei coniugi fu
denunciato già da Francesco Santoro Passarelli
( 32 ), il quale lo riteneva, sul piano dell’effettività, il problema forse più importante del governo della famiglia «perché riguarda l’affidabilità
dei coniugi di fronte ai terzi».
Il modello delle sentenze emesse nei casi implicanti la soluzione del quesito circa la responsabilità solidale dei coniugi per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia non
contempla la citazione delle norme tedesche e
francesi appositamente dedicate. Constatiamo,
tuttavia, un progressivo avvicinamento degli
esiti delle decisioni delle controversie, risultante dall’impiego della tecnica dell’apparenza del
diritto.
La chiusura all’importazione delle soluzioni
straniere manifestata dalle prime decisioni di
merito fu condivisa dalla Supr. Corte nel 1990,
escludendo che nella disciplina riformata del
diritto di famiglia l’obbligazione assunta da un
coniuge per soddisfare bisogni familiari ponga
l’altro nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi, e ciò indipendentemente dalla
circostanza che i coniugi si trovino in comunione dei beni, essendo tale regime rilevante in ordine all’invocabilità da parte del creditore della
garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, prevista dagli art. 189 e 190
( 31 ) Questa la traduzione del par. 1357: «(1) Ciascun coniuge è legittimato a compiere, con effetto
anche nei confronti dell’altro coniuge, negozi per
l’adeguato soddisfacimento dei bisogni di vita della
famiglia. Tramite tali negozi, entrambi i coniugi acquistano diritti e obblighi, salvo che diversamente
risulti dalle circostanze. (2) Un coniuge può limitare
o escludere la legittimazione dell’altro coniuge a gestire affari con effetto anche nei suoi confronti; se
per la limitazione o l’esclusione non sussiste una sufficiente ragione, il Tribunale della tutela deve eliminarle su domanda».
( 32 ) Santoro Passarelli, Poteri e responsabilità
patrimoniali dei coniugi per i bisogni della famiglia,
in Riv trim. dir. e proc. civ., 1982, 3.
NGCC 2010 - Parte seconda
Uso del diritto comparato nella giurusprudenza italiana
cod. civ. ( 33 ). Nel corpo della motivazione il
dato legislativo straniero è menzionato, ma per
ricavare un argomento contrario alla sua applicazione: «non v’è dunque una regola che, come
quella contenuta nell’art. 220 del c.c. francese,
introduca la solidarietà passiva del coniuge non
stipulante per le obbligazioni assunte dall’altro
coniuge per soddisfare i bisogni della famiglia.
Già questo silenzio del legislatore induce a ritenere che tale pretesa solidarietà non sussiste, in
quanto la questione era nota e dibattuta negli
anni che accompagnarono l’elaborazione della
riforma. Pare infatti logico dedurne che non si
sia trattato di una distrazione del legislatore ma
di una precisa volontà di non introdurre una deroga così vistosa al principio ex art. 1372, comma 2o, c.c. per cui il contratto non produce effetti
rispetto ai terzi».
Nel 1992 l’atteggiamento è ribadito, affermando che «qualora l’acquisto di un bene destinato ai bisogni della famiglia sia stato effettuato
da un coniuge in nome proprio, il venditore può
invocare la responsabilità solidale dell’altro coniuge, sotto il profilo dell’apparenza del diritto,
purché vi siano circostanze idonee a determinare
un ragionevole convincimento che il contratto
sia stato stipulato anche in rappresentanza di
detto altro coniuge»; è decisiva la considerazione che esclude la sola sussistenza del rapporto
coniugale e la suddetta destinazione del bene
( 33 ) Cass., 18.6.1990, n. 6118, in Giust. civ.,
1990, I, 2891 e 2282; in Vita not., 1990, 523; in Dir.
fam. e pers., 1991, 488. Nella specie una società aveva citato in giudizio due coniugi chiedendone la
condanna in solido al pagamento della somma costituente il prezzo di mobilia ai convenuti, ma la moglie eccepiva che l’acquisto era stato perfezionato
dal solo marito. Il Tribunale di Nicosia con sentenza
23.11-15.12.1982 aveva accolto la domanda, mentre
la Corte d’appello di Caltanissetta l’aveva rigettata
nei confronti della moglie, affermando che quest’ultima aveva partecipato alle trattative per la scelta dei
mobili e la fissazione del prezzo, compreso l’ottenimento di uno sconto; ma che tali circostanze perdevano di rilievo di fronte all’accertamento che il venditore aveva in realtà voluto contrarre solo con il
marito, al quale soltanto erano state fatte firmare le
commissioni e le cambiali, e col quale soltanto era
intercorsa copiosa corrispondenza sia per il rinnovo
delle cambiali che per la determinazione degli interessi.
NGCC 2010 - Parte seconda
compravenduto siano idonei ad ingenerare
l’affidamento del terzo ( 34 ).
( 34 ) Cass., 28.4.1992, n. 5063, in Giur. it., 1993,
I, 1, 1036, con nota di Carbone. In motivazione si
legge che «già questa Corte, con la cennata sentenza
n. 3177/1975, in riferimento al regime patrimoniale
della famiglia anteriore alla novella del 1975, escluse
che il coinvolgimento del coniuge non stipulante potesse trarre fondamento da teorie, riferite alla “procura tacita” (che ha pur trovato adesione in Cass.,
23.9.1986, n. 5709), alla “rappresentanza volontaria”,
alla “rappresentanza legale”, all’“utile gestione”, all’“azione surrogatoria”. A maggior ragione i riferimenti detti non si conciliano – in via astratta – con il
nuovo diritto di famiglia, che non prevede più nel marito “il capo della famiglia” (al quale riferire gli atti
negoziali compiuti dalla moglie), ma pone i coniugi in
posizione di uguaglianza, con rispettiva autonomia
contrattuale. Per il riferimento alla rappresentanza
volontaria fondata su una procura tacita sarebbe necessario accertare, caso per caso, come per qualunque
manifestazione tacita di volontà, un comportamento
del marito, che, per la sua concludenza e per la sua
conseguente incompatibilità con una volontà diversa,
consenta di indurre la volontà di lui di conferire alla
moglie una procura a rappresentarlo (sent. n. 3177/
1975, cit.). Per quanto concerne l’“apparenza” – sulla
quale essenzialmente si fonda la sentenza impugnata
– è evidente che non costituiscono sufficiente e decisivi elementi lo stato di coniugata dell’acquirente e la
natura dei beni acquistati. Il principio dell’apparenza
giuridica o dell’affidamento postula il concorso di due
condizioni: a) uno stato di fatto apparente non corrispondente all’effettiva situazione giuridica; b) il convincimento dei terzi, derivante da errore scusabile e
come tale immune da colpa, che lo stato di fatto apparente rispecchi la realtà giuridica (cfr., per il principio
dell’apparenza giuridica, tra le tante, Cass.,
17.3.1975 n. 1020; 7.10.1975, n. 3177; 12.8.1976, n.
3029; 12.9.1978, n. 4195; 16.11.1984, n. 5818;
19.1.1987, n. 423). Il regime patrimoniale vigente tra
i coniugi, con la relativa pubblicità, di per sé non impedisce che l’apparenza del diritto possa essere invocata anche quando la situazione apparente non coincide
con quella risultante dalla pubblicità predetta. È però
compito del giudice del merito l’accertamento – incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua
motivazione – dello stato di fatto apparente, tale da
ingenerare l’affidamento del terzo, e dell’errore scusabile di questi. Hanno rilevanza in tale accertamento il
comportamento tenuto dai coniugi, anche in contratti
precedenti, il ripetersi dei rapporti negoziali; le modalità di pagamento ed ogni altra peculiarità del caso
concreto. Tale accertamento – per le conseguenze che
171
Studi e Opinioni
Con una pronuncia di pochi mesi successiva
si inaugura, tuttavia, un nuovo corso almeno in
ordine alle obbligazioni contratte nell’interesse
dei figli, assumendo il riverbero esterno del dovere imposto dall’art. 147 cod. civ. ad entrambi
i coniugi di mantenere, educare ed istruire la
prole comune; la conseguenza è che, rispetto
alle obbligazioni derivanti dal soddisfacimento
di esigenze primarie della famiglia, quali, in
particolare, la cura della salute, viene riconosciuto il potere di ciascun coniuge, con efficacia verso i terzi (creditori), in virtù di un mandato tacito, di compiere gli atti occorrenti e di
assumere le correlative obbligazioni con effetti
vincolanti per entrambi; merita sottolineare come si faccia capo alla teoria del «mandato tacito», e si presenti tale acquisizione come «deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge
che ha personalmente stipulato l’obbligazione,
risponde del debito contratto». Nella specie la
responsabilità solidale fu affermata per l’obbligazione contratta da un genitore per inevitabili
prestazioni sanitarie erogate da un professionista
alla moglie ed ai figli minori della coppia ( 35 ).
L’orientamento viene ripreso negli anni successivi, ribadendo la regola che «anche in regi-
ne ha tratto il giudice del merito – risulta, per tutto
quanto rilevato, del tutto carente nella sentenza impugnata».
( 35 ) In motivazione si legge che «nel caso di specie, la Corte di merito, oltre ad evidenziare la natura
di esigenza primaria della famiglia nelle cure mediche
apprestate alla R., ha rilevato l’affidamento, ingenerato nel medico curante dal marito di costei col comportamento, che l’obbligazione è stata contratta anche
per suo conto. È risultato, infatti, che le prestazioni
oggetto del giudizio sono state eseguite negli anni dal
1977 al 1980 e sono state precedute da altre prestazioni eseguite nel 1974-76 a favore della R. e del figlio
Fabio e che queste ultime prestazioni sono state pagate dal C., il quale non ha sollevato obiezioni in quella
occasione. Il secondo giudice ha evidenziato infine, al
riguardo, una ulteriore emergenza di non poco momento, consistita nel fatto che, quando si è trattato di
pagare le ultime prestazioni oggetto della presente
causa a favore della moglie e delle due figlie minori, il
C., nell’incontro avuto con il medico, ha sollevato
obiezioni unicamente sull’ammontare dei compensi
chiesti, non negando in radice e riconoscendo implicitamente la propria obbligazione». Cass., 25.7.1992,
n. 8995, in Dir. fam. e pers., 1993, 91; in Vita not.,
172
me di comunione legale, dei debiti personalmente accesi da un coniuge per soddisfare i bisogni
della famiglia non risponde pure il coniuge di
quest’ultimo», ma pure l’eccezione secondo cui
si determina la responsabilità di entrambi non
solo nella ipotesi del rilascio di esplicita o tacita procura, ma pure qualora «in base al principio (non della mera apparenza, ma) dell’affidamento ragionevole dei terzi e della loro conseguente tutela, sia da ritenere, “per facta concludentia”, che il coniuge contraente abbia agito
non soltanto in proprio, ma anche in nome del
coniuge». Il caso riguardava una fornitura di
arredi, bensì ordinata dal marito, ma rispetto
alla quale constavano variazioni impartite dalla
moglie ( 36 ).
Il nuovo corso non conduce, però, ad esiti
coincidenti con quelli stranieri, dal momento
che l’affermazione della responsabilità solidale
è pur sempre subordinata alla prova del comportamento idoneo ad ingenerare affidamento:
«il coniuge non contraente è responsabile personalmente, oltre che nei casi in cui abbia conferito all’altro coniuge, in forma espressa o tacita,
una procura a rappresentarlo, solo quando sia
configurabile una situazione tale da far ritenere,
alla stregua del principio dell’apparenza giuridica, che l’obbligazione sia stata assunta in suo nome» ( 37 ).
1993, 219; in Giur. it. 1993, I, 1, 1512, con nota di
Musy; in questa Rivista, 1994, I, 26, con nota di Caravaglios.
( 36 ) Cass., 7.7.1995, n. 7501, in Dir. fam. e pers.,
1997, 1290, con nota di Curti. In motivazione si
apprende che i giudici di primo grado avevano accertato che effettivamente la moglie, per conto del
marito, aveva richiesto alcune variazioni sulla fornitura di pezzi ulteriori o diversi rispetto a quelli ordinati, e che i giudici di appello avevano confermato
risultare che la gestione concreta della fase successiva all’ordine fu tenuta dalla consorte dell’appellante
che agiva per conto e nell’interesse del marito o,
perlomeno, si presentava credibilmente alla ditta come legittimata ad effettuare delle scelte in luogo del
marito, ancora, che il marito, non avesse sollevato
alcuna obiezione in merito all’intera fornitura ed anzi l’ avesse riconosciuta, ingenerando nella venditrice il ragionevole convincimento che le modifiche richieste dalla moglie fossero state effettuate in suo
nome.
( 37 ) Si trattava di un trasloco di mobili, dalla vecNGCC 2010 - Parte seconda
Uso del diritto comparato nella giurusprudenza italiana
Nel caso oggetto dell’ultima pronuncia della
Supr. Corte l’onere della prova risulta soddisfatto, cosicché la responsabilità solidale è affermata: «Nella disciplina del diritto di famiglia,
introdotta dalla l. 19.5.1975, n. 151, l’obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto
che i coniugi si trovino in regime di comunione
dei beni, essendo la circostanza rilevante solo
sotto il diverso profilo dell’invocabilità da parte
del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei
limiti di cui agli artt. 189 e 190 (nuovo testo)
c.c.» ( 38 ).
chia alla nuova abitazione, eseguito in adempimento
di un contratto stipulato con la sola moglie – in regime di separazione dei beni, la quale non aveva assunto l’obbligazione in nome del marito, né era
emerso che la stessa avesse ricevuto alcun mandato
da costui né, infine, che sussisteva una situazione di
apparenza giuridica che facesse ritenere che questa
operasse – pur senza spenderne il nome – per conto
del marito. Nei gradi di merito fu valorizzata la circostanza che il marito era stato assente per tutto il
periodo in cui si erano svolte le operazioni di trasloco (per cui nulla escludeva che questo fosse stato
realizzato a sua insaputa o contro la sua volontà);
inoltre fu ritenuto irrilevante che sul campanello
della casa in cui furono trasportati i mobili fosse
scritto il suo cognome, precisando al riguardo «potendo, per ipotesi, il campanello recare il nome del
precedente occupante l’appartamento o, anche il cognome dei figli dei coniugi, giudizialmente o anche di
mero fatto separati». Ancora degno di nota il passo
secondo cui si precisa come non risultasse, in alcun
modo, che i coniugi avessero «concordato» il trasloco da un alloggio all’altro, e che, comunque il creditore, in tanto avrebbe potuto invocare la responsabilità del terzo, non contraente in quanto avesse dedotto di essere a conoscenza della decisione, assunta
dai coniugi, di procedere al trasloco da un appartamento all’altro. Cass., 6.10.2004, n. 19947, in Foro
it., 2005, I, 392.
( 38 ) Nella motivazione si legge che «In base al
concreto interesse delle parti, può essere considerato
parte sostanziale di un rapporto anche il coniuge rimasto apparentemente estraneo alla contrattazione, con
conseguente sua responsabilità solidale per le obbligaNGCC 2010 - Parte seconda
Al comparatista questa vicenda evoca le teorie che assumono come la circolazione di un
modello giuridico possa avvenire non solo a diversi livelli dell’ordinamento di arrivo rispetto
a quello di partenza, ma pure attraverso regole
ora affermate – o declamate –, ora praticate,
quindi realizzandosi una dissociazione tra il
piano delle verbalizzazioni e quello operativo,
nel senso che da noi la responsabilità solidale
dei coniugi per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia è in linea di principio
risolutamente esclusa, ma nei fatti spesso affermata, attraverso la tecnica della protezione dell’affidamento.
Inoltre è curioso ricordare che i recenti progetti italiani sulle unioni civili e simili prevedevano la responsabilità solidale dei conviventi,
senza far caso al fatto che da noi tra i coniugi
difetta. Essi erano chiaramente influenzati dai
PACS francesi, che appunto estendono ai conviventi la regola vigente tra i coniugi, ma con la
piccola differenza che la situazione nostrana è
un po’ diversa.
5. Lo sdoganamento del trust ed il
suo accostamento al fondo patrimoniale. In una pronuncia di merito troviamo affermato che l’atto costitutivo di trust su beni immobili, pur non rientrando in alcuna delle categorie di atti previste dagli art. 2643 e 2645
cod. civ., appare assimilabile al fondo patrimoniale, in entrambi i casi venendo posto un limite – per il titolare formale dei beni – alla dispozioni assunte dall’altro coniuge. Nella specie il giudice
di merito ha accertato che il marito separato, pur non
avendo partecipato alle trattative intercorse tra la moglie ed il gestore di uno stabilimento balneare, per il
rinnovo della locazione stagionale di una cabina e di
una tenda da sole, che da molti anni erano adoperate
dalla moglie stessa e dalla figlia minore, da tempo
aderiva di fatto a tale utilizzo, così inducendo il ragionevole affidamento del gestore, e da tale accertamento
ha desunto che egli doveva ritenersi solidalmente obbligato con la moglie per le relative obbligazioni, individuando ulteriore conferma della sussistenza dell’obbligazione solidale nel comportamento tenuto dal marito che non aveva contestato la richiesta del gestore
ed aveva contestualmente promesso di pagare (Cass.,
sez. III, 8.1.1998, n. 87, D’Onofrio c. Mazzoni, Giust.
civ., 1998, I, 1314)». Cass., 15.2.2007, n. 3471; in
Dir. fam. e pers., 2008, 48.
173
Studi e Opinioni
nibilità di determinati beni per il raggiungimento di uno scopo determinato; quindi, in
analogia con la previsione di cui all’art. 2647
cod. civ. per la costituzione del fondo patrimoniale, anche l’atto costitutivo del trust va assoggettato a trascrizione (e ciò anche in considerazione dell’esigenza di rendere opponibile ai
terzi il vincolo di destinazione posto a carico di
beni immobili, per i quali il legislatore nazionale ha previsto una disciplina tutta improntata al
regime pubblicistico) ( 39 ).
Registriamo, quindi, un accostamento del
trust al fondo patrimoniale in funzione dell’omologazione dell’istituto straniero a quello
nostrano, al fine di agevolarne l’ambientazione
nel nostro ordinamento. Merita notare come
questa operazione presupponga un verdetto
opposto quanto alla funzione assolta dal trust,
dal momento che il suo impiego in materia è
subordinato al perseguimento di obiettivi inattingibili tramite il fondo.
( 39 ) Trib. Milano, 29.10.2002, in Riv. notar.,
2003, 253.
174
NGCC 2010 - Parte seconda
DOVE VA LA RESPONSABILITÀ CIVILE? (*)
di Guido Alpa
Sommario: 1. La situazione di base. – 2. Il rapporto
tra regole generali e regole speciali. – 3. Le manipolazioni dell’interprete. – 4. Dietro lo schermo
delle argomentazioni formali.
1. La situazione di base. L’evoluzione
della giurisprudenza in materia di responsabilità civile assomiglia ad una sinusoide che si alza
o si abbassa a seconda che si passi dalla responsabilità fondata sulla colpa alla responsabilità fondata sulla responsabilità civile. I mobili confini della responsabilità civile si possono tracciare anche seguendo questo criterio, e
non solo quello in cui si riscontra una espansione tendenziale anche se non sistematica dell’area dell’illecito. L’incertezza che segna la
giurisprudenza in questa branca del diritto privato emerge sia dalla applicazione della clausola generale di ingiustizia del danno, sia dalla
applicazione dei criteri di imputazione della responsabilità, e, in connessione con questi, dalla
definizione del requisito della causalità. Mentre può essere giustificata, per la sua stessa natura, l’incerta applicazione della clausola generale, attesa la sua finalità di consentire l’adattamento delle regole ai nuovi postulati della vita
civile, dell’economia e dei bisogni sociali, più
complessa è la spiegazione delle esitazioni o
delle regressioni nella applicazione dei criteri
di imputazione della responsabilità, e altrettanto preoccupante può essere l’impiego discrezionale del criterio del nesso di causalità per
l’allocazione del rischio.
Non è però sufficiente chiedersi quali direzioni stia prendendo la responsabilità civile, essendo necessaria una maggiore consapevolezza
del modo nel quale le direzioni che essa prende
sono decise. L’impressione che si riceve è che
dietro l’uso degli schemi formali stia emergendo, oggi più che non in altri tempi, un atteggia(*) Seminario in onore di Guido Calabresi per
l’inaugurazione del Master in Diritto privato europeo, Roma, 15.1.2010.
NGCC 2010 - Parte seconda
mento pragmatico, anche nella giurisprudenza
di legittimità. Decidere sulla base di valutazioni
pragmatiche implica pertanto un apprezzamento particolare delle circostanze, una consapevolezza particolare dei criteri di distribuzione del danno, una combinazione ottimale di
istituti, principi, regole per ottenere il risultato
desiderato.
Alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza recente documentano questi assunti. Essi costituiscono la base necessaria per poter dare alcune risposte ai dubbi che si possono avanzare.
(i) Gli interessi protetti.
La clausola generale dell’art. 2043 cod. civ. è
stata letta, in una delle più recenti decisioni ( 1 )
come la «lesione di una posizione giuridica altrui, ritenuta meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, lesione non altrimenti giustificata». L’espressione «posizione giuridica» è volutamente generica ed ampia, perché ormai è acquisito, dopo quasi cinquant’anni dalla sua prima e compiuta elaborazione dottrinale ( 2 ), che
il requisito dell’ingiustizia si deve ravvisare nella lesione di un interesse giuridicamente protetto; «protetto» implica che l’ordinamento lo riconosce meritevole di tutela, e ciò non in base
ad una norma specifica emanata ad hoc – altrimenti si trasformerebbe il nostro sistema, che è
atipico, in un sistema tipico – ma in base ai
principi e ai valori sui quali l’ordinamento riposa. Ciò implica pure che non si possa interpretare la clausola generale come correlata ad un
sistema di tipicità delle cause di giustificazione.
( 1 ) Cass., 17.12.2009, n. 26516, in Dir. e giust.,
2010; la fattispecie concerneva il danno da fumo per
l’uso di sigarette «light»; nella specie il risarcimento
è stato negato, in quanto la domanda era stata formulata invocando l’applicazione dell’art. 2050 cod.
civ. anziché della clausola generale, e con riguardo
alla incidenza lesiva del messaggio pubblicitario derivante dalla scritta «light» apposta sul pacchetto di
sigarette.
( 2 ) Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Giuffrè, 1964.
175
Studi e Opinioni
Tuttavia quando si tratta di interessi tipizzati – come accade per il numerus clausus dei diritti reali – l’ingiustizia è evidente di per sé, e
non deve essere provata la meritevolezza dell’interesse di cui si chiede la protezione. In
questo senso, il titolare di un diritto reale non
è tenuto a provare il danno subìto poiché il
danno è in re ipsa ( 3 ). Il diritto di proprietà è
difeso in modo «forte»: e ciò quanto agli obblighi del detentore nei confronti del proprietario ( 4 ), quanto agli obblighi dei Comuni nei
confronti dei proprietari confinanti con le
strade invase dalle acque e defluite in modo
anomalo ( 5 ), quanto alle opere comunali danneggiate dalle mareggiate per omissione di
manutenzione della rete ferroviaria da parte
del gestore ( 6 ).
La tutela della proprietà è materia di una
giurisprudenza nutrita della Corte europea dei
diritti dell’uomo, che interpreta estensivamente l’art. 1 del protocollo addizionale ( 7 ).
Non sempre però la giurisprudenza, per tutelare la proprietà – o il patrimonio del danneggiato – si basa sulla lesione di diritti reali.
Emblematico è il caso della responsabilità della
società di revisione per il danno risentito dagli
azionisti che avevano fatto affidamento sulle
informazioni concernenti la correttezza dei bilanci della società emittente diffuse dalla società di revisione. In questi casi, si preferisce parlare di violazione della libertà contrattuale degli investitori, pur tenendosi in conto l’andamento della borsa e quindi il valore di mercato
oscillante delle azioni societarie ( 8 ).
D’altra parte, la invocazione di un diritto
( 3 ) Cass., 9.6.2008, n. 15238, in Mass. Giust. civ.,
2008; la fattispecie riguardava il danno risentito dai
condomini che non avevano potuto parcheggiare la
loro auto nelle aree condominiali riservate a questo
uso.
( 4 ) Trib. Marsala, 30.1.2007, in Arch. loc.,
2008, 401.
( 5 ) Cass., 6.2.2007, n. 2566, in Foro it., 2008, I,
599.
( 6 ) Trib. Paola, 30.7.2007, ibidem, 282.
( 7 ) Corte eur. dir. uomo, 20.1.2009, n. 75909,
in Giur. it., 2009, 2398; M. Trimarchi, Proprietà e
impresa, in Contr. e impr., 2009, 894 ss.
( 8 ) Trib. Milano, 4.11.2008, in Giust. a Milano,
2008, 11, 76.
176
soggettivo, anzi «fondamentale» in quanto costituzionalmente garantito, quale è quello della
salute giustifica l’imputazione di responsabilità
al Comune per disservizio nello smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e il risarcimento del
danno ai residenti ( 9 ).
Mentre più difficile è il cammino della tutela
risarcitoria dei diritti umani riconosciuti dalla
Carta europea dei diritti dell’uomo ( 10 ). Sempre in tema di proprietà sussiste una divergenza per il momento inconciliabile tra la Corte
europea e la Corte di cassazione in materia di
occupazione acquisitiva, riconoscendo la prima al privato titolare del bene un diritto risarcitorio che si aggiunge alla restituzione del bene, e la seconda un risarcimento del danno, ora
mero indennizzo, che implica la perdita del bene per la sua trasformazione irreversibile ( 11 ),
oppure, secondo il Consiglio di Stato, la scelta
tra il rimedio risarcitorio e quello restitutorio
( 12 ).
Così come è tormentata la definizione dei
criteri di responsabilità dello Stato per la omessa o tardiva attuazione di direttive comunitarie.
La Corte di cassazione continua a ragionare in
termini di dualità degli ordinamenti – comunitario ed interno ( 13 ) – mentre l’orientamento
univoco della Corte di Giustizia dell’Unione
europea è nel senso della unicità degli ordinamenti già dalla decisione Costa c. Enel che risale al 1964. La materia è stata oggetto di un
(curioso) révirement dal momento che dal( 9 ) Giud. Pace Napoli, 27.4.2006, in Resp. e risarc., 2008, n. 2, 22.
( 10 ) Per i riferimenti bibliografici essenziali v. Alpa, I diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario e il ruolo dell’avvocatura, in Rass. Forense, 67 ss.,
(in cui si sostiene l’applicabilità diretta delle disposizioni della CEDU, assumendosi una posizione in allora isolata in dottrina); di recente, Galgano, Danno non patrimoniale e diritti dell’uomo, in Contr. e
impr., 2009, 883 ss.
( 11 ) In tema di danno da occupazione appropriativa, v. Cass., sez. un., 8.4.2008, n. 9040, in Guida al
dir., 2008, n. 30, 84; Cass., sez. un., 19.12.2007, n.
26732, in Mass. Giust. civ., 2007; Cass., sez. un.,
23.11.2007, n. 24397, in Mass. Giust. civ., 2007.
( 12 ) Cons. Stato, V sez., 7.4.2009, in Guida al
dir., 2009, n. 19, 95.
( 13 ) Cass., sez. un., 17.4.2009, n. 9147, in Dir.
comm. int., 2009, II, 709, con nota di Rapisarda.
NGCC 2010 - Parte seconda
Responsabilità civile
l’area della responsabilità extracontrattuale è
passata all’area della responsabilità contrattuale, in quanto il diritto al risarcimento del danno deriverebbe da una obbligazione ex lege
dello Stato inadempiente e avrebbe natura indennitaria per attività antigiuridica; il che implica, ovviamente, l’inversione dell’onere della
prova, che ora è a carico dello Stato, e la prescrizione decennale del diritto all’indennizzo.
Questi spostamenti di campo non sono più
una novità nell’orientamento della Supr. Corte,
come si registra in materia di responsabilità del
medico e di responsabilità provvedimentale
della pubblica amministrazione, in cui si ravvisa la sussistenza di un contatto sociale tra il
danneggiante e il danneggiato avente natura
contrattuale. Egualmente per quanto riguarda
la violazione di obblighi di informazione ex lege da parte dell’intermediario finanziario nei
confronti degli investitori ( 14 ).
(ii) I criteri di imputazione.
L’area della responsabilità oggettiva si è venuta espandendo negli ultimi due decenni
( 15 ), sulla base di tre criteri che la dottrina
aveva affinato, applicando teorie maturate all’inizio degli anni Sessanta ( 16 ): l’imputazione
della obbligazione risarcitoria in capo al soggetto che trae vantaggio dal bene (cuius commoda eius et incommoda), ovvero al soggetto
che può prevenire il danno meglio di altri, ovvero al soggetto che può distribuire il danno
meglio di altri. Si è superata per molte fattispecie – non tutte però le fattispecie ascrivibili
all’area della responsabilità d’impresa – sia la
necessarietà della prova della colpa, sia la presunzione assoluta o relativa di colpa. Ma
l’orientamento della giurisprudenza è ondivago, si sposta verso la responsabilità oggettiva e
poi ritorna sulla responsabilità per colpa senza
linee uniformi di interpretazione e, fatto più
rimarcabile e deprecabile, senza una giustificazione motivata.
( 14 ) Cass., sez. un., 19.12.2007, n. 26725, in
Giust. civ., 2008, 2775.
( 15 ) Alpa, La responsabilità oggettiva, in Contr. e
impr., 2005, 959.
( 16 ) P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Giuffrè, 1961; Calabresi, Some Thoughts on
Risk Distribution and the Law of Tort, 70 Yale L.J.,
1961, 497.
NGCC 2010 - Parte seconda
Tanto per esemplificare, è ormai ritenuta oggettiva la responsabilità dei padroni e committenti ex art. 2049 cod. civ., ma è basata sulla
culpa in eligendo la responsabilità del committente, quando l’impresa scelta sia palesemente
inidonea a svolgere la prestazione ovvero il
comportamento dannoso sia stato imposto all’appaltatore dal committente medesimo ( 17 );
la responsabilità oggettiva sussiste anche quando il dipendente abbia agito con dolo ( 18 ).
Più problematica è la produzione e il commercio di sigarette: secondo alcune pronunce,
non si tratta di esercizio di attività pericolose
( 19 ), secondo altre, poiché «la qualifica di pericolosità dipende (...) da una valutazione empirica, la quantità di pericolo che la connota», «non
è fondatamente obiettabile che nella ipotesi (...)
di danno da prodotto ormai commercializzato, e
così uscito dalla sfera del produttore, si verterebbe in tema di cosa pericolosa, prodotta mediante
attività non pericolosa»; non si tratta quindi di
vizio del prodotto, ma di pericolosità intrinseca al prodotto ( 20 ). In ogni caso, secondo gli ultimi arresti, che confermano un orientamento
già serpeggiante nella giurisprudenza di legittimità ( 21 ), la Corte Supr. «ritiene di aderire alla
più recente dottrina e giurisprudenza» in base
alla quale «tale responsabilità è di natura oggettiva, in considerazione del fatto che soggettivamente (soprattutto se l’esercente è un imprenditore) il responsabile può non avere colpa alcuna
nella mancata predisposizione di tutte le misure
idonee» ( 22 ); «il soggetto chiamato a rispondere
(nell’ipotesi che l’attività pericolosa assuma la
forma di impresa) è colui che ha il controllo dell’attività al momento del danno, sul solo presup-
( 17 ) Cass., 23.4.2008, n. 10588, in Mass. Giust.
civ., 2008.
( 18 ) È il caso del dipendente della banca che si
appropria di somme affidategli dai clienti per l’investimento: v. Cass., 6.3.2008, n. 6033, in Mass. Giust.
civ., 2008.
( 19 ) V. ad es. Trib. Roma, 5.12.2007, in Foro it.,
2008, I, 985.
( 20 ) Cass., 17.12.2009, n. 26516, in Dir. e giust.,
2010.
( 21 ) V. ad es., Cass., 4.5.2004, n. 8457, in Mass.
Giust. civ., 2004.
( 22 ) Così, testualmente, Cass., 17.12.2009, n.
26516, cit.
177
Studi e Opinioni
posto dell’oggettiva mancanza delle misure protettive idonee».
La responsabilità oggettiva viene imputata
solo sulla base del nesso di causalità, in quanto
«nella responsabilità oggettiva il giudizio è puramente tipologico e consiste nell’appurare se
l’evento che si è verificato appartenga o meno alla serie di quelli che il criterio di imputazione
ascrive ad una certa sfera del soggetto per il loro
semplice accadere». In altri termini, il criterio
adottato è più assertivo che prescrittivo.
Non è che i giudici ignorino il dibattito svoltosi in sede scientifica in ordine alle ragioni
giustificative dell’accollo della responsabilità
che prescinde dalla colpa.
Nella motivazione della pronuncia più recente si aggiunge infatti che «la ratio di tale accollo del costo del danno non è più la colpa, ma
un criterio oggettivo, che tuttavia rimane fuori
dalla norma. Esso fu individuato nella deep
pocket (tasca ricca) negli ordinamenti del common law e nella richesse oblige, nella tradizione
francese, mentre nell’affinamento successivo si è
ritenuto che la ratio vada individuata nel principio dell’esposizione al pericolo o all’assunzione
del rischio, ovvero nell’imputare il costo del danno al soggetto che aveva la possibilità della costbenefit analysis, per cui doveva sopportarne la
responsabilità, per essersi trovato, prima del suo
verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente, sicché il verificarsi del danno discende da un’opzione per il
medesimo, assunta in alternativa alla decisione
contraria». Ma i giudici preferiscono rimanere
ancorati alla lettera della legge, seppure riformulata in modo da superare l’esimente della
prova di aver adottato tutte le misure idonee
ad evitare il danno (ex art. 2050 cod. civ.).
Ma si tratta comunque di un passo avanti, rispetto alla giurisprudenza che insiste sulla necessità di una prova contraria da parte del danneggiante ( 23 ).
Egualmente per quanto riguarda la responsabilità per cose in custodia. Non mancano
sentenze che insistono sulla colpa presunta
( 23 ) Cass., 15.7.2008, n. 19449, in Mass. Giust.
civ., 2008, in un caso di esercizio ippico; nello stesso
senso v. Trib. Perugia, 17.1.2008, in Rass. giur.
umbra, 2007, 697 per l’attività venatoria.
178
( 24 ); ormai è però consolidato l’orientamento
approdato alla responsabilità oggettiva ( 25 ),
esclusa solo dal fatto fortuito o dal fatto del
terzo ma non dal fatto ignoto. Il fondamento
della responsabilità è vario: o è dato dal semplice rapporto istituito tra il custode e la cosa,
ovvero è dato dalla ricostruzione del nesso
eziologico.
Il vizio di costruzione della cosa in custodia,
anche se ascrivibile al terzo costruttore, non
esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, a meno che non si
tratti di vizio intrinseco addebitabile unicamente alla società costruttrice ( 26 ).
(iii) Il nesso eziologico e il criterio probabilistico.
Come testimoniano molte delle pronunce citate, al nesso causale si rivolge l’interprete non
solo per accertare la sussistenza di uno dei requisiti essenziali dell’atto illecito, ma anche per
selezionare le fattispecie in cui il danno è risarcibile ( 27 ).
Tuttavia, la nozione di nesso causale, pur
avendo assunto un tale rilievo nella giurisprudenza recente, non è univoca. L’orientamento
tradizionale si trincera dietro il principio enunciato dagli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale
«un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dare
rilievo a quegli eventi che non appaiano, ad
una valutazione ex ante, del tutto inverosimili,
ferma peraltro restando la diversità del regime
probatorio applicabile, in ragione dei differenti
valori sottesi ai due processi» ( 28 ). Tuttavia si
riconosce che in materia civile è sufficiente
provare, sulla preponderanza dell’evidenza, o
della causa più probabile, mentre nel processo
( 24 ) V. ad es. Trib. Nuoro, 2.1.2007, in Rass.
giur. sarda, 2008, 57.
( 25 ) V. ad es. Cass., 27.3.2007, n. 7403, in Mass.
Giust. civ., 2007; Cass., 19.2.2008, n. 4279, ivi,
2008; Cass., 5.12.2008, n. 28811, ibidem.
( 26 ) Cass., 30.10.2008, n. 26051, ibidem.
( 27 ) Sul punto v. in particolare P. Trimarchi,
voce «Illecito», in Enc. del dir., XX, Giuffrè, 1970.
( 28 ) Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 576, in Dir. e
giust., 2008.
NGCC 2010 - Parte seconda
Responsabilità civile
penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio». E pertanto si è affermata la responsabilità della struttura ospedaliera unitamente a quella del Ministero della salute per il
contagio da HIV subìto da un paziente sottoposto a trasfusione di sangue infetto ( 29 ). Più
diffusamente si esprimono, di consueto, i giudici di merito, ai quali è demandato l’accertamento in fatto del nesso eziologico. In una recente pronuncia si è stabilito che per compiere
tale accertamento «il giudice non può fare ricorso né alla causalità naturalistica intesa in senso
stretto (il che porterebbe a ritenere causa di un
evento tutta la sterminata serie di precedenti
senza i quali il fatto non si sarebbe potuto verificare), né alla causalità statistica (impossibile da
applicare per la mancanza di rilevazioni oggettive), né alla propria intuizione, ancorché fondata
sulla logica; (...) il giudicante deve invece valutare tutti gli elementi della fattispecie al fine di
stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente idoneo (cioè con riferimento a quel singolo caso contingente) a produrre l’evento» ( 30 ).
L’orientamento della Supr. Corte è dunque
più incline a dare rilevanza, nella costruzione
del nesso eziologico, a fatti dai quali il danno
avrebbe potuto derivare con una certa probabilità. Si integra così il criterio della regolarità
causale, che già aveva attenuato il criterio della
condicio sine qua non, per attenuare ulteriormente il legame tra causa ed effetto inteso in
modo rigoroso, affidando il giudizio al calcolo
delle probabilità.
La regola trova molte conferme. Ecco alcuni
esempi. Un caso di wrongful life nel quale si è
affermato il «diritto a nascere sano» in capo ad
un bimbo nato deformato perché nel corso del
concepimento, la madre, che aveva problemi
di fertilità, era stata sottoposta in un centro
ospedaliero al trattamento di due farmaci rivelatisi dannosi. I giudici della Corte di cassazione hanno argomentato anche in punto di causalità, sostenendo che «la valutazione del nesso
causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di
( 29 ) Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 576, cit.; Cass.,
sez. un., 11.1.2008, n. 581, in Resp. civ. e prev., 2008,
827 e Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 584, in Foro it.,
2008, I, 451.
( 30 ) Trib. Bari, 8.6.2007, in Imm. e dir., 2008, n.
8, 66.
NGCC 2010 - Parte seconda
cui agli art. 40 e 41 c.p., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno
della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione
“ex ante” – del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime
probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola
della preponderanza dell’evidenza o del “più
probabile che non”, mentre nel processo penale
vige infatti la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”» ( 31 ).
In un caso di danno psichico, derivato alla
vittima da un evento traumatico costituito da
atti di libidine, e diventato una condizione psichica permanente, la Supr. Corte ha ritenuto
che «ai fini della configurabilità del nesso causale tra un fatto illecito ed un danno di natura psichica non è necessario che quest’ultimo si prospetti come conseguenza certa ed inequivoca dell’evento traumatico, ma è sufficiente che la derivazione causale del primo dal secondo possa affermarsi in base ad un criterio di elevata probabilità, e che non sia stato provato l’intervento di
un fattore successivo tale da disconnettere la sequenza causale così accertata. In applicazione di
tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, per avere quest’ultima condiviso le conclusioni di un c.t.u. medico-legale, il quale, considerando non sufficiente una valutazione probabilistica in termini pari al 70-80%, aveva
escluso il nesso causale tra il reato di atti di libidine di cui era rimasta vittima una minore e
l’esistenza di un danno psichico permanente, ritenendo plausibile un solo danno psichico transeunte» ( 32 ).
E nel caso più volte considerato della sottrazione di acque da parte di un ente pubblico la
Supr. Corte ha ribadito che colui il quale ai
sensi dell’art. 2043 cod. civ. «assumendo di avere patito un danno a causa della altrui condanna
( 31 ) Cass., 11.5.2009, n. 10741, in Dir. e giust.,
2009.
( 32 ) Cass., 11.6.2009, n. 13530, in Dir. e giust.,
2009.
179
Studi e Opinioni
agisca per il relativo risarcimento è tenuto non
solo a provare la esistenza del danno, ma anche
il nesso di causalità tra il fatto del terzo, nonché,
almeno la colpa di quest’ultimo, concretandosi
nella prevedibilità che dalla condotta posta in essere sarebbero derivate le denunciate conseguenze dannose. Contemporaneamente, l’accertamento del nesso causale tra il fatto illecito e
l’evento dannoso rientra tra i compiti del giudice
del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità della Suprema Corte, la quale, nei limiti
dell’art. 360 n. 5 c.p.c. è legittimata al solo controllo sull’idoneità delle ragioni addotte dal giudice del merito a fondamento della propria decisione».
In un caso di omissioni, il nesso causale è
stato accertato tenendo conto dell’effettivo e
concreto obbligo di agire. L’esperienza più recente riguarda la tragedia di Ustica, nella quale
un aereo si inabissò colpito da un missile. Secondo i giudici «la omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso,
solo quando si tratti di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione
specifica) ovvero in relazione al configurarsi nella posizione del soggetto cui si addebita la omissione, siccome implicante la esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell’evento poi verificatosi e, quindi, di un generico
dovere di intervento (omissione generica) in
funzione dell’impedimento di quell’evento. Il
giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale, quindi, non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la
preventiva individuazione dell’obbligo, specifico
o generico di tenere la condotta omessa in capo
al soggetto. L’individuazione di tale obbligo si
connota, quindi, come preliminare per l’apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo
imponeva, non è poi possibile apprezzare l’omissione del comportamento sul piano causale».
In applicazione di questo principio, i giudici
hanno ritenuto – con riguardo all’aereo Itavia
caduto a Ustica – che già all’epoca gravava, sulla base di specifiche normative, sul Ministero
della difesa l’obbligo di assicurare la sicurezza
dei cieli e di impedire l’accesso di aerei non au180
torizzati o nemici (d.p.r. 18.11.1965, n. 1477,
art. 12; d.p.r. 18.11.1965, n. 1478, art. 23; l.
16.2.1977, n. 38) e sul Ministero dei trasporti,
attraverso l’apposito Commissariato, l’assistenza e la sicurezza del volo. Dimostrata la sussistenza di uno specifico obbligo di impedire
l’evento, una volta che fosse appurato che
l’evento appartiene al novero di quelli che la
norma mirava a evitare attraverso il comportamento richiesto – ha concluso la Supr. Corte –
non sarebbe necessario che sussista anche la
conoscenza della esistenza del pericolo e, nella
specie, della presenza sulla rotta assegnata all’aereo Itavia di aerei pericolosi. Pertanto il Ministero della difesa è stato condannato a risarcire i danni alla società di trasporto aereo ( 33 ).
La regola probabilistica è di aiuto nei casi in
cui l’ultimo fatto collegato con l’evento appare
non essere l’unico della catena causale ad averlo provocato, e non è facile ravvisare nella vicenda una «regolarità» che consentirebbe di
qualificare l’ultimo fatto come unica ed esclusiva causa dell’evento. È evidente che se altre
condizioni influiscono sul modo nel quale
l’evento si è verificato, il giudice dovrà tenerne
conto nella determinazione del danno, ma non
potrà ignorare la rilevanza causale dell’ultimo
fatto. È appunto il caso di una persona in gravi
condizioni di salute che venga investita da
un’auto e che muoia dopo l’impatto; se l’incidente avesse colpito una persona di sana e robusta costituzione, sarebbe stato molto probabile che questa sarebbe rimasta in vita. E tuttavia non si può certo considerare non responsabile l’investitore. Facendo ricorso al principio
probabilistico, si ottiene una soluzione adeguata, perché si individua il responsabile ma si tiene conto delle circostanze di specie che portano ad attenuare l’ammontare del danno risarcito ai parenti della vittima deceduta. «La fattispecie generatrice della responsabilità civile, codificata in via generale nell’art. 2043 cod. civ.,
esige la sussistenza di una relazione causale fra
la condotta umana, commissiva od omissiva,
soggettivamente caratterizzata dal dolo o dalla
colpa, e l’evento pregiudizievole antigiuridico;
l’accertamento del nesso di causalità civilistica
( 33 ) Cass., 5.5.2009, n. 10285, in Guida al dir.,
2009, n. 26, 58.
NGCC 2010 - Parte seconda
Responsabilità civile
fra fatto illecito ed evento lesivo deve essere condotto sulla base di una valutazione probabilistica secondo la regola della prevalenza delle probabilità (più probabile che non) rispetto alle più
severe regole dell’accertamento della causalità
penalistica» ( 34 ).
2. Il rapporto tra regole generali e
regole speciali. Non vi è una uniforme e
coordinata disciplina delle fattispecie particolari previste dalle leggi speciali. Questa discrasia è duplice: da un lato riguarda il diritto interno, dall’altro riguarda i modelli stranieri, sì
da riflettersi anche nei progetti di uniformazione delle regole del diritto privato europeo che
trovano nel Draft Common Frame of Reference
il testo più accreditato.
Il rapporto tra le regole del codice e le regole
dettate da leggi speciali in materia di responsabilità è molto complesso. Certamente si può
descrivere come una delle vicende nelle quali si
manifesta in tutta la sua evidenza il principio
della derogabilità della legge ordinaria, che pone principi di carattere generale, da parte della
legge speciale, che porta invece disposizioni
aventi un ambito circoscritto e particolare.
Parlare di «deroga» tuttavia significa già prendere posizione nella decifrazione di un fenomeno, e condividere la posizione tradizionale
che si incentrava sulla colpa considerata il perno dell’intero sistema. In ogni caso, vengono in
considerazione altre prospettive, oltre a quella
formale. In quest’area il rapporto si è venuto
svolgendo in fatti in modo molto articolato.
Guardando a questo rapporto in dimensione diacronica, le prime leggi speciali – come
quella sulla responsabilità per l’esercizio di attività nucleare – avevano un ambito assai circoscritto e un tessuto molto ridotto: la preoccupazione del legislatore era mirata alla agevolazione dell’onere della prova a carico del
danneggiato e alla soddisfazione delle vittime.
Nel caso di attività nucleari potevano bastare
poche battute per risolvere il problema, né la
logica che governava il settore poteva considerarsi pregiudicata dalla necessità di intervenire
per attuare un interesse pubblico, costituito
( 34 ) App. Torino, 15.4.2009, in Redazione Giuffrè, 2009.
NGCC 2010 - Parte seconda
dal vantaggio di produrre energia a basso costo (creando tuttavia rischi catastrofici) e rimediare al danno che ne poteva derivare alle
persone e alle cose.
Al suo apparire la normativa fu intesa come
una vistosa eccezione ai principi tradizionali,
giustificata dalla eccezionalità dell’evento e
dalla eccezionalità del danno.
Via via che si sono affacciate sulla scena dell’illecito situazioni che richiedevano una particolare considerazione o per la diffusione capillare dei rischi, come accade per la circolazione
di prodotti difettosi o l’offerta sul mercato di
prodotti finanziari aleatori, oppure per la violazione delle regole sulla concorrenza, oppure
ancora per la natura sociale del ruolo svolto dal
potenziale danneggiante, come accade per l’attività medica o per il gioco sportivo, o ancora
per la difficoltà tecnica della gestione dei rapporti, come accade per l’attività informatica, la
spiegazione del fenomeno sulla base della correlazione generale/particolare, regola/eccezione non è più apparsa soddisfacente.
Innanzitutto perché tutte le variegate espressioni della esigenza di dettare regole speciali
per situazioni speciali si erano tradotte, al momento della loro emersione, in adattamenti
delle regole di codice alle particolari circostanze, e quindi esse avevano già in sé i germi di
una nuova e diversa configurazione della regola da applicare. Si pensi, ad es., alle circonvoluzioni della giurisprudenza sulla responsabilità
del fabbricante prima che fosse attuata la direttiva comunitaria n. 374/1985.
Le regole del codice civile potevano offrire
solo una applicazione difficoltosa di principi
che rimediavano singulatim a danni spesso non
solo individuali ma seriali.
Poi, perché oltre all’interesse individuale, alcune situazioni incidevano anche gli interessi
collettivi, come accade per il danno risentito
dall’ambiente. Le regole del codice civile trovavano difficoltà ad individuare sia il bene da
tutelare sia i criteri con cui provvedere alla sua
reintegrazione.
Ancora, perché erano coinvolti nuovi soggetti, facenti parte in senso lato dell’apparato amministrativo, come le Autorità amministrative
indipendenti. Le regole del codice sono sempre state applicate alla pubblica Amministrazione con molta cautela, e con molti limiti.
181
Studi e Opinioni
Infine, perché il danno non si manifestava
solo all’interno dei confini patrii, essendo ormai allestito un mercato europeo «unico» e
quindi destinatario di regole il più possibile armonizzate da Paese a Paese. Le regole dei codici o quelle della case law, per le loro caratteristiche nazionali, non si prestavano a dispiegare la loro funzione in modo adeguato.
Alcune disposizioni sono confluite poi nei
codici di settore – si pensi al codice del consumo e al codice dell’ambiente – e quindi si sono
aperti ulteriori problemi di interpretazione e
applicazione di quelle disposizioni. Esse infatti
obbediscono ad una logica sistematica interna
al codice, ma debbono essere coordinate con il
codice civile, dal momento che i codici di settore sono testi normativi complementari al codice civile.
Questa evoluzione normativa ha imposto un
ripensamento dell’intero comparto delle regole
della responsabilità civile e della stessa prospettazione dei principi che regolano la materia, facendo venire meno – de iure – molti dogmi che continuavano a resistere ad una realtà
incalzante e vorticosa.
Come accennavo, nel Draft Common Frame
of Reference il rapporto tra regole generali e regole speciali si modella in modo rilevante sugli
aspetti tipici del code civil e del codice civile
italiano, anche se per altri aspetti riflette le
scelte del B.G.B. In ogni caso, fermo il principio della colpa, il Draft prevede la responsabilità senza colpa dei datori di lavoro per i fatti illeciti commessi dai loro dipendenti, per l’esercizio di attività pericolose, per la proprietà di
edifici, per le immissioni, mentre non si occupa
della custodia in sé e per sé. L’unica fattispecie
riguardante – nel nostro ordinamento – leggi
speciali (peraltro ora inserita nel codice del
consumo) è la responsabilità del produttore,
qui inclusa tra le altre regole generali di responsabilità.
3. Le manipolazioni dell’interprete.
Nell’introduzione del suo prezioso e fortunato
manuale sulla Tort Law ( 35 ) ora aggiornato con
Simon Deakin e Angus Johnston, sir Basil
( 35 ) Deakin-Johnston-Markesinis, Markesinis
and Deakin’s tort law, London, 2009, 32 ss.
182
Markesinis ha avvertito i lettori che i requisiti
del tort – fault, causation, damage – non sono
di per sé sufficienti ad affermare la responsabilità di un soggetto nei confronti di un altro;
sovviene, ed è determinante, la «general policy»
che il giudice vuole perseguire. Sovvengono
cioè altri criteri di valutazione, come il dovere
di agire per proteggere il nostro prossimo (duty
of care), l’assenza di precauzioni (carelessness),
la prossimità del danno (remoteness). E ciò che
importa è che si comprenda (Markesinis si rivolge in particolare agli studenti, ed è quindi
bene che essi comprendano, fin dall’inizio della loro formazione culturale) come «tutti questi
concetti non sono altro che espedienti verbali
che aiutano le corti nel prendere le loro decisioni, ma non ne spiegano realmente il tenore»;
si tratta in altri termini di strumenti a cui si fa
ricorso per quanto possa servire, «sono strumenti per raggiungere uno scopo, non lo scopo
in sé».
Guido Calabresi, in un meditato saggio di
epistemologia giuridica, che costituisce una
sorta di grande, affascinante affresco delle tecniche di ragionamento, dello stile legale e delle
correnti di pensiero offerte dall’esperienza statunitense, per parte sua ci avverte che tutti i canali, tutte le prospettive sono utili per comprendere come funzionano le norme e come
ragiona l’interprete: quella formalista, quella di
«Law and...», quella funzionale che guarda alla
effettività e alle vie processuali per tutelare i diritti ( 36 ).
Ora, proprio dal common law inglese e nordamericano ci provengono suggerimenti e ammonimenti sulla opportunità/necessità di adottare un metodo pragmatico e flessibile per
comprendere i fenomeni e tradurli in fattispecie giuridiche, e poi adottare le decisioni. Attese le ancora notevoli differenze che sussistono
tra le concezioni e le regole di tort law in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Italia, non possiamo compiere una trasposizione dei modelli
di ragionamento e neppure seguire pedissequamente le soluzioni prospettate Oltremanica
o dall’altro lato dell’Oceano. Tuttavia quelle
( 36 ) Calabresi, An Introduction to Legal
Thought: Four Approaches to Law and the Allocation
of Body Parts, in 55 Stan. L. Rev., 2003, 2113 ss.
NGCC 2010 - Parte seconda
Responsabilità civile
esperienze ci aiutano a capire meglio la nostra
e possiamo verificare, sulla scorta di questi
suggerimenti e sulla scorta dei modelli interpretativi costruiti colà, se le soluzioni operative
– per adottare una terminologia cara a Rodolfo
Sacco ( 37 ) – possano risultare soddisfacenti.
Ovviamente, dobbiamo anche enunciare il metro di paragone, appunto per misurare il livello
di soddisfazione, che trae spunto dalla efficiente allocazione delle risorse, dal prudente bilanciamento degli interessi, dalla combinazione di
sanzione, prevenzione, soddisfazione, cioè delle funzioni basilari della responsabilità civile.
Lascio da parte le valutazioni etiche. È evidente che ogni decisione, ancorché ancorata al
diritto, sia intrisa di valori etici, ma confinerei
l’istanza etica nella esigenza di reazione al danno ingiusto. Se si insiste sulla istanza etica si finisce fatalmente per rivalutare senza ragione il
criterio di imputazione della colpa.
È quanto ha proposto – in una critica al pensiero di Calabresi – Jules Coleman in due contributi che hanno proposto una sorta di rivisitazione dell’intero sistema della responsabilità
civile ( 38 ). Secondo Coleman il sistema della responsabilità civile deve includere valutazioni di
carattere morale, sanzionare il danneggiante
perché ha tenuto un comportamento non conforme ai principi etici seguiti dalla maggioranza, e quindi realizzare le aspettative della giustizia correttiva (o retributiva). Pertanto esso
non si può reggere su una struttura binaria, data dalla ripartizione dell’area della colpa e dell’area in cui la colpa non è rilevante, ma concentrarsi sulla colpa, affidando a sistemi alternativi, diversi dalla responsabilità, l’indennizzo
delle vittime che, per particolari ragioni, si vogliono risarcire senza l’accertamento della responsabilità del soggetto chiamato a soddisfare
il danno da esse subito. Queste premesse portano quindi alla conseguenza che non solo non
si possa fare ricorso alla «market share liability» (cioè alla ripartizione del danno tra tutti i
( 37 ) Aa.Vv., Le fonti non scritte e l’interpretazione, nel Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, 2,
Utet, 1999, 5 ss.
( 38 ) Coleman, Tort Liability and the Limits of
Corrective Justice, Cambridge, 1994; Id., The Practice of Principle. In Defense of a Pragmatist Approach
to Legal Theory, Oxford, 2001.
NGCC 2010 - Parte seconda
soggetti che hanno creato il rischio nella loro
creazione del mercato dei beni e dei servizi potenzialmente dannosi), ma neppure al criterio
del soggetto che con il minor costo avrebbe
potuto evitare il danno (cheapest best avoider).
Quest’ultimo, come è noto, è il criterio posto
alla base dell’intera costruzione della responsabilità civile, come strumento per poter sviluppare una sistematica analisi economica del diritto, da parte di Guido Calabresi fin dai suoi
primi contributi ( 39 ). Si tratta di un criterio oggi definito «comportamentale», un criterio
flessibile che dovrebbe indurre chi ha creato il
rischio a valutare il costo delle precauzioni e a
sopportare quindi le conseguenze della mancata adozione degli strumenti di prevenzione del
danno il cui costo sia sopportabile ( 40 ). Non è
tuttavia l’unico criterio di imputazione della
responsabilità, né un criterio che serve per distribuire il danno o per soddisfare integralmente le vittime: solo un sistema di associazione sociale potrebbe realizzare tutti questi scopi
( 41 ).
4. Dietro lo schermo delle argomentazioni formali. È raro rinvenire nelle motivazioni delle sentenze rese dai giudici italiani
argomenti a supporto della affermazione della
responsabilità che siano diversi da quelli meramente formali, desunti cioè dalla interpretazione letterale delle norme del codice civile: tutt’al più esse sono arricchite da integrazioni e
variazioni desunte dalla dottrina, ma non esorbitano dai tratturi antichi. Il fatto che il testo
del codice, così come quello della Relazione
ministeriale al codice civile, non abbiano consentito la fondazione dell’obbligazione risarcitoria su criteri diversi dalla colpa ha pesato sulla cultura giuridica italiana per più di un trentennio, ma solo ora, a distanza di quasi settant’anni dalla entrata in vigore del codice,
( 39 ) Per una attenta ricostruzione dei paradigmi
di Calabresi v. Grembi, Guido Calabresi e l’analisi
economica del diritto, in www.cleis.unisi.it.
( 40 ) Questo criterio è oggetto di una interessante
discussione offerta da Faure, Calabresi and Behavioural Tort Law and Economics, in 1 Erasmus L.
Rev., 2008, 4, 75 ss.
( 41 ) Calabresi, Towards a Unified Theory of
Torts, in Journal of Tort Law, 1, 2007, 8.
183
Studi e Opinioni
possiamo verificare che alcune fattispecie sono
considerate – tendenzialmente – espressione
della responsabilità senza colpa.
Nella recente sentenza della Supr. Corte si
mostra consapevolezza dei problemi posti in
dottrina, sotto il profilo dell’analisi economica
del diritto e della critica alle categorie dogmatiche tradizionali, ma si ritiene che il testo della
legge sia di per sé sufficiente a dare una risposta a quei problemi.
L’interprete dunque deve saper leggere die-
184
tro lo schermo delle motivazioni, per accertare,
caso per caso e quindi in modo pragmatico, se
nella fattispecie considerata i giudici hanno voluto scegliere il soggetto che meglio di altri
avrebbe potuto sopportare il danno.
Questo è un criterio più discrezionale di
quello suggerito da Calabresi, e non necessariamente corrisponde a criteri ottimali di ripartizione dei costi, ma allo stato questa è la situazione che si può rilevare considerando gli ultimi apporti della giurisprudenza.
NGCC 2010 - Parte seconda