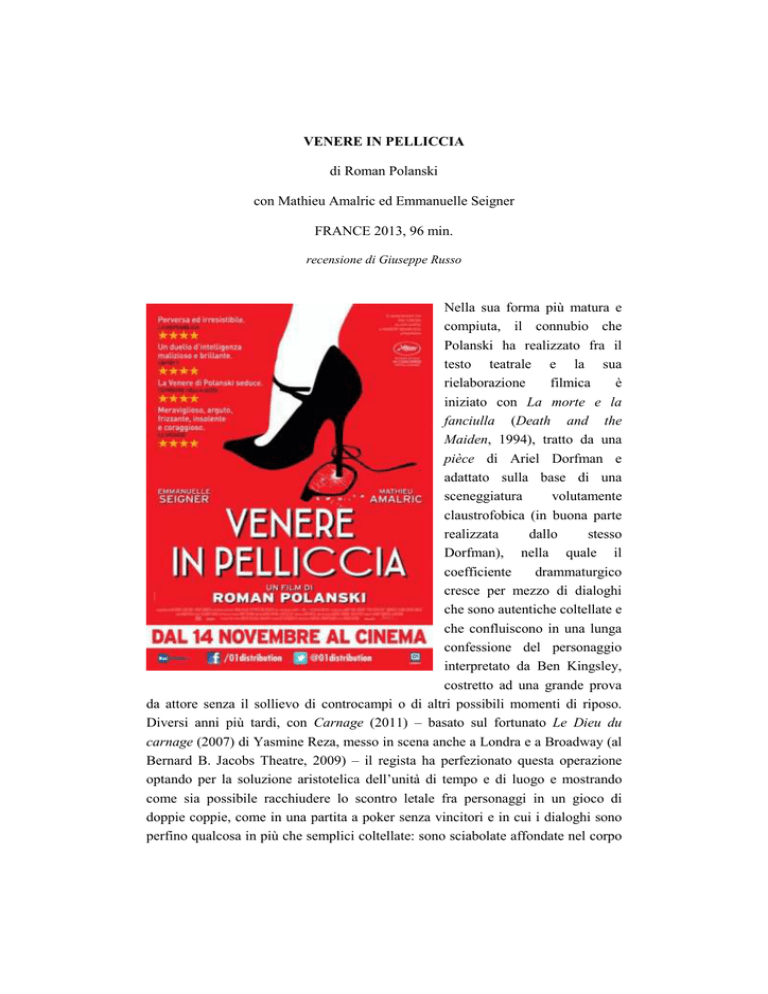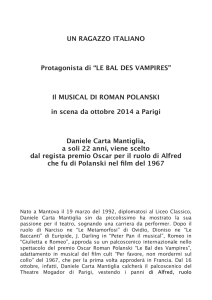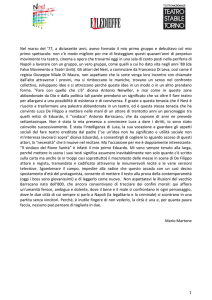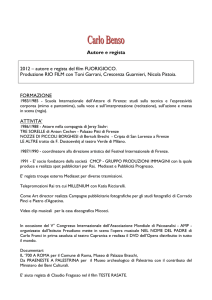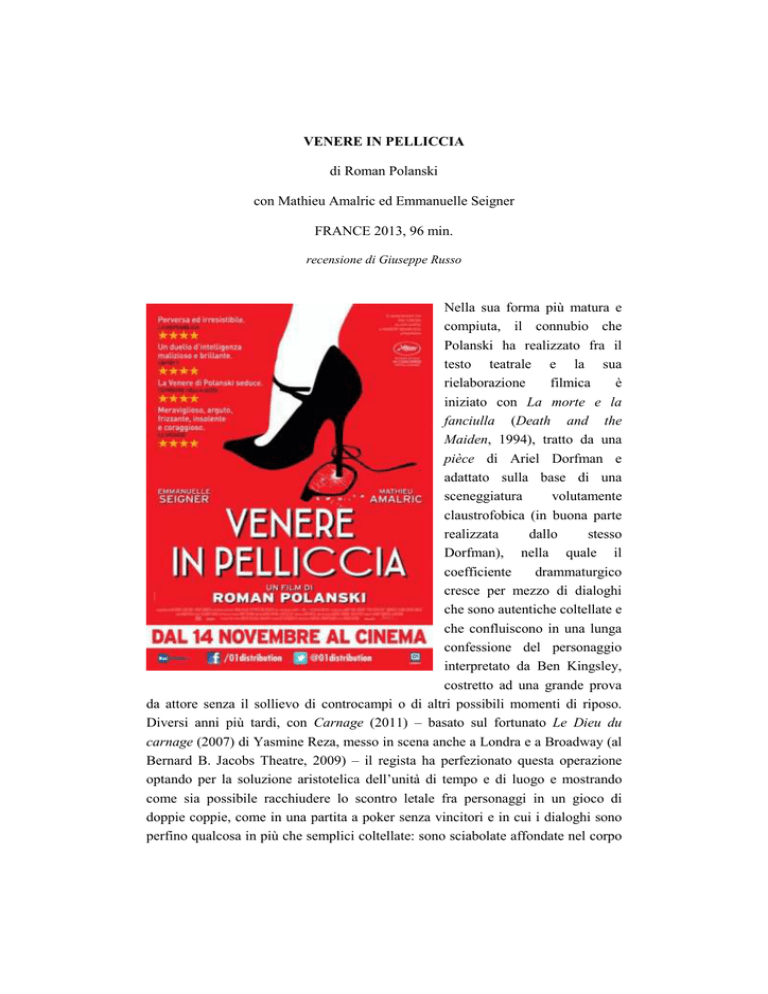
VENERE IN PELLICCIA
di Roman Polanski
con Mathieu Amalric ed Emmanuelle Seigner
FRANCE 2013, 96 min.
recensione di Giuseppe Russo
Nella sua forma più matura e
compiuta, il connubio che
Polanski ha realizzato fra il
testo teatrale e la sua
rielaborazione
filmica
è
iniziato con La morte e la
fanciulla (Death and the
Maiden, 1994), tratto da una
pièce di Ariel Dorfman e
adattato sulla base di una
sceneggiatura
volutamente
claustrofobica (in buona parte
realizzata
dallo
stesso
Dorfman), nella quale il
coefficiente
drammaturgico
cresce per mezzo di dialoghi
che sono autentiche coltellate e
che confluiscono in una lunga
confessione del personaggio
interpretato da Ben Kingsley,
costretto ad una grande prova
da attore senza il sollievo di controcampi o di altri possibili momenti di riposo.
Diversi anni più tardi, con Carnage (2011) – basato sul fortunato Le Dieu du
carnage (2007) di Yasmine Reza, messo in scena anche a Londra e a Broadway (al
Bernard B. Jacobs Theatre, 2009) – il regista ha perfezionato questa operazione
optando per la soluzione aristotelica dell’unità di tempo e di luogo e mostrando
come sia possibile racchiudere lo scontro letale fra personaggi in un gioco di
doppie coppie, come in una partita a poker senza vincitori e in cui i dialoghi sono
perfino qualcosa in più che semplici coltellate: sono sciabolate affondate nel corpo
e nella mente del nemico, in un sistema relazionale in cui ognuno è un nemico e la
coppia non serve a proteggere niente e nessuno. Nel tempo intercorso fra questi due
film, Polanski – che non ha mai fatto mistero di volersi anche divertire in questo
ambiente, non di rado producendosi in interpretazioni di un certo rilievo – ha avuto
modo di recitare come protagonista nello splendido adattamento della commedia di
Aleksander Fredro Zemsta (2002), un classico del teatro polacco dell’Ottocento
rivisitato da Andrzej Wajda e giustamente elogiatissimo dalla critica1 sia per
l’eleganza della regia che per la raffinata recitazione.
Con La Vénus à la fourrure, basato sulla pièce Venus in Furs dello statunitense
David Ives e presentato in concorso a Cannes 2013, assistiamo ad un ulteriore
passo avanti in questo incontro/scontro fra il territorio cinematografico e lo spunto
teatrale. Lo spettacolo, basato sull’omonimo romanzo di Leopold von SacherMasoch, è stato messo in scena nel 2011, prima al Manhattan Theatre Club di
Broadway e poi al Lyceum Theatre. Non molto tempo dopo, il testo è capitato fra
le mani di Polanski, che a quanto pare ne è stato subito attratto e ha preso
rapidamente la decisione di adattarlo, a quattro mani con Ives. In un’intervista
concessa ad ottobre ad un settimanale del gruppo RCS, alla domanda posta
dall’intervistatrice: «Un film con due attori, girato in un teatro: non facile. È stata
una sua idea?» Polanski ha risposto:
« Mi ha dato la sceneggiatura il mio agente. Siccome quel giorno non avevo molto
da fare ho cominciato a leggerla. E a ridere: i dialoghi erano davvero divertenti. A
un film con due soli attori, poi, ci pensavo da anni. Era una sfida riuscire a farlo
senza essere noiosi, e io ho bisogno di sfide. Anche l’ironia con cui veniva
affrontato il rapporto uomo-donna mi piaceva, questa specie di vendetta di Venere
era molto attraente. Inoltre, io amo il teatro. Ho cominciato presto, a 14 anni mi
diedero un ruolo da protagonista e da allora continuai ad andarci, avessero bisogno
di me o no»2.
Senza risalire fino a Les enfants du Paradis (1945) di Marcel Carné, di film che
insistono sull’esplorazione dei recessi del mondo teatrale ce ne sono stati molti,
basti pensare allo splendido Dopo la prova (Efter repetitionen, 1984), di Bergman.
E nel cinema francese ci sono stati anche ottimi esempi di lungometraggi concepiti
e realizzati intorno a due soli personaggi che dialogano all’infinito, come ha fatto
nel 1981 Louis Malle col socratico La mia cena con André (My Dinner with
André). Perciò, Polanski sapeva bene di avventurarsi in uno spazio per nulla
1
Cfr. la recensione di Katarzyna Długosz in: Tygodnik, n. 6/2002. Cfr. anche Cinema
Polska, nr. 10/2002, pp. 12-15.
2
http://www.iodonna.it/personaggi/interviste/2013/polanski-seigner-intervista401720825297.shtml
vergine e anzi ricco di precedenti illustri. Eppure, forse anche grazie alla sua ben
nota tendenza iconoclasta e ad una dose di divertimento che sembra provare da
sempre quando può mettere a nudo e ferire le sue creature, il suo sforzo è da
ritenersi perfettamente riuscito, tanto che Roberto Escobar ha legittimamente detto
che le diverse ipotesi interpretative di questo film «possono valere l’una accanto
all’altra»3 con buona pace del principio di esclusione reciproca.
La trama è riassumibile in poche righe. Thomas è un regista che sta allestendo una
rilettura del romanzo di Sacher-Masoch e sta facendo dei provini per selezionare la
protagonista. Al termine della (presumibilmente) prima giornata di audizioni,
mentre sta per andar via insoddisfatto delle attrici che si sono presentate, fa
irruzione nel teatro Vanda,
in apparenza una modesta
attricetta molto volgare,
grossolana, sovratatuata e
incolta. Si rivela però subito
adattissima al ruolo, che sa
mettere in scena con
un’intensità
tale,
da
coinvolgere Thomas in un
lungo gioco di scambi e
metamorfosi, al punto che
verso la fine induce il regista
ad interpretare lui stesso la parte della protagonista e lei la parte di lui. Affondando
sempre più nella psiche di Thomas, il gioco spinge il regista ad offrirsi in sacrificio
legato (non molto diversamente da come era legato alla sedia Trelkovsky ne
L’inquilino del terzo piano, interpretato nel 1976 dallo stesso Polanski) ad un
assurdo cactus finto, rimasto sulla scena da un precedente allestimento di un
musical basato su Ombre rosse, ossia proveniente da un mondo di valori ormai
antico, in cui il principio maschile e quello femminile erano chiaramente separati e
non confondibili. In un turbine di furori dionisiaci, Vanda si ripresenta sul palco
come baccante in grado perfino di uccidere Thomas/Penteo, ma preferisce andar
via dopo averlo annichilito e svuotato della sua presunzione autoriale.
3
Cfr. L’Espresso, n. 46/2013, p. 158.
Per certi aspetti, la donna incarna senza dubbio un principio femminile di fondo
che è presente anche nella struttura psichica di Thomas ma che l’uomo tende ad
occultare, probabilmente perché se ne sente minacciato. Tanto è vero che quando
tale principio emerge – in particolare dopo l’esilarante sequenza nella quale il
rapporto tra i due si trasforma in seduta psicoanalitica in cui è lei ad analizzare lui –
travolge completamente l’autore. Per altri versi, dato il fortissimo scarto esistente
(e sul quale Polanski
insiste molto) fra la
serietà borghese di lui
e il kitsch a dir poco
ruspante di lei, Vanda
può essere considerata
l’incarnazione di una
vendetta
anche
culturale: il basso che
rovescia l’alto, lo
smaschera, lo denuda,
lo
travolge;
che
volendo potrebbe perfino ucciderlo. E va ricordato che la tendenza a mostrare
personaggi che, isolati dal mondo esterno, tendono ad aggredirsi reciprocamente in
un’operazione di progressivo disvelamento delle rispettive ipocrisie ed esibizione
delle nature profonde – che sono quasi sempre violente, ma soprattutto miserabili –
è presente nel cinema di Polanski fin dal suo esordio come regista ne Il coltello
nell’acqua (Nóż w wodzie, 1962), tanto che non è eccessivo affermare che il suo
pubblico se lo aspetta, almeno ogni 3-4 film. Ma c’è un aspetto ulteriore da tenere
nella giusta considerazione, se si vuole andare alla ricerca della funzione svolta dal
personaggio di Vanda. Sia il lungo piano-sequenza iniziale, quando lei arriva in
teatro, che il suo reverse nella sequenza di chiusura (quando va via) sembrano
pensati e realizzati per far risaltare uno spaventoso temporale che sta avendo luogo
all’esterno del teatro e del quale sostanzialmente non si percepisce la presenza
durante la lunga audizione. Questo fa pensare alla volontà da parte del regista di
collegare la prorompente personalità della donna a certe potenze naturali che si
annunciano in modo classico, per mezzo di tuoni, fulmini e saette. Anche Álvaro
Mutis aveva fatto una scelta non molto diversa, quando ha elaborato i personaggi di
Ilona e di Larissa nel secondo romanzo della sua trilogia di Maqroll. Anche lì,
infatti, è la pioggia ad annunciare l’avvicinamento oppure l’allontanamento del
principio femminile, che però ha un valore molto più rassicurante poiché insegna
all’uomo l’arte della pazienza riflessiva: «Lascia che le cose scorrano, in esse è
nascosta la chiave. Se la si cerca, si perde la facoltà di scoprirla»4. Vanda non è
venuta per filosofeggiare ma per smontare la personalità di Thomas e metterne a
nudo la miseria che ne è al centro e intorno alla quale l’uomo ha costruito la sua
carriera e la sua reputazione. Vanda non è una consolatrice ma una vendicatrice, e
sembra proprio che attraverso di lei si scateni una potenza di origine sacra, che si
presenta lasciandosi precedere da pioggia e fulmini. In realtà, l’associazione tra le
forze meteorologiche e le divinità femminili è ben più antica dell’Afrodite greca,
ed è molto diffusa: la si ritrova nella sumera Inanna, nella babilonese Ishtar, nella
Tefnut egizia, nella Sulis celtica e così via. L’antropologia ci insegna che sono
alcune caratteristiche biologiche della donna (ciclo mestruale, fecondità, parto,
etc.) a farla percepire in moltissime culture come «un essere al tempo stesso ferito,
impaurito e malefico, che appartiene per natura al sacro “sinistro” e di cui in certi
casi occorre temere la presenza o il contatto»5, come lo teme in modo crescente
Thomas, appunto. Ma di certo a Polanski, soprattutto nel momento in cui sceglie la
moglie come interprete per questo ruolo così potente, facendola esporre fino ai
limiti delle sue possibilità anagrafiche (Emmanuelle Seigner ha ormai 47 anni e
non più 26 come durante le riprese di Luna di fiele), non interessa tanto il
background antropologico di questa combinazione quanto la sua eterna attualità.
Infine, a differenza di quanto accade in Carnage e nel relativo gioco di scambi e
smascheramenti reciproci, in La Vénus à la fourrure risulta particolarmente
decisiva la presenza di un
testo scritto (come accade
anche nella pièce teatrale)
con il quale i due
protagonisti si misurano in
modo continuo, incessante,
nevrotico, e che ha un
ruolo molto attivo nella
dialettica fra i due, quasi
che il testo scritto fosse
una
sorta
di
terzo
personaggio, con la sua particolare fisicità. In ogni momento il testo evoca elementi
presenti nei due protagonisti, li chiama all’appello, li sfida. E tuttavia ad esso non è
certo riservato un trattamento diverso, dato che anch’esso viene più volte
smascherato, violato, decostruito. Vanda lo getta nel (finto) caminetto, Thomas lo
4
Á. Mutis, Ilona arriva con la pioggia, a cura di E. Franco, Torino, Einaudi 1991, p. 62.
R. Caillois, L’uomo e il sacro, a cura di U.M. Olivieri, Torino, Bollati Boringhieri 2001,
p. 134.
5
strapazza senza soste, eppure il testo rimane lì e continua a partecipare al gioco
senza fornire neanch’esso punti di riferimento stabili ma, anzi, negando la sua
tradizionale funzione di donatore di senso. Contribuisce sia alla demolizione
dell’identità dei personaggi che al momentaneo riassemblaggio dei pezzi rimasti.
Siamo dunque in una giostra «di seduzione e dominio dove non è solo il trucco il
segno della metamorfosi ma proprio la scrittura come persistente inganno»6, dato
che nel mondo di Polanski – per sua stessa ammissione – le certezze sono la
quintessenza della noia7 mentre l’esplorazione dei vizi e delle perversioni
rappresenta quanto di più divertente il cinema possa rappresentare. E da questo
punto di vista, anche da questo punto di vista, La Vénus à la fourrure è un
autentico capolavoro.
6
7
S. Emiliani, Claustrofobie e romanticismo, in: Filmcritica, n. 635-636, 2013, p. 261.
Cfr. F. Di Celle, Roman Polanski, Milano, Il Castoro 2008.