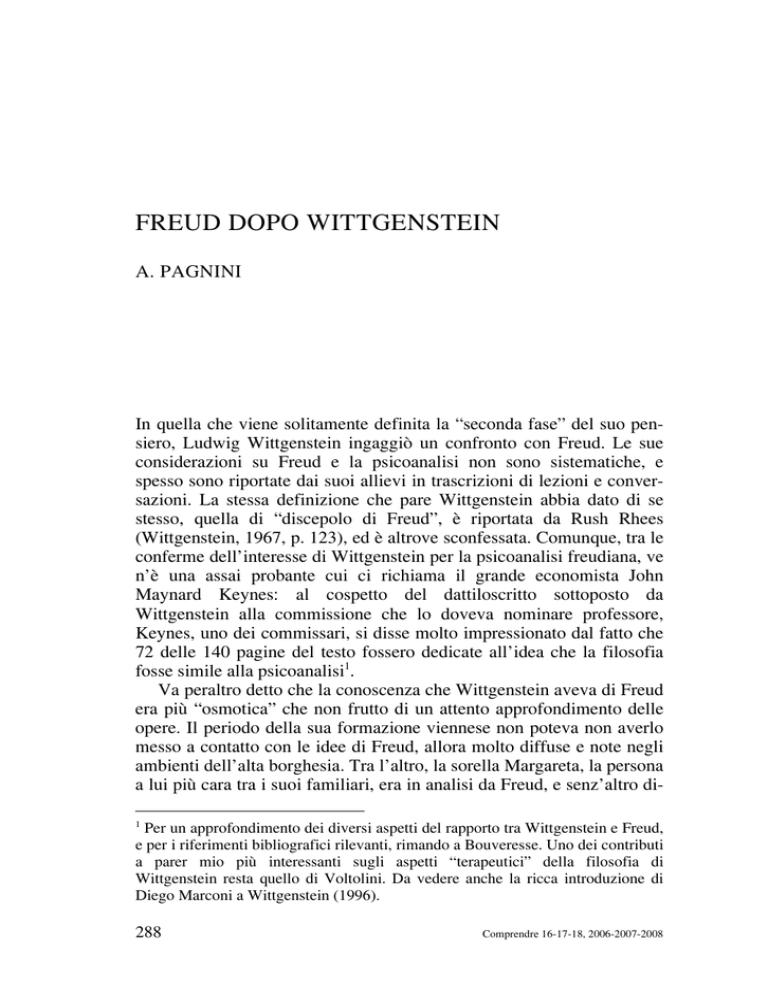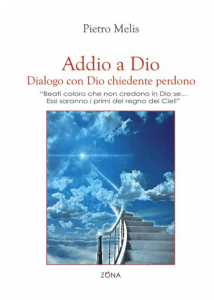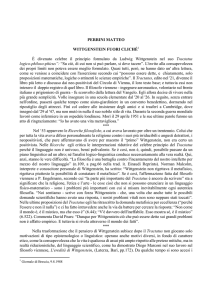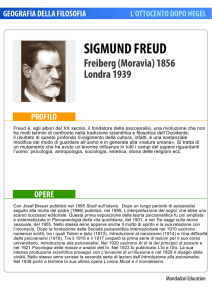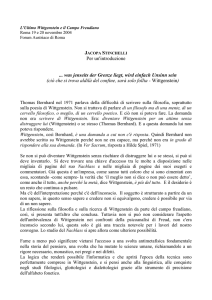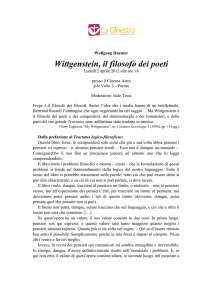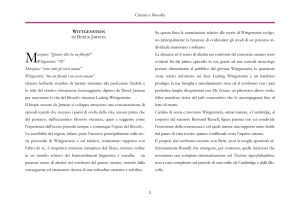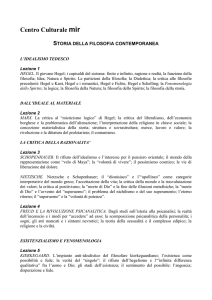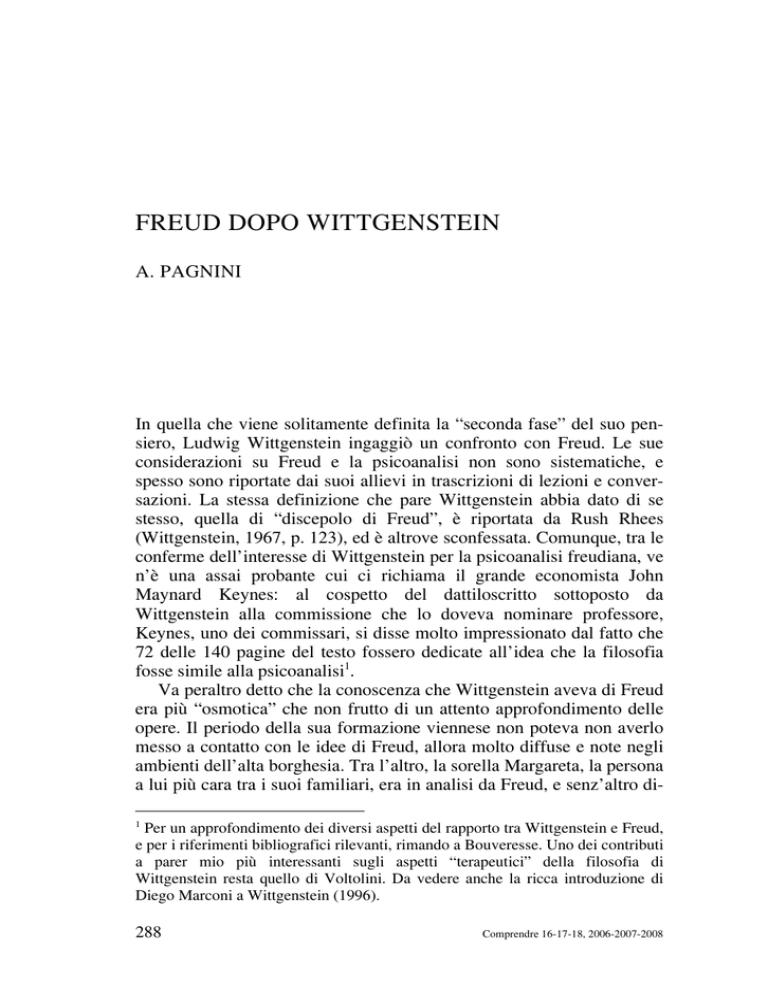
FREUD DOPO WITTGENSTEIN
A. PAGNINI
In quella che viene solitamente definita la “seconda fase” del suo pensiero, Ludwig Wittgenstein ingaggiò un confronto con Freud. Le sue
considerazioni su Freud e la psicoanalisi non sono sistematiche, e
spesso sono riportate dai suoi allievi in trascrizioni di lezioni e conversazioni. La stessa definizione che pare Wittgenstein abbia dato di se
stesso, quella di “discepolo di Freud”, è riportata da Rush Rhees
(Wittgenstein, 1967, p. 123), ed è altrove sconfessata. Comunque, tra le
conferme dell’interesse di Wittgenstein per la psicoanalisi freudiana, ve
n’è una assai probante cui ci richiama il grande economista John
Maynard Keynes: al cospetto del dattiloscritto sottoposto da
Wittgenstein alla commissione che lo doveva nominare professore,
Keynes, uno dei commissari, si disse molto impressionato dal fatto che
72 delle 140 pagine del testo fossero dedicate all’idea che la filosofia
fosse simile alla psicoanalisi1.
Va peraltro detto che la conoscenza che Wittgenstein aveva di Freud
era più “osmotica” che non frutto di un attento approfondimento delle
opere. Il periodo della sua formazione viennese non poteva non averlo
messo a contatto con le idee di Freud, allora molto diffuse e note negli
ambienti dell’alta borghesia. Tra l’altro, la sorella Margareta, la persona
a lui più cara tra i suoi familiari, era in analisi da Freud, e senz’altro di1
Per un approfondimento dei diversi aspetti del rapporto tra Wittgenstein e Freud,
e per i riferimenti bibliografici rilevanti, rimando a Bouveresse. Uno dei contributi
a parer mio più interessanti sugli aspetti “terapeutici” della filosofia di
Wittgenstein resta quello di Voltolini. Da vedere anche la ricca introduzione di
Diego Marconi a Wittgenstein (1996).
288
Comprendre 16-17-18, 2006-2007-2008
Freud dopo Wittgenstein
scusse con il fratello sogni e relative interpretazioni che il suo medico
le dava (tra l’altro, quello dell’interpretazione dei sogni era, all’epoca,
una sorta di gioco di società). In casa poi c’erano gli “Studi
sull’isteria”, che Wittgenstein aveva senz’altro letto, giacché in un’annotazione molto interessante dichiarò di sentirsi più vicino e solidale
all’“umiltà” di Breuer che non alla presunzione dogmatica di Freud; e
senz’altro Wittgenstein conosceva, giacché ne troviamo espliciti riferimenti nei suoi scritti, “L’interpretazione dei sogni” e “La psicopatologia della vita quotidiana”. Niente di più approfondito e niente di filologico nella sua lettura di Freud. Tuttavia, quelle considerazioni sparse
sulla psicoanalisi hanno dato luogo ad una vasta letteratura e sono state
considerate da alcuni come una vera e propria chiave interpretativa addirittura per rileggere Wittgenstein in modo unitario (vedi soprattutto il
recente Baker). Chi ha scritto su Wittgenstein e Freud lo ha fatto in vari
modi: o privilegiando un’attenzione per quello che potremmo chiamare
lo “spirito del tempo” e certe consonanze ideali tra gli intellettuali della
grand époque a Vienna (Cacciari, Gargani (1992), per esempio, o Janik
e Toulmin nel discusso libro su “La grande Vienna”, che hanno trovato
nei due, e in Musil, Kraus, Bernhard, Loos, Schönberg, intrinseche ed
estrinseche affinità); altri si sono dedicati a problemi metodologici ed
epistemologici per lo più incentrati sulla distinzione tra cause e ragioni,
tra spiegazioni e ridescrizioni, tra scienza e mitologia; altri, infine,
hanno preso spunto dalle considerazioni di Wittgenstein su Freud per
ripensare la psicoanalisi alla luce di quello che la filosofia del linguaggio e della mente del secondo Wittgenstein ha suggerito. È di questi ultimi che intendo qui parlare; e in particolare di autori che hanno esplicitamente tentato una ricostruzione della psicoanalisi dopo Wittgenstein
(Richard Allen, Louis Sass e Felice Cimatti su tutti), e di altri che,
come Mauro Mancia, Roberto Brigati o, in parte, gli stessi Paul-Laurent
Assoun e Jacques Bouveresse, hanno comunque considerato in maniera
costruttiva le critiche di Wittgenstein a Freud. In una parola, mi occuperò non tanto della rilevanza della psicoanalisi sulla filosofia di
Wittgenstein (cosa storicamente corretta e provata, seppur controversa),
ma della rilevanza di Wittgenstein sulla psicoanalisi; di fatto un falso
storico che si basa su un controfattuale: cosa sarebbe stata la psicoanalisi se Freud avesse letto e preso sul serio le critiche di Wittgenstein al
suo lavoro.
Ho detto di autori che hanno considerato in maniera costruttiva le
critiche di Wittgenstein a Freud. Certo, a prima vista, ciò può sembrare
un vero e proprio paradosso, giacché Wittgenstein accusò Freud di aver
perpetrato un “abominevole pasticcio” (confondendo cause e ragioni),
di aver fatto un “male incalcolabile” all’umanità («la psicoanalisi è una
289
A. Pagnini
prassi pericolosa e immonda, e ha causato male a non finire»), di aver
sedotto gli spiriti deboli con una potente “mitologia”, più che con una
scoperta scientifica; ma soprattutto accusò Freud di aver postulato processi psichici inconsci, che invece Wittgenstein negava, trattando il linguaggio del profondo come una mera façon de parler: esattamente
quello che, al contrario, Freud rimproverava a Pierre Janet di aver fatto,
con la conseguenza, secondo lui, di aver negato così l’ontologia stessa
su cui si edificava la psicoanalisi2. Ma, ripeto: è doveroso fare con questi autori uno sforzo d’immaginazione, e soprattutto di emendamento,
rinunciando a condividere le premesse scientifiche e teoriche di Freud e
assumendo quelle che, su temi come il linguaggio e la mente, caratterizzavano gli approdi del secondo Wittgenstein. Bisogna, cioè, per riprendere una delle tante immagini di Wittgenstein, provare a gettare il
seme di Freud nel terreno di Wittgenstein, e di vedere cosa ne nasce
(contrariamente a quanto si è in genere fatto in Francia e in Italia, dove
– come scrive Bouveresse – «si è ritenuto che fosse la filosofia ad aver
bisogno della “scienza” psicoanalitica, più che la psicoanalisi ad aver
bisogno di un lavoro di chiarificazione filosofica» (p. xi)). Personalmente ritengo, e ho argomentato altrove (1999), che Wittgenstein
avrebbe potuto benissimo dichiararsi “discepolo” di Goethe,
Kierkegaard o Spengler lasciando in pace Freud. Ma gli autori di cui
parlerò sono dell’avviso che sia la psicoanalisi a non poter fare a meno
di Wittgenstein, e il connubio da loro auspicato è talmente rilevante e
pervasivo nelle odierne letture filosofiche della psicoanalisi che merita
una riflessione.
Il primo aspetto che la psicoanalisi dovrebbe assimilare della critica
di Wittgenstein a Freud è di smetterla di pensarsi come una scienza
naturale, per attingere – come suggerisce Gargani – «un livello di autocomprensione più adeguato di quello che ne avrebbe avuto il suo stesso
fondatore» (2005, p. 38). Questo, però, non significa soltanto emancipazione della dottrina freudiana dai presupposti della fisica energetistica della seconda metà dell’Ottocento – come vuole Gargani – ma distacco della psicoanalisi dalle scienze naturali tout court: e cioè distacco da quelle scienze che si occupano di entità materiali; che usano
come nozione fondamentale quella di “causa efficiente”; che “spiegano”, nel senso che riconducono, riducono, la molteplicità e la plurivocità dei fenomeni a regolarità, a leggi, o, in ogni caso, ad una base
2
Per non appesantire il testo di riferimenti a Wittgenstein e ai tanti latori del suo
pensiero, raccomando ancora il libro di Bouveresse, in cui è possibile ritrovare
queste citazioni sparse di Wittgenstein adeguatamente contestualizzate e
commentate.
290
Freud dopo Wittgenstein
soggiacente, sia essa neurologica o simbolica. Qui c’è bisogno d’un ulteriore chiarimento, perché da quanto detto risulta che la psicoanalisi
non si debba soltanto emancipare dalle scienze cosiddette nomologicodeduttive e da una accezione “humeana” della spiegazione e della causalità, ma anche dall’ermeneutica, se per ermeneutica si intende una attività di interpretazione che riporti in qualche modo il caso al tipo, il
proliferare di sensi al “significato”, il dispiegarsi superficiale del senso
a un senso profondo, quello che si configura come un mero giustapporsi
di immagini ad un nucleo significativo univoco. Qui è Cimatti (2004)
che denuncia la portata complessiva di quello che battezza come “modello neurologico” di Freud. È il modello spaziale dell’inconscio;
quello che configura la mente come una sorta di contenitore (di ricordi,
di immagini, ecc.) e che presuppone (questo è importante) il linguaggio
come strumento di comunicazione, come essenzialmente referenziale,
come implicante una concezione corrispondentista della verità, e quindi
come una sorta di uncino che aggancia stati di cose, ricordi, “fatti” (vissuti e psichici). Nel modello neurologico-spaziale della mente ad ogni
traccia mnestica corrisponde un ricordo, ad ogni ricordo un segno, e ad
ogni ricordo e segno un fatto. Questo modello porta Freud a credere che
il linguaggio che noi usiamo durante le sedute analitiche serva a “pescare” un evento traumatico e a rappresentarlo verbalmente, portandolo
così alla coscienza dalle profondità dell’inconscio dove giace inespresso.
Eppure – ci dice Cimatti – Freud stesso scopre nella clinica qualcosa
che contrasta apertamente con questo modello: scopre l’importanza decisiva della fantasia e dell’immaginario nelle produzioni verbali del paziente. E questo per Freud è talmente problematico, che lo costringe ad
assegnare alla psicoanalisi un ruolo di sapere temporaneo, destinato
prima o poi ad essere riassorbito dalla scienza fisicalistica della mente.
Dopo Wittgenstein, però, questo svilimento della psicoanalisi a disciplina che un giorno sarà scienza nel pieno senso della parola perché riuscirà a dar conto di una realtà materiale e in ogni caso oggettiva, non
sono più necessari. Wittgenstein, infatti, ci permette di pensare un modello diverso, non più spaziale della mente, in cui non trovano più posto
distinzioni apparentemente alternative come superficiale e profondo,
interno ed esterno, dentro e fuori. Per Wittgenstein, il linguaggio non è
uno strumento per rappresentare oggetti, non ha un’unica funzione denotativa, non è neppure un mezzo per esprimere un’interiorità altrimenti inaccessibile (non denota puramente oggetti esterni e neppure
“idee” contenute nel “teatro cartesiano” della mente). Il linguaggio, in
positivo, è un insieme dinamico, variabile, di “giochi linguistici”,
ognuno con le sue regole, le sue ragioni, i suoi criteri di vittoria e di
sconfitta (per restare nella metafora del gioco). Questo significa che
291
A. Pagnini
Wittgenstein prende in considerazione tutti i tipi di proposizione che si
possono formare col linguaggio: non solo le asserzioni, ma anche le
domande, gli ordini, le esclamazioni, le scuse, le scommesse, le benedizioni, ecc.. «Innumerevoli tipi differenti d’impiego di tutto ciò che
chiamiamo “segni”, “parole”, “proposizioni”» – scrive Wittgenstein
(1967a, p. 203). E i giochi linguistici non sono fatti solo di parole. Ci
sono anche i gesti, i silenzi espressivi, le espressioni facciali. Parlare un
linguaggio è un’attività, una pratica sociale, una forma di vita – dice
Wittgenstein – non un qualcosa di preordinato che trascende la vita e il
parlare concreto. Non ci sono regole e significati che precedono e determinano univocamente il gioco linguistico che giochiamo; soprattutto,
non c’è una realtà esterna o interna che conferisce significato alle parole che usiamo. Per dirla in termini che trovano riscontro anche in altre
teorie del linguaggio (quella di Vygotsky, per esempio), i significati
sono costituiti congiuntamente dai partecipanti ad una conversazione,
costruiti da attori competenti nel corso di progetti che sono realizzati
all’interno di sistemi di norme pubbliche; e i fenomeni psicologici
espressi da alcune forme linguistiche non sono proprietà o processi
della mente nascosti che il discorso esprime. L’espressione discorsiva è
il fenomeno psicologico stesso.
Tutto ciò, ovviamente, comporta qualcosa di importante relativamente a una “ricostruzione razionale” di ciò che accade durante una
“cura parlata” (ché di transazione linguistica, o in ogni caso linguisticocomportamentale-gestuale, si tratta in psicoanalisi). Le parole dell’analista non “spiegano” il mentale, nel senso di ridurlo a qualcosa che non
è mentale (cause rimosse, o tantomeno attività neuronali e fisicochimiche), bensì rendono possibile acquisire coscienza delle regole nascoste del “gioco” che stiamo giocando. Per chiarire, cominciamo col
vedere come Wittgenstein tratta l’interpretazione dei sogni. Quando
commenta il modo in cui Freud spiega il significato dei sogni è inequivocabile: «La sua spiegazione storica di questi simboli è assurda […]
non c’è modo di mostrare che il risultato generale dell’analisi non potrebbe essere “inganno”. È qualcosa che la gente è portata ad accettare
e che rende loro più agevole seguire certe strade: certi modi di comportarsi e di pensare diventano per loro naturali […]» (1967, p. 129).
L’obiettivo dell’analisi non è dunque tanto quello di spiegare il sogno,
quanto di restituire al malato la sua libertà, e cioè la possibilità di disporre del materiale evocato nel racconto del sogno senza costrizioni,
vedendo più possibilità laddove era forzato a vedere un senso unico, e
dunque ad accettare quei contenuti senza esserne turbato, con naturalezza. Se l’immagine scientifica tipicamente ottocentesca della dinamica portava Freud a vagheggiare l’essenza del sogno, un modello che
292
Freud dopo Wittgenstein
funzionasse per dirci come si producono i sogni, qual è la meccanica
della loro configurazione, e dunque, a ritroso, ci consentisse di decifrarli, ora invece si tratta di riconoscerne a priori la complessità irriducibile, la loro estraneità a ogni logica “fondante”. Lo stesso si dica per
l’analisi nel suo complesso. Il malato non vuole che gli si spieghi il
sintomo, vuole star bene. L’analista – alla luce della filosofia del linguaggio di Wittgenstein – sa che il linguaggio non è un mezzo per
esprimere pensieri e sentimenti che sono chiusi da qualche parte nella
mente individuale privata e che precedono l’espressione. Il paziente che
proferisce l’enunciato “sono infelice” non descrive ad uso degli altri
uno stato interiore. Il modello non denotativo del linguaggio di
Wittgenstein – come abbiamo visto – nega la sequenza pensiero
privato-espressione linguistica-comunicazione agli altri di quel
pensiero. Se c’è qualcosa che la parola “inconscio” significa per
Wittgenstein è proprio il fatto che il paziente non può sapere nulla di
quello che succede in lui. Il problema non è rendere noto agli altri
quello che uno pensa o sente tra sé e sé, ma permettere di scoprire e definire quel che uno pensa ma non sa di pensare, quel che uno sente ma
non sa di sentire. Non c’è un contenuto nascosto in attesa che la parola
lo porti alla luce. Lo stato interno si costruisce insieme alla parola che
lo indica; diventa il risultato, e non la premessa, d’un’operazione linguistica riuscita. È qui che Wittgenstein trova una profonda analogia
con la filosofia: «Il filosofo si sforza di trovare la parola liberatrice,
quella parola che alla fine ci permette di cogliere ciò che fino allora,
inafferrabile, ha sempre oppresso la nostra coscienza. (È come quando
abbiamo un pelo sulla lingua: lo sentiamo, ma non possiamo afferrarlo/prenderlo e perciò non riusciamo a liberarcene)» (1967a, p. 243).
Scopo della terapia non è portare alla superficie ciò che è nascosto, sepolto nella memoria, bensì quello di dare forma, di dare corpo linguistico, ad una condizione altrimenti indeterminata, ad un disagio senza
portatore, che accade, ma non appartiene in senso stretto a chi lo sente.
Sono evidenti profonde, e talora dichiarate, somiglianze tra il “metodo” di Wittgenstein e la morfologia di Goethe nel suo “Metamorfosi
delle piante”. Per capire come Wittgenstein potesse interessarsi alla
morfologia, dobbiamo ricordare che fin dai tempi del “Tractatus” egli
sosteneva che per la filosofia niente è più fondamentale – in vista del
chiarimento logico dei pensieri – dell’esibizione delle relazioni logiche
(relazioni interne) del linguaggio; e che ciò deve ottenersi senza fare
uso di alcun metalinguaggio. Goethe gli interessava perché il suo progetto morfologico implicava l’eliminazione dallo studio della natura
della dicotomia profondità/superficie, il rifiuto del programma classico
di spiegazione dei fenomeni naturali in termini causali e la sua sostitu293
A. Pagnini
zione con una speciale analisi comparata, da cui sarebbe dovuta scaturire la chiara visione dei nessi intercorrenti tra gli elementi appartenenti
alle diverse serie naturali. Compito del morfologo è rendere possibile,
attraverso l’applicazione delle sue peculiari strategie comparative,
l’esibizione delle relazioni che intercorrono tra le diverse forme naturali, mostrando quale posto ognuna di esse occupa in rapporto all’altra e
considerandole a partire dalla chiara visione di tali relazioni. Anche
Wittgenstein considera fuorviante la coppia concettuale profondità/superficie in quanto perpetuante l’illusione – che deriva da un’erronea trasposizione dei metodi della scienza all’indagine del significato –
che attribuisce un carattere fondante a ciò che giace in profondità e si
ritiene agisca come struttura ultima, considerando invece le singole realizzazioni di superficie solo come esemplificazioni contingenti. Oggetto della sua indagine sono le regole dei giochi linguistici che, potremmo dire, stanno ai giochi o più in generale ai sistemi di senso nella
stessa relazione in cui i contorni di un disegno stanno alla forma, alla
figura cui danno origine. Come all’occhio del morfologo i contorni che
identificano una forma stanno solo per se stessi, così per il logico le regole dei giochi; esse non portano a espressione qualcosa di nascosto che
andrebbe scoperto, ma stanno lì in superficie, sono sotto i nostri occhi.
Tra le richieste che accomunano gli atteggiamenti di Goethe, di
Spengler e di Wittgenstein nei confronti dei loro oggetti di indagine,
quella che salta più agli occhi è la richiesta di abbandonare le spiegazioni causali per sostituirvi la semplice descrizione. La descrizione
morfologica rappresenta per loro un genere di attività conoscitiva essenzialmente interessata alla presentazione dei nessi tra i fenomeni,
all’esibizione delle relazioni che li connettono; il suo scopo è far scaturire la comprensione dai confronti che di volta in volta vengono istituiti
tra le diverse forme dei fenomeni, tra le diverse configurazioni che essi
assumono. In un passo della “Grammatica filosofica”, Wittgenstein, nel
pieno rispetto dell’atteggiamento morfologico, afferma: «Io mi limito a
descrivere il linguaggio e non spiego nulla» (p. 251); contestualmente
precisa che, dal suo punto di vista, qualsiasi fatto d’esperienza linguistico, in quanto tale, non lo interessa, perché della descrizione che il
filosofo produce al fine di esplicitare il significato di una parola non è
la verità che importa, bensì la forma. Ma se non importa la verità, a
cosa guardano le descrizioni filosofiche? A penetrare l’operare del linguaggio in modo da riconoscerlo (contro una forte tendenza a fraintenderlo), in modo da renderlo perspicuo, cioè da assestare e ordinare ciò
che da tempo ci è noto. A differenza delle descrizioni che riguardano
fatti empirici, e sono quindi interessate alla verità fattuale, le descrizioni prodotte dal filosofo si caratterizzano in primo luogo per il fatto di
294
Freud dopo Wittgenstein
vertere essenzialmente sulla dimensione non empirica del linguaggio:
su ciò che nel linguaggio è indipendente dal confronto con i fatti, dalla
verificazione e dalla falsificazione, nonché dalla sua funzione. In secondo luogo, le descrizioni filosofiche si caratterizzano per il fatto di
essere anzitutto interessate a rendere possibile il riconoscimento dei
modi di operare del nostro linguaggio, dove ormai appare evidente che
con “riconoscimento” Wittgenstein intende quel genere di conoscenza
che deriva dall’applicazione delle più svariate tecniche di raffronto e di
raggruppamento morfologico tra gli innumerevoli tipi di usi linguistici
possibili.
E torniamo alla psicoanalisi. Cimatti, in queste premesse che concernono la semantica e la metodologia, vede un immediato risvolto che
riguarda la pratica analitica. Il problema è quello dell’efficacia dell’analisi. Se non c’è un senso da ritrovare e riconoscere, se il significato si
acquisisce soltanto in terza persona, ed è determinato in una pratica sociale, discorsiva, allora al centro dell’analisi vi sarà la relazione di
transfert e controtransfert, con l’analista che non interviene direttamente sul paziente (sarebbe un residuo di quella logica chirurgica legata alla visione spaziale della mente e al modello descrittivo del linguaggio), ma deve solo aiutare a vedere, a vedere perspicuamente, a
rimettere i pezzi a posto. La cura è esperienza di libertà, e non è esperienza intellettuale, ma affettiva. Dove prima il paziente aveva una sola
via e soffriva ad attraversarla, ora ha di fronte diverse soluzioni, e anche la stessa via da sempre percorsa può essere percorsa con uno stato
d’animo diverso, con il senso della scelta tra più possibilità.
Wittgenstein lo dice chiaramente per la filosofia (e ricordiamoci: filosofia, analisi concettuale=terapia): «La filosofia non mi porta a nessuna
rinuncia, perché non mi vieto di dire qualcosa, bensì abbandono una
certa combinazione di parole come priva di senso. Ma in un altro senso
la filosofia esige una rinuncia, però una rinuncia del sentimento, non
dell’intelletto. Ed è forse questo il motivo che la rende difficile a molti.
Può essere difficile non usare un’espressione, come è difficile trattenere
le lacrime o uno sfogo dell’ira» (1990, p. 302). Dunque, l’efficacia
dell’analisi è interna alle sue regole, è un’efficacia legata al tipo di regole che l’analisi stessa istituisce; e la verità dell’analisi rimanda a
nient’altro che al dischiudere al paziente ipotesi diverse, realmente praticabili, rispetto al senso della sua sofferenza. La “costruzione” analitica mette a disposizione del paziente spazi di manovra che prima egli
non riusciva a cogliere.
Questo modello wittgensteiniano è oggi molto più influente (nelle
letture filosofiche della psicoanalisi) di quanto non sia certificato dagli
espliciti interventi degli autori che ho citato. Per esempio, la “svolta
295
A. Pagnini
etica” nella valutazione della psicoanalisi, di cui Jonathan Lear è uno
dei maggiori promotori, attinge a questo modello. Qui non discuto del
significato etico del modello che abbiamo presentato, bensì dei suoi limiti epistemologici; limiti che a mio avviso lo minano alla base e che
qui condenso in quattro punti:
1. Innanzitutto, la filosofia del linguaggio su cui si fonda tale modello
non è affatto immune da critiche, non è una acquisizione definitiva
(e, in Wittgenstein, non si è mai presentata neppure come una “teoria”, mentre invece i neowittgensteiniani la fanno apparire come
tale). Essa lascia intendere una opposizione laddove io direi che vi
sono semplicemente due facce della stessa medaglia: una cosa è
parlare del significato di eventi e pensare alle azioni individuali in
termini di eventi (compierle, prevenirle, ecc.), e una cosa è parlare
del significato o contenuto di stati psicologici in termini di strutture
di second’ordine nel cervello, o di computazioni su rappresentazioni
in un “sistema semantico” interno. Non può essere che le due cose
siano complementari? Che si parli di due aspetti diversi del significato? Wittgenstein non ha mai negato l’esistenza di stati mentali. Ha
semplicemente enunciato, con il noto argomento contro il linguaggio
privato, una tesi semantica sull’impossibilità di immaginare un linguaggio le cui espressioni assumono significato per il fatto di essere
associate a esperienze private vissute del soggetto che istituisce il
linguaggio. Wittgenstein dice semplicemente che il linguaggio privato non è un linguaggio perché non ci sarebbe alcun criterio per
determinare la correttezza dell’uso delle sue espressioni; e un linguaggio, per essere tale, deve essere corretto o scorretto. Quindi dice
solo che non si può determinare il significato di un’espressione tramite una sua connessione con un ente mentale, non che non ci sono
stati o enti mentali (la tesi semantica non implica la tesi ontologica).
2. Oltretutto, e in secondo luogo, è evidente un’affinità tra la negazione
degli stati mentali da parte dei neowittgensteiniani e il comportamentismo logico, con tutti i limiti che porta con sé il ridurre il mentale a disposizioni.
3. La critica alle spiegazioni causali del comportamento che il modello
avanza risente di una grave lacuna nel considerare la logica delle
spiegazioni causali in generale. Neppure in fisica si pensa che le
“entità” invocate in una spiegazione causale siano necessariamente
materiali. Funzionano eccome anche spiegazioni che fanno appello a
costrutti teorici, a tipi, a “entità” come la corrente elettrica, i campi
magnetici, le valenze chimiche e anche i tipi ideali di Weber, o le
sovrastrutture economiche di Marx, o i processi inconsci; proprio
296
Freud dopo Wittgenstein
perché tramite quelle entità teoriche, oltre a spiegare correlazioni altrimenti inspiegabili, si prevedono eventi e comportamenti, cosa che
non è possibile tramite mere ridescrizioni degli eventi. Oggi nessuno
più analizza il concetto di causalità in termini humeani di condizioni
necessarie e sufficienti. Si parla di rilevanza causale (vedi
Grünbaum, pp. 96-114). Ma soprattutto non si ritiene più che una
descrizione non sia una specie di spiegazione. La scienza è piena di
spiegazioni mediante processi (che sono descrizioni); e queste, sia
che invochino processi nascosti sia che facciano riferimento ad antecedenti causali, assumono valore esplicativo nella misura in cui descrivono un processo di collegamento (indipendentemente dalla natura materiale delle entità che impiegano).
4. Infine, la metafora del gioco linguistico (bonne a tout faire!). Perché
considerare la psicoanalisi un gioco linguistico a sé? I giochi linguistici cui faceva riferimento Wittgenstein erano ben più elementari e
in un certo senso naturali: il contare, il credere in Dio, l’amare, il
fare politica. Ma perché deve essere un gioco linguistico la psicoanalisi e non, per esempio, in generale il curare o il prendersi cura?
Siccome, soprattutto nell’interpretazione di Cimatti, non esiste un
super-gioco linguistico che consenta di parlare dei giochi linguistici
speciali, non ci sono regole che regolano e fondano i diversi giochi,
questo lascia presumere che la psicoanalisi sia un gioco che non si
deve “criticare”, ma che si deve solo giocare correttamente. Anzi, è
talmente chiuso in se stesso, che la sua efficacia è data proprio dalla
corretta applicazione delle regole del gioco; non da un confronto
delle regole coi fatti («la contraddizione sussiste fra una regola e
un’altra regola, non fra regola e realtà», diceva Wittgenstein (1967a,
p. 187)). L’analisi si ferma quando il paziente mostra di essere soddisfatto, così come la risposta filosofica è soddisfacente quando si
acqueta l’ansia, l’uneasiness, il disagio di chi si pone una domanda
carica di presupposti metafisici non esplicitati. Ma può essere la
soddisfazione del paziente, il fatto che il paziente dice basta, dice di
veder chiaro, un criterio di validità di un intervento terapeutico? E
siccome il tipo di intervento dell’analista è neutro rispetto ad una teoria (metapsicologica e anche clinica), questa ricostruzione
dell’efficacia analitica non equivale a dissolvere la specificità della
psicoanalisi?
297
A. Pagnini
BIBLIOGRAFIA
Allen R.: “Psychoanalysis after Wittgenstein”. Psychoanalysis and Contemporary
Thought, 1997, XX, 3.
Assoun P.-L.: “Freud et Wittgenstein”. PUF, Paris, 1988.
Baker G.: “Wittgenstein’s Method. Neglected Aspects”. Blackwell, Oxford, 2004.
Bouveresse J.: “Filosofia, mitologia e pseudo-scienza”. Einaudi, Torino, 1997.
Brigati R.: “L’albero della conoscenza. Appunti per una filosofia wittgensteiniana
della psicoanalisi”. Teorie & Modelli, 2000, n.s., V, 1-2.
Cacciari M.: “Krisis”. Feltrinelli, Milano, 1976.
Cimatti F.: “Il senso della mente”. Bollati Boringhieri, Torino, 2004.
… : “Freud lettore di Wittgenstein. Per una mente senza profondità”. Rivista di
psicoanalisi, 2005, LI, 1.
Gargani A.: “Il coraggio di essere”. Laterza, Roma-Bari, 1992.
… : “Wittgenstein e Freud: filosofia e terapia linguistica”, in Mancia M., 2005.
Grünbaum A.: “I fondamenti della psicoanalisi”. Il Saggiatore, Milano, 1988.
Janik A., Toulmin S.: “La grande Vienna”. Garzanti, Milano, 1975.
Lear J.: “Therapeutic Action. An Earnest Plea for Irony”. Karnac, London, 2003.
Mancia M. (a cura di): “Wittgenstein e Freud”. Bollati Boringhieri, Torino, 2005.
Pagnini A.: “Wittgenstein ‘discepolo’ di Freud”. Psicoanalisi, 1999, III, 2.
Sass L.A.: “Superficie e profondità. Wittgenstein, Freud e lo scandaglio dei
motivi”. Discipline filosofiche, 1998, VIII, 2.
Voltolini A.: “L. Wittgenstein: analisi come terapia e analisi come mitologia”.
Rivista di filosofia, 1985, LXXXVI, 3.
Wittgenstein L.: “Lezioni e conversazioni”. Adelphi, Milano, 1967.
… : “Ricerche filosofiche”. Einaudi, Torino, 1967a.
… : “Grammatica filosofica”. La Nuova Italia, Scandicci, 1990.
… : “Filosofia”. Donzelli, Roma, 1996.
Prof. Alessandro Pagnini
Via dei Macci, 19
I-50122 Firenze
298