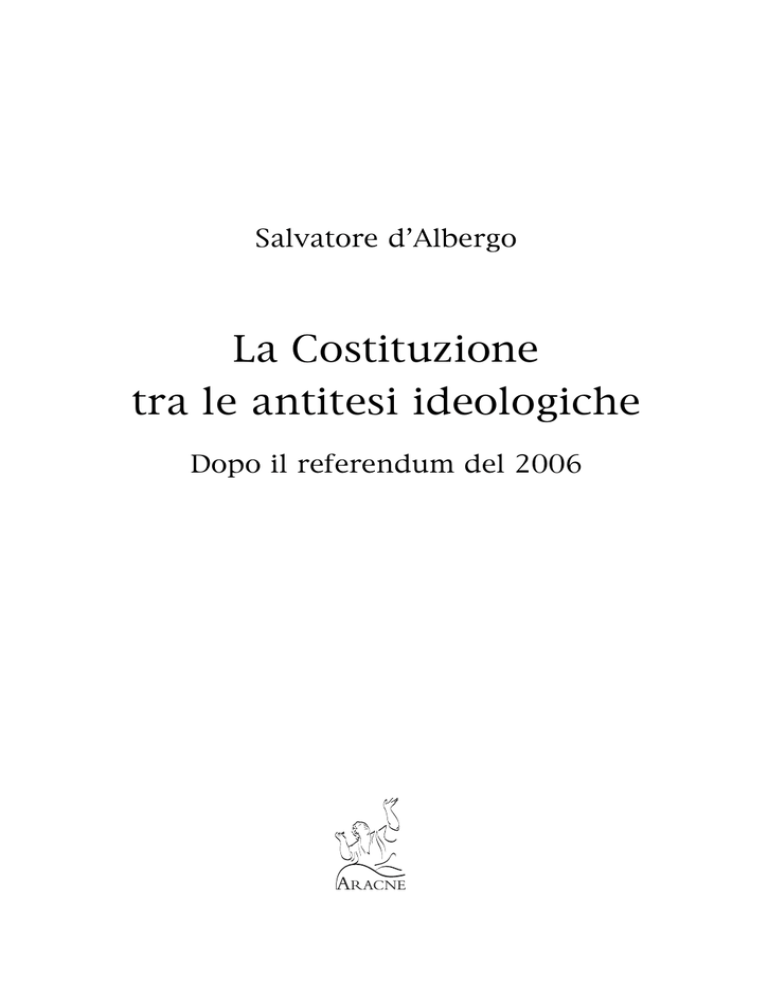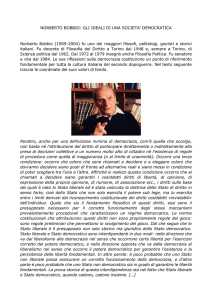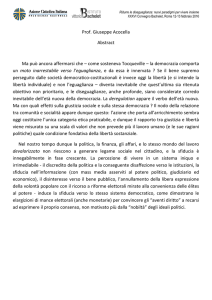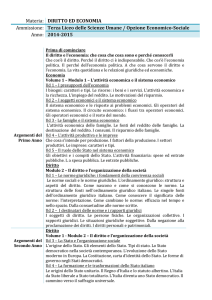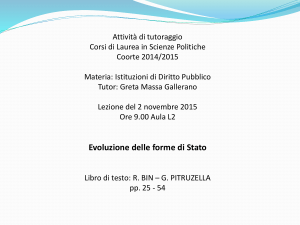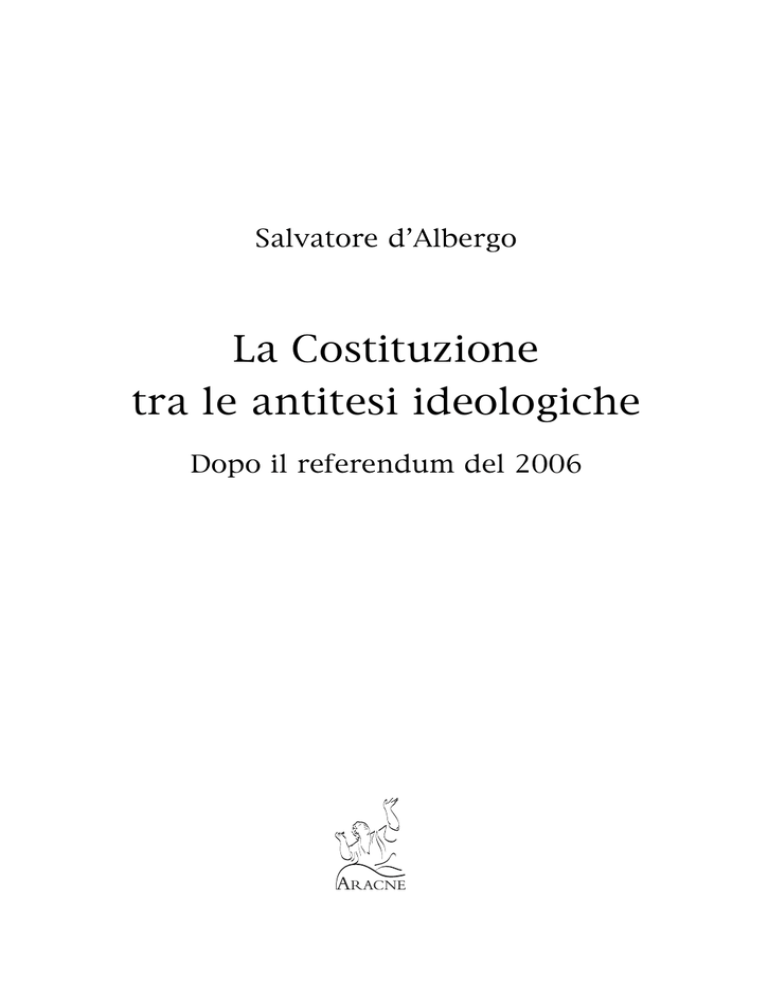
Salvatore d’Albergo
La Costituzione
tra le antitesi ideologiche
Dopo il referendum del 2006
ARACNE
Copyright © MMVIII
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
(06) 93781065
ISBN
978–88–548–1723–4
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: aprile 2008
5
Indice
PARTE PRIMA
Dal modello “liberale” al modello “democratico”
1.
Forma di Stato e forma di governo nell’ideologia
giuridica .................................................................
pag. 9
2.
La supremazia della “rappresentatività” sulla “governabilità” ................................................................. pag. 28
3.
Dal coordinamento dei poteri alle garanzie costituzionali ......................................................................... pag. 54
PARTE SECONDA
Il modello “democratico–sociale”
1.
L’antitesi “economicità / socialità” tra “blocco” e
“diffusione” del pluralismo ...................................
pag. 71
2.
Dalla stabilizzazione economico–istituzionale allo “sviamento” del modello democratico–sociale ............. pag. 110
3.
La strategia delle “riforme istituzionali” come omologazione ideologica tra “scardinamento” e adeguamento alla “democrazia costituzionale” ....................................... pag. 145
Riferimenti bibliografici ............................................... pag. 131
5
6
7
PARTE PRIMA
Dal modello “liberale” al modello “democratico”
8
1. Forma di Stato e forma di governo nell’ideologia giuridica
La cadenza del sessantesimo anniversario della Costituzione
sopravissuta quasi integralmente alle complesse e contraddittorie vicende che ne hanno accompagnato i travagliati decenni, si
presenta come occasione non rituale per una ricostruzione della
portata delle novità con cui gli istituti della democrazia sociale
hanno contraddistinto un “modello” che ha rovesciato i termini
dell’enfatizzata costituzione di Weimar: a suggello della legittimazione democratica aperta dalla fine della seconda guerra
mondiale dopo la sconfitta del fascismo, in alternativa al carattere effimero dei tentativi di c.d. “stato sociale” esperiti alla fine
della prima guerra mondiale, sotto l’incombere della prima esperienza di c.d. “socialismo reale” connotato dall’abolizione della
proprietà privata in nome del comunismo.
L’intuizione di massa che ha indotto l’elettorato italiano ― a
distanza di un complesso e contraddittorio sessantennio ― a rilegittimare con il referendum del 25/26 giugno 2006 lo spirito e
la lettera della trama della Costituzione approvata nel 1947 da
circa il 90% dei rappresentanti dei partiti che avevano organizzato nei Comitati di Liberazione Nazionale (CLN) la lotta sociale, politica e militare con la Resistenza antifascista contro gli epigoni della r.s.i e del nazismo in rotta, impone una riflessione
che valga a cogliere il significato di fondo del netto imprevisto
contrasto emerso tra il popolo Sovrano e il fronte delle forze politiche divise aspramente nel cosiddetto “bipolarismo”.
È stato sconfitto da un diffuso profondo senso civico l’intento
perseguito da destra e da sinistra di introdurre modelli di “revisione” dell’intera Seconda Parte della Costituzione, tutti ispirati
9
10
PARTE PRIMA
dal proposito di rovesciare la forma di governo “parlamentare”
e delle “autonomie” sociali e politiche, per delegittimare la Prima Parte e gli stessi Principi Fondamentali portatori insieme
della forma di stato di “democrazia sociale”, a differenza della
forma di stato “liberal–democratica” degli stati di “democrazia
classica”.
Si è così bloccato un quarantennio di tentativi di tipo “golpista” (a partire dalla metà degli anni ’60, sino allo stragismo e al
terrorismo degli anni ’70 e ’80); e di tipo “controrivoluzionario”
(nell’arco di tempo che va dal 1983 ad oggi) formalizzati nei
progetti di ben tre “commissioni bicamerali” in cui hanno colluso anche correnti eredi dei partiti di massa che avevano elaborato una costituzione risultata la più originale contro la tradizione
del “costituzionalismo liberal–democratico”.
Va pertanto colta questa storica rilegittimazione della cultura
politica posta a base della forma di stato di “democrazia sociale”
che la costituzione del 1948 ha incardinato sul completo rinnovamento dei “tre poteri” dello “stato costituzionale”della tradizione liberal–democratica (il c.s. “stato di diritto”), potere esecutivo, potere legislativo, potere giudiziario cui sono stati aggiunti
gli strumenti di garanzia costituzionale (corte costituzionale,
procedimento di revisione costituzionale, oltre che il referendum
abrogativo.
Ciò consente di verificare, rapportandola alla sintesi del modello emanato alla fine del 1947, la portata dei tentativi di sviamento e di scardinamento che sin da quella data si sono operati,
per rilanciare con la necessaria consapevolezza la lotta culturale
e politica che incombe in una situazione così degradata, e che il
referendum del 25–26 giugno 2006 consente di rimettere nella
giusta carreggiata se le forze politiche si conformeranno alla linea indicata dai cittadini.
Su queste premesse è possibile far tesoro degli esiti complessi del voto con cui è stato respinto l’attacco pericolosamente organizzato dai gruppi di potere facenti capo al centrodestra, sulla
scia di un processo avviato e proseguito dai partiti del cosiddetto
“ulivo” in nome di una mistificatrice esigenza di “adeguamento”
Dal modello “liberale” al modello “democratico”
11
della forma di governo italiana ad una enfatizzata “società della
globalizzazione”.
Tale inequivocabile risultato racchiude implicazioni che vanno al di là della dura sconfitta subita non solo dal provocatorio
tentativo “leghista” di estremizzare il federalismo incautamente
introdotto dal centrosinistra nel 2001, ma anche e soprattutto dal
disegno di Berlusconi, Fini, Casini e Bossi di rilanciare un modello di “capo del governo” arieggiante quello introdotto nel
1925 (con l’avallo della cultura giuridica dello autoritarismo liberale) dal primo fascismo: modello cui Prodi, D’Alema, Rutelli
da un canto e Bertinotti e Diliberto d’altro canto, hanno solo
giustapposto forme diverse di primato dell’esecutivo ma
anch’esse tutte “antiparlamentari”, in linea con la strategia incarnata dalla fine degli anni ’70 dal Psi di Craxi, cui in modo
strisciante ha finito per aderire prima la destra del Pci, e poi il
Pds unitamente al Ppi, effimeramente seguiti dagli ex comunisti
dichiaratisi disponibili a imitare il “cancelleriato” della Germania di Bonn, oltre che a subire il federalismo nel segno di un cosiddetto “regionalismo forte”.
Occorre subito precisare perciò quale margine di equivoco la
pur decisiva risposta popolare lascia per iniziative, subito annunciate, volte a recuperare tutto quel che sullo sfondo della
sconfitta del modello del centrodestra appartiene alla cultura politico–istituzionale dell’Ulivo, come conseguenza dello spirito
“controrivoluzionario” che presiede alla strategia “riformista”
per omologare l’eredità dell’antifascismo alla “normalità” di un
sistema di governo non più improntato alla “centralità” del parlamento e funzionale alla “democrazia sociale”, ma organizzato
secondo una delle numerose variabili modellistiche escogitate
dalla “ingegneria costituzionale” per servire gli interessi della
formazione sociale del capitalismo in tutto il mondo occidentale:
operando cioè una separazione, per un loro ribaltamento, tra il
ruolo della Seconda e quello della Prima Parte del modello costituzionale italiano entrato in vigore nel 1948.
Si rende perciò necessario e urgente rilanciare la lotta culturale per la costituzione abbandonata dalla fine degli anni ’70 con
12
PARTE PRIMA
una maggiore consapevolezza, oggi latente in seno al popolo che
ha votato un forte “no” allo stravolgimento della costituzione
repubblicana, della esigenza di consolidare la democrazia con
più profonda determinazione di quella assunta con il voto referendario in nome della pur indispensabile ma di per sé limitata
“difesa” della costituzione.
E tale lotta va incardinata su un preciso presupposto teorico e
politico, e cioè che la costituzione del 1948 è il condensato della
strategia politico–sociale imposta dai partiti di massa che, in
nome dell’ideologia antifascista, hanno mirato a porre le basi
della formazione di una nuova classe dirigente volta a tagliare
alle radici gli istituti politico–istituzionali del liberalismo “autoritario” che, entrati in crisi dopo la prima guerra mondiale, sono
stati ereditati dal fascismo e commutati secondo una concezione
“totalitaria” travolta a prezzo della alleanza delle democrazie liberali e socialiste che hanno combattuto nella seconda guerra
mondiale il nazi–fascismo.
Sì che con la Resistenza si è puntato a legittimare il pieno titolo del movimento operaio a contrastare, nel ripristino delle
premesse della libertà e della democrazia, il dominio di classe
del capitalismo, per erigere sulle ceneri del fascismo un nuovo
tipo di forma di stato, non più imperniata sulla sovranità degli
apparati burocratici repressivi ed oppressivi, ma sull’autonomia
della società assegnando alle forze sociali e politiche “organizzate” il compito di elaborare ― immettendole nel circuito delle
rinnovate istituzioni di governo ― gli indirizzi politici, economici e sociali contrastanti con il ristretto interesse di classe che
tradizionalmente ha visto contrapposto il meccanismo di accumulazione della ricchezza, agli interessi del “lavoro”.
L’unità nella diversità cementata nel pluralismo sociale e politico di partiti e movimenti collegati nella lotta di liberazione in
cui sono stati coinvolti anche i gruppi facenti capo alla monarchia (benché questi si siano arroccati nell’ultimo tentativo di fare salvo l’istituto monarchico, con il “referendum istituzionale”
che ha introdotto la repubblica mentre si eleggeva l’Assemblea
costituente) è valsa a dare piena coerenza alla rottura di conti-
Dal modello “liberale” al modello “democratico”
13
nuità segnato dalla cancellazione dello “statuto albertino” (che
ha avuto vigore dal 1848 al 1943). Consentendo così di oltrepassare i limiti storicamente attestati delle costituzioni dei paesi occidentali improntati ad una liberaldemocrazia che, proprio dove
è stabile, toglie alle masse la libertà sostanziale enfatizzando la
libertà formale, e dove è instabile blocca a stento le gravi contraddizioni tra libertà e democrazia derivanti dalle attese prospettate dalla inseguita democrazia “reale”, in nome del socialismo.
Quel che va tenuto ben presente oggi è che sotto le spoglie
della conclamata “globalizzazione” si cela il cedimento politico
e culturale all’espansione “reticolare” del sistema delle imprese
transnazionali sotto l’egida del capitale finanziario, con l’aggravante che si cerca dal centrosinistra oltre che dal centrodestra di
imporre la scelta di una delle molteplici vie offerte dalla modellistica istituzionale borghese per sovvertire il rapporto tra interessi sociali e potere di governo, tra democrazia di massa e comando capitalistico, con una operazione teorico–politica che occulta il carattere di originalità che la costituzione del 1948 ha
acquisito e mantiene, per motivi di fondo che come non sfuggirono alle forze conservatrici di allora, così sono presenti oggi a
tutti quanti da diverse angolazioni tramano per coagulare ideologicamente le erosioni materiali che nella fase attuale la costituzione ― come testo “formale” ― subisce alla stregua del resto
di quanto in ogni fase dei processi storici discende dalla dialettica tra la “forma” e la “realtà” del diritto e dello stato nei diversi
ordinamenti sociali e politici.
Il segno e il peso di tale originalità ― la cui rilevanza è ancora tale che gli esponenti della cultura liberaldemocratica puntano
ad una rivincita sull’esito negativo del referendum del 25–26
giugno perché ha fatto salva l’”eterna diversità” di quella costituzione che perpetua il “caso italiano” al cospetto dei “grandi sistemi dell’occidente” ― è riconoscibile se si parte dal presupposto che l’entrata in vigore di una nuova costituzione è comunque
un evento “politico” da cui discendono conseguenze anche di tipo “giuridico”, che non giustificano perciò quella inversione ti-
14
PARTE PRIMA
pica della cultura borghese per cui ogni fenomeno sociale a base
del diritto e soprattutto delle costituzioni andrebbe incasellata
nelle categorie concettuali della scienza giuridica, che cancellano aprioristicamente i caratteri “storico–politici” del fenomeno
di livello costituzionale, in nome di una modellistica che si attiene a schemi esteriori e formali ispirantisi oltretutto ad una ideologia conservatrice e continuistica.
E la natura “politica” della costituzione va sottolineata tanto
più nei casi in cui essa ― come conferma il contesto della elaborazione della costituzione italiana del 1948 ― si è posta come
sbocco di un processo di tipo rivoluzionario quale è stata la Resistenza ispirata dai partiti antifascisti, con la conseguenza che il
potere costituente “sociale” ha preceduto ed è stato il motore del
potere costituente “politico–istituzionale” espresso dalla successiva Assemblea costituente, destinata a delimitare i tratti del
nuovo ordinamento sociale, politico ed economico secondo un
modello non inquadrabile negli schemi della cultura giuridica
tradizionale, appunto perché prodotto delle culture “politiche”
dei partiti che avevano condiviso l’esigenza di predisporre una
strategia di trasformazione della società e dello stato. Tale cioè
da rivoluzionare i rapporti sociali ed i rapporti politici, elaborando un ordinamento conformato all’interdipendenza dei principi della “democrazia sociale”, antitetici alla “liberal–democrazia” garante della supremazia della proprietà e dell’“impresa”
sul “lavoro”, e quindi delle classi possidenti sul proletariato, e
sugli altri ceti socialmente dipendenti.
Poiché l’ingresso nello stato delle nuove forze sociali e politiche rappresentate soprattutto dai partiti di massa ― partito comunista, partito socialista e democrazia cristiana ― implicava
una profonda modifica dell’asse dei rapporti tra società e istituzioni con riferimento all’ideologia di cui ciascuno di tali partiti
era portatore, l’impatto più significativo maturato negli anni
1943–1946 ― anno in cui la Costituente cominciò i suoi lavori
― ha avuto come referente costante il nesso tra l’ideologia antifascista e il fondamento socio–politico del nuovo stato repubblicano, in contrasto con l’ideologia liberale e fascista che al coper-
Dal modello “liberale” al modello “democratico”
15
to dello “statuto albertino” aveva conferito fondamento al “protezionismo liberale” sino all’avvento del fascismo, e poi al “corporativismo” come criterio di organizzazione “blindata” della
supremazia del capitalismo.
Da un lato per effetto della eliminazione delle libertà politiche da parte del regime del partito unico, e dall’altro lato mediante l’eliminazione delle libertà sociali a carico esclusivamente della classe lavoratrice (sindacato “di stato”, sanzione come
“reato” del diritto di sciopero), come corrispettivo della consacrazione del dominio dell’impresa capitalistica (privata, e a partecipazione statale) nelle forme peraltro “coattive” della mistificatoria collaborazione di classe.
Solo tentando di svilire l’ideologia antifascista ricorrendo artificiosamente all’ideologia “giuridica” interna all’ideologia
“politica” liberaldemocratica, si poteva tentare di ostacolare
l’elaborazione della costituzione democratico–sociale che, sulla
spinta particolarmente dalla cultura marxista, puntava a creare le
premesse di una “transizione al socialismo” incontrando sulle
traiettorie della “democrazia progressiva”, strategicamente proposta nel nome del “partito nuovo” consacrato dalla “svolta di
Salerno”, quei partiti che su matrici teoriche di natura marxista e
cattolica erano orientati a coinvolgere gli epigoni della cultura
borghese tradizionale e laica (liberali, repubblicani e “azionisti”)
in una prospettiva di valorizzazione delle libertà “civili” e politiche ottocentesche, entro un quadro di apertura verso un processo
di “emancipazione” atto a far lievitare diritti di tipo nuovo ― i
“diritti sociali” ― dalla conversione del regime della proprietà e
dell’impresa a una disciplina di riqualificazione secondo le variabili utilità “sociali” da assegnare alla produzione di beni e
servizi: andando così oltre le stesse prospettive di “stato sociale”
i cui ascendenti sono inscritti nel tanto enfatizzato modello della
“repubblica di Weimar”, su cui si è attestata la cultura sociale e
politica socialdemocratica.
I leaders dei partiti alla Costituente erano quindi ben edotti
della natura delle costituzioni più emblematiche della tradizione
dell’occidente, sia europeo che statunitense, e la loro propensio-
16
PARTE PRIMA
ne ad innovare sulla tradizione muoveva dalla precisa intenzione
di trascenderle tutte, perché le costituzioni britannica e statunitense, nonché quella francese e tedesca (per stare ai modelli paradigmatici anche di altre costituzioni europee) avevano ed hanno una caratterizzazione comune, pur nella diversa datazione di
origine: e cioè di essere imperniate sulla preminente destinazione a delineare le specifiche “forme di governo” con cui dominare una società diretta ― appunto ― “dall’alto” anziché “dal basso”, per garantire “stabilità” agli assetti sociali di una struttura
economica prima improntata agli interessi della proprietà fondiaria, e poi anche a quelli della proprietà e dell’impresa capitalistica: donde il carattere “riflesso” anziché fondante dei “diritti”, intestati genericamente ai “cittadini” per occultare le contraddizioni di classe che la cittadinanza “politica” presenta e fa
vivere nella scissione tra “sociale” e “politico”, con univoche
proiezioni sui vari modelli di forma di governo. Testimonianza
degli intenti della “ingegneria costituzionale” di salvaguardare la
“forma di stato” liber0aldemocratica e la conservazione
dell’assetto nei rapporti tra le classi al di là delle mutazioni presentate anche con il concorso del progresso tecnico tra la fine
dell’800 e l’inizio del ‘900 nonché tra la fine del ‘900 e l’inizio
del 2000 ― cioè in contesti storici che l’odierna politologia tende a contrapporre apoditticamente in nome del “post–moderno”
― è rintracciabile nella ricerca puntigliosa ed ossessiva di celare
l’essenzialità dei rapporti di “potere” che condizionano la fissazione delle “regole” con cui, nel passaggio dall’assolutismo al
costituzionalismo dello “stato moderno”, si è pervenuti al riconoscimento dei “diritti individuali”, estendendoli a tutte le classi
con il suffragio universale (prima solo maschile, e poi anche
femminile): con la costante preoccupazione, però, di ottenere
che l’emanazione delle regole sia appannaggio esclusivo di
maggioranze fedeli interpreti ― con le “forme di governo” sorrette artatamente da meccanismi elettorali distorsivi della “reale”
rappresentanza politica ― degli intoccabili interessi della borghesia produttiva, sotto gli emblemi, enfatizzati nella loro crescente ambiguità, del cosiddetto “stato di diritto”.
Dal modello “liberale” al modello “democratico”
17
Consapevoli della necessità non solo di sbarrare la strada di
un infausto ritorno al fascismo ma soprattutto di creare i presupposti di una democratizzazione della società e dello stato che è
estranea alla cultura liberal–democratica anche nella versione liberal–socialista, i partiti “costituenti” dell’Italia repubblicana
hanno elaborato una “forma di stato” volta ad andare oltre i limiti dello “stato di diritto sociale” mediante una operazione di “teoria sociale” da combinare con una conseguente operazione di
“teoria istituzionale”, consistente nella elaborazione di norme
costituzionali di tipo nuovo perché statuenti un “progetto di società” alternativa a quella salvaguardata negli altri ordinamenti
capitalistici: progetto in cui la “legge” unisce al compito di garantire l’attuazione dei diritti individuali, anche il nuovo compito di “dirigere” l’uso dei meccanismi produttivi e riproduttivi ―
cioè l’economia e i servizi collettivi ― secondo un piano globale che sia conseguentemente imperniato sul potere preminente
degli organi parlamentari in quanto recettivi delle opzioni espresse dalle organizzazioni in cui si articola il pluralismo sociale e politico come cardine della democrazia di massa.
In tale tipo di impegno che ha caratterizzato sin dal primo avvio i lavori della Costituente i pochi giuristi presenti hanno svolto un ruolo di supporto ― quando non di più o meno larvato
contrappunto politico–culturale ― rispetto al compito preminente di prospettare quali nuovi “rapporti” ― civili, etico–sociali,
economici e politici ― prevedere innestandoli nell’asse di Principi Fondamentali volti a collegare il valore del “lavoro”,
l’adempimento dei doveri inderogabili di “solidarietà politica,
economica e sociale” e il perseguimento della “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, come ambito complessivo in cui garantire l’eguaglianza sia sostanziale che formale, “rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale” da cui era ed è limitata di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini (artt. 1, 2, 3,). Precisamente, respinta la prassi tradizionale di ritagliare in ininfluenti
“preamboli", enfatici richiami a valori che si presuppongono avulsi dalla dialettica sociale e politica, i “costituenti” italiani
18
PARTE PRIMA
hanno introdotto come “norme” coperte dalla garanzia della “rigidità” ― nel duplice e convergente senso di rinforzare
l’impegno ad attuarle, nonché di proteggerle da tentativi di alterazione o manomissione ad opera di improvvisate maggioranze
― principi di apertura a una nuova società e a un nuovo stato
innervati sul ruolo politico–istituzionale dei partiti e dei sindacati, riconosciuti come la forma organizzativa eminente nella regolazione dei rapporti politici (art. 49) e dei rapporti economici
(art. 39): ciò per approntare le linee di una elaborazione della
“politica nazionale” con scelte “programmatorie” generali da indirizzare e coordinare a “fini sociali” (art. 41), assumendole come sintesi dell’intreccio tra le esigenze politiche, economiche e
sociali coinvolte dalla dialettica tra società e stato nella Repubblica democratica fondata sul parlamento e sulle autonomie (art.
5). In tal guisa adottando per la prima volta nella storia delle costituzioni europee un meccanismo normativo inteso a trasporre
nella Costituzione, sulla base dei suoi Principi Fondamentali
connessi anzitutto alla Prima Parte sui “diritti e doveri dei cittadini”, la progettualità che è insita nella trama dell’ispirazione
antifascista delle formazioni politiche e sociali animatrici con la
Resistenza del potere costituente quale potere “sostanziale” prima che “formale”.
Va tenuto allora ben presente, per capire come si è passati
negli ultimi trenta anni alla politica delle “riforme istituzionali”, che la linea teorica della cultura borghese coonestata
dall’ideologia giuridica tuttora prevalente, è stata costantemente incentrata sull’identificazione dello stato con la sua forma di
governo, storicamente legata alla monarchia (ma anche alla repubblica, specie con l’emblematica versione “presidenzialista”
nordamericana), sì che l’operazione culturale delle forze antifasciste si è tradotta nell’invertire la sequenza tra le norme sui
rapporti sociali e le norme sull’organizzazione dello stato dando preminenza alla “forma di stato” di democrazia sociale, ciò
che risulta nel modo più esemplare dal confronto della costituzione italiana del 1948 con quella di Weimar del 1919, che
ha mantenuto in posizione secondaria e discendente le norme
Dal modello “liberale” al modello “democratico”
19
relative ai diritti e ai doveri con l’aggravante di averle modificate inserendo bensì quelle norme sul lavoro e la solidarietà
sociale che le costituzioni liberali ignoravano, purché risultasse confermata anche dalla cultura socialdemocratica il primato della “sovranità dello stato” come somma di poteri autoritari, sulle esigenze di una società invano appellantesi alla “sovranità popolare”.
E a riprova del contributo regressivo prevalente in quei costituenti volti con l’ideologia giuridica a recepire canonizzandoli i
principi conservatori dell’assetto di potere capitalistico, in senso
contrario all’accordo (tramite Dossetti, Togliatti e Basso) tra Dc,
Pci e Psiup per l’elaborazione delle norme sul controllo sociale e
politico del sistema produttivo, si è posto in luce a fianco dei liberali (Einaudi) quell’esponente tanto emblematico del ruolo del
partito d’azione ― il giurista Piero Calamandrei, assurto a miglior notorietà per le posizioni assunte (negli anni ’50) nella lotta al centrismo e al ruolo egemone della Dc ― il quale cercò di
contrastare l’accettabilità dell’orientamento prevalso per fare
degli indirizzi programmatori l’asse del primato della “socialità
sull’economicità”, ricorrendo ad un argomento conservatore
fondato sulla tradizione: come se si potesse scientificamente sostenere che non sono addirittura “norme giuridiche” solo perché
di nuovo tipo quelle contenute nella sezione sui “rapporti economici” (artt. 39–47) in quanto non provviste delle “sanzioni”
che, secondo una visione del diritto riduttivamente formalistica
(oltretutto non prevalente nella stessa scienza giuridica tradizionale), caratterizzano i dispositivi delle leggi ordinarie con cui si
disciplina essenzialmente nei codici anche l’attività delle imprese, sì quindi da presupporre come intangibile quella continuità
nella regolazione dell’economia liberale e corporativa che le
forze antifasciste si erano proposte di rompere, non confondendo
i “diritti” di libertà delle persone (cittadini e lavoratori) con il
“potere” di autonomia delle imprese (finanziaria, industriale, agraria).
In tale discussione, che valse solo a sostituire con la parola
“programmi” la parola “piani” che sembrava evocare meccanici-
20
PARTE PRIMA
sticamente l’espressione in uso nel sistema socialista sovietico
(quando, peraltro, nel diritto borghese si chiama “pianificazione” la disciplina territoriale in cui si colloca l’urbanistica nella
regolazione della proprietà privata), trovò netta evidenza
l’inconfondibilità della costituzione italiana del 1948 con la costituzione socialdemocratica di Weimar che è bensì meritevole
di distinzione dalle altre costituzioni successive alla fine della
prima guerra mondiale, ma che emanata (1919) a poca distanza
dalla prima costituzione sovietica (1918) se ne distaccava nel
punto più decisivo concernente la disciplina della produzione, e
cioè la forma di stato prima che la forma di governo.
E infatti, nel momento stesso in cui innovava alle altre costituzioni europee di impianto liberale introducendo norme sul lavoro e sulla sicurezza sociale che sono state assunte come emblema della categoria del cosiddetto “stato sociale” oggi vagheggiato dalla sinistra riformista come variante dello “stato di
diritto”, ci si è limitati però a sollevare problemi di tollerabilità
della spesa pubblica da parte dello stato capitalistico senza affrontare i problemi economico–sociali pregiudiziali all’attuazione di quella categoria dei diritti “etico–sociali” che lo stato
sociale tanto più oggi dovrebbe garantire: estraniando cioè dai
diritti sociali quei diritti collettivi che implicano il controllo del
mercato e quindi del sistema degli scambi e dei prezzi, dando
soggettività generale alla classe operaia ai fini della disciplina
della produzione dei beni di consumo oltre che dei servizi pubblici, non essendo sufficiente al riguardo ― appunto, senza programmazione globale e democratica ― la previsione delle nazionalizzazioni, e della creazione di società azionarie a partecipazione pubblica (le c.d. “società miste”) nonché della cooperazione, per mutare di segno la logica del mercato capitalistico.
Come dimostra l’esempio del fascismo con le forme di intervento pubblico nell’economia da esso introdotte.
Punto focale della strategia della “democrazia progressiva”
― volta a far tesoro anche dei limiti della pur emblematica via
weimariana indicata come apertura della “terza via” (rivendicata
del resto anche dal corporativismo fascista) ― è stato quello di
Dal modello “liberale” al modello “democratico”
21
un pluralismo così articolato da perseguire non solo il pluralismo sociale, economico e politico nella prospettiva di emancipazione generale della società con la partecipazione “effettiva”
dei lavoratori all’organizzazione della Repubblica, ma anche
quello connesso alla complessità del mercato e alla segmentazione della borghesia produttiva nelle forme della piccola, media
e grande impresa (nell’art. 47 si parla dell’investimento azionario nei “grandi complessi produttivi del paese”), dando evidenza
al ruolo dei lavoratori e di quella cooperazione di cui si è rimarcata la mutualità “senza fini di speculazione privata” (art. 45):
così come a proposito di attività economica “pubblica” (art. 41)
si è mirato a riqualificare quell’istituto delle partecipazioni statali, “irizzato” dal fascismo per finalità di sostegno del meccanismo “privato” di accumulazione, e che nella cultura dei cattolici
viene solo considerato come ambito della esperienza “pilota” di
un uso “sociale” delle società per azioni inquadrate in “holdings” pubbliche.
Quel che di essenziale il misconoscimento del fondamento
giuridico dell’uso sociale della proprietà privata implicava, risiede nella svalutazione che tramite una concezione del diritto e
dello stato sconnessa dal rapporto con la realtà contemporanea il
giurista del partito d’azione operava di quel problema teorico affrontato secolarmente dalla filosofia politica, e riguardante la relazione tra la libertà e l’eguaglianza, ovvero tra la libertà “negativa” come diritto garantito di agire in termini non impediti da
norme vincolanti (nelle forme della libertà personale, di pensiero, di associazione), e la libertà “positiva” come diritto garantito
di dare “concretezza” alle possibilità “astratte” di passare dalle
libertà “civili e politiche” alle “libertà sociali” indispensabili alla
dignità della persona e al libero sviluppo, facendo cioè entrare in
campo l’esigenza di “giustizia” per l’eguaglianza non solo formale ma anche sostanziale.
Si è scelto perciò di lasciare alle spalle il costituzionalismo
liberale che, mentre garantisce le libertà civili e politiche e in
generale i diritti “umani” reprimendo con sanzioni, cioè con interventi “coattivi”, le violazioni di tali diritti, è del tutto contra-
22
PARTE PRIMA
rio a riconoscere la limitabilità delle libertà economiche a favore
degli interessi sociali che sostanziano l’esigenza della libertà positiva, non come mera “declaratoria” ma come attuabilità concreta di una “modifica” dei rapporti sociali tra i soggetti appartenenti alle componenti ― rispettivamente, “forti” e “deboli” ―
della società, nei termini sinteticamente riassunti nell’antitesi
capitale/lavoro, facendo quindi intervenire i pubblici poteri con
l’uso di un nuovo tipo di leggi, volte cioè a supportare i compiti
di “direzione sociale” tramite vincoli non identificabili con le
sanzioni negative (con conseguenti pene e risarcimenti del danno tipiche forme della tutela dei diritti violati sulla base dei codici penale e civile), perché rivolte a perseguire finalità regolative e distributive in modo diretto (programmazione economica),
prima e più che indiretto (sicurezza sociale).
E infatti la cura messa dalla cultura marxista nel sottolineare
la differenza tra una costituzione “socialista” e una costituzione
(democratico–sociale) di transizione ― sul presupposto che lo
“stato sociale” canonizzato nella costituzione di Weimar coinvolgeva solo diritti sociali compatibili con l’intangibililtà del
meccanismo di accumulazione privata, pur introducendo per la
prima volta un richiamo ai principi di “solidarietà sociale” a
fianco dell’elenco dei diritti fondamentali ― ha avuto l’obiettivo di evidenziare quale processo di democratizzazione la “costituzione–programma” avesse il compito di avviare per conseguire finalità che la costituzione sovietica del 1936 dal canto su aveva sancito come raggiunti, per nuovi sviluppi da garantire
nel segno dell’abolizione della proprietà privata con la proprietà collettiva: il che ha concorso a evidenziare la specificità della novità di cui, oggi, quasi tutti i costituzionalisti compresi quelli “democratici”, hanno diluito e quindi svilito i
fondamenti parlano genericamente, contro la politica del centro–destra e nel segno del “bipolarismo”, di “stato costituzionale” e di “democrazia costituzionale”, termini qualificatori
che nella cultura politica democratica e nella stessa cultura
giuridica dominante negli anni ’45–90 erano addirittura desueti o assenti.