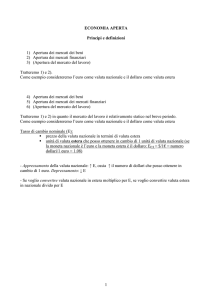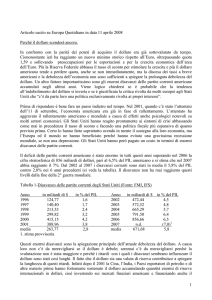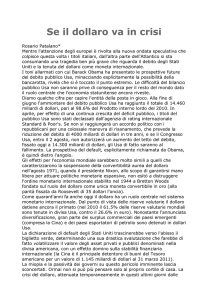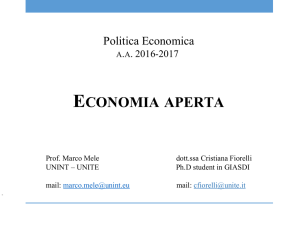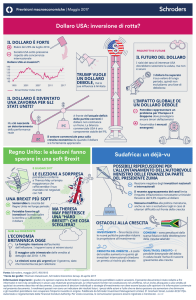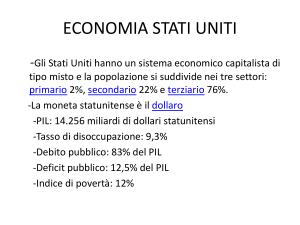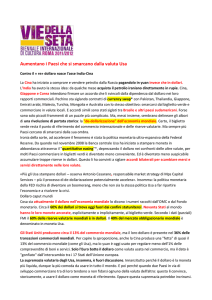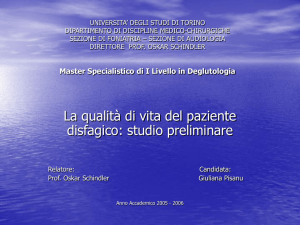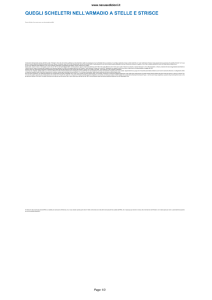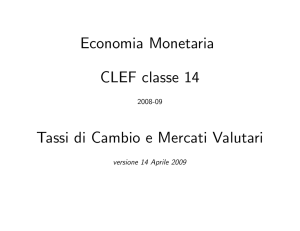L’Europa che non c’è
Stampa
Vladimiro Giacché
1 2 >>
L’Europa che vogliamo è facile a descriversi: è un’Europa giusta, democratica, unita, indipendente,
e - ovviamente - pacifica. Purtroppo, volere un’Europa con queste caratteristiche significa volere
un’Europa piuttosto diversa da com’è oggi. Diciamo pure: significa volere un’Europa che non c’è.
In effetti, è difficile definire “giusta” un’Europa nella quale le differenze nel reddito tra le diverse
classi sociali crescono anziché diminuire ed in cui la precarizzazione dei rapporti di lavoro avanza
pressoché ovunque. [1] Quanto alla “democrazia”, basterà ricordare che la cosiddetta “Costituzione
europea” non è nata da una Costituente eletta direttamente dalle popolazioni dell’Europa, e
tantomeno da un dibattito che abbia coinvolto i cittadini di questa “costituenda” Europa.
Anche l’”unità” europea non è oggi molto più che un’ideale - a parte la moneta unica: che è certo
di grande importanza, ma non è davvero sinonimo di un’unità europea in senso pieno (e del resto
non è adottata ufficialmente neppure da tutti i Paesi dell’Unione Europea).
Anche sull’”indipendenza” dell’Europa si potrebbe a lungo discutere: certo è che alla sovranità
monetaria (ormai pienamente acquisita) non fanno riscontro né una politica economica, né una
politica estera comuni - ed è ben difficile parlare di “indipendenza” laddove non vi sia neppure
un’uniformità di indirizzi in questi campi.
Quanto al fatto di vivere in un’Europa “pacifica”, pensando all’Irak ne siamo più o meno tutti
convinti: e certamente è un fatto che l’Unione Europea in quanto tale non ha dichiarato guerra a
nessuno. A dire il vero, non potrebbe neppure farlo, stante l’assenza di una politica estera e di difesa
comune; ma questo non dovrebbe rassicurarci: infatti - proprio a motivo di questa assenza - ben 10
tra i 25 Paesi dell’Unione Europea hanno inviato truppe in Irak - e di conseguenza non soltanto
hanno preso parte ad una guerra, ma ad una guerra intrapresa senza e contro il parere dell’Onu, e
quindi illegale secondo i principi della legalità internazionale. [2]
Insomma: per affermare i princìpi indicati all’inizio, si può dire - volendo essere eufemistici - che
c’è ancora molto da lavorare. E qui dobbiamo tenere a mente due cose. La prima è che sarebbe
illusorio pensare di potere conseguire quegli obiettivi al di fuori dell’Europa: in altri termini, quelle
5 sfide per noi oggi non possono giocarsi che sul terreno dell’Unione Europea (vedremo meglio più
avanti cosa questo significhi in concreto). La seconda cosa è che in Europa o quegli obiettivi si
conseguono tutti assieme, o non si conseguono affatto. Senza giustizia sociale avremo un’Europa
sempre più divisa al suo interno, sia in termini sociali che territoriali. E in occasione del grande
movimento per la pace del febbraio 2003 si è visto che il deficit di democrazia che affligge
l’Europa (emblematicamente raffigurato dalla partecipazione di dieci Stati europei alla guerra,
nonostante l’opinione pubblica europea fosse ovunque in maggioranza contraria) si è rivelato un
forte limite anche per una politica indipendente dell’Europa in quanto tale.
Resta il fatto che oggi, su tutti i princìpi citati, registriamo una situazione tutt’altro che
incoraggiante. In questo l’Europa è vittima di se stessa. In due sensi: è vittima del suo successo, del
successo della costruzione europea, ed è vittima di alcuni vizi di fondo, cioè di alcuni limiti
connaturati al processo di costruzione europea come si è svolto storicamente e fino ad oggi (più
precisamente: così come esso è stato voluto e condotto dalle élite europee). Vediamo perché,
cominciando dai successi dell’Europa.
1. L’euro: un successo... catastrofico?
Il vero, grande successo dell’Europa è l’euro. Per Robert Alexander Mundell, premio Nobel per
l’economia nel 1999, l’euro è stato “un successo eccezionale”, “il miglior lancio di una valuta in
tutta la storia delle monete su scala mondiale”. [i] Mundell ha ragione. Lo dimostra il fatto che,
dalla sua introduzione, il peso dell’euro a livello internazionale cresce: è sempre maggiore il
volume degli strumenti finanziari denominati in euro e delle transazioni commerciali effettuate in
questa valuta; inoltre, aumenta il numero dei Paesi che hanno adottato l’euro o comunque lo
adoperano come valuta di riferimento; e cresce il peso relativo delle riserve in euro detenute dalla
banche centrali di tutto il mondo. A quest’ultimo proposito, il presidente della Commissione
Europea Prodi ha raccontato che già quattro anni fa le autorità di Pechino gli avevano assicurato che
avrebbero continuato “a comprare euro fino a quando non avremo nel futuro non vicino una uguale
quantità di euro e di dollari nelle nostre riserve”.
Quindi quando lo stesso Prodi afferma che l’euro è “uno strumento che ha evitato il monopolarismo
monetario”, dice la pura e semplice verità. [3] Una verità che da un anno a questa parte ritroviamo
anche nelle dichiarazioni degli operatori sui cambi: “sono impressionato dalla forza dell’euro. Una
cosa che trovo incoraggiante come trader è la crescente statura internazionale della valuta europea
che in molti casi ormai la pone come alternativa diretta al biglietto verde”. [4] Il fatto di
rappresentare un’alternativa al dollaro sarebbe ovviamente un fatto positivo per l’economia
europea: ad esempio, l’Unione Europea potrebbe cominciare ad attrarre capitali dal resto del mondo
- e si tratta di un processo che del resto è già in corso dal 2002, anno in cui l’afflusso netto di
capitali verso la zona euro è stato di 29,4 miliardi di euro (l’anno precedente ne erano usciti
63,4). [5]
Potrebbe però essere un successo catastrofico. E non per via delle “alte quotazioni” dell’euro
rispetto al dollaro. Queste quotazioni non sono particolarmente elevate, e tra l’altro presentano
vantaggi non indifferenti (come quello di ridurre gli effetti dell’aumento del petrolio, che viene
pagato in dollari). Tra l’altro, la quota maggiore del commercio estero dei Paesi europei è interna
alla zona euro, e quindi da questo punto di vista le quotazioni della moneta unica rispetto al dollaro
sono pressoché ininfluenti.
No. I rischi legati all’euro ed al suo successo vengono da un’altra parte: vengono dagli Stati Uniti.
Nella stessa intervista citata più sopra Romano Prodi ha fatto anche un’affermazione piuttosto
pesante: dopo aver detto che la moneta unica è un fatto “soprattutto politico”, ha spiegato che “non
a caso i maggiori scontri e le maggiori tensioni con gli Stati Uniti sono avvenuti dopo che è stato
creato l’euro”.
Sono affermazioni che possono sembrare eccessive e fuori luogo soltanto a chi non capisce che
l’euro rappresenta la più seria minaccia di sempre all’egemonia valutaria del dollaro. Tale
egemonia ha assunto la configurazione che perdura tuttora nel 1971, allorché Nixon decretò la fine
della convertibilità del dollaro in oro. Da allora il dollaro è divenuto una valuta puramente
fiduciaria, senza più l’ancoraggio al valore delle riserve in oro detenute dalla Federal Reserve.
Nonostante ciò, oltre il 50% del commercio mondiale avviene tuttora contro pagamento in dollari
(mentre la quota statunitense del commercio mondiale è appena del 25%), così come la maggior
parte delle riserve valutarie delle banche centrali è in dollari. È questa egemonia valutaria che
consente agli Stati Uniti di avere una bilancia commerciale con il resto del mondo cronicamente in
rosso senza che questo comporti le conseguenze che ogni altro Paese del mondo al suo posto
dovrebbe patire: svalutazioni, pagamento di cospicui interessi sui titoli di Stato, crisi finanziarie.
Il punto è proprio questo: se quella egemonia valutaria venisse meno, verrebbero meno questi
privilegi (il cosiddetto “signoraggio del dollaro”). A questo tipo di osservazioni in genere i difensori
della valuta statunitense rispondono che è “il mercato” a decidere il valore delle valute, e che
quindi, se le cose vanno avanti in questo modo da così tanto tempo, è perché evidentemente non
esiste una valuta in grado di rivaleggiare col dollaro. Verissimo - sino a poco tempo fa. Oggi però
quella valuta esiste, ed è la moneta unica europea: che tra l’altro (a differenza di quanto troppo
spesso si legge sui giornali anche economici) si riferisce ad un’economia che ha fondamentali più
solidi di quelli statunitensi, a cominciare da una bilancia commerciale in attivo.
Di qui le contromisure adottate dagli Stati Uniti. Tra cui la guerra all’Irak. Da questa guerra, infatti,
gli Stati Uniti si ripromettevano il conseguimento di questi obiettivi: controllare materie prime
strategiche; scongiurare la possibilità che il petrolio fosse venduto in euro (come aveva iniziato a
fare Saddam Hussein) anziché in dollari; controllare e/o destabilizzare di un’area come il Medio
Oriente, che rientra nella zona gravitazionale dell’euro ed è geograficamente limitrofa all’Unione
Europea; [6] garantire introiti per le multinazionali a base Usa (tanto nella ricerca, estrazione e
commercializzazione del petrolio, quanto nella ricostruzione del Paese e nella gestione delle sue
risorse privatizzate); rilanciare le spese militari, di grande importanza per l’economia
statunitense; [7] e, last but not least, operare una spaccatura politica dell’Europa: facendo leva sui
Paesi dell’Europa dell’Est appena entrati nell’Unione Europea, nonché sui fedelissimi Blair, Aznar
e Berlusconi.
Il raggiungimento di molti degli obiettivi di cui sopra sarà determinato dall’effettivo esito della
guerra in Irak, che allo stato non sembra dare troppe soddisfazioni a chi l’ha voluta. Altri obiettivi,
invece, sono stati comunque conseguiti. A cominciare dalla frattura politica in Europa. La cosa è
stata subito chiara. “L’Europa è la prima vittima della guerra”: così titolava il Financial Times il
12 marzo 2003; “Ue, prima vittima”: quasi con le stesse parole, il 31 gennaio era stato titolato
l’articolo di fondo del Sole 24 ore, scritto da Adriana Cerretelli; [8] più esplicito l’articolo scritto
negli stessi giorni da Lucio Caracciolo: “È guerra contro l’Europa” (l’espresso, 6/2/2003). Al di là
di questi commenti “a caldo”, una cosa è certa: far fallire il progetto di unità politica dell’Europa è
tuttora un obiettivo esplicito dei neoconservatori americani che attorniano Bush. Basti pensare che
nel settembre 2003 il settimanale “The Weekly Standard”, diretto dal neoconservatore William
Kristol, ha fatto del motto “Contro l’Europa unita” il suo titolo di copertina. [9] Un’Europa unita,
così argomenta Gerard Baker all’interno della rivista, sarebbe oltremodo pericolosa: “immaginate
un’Europa unita che persegua aggressivamente un’unica linea contro gli Usa alla Nato. O che
rovesci il suo peso economico in America Latina o in Africa”. Le contromisure consigliate sono
varie: si va dal rafforzamento dei legami politici e militari degli Usa con i Paesi dell’Est europeo
(appunto...), all’ostacolare i tentativi dell’Unione Europea di presentarsi come un unico soggetto in
organismi internazionali quali l’Onu, il G8, la Nato (la rappresentanza unica europea è invece già
una realtà all’Organizzazione Mondiale del Commercio); dall’impedire l’adozione dell’euro da
parte della Gran Bretagna al far leva sul malcontento dei cittadini europei per questo nuovo Stato
calato dall’alto. Dopo cotanti consigli, la conclusione dell’articolo è ottimistica: “non è troppo tardi:
gli Usa possono impedire che questo superstato diventi realtà”.
Probabilmente, qualche mese dopo la pubblicazione di questo articolo sul “Weekly Standard”, i
neoconservatori americani hanno pensato di avercela fatta. È stato quando, nel dicembre 2003, la
Conferenza intergovernativa che doveva ratificare il progetto di Convenzione europea è fallita. Qui
è bene essere chiari: si è trattato di un fallimento voluto - e non del frutto dell’insipienza
berlusconiana. Curiosamente (ma non troppo) l’analisi più lucida in proposito si è potuta leggere sul
giornale della Confindustria - mentre le testate di sinistra si trastullavano con la presunta
“incapacità” di Berlusconi.
Ecco qualche passo dell’articolo che Piero Ignazi dedicò alla vicenda: “La crisi esplosa alla
Conferenza intergovernativa parte da lontano, dal mutato assetto internazionale del dopo guerra
fredda. Fino ad allora, Europa e Stati Uniti, al di là delle bizze [sic!] golliste, avevano sempre
marciato assieme. Il comune nemico attestato sulle sponde dell’Elba cementava l’alleanza atlantica.
(...) Scomparso il pericolo comune sovietico e, allo stesso tempo, approfondita la dimensione
integrativa dell’Unione con la nascita dell’euro e lo sviluppo dei due ‘pilastri’ (sicurezza interna ed
esterna), l’Europa è diventata, per forza di cose, non solo un partner degli Stati Uniti, ma anche un
concorrente. (...) Oggi l’Ue è atttraversata da una nuova linea di frattura, definita dalla relazione con
gli Stati Uniti”. E l’articolo proseguiva, venendo alle vicende della Conferenza intergovernativa:
“Proprio perché si stanno disegnando nuove alleanze e nuove gerarchie nello scacchiere mondiale,
Spagna e Polonia, capifila dei filo-americani ad oltranza, hanno avuto la forza di opporsi agli altri
23 paesi. (...) La conduzione dei lavori dimostra come il governo italiano avesse preventivato anche
un esito negativo, non necessariamente ‘sotto-ordinato’ rispetto a quello ufficiale. Al punto da far
pensare che l’obiettivo primario di Berlusconi non fosse la firma della convenzione ma il
mantenimento/rafforzamento di buoni rapporti con gli alleati della cordata pro-americana, anche a
costo di far fallire la trattativa”. [10]
Questa era quindi la situazione a fine dicembre 2003: la Costituzione europea non ratificata, e la
prospettiva di un lungo stallo istituzionale (prospettiva che sarebbe poi stata messa in discussione
dalla sconfitta di Aznar in Spagna, nel marzo successivo). Una gioia per i neoconservatori
americani, e un vero guaio per chi propugnava l’unità europea.
Che la mancata ratifica del dicembre 2003 abbia rappresentato un gradito regalo per gli Usa e per i
loro ascari europei, è un fatto. È altrettanto vero, però, che i limiti del progetto di Costituzione non
erano (e non sono) né pochi, né di poco conto. Questo aspetto è di grande importanza, perché dalla
sua comprensione dipende in misura non piccola la possibilità di perseguire con efficacia la
costruzione dell’Europa che vorremmo - e che oggi, come abbiamo visto, non c’è.
1 2 >>
[1] Vedi R. Martufi, L. Vasapollo, “Povero atipico... tipicamente povero”, in Proteo, n. 1/2004, pp.
3-19.
[2] Questi Paesi sono: Danimarca, Italia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Lituania, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria. Non si tratta quindi soltanto dei Paesi della “nuova
Europa” cari a Rumsfeld: i primi 5 di essi infatti fanno parte dell’Europa a 15.
[i] “Una scommessa vinta dall’Europa”, intervista a R.A. Mundell, il Sole 24 Ore, 2 gennaio 2003.
[3] Le due affermazioni sono tratte da un’intervista contenuta nel libro Europa al bivio di Piero
Badaloni (Portalupi Editore, 2004).
[4] B. Tamiso, “L’euro scavalca anche lo yen. La corsa potrebbe continuare”, Borsa & Finanza,
26 aprile 2003. Va notato che queste dichiarazione sono state rilasciate prima che l’euro toccasse i
massimi sul dollaro.
[5] Dati resi noti dalla Banca Centrale Europea il 24 febbraio 2003.
[6] Nel 2001 M. Sturm, un ricercatore della Banca Centrale Europea, osservava: i Paesi del Medio
Oriente e del Nord Africa sono tra i Paesi “nei quali probabilmente il ruolo internazionale
dell’euro crescerà più rapidamente ed estesamente. Già oggi l’euro gioca in molti di questi Paesi un
ruolo preminente per la determinazione dei tassi di cambio come riserva in valuta straniera”; per
questo motivo “l’Europa sarebbe maggiormente colpita da crisi politiche ed economiche in Medio
Oriente di quanto lo sarebbero, per esempio, gli USA” (“The Middle East and Northern Africa as
Part of the ‘Euro Time Zone’”, EUI Working Paper, Badia Fiesolana, novembre 2001, pp. 5 sgg.).
[7] Un’esame più dettagliato dei motivi della guerra all’Irak è contenuto in alcuni miei articoli:
“Irak: una guerra e i suoi perché”, la Contraddizione, n. 93, 6/2002; “La debolezza della forza.
L’imperialismo americano e i suoi problemi”, ne Il piano inclinato del capitale, a cura di L.
Vasapollo, Milano, Jaca Book, 2003, pp. 167-190.
[8] Anche se la Cerretelli, curiosamente, addebitava la cosa al “pacifismo franco-tedesco” [sic!].
[9] R. Menichini, “Usa, il manifesto anti Ue: ‘Fermiamo il Superstato’”, la Repubblica, 19
settembre 2003.
[10] P. Ignazi, “Nascono oltre l’Atlantico le divisioni esplose alla Cig”, il Sole 24 ore, 17 dicembre
2003.