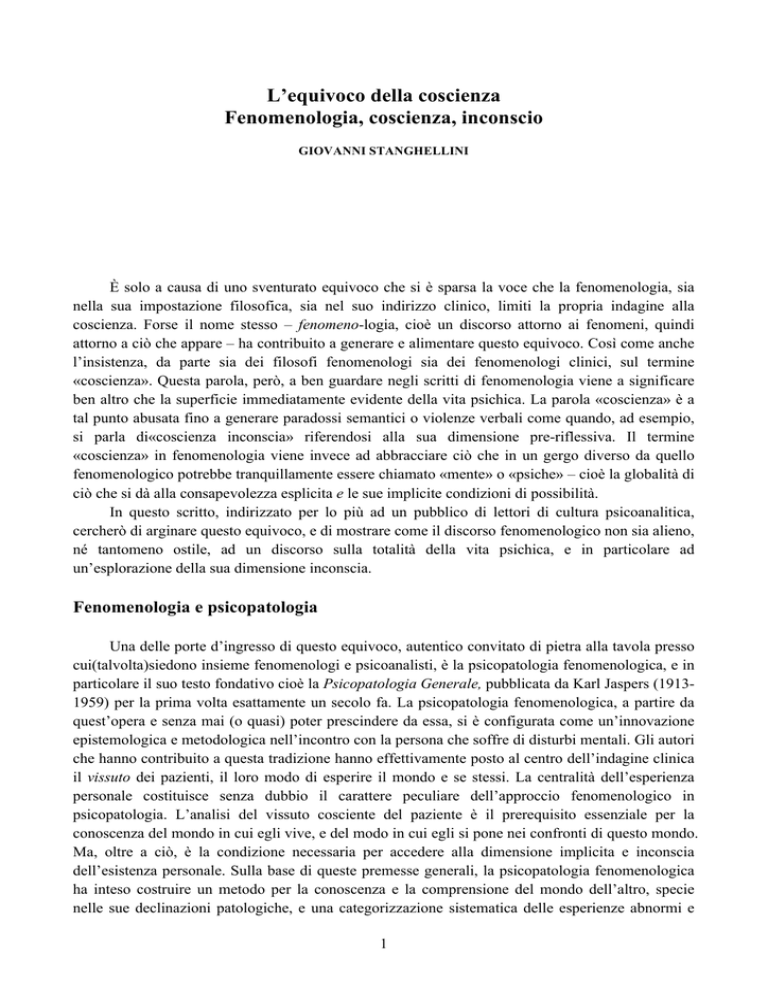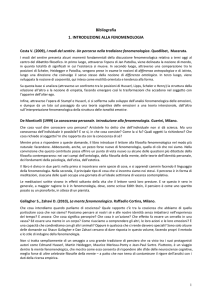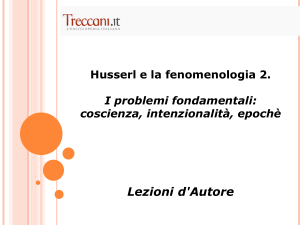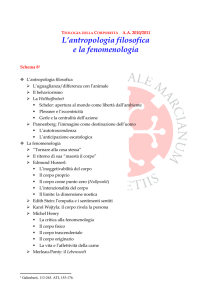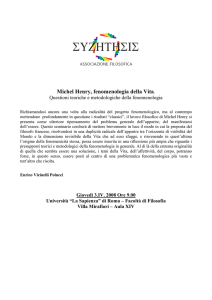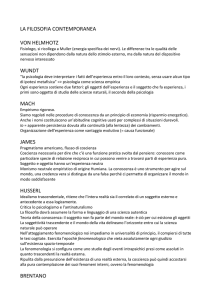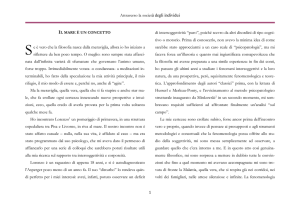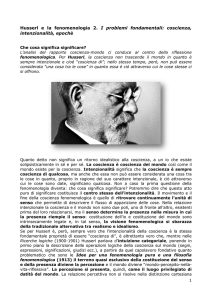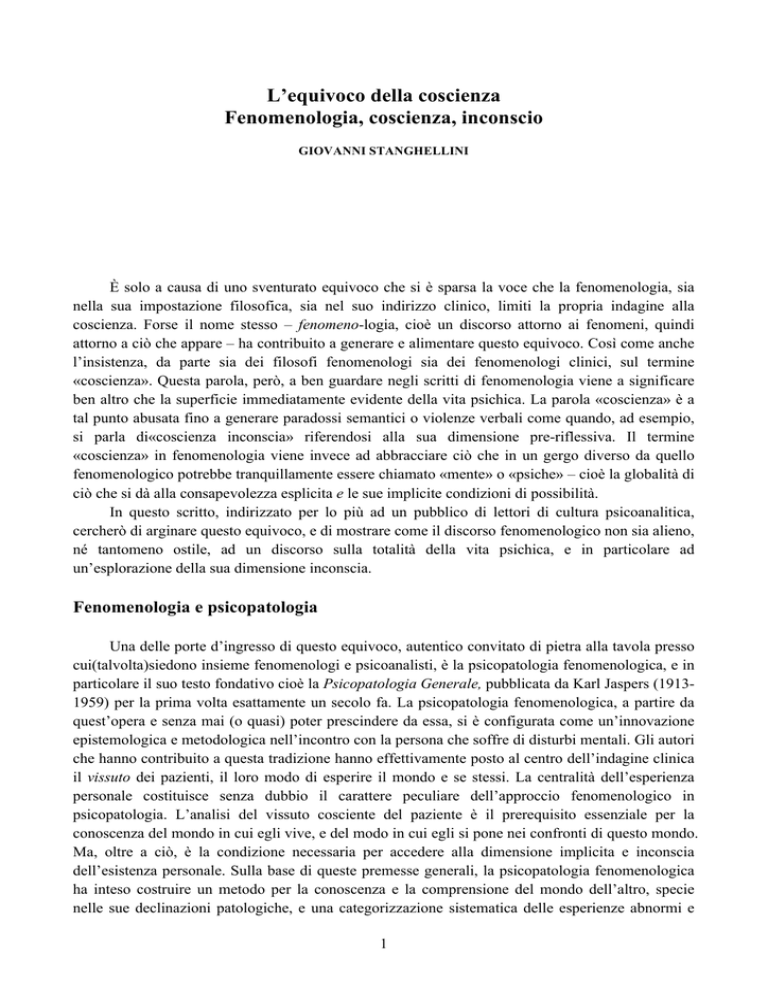
L’equivoco della coscienza
Fenomenologia, coscienza, inconscio
GIOVANNI STANGHELLINI
È solo a causa di uno sventurato equivoco che si è sparsa la voce che la fenomenologia, sia
nella sua impostazione filosofica, sia nel suo indirizzo clinico, limiti la propria indagine alla
coscienza. Forse il nome stesso – fenomeno-logia, cioè un discorso attorno ai fenomeni, quindi
attorno a ciò che appare – ha contribuito a generare e alimentare questo equivoco. Così come anche
l’insistenza, da parte sia dei filosofi fenomenologi sia dei fenomenologi clinici, sul termine
«coscienza». Questa parola, però, a ben guardare negli scritti di fenomenologia viene a significare
ben altro che la superficie immediatamente evidente della vita psichica. La parola «coscienza» è a
tal punto abusata fino a generare paradossi semantici o violenze verbali come quando, ad esempio,
si parla di«coscienza inconscia» riferendosi alla sua dimensione pre-riflessiva. Il termine
«coscienza» in fenomenologia viene invece ad abbracciare ciò che in un gergo diverso da quello
fenomenologico potrebbe tranquillamente essere chiamato «mente» o «psiche» – cioè la globalità di
ciò che si dà alla consapevolezza esplicita e le sue implicite condizioni di possibilità.
In questo scritto, indirizzato per lo più ad un pubblico di lettori di cultura psicoanalitica,
cercherò di arginare questo equivoco, e di mostrare come il discorso fenomenologico non sia alieno,
né tantomeno ostile, ad un discorso sulla totalità della vita psichica, e in particolare ad
un’esplorazione della sua dimensione inconscia.
Fenomenologia e psicopatologia
Una delle porte d’ingresso di questo equivoco, autentico convitato di pietra alla tavola presso
cui(talvolta)siedono insieme fenomenologi e psicoanalisti, è la psicopatologia fenomenologica, e in
particolare il suo testo fondativo cioè la Psicopatologia Generale, pubblicata da Karl Jaspers (19131959) per la prima volta esattamente un secolo fa. La psicopatologia fenomenologica, a partire da
quest’opera e senza mai (o quasi) poter prescindere da essa, si è configurata come un’innovazione
epistemologica e metodologica nell’incontro con la persona che soffre di disturbi mentali. Gli autori
che hanno contribuito a questa tradizione hanno effettivamente posto al centro dell’indagine clinica
il vissuto dei pazienti, il loro modo di esperire il mondo e se stessi. La centralità dell’esperienza
personale costituisce senza dubbio il carattere peculiare dell’approccio fenomenologico in
psicopatologia. L’analisi del vissuto cosciente del paziente è il prerequisito essenziale per la
conoscenza del mondo in cui egli vive, e del modo in cui egli si pone nei confronti di questo mondo.
Ma, oltre a ciò, è la condizione necessaria per accedere alla dimensione implicita e inconscia
dell’esistenza personale. Sulla base di queste premesse generali, la psicopatologia fenomenologica
ha inteso costruire un metodo per la conoscenza e la comprensione del mondo dell’altro, specie
nelle sue declinazioni patologiche, e una categorizzazione sistematica delle esperienze abnormi e
1
dei modi in cui si configurano come forme di esistenza mancata. Ciò che a noi interessa, in questa
sede, è principalmente il versante metodologico.
Sul versante metodologico, la psicopatologia fenomenologica insegna che la patologia
mentale non deve essere osservata dall’esterno come se fosse un mero epifenomeno di meccanismi
subpersonali, ma deve essere interrogata come l’indice semantico del percorso esistenziale di una
persona. La psicopatologia fenomenologica nasce in contrapposizione al mito positivista di una
psichiatria organicista, che riduce l’incontro con il malato a una mera descrizione dei sintomi, per
poi raggrupparli in entità nosografiche che richiamano le classificazioni botaniche, e da qui
procedere ad una terapia che ha come fine la potatura dei sintomi, in analogia al lavoro di un
diligente giardiniere. A tale proposito «il fatto che le malattie mentali siano fondamentalmente
umane ci obbliga – come osserva Jaspers – a non vederle come un fenomeno naturale generale, ma
come un fenomeno specificamente umano».
In tale cornice epistemologica viene privilegiato un vertice di osservazione che intende quindi
superare i limiti di ogni tipo di riduzionismo (non solo quello biologico), aprendo nella malattia
mentale un orizzonte di senso in grado di illuminarci sul nesso tra ciò che è umano e ciò che è
malato. In tal senso la psicopatologia fenomenologica va intesa come una «psicologia del
patologico», dove l’obiettivo centrale della clinica si traduce in un percorso esplorativo sulle
condizioni di possibilità dell’esperienza umana e delle sue declinazioni psicopatologiche. I disturbi
mentali vengono cioè studiati non in quanto deviazioni dalla norma o alterazioni del buon
funzionamento, ma in quanto espressioni (fenomeni) che consentono di risalire alla trama fondativa
dell’esperienza umana. In questa ricerca delle condizioni di possibilità della patologia mentale, e al
di là di questa della trama fondativa dell’esistenza umana, entrambe poste ben oltre i limiti abituali
di quanto si dà immediatamente alla coscienza, si può cominciare a rintracciare la specifica
dimensione fenomenologica dell’inconscio. La psicopatologia fenomenologica si è posta, inoltre, in
maniera radicale il problema di come, ed entro quali limiti, sia possibile accedere ai vissuti
dell’altro, comprenderne il senso, e ricostruire le strutture portanti dei mondi entro i quali tali vissuti
sono situati. Questo processo di conoscenza è consapevole di quanto i pregiudizi, cioè le categorie
(in particolare, quelle nosografiche, etiche, filosofiche ecc.) entrino in gioco nella genesi della
propria visione dell’altro e ne ostacolino una piena comprensione.
Fin dai suoi albori, la psicopatologia fenomenologica si è scagliata in specie contro i
pregiudizi metapsicologici, cioè contro una chiave di lettura della mente dell’altro, e dell’altro
sofferente in particolare, che si è supposto venga applicata in maniera automatica, stereotipa,
acritica, cortocircuitando il piano del vissuto cosciente del paziente. Si è ritenuto, da parte dei
fenomenologi clinici (e non sempre a torto)che gli aderenti al pensiero psicoanalitico concepissero
ciò che si dà nella coscienza del paziente un’ingannevole facciata, una razionalizzazione di ben più
profonde e autentiche verità, e pertanto una cortina fumogena tra il clinico e l’inconscio del
paziente. Questa aspra critica della metapsicologia psicoanalitica (e delle sue sventurate attuazioni)
ha avuto numerosi e ben noti obiettivi: tra questi, il suo (presunto) meccanicismo, la sua concezione
dell’uomo centrata sul primato delle pulsioni e quindi della sua (presunta) negazione della libertà
umana, il suo scetticismo (se non addirittura sarcastico dileggio) verso la superficie della coscienza.
Senza dubbio, queste sono state tra le ragioni che hanno radicalizzato, nei decenni passati, lo
scontro tra fenomenologi clinici e psicoanalisti. Al centro di questa contesa si sono poste, dunque,
questioni metodologiche – cosa è importante analizzare (i fenomeni della coscienza o l’inconscio),
quali vie prendere (ad es., i vissuti o i sogni) e quali strumenti adottare (ad esempio, la conoscenza
in prima persona, ovvero l’empatia, oppure l’interpretazione).
2
Ragioni meno nobili, ma non meno cogenti, sono state i conflitti di potere e il bisogno di
affermare la propria identità. Ma di questo non intendo parlare in questa sede, se non per dire che
solo le identità deboli sentono la necessità di erigere steccati ideologici, rivendicare primogeniture,
scagliare anatemi, come accade nelle guerre di religione – e per quanto riguarda la mia conoscenza
diretta del mondo fenomenologico di questo tipo di debolezza ne ho trovata una certa quantità.
L’antropologia psicoanalitica e quella fenomenologica
Che non sia proprio il caso di fare guerre di religione lo dimostra l’analogia tra l’antropologia
di marca psicoanalitica(che ha le sue principali radici nella clinica) e quella di matrice
fenomenologica(che ha le sue radici nella biologia e nell’antropologia scientifica, oltre che nella
riflessione speculativa). Per entrambe, la condizione umana è segnata dal medesimo dispositivo: il
conflitto. In quanto fenomeno clinico, il conflitto è stato consacrato dalla psicoanalisi quale snodo
patogenetico fondamentale nel percorso psicopatologico (in specie quello nevrotico) e punto di
repere irrinunciabile nel processo diagnostico e terapeutico. Esso rappresenta la contrapposizione
tra istanze o esigenze contrastanti. Per la clinica di matrice dinamica, questo contrasto è l’epicentro
della genesi dei sintomi.
A partire da questa ontologia del conflitto, o della disunione, su cui convergono sia la
psicoanalisi, sia l’antropologia fenomenologica, le differenze nella concezione dell’uomo sono
forse più sfumate di quanto non si voglia. La loro matrice comune può essere rintracciata nel
pensiero di Nietzsche (1872), il quale, ne La Nascita della tragedia, individua due istanze
fondamentali e in contrasto tra loro: l’apollineo e il dionisiaco. Apollo è il dio della scultura e il suo
mondo è determinato dal principio di individuazione, dalla forma, dalla misura; Dioniso è il dio
della musica e il suo impulso conduce viceversa all’eccesso. Dal contrasto tra questi due principio
nasce la tragedia greca, assunta come paradigma universale dell’esistenza umana.
L’esistenza umana è concepita a partire dalla constatazione della doppia appartenenza
dell’uomo, sospeso e in tensione tra natura e cultura, tra pulsioni vitali e civiltà, tra sensibilità e
ragione, tra logos e pathos, tra bisogno di socialità e di separatezza, tra aspirazione all’appartenenza
e all’individualità, e tra rappresentazioni della propria identità diverse e divergenti. Il conflitto viene
assunto come fenomeno ubiquitario nell’esistenza umana, non solo di quella patologica; forse
addirittura la cifra della humana condicio, della nostra duplice natura e doppia appartenenza. Credo
sia difficile per chiunque pensare all’esistenza umana scevra da questo conflitto che tiene in
tensione infere istanze bestiali e la «crosta sottile della civiltà».
I principali artefici dell’antropologia di ispirazione fenomenologica, e tra questi Scheler,
Plessner, Gehlen, Jaspers e Ricouer, continuano (sebbene in modi originali e diversi) a porre come
problema centrale il rapporto della doppia appartenenza dell’uomo alla dimensione naturale e a
quella culturale, che mette l’uomo in conflitto con sé stesso. Scheler (1928), che può essere preso ad
esempio, caratterizza l’essere dell’uomo come la possibilità di «dire no», di «protestare» contro
l’elemento vitale, e cioè di sublimare le proprie pulsioni. Quest’atto di negazione e di sublimazione,
argomenta Scheler, si compie a partire da un elemento diverso rispetto all’elemento vitale che
l’uomo condivide con gli altri animali: questo elemento è lo Spirito, ciò che caratterizza l’uomo in
quanto «persona». Lo spirito (Geist) è in sé stesso impotente e la pulsione (Drang) è in sé stessa
cieca. Lo spirito, incapace di realizzarsi con i propri mezzi, deve utilizzare le energie che
provengono dalle pulsioni. Spirito e pulsione, per quanto in conflitto, non sono semplicemente
3
contrapposti, ma interdipendenti: lo spirito dà forma alla vita, ma soltanto grazie a quest’ultima il
primo è reso potente ed efficace.
Una tesi non molto diversa è sviluppata da Ricoeur (1950). L’essenza conflittuale
dell’esistenza umana è radicata nel principio del disordine e della indeterminazione dell’esistenza
corporea, nella incoerenza dei valori sociali, e nel contrasto tra queste due sfere dell’involontario
che si collocano o si instillano al cuore dell’umano. Tra questa eterarchia di strati conflittuali
primordiali dell’esistenza e la sfera del volontario si instaura un rapporto non di opposizione, ma
chiasmatico e di interpenetrazione.
Queste, mi pare, le analogie tra la visione di ispirazione psicoanalitica dell’uomo e quella
fenomenologica. Oltre all’analogia, è forse necessario rimarcare anche una differenza. Laddove la
clinica psicoanalitica fa del conflitto la matrice patogenetica dei sintomi (in particolare di quelli
nevrotici), la clinica fenomenologica ne fa il dispositivo-chiave per leggere la patomorfosi dei
sintomi, delle sindromi e dei decorsi psicopatologici. Questa seconda idea si affaccia sulla scena
della psicopatologia ai primi dell’Ottocento a opera del medico-filosofo Philippe Pinel (1800). I
cardini della sua teoria della malattia mentale sono così riassumibili. Principio nosodromico:
esistono per Pinel gradienti di follia nelle varie forme dell’alienazione mentale; a seconda della
proporzione tra salute e malattia la persona transita (per questo si parla di noso-dromia) da un
quadro a un altro della patologia mentale. Principio della parzialità della follia: nessun folle è
completamente tale, resta sempre in piedi una parte della persona non invasa dalla follia, capace di
rappresentare una parte osservante del sé che fronteggia la propria patologia. Principio patoplastico:
i quadri morbosi sono l’immagine che il conio antropologico imprime sul metallo della vulnerabilità.
La persona, fronteggiando la sua vulnerabilità, entra in un rapporto dialettico con essa, conferisce a
essa una dimensione e una forma che è relativa alle proprie caratteristiche – per esempio alle
caratteristiche dei meccanismi di difesa a disposizione della persona stessa. Le malattie mentali
sono la risultante di una dialettica tra persona e vulnerabilità.
La psicoanalista e storica della psichiatria Gladys Swain scrive a questo riguardo:
«L’alienazione mentale non è mai totale: l’alienato conserva sempre una distanza dalla sua
alienazione […]. Essa emerge in seguito al vacillamento della capacità del soggetto a sostenersi in
quanto tale. A partire da qui, la raccolta e la decifrazione dei sintomi ricevono un senso
profondamente nuovo. C’è un fuoco centrale in funzione del quale ordinarli: essi devono essere letti
come espressione del vincolo del soggetto alla sua follia e del suo rapporto con la follia stessa»
(Swain, 1983, 13-14). Questa tesi è stata di recente sottoscritta e riaffermata da Mario Rossi Monti
(2008) in Forme del delirio e psicopatologia e nel libro che di recente abbiamo scritto insieme,
sulle orme di Eugène Minkowski, dal titolo Psicologia del patologico, che reca come sottotitolo
Una proposta fenomenologico-dinamica. Ora io mi sento di affermare che il trattino è una pura
esigenza tipografica ed editoriale, poiché per quanto mi concerne la proposta fenomenologica è
intrinsecamente dinamica.
Lo sfondo fenomenologico di questo pensiero, e di questo modello della patologia mentale (e
della cura) può essere rintracciato non solo nell’antropologia di matrice fenomenologica, ma anche
nella fenomenologia husserliana, e in particolare la distinzione tra intenzionalità implicita ed
esplicita. L’intenzionalità implicita o «operativa» (fungierende) si struttura come un campo precognitivo, «umorale», pronto ad accogliere, a essere impressionato, da certe esperienze, ma non da
altre. È il livello più fondamentale del nostro essere aperti al mondo. Non avrei nessuna difficoltà a
parlarne come di un livello inconscio. Da questo campo pre-tematico di impressioni emerge una
certa recettività, che consiste nel rispondere, prestare attenzione o dirigersi versi certi fenomeni
4
piuttosto che altri. L’intenzionalità esplicita è quella espressamente diretta a un oggetto. Un
ulteriore livello di intenzionalità esplicita è rappresentato dalla possibilità di prendere attivamente
una posizione rispetto a ciò che ci ha passivamente impressionato e a ciò che abbiamo quasiattivamente recepito. Le storie che ognuno di noi racconta su se stesso per dar senso ai dati «bruti»
della propria esistenza, che fanno parte dei «prodotti» dell’attività umana, sono per così dire
manufatti dell’intenzionalità esplicita nella sua opera di posizionamento e narrazione della propria
esperienza.
Fenomenologia e spiegazione causale
Una delle ragioni più profonde del mancato dialogo tra fenomenologia e psicoanalisi è da
ricercarsi nella diffidenza da parte di molti fenomenologi delle precedenti generazioni verso ipotesi
causali, e nel fraintendimento del pensiero dei padri della fenomenologia in tal senso. Ciò che si
temeva è che un’apertura verso le ipotesi etio-patogenetiche potesse far emergere il rischio di una
deriva riduzionista. Mantenere in sospeso l’interrogativo clinico sulle cause del sintomo ha avuto
tra le sue conseguenze più gravi eludere la domanda sul come intervenire su tali cause – e quindi sul
come sviluppare i presupposti di una psicoterapia fenomenologica.
In realtà, queste esitazioni non sembrano giustificate anche da un vertice di pura ortodossia
fenomenologica. Alla fenomenologia è da sempre inerente una dimensione che potremmo definire
dinamica. Sia in ambito filosofico, sia in ambito clinico il tema della spiegazione causale è fin dagli
inizi considerato di pertinenza fenomenologica. Husserl (1925) usa il concetto di «motivazione
causale» e scrive che «la coscienza consiste di… una rete fondata su intreccio intenzionale,
motivazione e mutua implicazione» (sez. 37) – sebbene ammetta che questo tipo di «causazione»
non è analogo a quello che si trova nel mondo fisico. Diversamente dalla causazione fisica, la
causazione psichica coinvolge elementi personali e soggettivi, come ad esempio gli atteggiamenti e
gli orientamenti del soggetto, il suo punto di vista, e la sua interpretazione del mondo. Si tratta, pur
tuttavia, di un dispositivo teso a spiegare l’interdipendenza tra diversi stati mentali e la loro
continuità temporale. In un recente contributo, due fenomenologi clinici tra i più rappresentativi
scrivono che «[a]vere una presa fenomenologica sulla mente di un’altra persona è afferrare le
relazioni motivazionali che conferiscono coerenza e continuità alla coscienza di quella persona»
(Parnas e Sass, 2008, 239-278). A me pare ovvio che comincia ad essere assai difficile parlare della
fenomenologia come di una disciplina meramente descrittiva.
Il padre della fenomenologia distingue tra un metodo fenomenologico statico e uno genetico
(Husserl, 1918-1926), cioè tra una descrizione dei fenomeni che si danno alla coscienza e una
esplicitazione e spiegazione dell’attività mentale implicita e fungente che costituisce, cioè genera,
tali fenomeni. Il metodo genetico in fenomenologia dischiude, come si può ben capire, oltre al
campo della coscienza il territorio dell’inconscio, cioè del fungere oscuro e inconsapevole al quale
va ricondotto il contenuto esplicito e cosciente dell’esperienza. Come scrive Carlo Sini (2003, 13),
l’immagine della fenomenologia che deriva dall’apertura alla causazione psichica e quindi alla
dimensione dell’inconscio è «lontana e incompatibile rispetto a quella che i suoi critici hanno da
sempre ostinatamente disegnato, l’immagine cioè di una sorta di idealismo metafisico e di
coscienzialismo e soggettivismo astratti e arbitrari».
Jaspers (1913-1959), da parte sua, descrive un concetto analogo alla motivazione causale che
egli denomina «comprensione genetica». Si tratta di un modo di cogliere le concatenazioni
5
psichiche dall’interno (cioè da una prospettiva di prima persona): come uno stato psichico derivi da
un altro stato psichico. Il comprendere genetico è sinonimo di «spiegare psicologico» e va tenuto
ben distinto dallo spiegare causale (il conoscere i nessi causali obiettivi visti dal di fuori, cioè in una
prospettiva di terza persona). Esso è alla base della cosiddetta psicologia comprensiva» alla quale il
padre della psicopatologia fenomenologica dedica molte pagine. Leggere Jaspers come puro fautore
della comprensione statica (cioè di un sapere esclusivamente centrato su ciò che è dato conoscere
mediante l’attualizzarsi nel clinico del singolo e isolato stato d’animo del paziente per mezzo
dell’empatia) rappresenta un radicale fraintendimento delle intenzioni del padre della
psicopatologia fenomenologica. Secondo Jaspers, invece, l’obiettivo fondamentale della
psicopatologia è rendere attuali ed esplicite le relazioni comprensibili che intercorrono tra
molteplici fenomeni che si danno nell’esperienza. Inoltre, la ricerca di tali relazioni comprensibili
non si articola soltanto su elementi immediatamente emersi alla coscienza, ma – come viene scritto
apertisverbis – si deve estendere «a meccanismi extracoscienti, normali o abnormi» (341).
Il concetto fenomenologico di comprensione, dunque, non equivale come spesso si crede a
comprensione mediante empatia e va ben oltre i limiti della comprensione statica e i confini della
coscienza esplicita. Come spiega Thomas Fuchs, il «concetto di comprensione, comunque, non
significa comprensione psicologica o empatica. Piuttosto, è una comprensione arricchita da ulteriori
risorse, in particolare informata da una spiegazione delle strutture implicite costitutive
dell’esperienza cosciente» (Fuchs, 2008, 280). Si può, infine, affermare che la comprensione statica
non sia possibile, in quanto non è possibile comprendere un fenomeno isolato, al di fuori dal flusso
dell’esperienza personale. Comprendere una sequenza è cosa ben diversa dal comprendere un
singolo fotogramma, poiché ogni fenomeno trae il proprio significato da una concatenazione di
fenomeni. È questo il punto in cui la stessa nozione di comprensione statica mostra tutti i propri
limiti, e la fenomenologia mostra la propria intrinseca natura ermeneutica. Comprendere un
fenomeno, dunque, non equivale a comprendere ciò che si dà immediatamente alla coscienza
riproducendo tale fenomeno in se stessi; bensì, inserirlo in un flusso di fenomeni che più o meno
esplicitamente affiorano alla coscienza e cogliere l’unità semantico-strutturale tra esso e tutti gli
altri. La dimensione temporale entra prepotentemente in gioco quando si intende comprendere un
vissuto, cioè un frammento del mondo interno di una persona.
Vari tipi di inconscio
Una silloge dei vari tipi di inconscio va ben oltre gli scopi di questo scritto. Qui basterà dire,
prendendo a prestito le parole di Aristotele, che l’inconscio si dice in molti modi – e che alcuni di
queste dimensioni dell’inconscio sono oggetto di studio della fenomenologia. È stato proposto di
distinguere due tipi di inconscio: il primo, detto inconscio dinamico viene a coincidere con
l’inconscio prodotto dalla rimozione. Esso però rappresenterebbe solo una parte della vita psichica
non presente nel campo attuale di coscienza. Accanto all’inconscio cosiddetto dinamico si rende
necessario ipotizzare l’esistenza di un inconscio non prodotto dalla rimozione. Sarebbe il repertorio
di esperienze pre-verbali precocissime che hanno partecipato in maniera fondante
«all’organizzazione di rappresentazioni affettive delle figure più significative nello sviluppo del
bambino e di fantasie e difese rispetto a delusioni, frustrazioni e traumi diversi che il bambino ha
incontrato nel suo impatto con la realtà» (49). Il tipo di memoria in gioco nell’inconscio nonrimosso sarebbe la memoria procedurale che consta di una serie di configurazioni (schemi) senso6
motori impliciti, cioè di risposte motorie (procedure) a stimoli sensoriali che rispecchiano l’uso
implicito delle esperienze predominanti nel passato – specialmente in quello pre-verbale. Tra le
manifestazioni principali della memoria procedurale, e dunque dell’inconscio non-rimosso, ci
sarebbero gli «usi» particolari del corpo come la postura, il modo di muoversi, l’espressività
facciale, il modo di vestire, il timbro della voce ecc.
Per usare un linguaggio prossimo a quello della fenomenologia, si tratterebbe di schemi
incarnati di azioni e percezioni, cioè da un insieme di disposizioni, implicite, non-concettuali che
guidano l’azione. Quindi, non di stati mentali, tantomeno di stati mentali consci, bensì di uno «stato
del corpo». Il nostro corpo, scrive Bourdieu (1980), è pieno di «imperativi muti»: atteggiamenti,
modo di parlare, di camminare, gusti e automatismi corporei. Questi schemi percettivi e motori che
ci guidano nel mondo sociale sono immersi nell’azione e non sono rappresentazioni teoriche del
mondo. Anche secondo Stern (2004) la regolazione del «campo intersoggettivo» avviene a opera di
un tipo di conoscenza implicita non-conscia nel senso di non-verbale e procedurale. I modelli
operativi interni (Bowlby), o gli stili di attaccamento in generale, le triadi Sé-Altro-Affetto
(Kernberg), o le rappresentazioni di interazioni generalizzate (RIGs) descritte dallo stesso Stern
potrebbero anch’essi essere considerati esempi di inconscio procedurale. Si tratta di schemi
emozionali che non sono inconsci in quanto oggetto di rimozione, ma in quanto fungono
implicitamente e involontariamente guidandoci nelle nostre interazioni con gli altri e con il mondo
in genere. Proprio in quanto principi incarnati stanno oltre la portata della coscienza e sono resi
accessibili solo attraverso la performance (e recuperabili nel corso del processo terapeutico).
Ora, sono proprio queste dimensioni incarnate, situate e pragmatiche che hanno rappresentato
la frontiera delle ricerche fenomenologiche nell’ultimo ventennio, specie nel mondo anglosassone.
Ancora una volta, trascende i confini di questo contributo tracciare una storia di questa traiettoria,
ma basterà indicare (per chi voglia documentarsi) un libro pubblicato nel 2007 intitolato Mind In
Life. Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind (Thompson, 2007) come esempio dello
sviluppo del pensiero fenomenologico nell’approccio detto embodied and enacted, e come antidoto
contro facili semplificazioni e pregiudizi «coscienzialisti» sulla fenomenologia. Thompson scrive
che, dal punto di vista della fenomenologia genetica, la struttura dell’intenzionalità deve essere
descritta in chiave di sviluppo (developmentally). La fenomenologia genetica studia come le
strutture intenzionali emergono nel tempo e come fenomeni impliciti e pre-riflessivi motivano
processi attentivi e riflessivi. Per la fenomenologia genetica (che, come abbiamo visto, è parte
integrante dell’eredità husserliana), ciò di cui facciamo esperienza non è un dato, ma qualcosa che
emerge (emergent) da esperienze precedenti. L’Io non è un «polo vuoto» ma un «soggetto concreto
che ha abitudini, interessi, convinzioni e capacità come risultati dell’esperienza accumulata» (29).
Per cogliere l’esperienza come fenomeno emergente abbiamo bisogno di mettere a fuoco due
sorgenti implicite fondamentali dell’esperienza esplicita che abbiamo del mondo: il corpo-vissuto e
la coscienza interna del tempo: «[i]l passaggio (shift) dalla fenomenologia statica a quella dinamica
segna una svolta verso il corpo vissuto e la coscienza del tempo» (28).
L’inconscio fenomenologico
Vorrei, per concludere, passare in rassegna le principali dimensioni dell’inconscio di cui parla
la fenomenologia, senza avere intenti sistematici, ma solo (per così dire) per marcare il territorio in
7
vista di un’analisi più dettagliata. Mi scuso in anticipo, con i fenomenologi per le evidenti
inesattezze e approssimazioni, e con tutti per lo schematismo apodittico dell’esposizione.
La dimensione pre-riflessiva della coscienza. La fenomenologia parla di coscienza di sé preriflessiva (con un evidente paradosso, come dicevo nell’introduzione) riferendosi ad una forma di
auto-coscienza inconscia intesa come la modalità fondamentale di presenza a sé stessi. Questi sono i
caratteri che la definiscono. È immediata: non raggiunta per inferenza o a partire da criteri. È nonosservativa: non origina da una percezione oggettivante di sé, cioè non è mediata da alcun atto
percettivo, che presupporrebbe una duplicazione tra soggetto e oggetto. È pre-riflessiva: anteriore a
e indipendente da un qualsiasi atto di coscienza riflessiva, cioè non origina a partire da una
duplicazione tra un Sé che riflette e un Sé oggetto di riflessione. È non-concettuale e nonlinguistica: non è una rappresentazione di sé mediata linguisticamente e tanto meno narrativamente.
È non-tematizzata: implicita e silente, ma ciononostante presente e fungente.
La coscienza di sé pre-riflessiva è possibile a partire dal carattere incarnato della coscienza: il
fondamento della coscienza è la carne in quanto materia impressionabile, che riceve dal contatto
con il mondo il sentimento della propria presenza al mondo. Questa primordiale presenza a sé stessi
incarnata, che alla base di qualsivoglia esperienza, è anche chiamata ipseità (Henry, 1963).
La coscienza di sé pre-riflessiva è all’origine del modo di darsi delle nostre esperienze e
azioni come esperienze e azioni “in prima persona”,cioè vissute come mie proprie (Zahavi, 1999).
Ciò che essa garantisce è il sentimento di meità (ownership) e diattività (agency) (Gallagher, 2004).
In assenza di questi due dispositivi la nostra esistenza non sarebbe la nostra esistenza. Il sentimento
di meità è il senso implicito di essere il titolare di quell’esperienza o azione, cioè che
quell’esperienza o azione è mia. Per esempio, questi pensieri sono miei pensieri (e non di qualcun
altro). Il sentimento di attività è il senso implicito di essere l’iniziatore di quella data azione o atto
psichico. Per esempio, sono io colui che vuole pensare questi pensieri (e non qualcun altro che me li
impone). La distinzione tra sentimento di meità e di attività è di fondamentale importanza in
psicopatologia. I disturbi della coscienza di sé pre-riflessiva sono al centro della concettualizzazione
fenomenologica dei sintomi schizofrenici.
La coscienza implicita del tempo. La fenomenologia rappresenta la coscienza come un arco il
cui vettore è il tempo. Gli oggetti di cui è fatto il nostro mondo ci appaiono come ci appaiono, cioè
familiari, reali e dotati di significato grazie al fatto che un dispositivo implicito svolge una funzione
di sintesi,al di sotto della soglia perspicua della nostra coscienza, delle prospettive che per istante
abbiamo su di essi. Tra gli esempi cari alla fenomenologia per rappresentare questo fungere
implicito vi è quello dell’ascoltare una melodia: quando ascolto un brano musicale, ciò che si dà in
questo istante nella mia coscienza è l’impressione di una singola nota. Essa mi suonerebbe priva di
senso, e avulsa da una qualunque melodia, se non venisse in me automaticamente articolata alle
note precedenti, ritenute nella mia memoria, e a quelle future, anticipate come momenti attesi,
sebbene non ancora presenti. Essere coscienti di un motivo musicale, quindi, necessita di un lavoro
oscuro di sintesi tra l’impressione presente, la ritenzione del già stato, e la protenzione verso il da
venire. In assenza di questo fungere implicito e inconscio, una melodia non sarebbe una melodia,
ma il mero succedersi di note musicali.
La coscienza, quindi, si distende oltre l’«ora» in direzione di ciò che, per intenderci,
chiamiamo «passato» e «futuro» – e che la fenomenologia invece chiama «ritenzione» (o memoria
primaria) e «protenzione» (o anticipazione primaria). Il motivo per cui la fenomenologia non parla,
a questo riguardo, di passato e futuro è perché essi non si danno alla coscienza se non in quanto
intenzionalmente contenuti nel presente. È nel presente che intende – ecco la metafora dell’arco che
8
si spiega – il «passato» e «futuro» tenendoli, per così dire, in vista. Un altro esempio, per capire il
ruolo fondamentale di questo dispositivo affinché le nostre esperienze coscienti si diano come
siamo abituati a viverle può essere il seguente. Quando stasera tornerò a casa, nell’istante
(chiamiamolo t0) in cui apparirà davanti a me la facciata del palazzo in cui vivo non avrò
l’impressione di essere di fronte ad un oggetto bidimensionale, ad una quinta di teatro; bensì ad un
edificio tridimensionale e in carne-e-ossa. Ciò che mi è dato vedere dell’edificio in quell’istante t0 è
un singolo scorcio dell’edificio stesso, che si imprime sulla mia coscienza come un’immagine a due
dimensioni. Ma in quello stesso istante la visione di quella particolare prospettiva dell’edificio
stessa sarà implicitamente in me articolata con il mio ricordo e con l’anticipazione dello scorcio
dell’edificio che mi aspetto di vedere un istante dopo quello presente. Il ricordo (la ritenzione) agirà
in me suggerendomi che ciò che vedo a t0 (cioè un profilo di un edificio, senza spessore né
profondità) altro non è che una delle innumerevoli prospettive su quella casa che ho già visto in
passato (essendo entrato e uscito da essa, mossomi al suo interno, ecc. innumerevoli volte). E la
protenzione mi farà anticipare le prospettive che, muovendomi, potrò avere sull’edificio stesso.
La sintesi passiva delle impressioni della coscienza con le ritenzioni da un lato e le protezioni
dall’altro è la condizione di possibilità dell’apparire degli oggetti mondani come reali, in-carne-eossa, e per me significativi, piuttosto che mere immagini prive di utilizzabilità e significato. Questa
è un’altra delle dimensioni della nostra vita inconscia esplorata dalla fenomenologia. La
disarticolazione delle sintesi passive è una chiave di lettura dei disturbi dello spettro psicotico
(Kimura, 1992).
La dimensione strutturale come condizione di possibilità dell’apparire dei fenomeni nel
mondo della vita. La fenomenologia studia il mondo in cui la coscienza si appropria del mondo. Ciò
significa che la fenomenologia è interessata a cogliere il modo in cui la mente deve essere
strutturata affinché il mondo le possa apparire in quel dato modo in cui le appare. Chiaramente,
questa struttura della mente non appare esplicitamente alla coscienza stessa, ma deve essere per così
dire ricavata tramite un qualche tipo di analisi. La peculiarità dell’analisi fenomenologica è la
seguente: per scoprire come è fatta la mente, piuttosto che rivolgersi alla mente stessa, l’analisi si
rivolge altrove, e in particolare al mondo. Questa è la direzione che deve prendere l’indagine
dell’inconscio nell’ottica fenomenologica (o, almeno, nella rotta tracciata dall’ultimo MerleauPonty): «Ciò che va compreso, al di là delle “persone” – scrive Merleau-Ponty (1964) ne Il visibile
e l’invisibile – sono gli esistenziali secondo i quali noi le comprendiamo, e che sono il senso
sedimentato di tutte le nostre esperienze volontarie e involontarie. Questo l’inconscio da cercare,
non in fondo a noi, dietro la nostra “coscienza”, ma davanti a noi, come articolazioni del nostro
campo. Esso è “inconscio” per il fatto che non è oggetto, ma è ciò grazie a cui degli oggetti sono
possibili, è la costellazione in cui si legge il nostro avvenire – L’inconscio è fra di essi come
l’intervallo degli alberi tra gli alberi, o come il loro livello comune. È la Urgemeinschftung della
nostra vita intenzionale, Ineinander degli altri in noi e di noi negli altri» (197).
Questo brano, scritto nel Febbraio del 1959, traccia la rotta dell’esplorazione fenomenologica,
designando il «cosa», il «come» e il «dove» cercare. Il «dove» è detto esplicitamente: non dentro il
soggetto, ma davanti a lui, cioè nel mondo in cui si proietta. Il «come» è altrettanto chiaro: andando
alla ricerca della struttura del mondo in cui il soggetto vive, che riflette la sua struttura interna.
«Cosa» si cerchi nel mondo del soggetto è anch’esso chiaro fin dalle prime righe: gli «esistenziali»
secondo i quali il soggetto comprende il mondo. Questi esistenziali sono le strutture trascendentali
della mente, e cioè le categorie implicite e fungenti in base alle quali il nostro mondo prende forma.
Gli esistenziali sono il modo in cui noi implicitamente strutturiamo il tempo, lo spazio, il nostro
9
corpo, l’altro, la materialità degli oggetti. Essi sono, prosegue Merleau-Ponty, l’«ossatura» del
mondo invisibile. Queste categorie – ma si tratta, beninteso, di categorie incarnate, e non di
categorie astratte e puramente cognitive – mettono in forma il nostro mondo e dettano il modo in
cui percepiamo e ci rappresentiamo lo scorrere del tempo, l’estensione dello spazio attorno a noi,
l’unità e i limiti del nostro corpo, la prossimità o la distanza dell’altro, la fisionomia delle cose che
incontriamo. Queste categorie incarnate sono il nostro “cardine esistenziale”. “[G]li e[sistenziali]
formano l’ossatura del campo trascendentale (…) ciò che la coscienza non vede sono gli
e[sistenziali] grazie ai quali il mondo diviene visibile» (316).
Gli esistenziali sono categorie descrittive fintantoché se ne fa un uso limitato a mostrare e
delineare l’architettura di un mondo – come è fatto quel mondo. Ma divengono categorie esplicative
dal momento in cui vengano usate per esporre e rendere visibile la struttura della mente, cioè come
la mente ha fatto quel mondo, cioè come organizza le proprie percezioni e rappresentazioni.
Merleau-Ponty fa un esempio del fungere di queste categorie, e lo fa con riferimento alla
psicoanalisi: «L’occulto in psicoanalisi (l’inconscio) è di questo tipo (cfr. una donna che per strada
sente che si guardano i suoi seni e che verifica il vestito. Il suo schema corporeo è per sé-per altri –
È la cerniera del per sé e del per altri. Avere un corpo significa essere guardati (non è soltanto
questo), significa essere visibili. (…). Certamente, se si interrogasse una donna in buona fede che
richiude il proprio cappotto (o viceversa), questa donna non saprebbe che cosa ha appena fatto. Essa
non lo saprebbe nel linguaggio del pensiero convenzionale, ma lo saprebbe come si conosce il
represso, cioè non come figura su sfondo, ma come sfondo» (205-6).
In altre parole, l’inconscio che può illuminare la fenomenologia è il nesso (per quella donna)
tra l’avere (o l’essere) un corpo e l’essere visibili – e tutto ciò che esso comporta in termini di
emozioni, laddove l’emozione qui in gioco è, evidentemente, la vergogna. E infatti le emozioni
sono l’epicentro della vita, il «vortice temporalizzante-spazializzante» (per usare ancora le parole di
Merleau-Ponty), ciò che motiva il nostro agire, e quindi in ultima analisi ciò che ci posiziona nel
mondo e detta la nostra prospettiva su di esso. Le emozioni sono intenzionalità incarnata, e
svolgono per l’ermeneutica fenomenologica del soggetto il ruolo fondamentale svolto, per altre
ermeneutiche, da altri strati dell’inconscio (Stanghellini, Rosfort, in press).
Qui si ferma l’analisi fenomenologica? Potremo mai sapere «perché» quella donna prova
vergogna? O dovremo chiederlo alla psicoanalisi?
SINTESI
Questo scritto si occupa dei rapporti tra fenomenologia e inconscio. La fenomenologia, sia nella sua
originaria fondazione filosofica, sia nella sua derivazione clinica, viene concepita come una dettagliata
vivisezione della coscienza. Se da un lato è vero che l’analisi dei fenomeni che si danno alla coscienza siano
l’oggetto da cui prende inizio l’indagine fenomenologica, è solo per un inveterato equivoco che si intenda il
termine «coscienza» in termini restrittivi e cioè contrapposti al termine «inconscio». È assai più corretto dire
che la fenomenologia filosofica e clinica si occupa delle condizioni di possibilità dell'apparire dei fenomeni
così come si danno coscientemente – ed essendo tali condizioni di possibilità al di là dei confini della vita
cosciente, è chiaro che esse estendono la propria indagine alla dimensione inconscia.
PAROLE CHIAVE: Coscienza, fenomenologia, inconscio, psicopatologia fenomenologica.
BIBLIOGRAFIA
Bourdieu P. (1980). Il senso pratico. Roma, Armando, 2005.
10
Fuchs T. (2008). Comment: beyond descriptive phenomenology. In Kendler K.S., Parnas J. (a cura di),
Philosophical issues in psychiatry; explanation, phenomenology, and nosology. Baltimore, J. Hopkins
Univ. Press.
Gallagher S. (2004). Neurocognitive models of schizophrenia. A neurophenomenological critique.
Psychopathology, 37, 8-13.
Henry M. (1963). L’essence de la manifestation. Paris, Presse Universitaire de France.
Husserl E. (1918-1926). Metodo fenomenologico statico e genetico. Milano, Il Saggiatore, 2003.
Husserl E. (1925). Phenomenological psychology (lectures, summer semester 1925). The Hague, Nijhoff,
1977.
Jaspers K. (1913-1959). Psicopatologia generale. Roma, Il Pensiero Scientifico, 1964.
Kimura B. (1992). Scritti di psicopatologia fenomenologica. Roma, Giovanni Fioriti, 2005.
Mancia M. (2004). Sentire le parole: archivi sonori della memoria implicita e musicalità del transfert.
Torino, Bollati Boringhieri.
Merleau-Ponty M. (1964). Il visibile e l’invisibile. Milano, Bompiani, 1969.
Minkowski E. (1966). Trattato di psicopatologia. Milano, Feltrinelli, 1973.
Nietzsche F. (1872). La nascita della tragedia. Milano, Adelphi, 1977.
Parnas J., Sass L.A. (2008). Varieties of ‘phenomenology’. On description, understanding, and explanation
in psychiatry. In Kendler K.S., Parnas J. (a cura di), Philosophical issues in psychiatry; explanation,
phenomenology, and nosology. Baltimore, Johns Hopkins Univ. Press.
Pinel P. (1800).Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie. Paris, Richard, Caille et
Ravier.
Ricoeur P. (1950). Philosophie de la volonté. Tome 1. Le volontarie et l’involontaire. Paris, Aubier.
Rossi Monti M. (2008). Forme del delirio e psicopatologia. Milano, Cortina.
Rossi P. (2008). Speranze. Bologna, il Mulino.
Scheler M. (1928). La posizione dell’uomo nel cosmo. Roma, Armando, 1997.
Sini C. (2003). Prefazione. In E. Husserl, Metodo fenomenologico statico e genetico. Milano, Il Saggiatore.
Stanghellini G. (1997). Antropologia della vulnerabilità. Milano, Feltrinelli.
Stanghellini G., Rosfort R. Emotions and Personhood. London/New York, Oxford University Press, in corso
di stampa.
Stanghellini G., Rossi Monti M. (2009). Psicologia del patologico. Una prospettiva fenomenologicodinamica. Milano, Cortina.
Stern D.N. (2004). Il momento presente. Milano, Cortina, 2005.
Swain G. (1983). Soggetto e follia. Pinel e la nascita della psichiatria moderna. Torino, Centro Scientifico
Torinese.
Thompson E. (2007). Life. Biology, phenomenology, and the sciences of mind., Cambridge, Massachussetts,
London, Harvard Univ. Press.
Zahavi D. (1999). Self-Awareness and alterity. A Phenomenological investigation. Evanston, Northwestern
Univ. Press.
11