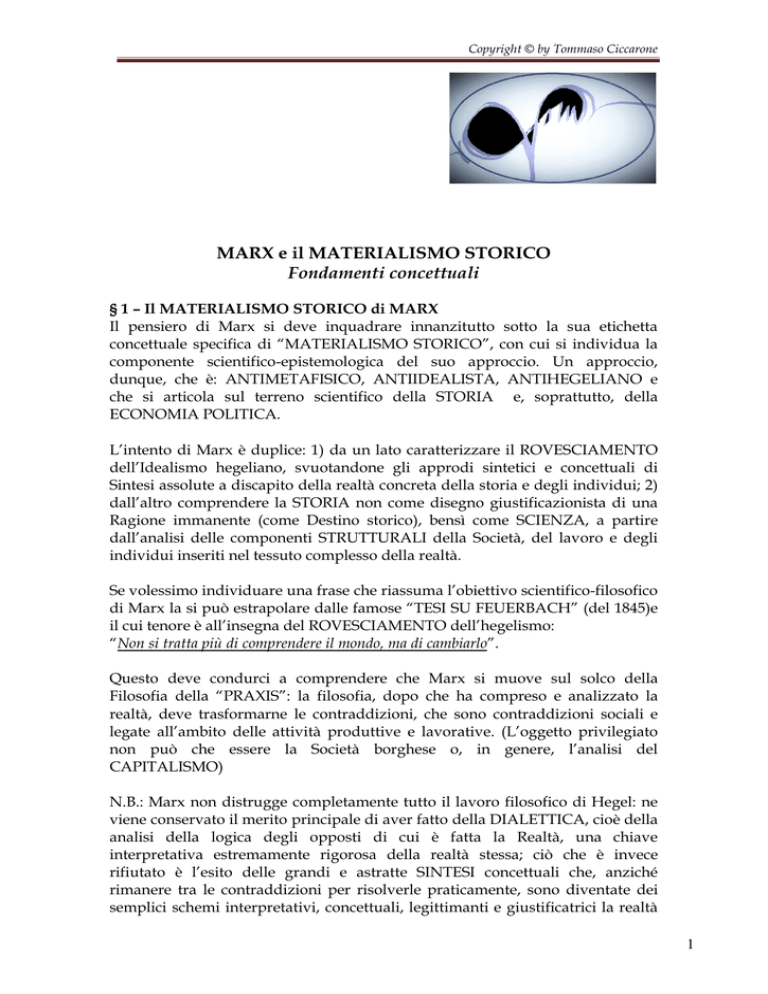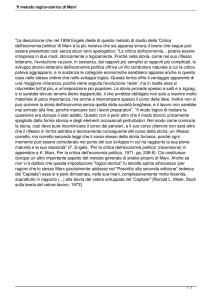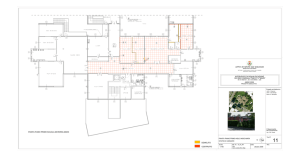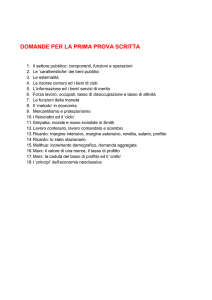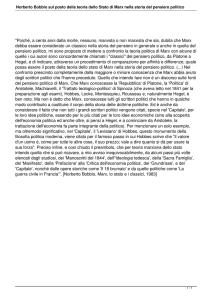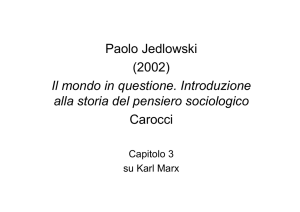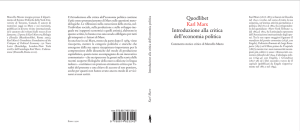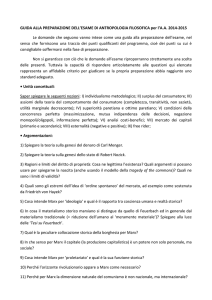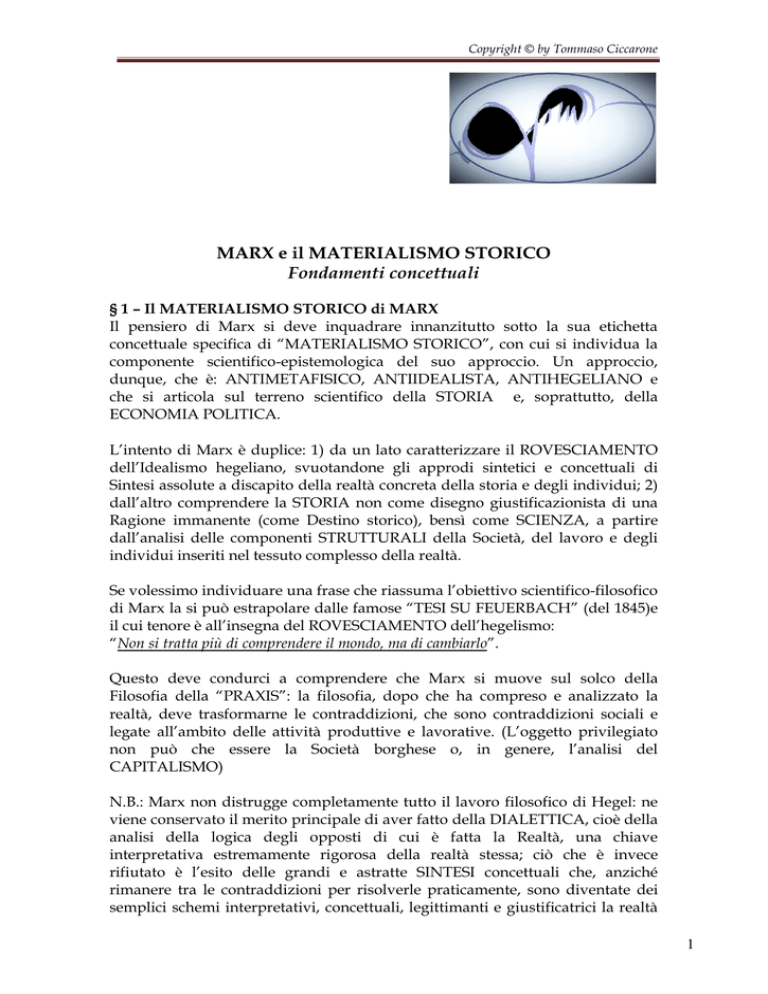
Copyright © by Tommaso Ciccarone
MARX e il MATERIALISMO STORICO
Fondamenti concettuali
§ 1 – Il MATERIALISMO STORICO di MARX
Il pensiero di Marx si deve inquadrare innanzitutto sotto la sua etichetta
concettuale specifica di “MATERIALISMO STORICO”, con cui si individua la
componente scientifico-epistemologica del suo approccio. Un approccio,
dunque, che è: ANTIMETAFISICO, ANTIIDEALISTA, ANTIHEGELIANO e
che si articola sul terreno scientifico della STORIA e, soprattutto, della
ECONOMIA POLITICA.
L’intento di Marx è duplice: 1) da un lato caratterizzare il ROVESCIAMENTO
dell’Idealismo hegeliano, svuotandone gli approdi sintetici e concettuali di
Sintesi assolute a discapito della realtà concreta della storia e degli individui; 2)
dall’altro comprendere la STORIA non come disegno giustificazionista di una
Ragione immanente (come Destino storico), bensì come SCIENZA, a partire
dall’analisi delle componenti STRUTTURALI della Società, del lavoro e degli
individui inseriti nel tessuto complesso della realtà.
Se volessimo individuare una frase che riassuma l’obiettivo scientifico-filosofico
di Marx la si può estrapolare dalle famose “TESI SU FEUERBACH” (del 1845)e
il cui tenore è all’insegna del ROVESCIAMENTO dell’hegelismo:
“Non si tratta più di comprendere il mondo, ma di cambiarlo”.
Questo deve condurci a comprendere che Marx si muove sul solco della
Filosofia della “PRAXIS”: la filosofia, dopo che ha compreso e analizzato la
realtà, deve trasformarne le contraddizioni, che sono contraddizioni sociali e
legate all’ambito delle attività produttive e lavorative. (L’oggetto privilegiato
non può che essere la Società borghese o, in genere, l’analisi del
CAPITALISMO)
N.B.: Marx non distrugge completamente tutto il lavoro filosofico di Hegel: ne
viene conservato il merito principale di aver fatto della DIALETTICA, cioè della
analisi della logica degli opposti di cui è fatta la Realtà, una chiave
interpretativa estremamente rigorosa della realtà stessa; ciò che è invece
rifiutato è l’esito delle grandi e astratte SINTESI concettuali che, anziché
rimanere tra le contraddizioni per risolverle praticamente, sono diventate dei
semplici schemi interpretativi, concettuali, legittimanti e giustificatrici la realtà
1
Copyright © by Tommaso Ciccarone
(la Filosofia come SPECULAZIONE astratta, come “la Nottola di Minerva che
spicca il suo volo sul calar della sera”). Quindi MARX è in parte debitore nei
confronti di Hegel, ma rimane al di qua della soluzione SINTETICA degli
opposti (possiamo dire che sia per certi versi più affine all’impostazione di
FICHTE: l’Io e il Non-Io non si conciliano mai, ma sono aperti in un processo
dinamico e in evoluzione).
§ 2 - TAPPE dell’evoluzione intellettuale e bibliografica di MARX
Per comprendere bene il percorso evolutivo del pensiero di Marx, solitamente si
distingue tra 1) il “GIOVANE” Marx e 2) il Marx della “MATURITA’”. La cifra
discriminante e che caratterizza la svolta del cambiamento è data dall’anno
1845; l’anno invece della piena consacrazione “scientifica” del suo pensiero
parte dal 1857.
PRIMA DEL 1845: Marx è ancora vincolato ad un pensiero astratto, non
orientato sull’analisi dei problemi economici; si parla infatti piuttosto di un
Materialismo “piatto”, che parlava della Natura dell’uomo in generale,
decontestualizzato dal tessuto sociale fatto di relazioni con i fattori di
produzione e le forze produttive della società (le differenze fra le classi sociali; i
soggetti della produzione; l’influenza della Cultura della classe dominante;
etc…); prima del 1845, insomma, Marx cammina ancora con le gambe e il
linguaggio di HEGEL o di una speculazione astratta e generica.
1845: è l’anno in cui ha appena pubblicato i “MANOSCRITTI ECONOMICOFILOSOFICI” (1844), l’ “IDEOLOGIA TEDESCA” e le famosissime “TESI SU
FEUERBACH”; questa trilogia di opere lo immette su un terreno filosofico che
ha a che fare con problemi CONCRETI che riguardano le STRUTTURE della
società e del contesto politico, distinte quindi dalle idee metafisiche, astratte e
generiche che in gergo si chiamano SOVRASTRUTTURE. Ci occuperemo, per
capire questo anno cruciale, del rapporto concettuale instaurato da MARX tra
STRUTTURA/SOVRASTRUTTURA.
P.S.: Tra l’altro ci si deve chiedere: come mai avviene questo cambiamento così
drastico in Marx; quali sono i fattori che in lui producono questa svolta?
Bisogna dire che sono fattori AUTOBIOGRAFICI e GEOGRAFICO-POLITICI.
Infatti Marx a BERLINO faceva il giornalista per la “Gazzetta Renana”: lì
cominciò a occuparsi di tematiche scottanti per il Sistema dello Stato prussiano,
di cui Hegel era stato il massimo sostenitore ideologico e filosofico. La sua
posizione era quindi scomoda o pericolosa: la sua vita è stata all’insegna spesso
anche dell’indigenza e della povertà in quanto intellettualmente era in contrasto
con un Sistema borghese e tradizionale fondato sul nascente capitalismo
industriale e su un’amministrazione burocratica statale oppressiva della libertà
di stampa e pensiero (ricordatevi che i moti del 30/31 in Prussia fallirono prima
ancora di cominciare)
Marx fu costretto all’esilio volontario in Francia, precisamente a Parigi, dove
lavorò al giornale “ANNALI FRANCO-TEDESCHI”; in Francia cominciava a
2
Copyright © by Tommaso Ciccarone
montare l’aria socialista e operaia che porterà ai giorni del 48; Marx fu
interprete e attento lettore delle dinamiche e fattori che avrebbero determinato
lo scontro sociale; fattori che erano da ricercarsi nelle contraddizioni di una
società, quella parigina, di pieno CAPITALISMO e BENESSERE industrialeborghese (la condizione operaia era la più macroscopica di queste
contraddizioni, in termini di SFRUTTAMENTO e ALIENAZIONE, condizioni
alla base del PROFITTO del Capitale: la cosiddetta Teoria del PLUSVALORE)
Nel 1848: per la cronaca e non casualmente, questa è la data della pubblicazione
del saggio più famoso ma anche più controverso e male interpretato di tutto il
marxismo, il “MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA”,in cui Marx ipotizza
scientificamente (e non ideologicamente: cioè lui non si pone come capo-popolo
rivoluzionario)la necessità utopica di un rovesciamento del sistema di
sfruttamento capitalistico da parte della classe operaia. Sarà LENIN che
tradurrà in termini rivoluzionari la teoria marxista in un contesto che Marx non
poteva conoscere, capire ed analizzare, quello Zarista della Russia del primo
decennio del XX secolo.
1857: è l’anno in cui pubblica la celebre “INTRODUZIONE” a “per la Critica
dell’Economia Politica” (del 1859); data la sua importanza riguardo al metodo
d’analisi filosofica e degli strumenti concettuali economico-politici,
quest’Introduzione è paragonabile al “Discorso sul Metodo” del Materialismo
Storico (così come CARTESIO con il suo “Discorso sul Metodo” instaurò un
nuovo corso nel pensiero filosofico moderno all’insegna del razionalismo
soggettivo).
In queste due opere, del 1857 e ’59, MARX pone le premesse teoriche che
confluiranno nell’Opera più specifica e tecnica riguardo alla Filosofia politica,
storica ed economica (IL CAPITALE); in queste due opere gli oggetti della
ricerca fanno capo al DENARO, alle MERCI, al loro VALORE, ai complessi
meccanismi di MERCATO, ma, soprattutto, Marx qui parla delle Forze
produttive (umane) e dei rapporti di produzione (lotte di classe tra Capitalisti e
Operai) dalla cui analisi deriveranno nozioni centrali del pensiero
contemporaneo come l’ALIENAZIONE dell’uomo (rispetto al processo
lavorativo o al prodotto del suo lavoro che non può padroneggiare a causa della
frantumazione TAYLORISTICA della catena di montaggio; alienazione rispetto
alla propria DIGNITA’ autonoma e individuale, perché il processo
TAYLORISTICO ha finito per svuotare l’uomo della sua umanità e soggettività,
per ridurlo ad un ingranaggio del Sistema di fabbrica, ad uno strumento del
meccanismo capitalistico, per ridurlo ad OGGETTO…
1867: è l’anno di pubblicazione del I LIBRO de “IL CAPITALE” (gli altri 3 libri
o parti sono state pubblicate postume dal suo amico ENGELS e, comunque,
costituiscono degli approfondimenti o delucidazioni di argomenti e concetti
elaborati sin dal 1857 con l’INTRODUZIONE).
3
Copyright © by Tommaso Ciccarone
§ 3 – Sui concetti di Struttura e Sovrastruttura
Sono i concetti che spiegano l’antiidealismo di MARX nei confronti
dell’impostazione che HEGEL assume sulla STORIA.
Per Hegel, infatti, la Storia è “destinale” cioè è sostenuta dallo Spirito Assoluto
(il GEIST o zeit-geist, LO SPIRITO DEL TEMPO)che determina gli individui
dando loro un senso e una collocazione logica. Per HEGEL, insomma, è la
SOVRASTRUTTURA della Logica e della Filosofia a dare un senso e quindi a
far esistere le strutture della realtà.
(quando si parla di “Misticismo Logico”, come fa il libro di testo, in certi
ambienti filosofici si inquadra la Logica di Hegel curiosamente, ma anche con
qualche forzatura, all’INCIPIT del IV VANGELO di GIOVANNI: “All’inizio era
il Verbo/Logos e il Verbo era presso Dio”; naturalmente questo può essere
preso come riferimento simbolico o metaforico dell’approccio totalizzante di
HEGEL e del suo “panlogismo” (= la Totalità della realtà spiegata tramite la
logica: “Tutto ciò che è reale è razionale; tutto ciò che è razionale è reale”).
Chiusa parentesi teo-idealistica…
Vice-versa Marx, come già aveva preannunciato FEUERBACH, le
Sovrastrutture (termine che indica tutte le categorie del pensiero: dall’ARTE
alla FILOSOFIA, dalla RELIGIONE alla LETTERATURA o IDEOLOGIA di una
nazione)sono in realtà derivazioni di determinate strutture storiche, concrete,
sociali, fatte dagli uomini e dei loro rapporti di classe.
L’operazione filosofica di MARX si basa sul CAPOVOLGIMENTO del discorso
(ideologico) di Hegel. Ho detto “ideologico”, nel senso negativo in cui lo
intende Marx: quello di hegel è un discorso mirante a giustificare e legittimare
la Sovrastruttura (la cultura e mentalità) dello Stato prussiano.
Ciò che è “salvato” dell’hegelismo è il metodo DIALETTICO ( La “Dialettica”
come svolgimento-movimento delle contraddizioni/opposizioni), ma non
accetta il fatto che la Dialettica per Hegel vada a culminare in una sintesi finale
che è solo concettuale e, quindi, meta-fisica (cioè supera la realtà concreta
chiudendosi in una dimensione speculativa, solo ed esclusivamente teorica).
Per Marx, al contrario, la Dialettica deve essere intesa come svolgimento della
storia reale-concreta-materiale, fatta dagli uomini. Ecco perché si parla di
“Materialismo Storico” e si può parlare anche di “Materialismo Dialettico” in
Marx.
In conclusione: è la STRUTTURA socio-economico-storica della Realtà a
determinare e produrre le corrispettive Sovrastrutture (mentalità, concezioni
letterarie, filosofiche, morali, di costume, etc etc), E NON IL CONTRARIO!
§ 4 – I Manoscritti Economico-Filosofici (ovvero: sul confronto con gli
“Economisti Classici”)
Partendo dallo studio delle STRUTTURE economiche e sociali della Realtà,
inevitabilmente Marx si deve confrontare non solo con Hegel (l’interlocutore
privilegiato di Marx) ma, trattando di questioni di ECONOMIA POLITICA e
scientifiche, in senso stretto, si confronta con i teorici dell’Economia Politica
4
Copyright © by Tommaso Ciccarone
classica facenti parte della scuola inglese del XVIII sec: SMITH, RICARDO E
MALTHUS.
PERCHE’ MARX CRITICA GLI ECONOMISTI CLASSICI?
Perché questi,come appunto Smith e Ricardo soprattutto, pur avendo avuto il
merito di affermare che il VALORE delle MERCI DIPENDE DIRETTAMENTE
DALLA QUANTITA’ DI LAVORO SOCIALMENTE NECESSARIO PER
FARLE, si sono però fermati alla superficie del problema: cioè hanno avuto il
torto filosofico di dare esclusiva importanza alle merci in sé, alle COSE, e non
invece alla componente UMANA, al lavoro UMANO socialmente utile per
costituire il processo produttivo di tutta l’economia. Cioè, in breve: essi hanno
dato rilievo agli EFFETTI e non alle CAUSE ANTROPOLOGICHE e quindi
SOCIALI alla radice di quegli effetti.
Sulla distorsione e circolo vizioso che gli Economisti classici alla fine non hanno
saputo individuare dell’intero e complesso sistema capitalistico di produzione e
ricchezza economica, Marx riprende un passo molto significativo dal TIMONE
DI ATENE, una delle ultime tragedie di SHAKESPEARE, sul capovolgimento
delle priorità e dei valori nella società del benessere (il DENARO che rimpiazza
la centralità dell’uomo e diventa l’unico criterio fondante l’essenza dei rapporti
umani):
“Oro? Prezioso, scintillante, rosso oro? No, dei, non è frivola la mia
supplica. Tanto di questi fa il nero bianco, il brutto bello, il cattivo buono, il
vecchio giovane, il vile valoroso, l’ignobile nobile. Questo stacca (…) il prete
dall’altare; sì, questo rosso schiavo scioglie e annoda i legami sacri; benedice il
maledetto; fa la lebbra amabile; onora il ladro e gli dà il rango, le genuflessioni e
la influenza nel consiglio dei senatori; questo conduce dei pretendenti alla
troppo stagionata vedova; questo ringiovanisce, balsamico, in una gioventù di
maggioi, colei che è respinta con nausea, marcia com’è di ospedale e pestifere
piaghe. MALEDETTO METALLO, COMUNE PROSTITUTA DEGLI UOMINI,
CHE SCONVOLGI I POPOLI”
(W. Shakespeare, Timone d’Atene)
“Il denaro, poiché possiede la proprietà di comprar tutto, la proprietà di
appropriarsi tutti gli oggetti, è così l’OGGETTO in senso eminente.
L’Universalità della sua proprietà è l’onnipotenza del suo essere; esso VALE
QUINDI COME ENTE ONNIPOTENTE (…) Uil denaro è l’INTERMEDIARIO
fra il bisogno e l’oggetto, fra la vita e il mezzo di vita dell’uomo. Ma ciò che mi
media la mia vita mi media anche l’esistenza degli altri uomini. Questo è il
prossimo per me…”
(K. Marx, manoscritti Economico-Filosofici)
“Shakespeare rileva nel denaro particolarmente due proprietà:
1) è la visibile deità, il tramutamento di ogni qualità umana e naturale nel suo
opposto, la generale CONFUSIONE e PERVERSIONE delle cose, la
conciliazione delle impossibilità;
5
Copyright © by Tommaso Ciccarone
2) è l’universale prostituta, l’universale mezzana di uomini e popoli”
(K. Marx, M.E.F.)
da questo excursus possiamo senz’altro approfittare di Marx per prendergli in
prestito un concetto che ben si applica alla situazione che in verità aveva intuito
in tempi non sospetti, nel 1750, J.J. ROUSSEAU il celebre “Discorso sulla
Disuguaglianza dell’Uomo”, relativamente alle conseguenze negative del
progresso : l’ALIENAZIONE dell’uomo a se stesso e la sua dis-umanizzazione,
nella misura in cui egli stesso diventa rotella, e quindi merce-oggetto,
dell’intero ingranaggio.
§ 5 – Il Capitale (Analisi sul “saggio di Profitto” e del Plusvalore del
Capitalismo)
PER MARX IN COSA CONSISTE ESATTAMENTE LA CONTRADDIZIONE
DELLA E NELLA SOCIETA’ BORGHESE CAPITALISTA?
La contraddizione deriva dal fenomeno della ALIENAZIONE del LAVORO.
(Alienazione come innanzitutto significante una “privazione”, uno s-possesso
di qualcosa di costitutivo l’essenza dell’uomo).
Il lavoratore, l’operaio, produce un oggetto con un suo VALORE D’USO
intrinseco (il valore d’uso è dato dalla risposta alla domanda “A CHE SERVE
QUESTO OGGETTO?”; cioè il valore d’uso di un oggetto è dato da un bisogno
corrispondente da soddisfare); ma questo oggetto ha anche un VALORE DI
SCAMBIO (il PREZZO, cioè, che la MERCE ha sul Mercato).
Però: il lavoratore quando finisce il suo oggetto non ne è più il “padrone”, non
gli appartiene più (come avveniva per l’ormai sorpassato ARTIGIANO
dell’epoca pre-capitalistica) in quanto inserito in un processo su larga scala
industriale dettato dalla razionalizzazione della produzione e dei tempi di
lavorazione (il TAYLORISMO). L’operaio dunque non realizza se stesso ma lo
scopo di chi gestisce l’intero processo: il CAPITALE, insomma. Il capitalismo, è
questa la conclusione teorica di Marx, si basa sull’espropriazione del lavoro
della sue stesse forze produttive.
L’opera più matura di Marx, IL CAPITALE, mette ulteriormente in luce il
meccanismo contraddittorio dell’ESPROPRIAZIONE operata dal Capitalismo a
danno della classe operaia, parlando della teoria del SAGGIO DEL PROFITTO
(cioè svelando in termini tecnici in cosa consistano le coordinate del profitto
capitalistico). Per far ciò Marx elabora e analizza, anche matematicamente, il
concetto di PLUSVALORE.
DEF: Innanzitutto il PLUSVALORE è il PROFITTO che il capitalista deve
ottenere se vuole ottenere, se vuole “sopravvivere” nel libero mercato della
concorrenza (non dimentichiamo che il Capitalismo deriva da una costola del
LIBERISMO economico di stampo anglosassone che teorizza il Libero Mercato e
il sistema del Welfare/Benessere fondato sulla PROPRIETA’ PRIVATA).
Il Plusvalore deriva dall’incidenza sul cosiddetto CAPITALE VARIABILE del
sistema capitalistico (è il SALARIO degli operai, della forza-lavoro umana; si
distingue dal CAPITALE COSTANTE o FISSO che corrisponde con gli
6
Copyright © by Tommaso Ciccarone
INVESTIMENTI che ogni capitalista deve operare in , per es., macchinari,
tecnologie all’avanguardia, ricerca scientifica, ricerche di mercato, pubblicità,
formazione dei “colletti bianchi”, etc: è ovvio che il capitalista non inciderà sul
Capitale Costante ai fini dell’accumulo del profitto)
L’ACCUMULO di CAPITALE (ovvero del Profitto o proprietà privata) è
sintetizzato da Marx in una formula schematica:
D – M – D+
Per capirlo basta semplicemente partire dalla logica delle Enrate/Uscite.
L’acumulo di Capitale si ottiene quando le ENTRATE superano le USCITE
iniziali:
D = Denaro iniziale che il Capitalista investe per acquistare la sua merce M (in
cui è inclusa anche la forza lavoro degli operai che deve pagare; marx vuole
proprio sottolineare la MERCIFICAZIONE degli operai, la loro
disumanizzazione).
M = E’, appunto, la Merce comprata e investita dal capitalista per la vita stessa
della sua atività
D+ = E’ il denaro IN Più, nel senso che E’ SOTTRATTO dal salario operaio. In
particolare Marx parla di “Plusvalore ASSOLUTO” quando non solo l’operaio
è pagato in meno, ma contemporaneamente lavora DI PIU’ intermini di tempo o
giornata lavorativa.
Un altro meccanismo sottostante alla logica del PROFITTO è invece ciò che
Marx indica con la nozione tecnica di “PLUSVALORE RELATIVO” (per
distinguerlo da quello “assoluto”): esso consiste, da parte del capitalista, nel
formare SQUADRONI di operai in modo che il lavoro sia COLLETTIVO
(proporzionalmente il lavoro individuale si riduce sempre di più, cioè viene
parcellizzato, frantumato) che abbatte il costo stesso del lavoro. Si tratta, ancora
una volta, del modello taylorista del FORDISMO, per es, in cui, per realizzare
una automobile, una squadra di operai è impiegata per i bulloni delle ruote;
un’altra per uno sportello; un’altra per i pneumatici, e così via: il prodottoautomobile l’operaio non lo possiede nel processo lavorativo). Tale divisione,
tra l’altro, implica contraddizioni maggiori quando ad affiancare gli squadroni
di operai sono poste le stesse macchine o i primi ROBOT di fabbrica che
potenziando l’ottimizzazione dei tempi e della quantità di produzione, rende
superflua la stessa forza lavoro umana, determinando i meccanismi di
DISOCCUPAZIONE o CASSA INTEGRAZIONE.
La lotta di classe è innescata, per Marx, dal saggio di Profitto del Capitale: a
questa analisi interpretativo-teorica deve potersi affiancare una conseguente
FILOSOFIA DELLA PRAXIS che ristabilisca le condizioni di umanizzazione
dell’Economia e/o della società.
7