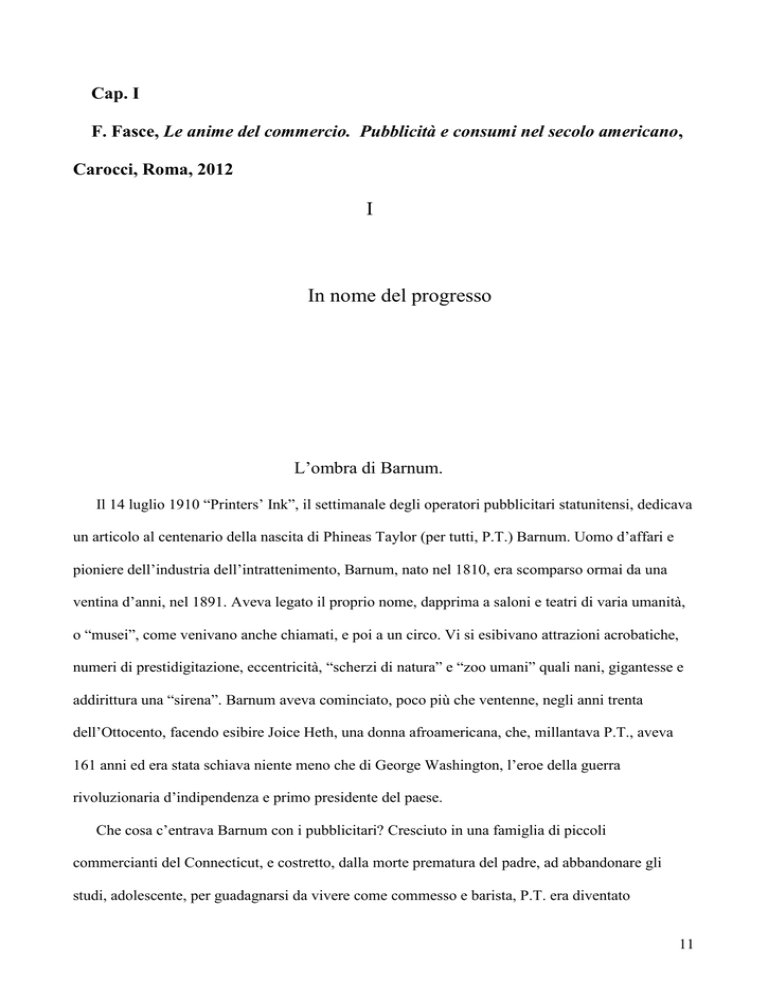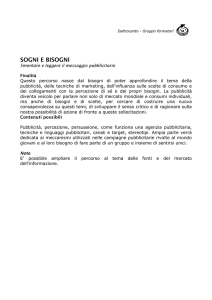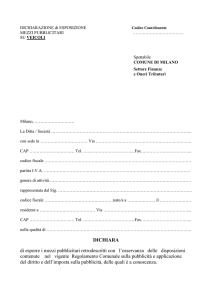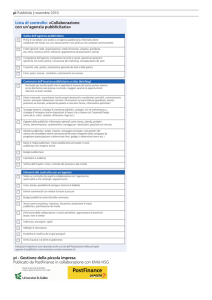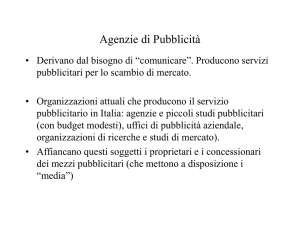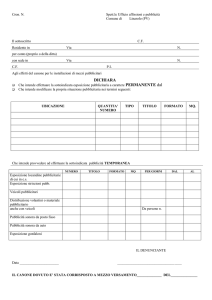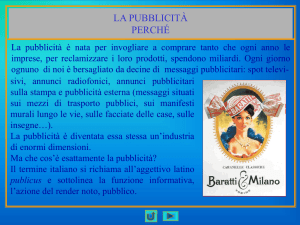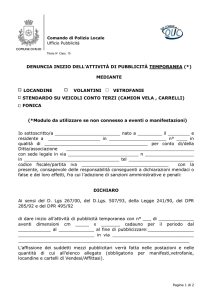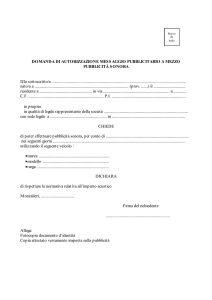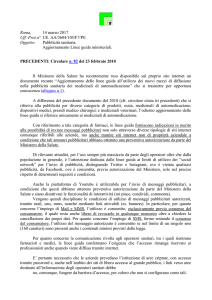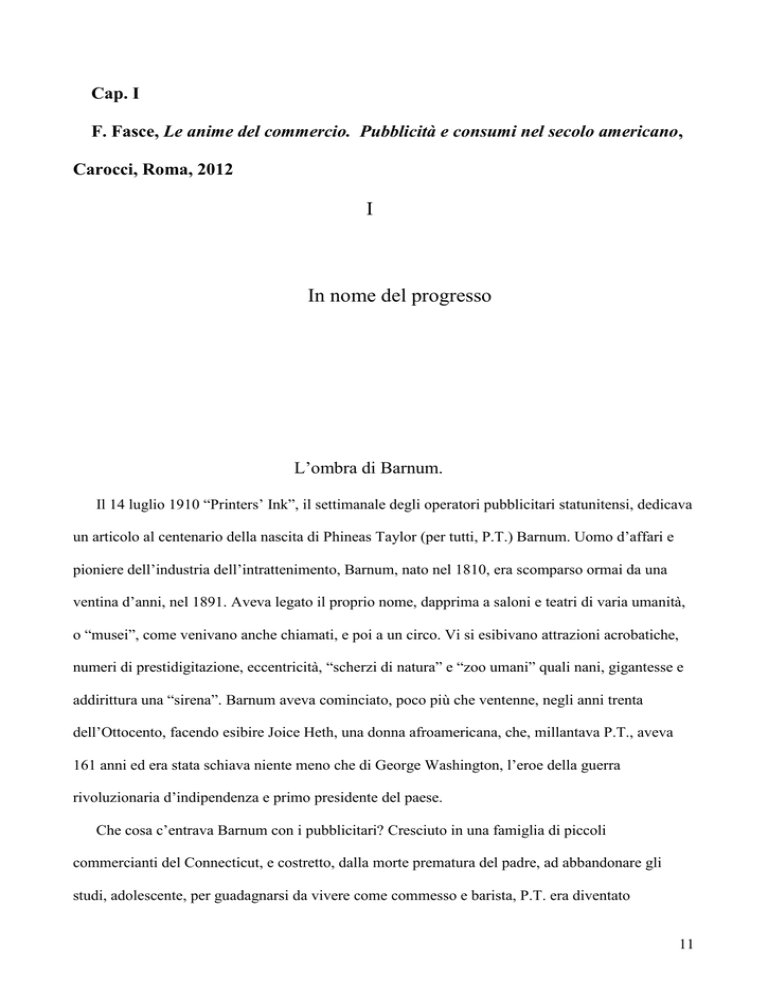
Cap. I
F. Fasce, Le anime del commercio. Pubblicità e consumi nel secolo americano,
Carocci, Roma, 2012
I
In nome del progresso
L’ombra di Barnum.
Il 14 luglio 1910 “Printers’ Ink”, il settimanale degli operatori pubblicitari statunitensi, dedicava
un articolo al centenario della nascita di Phineas Taylor (per tutti, P.T.) Barnum. Uomo d’affari e
pioniere dell’industria dell’intrattenimento, Barnum, nato nel 1810, era scomparso ormai da una
ventina d’anni, nel 1891. Aveva legato il proprio nome, dapprima a saloni e teatri di varia umanità,
o “musei”, come venivano anche chiamati, e poi a un circo. Vi si esibivano attrazioni acrobatiche,
numeri di prestidigitazione, eccentricità, “scherzi di natura” e “zoo umani” quali nani, gigantesse e
addirittura una “sirena”. Barnum aveva cominciato, poco più che ventenne, negli anni trenta
dell’Ottocento, facendo esibire Joice Heth, una donna afroamericana, che, millantava P.T., aveva
161 anni ed era stata schiava niente meno che di George Washington, l’eroe della guerra
rivoluzionaria d’indipendenza e primo presidente del paese.
Che cosa c’entrava Barnum con i pubblicitari? Cresciuto in una famiglia di piccoli
commercianti del Connecticut, e costretto, dalla morte prematura del padre, ad abbandonare gli
studi, adolescente, per guadagnarsi da vivere come commesso e barista, P.T. era diventato
11
pubblicitario improvvisandosi autore di manifesti e volantini promozionali per i negozi nei quali era
impiegato e poi per un emporio acquistato con i risparmi accumulati come lavoratore dipendente.
Di qui era passato a ricorrenti incursioni nel mondo dei teatri e dello spettacolo popolare. Finchè
questa era diventata la sua occupazione principale, a New York e soprattutto a Bridgeport, nel natio
Connecticut, che aveva assunto come base delle sue attività. Le locandine, i manifesti, le inserzioni
sui giornali, rutilanti di frasi a effetto e rime accattivanti, con cui aveva propagandato gli spettacoli
e le esibizioni, si erano rivelati un modo efficace di attirare l’attenzione dei passanti e portarli al
“museo” e al circo. E si erano conquistati una fama nazionale, diventando rapidamente sinonimo di
pubblicità negli Stati Uniti degli anni a cavallo della Guerra civile.
Alla vocazione commerciale e propagandistica, Barnum, infaticabile imbonitore, organizzatore
di incontri, coltivatore di relazioni, aveva unito un profondo zelo religioso e un vivo interesse verso
questioni come il suffragio femminile e la battaglia per la “temperanza” contro l’alcolismo. Questi
interessi, la naturale predisposizione a socializzare con chiunque e la popolarità acquisita con i
“musei” e i circhi gli avevano dischiuso le porte della politica cittadina e statale. Tanto da
catapultarlo, per un biennio (1875-76), sulla poltrona di sindaco (repubblicano) di Bridgeport, e poi
addirittura su quella di deputato al parlamento del Connecticut (1878-79). Alle soglie degli anni
ottanta solo una manciata di voti gli aveva sbarrato la strada del Senato federale a Washington
(Harris 1973).
Il successo presso i concittadini e l’apparente rispettabilità, che gli avevano consentito queste
sortite al vertice della vita pubblica, non avevano sopito tuttavia le frequenti polemiche suscitate
dalle sue attività commerciali e le accuse di truffa che spesso si erano levate contro i “musei” o
contro operazioni immobiliari e di ristrutturazione troppo disinvolte, nelle quali Barnum si era
impelagato per allargare o dotare di qualche speciale marchingegno, necessario ai numeri che
animavano le serate da lui organizzate, i teatri di sua proprietà. Del resto, come poteva reagire se
non gridando alla frode chi, pagati i venticinque centesimi del biglietto di ingresso, scopriva che,
guardata da vicino, la tanto decantata e apparentemente così fascinosa “sirena” altro non era che la
12
testa e il torso di una scimmia imbalsamata, impiantati sul corpo di un pesce? L’odor di frode e il
gusto dell’esagerazione e dell’eccesso, che avevano accompagnato come un leitmotif la carriera di
Barnum, erano al centro dell’articolo di “Printers’ Ink” del 1910. La rivista, è vero, riconosceva gli
indubbi successi commerciali del vulcanico tuttofare di Bridgeport e i suoi ripetuti tentativi di
scrollarsi di dosso la cattiva fama acquisita con la “sirena”, cambiando registro e promuovendo
artisti “veri”, di collaudata professionalità, come, ad esempio, la celebre cantante Jenny Lind. Ma
essa parlava di questo “pioniere” soprattutto per prenderne, in maniera netta, le distanze. Celebrarlo
acriticamente come un esempio di “abilità pubblicitaria senza fare alcune chiare distinzioni”, diceva
“Printers’ Ink”, era come “se i medici celebrassero un uomo-medicina del woo-doo”. Barnum,
concludeva la rivista, poteva risultare “interessante come punto di partenza di una professione”, ma
era “deplorevolmente volgare e fuorviante rispetto agli sviluppi moderni” della professione stessa. 1
L’articolo era anonimo. Non era difficile, però, riconoscervi argomentazioni comuni a tanti
pubblicitari impegnati all’epoca a provare che la loro era un’attività rigorosa e tecnicamente
accurata, lontana dalla dimensione carnevalesca e plebea dei venditori di intrugli e degli
organizzatori di spettacoli popolari non sempre rispettabili (Lears 1994). Questi pubblicitari, che
volevano essere riconosciuti come professionisti, alla stregua di avvocati o ingegneri, dirigevano o
lavoravano per le agenzie, il soggetto emerso già negli anni ottanta e novanta dell’Ottocento, per
poi affermarsi definitivamente nel nuovo secolo come il fulcro delle attività di promozione
commerciale. Un fulcro collocato al centro di un triangolo produttivo che comprendeva, da un lato,
gli inserzionisti, e dall’altro, i media. Ma quale era stata la pubblicità dalla quale l’anonimo autore
di “Printers’ Ink” voleva differenziarsi? E come vi erano emerse le agenzie?
L’attività pubblicitaria si perdeva nella notte dei tempi dell’età coloniale. Alcuni attribuiscono
alla “Pennsylvania Gazette” di Benjamin Franklin, fra molte innovazioni giornalistiche, assieme ai
titoli accattivanti degli articoli e alle prime illustrazioni, anche gli avvisi commerciali; avvisi
piazzati, in maniera strategica, a fianco delle informazioni vere e proprie e degli editoriali, ma a
lungo mescolati agli annunci giudiziari, senza tratti distintivi specifici di natura grafica e visiva. Né
13
la pubblicità era riuscita a sottrarsi a un legame, remunerativo e perciò duraturo, con quella tragedia
della schiavitù che aveva accompagnato tutta la storia delle colonie nordamericane inglesi, dalle
origini in poi. Nel Sette e Ottocento, fra i più rilevanti avvisi sui giornali e i più significativi
manifesti affissi nelle strade, a pagamento, per richiamare l’attenzione del pubblico su un prodotto o
un affare commerciale, vi erano spesso le segnalazioni delle aste di schiavi e soprattutto le
descrizioni degli schiavi fuggiaschi. Tali descrizioni erano accompagnate dal perentorio invito a
fornire ogni informazione su di loro atta a favorirne la cattura e la riconsegna ai legittimi
proprietari. Questi annunci erano ancora più che mai diffusi quando, negli anni cinquanta
dell’Ottocento, col progressivo avanzare della rivoluzione industriale e l’allargamento del volume
dei traffici reso possibile dall’avvento delle ferrovie, le comunicazioni commerciali a pagamento si
ritagliarono una spazio specifico, ospitato dai giornali in una sezione ora nettamente separata da
quella delle informazioni giudiziarie. Erano comunque, alla metà del secolo, ancora sporadiche, in
gran parte confinate a una singola colonna, con rare illustrazioni, o più spesso senza, così come
continuavano a mancare di caratteri tipografici di un qualche rilievo distintivo (Pope 2003).
In quegli stessi anni cinquanta, tuttavia, un protetto di Barnum, il tipografo-incisore Frank
Leslie, col suo “Frank Leslie’s Illustrated Newspaper”, avviò l’esperimento delle riviste illustrate,
sul modello della “London Illustrated News”. Esse incrementarono la presenza di immagini anche
negli annunci pubblicitari, peraltro sempre molto limitati. Grazie a questi annunci e soprattutto ad
altri strumenti, anch’essi di ispirazione europea, come il manifesto e l’affissione, a cavallo della
Guerra civile dunque la pubblicità aveva acquisita, non senza fatica, una dimensione autonoma,
nella congerie di segni che popolavano, con crescente intensità, l’orizzonte visuale delle masse
urbane. Ma dal punto di vista produttivo rimaneva un meccanismo composito e aggrovigliato. Lo
animavano attori profondamente diversi, distribuiti lungo un eterogeneo continuum di interessi,
competenze e rapporti reciproci di concorrenza e cooperazione. Sul lato di chi voleva propagandare
un prodotto o un servizio, si andava dai produttori di medicinali, un tipo di beni che rimase sino agli
anni settanta in testa alla classifica delle spese in pubblicità, alle aziende produttrici di cibi e
14
utensili, agli intrattenitori come Barnum, che, a loro volta, in certi casi, contribuivano direttamente,
con giornalisti, editori e tipografi, alla preparazione degli annunci o dei manifesti. Sul lato di chi
realizzava la pubblicità, troviamo giornalisti ed editori, che raccoglievano le richieste di inserzioni e
provvedevano a elaborarle sui loro fogli; e, ancora e soprattutto, i tipografi che, per conto terzi,
curavano e stampavano manifesti, volantini, cataloghi e cartoline promozionali, usando illustratori
professionisti, assunti a lavorare più o meno stabilmente nelle loro imprese in gran parte di natura
artigianale e locale (Brown 2002).
Non bisogna dimenticare, d’altra parte, il più ampio contesto che alimentava l’attività
pubblicitaria. Finito lo scontro fra Nord e Sud, si era messo in moto un tumultuoso processo di
trasformazione economica e sociale che, nell’arco di un quarto di secolo, avrebbe consegnato agli
estensori del Censimento del 1890 un paese profondamente mutato. Dalle loro schede emergeva un
paese industriale, nel quale, cioè, il settore manifatturiero superava quello agrario quale produttore
di ricchezza, con un incremento in capitale investito e salari nel solo decennio 1879-1889 del 133,8
%; speditamente incamminato sulla strada dell’urbanizzazione, con la quota di popolazione delle
città salita a oltre un terzo del totale; e che, almeno ufficialmente, dichiarava chiusa la frontiera
dell’Ovest, adombrando così i processi di tendenziale unificazione del mercato nazionale in corso
(Edwards 2006).
A mano a mano che procedeva l’età vittoriana, all’espansione produttiva faceva riscontro, grazie
alla rivoluzione dei trasporti che estendeva il bacino di utenza dei beni, la comparsa di nuove
istituzioni per l’esibizione e la distribuzione delle merci quali le esposizioni universali, che
arrivarono negli Stati Uniti per la prima volta in occasione del centenario del 1876, i grandi
magazzini e le catene di vendita per corrispondenza: istituzioni che prefiguravano, seppure in modo
ancora embrionale, il prendere corpo di una moderna società dei consumi. E’ vero che solo alcuni
strati sociali, raramente al di sotto dei ceti medi, e nelle città, potevano usufruire, con una certa
continuità, di beni per la casa e oggetti di vestiario resi accessibili alle loro tasche, relativamente
prospere, da una fase di sostenuta deflazione che riduceva i prezzi. Ma, se consideriamo che da 1/10
15
a un 1/5 della popolazione statunitense si inoltrava nella fantasmagoria di beni e colori di
esposizioni universali come quelle di Filadelfia del 1876 o di Chicago del 1893 e che a cavallo del
secolo i colletti bianchi costituivano una quota oscillante fra il 25 e il 40 % della popolazione in
centri come Boston, Filadelfia o San Francisco, si trattava comunque di un fenomeno di notevole
visibilità e portata, sul piano economico, non meno che valoriale (Blaszczyk 2009). Tant’è vero che
era accompagnato dai primi tentativi, di economisti e osservatori, di giustificarne l’utilità, in un
mondo abituato, sino ad allora, a esaltare soprattutto le virtù del lavoro o dell’intraprendenza
imprenditoriale, e perciò sospettoso nei confronti di un’attività come il consumo a lungo identificata
con il lusso e lo spreco e considerata appannaggio del genere femminile. Un’attività dunque, agli
occhi di taluni, dall’incerto statuto morale e civile, capace di corrompere le menti, fiaccare i corpi e
intaccare l’identità maschile, già gravemente insidiata, per giunta, dalla meccanizzazione, che
riduceva pericolosamente la “virile” autonomia produttiva di artigiani e operai qualificati, e dalle
ricorrenti ondate di mobilitazione femminile e suffragista (Horowitz 1985).
L’esplosione inarrestabile della carta stampata, favorita dalle nuove tecniche di raccolta e
trasmissione delle notizie per via telegrafica, ormai anche internazionale e transoceanica, e dai
sempre più avanzati strumenti tipografici e di riproduzione delle immagini, forniva il supporto
mediatico e un fattivo stimolo alla trasformazione in corso. Le pubblicazioni periodiche, i giornali, i
libri a basso costo costituivano il cardine di un mondo parallelo e sempre più sovrapposto e
intrecciato a quello delle relazioni primarie vis-a- vis. Col nuovo secolo, questo mondo si sarebbe
arricchito di mezzi rivoluzionari, a forte intensità tecnologica, come il telefono, il cinema, il
fonografo, il grammofono, il pieno dispiegamento dell’elettricità, che avrebbero ridefinito i termini
della vita individuale e delle relazioni sociali. Eppure, già le modificazioni indotte in un manufatto,
con una lunga storia alle spalle, come il libro dalle inaudite tirature dei romanzi popolari - venduti
adesso anche attraverso la grande catena di corrispondenza Sears & Roebuck - o la configurazione
di “vetrina sulla città” assunta da quotidiani commerciali di ampia diffusione e con sempre più
pagine - piene di cronaca rosa e nera, di rubriche di costume, di sport - delineavano il
16
cristallizzarsi di un enorme serbatoio di “piaceri dell’immaginazione” (Brewer 1997) non più
ristretti ai soli strati superiori. Ovvero, di emozioni, interessi, discorsi, passioni, comprati e venduti
sul mercato, che mettevano alla prova, inquietavano, stimolavano i sensi. Per poi scivolare nelle
conversazioni quotidiane e nella corrispondenza delle persone comuni, a mano che si ampliava il
perimetro dell’istruzione di base.
Senza mai perdere di vista l’obiettivo di colpire alle viscere l’uditorio, la letteratura popolare
aiutava la gente a dare voce alle sue sensazioni e costruiva forme di immaginario collettivo
condiviso che alimentavano tanto le relazioni a distanza, quanto quelle primarie, vissute nella
cerchia famigliare o amicale, o nelle occasioni di socializzazione, disciplinate da un biglietto di
ingresso, offerte dalle esibizioni dal vivo. In queste occasioni, operatori come Barnum riflettevano e
articolavano la transizione “dal carnevale allo spettacolo”, ovvero dalla cultura popolare delle fiere
di paese e di strada - con una magmatica confusione dei ruoli fra chi si esibiva e chi guardava e
una limitata circolazione di denaro - alla cultura commerciale della performance a pagamento, in
uno spazio pubblico privatizzato (Butsch 2008).
La propaganda, locale e nazionale, che accompagnava la performance, forniva una cornice
mediatica, più sofisticata e impersonale, a uno spettacolo che conservava tuttavia alcuni tratti tipici
del carnevalesco tradizionale, con dinamiche di circolazione e scambio comunicativo fra il palco e
la sala animatissime e aperte a improvvisi capovolgimenti di fronte fra le due parti. A un pubblico
eccitato e preoccupato dal recente inurbamento, dalla congestione demografica, dallo spaesamento
provato di fronte all’eterogeneità e alla velocità della vita quotidiana Barnum proponeva un
contatto, ravvicinato, ma al riparo del chiuso di un teatro, con il pericolo tenuto sotto controllo,
l’esoterico addomesticato, l’ignoto e il magico risolti in un sorriso. Ne nasceva una sfida sottile e
acuta con l’uditorio, intessuta di un incessante ammiccamento reciproco, di un inseguirsi degli
sguardi alla ricerca del trucco e dello stupore liberatorio, di un continuo innalzamento della posta
fra l’imbonitore e i suoi spettatori. Questi imparavano a gestire, nella forma trasfigurata e simbolica
del gioco di prestigio o della beffa della “sirena”, le insidie nascoste nell’anonimato urbano e nelle
17
tante opportunità che esso offriva alle truffe, non a caso segnalate in costante aumento nell’ultimo
terzo dell’Ottocento (Cook 2001).
Fra le truffe più comuni spiccavano quelle legate alla vendita “selvaggia” di pozioni e
medicinali. Erano beni promossi mediante inserzioni sui giornali o più spesso brevi pamphlet o
corrispondenza personalizzata, distribuita in maniera capillare anche nelle campagne e nei centri più
piccoli. Questi materiali erano dominati dalle dichiarazioni di testimonials, creatori dei farmaci o
utenti che vantavano le doti dei prodotti, asserendo di aver tratto esiti miracolosi dal loro uso. I
testimonials di medicinali scatenarono l’indignazione dello stesso Barnum, che ci teneva a
distinguere i suoi piccoli, “innocenti” trucchi da quelli “pericolosi” di chi giocava con la salute
altrui. Delle carte promozionali e dei campioni di medicine vere e presunte erano rigonfie le borse
dei commessi viaggiatori, che battevano in lungo e in largo la nazione, per accorciare le distanze tra
i produttori e i rivenditori, tra la macchina in espansione del sistema industriale e i piccoli e medi
centri dell’enorme provincia statunitense. Come testimoniavano i loro vestiti sgargianti e alla moda,
le maniere della grande città, lo scilinguagnolo e la battuta sempre pronta che sciorinavano con le
massaie o con i rivenditori al dettaglio, anche nel loro caso, come in quello di Barnum, la
performance, la showmanship personale si integrava con e faceva aggio sulla dimensione mediatica
(Friedman, 2004; Pettit 2009).
I commessi viaggiatori, la posta e i dettaglianti portavano nei luoghi più nascosti del paese e
invero, nel caso di prodotti di particolare successo all’estero come le macchine da cucire Singer, in
tutto il mondo (Domosh 2006), ciò che costituiva, in termini di volumi, l’essenza della pubblicità
nella seconda metà dell’Ottocento e che ci consente di individuare i soggetti che stavano al centro
della sua produzione. Fino agli anni settanta e ottanta i più diffusi strumenti pubblicitari statunitensi
non furono le inserzioni sui giornali, ma i volantini, le brochures, i cataloghi e soprattutto le stampe
e le cosiddette “trade cards”, cartoline o figurine commerciali, a colori, di dimensioni medie di
cinque centimetri per dieci, collezionabili. Erano prodotte in grandi quantità dai tipografi. Questi
acquistavano o commissionavano immagini standard (alquanto comuni erano ad esempio le
18
litografie con variazioni sul tema del West, che servivano sia ad alimentare il nascente turismo “di
frontiera”, favorito dallo sviluppo delle ferrovie e dal mito degli show di Buffalo Bill, sia a
pubblicizzare i prodotti più diversi). E le personalizzavano su richiesta di singoli imprenditori. I
quali, a loro volta, le fornivano ai rivenditori. Di qui le cartoline o le stampe finivano come regalo ai
clienti o ai loro bambini per assicurarsene la fedeltà (Walker Laird 1998).
La pubblicità più diffusa e consumata dalla gente nasceva dunque dalla collaborazione fra gli
imprenditori e i tipografi, i veri protagonisti della catena produttiva di promesse e allusioni rivolte,
attraverso il luccichio delle immagini policrome e floreali di impronta bell’epoque, ai consumatori.
Lo stretto contatto che tipografi e illustratori intrattenevano con i committenti trovava espressione
nel codice prevalente in queste immagini. Abbiamo parlato di stampe e cartoline con vedute più o
meno romanticizzate del West. Ma in realtà più spesso al centro delle immagini pubblicitarie c’era,
sottolinea Pamela Walker Laid, il binomio prodotto-imprenditore/produttore. Tipico il manifesto
che vediamo qui raffigurato, che riguarda un’impresa di organi e strumenti musicali del Vermont a
metà anni ottanta (fig. 1). L’enfasi, comune ad altri strumenti della comunicazione aziendale come
la carta intestata, è sugli stabilimenti, esibiti con l’orgoglio di un datore di lavoro che si identifica
prima di tutto come “classe produttiva”, secondo un costume diffuso all’epoca, date le dimensioni
ancora relativamente limitate delle aziende, i rapporti, di lunga consuetudine e interazione su base
personale fra i padroni e i dipendenti più qualificati e anziani, e l’origine non di rado artigianale e
tecnica degli imprenditori stessi.
Questi ultimi figurano, direttamente e indirettamente, nelle due immagini più piccole, che
incorniciano la parte inferiore della scena. Direttamente perché, sulla destra, sono raffigurati il
proprietario e i fondatori dell’impresa; indirettamente perché il salotto riprodotto a sinistra, per
mostrare gli effetti di socializzazione e incivilimento, indotti, nella vita quotidiana di una famiglia
borghese, dall’introduzione di un organo, è, con tutta probabilità, una proiezione della stessa
famiglia del proprietario. Che in questo modo si propone come esempio di identificazione
19
immediata per i suoi pari, oppure come oggetto di impulsi “aspirazionali” e imitativi, di crescita
sociale e di status, da parte di strati inferiori (Ibidem).
FIG. 1
Ecco che allora l’espressione di un osservatore dei primi anni settanta, secondo cui Barnum
aveva insegnato “un nuovo modo di leggere il mondo attraverso la pubblicità” (Blake 2006, p. 106),
suona oggi al tempo stesso veritiera e fuorviante. E’ veritiera perché nessuno poteva negare il ruolo
svolto dal grande intrattenitore nella creazione di slogan, nell’uso pionieristico dell’illuminazione a
sostegno della comunicazione pubblicitaria, nell’utilizzo di eventi e segmenti dello show business a
fini promozionali, o nell’invenzione di trovate destinate alla celebrità come, ad esempio, il cartello,
con su scritto “All’Egresso”, fatto apporre per far scorrere i visitatori attraverso le sale dei suoi
“musei”. Il cartello si rivelò provvidenziale perché, come Barnum aveva immaginato, la gente, non
sapendo che cosa significasse “Egresso”, e perciò attirata dall’insegna, la seguiva con l’ansia di
capire il prima possibile di che cosa si trattasse e, senza accorgersene, si trovava involontariamente,
con grande rapidità, all’uscita. E così, come auspicato da Barnum, liberava spazio. Ma concentrare
esclusivamente l’attenzione sull’imbonitore di Bridgeport impedisce di vedere sia l’azione, meno
appariscente, ma indubbiamente significativa, dei tipografi, che per molti versi detenevano la
chiave, tecnica e culturale, del mestiere pubblicitario, sia quella di altri attori che nel frattempo
cercavano di farsi largo sulla scena.
Fra questi c’era anche proprio l’osservatore che elogiava Barnum e che era fattivamente
impegnato all’epoca nella crescita del nuovo soggetto, le agenzie, destinate a imporsi come il
motore dell’intero sistema. Si chiamava George P. Rowell, veniva dall’editoria e si era formato in
una delle piccole agenzie create negli anni a cavallo della Guerra civile, a opera di ex giornalisti e
contabili o impiegati del mondo editoriale, col compito di gestire gli spazi pubblicitari sui giornali,
che in genere erano ancora poco interessati a perseguire in maniera sistematica questa fonte di
20
reddito e perciò erano favorevoli a lasciarne la gestione all’esterno. Gli agenti opzionavano gli spazi
sui giornali, mettendoli a disposizione degli inserzionisti. Questi preparavano gli annunci e li
pagavano direttamente ai fogli stessi, i quali lasciavano agli agenti una piccola percentuale sul costo
dell’inserzione. Non era un business particolarmente lucrativo perché, lo si è detto, con pochissime
eccezioni, gli avvisi sui giornali erano una parte molto limitata delle attività promozionali. I
contratti che vincolavano l’agente ai giornali non superavano di norma il 10 % di commissione e
per giunta erano fragili e oggetto di frequenti discussioni, anche con gli inserzionisti. Il lavoro
dell’agente era di contenuto tecnico e professionale decisamente inferiore a quello dei giornalisti o
dei tipografi, dati anche il raggio locale e le dimensioni ridotte del giro d’affari (Walker Laird
1998).
Rowell e altri tuttavia seppero cogliere l’occasione per ribaltare i rapporti di forza, con giornali e
stampatori. L’occasione si presentò a cavallo degli anni settanta e ottanta, quando alcune imprese
manifatturiere di beni di consumo a domanda anelastica come le saponette, i medicinali e i cibi in
scatola, con un potenziale produttivo su grandi volumi grazie alla recente messa a punto di
macchinari a ciclo continuo, si videro costrette, dalla concorrenza, a cercare elementi di
differenziazione del prodotto che consentissero loro di aumentare il fatturato, sfruttando appieno le
economie di scala. Lo fecero ricorrendo alla marca (brand), cioè sostituendo a prodotti venduti in
barili e contenitori generici, senza elementi identificativi, prodotti impacchettati e identificati da un
marchio depositato, protetto da norme affini a quelle che garantivano i brevetti. Ne nacque, da parte
loro, una domanda di servizi pubblicitari più specialistici di quelli di cui avevano usufruito sino a
quel momento. Servizi capaci di raggiungere, in tempi rapidi e su tutto il territorio nazionale, il
pubblico di ceto medio, con messaggi incisivi e immediati, risultato di un lavoro più sistematico e
organico di quello svolto dalla composita, e fortemente localistica, ragnatela di attori che abbiamo
esaminato (Strasser 1989).
Alcune agenzie ebbero l’intuizione di inserirsi nello spazio compreso fra questi imprenditori e i
consumatori. Ma per riuscirci dovettero modificare ruolo e attività, abbandonando il rapporto di
21
dipendenza economica dai giornali, per rivolgersi direttamente agli inserzionisti e proporre loro un
contratto che gradualmente arrivò a coprire la fornitura di un servizio completo. Gli agenti, cioè,
consegnavano alle imprese non più uno spazio opzionato sui giornali, ma un’inserzione, da loro
redatta e già piazzata su una determinata pubblicazione, in cambio di una commissione fissa, che si
convenne di stabilire nella misura standard del 15 % del budget preventivato per una data
campagna. Le agenzie contavano sul fatto che il variegato mondo della carta stampata era, a sua
volta, in ebollizione e andava scoprendo lo straordinario potenziale di reddito insito nella pubblicità.
A conferma del ruolo decisivo svolto dall’innovazione mediatica nell’evoluzione della pubblicità,
negli anni ottanta crescevano le riviste che curavano le vendite per corrispondenza e aumentava la
sensibilità dei quotidiani per gli annunci commerciali a pagamento. All’inizio del decennio
successivo, col sostegno delle stesse agenzie, che, forti dei contratti stipulati con gli inserzionisti, a
questo punto erano in grado di fornire anticipi a giovani editori e giornalisti intraprendenti, ma a
corto di fondi, apparvero riviste mensili a basso costo e altissima tiratura; riviste che puntavano,
oltre che sulle vendite, sulla pubblicità, come principale fonte di sostentamento. Con esse,
modellate sul “catalogo di vendita per corrispondenza […] la stampa si trasformò […] da semplice
strumento di produzione di massa a mezzo di comunicazione di massa” che contribuiva “a
incoraggiare […] le produzioni” e il consumo (Beniger 1995, p. 409).
Venduti a dieci-quindici centesimi, di contro ai trentacinque dei loro concorrenti, tali periodici,
come “McClure’s” o “Ladies’ Home Journal”, avrebbero conosciuto, negli anni a cavallo del
secolo, tirature vertiginose. Che surclassavano, col loro milione di copie, i record di 50.000 unità
della concorrenza di più vecchia tradizione. E rendevano questo medium particolarmente appetibile
agli inserzionisti. Nell’arco di un ventennio, fra il 1890 e il 1910, il cerchio di un nuovo assetto
della pubblicità - un assetto che esaltava il ruolo centrale delle agenzie, spostando il fuoco
comunicativo sul veicolo giornalistico, ridefinendo la funzione dei tipografi e al tempo stesso
aggirando i giornali presso gli inserzionisti - si era chiuso. Dalla semplice compravendita di spazi,
in genere remunerata poco e male dai giornali, le agenzie erano passate alla fornitura, direttamente
22
agli inserzionisti, di un prodotto finito, indirizzato primariamente a quotidiani e riviste (Schneirov
1994). Alla loro storia è dunque giunto il momento di volgere la nostra attenzione.
La sensualità del sapone.
Tre agenzie dominavano la scena nel primo decennio del Novecento: N.W. Ayer & Son, Lord &
Thomas (L&T) e J. Walter Thompson (JWT). Erano collocate nei tre principali centri industriali del
paese: la prima a Filadelfia, culla politica della nazione e sua più antica roccaforte manifatturiera,
solo dagli anni ottanta sopravanzata, per popolazione e fatturato industriale, da New York e
Chicago; la seconda, a Chicago, la metropoli del Middle-west, fresca della fama internazionale
acquisita con la recente Esposizione universale colombiana; l’ultima, a New York, ormai indiscussa
capitale della “modernità culturale” d’oltre Atlantico, grazie alla rigogliosa industria editoriale con
al centro il “New York Times”, e sede, già nel 1890, della maggioranza delle agenzie. Uno sguardo
al loro interno ci consente di vedere come funzionava la pubblicità nel nuovo secolo.
La prima agenzia per fatturato e importanza, la Ayer, era stata creata, alla fine degli anni
sessanta dell’Ottocento, da Francis Ayland Ayer, un fervente battista, insegnante di scuola
elementare. Il forte imprinting religioso del fondatore confermava l’intreccio, già intravisto con
Barnum, e che troveremo ancora nella comunicazione commerciale statunitense, fra il pulpito e il
mercato, gli strumenti di propagazione della fede, spesso tanto gridati ed emotivi, dell’uno, e quelli
di promozione di merci e idee, dell’altro. Partito come gestore di spazi pubblicitari su una decina di
quotidiani religiosi, Ayer era stato il primo a perfezionare il modello di contratto diretto con gli
inserzionisti. La materia, giuridica e commerciale, restava comunque di fatto alquanto intricata
perché non era stata ancora risolta la questione della possibilità per l’agenzia di lavorare
contemporaneamente per imprese tra loro concorrenti, né tanto meno quella della frequenza con la
quale gli inserzionisti potevano cambiare agenzia. A dimostrazione della natura sostanzialmente
asimmetrica, a vantaggio degli inserzionisti, del rapporto che questi ultimi instaurarono da subito, e
poi conservarono nel tempo, nei confronti delle agenzie, riguardo al primo nodo sarebbe invalsa la
23
prassi, tassativa, di incompatibilità di ingaggi, per le agenzie, da parte di aziende in concorrenza fra
loro. Mentre, sull’altro versante, per quanto potesse risultare loro costoso, le imprese di norma
avrebbero invece cambiato agente con relativa facilità, o avrebbero addirittura ingaggiato aziende
pubblicitarie diverse, a seconda delle sedi e dei mercati (Pope 1983).
A complicare ulteriormente la vita delle agenzie c’era poi una ristrettissima, ma agguerrita,
minoranza di operatori, in genere proprietari-imprenditori, quali la produttrice di saponette Procter
& Gamble (P&G), particolarmente interessati a investire in pubblicità e dotati di quella che Barnum
aveva definito vocazione per la showmanship, che avevano deciso di far da sé, dotandosi di
un’agenzia interna. Per scongiurare il diffondersi di questa tendenza o scoraggiare il passaggio di
clienti alla concorrenza, Ayer aveva nel frattempo allargato la gamma dei propri servizi,
avventurandosi sul terreno, fino a quel momento del tutto inesplorato, di prime rudimentali indagini
di mercato. Lo aveva fatto già alla fine degli anni settanta, per conto di un produttore di trebbiatrici.
Con i suoi collaboratori, Ayer aveva compulsato le più diverse pubblicazioni, governative e private,
alla ricerca delle aree con una potenziale domanda di trebbiatrici e dei periodici più letti dai
coltivatori diretti, su cui piazzare le inserzioni, spedendo poi telegrammi a funzionari degli stati ed
editori ai quattro angoli del paese, per chiedere dati ulteriori con cui integrare le informazioni. In
soli tre giorni ne aveva tratto un voluminoso rapporto, per ottenere il quale l’imprenditore, sorpreso
dall’efficienza dell’agenzia, aveva sottoscritto un cospicuo contratto.
Nei primi anni novanta Ayer si era inoltre dotato di un copywriter, o copy, come fu presto
chiamato, per l’elaborazione dell’idea-guida e del testo dei messaggi; un servizio, questo, poi
allargato e trasformato in un reparto detto editorial department. Per il momento, la parte artisticoillustrativa veniva ancora affidata all’esterno. Seguendo l’esempio dell’agenzia Bates, che lo aveva
aperto già nel 1892, di lì a poco anche Ayer costituì un art department, piccolo come in genere
erano queste strutture, in una fase nella quale la redazione dei testi occupava l’attenzione principale
dei pubblicitari. Ma il contributo più significativo di Ayer, e il segreto del suo successo, oltre a
quello della formula del contratto a commissione con gli inserzionisti, riguardò il cosiddetto
24
planning. L’agenzia fu la prima, non solo a garantire agli inserzionisti, in virtù del proprio volume
di affari, tariffe inferiori a quelle che avrebbero ottenuto se si fossero presentati direttamente, su
base individuale, ai giornali. Fatto non meno importante, essa mostrò come si potessero coordinare
tutti i passaggi della delicata relazione triangolare con il cliente, da un lato, e i media, dall’altro.
Gestì, cioè, le prime vere e proprie “campagne”, come furono chiamate le iniziative di pubblicità
ripetute per un certo periodo e articolate su più media, con una traslazione sul terreno commerciale
di un linguaggio di origine militare, già preso a prestito da tempo dall’organizzazione elettorale
partitica (Hower 1939).
Invero, sin dagli anni ottanta e novanta imprenditori orientati al fai da te quali la P&G di Harley
Procter (Schisgall 1981), cresciuto come responsabile vendite dell’impresa di famiglia, avevano
dato prova di notevole capacità di promuovere le loro saponette, puntando su nomi seducenti come
“Ivory”, suggerito a Procter da un sermone domenicale dedicato alle “torri d’avorio”, o slogan come
il celebre “Galleggia!”, col sostegno di annunci illustrati a tutta pagina. 2 Tuttavia le loro iniziative
impallidivano di fronte all’ampiezza e all’organicità della campagna che Ayer progettò per la
Nabisco, in occasione del lancio, a fine secolo, di Uneeda Biscuit, un nuovo tipo di cracker. Colosso
corporate del settore, cioè grande impresa strutturata secondo la formula della società per azioni,
emersa nel 1898, nella fase di più intensa concentrazione aziendale della storia del paese, Nabisco
aveva adottato come politica la rinuncia alla concorrenza sul prezzo, a favore di una strategia
giocata sull’efficienza interna e soprattutto sull’affermazione della marca. Di qui l’investimento
massiccio in pubblicità, che si concretò in un intenso lavoro comune fra i vertici dell’azienda e
Ayer, scelta da Nabisco per la fama di cui già da tempo godeva. Lavorando, per mesi, a stretto
contatto di gomito con Adolphus Green, l’amministratore delegato del colosso alimentare, Henry
McKinney, che Ayer aveva associato a sé alla guida dell’agenzia, contribuì all’individuazione del
nome del prodotto, all’elaborazione della confezione e alla progettazione e realizzazione di un piano
integrato che prevedeva la diffusione di annunci, forniti per intero dall’agenzia, sui quotidiani, nei
negozi e nei cartelloni distribuiti per le città. Comparsi all’inizio degli anni novanta, i cartelloni
25
erano un medium di particolare interesse, destinato a soppiantare rapidamente i più tradizionali
manifesti di derivazione europea perché, con le loro dimensioni e la loro visibilità, meglio si
attagliavano agli spazi urbani e a quelli delle periferie, delle campagne e delle enormi aree ancora
largamente incontaminate, ma che ben presto le auto avrebbero raggiunto, dell’Ovest (Baker L. E.
2007).
La campagna dunque metteva insieme per la prima volta in maniera organica un soggetto
corporate, impersonale e a direzione manageriale, lanciato alla conquista dei mercati, l’universo
emergente delle agenzie in cerca di affari e di legittimazione commerciale e sociale e quello in
trasformazione dei media. L’immagine che le dava il tono era quella di un bambino, equipaggiato
con una cerata antipioggia nuova di zecca, che ne denunciava l’estrazione middle class, con in
mano ben stretta una scatola di crackers. La scomparsa dall’orizzonte visivo del produttore, un
fenomeno ormai sempre più frequente nelle illustrazioni pubblicitarie, rifletteva la natura corporate
del committente, non più identificabile con un proprietario singolo, e la preoccupazione
dell’agenzia e dell’inserzionista di trovare elementi di maggior attrattiva, più vicini alla mentalità
del consumatore, rispetto alla prosaica dimensione manifatturiera. Tanto più che il design delle
nuove, enormi fabbriche in corso di costruzione negli anni a cavallo del secolo era improntato a
criteri di stretta efficienza e sobrietà, che rendevano gli stabilimenti meno individuati e “citabili”,
dal punto di vista figurativo, di certi loro predecessori ottocenteschi. Inoltre, la questione sociale
cominciava a indirizzarsi anche verso il problema del rapporto fabbrica-ambiente, contribuendo a
“spoeticizzare” la fisionomia delle unità produttive nell’immaginario collettivo e dunque a renderle
meno adatte all’uso promozionale. L’attenzione al consumatore e l’intenzione evocativa del
messaggio erano ribadite dal nome stesso del prodotto e dal testo di accompagnamento. L’uno non
recava alcun riferimento al produttore o alle caratteristiche della merce, ma, pronunciato “Youneed-a” (ne hai bisogno), suggeriva un inscindibile legame di affezione e dipendenza nei confronti
del cracker. L’altro si componeva di una sequenza di formule criptiche e interrogative, che si
susseguirono per alcuni giorni sui quotidiani, con l’obiettivo di suscitare la curiosità dei lettori,
26
partendo dalla semplice enunciazione “Uneeda Biscuit” e proseguendo con la domanda
“CONOSCETE Uneeda Biscuit?” (Walker Laird 1998).
“CONOSCETE Uneeda Biscuit?” divenne il biglietto da visita di Ayer, che lo usò ampiamente
in inserzioni di autopromozione su riviste di grande tiratura come “McClure’s”. Il successo
conseguito con Nabisco sancì il primato dell’agenzia, che già nel 1900 vantava un milione e mezzo
di dollari di giro d’affari annuo, oltre 58.000 dollari di utili e un organico di 163 dipendenti. A
questo punto Ayer poteva permettersi di rifiutare contratti, come i liquori o i medicinali poco
raccomandabili, da lui considerati “imbarazzanti” dal punto di vista etico. Anzi, per far fronte alla
domanda, nell’arco di nemmeno un decennio, dovette aprire filiali a New York, Boston e Chicago.
Ciò pareva confermare quello che T. A. DeWeese, un autorevole esponente del settore, responsabile
dell’ufficio pubblicità di un’azienda alimentare, scriveva nel 1906, ovvero che le agenzie si
potevano considerare ormai un elemento stabile della vita economica del paese. Nemmeno questo
osservatore, tuttavia, si nascondeva i problemi nei quali comunque esse si dibattevano, visto che,
diceva, “alcuni industriali e mercanti”, inclusi i suoi datori di lavoro, continuavano a fare pubblicità
“come se le agenzie non esistessero” (in effetti all’epoca il singolo budget pubblicitario annuale più
elevato non stava nel portafoglio di alcuna agenzia, ma piuttosto nel bilancio di un imprenditore faida-te, il geniale George Eastman, l’uomo della Kodak e dello slogan, autoctono, volto a “creare un
nuovo tipo di bisogno per la fotografia”, “Voi premete il bottone, noi facciamo il resto”) (Deweese
1906). Soprattutto, le agenzie erano strette fra i giornali, con cui intrattenevano rapporti
inevitabilmente complicati, di convergenza nel comune interesse di far funzionare il fruttuoso
sistema delle inserzioni, ma anche di contrasto, fisiologico, sulle tariffe e sulle modalità di uso degli
spazi; e gli imprenditori, che le guardavano non senza sospetto e scetticismo, date la difficoltà
cronica di quantificare l’esito, e dunque la remunerazione, delle loro prestazioni, e la natura delle
loro competenze, all’apparenza impalpabili e così poco “virili”, rispetto alla materia contabile o
ingegneristica, di più “rude” e immediata evidenza, che dominava i bilanci e le procedure delle
aziende. Per non parlare dell’insidia costituita da quegli opinionisti e reporter la cui penna stava
27
trasformando alcune dei magazines più in vista come “McClure’s” in organi di denuncia contro la
corruzione imperversante nelle città, le frodi e i soprusi dei trust. Essi minacciavano di coinvolgere
nei loro attacchi anche i pubblicitari, vista la contiguità di questi ultimi, per motivi di lavoro, con il
tanto chiacchierato settore dei medicinali e con le corporations (Applegate 1998).
Questi giornalisti “d’assalto”, o muckrakers (mestatori di letame), come li definì nel 1906 in
tono dispregiativo il presidente repubblicano Theodore Roosevelt, erano parte di un variegato
movimento riformatore attivo, nella società civile delle città, in uno spazio trasversale ai due partiti
maggiori, democratico e repubblicano. Ne faceva parte, nella corrente maggioritaria più moderata,
preoccupata prima di tutto della stabilità sociale, lo stesso Roosevelt. Lo componevano i nuovi ceti
medi dipendenti in espansione, quali ingegneri, assistenti sociali, insegnanti e docenti universitari.
Essi si mobilitavano per il riconoscimento della expertise tecnica e la sua applicazione ai problemi
della vita associata, candidandosi, in nome di questi principi, al governo di una cosa pubblica di cui
reclamavano una più incisiva e strutturata presenza per affrontare il degrado delle città, la
regolazione dei trust, la questione sociale e la tutela dei consumatori (Flanagan 2006). Questi
intellettuali e professionisti riformatori si autodefinivano progressisti, intendendo per “progresso” la
modernità, la tecnica e una certa dose di giustizia sociale, da realizzare mettendo in pratica i precetti
evangelici e ingaggiando una spietata lotta agli sprechi. Tra i loro obiettivi spiccava la difesa dei
consumatori e soprattutto delle consumatrici. Organizzazioni progressiste come la National
Consumers League (NCL), fondate e guidate da assistenti sociali e militanti suffragiste, di ceto
medio, con l’aiuto di giuristi e consulenti del lavoro, puntavano contemporaneamente a educare le
consumatrici a comprare in maniera etica ed efficiente e a tutelare le condizioni di lavoro delle
operaie. Mediante ampie campagne di informazione cercavano di persuadere le prime ad acquistare
prodotti di imprese che si impegnavano a rispettare i loro dipendenti con condizioni decorose di
paga e ambiente lavorativo. Al tempo stesso facevano pressioni sui governi dei singoli stati perché
approvassero norme di tutela delle lavoratrici e le imponessero agli imprenditori. Al pari degli altri
progressisti, la NCL brandiva dunque come cruciale la bandiera della publicity nel senso,
28
illuministico, di “pubblicizzazione”, svelamento, trasparenza, informazione, nella convinzione che
per “ correggere le cose che non vanno (…) bisogna solo mostrarle in modo che tutti possano
vedere e capire” (Wiebe 1995, p. 277).
Alcuni pubblicitari risposero alla sfida, rivendicando il loro buon diritto a essere considerati
anch’essi professionisti ed esperti. Anche loro, dicevano, incarnavano il “progresso” e i valori della
modernità, intesa anzitutto come sviluppo tecnologico ed economico. Anche loro parlavano di
publicity, di trasparenza e informazione. Combinavano questa retorica con sforzi di autocontrollo,
all’interno della professione, sull’attendibilità dei messaggi, per garantirsi rispettabilità. Questo
impulso rafforzava ulteriormente il ruolo del copy e dei testi, con messaggi volti a presentare la
“ragione per cui” (reason-why) un prodotto andava preferito a un altro. Col procedere del nuovo
secolo, reason-why divenne una formula diffusa e popolare tra i pubblicitari, trovando in Claude
Hopkins, un copy che lavorava per la Lord &Thomas (L&T) di Chicago, il suo più strenuo
difensore.
L&T era stata fondata nei primi anni ottanta da D. M. Lord e Ambrose Thomas, due abili
opzionatori di spazi pubblicitari. Dovette attendere, però, l’inizio del nuovo secolo per decollare,
grazie ad Albert Lasker, un suo giovane e intraprendente impiegato, che presto ne divenne partner e
poi addirittura proprietario, pur senza mettere mai il nome in ditta. Figlio di un ricco uomo d’affari
e banchiere ebreo di origine tedesca, Lasker era stato assunto con la raccomandazione del padre,
amico di Lord. In poco tempo, superando le resistenze dei fondatori ad allargare lo spettro di azione
dell’agenzia al di là della compravendita di spazi, si guadagnò i galloni sul campo, come
procacciatore di affari e manager (ovvero account, come veniva e ancora oggi è chiamato chi cura i
rapporti con i clienti), particolarmente versato nell’ingrossare il portafoglio ordini dell’azienda e
nello scovare copy capaci di soddisfare le attese del cliente. Cominciò con il canadese John
Kennedy, un’ex giubba rossa con esperienze di redazione di annunci per un’impresa di medicinali.
Kennedy per primo caldeggiò l’abbandono della sloganistica gridata alla Barnum, a vantaggio di
una comunicazione nella quale lo slogan doveva riassumere una “ragione”, basata sui meriti e sugli
29
effetti dei prodotti, per cui il consumatore avrebbe dovuto acquistarli. Per conto di un produttore di
lavatrici, Kennedy studiò l’inserzione, dai toni “negativi”, di un’impresa concorrente, che, sullo
slogan “Sei incatenata al mastello del bucato?”, mostrava l’immagine di una donna, affaticata e
visibilmente indispettita, letteralmente incatenata alla tinozza. E la rovesciò nel messaggio positivo,
di “liberazione” della donna dalla schiavitù domestica, “Lasciate che questa macchina faccia
liberamente il suo lavoro”. Uno slogan sovrastato dall’illustrazione di una signora di ceto medio,
elegante e composta, còlta mentre, comodamente seduta, osservava la macchina eseguire il lavoro al
suo posto. Lo integrava un fitto testo, che spiegava in dettaglio le caratteristiche strutturali e di
funzionamento della macchina.
Stando a Lasker, le vendite triplicarono, inducendolo ad aumentare sino alla ragguardevole cifra
di 75.000 dollari annui la paga del copy. Purtroppo, però, la “genialità” di Kennedy, magnificato da
Lasker come “il magico ingrediente che distingue L&T dalla agenzie minori”, si accompagnava alla
sregolatezza e a un’inguaribile instabilità emotiva, che costrinsero il manager a liberarsene,
sostituendolo con Claude C. Hopkins. Figlio del proprietario di un quotidiano di provincia,
cresciuto dalla gavetta, nella piccola azienda paterna, come “sollecitatore di pubblicità” presso le
imprese e distributore di volantini, Hopkins aveva una conoscenza diretta dei gusti del pubblico. E
avrebbe fatto della ricerca inesausta di informazioni sui mercati, mediante la distribuzione ai
consumatori di campioni di merci, accompagnati da schede da restituire compilate, uno dei tratti
distintivi del proprio lavoro. Altri elementi per i quali è unanimemente considerato un padre
fondatore della professione sono la consuetudine a familiarizzarsi il più possibile con i prodotti e le
tecniche di produzione, attraverso visite agli stabilimenti, e l’adozione di una prospettiva integrata
dei vari elementi dell’azione pubblicitaria; una prospettiva di “sistema”, come egli diceva,
prendendo a prestito l’espressione dagli ingegneri e tecnici aziendali impegnati nella
razionalizzazione tayloristica delle imprese (Cruikshank and Schultz 2010)
Una delle sue prime campagne fu svolta, nel 1908, per la neonata impresa d’auto ChalmersDetroit, un’azienda di piccola scala, tipica del settore in un’epoca in cui la “rivoluzione” fordista del
30
modello unico, costruito in serie, era ancora agli albori e solo l’1% dei nuclei famigliari possedeva
un’auto. Per Chalmers-Detroit, Hopkins virò la secca logica reason-why di Kennedy in una
direzione ancora più “testuale” e al tempo stesso più articolata, come imponeva la peculiarità
dell’oggetto e del tipo di acquisto, tra i più impegnativi e sofisticati per i consumatori dell'epoca.
Anche qui il testo la faceva da padrone, soverchiando, con le sue ottocento parole, una piccola
illustrazione del veicolo, che occupava per intero la parte iconografica, senza presenze umane,
tipiche invece della pubblicità ottocentesca, usate da Kennedy e che invero lo stesso Hopkins, in
altre occasioni, avrebbe utilizzato, soprattutto come parte del logo. In ossequio ai dettami del
“ragion per cui” vi predominava una rassegna accurata dei componenti, con tanto di prezzo dei
singoli pezzi, e delle performance del prodotto, la cui complessità tecnica spiegava il numero
eccezionale di parole, oltre il triplo di quelle che Hopkins adoperava, ad esempio, per promuovere
una marca di birra. Dove Hopkins si staccava maggiormente da Kennedy era nell’intestazione ad
effetto (“Un’auto strabiliante per 1500 dollari”), nel contrasto insistito fra la gamma “esclusiva”
dell’auto e il suo costo (“un modello da milionari reso accessibile, dati i volumi produttivi, a
molti”), nell’invito ad affrettarsi a comprarla, perché l’impresa aveva sottoscritto ordini di materie
prime e semilavorati per soli duemilacinquecento esemplari. Vi risuonavano lo sforzo di cogliere e
forgiare i “desideri” dei consumatori, come li chiamava Hopkins, e la sensibilità per lo status, per
quella “cultura delle celebrità” e del bel mondo, che, attraverso i giornali illustrati, forniva al
pubblico modelli di identificazione “aspirazionale” (Schorman 2010).
Un più esplicito richiamo allo status troviamo nell’inserzione, coeva, di un altro produttore
d’auto, che mostra come, per quanto popolare, il “ragion per cui” non fosse comunque il solo modo
di intendere la pubblicità. In esplicita contrapposizione ad esso, un’altra impresa, la Pierce-Arrow,
si affidava a messaggi nei quali la componente artistico-illustrativa era assolutamente predominante.
L’auto vi era raffigurata su sfondi di quotidianità metropolitana di stampo upper class, come
l’ingresso di un teatro alla moda, o neoclassicheggianti e dotati di un’aura pubblica legittimante,
come la Casa Bianca. La accompagnava, la semplice, ma graficamente rilevata, indicazione del
31
nome dell’impresa, senza alcuna parola di commento. Queste inserzioni erano opera di una piccola,
apprezzata, agenzia, la Calkins & Holden di New York, guidata da Earnest Elmo Calkins.
Anch’egli, come Hopkins, in origine copy, proveniente dalla provincia del Middle-west e altrettanto
convinto assertore del carattere “professionale” del suo lavoro, da “assimilare a quello di un
avvocato, un dottore, o un architetto”, Calkins aveva però presto sviluppato un orientamento
profondamente diverso, di natura prevalentemente visuale. Nella sua agenzia trovavano espressione
gli sforzi di illustratori e pittori di ritagliarsi uno spazio nella prorompente industria culturale
newyorkese, inclusa quella pubblicitaria, senza compromettere troppo la propria integrità artistica e
bohemien, intrisa di frequentazioni e scambi con il Vecchio mondo. Il suo approccio rientrava in
quella che all’epoca fu chiamata pubblicità “atmosferica” perchè il prodotto vi era definito, anziché
dalla caratteristiche tecniche, dall’atmosfera sociale e culturale nella quale era presentato, da un
ambiente, un modello di esperienze e sensazioni associate a quell’ambiente e alle persone che lo
animavano. La pubblicità “atmosferica” era influenzata da psicologi come Walter Drill Scott, che
proprio in quegli anni aveva avviato una riflessione sull’importanza delle scelte razionali e
soprattutto degli “istinti” nel comportamento umano, inclusa la sfera del consumo (Schorman
2010).
Per quanto i sostenitori del “ragion per cui” e gli “atmosferici” si scontrassero, anche
aspramente, sulle riviste e nei dibattiti pubblici, nei fatti spesso l’advertising del primo decennio del
Novecento era un ibrido di pratiche attinte ai due campi (McFall 2004), anche se il reason why,
nelle forme rielaborate da Hopkins, prevaleva. Il conflitto ideologico e l’ibridazione nella prassi fra
le due tendenze sono comunque significativi perché mostrano come la pubblicità fosse al centro
delle contraddizioni e dei paradossi che agitavano la società e l’universo comunicativo, con il
crescere dell’interazione affidata a media quali il telefono, il successo di riviste sempre più ricche di
illustrazioni, il definitivo diffondersi della fotografia, grazie alle portatili Kodak, e l’avvento del
cinema (West 2000). Il nuovo regime di visibilità, esposizione allo sguardo pubblico, curiosità
diffusa e “volontà di sapere”, che ne derivava, pareva realizzare finalmente il vecchio sogno
32
illuminista della trasparenza assoluta, di un mondo di specchi in cui tutto e tutti erano chiari a se
stessi e agli altri. Di qui veniva la grande fortuna, presso i progressisti e nel discorso comune, della
formula della publicity, nel senso di diventare e rendere pubblici, esporsi al giudizio collettivo,
esaltare il ruolo di un’opinione pubblica informata e responsabile come base del governo. E di qui
veniva, anche, la risposta dei pubblicitari del reason-why. Tuttavia, lo stesso processo di
riorganizzazione del visibile, che dischiudeva gli orizzonti della trasparenza, agiva anche in
direzione opposta, aprendo inedite possibilità di contaminazione e confusione tra finzione e vita
quotidiana, razionale ed emotivo, magico e realistico, persuasione e manipolazione. Tali possibilità
alimentavano l’enfasi dei Calkins su “atmosfere” e “suggestioni”, instillando, però, come si è visto
in Hopkins, anche nell’universo dei fautori della “ragione per cui” la forza di un magma di impulsi
difficilmente riducibili a una formula razionale univoca (Strasser 2008).
Né evidentemente la questione di come muoversi e produrre senso, nell’intreccio fra
argomentazione e suggestione, ragione ed emotività, publicity e advertising, che materiava il
discorso pubblico, era confinata ai pubblicitari. I contorni ambigui e sfuggenti, ricchi di opportunità
e di insidie, di una sfera pubblica influenzata ogni giorno di più dalla dimensione di mercato
investivano in vario modo tutti. Lo provavano quelle progressiste suffragiste che non disdegnavano
l’uso di tecniche prese a prestito dalla promozione commerciale per la loro propaganda. Lo provava
lo stesso presidente Roosevelt, pronto a tuonare contro il “sensazionalismo” dei giornalisti
“d’assalto”, ma altrettanto pronto a mettersi in posa come un divo o ad adottare, durante le
campagne elettorali, trovate a forte gradazione emotiva ispirate all’advertising. Lo provava
soprattutto il fatto che proprio in questi anni si sentisse il bisogno di nuovi termini per indicare il sé
e le sue modalità di formazione. La costruzione dell’identità individuale, notavano i contemporanei,
non passava più solo, come era accaduto nell’età vittoriana, per il silenzio e il chiuso delle
coscienze che formavano il “carattere”. Ora essa si affidava piuttosto alla fascinazione per le
immagini, alle occasioni di identificazione e proiezione offerte dalle riviste ricche di disegni e foto
o dalla “privacy in pubblico” del buio delle sale cinematografiche, al consumo di beni ed emozioni
33
nella società del mercato allargato e delle apparenze: a tutto ciò insomma che modellava quella che
sempre più spesso, con l’avanzare del nuovo secolo, manuali di etichetta e tomi di psicologia
definirono “personalità”, ovvero qualcosa di più scintillante e colorato, ma anche più volatile e
instabile, più variegato e opaco, del “carattere” ottocentesco (Susman 1984).
“Personalizzare” i prodotti per far breccia nelle “personalità” dei consumatori e neutralizzare
l’impersonalità delle grandi imprese, mediante l’adozione di toni e forme di interpellazione diretta,
che suggerivano vicinanza e intimità, o l’uso di testimonial o di figure di finzione, destinate a
diventare familiari, nel logo, per “creare una persona al posto della lontana corporation” (Ohman
1996, p. 191), divenne un articolo di fede tanto per i fautori del “ragion per cui” quanto per gli
“atmosferici”. Per questo Hopkins sosteneva la necessità che “gli annunci contenessero degli
individui [di finzione] riconoscibili, perché erano loro che vendevano i prodotti, non l’impresa
senz’anima” (Schwarzkopf 2009, p. 19). I messaggi avrebbero “aiutato” i consumatori - in genere
immaginati dai pubblicitari come socialmente simili a loro, cioè di ceto medio e anche superiore,
ma culturalmente meno smaliziati, bisognosi di guida e malleabili - a districarsi nel dedalo dei
grandi magazzini. E a scegliere il marchio più “adatto” e a restargli fedele. Così gli “alimenti
Mellin” promettevano di “far andare d’accordo il vostro bambino con il latte”, o il “rasoio Gillette”
assicurava di costituire, per il consumatore, “non (…) un semplice strumento”, ma “un servizio
pubblico con una personalità dietro di esso” (Strasser 1989, p. 97).
Nei primi anni dieci un contributo di rilievo alla “personalizzazione” delle merci agli occhi dei
consumatori e un impulso a uno stile a metà fra “ragion per cui” e “atmosferico”, che i
contemporanei definivano “descrittivo” (Hotchkiss 1924), fu fornito dall’agenzia che all’epoca
poteva vantare la più lunga anzianità di servizio, la JWT. L’agenzia era nata durante la Guerra
civile, col nome dei fondatori, Carlton & Smith. Aveva cambiato ragione sociale quando, nel 1878,
l’aveva acquistata, dopo averci lavorato per un decennio come contabile, un veterano dei marines, J.
Walter Thompson. Questi la fece prosperare, negli anni ottanta, specializzandola, per prima, nella
raccolta e gestione delle inserzioni per le riviste. Troppo legato alla vecchia scuola della
34
compravendita degli spazi, Thompson non seppe tuttavia tenere il passo con Ayer rispetto alla
capacità di allargare la filiera produttiva con servizi integrati efficaci. Nonostante l’assunzione di un
copy e di un artista-disegnatore, l’attività di consulenza agli inserzionisti sui contenuti degli annunci
rimase un aspetto secondario, che Thompson affrontava con riluttanza, rispetto al business
prevalente di opzionare colonne sui periodici. Un business che, però, col passare del tempo, fu
insidiato con successo da Ayer, che dai quotidiani, suo feudo originario, cercava di sfondare sulle
riviste e proponeva con determinazione agli inserzionisti campagne “chiavi in mano” come quella
per Nabisco.
Le cose cominciarono a cambiare per JWT nel 1908, con l’assunzione, per aprire una filiale a
Cincinnati, di Stanley Resor, un giovane e brillante laureato in storia ed economia a Yale. Era stato
scelto perché conosceva quella città, essendoci cresciuto e avendo poi lavorato nella principale
impresa locale, P&G, come venditore nell’agenzia interna di pubblicità. Il suo successivo
trasferimento alla sede centrale JWT di New York, dopo che si era segnalato per il fattivo lavoro
svolto a Cincinnati, contribuì in modo decisivo a rivitalizzare la vecchia agenzia. Resor introdusse
nel mondo dell’advertising una nuova figura di tecnico-manager, colto e di formazione
universitaria. Allievo e seguace del celebre sociologo social darwinista e conservatore William
Graham Sumner, tradusse lo spirito elitario e disilluso rispetto agli “istinti” umani del maestro in un
incessante impulso “pedagogico” verso i consumatori. Con lui, JWT cominciò a sperimentare, con
crescente successo, ma non senza contrasti fra l’anziano proprietario-presidente e il suo giovane
manager, assurto nel 1912 alla posizione di vicepresidente e direttore generale, la fornitura di un
servizio completo agli inserzionisti. Ne era parte integrante la redazione, sotto la diretta
supervisione di Resor, appassionato di statistica, di uno dei primi studi quantitativi realizzati
all’interno di un’agenzia sul sistema distributivo del paese: una voluminosa rassegna sui punti
vendita, che riguardava tutti i centri urbani, redatta per conto di un’impresa di scarpe. 3
Nella trasformazione di JWT un ruolo rilevante, anche se non sempre adeguatamente
riconosciuto all’esterno dell’agenzia, fu svolto da Helen Lansdowne, un’ex segretaria con
35
esperienze di copy per conto di rivenditori, imprese di trasporti urbani e per l’agenzia di P&G. In
quest’ultima sede la conobbe Resor, che poi la assunse, appena aperta la filiale JWT di Cincinnati,
per portarla quindi con sé a New York. Il caso di Lansdowne apre una finestra sulla dimensione di
genere dell’attività pubblicitaria. Le donne di ceto medio furono quasi subito individuate
dall’advertising come target privilegiato, perchè delegato agli acquisti di casa e, si pensava,
emotivamente più vulnerabile. Le pagine di mensili come “Ladies’ Home Journal” mostrano
l’intreccio e le corrispondenze che si producevano sulle loro colonne fra la cronaca, i pezzi
redazionali e le inserzioni. Era un amalgama cattivante, volto a “educare” la donna, come diceva
Resor, ai costumi emergenti e alla modernità. Il sovrapporsi, soprattutto visivo, fra le rubriche era
tale che, interrogate sulla migliore illustrazione della sezione editoriale del 1902, le lettrici del
“Journal” indicavano, a larga maggioranza, un disegno appartenente in realtà alla sezione
pubblicitaria (Kitch 2001). Strutturate come i reparti di un grande magazzino, al pari di quest’ultimo
le pagine delle riviste inseguivano e modellavano desideri e speranze delle lettrici, imitando la
ricchezza e varietà di merci e servizi, indirizzati ancora prevalentemente alla casa, con una
crescente presenza di prodotti importati quali tappeti turchi, porcellane cinesi e vestiti parigini
(Hoganson 2007), esibiti nei department stores (Garvey 1996).
Se erano al centro dell’attenzione dei pubblicitari come destinatari di messaggi, le donne, sino
all’ingresso di Lansdowne a JWT, brillavano, però, per la loro assenza nel cuore dell’apparato
produttivo delle agenzie. Lì svolgevano solo lavori segretariali. Resor fu il primo ad affidare a una
donna il compito di copy all’interno di una grande agenzia. E ne fu ripagato con una serie di
progetti destinati a passare alla storia del settore. Figlia di una divorziata, che aveva cresciuto la
famiglia lavorando come immobiliarista e assicuratrice, liceale modello e poi donna indipendente e
convinta suffragista, Lansdowne “riuscì a rivolgersi alle consumatrici non solo come donne con
denaro da spendere, ma anche come donne sensuali e sensibili. Ciò che è diventato una delle
principali controversie in pubblicità - le donne come oggetti sessuali - fu sviluppato da una donna
che molto probabilmente vedeva il riconoscimento della sessualità delle donne come un passo
36
avanti entro un mondo della pubblicità che aveva prevalentemente rappresentato le donne come
mogli e madri asessuate” (Scanlon 1995, p. 176).
Elementi emotivi e sensualità femminile dominavano il lavoro svolto per il suo primo incarico
di rilievo, a partire dal 1911, per conto dell’azienda Jergens, produttrice delle saponette Woodbury
(fig. 2). L’immagine raffigurava una coppia, giovane, bella ed elegante. L’uomo cingeva, in un
delicato abbraccio, una donna dall’aria trasognata e all'apparenza distante, che, quasi sopra
pensiero, prestava la mano alla presa, leggera e adorante, dell’amato. Questi le sfiorava il collo col
viso, attratto dalla “Pelle che ti piace toccare”, come recitava il claim, che pareva assumere come
obiettivo del messaggio gli uomini. Nel testo successivo, di poco più che un centinaio di parole,
emergeva, però, il vero destinatario, che erano le donne e il loro potenziale seduttivo (“anche voi
potrete avere il suo charme se cominciate il seguente trattamento stasera”). A loro l’annuncio dava
suggerimenti su quando e come usare la saponetta, allegando un coupon e un indirizzo al quale
richiedere piccoli campioni e brochure del prodotto. In uno stretto riquadro in basso, a destra, dalla
saponetta si affacciava il profilo dell’antico depositario del marchio, il dermatologo dottor
Woodbury, che a lungo, dagli anni settanta dell’Ottocento, era stato il protagonista della pubblicità,
secondo il classico modulo dell’imprenditore-testimonial di se stesso. Finchè, di fronte al calo
inarrestabile delle vendite, anche i produttori di Woodbury avevano deciso di cambiare registro,
ingaggiando JWT, mediante un contratto, inizialmente modesto, di 25 mila dollari (Sutton 2009).
FIG 2
Lansdowne perfezionò questo lavoro - che esemplificava l’obiettivo dichiarato dell’agenzia di
“creare un desiderio nei confronti del prodotto pubblicizzato” - per un decennio, sulla base di un
esame diretto di clienti dei grandi magazzini, interviste porta a porta a massaie e consulenze con
dermatologi (McFall 2004). I risultati si rivelarono sorprendenti. Fra il 1911 e il ’22 le vendite
balzarono da 122 mila a 2 milioni di dollari. A quel punto l’ormai ricco contratto Woodbury era
37
gestito da Lansdowne - nel frattempo divenuta, dal 1916, “signora Resor” - con l’aiuto di un intero
reparto femminile, lo Women’s Editorial Department. Vi torneremo parlando degli “anni ruggenti”
(Sivulka 2009).
Telefoni e nazione
Occorre a questo punto spostare di nuovo l’attenzione sull’agenzia leader Ayer perché, a partire
dal 1908, essa si trovò coinvolta nella più impegnativa campagna di un nuovo tipo di pubblicità che
cominciava a emergere in quegli anni. Era indicata come pubblicità istituzionale, cioè non orientata
semplicemente a vendere un prodotto, ma impegnata piuttosto a vendere o migliorare l’immagine
complessiva di un’azienda o di una qualsiasi istituzione. L’anno prima, nel 1907, la questione
dell’immagine delle imprese era stata sollevata da James H. Collins, uno dei più ascoltati
commentatori di temi pubblicitari. Il rebus della “personalità”, osservava Collins, riguardava non
solo gli uomini e le merci, ma anche le imprese. Ovvero, quelle “centinaia di grandi corporations
silenziose, che producono cose che sono ben note grazie all’esposizione pubblicitaria, ma che a loro
volta, esse imprese, non sono affatto note in virtù di una personalità (…) che arriva sui giornali”.
Tutto nasceva, diceva Collins, dalle dimensioni, dall’impersonalità crescente della grande impresa.
La bigness delle holdings le rendeva vulnerabili agli attacchi dei giornalisti d’“assalto”, alle
commissioni statali e federali antitrust, alle denunce e alle mobilitazioni del movimento sindacale. E
“in un’epoca di così forte pubblicizzazione (publicity)”, la scarsa dimestichezza dei manager a
comunicare con l’esterno e il loro “timore della carta stampata (…) che si basa sulla (…)
convinzione che i giornali travisano le cose” erano un serio handicap. Per Collins la risposta
consisteva in un’attività di “pubblicità (advertising) indiretta”, ovvero, ed ecco tornare la parolachiave dell’epoca, di publicity, intesa come costante informazione ai giornali. Andava condotta
“senza appelli sensazionalistici, senza pezzi di colore, senza tentativi di guidare i lettori a pensare in
un certo modo”. Avrebbero parlato da soli i “fatti”, che il responsabile del publicity bureau - un
nuovo ente interno all’azienda o un suo consulente, che doveva essere “qualcuno con un autentico
38
istinto per le notizie e la capacità di articolare i fatti per il pubblico” - avrebbe sottoposto
all’attenzione dei giornali, senza alcuna intermediazione clientelare, favore o prebenda. “In affari
paga avere una voce”, concludeva l’articolo. 4
Chi aveva bisogno di questo nuovo tipo di servizio, che i pubblicitari speravano di tenere sotto
la propria egida, ma che invece sarebbe divenuto appannaggio di un’altra professione, definita
dapprima “publicity” e in seguito “public relations” ? Un’immagine comparsa, proprio mentre
Collins scriveva, su una rivista di telefonia che ospitava le denunce dei muckrakers e dei
progressisti più radicali del Middle –West, forniva il profilo del più probabile candidato.
L’iconografia era un classico della tradizione populista e antitrust: una piovra che allungava i
tentacoli da Chicago alle più sperdute lande del Nebraska. Dietro la piovra non era difficile
riconoscere il colosso della telefonia American Telephone and Telegraph (AT&T). Nata negli anni
a cavallo del secolo mediante l’integrazione, in un monopolio nazionale, delle tante “società Bell”
che fino a quel momento avevano gestito i numerosi segmenti separati del nuovo business, nel 1907
AT&T soffriva di un duplice problema ed era particolarmente sensibile alla questione della bigness.
Per un verso, le piccole imprese locali avevano recuperato ed erano riuscite a insediarsi in numerose
nuove aree, riducendo la quota della market leader dal 100 al 51 %. Per l’altro, date le sue
persistenti enormi dimensioni, essa continuava a suscitare comunque sospetti e ostilità. Tanto più in
un clima nazionale reso incandescente da un intensificarsi della polemica sui trust, in concomitanza
con l’approvazione della nuova legge ferroviaria Hepburn, e dal crollo finanziario che passò alla
storia come “panico del 1907”. Finita sotto il controllo del banchiere Morgan, AT&T fu affidata a
un manager di sua fiducia, buon conoscitore dell’impresa per averci lavorato a lungo, occupandosi
soprattutto dei pionieristici servizi a lunga distanza, Theodore N. Vail.
Manager illuminato, impegnato a rispondere in maniera dialettica alla sfida progressista, Vail
era convinto della necessità di procedere, in maniera cauta, ma risoluta, sulla strada della
riconquista del controllo del mercato nazionale, puntando sulla lunga distanza. A questo fine
elaborò un’ambiziosa strategia. Essa prevedeva, per il versante interno, una razionalizzazione della
39
struttura, in modo da abbatterne sistematicamente i costi, e ampi programmi di assistenza
neopaternalistica per l’integrazione e la responsabilizzazione dei (e ormai, sempre più spesso, delle)
dipendenti. A ciò corrispondeva, sul versante esterno, una certa disponibilità a discutere moderate
forme di regolazione pubblica, un maggiore orientamento che in passato a studiare accordi parziali
con la piccola concorrenza e soprattutto una grande attenzione al rapporto con l’opinione pubblica.
Negli anni immediatamente precedenti, AT&T aveva provato a svolgere un’attività di publicity con
i giornali, simile a quella indicata da Collins, con l’aiuto di uno dei primi consulenti in materia, un
piccolo publicity bureau con sede a Boston. Ma, vista la gravità della situazione, secondo Vail ciò
non era più sufficiente. Ecco allora la decisione di rivolgersi alla prima agenzia di pubblicità del
paese, che invero aveva appena completato un progetto analogo, anche se di dimensioni
decisamente più ridotte, per conto di un’altra azienda molto chiacchierata, la società di assicurazioni
Mutual Life Insurance Company (McDougall 2006).
Oltre a costituire un’esperienza pilota di assoluto rilievo per la storia della pubblicità, la
campagna Ayer per AT&T ci consente di vedere da vicino la dinamica della relazione fra
un’agenzia e una corporation, l’intreccio e i compromessi fra le richieste di quest’ultima e la linea e
le consuetudini, culturali e operative, della prima. L’input iniziale di AT&T partiva dalla formula
che riassumeva la strategia di Vail: “Un sistema, una politica, servizio universale”. Il top
management tendeva, cioè, a ribadire ed estendere, come punto di forza ed elemento distintivo di
AT&T rispetto alla concorrenza, la dimensione nazionale, quella delle chiamate interurbane e
interstatali sempre più indispensabili a un mondo del business disteso ormai sull’intero territorio del
paese, e anzi proiettato sensibilmente al di là dei suoi confini. Tendeva dunque a rovesciare il
tallone d’Achille dell’azienda, ovvero le sue dimensioni, in un’esigenza irrinunciabile della scala
tecnico-produttiva, un’esigenza imposta dalla modernità, e dunque anche una garanzia di servizio
sistematico (Fischer 1995).
Invero “sistema” e “servizio” erano parole capaci di toccare una corda particolarmente sentita
nell’opinione pubblica dell’epoca. La prima, si è visto, faceva appello allo spirito scientista e di
40
expertise dei riformatori e dei tecnici aziendali. La seconda faceva convergere su di sè investimenti
etico-religiosi (vi attingeva il cristianesimo sociale dei primi assistenti sociali e della filantropia
imprenditoriale), tecnico-ingegneristici, politici (l’ideale progressista di una politica come
amministrazione e “servizio civile”) ed economico-produttivi (il “servizio” fornito, ad esempio,
come suggerivano le loro inserzioni, dalle lamette Gillette). Vi avrebbero fatto ricorso gli stessi
pubblicitari per giustificare la loro professione. Il “servizio” fornito dal “sistema” telefonico pareva
incarnare attese di comunicazione universale e immediata, di superamento degli equivoci e dei
conflitti, nelle quali confluivano promesse vecchie e nuove: dall’ideale di Morse di “rendere nei
fatti simile a un villaggio un’intera nazione”, alla speranza di incontro e scambio con la quale nel
primo Novecento ogni sera centomila americani sintonizzavano il loro telegrafo senza fili, per
tuffarsi “nel più vasto pubblico del mondo” (Douglas 1987). Per queste ragioni al management del
settore, diceva una Storia del telefono commissionata in quegli anni da AT&T, toccava il compito
di studiare “la chimica sottile dell’opinione pubblica e adattare il servizio telefonico ai mutevoli
umori e necessità dei tempi”, ovvero “educare ed educare, sino a creare un pubblico esperto”. 5
L’idea dell’ “istruzione” era in testa all’agenda di Vail quando si rivolse ad Ayer. Chiarendo che
l’obiettivo non era commerciale, chiese un tipo di comunicazione improntato a una logica
strettamente razionalistica e tecnica. Referente primario era quello che il management telefonico,
trasferendo meccanicamente nel nuovo settore la propria precedente esperienza di operatore nel
comparto telegrafico, considerava il mercato principale e dunque il suo più naturale sostenitore,
ovvero il mondo degli affari e delle elite. I primi cinque annunci, apparsi nel luglio 1908, si
componevano di lunghi testi, oscillanti fra le 350 e le 500 parole, sormontati da piccole immagini di
telefoni e pali telefonici. Come in un sussidiario, l’inserzione di esordio della serie, intitolata ai
“venti milioni di voci” già collegate dal sistema, spiegava la densa rete di “connessioni”, tecniche e
umane, sottesa all’interazione fra quelle voci. AT&T dava istruzioni su come usare il telefono,
raccomandando di pronunciare il numero con chiarezza e senza “irritarsi” con l’operatrice “al
pensiero che essa rappresenti un monopolio”; un pensiero che poteva affacciarsi anche fra gli
41
imprenditori, specie quelli più piccoli e provinciali. Non era così, rassicurava il messaggio. Il
sistema telefonico AT&T, concludeva l’annuncio, svolgeva, da operatore privato, un ruolo
esattamente uguale a quello del sistema postale pubblico: rendeva un servizio la cui “utilità”
risiedeva nella sua “universalità, come un solo sistema” (Marchand 1998).
Se era difficile, con i rudimentali strumenti di rilevazione dell’epoca, misurare i risultati di una
campagna pubblicitaria di prodotto, farlo rispetto a questo tipo di iniziative, più complesse e
sfuggenti, era addirittura impensabile. Eppure, anche in assenza di dati attendibili sull’esito dei
primi annunci, Vail decise di proseguire. Il contratto fu rinnovato per la cifra annuale, considerevole
per i tempi, di 220 mila dollari, 190 mila di costi più l’ormai usuale 15 % di commissione per
l’agenzia. Al momento del rinnovo, Ayer illustrò l’intenzione di estendere la campagna a un
centinaio di periodici, con un potenziale complessivo di diciassette milioni di lettori. Nei loro
confronti, diceva l’agente, si poteva provare anche a far scivolare qualche elemento di pubblicità di
prodotto, specie rispetto ai servizi a lunga distanza, visto che la misura in cui “le aziende” usavano
il mezzo era ancora ben “lontana da quello che avrebbe dovuto essere” e che si poteva “instillare
nelle menti una sensazione che usare le chiamate a lunga distanza non era una spesa, ma
un’economia ”. Come si vede da questi toni, in realtà il punto che Ayer teneva a sottolineare di più
era la necessità di un approccio meno rigidamente didascalico di quello della prima serie.
Occorreva, dicevano con cautela i pubblicitari, toccare corde più sottili ed emotive, pur all’interno
di un progetto di cui si ribadiva l’intento eminentemente “educativo”. Le inserzioni sarebbero state
così “attraenti”, scriveva Ayer al committente, che “la gente” avrebbe “cominciato ad aspettare ogni
mese”, con interesse, l’uscita di una nuova “storia sul telefono”. 6
In effetti, seguendo le campagne del 1909 e degli anni successivi, assistiamo a un progressivo
cambiamento della forma e dei contenuti degli annunci. Tra iperboli e trovate immaginifiche (e
talvolta decisamente un po’ bizzarre) essi paiono disegnare un racconto a puntate, modellato sulle
storie brevi delle riviste, sulla cronaca, le human interest stories e i fumetti dei giornali. I testi, nei
quali aumenta costantemente la citazione di cifre, relative agli abbonati, ai servizi, agli spazi coperti
42
dalle linee, si riducono a beneficio delle immagini: da una media di 350 parole del 1908 si scende
alle 150 di tre anni dopo. Al centro delle “storie” di AT&T è anzitutto l’uomo d’affari, raffigurato
in origine come un maturo businessman. Gli si affiancano e sovrappongono ben presto, però, figure
più giovani, con una insistita sottolineatura del loro vigore e della loro disinvoltura. E’ il “moderno
Montecristo”, come un annuncio del 1910 definiva un giovane manager elegante e volitivo, con una
cornetta in mano, su uno sfondo di grattacieli, incurante di un eroe di Dumas di proporzioni
infinitamente più ridotte che pareva chiedergli aiuto da una lunetta laterale che lo raffigurava
appena sfuggito alle insidie delle onde. L’analogia del titolo fra le due figure prometeiche del
passato e del presente si risolveva nell’assoluta superiorità della forza, tecnica e impalpabile, del
manager rispetto a quella, primordiale e messa duramente alla prova dagli eventi, dell’eroe di
Dumas. Il telefono, “un servizio che sarebbe impossibile anche con un esercito di galoppini e un
tesoro illimitato a sua disposizione”, faceva la differenza. “Annichilatore di spazio”, esso
“moltiplicava il potere” del suo utente più naturale, l’uomo d’affari, secondo quanto titolavano altri
due annunci. 7
Il “potere” della piovra si transustanziava così in una forza benefica, messa al servizio della
nazione e del mondo. Mediante la “proiezione” della “personalità” dell’uomo d’affari sino ai “limiti
estremi”, il sistema Bell o AT&T, come si autodefiniva in maniera intercambiabile, assurgeva a una
dimensione senza confini, diventava “servizio universale”, “autostrada della comunicazione”,
“segnale di civiltà”. Fino a giustapporsi alla massima autorità politica del paese, in un annuncio
intitolato In The Public Service (fig. 3). L’annuncio inaugurava un uso dello spazio articolato in due
parti, un’immagine della Casa Bianca e quella di un’elegante villa sulle coste del New England,
residenza estiva o di riposo del presidente della repubblica. Le metteva in contatto un apparecchio
telefonico le cui dimensioni, accresciute rispetto alle prime immagini, conferivano al medium un
potere iconico (Marchand 1998). La didascalia sottolineava ancora una volta la superiorità dei tempi
moderni, notando come “Quando Washington era presidente, se ne andava a cavallo sino a Mount
Vernon e si teneva in contatto con gli affari di stato mediante un corriere. Oggi il presidente (…)
43
può andare a cercare la fresca brezza della costa del New England. Le chiamate interurbane lo
tengono in costante comunicazione con la capitale e la nazione (…) Il sistema Bell svolge questo
servizio non solo per il presidente, ma per tutto il pubblico”. 8
FIG. 3
Come accennava la chiusa di questo messaggio, anche se i manager e le elite continuavano a
dominare il campo, lo sguardo si spostava, di tanto in tanto, sul paese intero. Ne era prova un
annuncio del 1910 intitolato Una nazione unita. Lo componeva una lunga sequenza di uomini (e
qualche sparuta donna) al telefono, che sfumavano all’orizzonte, verso l’infinito, su un claim che
attribuiva solo a “un sistema universale di questo tipo” la possibilità per “una nazione” di “tenersi
insieme”. Sulla stessa falsariga un’inserzione dell’anno successivo mostrava una landa dell’Ovest
innevata, solcata da un pony express, con sullo sfondo una lunga teoria di pali telefonici. Era, diceva
il titolo, la “democrazia Bell”, composta dai suoi utenti, nella quale “ogni uomo, non importa chi sia
o dove sia (…) ha lo stesso diritto alla comunicazione, limitato solo dalla distanza alla quale la voce
può essere trasportata”.
Sappiamo che non era vero. Il management AT&T, prigioniero delle sue idiosincrasie, stava
strettamente attaccato al mercato delle imprese urbane. Solo lentamente si sarebbe aperto alla
domanda che invece saliva, prepotente, dal mondo rurale e da quello delle potenziali utenze
domestiche. Né, per ragioni analoghe, si scrollava di dosso l’impronta rigorosamente maschile e
virile. Quando, nel 1909, Ayer, accanto all’icona manageriale del “moltiplicatore di potere”,
suggerì, per la verità non senza nascondere “il timore che non siate favorevoli”, un’immagine di
donna, la proposta subì un radicale ridimensionamento da parte della direzione AT&T. Il progetto
nasceva dalla consuetudine di lavoro di Ayer con le riviste femminili e dalla convinzione che il
“lato femminile della pubblicità” dischiudeva un ampio uditorio perché “tutti hanno una casa. Gli
uffici ce li hanno solo gli uomini”. Per dare un’idea di una possibile soluzione iconografica i
44
pubblicitari vi avevano allegato una classica “ragazza copertina” del “Saturday Evening Post”:
moderatamente emancipata e molto perbene, languida e sorridente, il ricevitore in una mano
appoggiata a un morbido cuscino, impegnata in una telefonata che si presumeva di piacere. Il
prodotto che in ultimo ne uscì, frutto di un compromesso fra l’ipotesi originaria di Ayer e
l’orientamento tutto virile e da “spirito degli affari” del management AT&T , era alquanto diverso.
Vi campeggiava l’illustrazione di una donna con qualche anno di più e soprattutto ritratta in casa,
seduta a una scrivania, con l’aria responsabile di una “manager domestica”, in atto di telefonare,
probabilmente al marito, con sullo sfondo i bambini (Marchand 1998).
Grazie a compromessi del genere la collaborazione fra Ayer e AT&T durò sino agli anni venti.
Quando fu usata anche per propagandare l’azionariato di massa dell’impresa (senza dire
naturalmente che il 50 % del pacchetto totale era saldamente nelle mani del 5 % degli investitori più
potenti), secondo la formula lincolniana “del popolo, dal popolo, attraverso il popolo”, che
inquadrava illustrazioni affollate di gente di ogni ceto. Nel frattempo i canoni di genere si erano
allentati e la presenza femminile negli annunci era aumentata, mediante le immagini delle “tessitrici
del discorso”, come recitava un’illustrazione, comparsa alla fine del 1915 e poi in vario modo
rielaborata e riproposta. Mostrava una telefonista ripresa, a figura intera, mentre teneva in pugno fili
sospesi su campagne e città che si stagliavano sullo sfondo, sovrastati dal potere del mezzo e
dell’operatrice. Non c’è modo di sapere quanto la collaborazione fra agenzia e impresa contribuì a
migliorare l’immagine aziendale, soprattutto nel periodo precedente la Grande guerra. Vista la sua
prosecuzione nel tempo, è ragionevole pensare che Vail fosse convinto della sua utilità. E la
ritenesse parte integrante di quelle politiche - una maggiore arrendevolezza verso i concorrenti più
piccoli e la rinuncia all’acquisto di compagnie indipendenti senza previo consenso da parte del
Dipartimento della Giustizia – che, tra il 1912 e il ’14, gli consentirono di pilotare con un certo
successo AT&T alla riconquista del mercato e salvaguardarla dal pericolo di interventi pubblici
antitrust più aggressivi e radicali (Ewen 1996).
45
Un’anima per l’impresa
Tra i più convinti ammiratori di Vail si annoverava il giovane John D. Rockefeller jr., figlio ed
erede dell’omonimo fondatore dell’impero petrolifero Standard Oil. Nel 1912, in una lettera a un
collaboratore, egli additava il manager della telefonia a esempio insuperato di come, in virtù di
un’azzeccata combinazione di politiche comunicative e strategiche, fosse possibile per “un’impresa,
uno dei più grandi, se non il più grande, monopolio, continuare la propria attività indisturbata (…)
con l’approvazione persino della Corte Suprema e del grande pubblico”. Un paio d’anni dopo i
Rockefeller si trovarono, a loro volta, al centro di una delle più profonde crisi di popolarità che la
storia imprenditoriale americana ricordi. Questa crisi ci consente di osservare sul nascere quella
professione dei publicity agents, che cominciava a correre parallela e in concorrenza alla pubblicità
e che era stata adombrata nell’articolo citato di James H. Collins. Il più famoso di questi
comunicatori, Ivy L. Lee, fu coinvolto dai Rockefeller nel tentativo di contenere la piena di critiche
che, nella primavera del 1914, si rovesciarono contro di loro, facendone l’incarnazione dell’altro
grande “male” attribuito al mondo corporate dai suoi oppositori, oltre alla bigness: la
“soullessness”, il non avere un’anima, il perseguire in maniera predace sempre ed esclusivamente il
profitto (Jordan 1991).
L’intera carriera dell’eroe eponimo, John D. Rockefeller sr., ancora ben presente sulla scena
accanto al figlio, era stata costellata di polemiche sulla sua azione spietata di eliminazione della
concorrenza. Nel 1911 Standard Oil era stata oggetto del più clamoroso intervento di regolazione
antitrust, con lo scioglimento dell’impresa e il suo spezzettamento in unità più ridotte, ma che
conservavano comunque ragguardevoli dimensioni e che ricominciarono subito il processo di
espansione. La primavera del 1914 aveva gettato un’ombra ancora più profonda sui petrolieri, sotto
forma di una vera e propria “guerra industriale” tra i minatori di un’impresa di Ludlow, in
Colorado, controllata dai Rockefeller, e la Guardia nazionale di quello stato e le milizie private al
soldo degli imprenditori. I primi, con l’aiuto del sindacato della United Mine Workers (UMW),
46
avevano provato ad alzare la testa chiedendo migliori condizioni di lavoro; le seconde erano
intervenute a reprimerne con la violenza l’agitazione. Dieci uomini, due donne e dodici bambini
erano rimasti sul campo a conclusione dello scontro, subito ribattezzato come il “massacro di
Ludlow” (Andrews 2008).
La crisi cadeva, per giunta, in un clima generale in cui la centralità della questione operaia nel
discorso pubblico aveva appena ricevuto una sanzione ufficiale, grazie alla costituzione, a livello
federale, della Commissione sulle Relazioni Industriali (CIR). La CIR era stata incaricata dal
presidente, il democratico progressista Woodrow Wilson, di occuparsi del problema in maniera
sistematica, anche se con funzioni solo investigative e consultive. Inoltre, con la sua lunga storia di
conflitti di lavoro, il Colorado riassumeva l’intensità e la radicalità di quel conflitto operaio
sviluppatosi ininterrottamente, su tutto il territorio nazionale e nei settori produttivi più disparati,
dentro e fuori della moderata confederazione maggioritaria dell’American Federation of Labor,
dopo che il paese era uscito dalla recessione del 1907. Lo provava la costituzione, proprio in quello
stato, del nucleo originario del sindacato rivoluzionario degli Industrial Workers of the World
(Cartosio 2007).
I Rockefeller si mossero in due direzioni convergenti: una campagna informativa per
neutralizzare la cattiva stampa, affidata a Lee; l’avvio di politiche del lavoro che impedissero il
ripetersi di conflitti di questa portata. Per quest’ultimo aspetto il colosso petrolifero si rivolse al
canadese W.L. MacKenzie King, esperto di relazioni industriali, ex ministro del lavoro liberale del
governo di Ottawa e futuro premier del Dominion. King propose un sofisticato programma di
rappresentanza della forza lavoro interno all’impresa. Al riparo dal sindacato ufficiale esterno, e
dunque senza che venissero intaccate le prerogative di comando padronali, il “piano industriale del
Colorado” dischiudeva, sulla carta, ai lavoratori una qualche forma di udienza per le loro
rivendicazioni presso la direzione. Con l’esplicito obiettivo aziendale di ottenere “un massimo di
pubblicizzazione (publicity) con un’interferenza minima per tutto quanto pertiene alle condizioni
d’impiego” (Fasce 2000).
47
Un obiettivo analogo si riprometteva, nel suo campo, Ivy Lee, figlio di un noto pastore
metodista meridionale, ex giornalista, con una laurea a Princeton e quasi dieci anni di esperienza
pionieristica come publicty agent. La professione era sorta a inizio secolo, col montare delle
denunce e della richiesta di trasparenza a opera di riformatori, autorità pubbliche e movimento
sindacale. Di fronte a questo ambiente in ebollizione alcuni imprenditori avevano sentito il bisogno
di mettere da parte la politica adottata sino a quel momento. Essa consisteva nel rinserrarsi dietro un
ostinato silenzio ufficiale, in nome della privacy e della difesa assoluta delle prerogative
proprietarie, e lavorare dietro le quinte, mediante pressioni informali sui giornali e manovre poco
specchiate con i loro editori quali la fornitura di contratti di pubblicità da parte di una determinata
impresa in cambio della pubblicazione di articoli favorevoli all’impresa medesima. Per queste
operazioni si prestavano a fare da tramite fra aziende e giornali figure, molto chiacchierate, di
mediatori, in genere ex giornalisti, detti press agents. A inizio secolo imprese come le ferrovie, a
forte concentrazione e quindi con problemi di bigness, che fornivano servizi cruciali al pubblico e
temevano interventi delle autorità nei loro confronti sull’esempio di quanto avveniva in Europa, si
erano messe alla testa di iniziative volte a superare queste consuetudini e a rispondere direttamente
e in maniera trasparente alle sollecitazioni dell’ambiente esterno. Così, per conto di Pennsylvania
Railroad, Lee aveva creato un piccolo publicity bureau, accompagnandone la formazione con
dichiarazioni di principio molto impegnative, che miravano a prendere le distanze tanto dai press
agents quanto dall’attività pubblicitaria commerciale. Obiettivo, scriveva Lee, era “fornire alla
stampa ogni possibile informazione (…) una tempestiva e accurata informazione riguardo a temi
che è bene e interessante che il pubblico conosca”. Fedele alle promesse, il pubblicista aveva
inaugurato una pratica di costante e aperto invio ai giornali di note, ricche di dati e già elaborate in
maniera tale da prestarsi alla trasformazione immediata in articoli. Immancabilmente introdotti da
un perentorio richiamo ai “fatti”, i comunicati di Lee, anzichè nascondere problemi, oggetto di
controversie sulla carta stampata, come gli incidenti, secondo quanto le ferrovie avevano spesso
fatto in passato, cercavano di contestualizzarli e spiegarli con le difficoltà tecniche e organizzative
48
correnti della struttura aziendale. Non sempre tuttavia Lee era riuscito a garantire trasparenza e
affidabilità e ad arginare le pressioni dei suoi manager perché fosse più selettivo e guardingo nel
fornire informazioni. Né si era sottratto a pratiche disinvolte e francamente censurabili come quella
di pubblicare, su riviste economiche o di settore, opinioni favorevoli a Pennsylvania, dimenticando
di scrivere da qualche parte, sotto la sua firma, di essere consulente della medesima impresa.
Oppure quella di pubblicare editoriali anonimi, a esplicito sostegno degli interessi delle ferrovie
nella questione delle tariffe (Fasce 2000).
La tensione irrisolta fra le dichiarazioni di principio e l’attività quotidiana della publicity
aziendale praticata da Lee percorre con forza il lavoro che egli svolse sulla vicenda di Ludlow e
mostra, ingigantite, le questioni di veridicità e rispettabilità che agitavano l’universo comunicativo
commerciale. A cominciare dalla cornice stessa nella quale il lavoro fu condotto. Lee assunse
l’incarico di Rockefeller in gran segreto perché all’epoca era ancora legato a Pennsylvania. Il che
significò una clamorosa violazione della parola d’ordine ufficiale di trasparenza con la quale l’ex
giornalista aveva costruito la sua carriera sino a quel momento. Così come non recò alcun
riferimento ai Rockefeller, o alla loro consociata di Ludlow, la lunga serie di bollettini, redatti sotto
la supervisione di Lee e denominati La lotta in Colorado per la libertà industriale, che costituì il
clou della campagna. In essi, esponenti autorevoli del mondo religioso, scientifico e culturale,
conservatore o comunque vicino all’impresa (ad esempio, l’illustre economista di Columbia E.A.R.
Seligman), snocciolavano dati sulla difficile congiuntura dell’azienda e del settore e denunciavano,
con l’aria di fornire un parere neutrale e distaccato, la limitazione della “libertà” individuale dei
lavoratori e degli imprenditori provocata dalla “pretesa” del sindacato di introdurre la contrattazione
collettiva. In questa “pretesa”, proseguiva l’argomentazione padronale, risiedeva la vera radice di
ogni violenza (Ibidem).
Secondo una tecnica collaudata, tali bollettini vennero inviati alle parrocchie, agli insegnanti,
alle camere di commercio, agli assistenti sociali, del Colorado e di altri stati. Obiettivi:
controbattere le argomentazioni contenute nel pamphlet Il massacro di Ludlow, che nel frattempo la
49
UMW, che continuava a guidare lo sciopero, stava distribuendo in tutto il paese, e creare un clima
di opinione nel quale risultasse più facile risolvere la vertenza con i minatori, senza passare per la
negoziazione col sindacato, ed evitando guai con la commissione federale CIR. Stando a una
rassegna stampa commissionata dai Rockefeller nel novembre 1914, l’azione di Lee aveva sortito
effetti positivi: su 47 editoriali esaminati, oltre la metà, 28, erano a favore degli imprenditori, di
contro a soli 14 favorevoli agli scioperanti, il rimanente essendo neutrali. Non mancarono, tuttavia,
clamorosi infortuni da parte dell’esperto di comunicazione. L’emergenza più grave occorse quando
in un bollettino finì la notizia, evidentemente falsa, che attribuiva alla celebre, ultraottantenne
militante operaia “Mamma” Jones uno stipendio sindacale di diverse migliaia di dollari annui. Di
fronte alle furiose reazioni dei giornali progressisti e di tutta la stampa nazionale, Lee si trovò nella
scomoda posizione di strappare ai manager del Colorado, che gli avevano trasmesso quei dati ed
erano riluttanti ad ammettere in pubblico errori o contraffazioni, il consenso a pubblicare una
rettifica ufficiale su uno degli innumerevoli “bollettini della libertà” (Andrews 2008).
La posizione di Lee si fece più imbarazzante quando, all’inizio del 1915, dopo che la sua
collaborazione con i Rockefeller era stata sancita da una rescissione del contratto con Pennsylvania
e resa di pubblico dominio dal suo nuovo committente, e mentre nel frattempo i minatori avevano
dovuto arrendersi e rinunciare allo sciopero, la vicenda di Ludlow finì sotto i riflettori della CIR e
soprattutto sotto lo sguardo impietoso del suo presidente, Frank Walsh, nominato da Wilson.
Progressista radicale e visionario, avvocato e riformatore di provincia giunto a Washington con la
convinzione che “il nostro attuale sistema industriale dovrebbe essere messo sotto processo”, Walsh
pensò che il destino gli avesse finalmente servito su un piatto d’argento tale processo. Nelle sedute
dell’inchiesta CIR dedicate a Ludlow egli vide inoltre l’occasione per superare, con una forzatura,
in un coraggioso colpo di teatro, le profonde divisioni che laceravano le varie componenti
(conservatrici, moderate e radicali) della commissione. Non senza qualche scivolone demagogico o
eccesso retorico, egli fece dunque di John D. Rockefeller jr. e di Ivy Lee i bersagli privilegiati
attorno ai quali costruì la sua implacabile requisitoria. L’ex studente di Princeton dovette ammettere
50
di essersi comportato come minimo con “leggerezza” nell’avallare e propalare informazioni come
quella relativa a “Mamma” Jones senza averle verificate. Né, naturalmente, gli giovò la pubblica
ammissione di aver gestito la campagna nascondendosi dietro sigle e firme apparentemente neutrali
(Stromquist 1998).
Com’era prevedibile, l’intelligentsia progressista rovesciò su Lee accuse roventi, che si
protrassero ben al di là della sua ultima audizione presso la CIR, nel maggio 1915. Il poeta Carl
Sandburg lo definì un “bugiardo prezzolato”. George Creel, muckraker e amico di Walsh, gli
affibbiò l’etichetta di “avvelenatore dell’opinione pubblica”. Un’etichetta che lo scrittore radicale
Upton Sinclair perfezionò, con un brillante gioco di parole che associava il nome di una pianta
velenosa a quello di battesimo di Lee ( “poison Ivy”=edera velenosa).
Per quanto profondamente ferito nell’orgoglio da accuse che, come il soprannome datogli da
Sinclair, non lo avrebbero più abbandonato, Lee consolidò comunque il rapporto di stima reciproca
e di collaborazione col giovane Rockefeller. E poté, grazie anche all’ausilio di un improvviso mutar
di circostanze generali, uscire in buona sostanza indenne da una situazione che minacciava di farsi
esplosiva. Infatti, spentisi i riflettori delle audizioni pubbliche, la CIR, dilaniata dai propri dissidi
interni, chiuse i lavori tra polemiche e rancori, senza arrivare a redigere un rapporto finale operativo
omogeneo e consensuale. Per converso, in virtù di una martellante campagna di incontri con
manager e lavoratori, che John D. Rockefeller jr. intraprese con la costante consulenza di Lee e
King, il “piano del Colorado” fu in ultimo approvato dai dipendenti delle miniere. Esso divenne
gradualmente una significativa piattaforma di discussione sulle relazioni industriali, estesa a vasti
segmenti del mondo imprenditoriale nazionale. Dal canto suo, complici la guerra sottomarina
tedesca e la scadenza elettorale presidenziale, con l’avvicinarsi del nuovo anno la comunità
progressista spostò definitivamente la propria attenzione sui campi di battaglia europei e sulla
campagna per la rielezione di Woodrow Wilson (Ewen 1996).
Quei campi avrebbero fornito a Lee e ai pubblicitari insperate occasioni di insediamento
professionale e sociale.
51
52