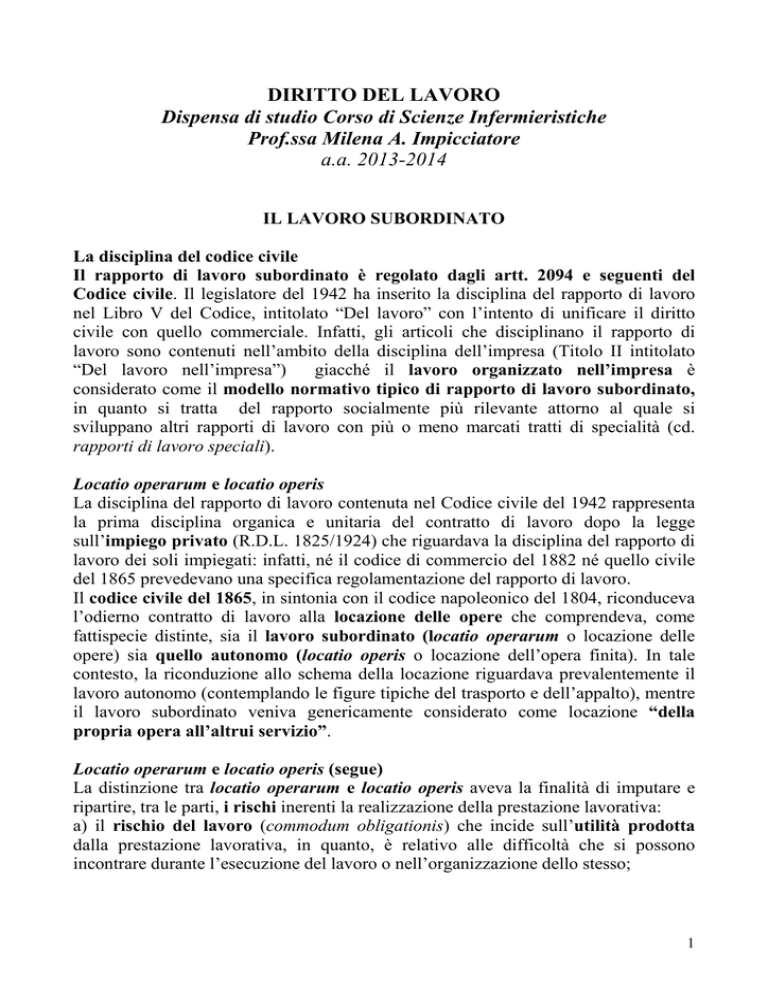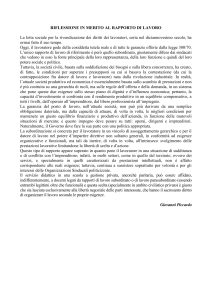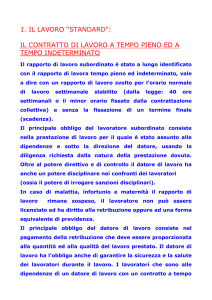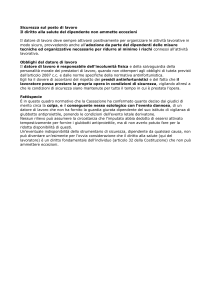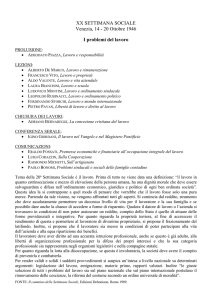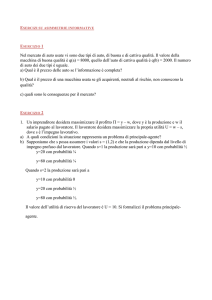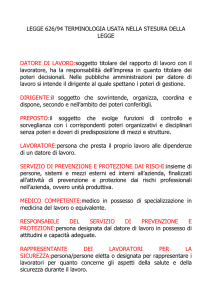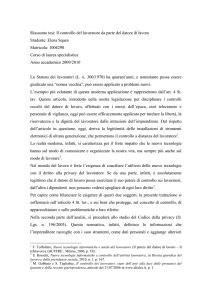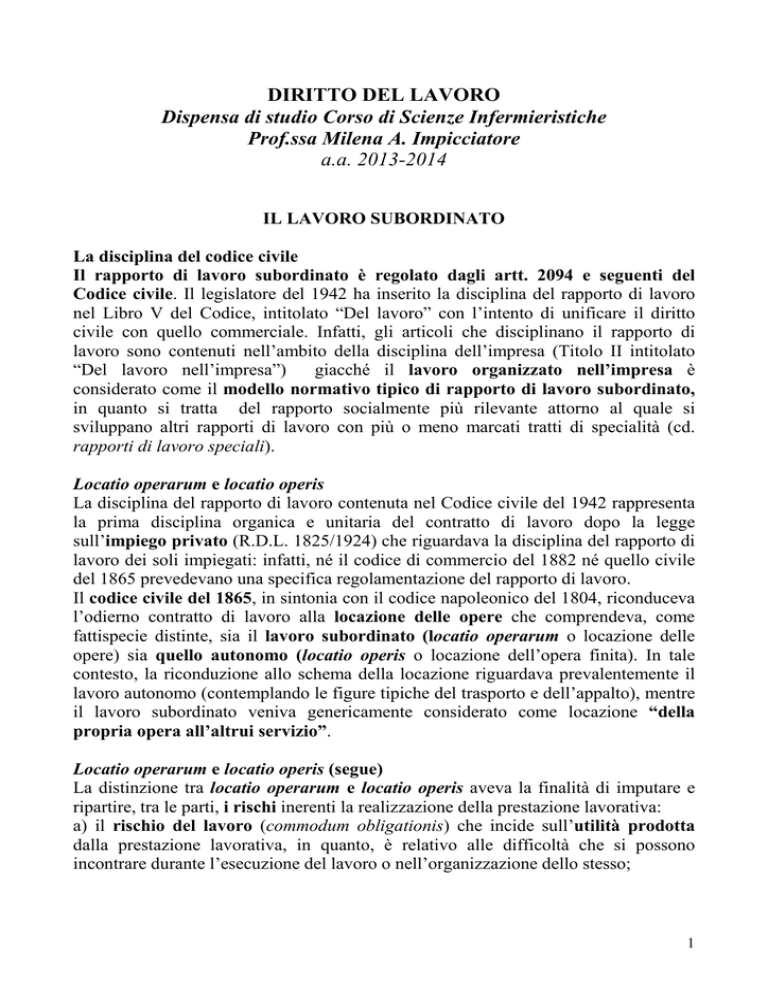
DIRITTO DEL LAVORO
Dispensa di studio Corso di Scienze Infermieristiche
Prof.ssa Milena A. Impicciatore
a.a. 2013-2014
IL LAVORO SUBORDINATO
La disciplina del codice civile
Il rapporto di lavoro subordinato è regolato dagli artt. 2094 e seguenti del
Codice civile. Il legislatore del 1942 ha inserito la disciplina del rapporto di lavoro
nel Libro V del Codice, intitolato “Del lavoro” con l’intento di unificare il diritto
civile con quello commerciale. Infatti, gli articoli che disciplinano il rapporto di
lavoro sono contenuti nell’ambito della disciplina dell’impresa (Titolo II intitolato
“Del lavoro nell’impresa”)
giacché il lavoro organizzato nell’impresa è
considerato come il modello normativo tipico di rapporto di lavoro subordinato,
in quanto si tratta del rapporto socialmente più rilevante attorno al quale si
sviluppano altri rapporti di lavoro con più o meno marcati tratti di specialità (cd.
rapporti di lavoro speciali).
Locatio operarum e locatio operis
La disciplina del rapporto di lavoro contenuta nel Codice civile del 1942 rappresenta
la prima disciplina organica e unitaria del contratto di lavoro dopo la legge
sull’impiego privato (R.D.L. 1825/1924) che riguardava la disciplina del rapporto di
lavoro dei soli impiegati: infatti, né il codice di commercio del 1882 né quello civile
del 1865 prevedevano una specifica regolamentazione del rapporto di lavoro.
Il codice civile del 1865, in sintonia con il codice napoleonico del 1804, riconduceva
l’odierno contratto di lavoro alla locazione delle opere che comprendeva, come
fattispecie distinte, sia il lavoro subordinato (locatio operarum o locazione delle
opere) sia quello autonomo (locatio operis o locazione dell’opera finita). In tale
contesto, la riconduzione allo schema della locazione riguardava prevalentemente il
lavoro autonomo (contemplando le figure tipiche del trasporto e dell’appalto), mentre
il lavoro subordinato veniva genericamente considerato come locazione “della
propria opera all’altrui servizio”.
Locatio operarum e locatio operis (segue)
La distinzione tra locatio operarum e locatio operis aveva la finalità di imputare e
ripartire, tra le parti, i rischi inerenti la realizzazione della prestazione lavorativa:
a) il rischio del lavoro (commodum obligationis) che incide sull’utilità prodotta
dalla prestazione lavorativa, in quanto, è relativo alle difficoltà che si possono
incontrare durante l’esecuzione del lavoro o nell’organizzazione dello stesso;
1
b) il rischio dell’impossibilità (o mancanza) del lavoro (periculum obligationis),
relativo ad un impedimento sopravvenuto della prestazione dovuto a caso fortuito
o forza maggiore.
Tali rischi si ripartiscono in modo diverso nelle due sottospecie: nella locatio
operarum il rischio del lavoro non è a carico del lavoratore ma del datore di lavoro;
nella locatio operis è totalmente a carico del lavoratore autonomo che ha l’obbligo di
eseguire l’opus perfectum. Il rischio della impossibilità era invece sempre a carico
del lavoratore.
…dalla locatio operarum…
La carenza legislativa, che si rileva nel codice civile del 1865, in merito alla locatio
operarum non era certamente dovuta alla scarsa rilevanza sociale della fattispecie,
quanto piuttosto era il risultato di una tradizione interpretativa secondo cui il
contenuto della locatio operarum doveva essere lasciato alla determinazione delle
parti contraenti, e quindi all’autonomia privata. Di conseguenza, tale fattispecie
veniva costruita dagli interpreti e per il legislatore non rappresentava altro che una
sottospecie della locazione delle opere, definita dall’art. 1570 come “il contratto
per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita
mercede”, che a sua volta rappresentava un adattamento del più generale schema
contrattuale della locazione di cose. La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro
autonomo veniva così impropriamente fatta risalire all’oggetto della locazione che
riguardava rispettivamente l’attività del lavoro (le cd. energie lavorative) o il risultato
dello stesso (cd. opus perfectum).
Secondo una dottrina minoritaria, lo schema contrattuale del rapporto di lavoro era quello della
compravendita: in entrambi i tipi contrattuali il lavoro prestato veniva considerato alla stregua di una merce
(res) di cui il creditore acquisiva la disponibilità attraverso un contratto di scambio.
…alla nozione di subordinazione
Il codice civile del 1942 individua il criterio distintivo del lavoro subordinato rispetto
al lavoro autonomo non più nella distinzione tra attività di lavoro e risultato del
lavoro, ma nella nozione di subordinazione.
Tale nozione si ricava dall’art. 2094 del Codice civile, che si riferisce al prestatore
di lavoro subordinato definendolo come colui che “si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
L’art. 2094 nell’identificare la subordinazione come dipendenza del prestatore
dalla direzione del datore di lavoro nell’esecuzione dell’attività lavorativa
all’interno dell’impresa, definisce la c.d. subordinazione tecnico-funzionale.
La rilevanza della subordinazione del prestatore.
La subordinazione del prestatore di lavoro si identifica con la dipendenza o
sottoposizione del debitore al potere del creditore. Infatti, il lavoratore
subordinato è vincolato all’osservanza delle direttive di carattere tecnicoorganizzativo e delle disposizioni sulla disciplina del lavoro impartite dal datore di
2
lavoro in qualità di titolare del potere direttivo (art. 2104 c.c.) e del potere
disciplinare (art. 2106 c.c).
La subordinazione come eterodirezione
La subordinazione, dunque, è intesa come assoggettamento del lavoratore al potere
direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione).
Tale assoggettamento, che limita l’autonomia del lavoratore ed allo stesso tempo ne
consente l’inserimento nell’organizzazione dell’impresa, si desume da una serie di
comportamenti posti in essere dal datore di lavoro quali, ad esempio, l’emanazione
di specifici ordini oppure l’esercizio di una costante ed assidua attività di
vigilanza e controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa.
L’eterodirezione consiste nell’assoggettamento ad un potere che si estrinseca nella
emanazione di ordini specifici e nell’esercizio di una assidua attività di vigilanza e
controllo sull’esecuzione della prestazione di lavoro.
La subordinazione: contenuto tipico dell’obbligazione di lavoro
In sostanza, la subordinazione rappresenta il contenuto tipico dell’obbligazione di
lavoro, in quanto, rappresenta la situazione soggettiva del lavoratore-debitore di
fronte all’autorità dell’imprenditore-creditore del lavoro (ex art. 2086 c.c.).
La subordinazione intesa come vincolo di carattere personale che assoggetta il
prestatore al potere direttivo (o conformativo) del datore, si configura pertanto
come elemento esterno all’oggetto della prestazione e quindi alla struttura
dell’obbligazione di lavoro, rappresentando l’effetto giuridico essenziale del
contratto.
La subordinazione in senso stretto
Accanto alla nozione di subordinazione di carattere tecnico-funzionale è possibile
ricavare, dalla norma codicistica, una nozione di subordinazione in senso stretto
(Corte costituzionale, sentenza. n. 30/2006) volta a leggere la formula “alle
dipendenze e sotto la direzione” con un significato più pregnante e qualitativamente
diverso, che fa riferimento alla incorporazione della prestazione di lavoro in
un’organizzazione produttiva altrui e in vista di uno scopo, di cui il titolare
dell’organizzazione è immediatamente legittimato ad appropriarsi, in ordine al quale
il lavoratore non ha alcun interesse giuridicamente tutelato (situazione di doppia
alienità): questa situazione di dipendenza è la ragione ultima delle tutele del diritto
del lavoro. Tale nozione appare più idonea a cogliere l’esistenza della subordinazione
in quelle fattispecie in cui l’eterodirezione, in concreto, non si manifesta.
La subordinazione quale continuità nel tempo della prestazione
La subordinazione si identifica con l’inserzione del prestatore di lavoro
nell’organizzazione dell’impresa e quindi con la continuità o disponibilità nel
tempo della prestazione di lavoro nei confronti del datore di lavoro. La continuità,
intesa anche come disponibilità al coordinamento della prestazione nello spazio e
3
nel tempo, qualifica la subordinazione come eterodirezione, cioè dipendenza dal
controllo dell’imprenditore, e pertanto diversa dalla semplice distribuzione temporale
dell’adempimento dell’obbligazione del lavoratore. La durata attiene essenzialmente
al profilo della causa del contratto e va intesa non come continuità materiale ma
puramente ideale, ossia come dipendenza o disponibilità funzionale del prestatore
all’impresa altrui. In tal senso, la persistenza nel tempo degli obblighi del prestatore
fa sì che questo ultimo resti obbligato, e quindi idealmente alle dipendenze del datore
di lavoro, anche durante le interruzioni dell’esecuzione della prestazione (come ferie,
pause, riposi).
Intuitus personae
La centralità che riveste la persona del prestatore (intuitus personae) nel rapporto
di lavoro subordinato comporta la c.d. infungibilità soggettiva della prestazione.
Infatti, l’obbligazione di eseguire una prestazione lavorativa non è trasmissibile
mortis causa e non può in alcun caso essere legittimamente adempiuta da un
terzo in qualità di sostituto del lavoratore-debitore, questo comporterebbe una
novazione soggettiva del contratto di lavoro e quindi la nascita di un nuovo rapporto
di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal precedente lavoratore.
L’esclusione dell’adempimento da parte del terzo è insita nella impossibilità di cedere
la situazione soggettiva debitoria del prestatore di lavoro. La ragione per cui vige tale
intrasmissibilità inter vivos va ricercata nell’insostituibilità del debitore agli effetti
della subordinazione che caratterizza l’obbligazione di lavoro.
In altre parole, la successione del lavoratore nel contratto di lavoro sia mortis causa
sia inter vivos è esclusa per la rilevanza essenziale della sua persona.
La rilevanza della persona fisica del lavoratore
Altro aspetto fondamentale legato alla “persona” del lavoratore nel contesto di un
rapporto di lavoro subordinato è che la prestazione lavorativa implica un diretto
coinvolgimento delle energie fisiche del lavoratore, pertanto solo le persone
fisiche possono prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di
un datore di lavoro.
Proprio per la rilevanza della persona fisica del lavoratore, va sottolineato che, in
merito alla capacità giuridica ed alla capacità di agire in materia di lavoro, si applica
la normativa prevista in generale per la disciplina della capacità delle persone fisiche.
Requisiti soggettivi del datore di lavoro
A differenza del prestatore di lavoro, non sono previsti requisiti soggettivi
speciali per quanto concerne la persona del datore di lavoro, pertanto, si
applicano, senza eccezioni, le norme dettate per la capacità giuridica e di agire della
generalità dei soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche.
Per quanto concerne il datore di lavoro rileva in particolare la distinzione tra
imprenditori ed altri datori di lavoro. Tale distinzione viene spesso in rilievo ai
fini della disciplina del rapporto di lavoro, in quanto, una serie di limiti ed
obblighi vengono imposti soltanto al datore-imprenditore non tanto in virtù della
4
destinazione della prestazione di lavoro ad un’attività professionale esercitata ai fini
produttivi, ma per l’articolazione di un complesso di norme per la tutela individuale e
collettiva del lavoro subordinato alle dipendenze dell’impresa, soprattutto media o
grande.
Spersonalizzazione dell’imprenditore
La qualità di imprenditore del datore di lavoro seppure non costituisca requisito
differenziale ai fini della capacità di concludere il contratto di lavoro, assume
rilevanza sotto il profilo della c.d. spersonalizzazione dell’imprenditore agli
effetti della formazione e conclusione del contratto e della successione nello
stesso.
In merito alla formazione e conclusione del contratto di lavoro si applica l’art.
1330 del Codice Civile secondo il quale “la proposta o l’accettazione, quando è
fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se
l’imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto”.
Per quanto attiene la successione in un contratto di lavoro vige il principio della
continuità dell’impresa. Tale successione è dettata dall’art. 2112 del Codice Civile
secondo il quale “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro
continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne
derivano”.
Spersonalizzazione dell’imprenditore (segue)
Secondo la dottrina la possibilità di far subentrare il cessionario nella posizione del
datore di lavoro fa sì che il contratto di lavoro si configuri come un tipico contratto
d’impresa, in perfetta armonia con il disposto generale dell’art. 2558 del Codice
Civile che disciplina la successione nei contratti. Da questo dettato normativo, l’art.
2112 si distingue per la previsione del carattere automatico dell’effetto
successorio ed in particolare per la speciale disciplina che regola i rapporti tra
cedente e cessionario d’azienda. Tale disciplina, ancora una volta, è finalizzata alla
tutela del lavoratore nella sua veste di contraente debole ed in sostanza è volta a
salvaguardare la continuità del rapporto di lavoro.
È agevole comprendere che la persona dell’imprenditore, ai fini della successione
nel contratto di lavoro, anche mortis causa, non ha rilevanza.
IL LAVORO AUTONOMO E LA PARASUBORDINAZIONE
La disciplina del codice civile
Il Libro V del Codice civile contiene anche la disciplina del prototipo del lavoro
autonomo, il contratto d’opera (art. 2222 ss.), tradizionalmente contrapposto, in una
logica di tipo binario, al lavoro subordinato.
Il rapporto di lavoro autonomo è disciplinato dall’art. 2222 del Codice civile che
definisce il contratto d’opera come quel negozio in cui “una persona si obbliga a
5
compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente”.
Il lavoro autonomo: l’assenza del vincolo di subordinazione
Dalla lettera dell’art. 2222 del Codice Civile si desume che il tratto caratterizzante
del rapporto di lavoro autonomo è dato dall’assenza del vincolo di
subordinazione.
In realtà, dal punto di vista del contenuto dell’obbligazione, il rapporto di lavoro
autonomo può non essere diverso dal rapporto di lavoro subordinato, infatti in
entrambi i casi l’oggetto dell’obbligazione è dato dal lavoro stesso inteso come
prestazione di facere (faciendi necessitas).
Il vero elemento differenziale è dato dalle modalità di effettuazione della
prestazione e cioè dall’assenza del vincolo di subordinazione, in quanto nel
contratto d’opera il facere è finalizzato alla realizzazione di un’opera o di un
servizio (opus perfectum), mentre nel lavoro subordinato il facere è inserito in
una attività organizzata dall’imprenditore.
Stesso contenuto della prestazione…
Per comprendere la differenza sostanziale tra i due contratti può essere utile un
esempio: si pensi al confezionamento di una borsa di cuoio quale oggetto della
prestazione di lavoro.
Nel caso di lavoro autonomo la realizzazione della borsa sarà affidata ad un artigiano
pellettiere che si impegnerà a consegnare il lavoro finito dietro il corrispettivo di un
prezzo.
Nel caso di lavoro subordinato la borsa sarà confezionata all’interno di una pelletteria
avvalendosi di materiali e strumenti dell’imprenditore, attraverso la prestazione di
attività lavorativa dietro il corrispettivo di una retribuzione che sarà corrisposta in
base al tempo necessario per l’esecuzione della prestazione di lavoro.
...diverso rischio di risultato
In entrambi i casi si tratta di realizzare uno stesso oggetto, ma mentre nel primo caso
l’artigiano si obbliga a consegnare il lavoro finito al committente assumendosi il
rischio del risultato della prestazione, nel secondo caso il lavoratore si obbliga a
prestare la sua attività lavorativa sotto la direzione del datore di lavoro, dietro il
versamento della retribuzione senza assumere il rischio del risultato della prestazione,
a carico del titolare della pelletteria.
Infatti, se in seguito ad un incendio la bottega dell’artigiano dovesse perire ed egli si
trovasse nell’impossibilità di consegnare la borsa commissionata, lo stesso artigiano
subirebbe il rischio del risultato e non avrebbe diritto ad alcun compenso per il lavoro
già eseguito. Se, invece, per lo stesso incendio perisse la pelletteria presso la quale il
lavoratore subordinato presta la sua attività di lavoro, il rischio economico della
perdita ricadrebbe interamente sul datore di lavoro, mentre il lavoratore avrebbe il
6
diritto di percepire la retribuzione per il lavoro prestato, indipendentemente
dall’evento impeditivo della consegna della res.
Altre fattispecie di lavoro autonomo
Il contratto d’opera rappresenta la fattispecie generica e al tempo stesso residuale
di lavoro autonomo prevista dal nostro ordinamento, che contempla altre quattro
figure fondamentali definite in modo più specifico secondo la loro tipicità sociale:
l’appalto, il trasporto, il deposito generico e il mandato.
Nel contratto di appalto, disciplinato dall’artt. 1655 e seguenti del Codice Civile,
la causa è data dallo scambio tra la realizzazione di un’opera o un servizio
eseguita con organizzazione propria dell’appaltatore (che è un imprenditore)
verso il corrispettivo di un prezzo.
Nel contratto di trasporto, disciplinato dagli artt. 1678 e seguenti del Codice
Civile, la causa va ravvisata nel trasferimento di persone o cose da un luogo ad un
altro verso il corrispettivo di un prezzo.
Il contratto di deposito generico, previsto dall’art. 1776 del Codice Civile, invece,
assolve alla funzione di custodia di beni verso il corrispettivo di un prezzo, mentre
la causa del contratto di mandato, disciplinato dagli artt. 1703 e seguenti del
Codice Civile (così come delle sottospecie: commissione, agenzia e spedizione)
consiste nella gestione di affari nell’altrui interesse mediante la conclusione di
contratti.
Realizzazione del risultato
In tutte le fattispecie di lavoro autonomo previste dal Codice Civile la prestazione
eseguita dal lavoratore è finalizzata al risultato dell’opera finita, c.d. opus
perfectum, ovvero al risultato economico dell’attività organizzata dal debitore che
è il lavoratore stesso.
Ancora una volta si evince la differenza sostanziale con il lavoro subordinato nel
quale, invece, l’oggetto del contratto è costituito dalla prestazione dell’attività del
debitore messa a disposizione dell’organizzazione del creditore che è il datore di
lavoro.
Lavoro autonomo e ingerenza del creditore
Nel contratto d’opera, come negli altri contratti di lavoro autonomo, può talora
manifestarsi un vincolo simile a quello della subordinazione, di sottoposizione del
debitore all’ingerenza del creditore nell’esecuzione della prestazione (ad
esempio, nel contratto d’appalto il committente può apporre variazioni al progetto o
fare verifiche in corso di esecuzione dell’opera o sull’opera compiuta), ma la
sottoposizione del lavoratore autonomo all’ingerenza del committente
nell’esecuzione della prestazione è ben diversa dalla subordinazione.
Il committente, infatti, può stabilire le condizioni per la realizzazione dell’opera, può
altresì fissare un termine entro il quale il lavoratore è tenuto a conformarsi alle stesse,
7
pena il recesso dal contratto con diritto al risarcimento del danno, ma anche in questi
casi, sebbene il lavoratore autonomo sia vincolato alle direttive impartite dal
committente e per tale ragione sia soggetto al suo potere di controllo, di certo egli
non può essere considerato alle dipendenze del committente, rimanendo comunque
obbligato esclusivamente al risultato della propria prestazione personale o
organizzata.
Tra autonomia e subordinazione: la parasubordinazione
In linea generale l’inserzione del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa e la
disponibilità al coordinamento della prestazione nello spazio e nel tempo è un
sicuro indice presuntivo della sussistenza della subordinazione ma non è possibile
asserire che tale presunzione abbia valore assoluto.
Infatti, l’inserzione del lavoratore nell’impresa può aversi sotto forma di
collaborazione coordinata e continuativa anche nel contesto del lavoro autonomo,
in questo caso la fattispecie rientra in un ambito solitamente definito “zona grigia” o
altrimenti parasubordinazione.
La parasubordinazione secondo la giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza un rapporto di lavoro si configura quale rapporto
parasubordinato se sussistono i seguenti tre requisiti:
a) la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri
nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del
committente;
b) la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un
protratto inserimento nell’organizzazione aziendale o, più in generale, nelle
finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di
quest’ultimo nell’attività del prestatore;
c) la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del
prestatore sull’utilizzazione di una struttura di natura materiale.
Non è, invece, necessario che la prestazione abbia ad oggetto un’attività diversa
da quella abitualmente esercitata dal prestatore, né che tale prestazione sia resa
con totale esclusione di mezzi organizzati o personale subordinato, è altresì
irrilevante che il suddetto prestatore agisca in regime di autonomia o di
subordinazione.
I rapporti di lavoro che possono definirsi parasubordinati
Secondo la giurisprudenza rientrano nell’ambito della
cosiddetta
parasubordinazione, con conseguente assoggettamento delle relative controversie al
rito del lavoro ai sensi dell’art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, tutti quei
rapporti che riguardano prestazioni di facere riconducibili allo schema generale
del lavoro autonomo, a condizione che abbiano per oggetto una prestazione
coordinata e continuativa a carattere prevalentemente personale. Naturalmente
questi rapporti possono anche rientrare in figure contrattuali tipiche già previste
8
dall’ordinamento, in quanto non osta il fatto che il prestatore d’opera svolga la
propria attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri.
In altri termini, secondo la giurisprudenza, un rapporto di lavoro autonomo, come ad
esempio il trasporto, inteso quale fattispecie contrattuale tipica prevista dal
legislatore, può configurarsi quale lavoro parasubordinato se la prestazione è eseguita
in modo coordinato e continuativo per uno stesso committente.
La collaborazione coordinata e continuativa
L’art. 409, n. 3 c.p.c. ai soli fini della sottoposizione al rito del lavoro e della
disciplina delle rinunce e transazioni (art. 2113 c.c.), nel disporre l’equiparazione al
lavoro subordinato dei rapporti di lavoro autonomo caratterizzati da un’attività
prevalentemente personale continuativa e coordinata ma non subordinata, come
il contratto di agenzia o la rappresentanza commerciale, riconosce che l’inserzione
nell’altrui organizzazione di impresa con carattere continuativo e coordinato è
elemento tipico ma non esclusivo del lavoro subordinato, potendo riguardare
anche il lavoro autonomo svolto non nei confronti del mercato, ma di un unico
committente.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono, dunque, prima di
tutto, rapporti di lavoro autonomo che si distinguono e si caratterizzano, rispetto
ai rapporti di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 del Codice Civile, per la natura
coordinata e continuativa della prestazione d’opera.
La diversa accezione dell’elemento della continuità
In effetti, nella prestazione d’opera coordinata e continuativa l’attività del
lavoratore è collegata stabilmente al ciclo produttivo, e quindi inserita
nell’impresa, sebbene lo stesso lavoratore non sia vincolato a tenersi a disposizione
del committente.
Secondo la giurisprudenza, la continuità della prestazione si identifica con la sua
reiterazione nel tempo e caratterizza la parasubordinazione per la sua non
occasionalità.
Il contratto d’opera e la funzione di durata
Un’attività continuativa e coordinata prestata a favore di un’impresa può conferire
anche al contratto di lavoro autonomo una funzione di collaborazione analoga a
quella subordinata. L’analogia si spiega in quanto ogni volta che il lavoro autonomo
è finalizzato alla produzione di un risultato stabilmente integrato nell’attività del
committente, anche il contratto d’opera si caratterizza per la sua funzione di
durata.
Un contratto d’opera si caratterizza per la sua funzione di durata quando è
finalizzato al soddisfacimento di un interesse durevole del creditore.
In sostanza, nel contratto di lavoro coordinato e continuativo ma non subordinato,
solitamente qualificato come parasubordinato, viene soddisfatto un interesse
dell’imprenditore che può definirsi continuativo sul piano della reiterazione nel
tempo delle singole prestazioni di risultato dovute dal lavoratore, ma non sul
9
piano della programmazione o del coordinamento della disponibilità del lavoratore
stesso nello spazio e nel tempo.
La collaborazione coordinata e continuativa: contratto atipico di lavoro
autonomo
La possibilità che anche il contratto d’opera possa assolvere ad una funzione di
durata attraverso la coordinabilità della prestazione di lavoro con
l’organizzazione dell’impresa è stata integralmente rimessa all’autonomia
negoziale delle parti, configurando, come atipico, il contratto di lavoro
autonomo in cui la prestazione sia effettuata con modalità di collaborazione
coordinata e continuativa.
La collaborazione coordinata e continuativa: assenza di disciplina e ruolo della
giurisprudenza
La giurisprudenza ha, per decenni, supplito all’assenza di disciplina del rapporto di
lavoro coordinato e continuativo preoccupandosi di delineare soprattutto i caratteri
della coordinazione, della continuatività della prestazione, al fine di tracciare i
confini tra questo specifico rapporto negoziale, il lavoro autonomo vero e
proprio da un lato ed il rapporto di lavoro subordinato dall’altro.
Nel corso degli anni la giurisprudenza, nel tentativo di inquadrare la fattispecie si è
soffermata soprattutto sulla persona del prestatore e sul modo della prestazione
trascurando l’oggetto della prestazione stessa, ovvero il risultato.
L’opera fornita dal lavoratore parasubordinato è stata oggetto di attenzione da parte
della giurisprudenza solo nel ristretto ambito dei rapporti tra soci e società
cooperativa ed al solo fine di individuare gli elementi caratterizzanti il rapporto
cooperativistico-societario rispetto a quello lavorativo vero e proprio.
La anomala diffusione dei contratti di collaborazione coordinati e continuativi
L’assenza di disciplina sostanziale dell’istituto, unita all’assoggettamento a
contribuzione previdenziale ridotta rispetto a quella gravante sul lavoro subordinato,
ha favorito un’ampia diffusione delle collaborazioni coordinate e continuative che, di
fatto, rispondevano a durevoli esigenze organizzative dell’impresa senza però
implicare l’applicazione dello statuto protettivo del diritto del lavoro al
collaboratore, considerato un libero prestatore d’opera malgrado la sua dipendenza
economica dall’organizzazione del committente.
La riconduzione della collaborazione coordinata e continuativa come species del
genus lavoro autonomo, infatti, impedisce di applicare lo speciale regime protettivo
del lavoro subordinato, demandando all’autonomia negoziale delle parti, ex art. 1322
del codice civile, la determinazione del concreto assetto degli interessi.
L’intervento del legislatore
L’ampia diffusione dell’utilizzo inappropriato del contratto di collaborazione
coordinato e continuativo ha portato il legislatore del 2003, con la riforma del
mercato del lavoro, ad intervenire prevedendo l’estensione parziale di alcune
10
forme minime di tutela a favore del prestatore di lavoro parasubordinato
attraverso la disciplina della collaborazione continuativa “a progetto” disciplinata
dagli artt. 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Si rileva, comunque, che la riforma in questione non è estesa alla pubblica
amministrazione, che resta esclusa dall’obbligo di applicare la disciplina della
collaborazione continuativa a progetto.
Il lavoro a progetto
Nel tentativo di specificare i tratti caratterizzanti della fattispecie, il legislatore ha
previsto che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409, n. 3 c.p.c., devono
essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività
lavorativa” (art. 61, d.lgs. 276/03).
Il contratto di lavoro a progetto, da stipularsi in forma scritta, viene espressamente
ricondotto, dal legislatore, all’ambito del lavoro autonomo.
LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La qualificazione del rapporto di lavoro
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro la volontà dichiarata dalle parti,
c.d. nomen iuris, non ha rilievo assorbente, dovendo invece riconoscersi rilievo
prevalente al concreto contenuto del rapporto e alle sue effettive modalità di
svolgimento.
Infatti, in caso di contrasto tra dato formale (rapporto cartolare) e dato fattuale
(esecuzione della prestazione) deve essere dato rilievo al secondo, dato che la
tutela relativa al lavoro subordinato per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale
non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia che non risulta essere
rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto.
La questione della qualificazione del rapporto di lavoro presenta rilievo pratico
essenziale giacché la disciplina del diritto del lavoro nel corso della sua evoluzione
storica si è assestata sulla inscindibilità del binomio fattispecie/effetti.
Il nomen iuris e la qualificazione del rapporto di lavoro
Nella determinazione della natura di un rapporto di lavoro deve essere
analizzato il contenuto del contratto con riguardo sia alla qualificazione
espressamente indicata, sia al regolamento di interessi adottato nell’intero testo
negoziale, indipendentemente dal nomen iuris.
Il nomen iuris, ovvero quello attribuito dal legislatore alla fattispecie contrattuale, è
vincolante per l’interprete solo nei limiti in cui le concrete caratteristiche del
11
rapporto di lavoro riproducono quelle del tipo legale indicato dalle parti
contraenti, ad esempio: il nomen iuris corrisponde al contratto di lavoro a progetto,
le caratteristiche del rapporto di lavoro sono quelle tipiche del lavoro a progetto così
come definite dal legislatore.
La qualificazione del rapporto di lavoro secondo la giurisprudenza
Ad ogni modo la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro operata dal
legislatore non è mai preclusiva dell’accertamento giudiziale della reale situazione
di subordinazione in contrasto con il contenuto formale del contratto.
Al riguardo, va ribadito il prevalente orientamento della Corte di Cassazione secondo
cui la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione
del contratto non è determinante stante la attitudine del comportamento delle parti,
nei rapporti di durata, ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale sia
una diversa nuova volontà.
Il comportamento delle parti va dunque considerato e valorizzato proprio
perché idoneo a render manifesto il concreto assetto che esse hanno inteso
imprimere ai loro rapporti, a prescindere dal carattere confermativo o non della
originaria qualificazione da esse voluta, fermo restando il ruolo di questa nei casi,
peraltro marginali, in cui ogni altra circostanza complessivamente valutata non offra,
ai fini della qualificazione del rapporto, elementi decisivi in un senso o nell’altro.
La divergenza tra nomen iuris ed effettivo contenuto del contratto
Una costante giurisprudenza ha affermato che la divergenza tra nomen iuris e
contenuto effettivo del rapporto di lavoro può verificarsi in tre casi:
a) quando le parti contraenti nel negozio giuridico fanno espressamente
riferimento ad un rapporto di collaborazione autonoma per evitare i costi
derivanti da un regime di subordinazione;
b) quando l’espressione letterale abbia tradito la vera intenzione dei contraenti;
c) quando le parti contraenti, al momento della conclusione del contratto, pur
volendo costituire un rapporto di lavoro autonomo, nella fase esecutiva
mostrino, attraverso fatti concludenti, di aver cambiato intenzione.
La controversa qualificazione giuridica
Di fronte a un concreto rapporto di lavoro di cui sia controversa la qualificazione
giuridica, quale che sia il nomen iuris utilizzato dalle parti, occorre verificare se esso
sia riconducibile entro lo schema negoziale astratto del lavoro subordinato o,
viceversa, nella categoria contrapposta del lavoro autonomo.
Nei fatti, se nella maggior parte dei casi la riconducibilità all’uno piuttosto che
all’altro schema negoziale è pacifica, in quanto entrambi i contratti presentano dati di
tipicità chiaramente avvertiti nella coscienza sociale. Tuttavia esiste un notevole
contenzioso riguardante fattispecie di confine tra l’autonomia e la
subordinazione, come nel caso del lavoro parasubordinato.
L’identificazione della fattispecie concreta spetta al giudice di merito, come
stabilito dalla Corte Costituzionale in una pronuncia del 1975.
12
La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo viene
operata essenzialmente attraverso due metodologie, che consentono al giudice di
ricondurre un rapporto di natura incerta alla fattispecie legale disciplinata dell’art.
2094 del codice civile: si tratta del metodo sillogistico o sussuntivo e del metodo
tipologico.
I criteri utilizzati dalla giurisprudenza
La giurisprudenza nell’identificare gli elementi costitutivi della fattispecie tipica del
rapporto di lavoro subordinato individua essenzialmente dei criteri classificabili in
ordine gerarchico secondo tre gruppi:
a) i criteri assolutamente prioritari propri del vincolo di subordinazione come
l’eterodirezione (direzione di un altro soggetto);
b) i parametri esterni al contenuto dell’obbligazione come la collaborazione,
l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro e la continuità della
prestazione;
c) i criteri residuali come il vincolo dell’orario di lavoro, la forma della
retribuzione, l’incidenza del rischio e l’oggetto della prestazione.
I criteri propri del vincolo di subordinazione: la eterodirezione
Secondo la giurisprudenza ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come
autonomo o subordinato assume rilievo prioritario e decisivo l’indagine sulla
sussistenza del requisito della subordinazione inteso come assoggettamento del
lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro,
c.d. eterodirezione.
L’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro rappresenta
il tratto distintivo essenziale della subordinazione. L’assoggettamento a
eterodirezione va inteso come modo di essere della prestazione lavorativa e non
dell’attività svolta; infatti, non rileva la conformità dell’attività lavorativa alle
direttive del datore di lavoro ma l’assunzione da parte del lavoratore di un obbligo di
obbedienza.
Parte della giurisprudenza sostiene che ai fini dell’individuazione
dell’eterodirezione è rilevante la posizione di dipendenza gerarchica che si
instaura tra il datore di lavoro e il prestatore, di fatto sottoposto all’iniziativa
unilaterale e agli ordini della controparte.
I parametri esterni al contenuto dell’obbligazione: la collaborazione
La prevalente giurisprudenza identifica la collaborazione come il collegamento
funzionale della prestazione lavorativa con la struttura organizzativa aziendale
che si realizza mediante l’inserzione organica, continuativa e sistematica del
lavoratore nell’organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell’impresa
nella quale egli opera.
In tal senso la collaborazione è considerata un elemento essenziale per la
qualificazione della fattispecie e accanto alla subordinazione rappresenta la nota
distintiva del rapporto di lavoro subordinato.
13
I parametri esterni al contenuto dell’obbligazione: l’inserimento e la continuità
L’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale si desume dalle
concrete modalità di svolgimento della prestazione e si realizza nel modo in cui le
energie del prestatore, messe a disposizione del datore, vengono da quest’ultimo
concretamente utilizzate e coordinate funzionalmente all’interno della sua
organizzazione.
La continuità più che un indicatore qualificante della fattispecie costituisce un
elemento costitutivo e strutturale del rapporto di lavoro subordinato. Il carattere
saltuario o discontinuo di una prestazione può essere compatibile con il criterio della
continuità solo a condizione che tra una prestazione e l’altra il lavoratore resti a
disposizione del datore di lavoro.
I criteri residuali
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, al fine di accertare l’esistenza di
della subordinazione in una fattispecie di natura controversa, possono utilizzarsi in
via sussidiaria, o residuale, elementi di valutazione, quali:
a) l’osservanza di un determinato orario di lavoro;
b) l’importo fisso e la cadenza regolare della retribuzione;
c) l’assenza del rischio della prestazione da parte del lavoratore.
Il vincolo dell’orario di lavoro
Secondo un orientamento formalistico, il vincolo dell’orario di lavoro
rappresenta un elemento imprescindibile del rapporto di lavoro subordinato, nel
cui ambito il lavoratore non gode di alcuna discrezionalità in merito a modi e tempi
della propria attività.
La giurisprudenza prevalente ritiene, invece, che la determinazione e l’osservanza
di un determinato orario di lavoro non incidano sulla continuità della prestazione, in
quanto possono essere subordinati anche rapporti di lavoro non giornalieri o con
orario libero.
Pertanto la mancanza di un vincolo di orario determinato non è sufficiente ad
escludere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La forma della retribuzione
L’esistenza di un corrispettivo per una prestazione di lavoro non fa presumere di
per sé un rapporto di lavoro subordinato, in quanto anche il rapporto di lavoro
autonomo si caratterizza per la onerosità dell’obbligazione.
Presenta, invece, utilità nella qualificazione del rapporto di lavoro la forma della
retribuzione.
Il riferimento ad istituti retributivi propri del lavoro subordinato quali un minimo di
retribuzione periodica, la tredicesima e la quattordicesima mensilità offre al
giudice di merito la possibilità di ricondurre la prestazione, in tal modo retribuita, allo
schema del lavoro subordinato. Inoltre, la percezione di un compenso fisso
14
mensile, anche per periodi di ferie, costituisce criterio distintivo di lavoro
subordinato.
L’incidenza del rischio della prestazione
La diversa ripartizione del rischio della prestazione nel rapporto di lavoro
subordinato e nel rapporto di lavoro autonomo di per sé non è sufficiente a
qualificare il rapporto di lavoro; infatti, vi sono rapporti di lavoro subordinato in
cui il rischio emerge in modo palese, così come vi sono ipotesi di lavoro autonomo,
come le professioni intellettuali, in cui il rischio è molto attenuato.
Ad ogni modo è possibile affermare che qualora il rischio riguardi solo la
retribuzione e non il risultato dell’attività esso rappresenta un chiaro indice per
qualificare un rapporto quale subordinato.
La giurisprudenza ha, comunque, rilevato l’indispensabilità di tale indice per la
qualificazione di un rapporto quando si configuri una prestazione in cui il prestatore
potrebbe rivestire la qualità di imprenditore e come tale eseguire la propria attività
autonoma all’interno o a favore dell’impresa committente.
Gli indici di subordinazione
La presenza degli indici appena definiti può non rivelarsi dirimente ai fini della
qualificazione del rapporto di lavoro in contesti organizzativi che sono
caratterizzati da notevole grado di autonomia nell’esecuzione della prestazione
di lavoro.
La giurisprudenza costante della Cassazione ritiene, in tali casi, che sia decisiva
l’assunzione, nello stesso contratto, dell’obbligazione di porre a disposizione del
datore di lavoro le proprie energie lavorative impiegandole con continuità, fedeltà e
diligenza attenendosi alle direttive di ordine generale e in funzione dei programmi cui
è destinata la prestazione di lavoro.
Gli effetti diretti della subordinazione
È indispensabile definire con esattezza la qualificazione del rapporto in quanto solo
dalla sua qualificazione come lavoro subordinato discendono, come effetti,
l’applicazione delle normative del diritto del lavoro e della previdenza sociale.
Dalla qualificazione della fattispecie lavoro subordinato discendono effetti diretti e
indiretti. Gli effetti diretti sono quelli destinati a incidere sul contenuto del rapporto
di lavoro e quindi sul regolamento contrattuale, come ad esempio il diritto alla
retribuzione, alle ferie, al TFR, alla giustificazione del licenziamento,
all’applicazione dei contratti collettivi.
Gli effetti indiretti della subordinazione
Gli effetti indiretti sono destinati a incidere sui presupposti e sulle conseguenze della
costituzione del rapporto di lavoro, che è collegato ad una serie di situazioni
soggettive esterne al rapporto ma da esso scaturenti e di rilevanza previdenziale o
amministrativa o addirittura penale, come ad esempio la sicurezza del lavoro.
15
Tra i più rilevanti effetti indiretti derivanti dalla costituzione del rapporto di lavoro
subordinato vi è la costituzione obbligatoria (imposta ope legis sul presupposto
dell’esistenza del rapporto di lavoro) del rapporto giuridico previdenziale,
intercorrente tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale, volto ad
assicurare, attraverso un meccanismo di contribuzione obbligatoria da parte del
datore di lavoro e, in diversa misura, del lavoratore, la copertura dal bisogno
rispetto a una serie di situazioni di rischio (cd. rischio sociale) che possono ridurre la
capacità lavorativa e di produzione di reddito del lavoratore (malattia, infortunio,
gravidanza, disoccupazione involontaria, disoccupazione temporanea o parziale,
vecchiaia).
GLI OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI LAVORO
Gli obblighi essenziali della prestazione di lavoro.
Come abbiamo già avuto modo di vedere, l’obbligazione di lavoro vincola il
prestatore a sottoporsi alle direttive del datore di lavoro durante l’esecuzione
della prestazione.
Il codice civile fissa gli obblighi essenziali della prestazione di lavoro subordinato
che sono la diligenza e l’obbedienza. L’osservanza di tali obblighi consente di
stabilire se il debitore della prestazione di lavoro subordinato sia adempiente o meno
rispetto all’obbligazione assunta.
L’orientamento della dottrina
Secondo la dottrina giuslavoristica si tratta di obblighi integrativi e strumentali
rispetto all’adempimento dell’obbligazione di lavoro. Essi infatti non realizzano
situazioni soggettive autonome o separate rispetto all’obbligazione principale del
lavoratore, nel senso che la loro violazione si risolve nell’inadempimento o
nell’inesatto adempimento della prestazione lavorativa.
In altre parole, diligenza ed obbedienza individuano i parametri di valutazione
oggettiva dell’esatto adempimento del lavoratore.
L’obbligo di diligenza.
La diligenza è prevista dal primo comma dell’art. 2104 del codice civile che recita:
“il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della
prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della
produzione nazionale”.
Tale dettato normativo si pone come una specificazione del più generale principio
previsto dall’art. 1176 del Codice Civile secondo il quale il debitore, nell’adempiere
alla propria obbligazione, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e,
nell’adempimento di obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la
diligenza deve essere valutata in riguardo alla natura dell’attività esercitata.
16
È subito evidente il collegamento tra le due norme nel richiamo alla natura della
prestazione e alla natura dell’attività esercitata.
La diligenza quale obbligo relativo
Poiché l’attività esercitata dal prestatore di lavoro viene organizzata
dall’imprenditore, la diligenza dovrà essere commisurata al risultato dell’attività
di organizzazione posta in essere dal datore di lavoro, in quanto quest’ultimo non
detiene un generico interesse all’esatto adempimento della prestazione da parte del
debitore, ma uno specifico interesse all’esercizio dell’attività lavorativa alle
proprie dipendenze e da egli stesso organizzata. Tutto questo nella norma è
riconducibile al parametro dell’interesse dell’impresa, mentre è da ritenere non più
attuale il parametro costituito dall’interesse superiore della produzione nazionale,
ispirato all’ideologia corporativa vigente all’epoca dell’emanazione del codice civile.
Non esiste, dunque, un obbligo autonomo di diligenza ma un obbligo relativo ed
inerente all’esecuzione della prestazione lavorativa.
La regola della diligenza non individua l’oggetto o l’ambito dell’obbligazione
lavorativa ma opera al fine di valutare la conformità del comportamento tenuto dal
debitore a quello dovuto dal creditore.
Diligenza e perizia
Secondo la dottrina prevalente, la diligenza si identifica con la perizia del
lavoratore subordinato e per converso l’imperizia o la negligenza realizzano un
inadempimento del contratto di lavoro.
La perizia, in termini generali, viene definita come l’insieme di conoscenze ed
esperienze tecniche di cui il lavoratore deve essere provvisto per poter espletare
una determinata prestazione lavorativa.
Vi è un altro orientamento della dottrina che identifica la diligenza con la perizia,
intesa quale osservanza delle regole tecniche che presiedono all’esecuzione della
prestazione di lavoro. In tal senso, la diligenza si configura non solo come modalità
tecnica della prestazione ma piuttosto come regola che coinvolge la professionalità
del lavoratore chiamato ad individuare autonomamente i modi più efficienti ed
efficaci per raggiungere l’obiettivo affidato.
L’obbedienza del lavoratore
L’altro obbligo caratteristico dell’obbligazione di lavoro è dettato dal secondo
comma dell’art. 2104 del codice civile ed è il dovere di obbedienza.
L’obbedienza consiste nell’osservanza, da parte del prestatore di lavoro, delle
disposizioni impartite dal datore di lavoro o da suoi collaboratori per
l’esecuzione dell’attività lavorativa e per la c.d. disciplina del lavoro.
Si rileva che l’individuazione del contenuto e dei limiti del dovere di obbedienza del
lavoratore subordinato rappresenta un tema controverso nella dottrina giuslavoristica.
Caratteristiche dell’obbedienza
17
Secondo la tesi prevalente della dottrina, l’obbedienza costituisce un elemento
implicito nella condizione di assoggettamento del lavoratore, l’espressione del
lato passivo della subordinazione nel momento esecutivo della prestazione.
Pertanto, secondo questa interpretazione, non esiste un autonomo dovere di
obbedienza ma anche l’obbedienza è un modo di essere della subordinazione.
L’obbedienza, infatti, si riferisce alle prescrizioni e agli ordini impartiti dal datore di
lavoro, ovvero dai superiori gerarchici, concernenti l’organizzazione del lavoro, la
disciplina e la vita di relazione in azienda.
L’obbedienza contrapposta al potere direttivo
In merito al dovere di obbedienza, dalla lettera della norma si desume oltre che la
situazione soggettiva passiva del debitore nell’obbligazione di lavoro, anche la
situazione soggettiva attiva del creditore che detiene il potere direttivo.
L’esercizio del potere direttivo previsto in capo all’imprenditore, creditore del
rapporto di lavoro, può essere demandato anche ai suoi collaboratori : questa
situazione si configura quale manifestazione di un’autorità di tipo gerarchico che
dall’imprenditore discende verso i collaboratori di grado inferiore nella scala
gerarchica dell’organizzazione d’impresa.
Potere direttivo e potere disciplinare
In sostanza, come disposto dall’art. 2104 del codice Civile, il potere direttivo del
datore di lavoro si estrinseca in due tipologie di comportamento, da un lato le
disposizioni impartite dall’imprenditore inerenti all’esecuzione della prestazione
e quindi all’organizzazione dell’attività lavorativa (potere direttivo); dall’altro le
disposizioni impartite relative alla disciplina del lavoro, cioè alla
regolamentazione dei rapporti collaborativi all’interno dell’organizzazione di
impresa (potere disciplinare).
L’obbligo di fedeltà
Oltre agli obblighi di diligenza ed obbedienza, il codice civile prevede, in capo al
prestatore di lavoro, un ulteriore obbligo: l’obbligo di fedeltà. Infatti, l’art. 2105 del
codice civile dispone: “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto
proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie
attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in
modo da poter arrecare ad essa pregiudizio”.
L’obbligo di fedeltà quale obbligo accessorio
L’obbligo di fedeltà che si pone come obbligo accessorio a quello principale, relativo
alla prestazione di lavoro, si sostanzia in due divieti, quello di concorrenza e
quello di divulgazione dei segreti aziendali, c.d. obbligo di fedeltà in senso
stretto.
Più in generale rientra nei c.d. obblighi di protezione che l’ordinamento ha posto
in essere a tutela dell’imprenditore, il quale deve proteggersi dalla possibile
concorrenza del lavoratore.
18
Il divieto di concorrenza
Il divieto di concorrenza si estrinseca nell’obbligo, in capo al lavoratore, di
astenersi dal trattare affari in concorrenza con l’impresa. Tale divieto, insito
nell’esistenza di un contratto di lavoro, permane esclusivamente durante tutta la
durata dello stesso, sebbene l’art. 2125 preveda la possibilità di stipulare un
patto di non concorrenza, tra il datore di lavoro ed il lavoratore, che vada oltre la
durata del contratto. Infatti il patto di non concorrenza può essere previsto per un
periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro pur non potendo superare i
cinque anni per quanto riguarda i dirigenti ed i tre anni per tutte le altre categorie di
lavoratori. Perché il patto sia valido è richiesta la forma scritta ad substantiam. Inoltre
è necessario che il vincolo in esso contenuto delimiti l’oggetto ed il luogo oltre a
stabilire un corrispettivo per il lavoratore.
L’obbligo di fedeltà in senso stretto
Per quanto concerne l’obbligo di fedeltà in senso stretto esso, a differenza del
divieto di concorrenza, consiste nel divieto di divulgare o utilizzare a vantaggio
proprio o di terzi, notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di produzione
dell’impresa.
In tal caso il lavoratore è tenuto al rispetto dei segreti di cui viene a conoscenza
nel contesto della prestazione di lavoro al fine di non arrecare pregiudizio
all’attività dell’impresa diffondendo informazioni che potrebbero mettere a
repentaglio la competitività stessa dell’impresa.
Tale obbligo trova tutela anche da parte della disciplina penale con gli artt. 621 e
seguenti del codice penale.
Il segreto aziendale
Nell’ambito dell’obbligo di fedeltà in senso stretto si annovera il c.d. segreto
aziendale che consiste, appunto, nell’obbligo, in capo a tutti i dipendenti del datore di
lavoro, di mantenere il silenzio nei confronti degli estranei su notizie riservate
conosciute in occasione della propria prestazione di lavoro nell’impresa.
Va sottolineato che il segreto aziendale è tutelato anche in sede penale secondo
quanto disposto dagli artt. 621 del codice penale.
Il segreto professionale
Altra declinazione dell’obbligo di fedeltà in senso stretto è il segreto
professionale, che consiste nell’obbligo che grava sui prestatori che rivestono una
speciale qualifica o funzione di mantenere il silenzio su notizie riservate conosciute
a motivo delle proprie personali incombenze.
Il segreto professionale è tutelato in sede penale dall’art. 622 del codice penale.
Il segreto industriale e scientifico
19
L’ultima declinazione dell’obbligo di fedeltà in senso stretto è il segreto
industriale e scientifico che consiste nell’obbligo in capo al prestatore di tenere il
silenzio limitatamente alle scoperte o invenzioni scientifiche e alle relative
applicazioni al processo produttivo.
Il segreto industriale e scientifico è tutelato in sede penale dall’art. 623 del codice
penale.
L’inosservanza degli obblighi del prestatore
Tornando agli obblighi previsti in capo al lavoratore dagli art. 2104 e 2105, cioè
l’obbedienza e la diligenza e l’obbligo di fedeltà, l’art. 2106 c.c. dispone che
l’inosservanza degli stessi da luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari in
conformità alle norme previste dalla contrattazione collettiva e in proporzione
alla gravità dell’infrazione commessa.
I contratti collettivi prevedono le c.d. mancanze, cioè inadempienze del
lavoratore, elencandole insieme alle relative sanzioni disciplinari che vanno dal
rimprovero verbale o scritto, alla multa, e ancora dalla sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione fino alla massima sanzione prevista che è il licenziamento disciplinare. Il
criterio di proporzionalità previsto dall’art. 2106 costituisce un limite generico al
potere disciplinare del datore di lavoro, che consentirebbe un’applicazione elastica
e soggettiva della valutazione. Ecco la ragione per cui sono stati introdotti ulteriori
limiti sostanziali e procedurali con la Legge n. 300 del 1970, meglio nota come
Statuto dei lavoratori.
I POTERI DEL DATORE DI LAVORO
Il potere direttivo del datore di lavoro
Dalla lettera del secondo comma dell’art. 2104 del codice civile, che disciplina il
dovere di obbedienza del lavoratore, si desume anche la situazione soggettiva attiva
del creditore che detiene il potere direttivo.
L’esercizio del potere direttivo previsto in capo all’imprenditore, titolare del
rapporto di lavoro, può essere demandato anche ai suoi collaboratori e questa
situazione si configura quale manifestazione di un’autorità di tipo gerarchico che
dall’imprenditore discende verso i collaboratori di grado inferiore nella scala
gerarchica dell’organizzazione d’impresa. In sostanza, come disposto dall’art. 2104
del codice civile il potere direttivo del datore di lavoro si estrinseca in due
tipologie di comportamento: da un lato le disposizioni impartite
dall’imprenditore inerenti l’esecuzione della prestazione e quindi
l’organizzazione dell’attività lavorativa, dall’altro le disposizioni relative alla
disciplina del lavoro cioè alla regolamentazione dei rapporti collaborativi
all’interno dell’organizzazione di impresa.
Il potere disciplinare del datore di lavoro
Prima di passare all’analisi dei limiti sostanziali e procedurali posti al potere
disciplinare del datore di lavoro è bene soffermarsi sul significato del potere
20
disciplinare stesso. Così come il potere direttivo, anche il potere disciplinare è
espressione dell’autorità gerarchica del datore di lavoro e trova il suo
fondamento nella responsabilità contrattuale del prestatore. Infatti il potere
disciplinare può essere considerato il riflesso della subordinazione in relazione
all’inadempimento. In generale, nella disciplina civilistica dei contratti è
riconosciuta all’autonomia negoziale la possibilità di prevedere sanzioni punitive
dell’inadempimento, come ad esempio la clausola penale prevista dall’art 1382 c.c.,
per cui il potere disciplinare del datore di lavoro, inteso quale potere privato
unilaterale di reagire all’inosservanza degli obblighi contrattuali attraverso
l’applicazione di misure punitive, pur essendo un tratto peculiare del rapporto di
lavoro, non può ritenersi estraneo al diritto privato.
I limiti ai poteri del datore di lavoro
Come anticipato, la disciplina prevista dal codice civile in relazione al potere
direttivo ed al potere disciplinare, è stata integrata dalle norme dello Statuto dei
lavoratori del 1970.
Tali norme hanno l’obiettivo di tutelare la libertà e la dignità del lavoratore e a tal
fine hanno posto una serie di limiti all’esercizio dei poteri del datore di lavoro, pur
salvaguardando la struttura formale degli stessi che rimane quella delineata dal codice
civile. In particolare, le innovazioni più significative introdotte dallo Statuto dei
lavoratori riguardano i limiti sostanziali e procedurali posti al potere disciplinare.
I limiti procedurali
Per quanto concerne i limiti procedurali, l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori dispone
che per poter esercitare il potere disciplinare è necessario che venga pubblicato un
regolamento, o meglio codice, disciplinare che deve essere portato a conoscenza di
tutti i lavoratori mediante affissione in un luogo accessibile a tutti. Il codice
disciplinare, in conformità ai contratti collettivi, dove esistenti, deve indicare le
infrazioni e le sanzioni applicabili oltre che le procedure di contestazione
dell’inosservanza allo stesso lavoratore. Inoltre, il dettato normativo dispone che il
provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del lavoratore soltanto
dopo che gli sia stato contestato l’addebito e che egli sia stato sentito a sua difesa.
Infatti, la procedura di contestazione deve essere tale da consentire al lavoratore la
possibilità di difendersi direttamente o attraverso rappresentanti sindacali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la contestazione deve anche essere
immediata e immutabile, nel senso che il datore di lavoro non può addurre
circostanze nuove e di maggiore gravità a giustificazione delle sanzioni disciplinari
comminate.
I limiti sostanziali
Per quanto attiene ai limiti sostanziali posti al potere disciplinare, lo stesso art. 7
dello Statuto dei lavoratori, ai commi 4 e 5 ha disposto l’inammissibilità di
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro operati mediante l’applicazione di
sanzioni disciplinari (ad esempio la retrocessione, il trasferimento), ad eccezione
21
del licenziamento. La stessa norma ha anche introdotto limiti massimi all’entità
delle sanzioni irrogabili, prevedendo ad esempio che l’importo della multa non
possa essere di ammontare superiore alla retribuzione base spettante per quattro ore
lavorative, oppure che la sospensione dal lavoro e della retribuzione non possa essere
di oltre dieci giorni. Inoltre è previsto che i provvedimenti più gravi del rimprovero
verbale non possono essere applicati se non sono trascorsi almeno cinque giorni
dalla contestazione scritta del fatto che ne ha determinato la causa.
Il limite alla rilevanza della recidiva
Altro importante limite sostanziale è quello posto alla rilevanza della recidiva, cioè
della ripetizione nel tempo di inadempienze da parte del prestatore di lavoro. Secondo
l’art. 7, co. 8, dello Statuto non è possibile tenere conto di una sanzione
disciplinare quando siano decorsi due anni dalla sua applicazione. Tale limite
incide su uno degli aspetti pratici di maggiore importanza nell’esercizio del potere
disciplinare, in quanto il datore di lavoro, secondo la legge, nel comminare una
sanzione e nello stabilirne l’entità non può tener conto di quali siano state le
infrazioni commesse nel tempo dal lavoratore ed anche della loro eventuale
ripetizione. Ogni infrazione deve essere sanzionata singolarmente senza tenere conto
di precedenti inosservanze (ovviamente attenendosi ai limiti temporali previsti dal
dettato normativo), altrimenti si correrebbe il rischio di sanzionare più gravemente un
comportamento per il fatto che il lavoratore, nel tempo, ha già commesso altre
violazioni. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso che si possa
tenere conto delle sanzioni precedentemente comminate al fine di valutare il
profilo soggettivo della violazione commessa (Cass. 25 novembre 1996, n. 10441).
L’impugnazione del provvedimento sanzionatorio
Il lavoratore al quale venga comminata una sanzione ha la facoltà di impugnarla nei
venti giorni successivi. I venti giorni decorrono dal momento dell’irrogazione
della sanzione e non dal momento della contestazione, che come abbiamo già detto
deve essere fatta per iscritto almeno cinque giorni prima dell’applicazione del
provvedimento, quando si tratti di una sanzione più grave del rimprovero verbale.
L’impugnazione può avvenire davanti ad un collegio di conciliazione e arbitrato
che può essere previsto dai contratti collettivi oppure essere costituito espressamente
presso la Direzione provinciale del lavoro. L’impugnazione del provvedimento
sanzionatorio ne comporta la sospensione, rendendolo inefficace, quindi, fino al
momento della definizione del giudizio da parte del collegio di arbitrato.
Altri limiti al potere direttivo del datore di lavoro
Nell’esercizio del potere direttivo, il datore di lavoro incontra altri due limiti alla sua
capacità discrezionale, sanciti dagli articoli 8 e 15 dello Statuto dei lavoratori: si tratta
del divieto di indagine sulle opinioni del lavoratore e del divieto di
discriminazione dei lavoratori, a sua volta integrato dall’ art. 13 della legge n. 903
del 1977 sulla parità uomo-donna in ambito lavorativo.
22
Il divieto di indagine sulle opinioni del lavoratore
Quanto al primo divieto previsto in capo al datore di lavoro la norma ha il fine di
tutelare la libertà di espressione e di opinione del lavoratore, che non deve avere
alcuna rilevanza nel rapporto di lavoro, a meno che la manifestazione di opinioni non
abbia stretta attinenza con le finalità perseguite dall’impresa di tendenza e con le
specifiche mansioni per cui il lavoratore è stato assunto (ad esempio, l’editorialista di
una testata giornalistica di un determinato orientamento politico).
Salvo il caso delle cd. imprese di tendenza, il fine prefissato dalla legge è la garanzia
di riservatezza del lavoratore e l’irrilevanza delle sue opinioni rispetto al contenuto
Il divieto di discriminazione dei lavoratori
In merito al divieto di discriminazione dei lavoratori, occorre dire che secondo il
terzo comma dell’art. 15 dello Statuto dei lavoratori “sono nulli i patti o gli atti
diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di
handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni
personali”.
La formulazione, che ricalca quella dell’art. 3 della Costituzione, copre praticamente
i principali fattori di discriminazione che si possono manifestare in ambito lavorativo,
e colpisce con la nullità ogni atto discriminatorio che si verifichi all’interno
dell’impresa in violazione dell’articolo 15, come ad esempio trasferimenti
ingiustificati, mutamenti di mansioni, comminazione di sanzioni disciplinari.
L’effetto della dichiarazione di nullità effettuata dal giudice è la cancellazione degli
effetti dell’atto impugnato.
I limiti al potere di controllo del datore di lavoro
Lo Statuto dei lavoratori pone anche una serie di limiti al potere di controllo che il
datore di lavoro detiene in merito all’esecuzione della prestazione lavorativa. L’art. 2
prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di impiegare guardie giurate
esclusivamente ai fini di tutelare il patrimonio aziendale. Infatti, alle stesse è
preclusa la possibilità di contestare al lavoratore azioni o fatti o comportamenti che
non siano rilevanti ai fini della tutela del patrimonio stesso. Alle stesse guardie non è
consentito di svolgere compiti di vigilanza sull’attività lavorativa al punto tale che ne
viene impedito l’accesso ai locali in cui l’attività lavorativa si svolge, durante
l’orario di lavoro, a meno che non si tratti di specifiche e motivate esigenze di
salvaguardia del patrimonio aziendale.
La finalità di questo dettato normativo è quella di impedire al datore di lavoro di
abusare del proprio potere di supremazia all’interno dell’azienda avvalendosi di
guardie giurate alla proprie dipendenze per controllare l’attività dei prestatori di
lavoro.
Le visite personali
Anche le visite personali di controllo sono finalizzate alla tutela del patrimonio
aziendale. Infatti, l’art. 6 dello Statuto consente tali visite quando siano
indispensabili per la salvaguardia del patrimonio aziendale in relazione alla qualità
23
degli strumenti di lavoro o delle materie prime utilizzate o dei prodotti stessi. In ogni
caso, tali visite sono consentite a patto che siano rispettate la dignità e la
riservatezza del lavoratore, che siano utilizzati sistemi imparziali di selezione dei
lavoratori da sottoporre al controllo, inoltre che il controllo avvenga soltanto
all’uscita dei luoghi di lavoro.
Le modalità di controllo
Le modalità di controllo devono essere concordate con le rappresentanze
sindacali aziendali; in caso di mancato accordo il datore di lavoro può essere
autorizzato, su sua istanza, dalla Direzione provinciale del lavoro.
Il
provvedimento della Direzione provinciale è impugnabile entro 30 giorni davanti al
Ministero del lavoro da parte di tutte le parti interessate.
La Corte costituzionale, con una sentenza del 1980, ha ritenuto che i controlli ex art.
6 dello Statuto non possono mai essere imposti d’autorità, ma devono svolgersi con
il consenso dell’interessato in quanto la presenza di oneri di controllo
volontariamente assunti o concertati in sede sindacale e rispettosi della dignità umana
non determinano alcun contrasto con l’art. 13 della Costituzione, il quale si riferisce
unicamente a potestà coattive dirette a limitare l’autonomia e la disponibilità della
persona.
Il controllo sull’attività lavorativa
Oltre ai controlli finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, lo Statuto dei
lavoratori ha disciplinato, in modo restrittivo, le diverse forme di controllo funzionale
sull’attività lavorativa.
Rispettivamente, l’art. 3 e l’art. 4 dello Statuto prevedono che l’identità del personale
addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa deve essere nota ai lavoratori, e che
sono vietati i c.d. controlli a distanza dei lavoratori stessi.
In merito all’attività di vigilanza va sottolineato che sono esclusi dal dettato
normativo dell’art. 3, che riguarda addetti a mansione di vigilanza specifica, i
collaboratori del datore di lavoro che, ricoprendo una posizione direttiva
nell’organizzazione gerarchica dell’impresa, svolgono un’attività di controllo insita
nella loro posizione (capi-ufficio, capi-reparto).
Il controllo a distanza del lavoratore
Quanto al controllo a distanza del lavoratore, l’art. 4 vieta l’utilizzo di impianti
audiovisivi ed altre apparecchiature che abbiano la sola finalità di vigilare
sull’attività lavorativa.
La norma consente l’impiego di tali dispositivi a patto che vi siano obiettive
esigenze di organizzazione e produzione, o di sicurezza del lavoro. Anche in tal
caso l’utilizzo di impianti va preventivamente concordato con le rappresentanze
sindacali aziendali ed in caso di mancato accordo vige il principio dettato dall’art. 6
in merito alle visite personali di controllo di cui sopra.
A proposito dell’art. 4, è importante segnalare l’acceso dibattito che si è aperto negli
ultimi anni, sia in dottrina sia in giurisprudenza, in merito all’utilizzo di nuove
24
tecnologie. Il problema sostanziale è quello di comprendere se la norma definita
dallo Statuto sia datata oppure se se ne possa dare un’interpretazione ampia tale da
renderla applicabile ai nuovi dispositivi informatici e telematici che consentono un
controllo a distanza sull’attività lavorativa.
Il controllo a distanza del lavoratore: l’orientamento della giurisprudenza
In riferimento all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori si è affermato un orientamento
giurisprudenziale che concorda in merito alla legittimità dell’installazione di impianti
per il controllo a distanza mirato non sull’attività lavorativa, ma su possibili attività
illecite del lavoratore.
Secondo un orientamento della Corte di Cassazione, affinché si possa ritenere
operativo il divieto di utilizzo di apparecchiature per i controlli a distanza
dell’attività dei lavoratori previsto dall’art. 4 è necessario che il controllo riguardi
direttamente o indirettamente l’attività lavorativa, mentre devono ritenersi
certamente fuori dall’ambito di applicazione delle norma i controlli diretti ad
accertare condotte illecite del lavoratore (c.d. controlli difensivi), quali, ad
esempio, l’accesso ad aree riservate.
Gli accertamenti sanitari
Infine, lo Statuto dei lavoratori, all’art. 5, disciplina gli accertamenti sanitari,
ponendo il divieto in capo al datore di lavoro di eseguire accertamenti sulla
idoneità e sulla infermità per malattia o per infortunio del lavoratore
dipendente.
Il controllo sulle assenze del lavoratore per causa di malattia o infortunio può
avvenire soltanto attraverso un accertamento medico effettuato dai servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti, su richiesta del datore di lavoro.
La finalità della norma sugli accertamenti sanitari
La finalità della norma è quella di conciliare il diritto, costituzionalmente
sancito, alla salute del lavoratore con il diritto del datore di lavoro alla
prestazione dovuta.
Al fine di rendere efficaci tali controlli, attraverso successivi interventi legislativi,
sono state previste una serie di misure procedurali, sia per quanto concerne la
certificazione attestante l’infermità da inviare al datore di lavoro ed all’istituto
previdenziale, sia per quanto concerne gli orari di reperibilità del lavoratore e le
sanzioni in caso di assenza del lavoratore durante le visite di controllo.
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Il procedimento disciplinare: presupposti
Nella lezione precedente è stato introdotto il concetto di potere disciplinare che,
nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, si sostanzia nel diritto del datore
di lavoro di esercitare un potere di natura sanzionatoria, a fronte di
25
comportamenti del lavoratore che costituiscano inosservanza degli obblighi
contrattuali.
Il potere disciplinare, dunque, ha l’obiettivo di tutelare l’organizzazione
economica del datore di lavoro assicurando il rispetto degli obblighi contrattuali da
parte del lavoratore. Tale potere del datore di lavoro, fondato sul principio di
subordinazione del prestatore di lavoro, si attua attraverso la comminazione di
sanzioni disciplinari nei riguardi del lavoratore inadempiente.
La sanzione disciplinare non è che l’ultimo atto di una procedura, il c.d.
procedimento disciplinare, i cui termini e fasi sono sanciti espressamente dalla legge
e dalla contrattazione collettiva al punto che, in gran parte dei casi, il mancato
rispetto della procedura può rendere nulla la sanzione.
L’introduzione di limiti al potere disciplinare
La normativa codicistica prevede una serie di obblighi in capo al prestatore di lavoro,
il mancato rispetto dei quali rende il lavoratore inadempiente e consente l’attivazione
della procedura disciplinare da parte del datore di lavoro. Il Codice Civile però, pur
regolando il potere disciplinare del datore di lavoro, non pone ad esso alcun limite né
sostanziale né procedurale, in altre parole non individua una procedura attuativa
del potere disciplinare stesso che tuteli il lavoratore.
Soltanto a seguito della Legge 300 del 1970, comunemente nota come Statuto dei
lavoratori, la disciplina del Codice Civile è stata innovata e, in particolare, l’art. 7
dello Statuto ha introdotto una serie di limitazioni sostanziali e formali
riguardanti l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, al
quale viene comunque riconosciuto il diritto di esercitare il potere disciplinare,
sebbene quest’ultimo debba essere attuato nel rispetto di precise norme anche di tipo
procedurale.
Il procedimento disciplinare: articolazione
In sintesi, ai sensi del citato art. 7 dello Statuto dei lavoratori, il procedimento
disciplinare si articola nelle seguenti fasi:
1. contestazione di addebito
2. formulazione delle giustificazioni
3. comminazione della sanzione disciplinare
4. impugnazione della sanzione da parte del lavoratore
I limiti al potere disciplinare
Più in dettaglio, le prescrizioni introdotte dall’art. 7 della Legge 300 del 1970, ed in
seguito integrate dalle elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza, nonché della
contrattazione collettiva, in particolare, riguardano:
- l’obbligo di pubblicità della normativa disciplinare
- la necessità di una preventiva contestazione e suoi requisiti
- la tempestività della contestazione
- la specificità della contestazione
- la immodificabilità del contenuto della contestazione
26
- la necessità della forma scritta della contestazione
- il divieto di procedere ad indagini preliminari
- il rispetto di un criterio di proporzionalità della sanzione adottata
- l’indicazione di termini e modalità di difesa
- il divieto di mutamenti definitivi del rapporto di lavoro
- i termini per la comminazione del provvedimento
- la recidiva dell’inadempimento
- la sospensione cautelare
- le sedi e le modalità di impugnazione della sanzione disciplinare
Si segnala che esiste un regime normativo e contrattuale specifico che regola gli
aspetti procedurali per quanto attiene i pubblici dipendenti, per i quali si rinvia
alla lezione dedicata.
L’obbligo di pubblicità della normativa disciplinare
Il comma 1 dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dispone, in capo al datore di
lavoro, l’obbligo di “affiggere in luogo accessibile a tutti” il c.d. codice
disciplinare.
Il codice disciplinare contiene l’elenco delle norme disciplinari, delle infrazioni in
relazione alle quali le norme disciplinari possono essere applicate e delle relative
procedure di contestazione.
La normativa disciplinare così formalizzata e pubblicizzata deve essere riconducibile
a quanto stabilito in materia dalla contrattazione collettiva ovvero dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro eventualmente applicato nell’unità produttiva.
Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, l’assenza del codice
disciplinare comporta la nullità del provvedimento adottato. Più precisamente
questo orientamento si applica in relazione alle sanzioni di tipo “conservativo”, vale a
dire quelle sanzioni che non comportano un mutamento definitivo del rapporto di
lavoro come il rimprovero, la multa o la sospensione. Lo stesso orientamento non è
applicabile, invece, al caso del licenziamento disciplinare poiché la gravità degli
inadempimenti che determinano la massima sanzione disciplinare è tale che si
presume possa in ogni caso rientrare nelle ipotesi di giusta causa o di giustificato
motivo di licenziamento.
Obbligo di affissione e licenziamento disciplinare
Per trattare l’argomento in modo esaustivo si anticipa brevemente quanto verrà
meglio esposto nelle lezioni relative al licenziamento disciplinare. Infatti, si rileva
come la conforme giurisprudenza non consideri l’assenza di affissone del codice
disciplinare quale ostacolo alla adozione della sanzione disciplinare del
licenziamento. Questo si giustifica alla luce del fatto che la facoltà del datore di
lavoro di risolvere il rapporto per fatti di grave entità, tali da non consentire la
prosecuzione dell’attività lavorativa, deriverebbe direttamente dalle disposizioni del
Codice Civile e delle leggi speciali in materia di giusta causa e di giustificato motivo
di licenziamento.
27
Pertanto, nel caso di licenziamento disciplinare, la mancata e/o preventiva affissione
del codice disciplinare non comporta, di per sé, l’automatica illegittimità della
sanzione espulsiva comminata.
L’affissione del codice disciplinare
Il codice disciplinare deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori e,
nel caso di imprese articolate in più unità produttive, l’affissione deve essere
effettuata in ciascuna sede, stabilimento e reparto autonomo, ed anche in locali di
terzi dove l’impresa depositi materiali o occupi personale. Inoltre, il codice deve
essere affisso in modo permanente e soprattutto l’affissione deve essere in atto al
momento della commissione della infrazione contestata.
Rientra nel concetto di libero accesso al codice anche la comodità dell’accesso,
ovvero la necessità che non sussistano impedimenti di sorta all’accesso al luogo di
affissione o l’esigenza di particolari permessi per accedere allo stesso. Per quanto
concerne l’idoneità del luogo di affissione la sua valutazione integra un accertamento
di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità.
La pubblicizzazione del codice disciplinare
La pubblicizzazione del codice disciplinare, a parte l’affissione, non può
avvenire con altri mezzi di comunicazione, ancorché considerati equipollenti: tra le
indicazioni fornite dalla giurisprudenza, si rileva che le forme di comunicazione
indirizzate singolarmente a ciascun lavoratore non sono ritenute valide ai fini
della pubblicizzazione del codice disciplinare aziendale, così come non lo sono gli
avvisi in bacheca indicanti la possibilità di consultare il contratto collettivo o il
codice disciplinare custoditi in altri luoghi. Infatti, nei numerosi pronunciamenti
giurisprudenziali che escludono la validità di forme di pubblicità equivalenti
all’affissione, si annoverano: la consegna ai singoli lavoratori di copia del contratto
collettivo nazionale; la disponibilità del codice presso i locali della RSU o presso gli
uffici aziendali; la stessa integrale affissione del contratto collettivo nazionale.
Si rileva che parte della dottrina propendeva per forme equivalenti di
pubblicizzazione in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo,
ma dirimente è stata una pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite (la
sentenza n. 1208 del 5.2.88) che ha ribadito la necessità di affissione del codice
disciplinare escludendo forme alternative di pubblicità dello stesso.
Divieto di procedere ad indagini preliminari
Il datore di lavoro non può procedere ad indagini preliminari prima che venga
formalmente contestato l’addebito al lavoratore. Sul punto occorre tuttavia una
precisazione, sono infatti state ritenute legittime brevi indagini preliminari volte
all’esclusivo fine di consentire al datore di lavoro di acquisire gli elementi necessari
per assumere la decisione di attivare la procedura, e ciò purché dette indagini
preliminari non si trasformino in una anticipata procedura sommaria.
28
La contestazione dell’addebito
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore, ad eccezione del rimprovero verbale, senza avergli
preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua discolpa.
Affinché la procedura disciplinare sia valida occorre che la contestazione sia
formulata per iscritto e contenga in maniera precisa i fatti contestati; si deve ritenere
esclusa la possibilità di una contestazione priva di forma scritta, infatti, in difetto
della forma scritta nessuna sanzione adottata è legittima.
La contestazione deve soddisfare alcuni requisiti ai fini della sua legittimità:
1. specificità: il datore di lavoro deve fornire tutte le indicazioni necessarie ed
essenziali al fine di individuare il fatto specifico contestato;
2. immediatezza: l’addebito deve essere tempestivamente contestato. Il principio
dell’immediatezza deve essere valutato con riferimento al momento della
commissione o della conoscenza del fatto contestato, e deve essere inteso
secondo buona fede; esso è compatibile con quel lasso di tempo che risulti
necessario per il puntuale accertamento della condotta del lavoratore;
3. immutabilità: i fatti oggetto del provvedimento disciplinare devono coincidere
con i fatti oggetto della avvenuta contestazione.
Specificità della contestazione
La specificità della contestazione è il terzo principio introdotto dall’art. 7 della
Legge 300 del 1970 secondo il quale una contestazione generica, non riconducibile a
fatti concreti, circostanziati e circoscritti nel tempo, vìola il diritto alla difesa del
lavoratore poiché gli impedisce una conoscenza adeguata dell’addebito mosso e
comporta, di conseguenza, la nullità della sanzione disciplinare adottata
successivamente.
Tempestività della contestazione
L’art. 7 dello Statuto non indica un termine preciso per l’irrogazione della sanzione
disciplinare, si intende in ogni caso che la comunicazione del provvedimento
debba avvenire rispettando un criterio di tempestività.
La giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, ha ribadito che è necessario, ai fini
della validità del successivo provvedimento disciplinare, che la contestazione dei fatti
avvenga tempestivamente, sia per consentire al lavoratore di esercitare in modo
efficace il proprio diritto alla difesa, sia perché da parte del datore di lavoro deve
essere applicato un criterio di correttezza e buona fede nell’esercizio del potere
disciplinare.
In altri termini, pur non essendo previsto un rigido termine entro il quale la
contestazione debba essere emessa, la conforme giurisprudenza ha sottolineato la
necessità della attivazione della procedura con “sollecitudine”, condizione
ineliminabile per garantire al dipendente una effettiva possibilità di esercitare in
modo adeguato ed efficace il proprio diritto di difesa.
Al riguardo i contratti collettivi nazionali dei settori della pubblica
amministrazione stabiliscono il termine perentorio entro il quale la
29
contestazione deve essere comunicata, che non può superare i 10 o 20 giorni
dalla data in cui la pubblica amministrazione è venuta a conoscenza dei fatti
contestati a seconda della gravità dell’addebito e dell’organo competente a
gestire la specifica procedura disciplinare.
I termini per la contestazione
La contrattazione collettiva è intervenuta in numerosi casi stabilendo un termine
massimo entro il quale il datore di lavoro deve comunicare l’irrogazione della
sanzione. In particolare, sono stati previsti dei termini per l’irrogazione della
sanzione nei contratti collettivi nazionali di lavoro dell’industria meccanica e
chimica, del terziario e dei pubblici esercizi.
Il mancato rispetto dei termini stabiliti dalla contrattazione comporta la nullità
della sanzione disciplinare.
Immodificabilità del contenuto della contestazione
Altro requisito necessario per la validità del provvedimento disciplinare è ravvisato
dalla giurisprudenza nell’immodificabilità del contenuto della contestazione
rivolta al lavoratore.
È, pertanto, illegittima la sanzione disciplinare adottata con motivazioni
differenti da quelle contenute nella lettera di contestazione, o addirittura, come
spesso si constata, sulla base di fatti e circostanze ulteriori di cui il lavoratore viene a
conoscenza solo in occasione della emanazione della sanzione.
La difesa del lavoratore
Il comma quinto dell’ art. 7 stabilisce che i provvedimenti disciplinari non possono
essere adottati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione scritta
dell’addebito, ovvero decorso il più lungo termine eventualmente indicato dal
contratto collettivo di lavoro.
Entro cinque giorni di calendario dalla ricezione della contestazione, il
lavoratore può produrre le proprie difese e controdeduzioni in forma scritta o
orale avvalendosi, se lo ritiene opportuno, dell’assistenza di un rappresentante
sindacale.
La sanzione, diversa dal rimprovero verbale, eventualmente irrogata prima dello
scadere dei cinque giorni è nulla, fatta salva l’ipotesi in cui il lavoratore abbia
efficacemente presentato al suo datore di lavoro le sue giustificazioni entro il termine
ordinario e non si sia riservato di produrre ulteriore documentazione a suo discarico,
o non abbia manifestato la volontà di voler essere riascoltato dal medesimo entro la
scadenza del termine.
Le controdeduzioni del lavoratore, a sua difesa, devono pervenire al datore di
lavoro entro i cinque giorni decorrenti dalla data di ricezione della contestazione
da parte del lavoratore stesso, non essendo sufficiente la rilevazione della data di
invio.
La difesa del lavoratore: le prescrizioni
30
Non vi è obbligo per il lavoratore di presentare giustificazioni scritte; il lavoratore ha
il pieno diritto di scegliere se esporre le proprie controdeduzioni in forma orale
ovvero in forma scritta.
Illegittima, e come tale causa di radicale illegittimità della sanzione poi comminata,
sarebbe la pretesa del datore di lavoro di avere controdeduzioni scritte,
rifiutandosi di convocare apposito incontro per le difese richieste in forma orale.
Nel termine dei cinque giorni sono possibili eventuali integrazioni alle
giustificazione.
Il lavoratore che non si avvale del diritto alla difesa non vede in ogni caso
pregiudicato il diritto ad impugnare il provvedimento disciplinare.
La comminazione del provvedimento
Il datore di lavoro non può procedere alla comminazione del provvedimento
prima che siano trascorsi i termini a difesa del lavoratore. Su questa materia vi è
divergenza negli orientamenti della giurisprudenza.
Recentemente la Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto legittima l’adozione del
provvedimento prima che siano trascorsi i cinque giorni nel caso di giustificazioni
immediate ed esaustive da parte del lavoratore. Allo stesso tempo, ha ritenuto
legittimo il diritto del lavoratore di esplicitare la riserva a fornire ulteriori
giustificazioni entro il termine dei cinque giorni. Pertanto è da ritenersi opportuno che
il lavoratore che intenda meglio precisare le proprie difese, magari dopo essersi
consultato con i rappresentanti sindacali, manifesti esplicitamente di volersi riservare
il diritto ad ulteriori controdeduzioni; in presenza di tale richiesta esplicita, il datore
di lavoro dovrà necessariamente attendere i cinque giorni, all’opposto la eventuale
sanzione sarà ritenuta illegittima.
Trascorso il termine dei cinque giorni dalla ricezione della contestazione di
infrazione disciplinare da parte del lavoratore, il datore di lavoro può comunicare
formalmente a quest’ultimo la sanzione disciplinare comminata.
Impugnazione del provvedimento
Il lavoratore, che subisca un provvedimento disciplinare, può impugnarlo sia
per ragioni sostanziali sia per ragioni di carattere formale. Per quanto concerne il
profilo sostanziale, il provvedimento può essere impugnato essenzialmente quando il
dipendente contesti la veridicità dei fatti o, comunque assuma la sua estraneità
ai medesimi. Il provvedimento, può essere impugnato, invece, sotto un profilo
formale quando il datore di lavoro non abbia seguito le procedure indicate
dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal contratto collettivo.
Anche la mancata affissione del regolamento disciplinare, determina
l’illegittimità formale del provvedimento, che non può essere nemmeno ripetuto o
rinnovato, proprio perché mancava l’affissione. Nell’ipotesi di provvedimento
disciplinare intimato senza la contestazione scritta del fatto al lavoratore, oppure
senza consentire la difesa a mezzo del rappresentante dell’associazione sindacale ai
sensi dei commi due e tre dell’art. 7, in entrambi i casi, il provvedimento è illegittimo
sotto il profilo formale, ma il datore di lavoro potrà rinnovare la contestazione.
31
Il lavoratore, può impugnare il provvedimento davanti al giudice del lavoro, oppure
davanti al collegio di conciliazione ed arbitrato, oppure davanti a collegi di
conciliazione previsti dai contratti.
Modalità di impugnazione del provvedimento
Irrogata la sanzione, il lavoratore può scegliere di:
1. promuovere entro i venti giorni successivi la costituzione di un collegio di
conciliazione e arbitrato presso la Direzione provinciale del lavoro
competente al fine di ottenere la revoca o la conversione del provvedimento; in
questo caso, la sanzione rimane sospesa sino al pronunciamento della
commissione;
2. impugnare la sanzione davanti all’autorità giudiziaria.
A sua volta, il datore di lavoro deve agire di conseguenza: nel caso in cui il lavoratore
abbia presentato ricorso presso il collegio di conciliazione ed arbitrato, egli deve
nominare il proprio rappresentante in seno al consiglio stesso entro dieci giorni
dall’invio. Inoltre, può rivolgersi all’autorità giudiziaria per l’accertamento della
sanzione irrogata; in questo caso la sanzione resta sospesa sino alla definizione del
giudizio.
LE SANZIONI DISCIPLINARI
Le sanzioni disciplinari
In linea generale, ed in ordine di gravità, le sanzioni normalmente previste dai
contratti collettivi sono le seguenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
e) licenziamento.
È importante sottolineare e ribadire che nella scelta tra le diverse tipologie di
sanzione, il datore di lavoro deve attenersi ad un principio fondamentale: la
proporzionalità tra la gravità dell’inadempimento e la relativa punizione. La
valutazione in merito all’effettivo rispetto di tale principio è sempre soggetta al
controllo del giudice. Nel caso in cui il criterio di proporzionalità non venga
rispettato, il giudice può disporre la modifica della sanzione adottata dal datore di
lavoro, applicando la sanzione relativa all’infrazione in base a quanto previsto dalla
contrattazione collettiva.
I principi che regolano le sanzioni disciplinari
La legge, tranne casi specifici che vedremo meglio oltre, non dispone una casistica
delle sanzioni disciplinari applicabili, ma si limita a stabilire alcuni principi
generali. Innanzitutto, se si esclude l’ipotesi del licenziamento disciplinare, la
sanzione non può comportare mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre, la multa non può eccedere l’importo corrispondente a quattro ore di
32
retribuzione base e la durata della sospensione dal servizio e dalla retribuzione
non può essere superiore a dieci giorni, le sospensioni per periodi superiori sono
regolamentati in modo che il lavoratore percepisca comunque una indennità.
È proprio sulla base di tali principi che i contratti collettivi prevedono, ancorché a
titolo meramente esemplificativo, una serie di possibili infrazioni a cui vengono
abbinate le relative sanzioni.
La recidiva
L’art. 7 ultimo comma della Legge 300 del 1970 stabilisce, altresì, che “non può
tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla
loro applicazione”, quindi non si può considerare la reiterazione di una infrazione,
ovvero la recidiva del lavoratore, se non nel rispetto della legge.
La lettera della norma ha la finalità di salvaguardare il lavoratore dalla possibile
applicazione di una sanzione più grave, e quindi non proporzionata allo specifico
inadempimento, solo in quanto lo stesso lavoratore è già stato assoggettato in passato
a procedimenti e relative sanzioni disciplinari.
Il termine entro cui è possibile riferirsi a precedenti sanzioni disciplinari applicate è
fissato in due anni, decorso tale termine il datore di lavoro, nella comminazione di
una sanzione, non potrà tener conto di eventuali fatti pregressi.
Legittimità della recidiva
Nel caso in cui il termine dei due anni non sia ancora decorso, il datore di lavoro,
nella comminazione della sanzione, può legittimamente tener conto della recidiva del
lavoratore; in tal caso, la lettera di contestazione dell’infrazione deve contenere
esplicito riferimento alla recidiva affinché sia possibile la conseguente graduazione
delle sanzioni.
Inoltre, pur rilevando, in materia, orientamenti giurisprudenziali contrastanti, si
segnala la prevalenza della posizione a favore della c.d. recidiva disciplinare
specifica. Secondo questo orientamento la recidiva, per essere contestata all’atto della
comminazione di una sanzione, dovrebbe essere relativa ad infrazioni analoghe
commesse dal lavoratore nei due anni precedenti.
Si segnala, altresì, che la recidiva disciplinare specifica comunque non può dar
luogo automaticamente al licenziamento disciplinare per giusta causa. Infatti,
anche in presenza di fatti disciplinari regolarmente contestati e per i quali siano stati
in passato già emessi provvedimenti definitivi, non si può dar luogo automaticamente
al licenziamento, dovendo il giudice comunque controllare la concreta gravità dei
fatti.
La sospensione cautelare
Oltre alle sanzioni disciplinari è bene segnalare che il datore di lavoro, per gravi
motivi, ha la possibilità di sospendere il lavoratore dal servizio, corrispondendogli
però l’intera retribuzione per il periodo strettamente necessario all’accertamento di
sue eventuali responsabilità disciplinari che possono portare al licenziamento, si parla
in tal caso di sospensione cautelare.
33
La sospensione si attua nel caso in cui la permanenza in azienda del lavoratore
costituisca pericolo di inquinamento delle prove dell’infrazione con conseguente
impossibilità di applicare la relativa sanzione disciplinare, oppure quando si vuole
impedire che lo stesso lavoratore possa compiere azioni e fatti che possano
comportare danni all’incolumità fisica dei lavoratori o alla sicurezza degli impianti.
La sospensione cautelare non è una sanzione disciplinare; rispetto alla sanzione
disciplinare della sospensione si caratterizza per il fatto di prevedere comunque la
retribuzione a favore del lavoratore e per la possibilità di essere disposta per un
periodo più ampio di quello consentito dall’art. 7 della Legge 300 del 1970 per la
sospensione disciplinare.
Il principio della preventiva conoscenza delle sanzioni
Le sanzioni disciplinari per poter essere comminate devono essere conosciute dal
lavoratore, in tal senso si richiama il principio della preventiva conoscenza
secondo il quale le norme in materia di disciplina devono essere note a tutti i
lavoratori.
Tale principio comporta a carico del datore di lavoro il duplice obbligo della
necessaria predeterminazione delle norme disciplinari relative alle sanzioni e alle
infrazioni e la pubblicità delle stesse norme, come già detto nella lezione
precedente, mediante affissione del cd. codice disciplinare in luogo accessibile a tutti,
pena l’illegittimità dell’esercizio del potere disciplinare e della validità degli atti che
ne costituiscono l’espressione.
Si sottolinea che nell’ambito del lavoro pubblico, la recente Riforma Brunetta del
2009 ha introdotto, sul punto della pubblicizzazione del codice disciplinare, una
importante novità: l’equivalenza, a tutti gli effetti, della pubblicazione del codice
disciplinare sul sito istituzionale dell’amministrazione alla sua affissione nella
sede di lavoro.
La predeterminazione degli illeciti e delle sanzioni
Per garantire una maggiore tutela del lavoratore, in merito all’applicazione delle
sanzioni disciplinari vige il principio della predeterminazione degli illeciti e delle
relative sanzioni. Tale principio elemento è il presupposto stesso dell’onere di
pubblicità del codice disciplinare a carico del datore di lavoro.
Su questo argomento si è a lungo soffermata la giurisprudenza che ha più volte
ribadito che per la validità del codice disciplinare è sufficiente che lo stesso sia
redatto in una forma tale da rendere immediatamente chiare le ipotesi di
infrazione, anche indicandole in modo schematico e non dettagliato, inoltre, riporti
contestualmente, le relative sanzioni seppur indicandole in maniera ampia,
suscettibili di adattamento, di volta in volta ai concreti inadempimenti del lavoratore.
In questo ambito, infatti, non vige il principio di tassatività degli illeciti imposto per
gli illeciti penali, secondo il quale ad ogni violazione corrisponde una precisa
sanzione non suscettibile di discrezionalità, in quanto, va fatta una doverosa
distinzione tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni inerenti
l’organizzazione del datore di lavoro, conoscibili solo se chiaramente descritte dal
34
codice disciplinare, e gli illeciti costituiti da comportamenti contrari alle norme
dell’ordinamento a fronte dei quali non è necessaria la specifica previsione nel codice
disciplinare, poiché, il potere sanzionatorio deriva direttamente dalla legge.
Gli obblighi del lavoratore nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
del Comparto del personale del Servizio Sanitario nazionale.
Secondo il CCNL del Comparto Sanità siglato nel 1995, così come modificato dal
CCNL del Comparto del personale del Servizio Sanitario nazionale per il biennio
normativo 2002-2005 e confermato dai successivi e recenti rinnovi contrattuali, il
dipendente deve conformare la propria condotta al dovere “di contribuire alla
gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità…anteponendo il rispetto
della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui”.
Inoltre, il comportamento del dipendente deve essere volto al perseguimento
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali resi in modo da tener conto
principalmente delle esigenze dei cittadini utenti. In questa prospettiva il CCNL
sancisce una serie di obblighi specifici del lavoratore del Comparto Sanità a fronte
dei quali delinea le possibili sanzioni in caso di inadempimento.
Gli obblighi di diligenza e fedeltà per il personale del Comparto Sanità
Il CCNL del comparto Sanità dettaglia chiaramente gli obblighi del lavoratore che
rientrano nelle più ampie fattispecie dettate, in materia, dal Codice Civile,
prevedendo espressamente come debbano configurarsi gli obblighi di obbedienza,
diligenza e fedeltà del lavoratore. La norma collettiva dispone che il dipendente
deve, in particolare, collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto
collettivo e le disposizioni impartite dall’Azienda o ente per l’esecuzione e la
disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di
ambiente di lavoro. Sempre nell’ambito della diligenza del lavoratore è fatto obbligo
di vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale eventualmente
sottordinato, ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità. Naturalmente, nello
stesso ambito, è fatto obbligo al lavoratore di avere cura dei beni strumentali a lui
affidati e di non avvalersi di quanto è di proprietà dell’azienda o ente per ragioni che
non siano di servizio. Inoltre, nello stesso contesto, si precisa chiaramente anche
l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalla legge e
quello di non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si venga a conoscenza per
ragioni di servizio oltreché astenersi dal partecipare, nell’esercizio della propria
attività di servizio, all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente interessi propri.
L’obbligo di obbedienza per il personale del Comparto Sanità
Nel rispetto dell’obbligo di obbedienza che come ricordiamo consiste
nell’osservanza, da parte del prestatore di lavoro, delle disposizioni impartite
dal datore di lavoro o da suoi collaboratori per l’esecuzione dell’attività
lavorativa e per la c.d. disciplina del lavoro, il CCNL del Comparto Sanità prevede
una serie di fattispecie nelle quali lo stesso obbligo deve espletarsi.
35
Innanzitutto il lavoratore deve rispettare l’orario di lavoro, e di conseguenza
adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, non assentandosi
dal luogo di lavoro senza la preventiva autorizzazione del dirigente del servizio. È
fatto, inoltre, obbligo di non svolgere, durante l’orario di lavoro, attività non attinenti
al proprio servizio. Durante l’orario di lavoro, il lavoratore è tenuto, altresì, a
mantenere, nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta conforme a
principi di correttezza ed astenersi da comportamenti che possano in qualche misura
risultare lesivi della dignità della persona.
Nell’ambito dell’obbligo di obbedienza il lavoratore, secondo le disposizioni del
contratto collettivo, è tenuto ad eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento
delle proprie funzioni o mansioni così come impartiti dai propri superiori. Qualora il
lavoratore ritenesse illegittima la disposizione impartitagli è tenuto a farne immediata
e motivata contestazione a chi l’ha impartita, dichiarandone le ragioni; nel caso in cui
la stessa disposizione venisse rinnovata per iscritto egli ha il dovere di darvi
esecuzione, a meno che la disposizione stessa sia vietata dalla legge o costituisca un
illecito amministrativo.
Il lavoratore del Comparto Sanità, secondo le disposizioni sancite dalla norma
collettiva, è obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l’accesso ai locali dell’azienda o ente da parte del personale e rispettare le
disposizioni che regolano l’accesso in locali non aperti al pubblico da parte di
persone estranee.
Le sanzioni disciplinari nel CCNL del Comparto del personale del Servizio
Sanitario nazionale.
Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati dal CCNL del
Comparto Sanità danno luogo, per precisa statuizione dello stesso contratto,
all’applicazione di una serie di sanzioni, da comminare nel rispetto del principio di
proporzionalità e quindi in considerazione della gravità dell’illecito commesso dal
lavoratore.
Le sanzioni espressamente previste dal contratto oggetto di analisi sono:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad
un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
Limite procedurale al potere disciplinare del datore di lavoro nel CCNL del
Comparto del personale del Servizio Sanitario nazionale.
Le sanzioni disciplinari, come abbiamo già avuto modi di vedere, possono essere
comminate a condizione che venga rispettato il principio generale vigente del
limite procedurale posto dall’ordinamento al potere disciplinare del datore di
36
lavoro. A tal fine il contratto collettivo del Comparto Sanità prevede espressamente
che l’azienda o ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non possa adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione
scritta dell’addebito, da effettuarsi tempestivamente e comunque entro 20 giorni da
quando l’ufficio istruttore che, secondo l’ordinamento dell’azienda o ente è tenuto
alla contestazione, sia venuto a conoscenza del fatto e, senza averlo sentito a sua
difesa con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale cui
il lavoratore stesso aderisce o conferisce mandato.
I criteri per la gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari nel CCNL
del Comparto del personale del Servizio Sanitario nazionale.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni e in
relazione alla gravità dell’illecito commesso dal lavoratore, il tipo e l’entità di
ciascuna delle sanzioni previste dal contratto collettivo sono determinati in
relazione ad una serie di criteri generali espressamente definiti.
Gli stessi criteri attengono: alla intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell’evento; alla rilevanza degli obblighi violati; alle responsabilità connesse alla
posizione di lavoro occupata dal dipendente; al grado di danno o di pericolo causato
all’azienda o ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; alla
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti e infine al concorso nella
mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
Quando si applicano le sanzioni disciplinari dal rimprovero verbale alla multa.
La sanzioni disciplinari dal rimprovero verbale o scritto alla multa, di importo
pari a quattro ore della retribuzione, si applicano, graduando l’entità propria delle
sanzioni in relazione ai criteri di proporzionalità su definiti, per le seguenti fattispecie
di infrazioni previste in capo al lavoratore:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia,
nonché dell’orario di lavoro;
b) condotta, nell’ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza verso
superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o dei terzi;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni
mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza
sul lavoro, ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell’azienda o ente;
f) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi
di lavoro.
37
Le stesse sanzioni si applicano, sempre tenendo conto del principio di proporzionalità
e gradualità, anche a quelle fattispecie di violazione dei doveri di comportamento
non ricomprese espressamente nell’elenco appena delineato ma che comportino una
delle seguenti situazione:
1. disservizio
2. danno o pericolo all’azienda o ente
3. danno o pericolo agli utenti o terzi.
La sospensione dal servizio con sospensione breve della retribuzione
Il CCNL del Comparto Sanità prevede una duplice possibilità di sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione: per un periodo breve, di massimo
dieci giorni; oppure per un periodo più lungo che possa durare al massimo sei mesi.
Nel primo caso, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a
un massimo di dieci giorni si applica, sempre nel rispetto di principio di gradualità e
proporzionalità, nei casi di:
a) recidiva nelle infrazioni che siano già state punite con una delle sanzioni previste
tra il rimprovero e la multa;
b) particolare gravità delle infrazioni per le quali il contratto prevede l’applicazione
delle sanzioni dal rimprovero alla multa;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono del
servizio stesso. In questi casi l’entità della sanzione deve essere determinata in
funzione: della durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio; del disservizio
determinatosi; della gravità della violazione dei doveri del dipendente e degli
eventuali danni causati all’azienda o ente, agli utenti o terzi.
d) ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata, per un periodo non
superiore a 10 giorni;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di
malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa,
fatta salva la tutela del segreto professionale nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti di utenti, altri dipendenti o terzi;
h) litigi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’azienda o ente, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, secondo quanto stato dall’art. 1 dello Statuto dei
Lavoratori;
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della
persona;
m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’azienda o ente, agli
utenti o terzi.
La sospensione dal servizio con sospensione lunga della retribuzione
38
Nel caso di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un
periodo di durata compresa tra gli undici giorni e i sei mesi, le infrazioni che
espressamente richiamano l’applicazione di tale sanzione disciplinare,
opportunamente graduata in funzione della gravità del fatto concretamente commesso
dal lavoratore, sono le seguenti:
a) recidiva nel biennio delle mancanze per le quali è già stata comminata la
sospensione per un massimo di 10 giorni o per le stesse infrazioni per le quali è
prevista la sospensione per un massimo di 10 giorni qualora presentino una
particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre dieci giorni e fino a quindici giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’azienda o ente o ad essa
affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di
vigilanza o di controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti
di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità
che siano lesivi della dignità della persona.
Si precisa, come sarà anche richiamato dalla lezione successiva, che nella
sospensione dal servizio prevista per un massimo di sei mesi, il dipendente è
privato della retribuzione fino al decimo giorno, a decorrere dall’undicesimo
giorno al lavoratore vengono corrisposti stesso una indennità pari al 50% della
retribuzione nonché gli assegni del nucleo familiare, se spettanti. Tuttavia il
periodo di sospensione non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
Il licenziamento disciplinare con preavviso
La massima sanzione del licenziamento disciplinare, con obbligo di preavviso in
capo al datore di lavoro, si applica per le seguenti tipologie di infrazioni:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste per le
quali sia stata comminata la sospensione con privazione breve o lunga delle
retribuzione, oppure recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato
l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione;
b) recidiva nell’infrazione di occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito
uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza
dell’azienda o ente o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il
lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’azienda o ente per riconosciute
e motivate esigenze di servizio;
39
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’azienda o ente quando
l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a
quindici giorni;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione
di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per
qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente
agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e
reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli
un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal
servizio seppur non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità.
Il licenziamento disciplinare senza preavviso
La massima sanzione del licenziamento disciplinare, senza obbligo di preavviso per il
datore di lavoro, si applica per le seguenti tipologie di infrazioni:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso
il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio
che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere, anche nei confronti di terzi, di fatti o atti anche dolosi, che,
costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire
la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
Le sanzioni disciplinari nella Pubblica Amministrazione: le previsioni normative
Dopo aver preso in considerazione le disposizioni disciplinari previste dal Contratto
collettivo nazionale del Comparto Sanità, è bene sottolineare come l’art. 55-quater
del Decreto legislativo 165 del 2001, così come modificato dalla recente Riforma
Brunetta, preveda espressamente nel dettato normativo una serie di infrazioni
particolarmente gravi per le quali trova applicazione la sanzione del licenziamento
disciplinare. Tale elenco di infrazioni, con le relative sanzioni, in questo caso è
espressamente sancito dalla legge e può soltanto essere ampliato dal contratto
collettivo, ma certamente non ridotto. Per l’approfondimento di questo specifico
argomento si rinvia alla lezione successiva, mentre, in questa sede si ritiene utile
40
richiamare i soli casi previsti dalla norma per l’applicazione della sanzione massima
del licenziamento.
I casi previsti dalla norma punibili con licenziamento senza preavviso sono
1) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta
falsamente uno stato di malattia;
2) falsità documentali o dichiarative in caso di assunzione o progressioni di carriera;
3) reiterazione, nell’ambiente di lavoro, di gravi condotte aggressive o moleste o
minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
4) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto
di lavoro.
I casi previsti dalla norma punibili con licenziamento con preavviso sono:
1) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non
continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni
nel corso degli ultimi dieci anni, ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di
assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
2) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivi di
servizio.
IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
La prevalenza del rapporto sul contratto di lavoro subordinato
Il Codice civile, all’art. 2094, disciplina il rapporto di lavoro e non il contratto di
lavoro subordinato, a significare che il profilo del rapporto prevale su quello del
contratto. Infatti, in merito alla complessa struttura del rapporto di lavoro
subordinato va sottolineato che la regolamentazione dell’esecuzione della prestazione
di lavoro da parte del lavoratore, così come la disciplina della concreta attuazione
delle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto stesso, non sono demandate
all’autonomia delle parti contraenti, ma è la legge stessa che impone direttamente, o
attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva, una serie di limitazioni al contenuto
del contratto ed all’autonomia negoziale delle parti.
Pertanto, la legge disciplina il rapporto nel suo svolgimento effettuale
comprimendo l’autonomia contrattuale delle parti; infatti, la stessa legge e la
contrattazione collettiva stabiliscono in via preventiva il contenuto
imprescindibile di diverse disposizioni o clausole negoziali inerenti il rapporto
tra i due contraenti.
L’indisponibilità del tipo legale
La compressione dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro è necessaria
conseguenza del fatto che il tipo legale del contratto di lavoro subordinato si
configura quale modello di regolamentazione di interessi rigido che, pertanto,
41
diversamente da altri contratti, non può essere determinato dalle parti: si parla, in
tal senso, di indisponibilità del tipo legale.
Le parti, infatti, non possono in alcun modo separare la subordinazione dallo
statuto protettivo del lavoratore, cioè dalla disciplina imperativa del rapporto che
tutela il lavoratore come persona e come contraente debole.
La causa del contratto di lavoro
In un contratto la causa è l’elemento richiesto a pena di nullità che ne individua la
funzione economico-sociale e quindi l’interesse meritevole di tutela perseguito dalla
volontà delle parti.
Il contratto di lavoro subordinato è un tipico contratto di scambio o a
prestazioni corrispettive, la cui causa è identificata dal legislatore nel sinallagma
che pone in correlazione l’obbligazione del prestatore e quella del datore di
lavoro, che sono rispettivamente la collaborazione e la retribuzione (“chi si
obbliga mediante retribuzione”). La collaborazione alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2094 rappresenta lo scopo tipico della
prestazione e quindi la causa che identifica il tipo negoziale del contratto di lavoro
subordinato.
Il regolamento contrattuale
In generale, il nostro ordinamento definisce il contratto all’art. 1321 del codice
civile che recita “il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Partendo da tale definizione e dall’importanza che il legislatore assegna
all’autonomia delle parti nella definizione del regolamento contrattuale, c’è chi, in
dottrina, ha anche sollevato il dubbio che il rapporto di lavoro subordinato
avesse natura acontrattuale, data la limitata autonomia delle parti contraenti.
Ovviamente la teoria dell’acontrattualità del rapporto, seppur meritevole di
citazione, non può in alcun modo essere accolta in quanto la limitata autonomia
delle parti non coincide con la soppressione dell’autonomia contrattuale.
La fonte del rapporto di lavoro subordinato
La disciplina del rapporto di lavoro, pur essendo una disciplina inderogabile, in
quanto il contenuto delle obbligazioni derivanti dal contratto è in gran parte
espressione di regolamento di interessi sovraordinati all’autonomia individuale,
non ha tuttavia natura imperativa per il fatto stesso che l’autonomia delle parti
può intervenire a modificare il contratto in qualsiasi momento, seppure soltanto
derogandolo con disposizioni in favore del lavoratore (derogabilità in melius).
Si assiste, dunque, ad una compressione dell’autonomia contrattuale finalizzata
esclusivamente alla restrizione del potere di autoregolamento del contraente
forte (datore di lavoro) a vantaggio del contraente debole (lavoratore) e, dunque, a
sostenere l’autonomia individuale rafforzandola dal lato del lavoratore. Pertanto, va
ribadito che l’inderogabilità del regolamento degli interessi non può essere un
42
elemento decisivo per escludere la natura contrattuale del rapporto e di
conseguenza la fonte del rapporto di lavoro subordinato resta il contratto.
L’inderogabilità in peius
La particolare disciplina del contratto di lavoro subordinato è data dal fatto che
l’autonomia contrattuale, definita agli artt. 1321 e 1322 del codice civile quale
potere delle parti di determinare il regolamento dei propri interessi attraverso il
reciproco accordo, è ripartita in modo diseguale tra i contraenti a causa della
debolezza contrattuale del lavoratore.
Infatti, proprio a causa dell’inferiorità della posizione economica del lavoratore
nell’ambito dell’accordo è prevista la limitazione dell’autonomia privata imposta
dalla disciplina imperativa legale e la stessa Costituzione, al fine di correggere lo
squilibrio esistente nel rapporto di lavoro, ha previsto l’organizzazione e l’azione
del sindacato e il diritto di sciopero agli artt. 39 e 40.
È importante sottolineare e ribadire che sono sempre ammesse, nel regolamento
contrattuale, clausole non previste dalla legge ma più favorevoli al lavoratore; in
tal senso si definisce la c.d. inderogabilità in peius ovvero l’impossibilità di
derogare alle norme imperative introducendo patti contrari alle norme stesse ed
alla contrattazione collettiva, ma è sempre ammessa la deroga in meglio a favore
del lavoratore.
Il principio del favor
Le norme inderogabili poste a tutela del lavoratore hanno una funzione protettiva
dell’interesse del lavoratore. In questo senso, la compressione dell’autonomia
negoziale opera secondo un meccanismo assimilabile a quanto previsto dall’art. 1324
del codice civile secondo il quale le parti contraenti sono obbligate non solo a
quanto previsto nell’accordo ma anche “a tutte le conseguenze che ne derivano
secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e la equità”. In sostanza il
principio di inderogabilità del regolamento contrattuale si combina con il
principio della prevalenza del trattamento più favorevole al lavoratore, c.d.
principio del favor consentendo alle parti contraenti la sola possibilità di stabilire
patti o clausole, anche taciti, che siano migliorativi dei trattamenti normativi ed
economici fissati dal contratto collettivo applicabile: il caso tipico è quello
dell’applicazione degli usi aziendali.
Attuazione del principio di inderogabilità del contratto di lavoro
L’inderogabilità del regolamento contrattuale si realizza attraverso una serie di effetti
previsti dal nostro ordinamento che rafforzano i limiti all’autonomia negoziale nel
contratto di lavoro e sono posti a fondamento del principio dell’effettività della
tutela degli interessi del lavoratore.
Il meccanismo tipico previsto dal nostro ordinamento è quello della sostituzione
legale delle clausole difformi alla legge e alla contrattazione collettiva. In virtù di tale
principio i patti contrari alle norme imperative vengono, dalle stesse, sostituiti di
diritto.
43
Oltre alla sostituzione legale, è previsto anche il meccanismo della inserzione
automatica nel contratto, grazie al quale le clausole previste dalla legge, e non prese
in considerazione dai contraenti, sono inserite di diritto nel regolamento contrattuale
anche in sostituzione delle clausole difformi alle norme imperative apposte dalle parti
stesse.
La ratio di entrambi i principi è quella di tutelare gli interessi del lavoratore quale
parte debole del contratto.
L’invalidità del contratto secondo la disciplina civilistica
La specialità del contratto di lavoro subordinato si rileva anche per i tratti peculiari
legati all’invalidità del contratto stesso.
Secondo la disciplina civilistica, dettata per la generalità dei contratti,
l’invalidità del contratto si ha quando l’accordo tra le parti è contrario alle
norme imperative dell’ordinamento, oppure per mancanza di requisiti previsti
dalla legge, come ad esempio la forma, o ancora quando l’oggetto del contratto è
illecito; in tutti questi casi il nostro ordinamento prevede la nullità ovvero si ritiene
che il contratto non abbia mai prodotto effetti, come se non fosse stato mai stipulato.
L’invalidità del contratto si può avere anche per vizi della volontà e in questo caso
il contratto può essere annullato attraverso una sentenza del giudice che ne
pronuncia l’annullamento, per cui da quel momento il contratto non può più
produrre effetti.
L’invalidità del contratto di lavoro.
Il contratto di lavoro è invalido quando:
a) i contraenti stipulano un negozio contrario alla legge o alla contrattazione
collettiva: si pensi ad un rapporto di lavoro che contempli un orario di lavoro
decisamente superiore a quanto previsto dalla normativa, oppure ad un
rapporto di lavoro che non rispetti l’età minima necessaria per concludere il
contratto di lavoro, o ancora ad un contratto di lavoro che non preveda le ferie
e i riposi;
b) i contraenti stipulano un negozio in cui la causa è illecita: si pensi ad un
contratto di lavoro con il quale una persona viene assunta alle dipendenze di
un’altra con il compito di prostituirsi;
c) i contraenti stipulano un negozio in cui l’oggetto è illecito: si pensi ad un
rapporto di lavoro con il quale una persona viene assunta alle dipendenze di
un’altra con il compito di smerciare droga;
d) i contraenti stipulano un contratto in cui vi siano vizi di forma: si pensi ad un
contratto che richiede la forma scritta ad substantiam e che invece viene
concluso solo verbalmente;
e) i contraenti stipulano un negozio che presenti vizi della volontà: si pensi ad un
rapporto di lavoro in cui il prestatore ritenga di aver stipulato un contratto di
lavoro subordinato mentre invece viene impiegato come socio d’opera.
La disciplina speciale nell’invalidità del contratto di lavoro
44
Nel contratto di lavoro, la disciplina generale in materia di invalidità del contratto va
integrata dalla lettera dell’art. 2126 del codice civile che, al primo comma, dispone
“la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il
periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, salvo che la nullità
derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa”.
La stessa norma, al secondo comma, prescrive: “se il lavoro è stato prestato con
violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso
diritto alla retribuzione”.
La finalità dell’art. 2126 è quella di tutelare il prestatore di lavoro che abbia
eseguito la propria attività al servizio del datore di lavoro nonostante l’invalidità del
contratto.
L’inefficacia dell’invalidità nel caso di illiceità dell’oggetto o della causa
La regola dell’inefficacia dell’invalidità, contemplata dall’art. 2126, co. 1,
secondo la quale l’invalidità è temporaneamente inefficace e dal rapporto sorgono
valide obbligazioni, vige in tutti i casi tranne quando si sia in presenza di nullità
derivante dall’illiceità dell’oggetto o della causa del contratto.
In tal caso è esplicitamente esclusa la possibilità di conservare gli effetti del
contratto invalido.
Quando, invece, si sia in presenza di violazione delle norme protettive del
lavoratore l’inefficacia dell’invalidità risulta essere rafforzata dalla lettera del
secondo comma dell’art. 2126 che prevede, in ogni caso, il diritto alla
retribuzione per l’effettiva prestazione di lavoro eseguita, anche quando
l’oggetto o la causa del contratto sono illeciti, come ad esempio nel caso del lavoro
minorile.
Le ragioni della norma
L’art. 2126, in pratica, diversamente da quello che accade nella disciplina generale
dove abbiamo visto che un contratto invalido può essere nullo, e quindi considerato
privo di effetti fin dal momento della conclusione, oppure annullato, e quindi
incapace di produrre effetti dal momento della pronuncia della sentenza di
annullamento, riconosce ad un contratto di lavoro invalido, nullo o annullabile, di
aver prodotto degli effetti per il periodo di tempo in cui la prestazione è stata
eseguita. In particolare, si ribadisce il diritto del lavoratore alla retribuzione per la
prestazione svolta nell’ambito di un contratto nullo o annullabile.
La norma, in sostanza, sancisce l’irretroattività delle vicende che sono volte
all’eliminazione del negozio invalido, e tale irretroattività estesa alla nullità stessa
comporta l’efficacia del contratto invalido limitatamente al periodo di esecuzione del
rapporto, data l’irripetibilità delle prestazioni già eseguite.
È importante ribadire che le uniche ragioni che non consentono l’applicazione
dell’art. 2126 a tutela del lavoratore sono i casi in cui siano illeciti la causa o
l’oggetto della prestazione.
45
Il negozio invalido quale fonte del rapporto obbligatorio
L’art. 2126, in sostanza, permette ad un contratto invalido, sia esso nullo che
annullabile, di produrre determinati effetti pur non essendo idoneo a costituire il
rapporto di lavoro proprio a causa della sua invalidità.
Dunque, la c.d. prestazione di fatto, che consiste nell’esecuzione del contratto
invalido, non ha la capacità di costituire il rapporto di lavoro subordinato ma la
capacità di conservare gli effetti scaturiti dall’attuazione del negozio invalido.
In tal senso si può affermare che il negozio di lavoro invalido, in via eccezionale,
funge da fonte del rapporto obbligatorio.
L’inefficacia dell’invalidità a salvaguardia dei diritti del lavoratore
La regola prevista dall’art. 2126 non equivale ad una sanatoria del contratto invalido;
l’inefficacia dell’invalidità, prevista dal dettato normativo, ha esclusivamente la
finalità di salvaguardare i diritti del lavoratore, che in alternativa dovrebbe
esercitare l’azione per la ripetizione di una indennità equivalente alla indebita
prestazione di lavoro.
La conservazione degli effetti del contratto invalido
In sostanza, la conservazione degli effetti del contratto invalido si pone in
alternativa sia all’eliminazione degli stessi, normale conseguenza dell’azione di
nullità o di annullamento, sia alla conseguente ed eventuale ripetizione
dell’indebito.
In altri termini, la conservazione degli effetti del contratto invalido prevista
dall’art. 2126 c.c., nei casi di annullabilità o nullità del negozio giuridico, ha la
funzione di garantire i diritti del lavoratore al pari dell’inderogabilità propria
del regolamento contrattuale del rapporto di lavoro subordinato e della
sostituzione legale delle clausole previste dai contraenti in difformità alle norme
imperative.
La sostituzione legale
Infatti, come già detto, la sostituzione legale dispone la conservazione del contratto
attraverso l’inserzione automatica, nello stesso, delle clausole imposte
inderogabilmente a tutela del lavoratore dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Infatti, nei casi di invalidità del contratto di lavoro la sostituzione automatica
degli effetti legali, a quelli stabiliti dalle parti e contrari alle norme imperative, ha
l’obiettivo di rafforzare l’inderogabilità del regolamento contrattuale e adeguare
il negozio invalido agli standard minimi di protezione del prestatore di lavoro.
Questi ultimi, che sono i diritti riconosciuti dalla disciplina del trattamento
minimo, sono garantiti, dall’art. 2126, sul piano dell’effettività della tutela del
lavoratore.
Come opera la sostituzione legale
46
Data l’inderogabilità del contratto di lavoro subordinato, il lavoratore potrà far
valere l’invalidità delle clausole difformi alle norme imperative non attraverso
l’azione di nullità ma attraverso la rivendicazione dei diritti che gli sono
riconosciuti dalla disciplina legale del contratto di lavoro.
In pratica, se un contratto di lavoro non prevede una clausola imposta dalla legge o
dal contratto collettivo, come ad esempio il diritto alle ferie, o preveda, invece, una
clausola contraria alle norme inderogabili, come ad esempio una retribuzione al di
sotto del limite fissato dalla contrattazione collettiva, il principio della sostituzione
legale permette al lavoratore di non invocare la nullità del contratto in quanto
invalido, ma di sostituire le clausole difformi con quelle già previste dalla normativa
a tutela del lavoratore e pertanto inderogabili in peius.
L’art. 2126 nei rapporti di pubblico impiego
L’art. 2126 del Codice Civile trova piena attuazione anche nel settore del pubblico
impiego ed opera quale strumento di protezione delle aspettative minime di chi abbia
reso una prestazione di fatto, in carenza di un contratto valido.
In pratica, in tale ambito, l’art. 2126 svolge la funzione di garantire l’applicazione
degli artt. 2, 35 e 36 della Costituzione per chi comunque abbia effettuato un’attività
lavorativa. Secondo l’orientamento costante del Consiglio di Stato le conseguenze
previste dall’art. 2126 si applicano al rapporto di pubblico impiego nullo quando lo
stesso, pur essendo costituito senza il rispetto delle modalità prescritte, presenti
elementi assimilabili al rapporto di lavoro subordinato
LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
La conclusione del contratto di lavoro
Dopo aver parlato del ruolo dell’autonomia privata nel contratto di lavoro e della
disciplina speciale cui è sottoposto il rapporto di lavoro subordinato, è bene
soffermarsi sul procedimento di formazione del regolamento contrattuale. In tal
senso, il contratto di lavoro non si presenta dissimile dagli altri contratti
disciplinati dal codice civile, pur presentando alcuni tratti di specialità.
In generale un contratto si considera concluso quando si ha l’incontro tra la
volontà delle parti, ovvero quando si manifesta il consenso, cioè l’incontro tra una
proposta e un’accettazione, così come disposto dagli artt. 1325 e 1326 c.c.. Anche
nel contratto di lavoro la formazione discende dall’incontro tra la volontà dei
contraenti: il problema, piuttosto è quello di stabilire il momento in cui si possa
ritenere avvenuto l’incontro tra proposta e accettazione.
L’incontro tra proposta e accettazione
Si ritiene che l’incontro tra proposta e accettazione si verifichi nel momento in
cui il lavoratore sostanzialmente aderisce alla proposta del datore di lavoro; tale
considerazione ha fatto sì che il contratto di lavoro fosse ricondotto nello schema più
generale del contratto di adesione previsto dall’art. 1341 del codice civile anche se a
47
differenza di quest’ultimo, dove le condizioni del regolamento contrattuale sono
stabilite unilateralmente dal contraente forte, nel contratto di lavoro la
determinazione del regolamento è bilaterale ed è demandata all’autonomia
collettiva, in quanto, come abbiamo già avuto modo di vedere, l’autonomia
individuale può determinare solo condizioni più favorevoli per il lavoratore.
Il comportamento concludente
Proprio la manifestazione del consenso, nel contratto di lavoro subordinato, rileva
quale tratto caratterizzato da specialità rispetto alla disciplina generale.
In ogni contratto, così come nel contratto di lavoro, il momento genetico della
formazione è distinto dal momento attuativo, ma come ben sappiamo nel
contratto di lavoro quest’ultimo prevale sul primo per la concreta qualificazione
del rapporto di lavoro stesso.
Da ciò discende che l’esecuzione della prestazione di lavoro può essere ritenuta
comportamento concludente ai fini della prova dell’esistenza del contratto e
quindi ai fini della formazione dello stesso.
La qualificazione del rapporto di lavoro
La particolarità del contratto di lavoro subordinato si ravvisa anche nel momento
della qualificazione del rapporto di lavoro stesso.
In generale, per qualificare un rapporto è necessaria una interpretazione del contratto
che lo ha instaurato e ne detta le regole secondo la volontà dei contraenti; nel
contratto di lavoro la volontà cartolare, cioè la qualificazione dell’accordo
attribuita dalle parti, non ha valore determinante rispetto al contenuto effettivo
del rapporto.
La prevalenza del momento attuativo su quello dichiarativo dell’accordo
Ne deriva che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro rileva il
comportamento tenuto dai contraenti nella fase di esecuzione del rapporto
stesso, anche se successiva al momento della conclusione del contratto; rileva,
inoltre, l’effettività della subordinazione e l’esistenza dei suoi indici sintomatici
come, ad esempio, l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare ed al controllo
del datore di lavoro.
A questo punto si può meglio comprendere come la sottoposizione del lavoratore al
potere organizzativo e di controllo del datore di lavoro non si identifichi soltanto
come comportamento esecutivo dell’obbligazione assunta, ma si configuri come
comportamento utile ai fini dell’individuazione della causa del contratto.
D’altro canto, la prevalenza del momento attuativo del contratto sul momento
dichiarativo dell’accordo tra le parti non è solo funzionale all’accertamento in via
presuntiva della volontà dei contraenti ma rappresenta la necessaria conseguenza
della compressione dell’autonomia negoziale quale fonte regolatrice del rapporto di
lavoro.
L’oggetto del consenso
48
Nella formazione del contratto di lavoro l’oggetto del consenso non è rappresentato
dal contenuto del contratto ma piuttosto dalla stipulazione dello stesso, infatti si
discute, in genere, del se del contratto e non del come.
In altri termini, il tema della formazione del consenso nella conclusione di un
contratto di lavoro subordinato va ricondotto alle diverse posizioni di potere
contrattuale che assumono le parti contraenti nel rapporto di lavoro.
Elementi accidentali del contratto di lavoro: il patto di prova
Al momento della stipula del contratto di lavoro subordinato le parti possono
decidere, di comune accordo, l’inserimento del patto di prova, quale clausola
accessoria al contratto stesso. Attraverso il patto di prova i contraenti subordinano
l’assunzione in via definitiva all’esito positivo di un periodo di prova.
Durante questo periodo, il datore di lavoro ha la possibilità di verificare le attitudini
psico-fisiche e professionali del lavoratore attraverso l’esecuzione della prestazione
ed il lavoratore ha l’opportunità di verificare l’interesse e la convenienza del nuovo
lavoro. Infatti larga parte della dottrina ritiene che il patto di prova sia finalizzato
a valutare la reciproca convenienza dei contraenti a rendere definitivo il
rapporto di lavoro.
Il Patto di prova: requisiti di forma
L’art. 2096 del codice civile prevede che “salvo diversa disposizione delle norme
corporative, l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve
risultare per atto scritto”.
Il patto di prova deve essere sottoscritto precedentemente o contestualmente all’inizio
del rapporto e la clausola può essere inserita direttamente nel contratto di lavoro o in
un atto separato; inoltre, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni
contrattuali, al fine di consentire, in primo luogo, la corretta identificazione
dell’oggetto della prova ed in secondo luogo, nel caso di mancato superamento della
prova stessa, il giudizio sulla correttezza della valutazione del datore di lavoro.
Il Patto di prova: durata
La funzione stessa del patto di prova comporta che l’esperimento abbia una durata
limitata nel tempo. La durata del periodo di prova è fissata generalmente dai
contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto individuale di lavoro, ma data la
natura della clausola e vista la possibilità per entrambi i contraenti di recedere senza
preavviso, il legislatore, al fine di salvaguardare il lavoratore, è intervenuto a
stabilire un termine massimo per la durata del patto di prova che è fissato in sei
mesi (art. 10, legge 604/66).
Decorso il periodo di prova, senza che una delle parti abbia manifestato la volontà di
recedere, il rapporto di lavoro si considera definitivo e a tempo indeterminato fin
dall’inizio.
Il Patto di prova: trattamento economico
49
Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, la posizione del
lavoratore in prova è tendenzialmente equiparata a quella derivante
dall’assunzione definitiva.
L’esito negativo della prova non consente l’attribuzione al lavoratore di un
trattamento economico inferiore rispetto a quello percepito da un lavoratore di pari
grado assunto in via definitiva. Indipendentemente dall’esito finale del periodo di
prova al lavoratore spettano il trattamento di fine rapporto (TFR), le mensilità
aggiuntive, il decorso dell’anzianità di servizio e le ferie retribuite.
La forma del contratto di lavoro
Altro tratto del contratto di lavoro caratterizzato da specialità è la forma, perché,
anche in questo caso, la legge impone molteplici limiti all’autonomia negoziale non
in funzione della tutela di entrambi i contraenti ma della tutela unilaterale del
lavoratore.
Come per la generalità dei contratti vige il principio della libertà della forma anche
se a questo principio fa riscontro una speciale rilevanza delle forme tacite di
manifestazione del consenso e in particolare del comportamento concludente.
Inoltre, alla regola generale fanno eccezione il contratto di arruolamento
marittimo, che per legge deve essere concluso per atto pubblico, ed altri contratti
per i quali la forma scritta è richiesta ad probationem o ad substantiam.
Quando la forma scritta è richiesta ad substantiam
In generale la forma scritta, nel contratto di lavoro, è richiesta ad substantiam per
particolari patti o elementi accidentali che potrebbero essere lesivi di un
interesse del lavoratore, come ad esempio l’apposizione di un termine.
Per una maggiore tutela del lavoratore il D.lgs. 152 del 1997, in recepimento della
Direttiva comunitaria n. 533 del 1991, ha disposto l’obbligo per il datore di
lavoro di comunicare per iscritto, al lavoratore, le principali condizioni
applicabili al rapporto di lavoro quali: la data di inizio del rapporto, il luogo di
lavoro, la qualifica e l’inquadramento del lavoratore ed ogni altra informazione utile a
tutelare il lavoratore sotto il profilo della trasparenza delle condizioni di lavoro.
Lo stesso obbligo è previsto in capo al datore di lavoro in caso di modifiche alle
condizioni preventivamente stabilite, intercorse durante lo svolgimento del
rapporto di lavoro.
L’obbligo di informazione
Va sottolineato che l’obbligo di informazione, previsto in capo al datore di lavoro,
non rappresenta una deroga al principio della libertà della forma del contratto
di lavoro. Infatti, va ravvisato come obbligo di informazione relativo
all’esecuzione del rapporto e può essere adempiuto attraverso la lettera di
assunzione oppure in un qualsiasi altro atto, attestante la sottoscrizione del
contratto, che deve essere consegnato al prestatore di lavoro entro 30 giorni
dalla data di assunzione.
50
È altresì previsto dall’art. 4 bis del D. Lgs. 181 del 2000 l’obbligo, in capo al datore
di lavoro, di consegnare al lavoratore, all’atto di assunzione, una dichiarazione
sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola.
I vizi della volontà
Un’altra annosa problematica affrontata dalla dottrina generale del contratto attiene
alla possibile estrinsecazione dei vizi della volontà, che come è agevole
comprendere nel caso del rapporto di lavoro subordinato va considerata alla luce
della ridotta autonomia individuale delle parti nella formazione del consenso.
Infatti, hanno un rilevo pratico ridotto le ipotesi della violenza morale e del dolo;
tali vizi agiscono sulla formazione della volontà dei contraenti influenzandola
non sul piano dei motivi ma sul piano delle divergenze tra la volontà ipotetica e
quella dichiarata.
I vizi della volontà nel contratto di lavoro
Nel contratto di lavoro, ovviamente, le ipotesi della violenza morale e del dolo
hanno una scarsa influenza in quanto la conclusione del contratto si attua
attraverso l’esecuzione della prestazione di lavoro che non può essere diversa
dalla volontà dichiarata.
Nel contratto di lavoro è, invece, difficile configurare in concreto un’ipotesi di
errore essenziale sull’oggetto o sul contenuto del contratto: l’ipotesi principale
resta quella che si verifichi un errore essenziale e riconoscibile dall’altro
contraente sulla persona. Nel rapporto di lavoro, come abbiamo avuto modo di
affermare in precedenza, una simile rilevanza è strettamente connessa alla
considerazione soggettiva della persona (c.d. intuitus personae) del prestatore.
Nel caso dell’errore, come degli altri vizi, il problema va rinvenuto nella divergenza
tra l’intenzione e la volontà concretamente manifestata dalle parti.
La simulazione nel contratto di lavoro
Altra natura assume il problema della divergenza tra la volontà e la dichiarazione
in caso di simulazione. Infatti, in tal caso la volontà dichiarata verso l’esterno è
diversa dalla volontà dichiarata verso l’interno dagli stessi contraenti che viene
generalmente definita controdichiarazione.
Naturalmente quest’ultima è l’unica manifestazione di volontà efficace tra le
parti in virtù dell’accordo simulatorio che le vincola, se sussistono i requisiti di
sostanza e di forma prescritti per la valida esistenza del negozio effettivamente
voluto, fatti salvi i diritti dei terzi. Di conseguenza, se il contratto simulato è un
contratto di lavoro autonomo, ma il rapporto effettivamente voluto dalle parti è di
carattere subordinato, sarà quest’ultimo a prevalere sul piano della realtà negoziale.
Lavoro gratuito e volontario
La causa del contratto di lavoro subordinato è tipicamente onerosa di scambio,
costituendo la retribuzione l’obbligazione fondamentale gravante sul datore di lavoro,
legata con vincolo di corrispettività genetica e funzionale alla attività di lavoro svolta
51
dal prestatore. Da ciò deriva che la controversa fattispecie del lavoro gratuito non
possa essere ricondotta al contratto di lavoro subordinato, trattandosi di attività
lavorativa non originata da un vincolo contrattuale, ma effettuata affectionis vel
benevolentia causa in adempimento di doveri morali o sociali.
La presunzione iuris tantum di gratuità è pertanto sostenibile solo in relazione a
prestazioni lavorative rese nell’ambito di convivenze familiari o comunità religiose,
mentre al di fuori di queste ipotesi la gratuità può dar luogo a sospetti di frode alla
legge (1344 c.c.). Organizzazioni a scopo benefico o solidaristico, oppure ideologico
o di tendenza (partiti, sindacati, giornali) spesso si avvalgono di prestazioni gratuite,
da considerarsi come una obbligazione naturale. La legge-quadro sul volontariato n.
266/1991 prevede che le organizzazioni di volontariato, in considerazione dell’alto
valore sociale di partecipazione, solidarietà e pluralismo, possano avvalersi in modo
prevalente di prestazioni volontarie e gratuite degli associati e aderenti, la cui attività
è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo con le
organizzazioni. Queste possono assumere con contratti di lavoro (subordinato o
autonomo) solo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nel caso in cui
ciò sia necessario a qualificare l’attività da esse svolta (ad es. lo psicologo nella
comunità di recupero di ex tossicodipendenti).
I rapporti associativi
Diversi sotto il profilo causale sono i rapporti di lavoro associativi, nei quali una
obbligazione di facere finalizzata alla collaborazione nell’impresa è inserita nello
schema tipico dei contratti associativi, caratterizzati non dalla causa di scambio
lavoro-retribuzione, bensì dall’esercizio in comune di una attività economica e
quindi dalla comune assunzione del rischio di impresa e dallo scopo di lucro.
Questi rapporti sono caratterizzati, sul piano pratico, dall’obiettivo di cointeressare il
lavoratore al risultato d’impresa, associandolo all’esercizio dell’attività economica e
alla ripartizione degli utili: il socio d’opera nella società di persone o l’associato
nell’associazione in partecipazione conferiscono la propria attività per un interesse
comune con gli altri soci o con l’associante, ma anche in questi casi per
l’accertamento della vera natura del rapporto risulta decisivo non il nomen iuris
dichiarato ma un’indagine sullo svolgimento effettivo dello stesso.
Il socio lavoratore
Il legislatore ha in particolare disciplinato il lavoro del socio lavoratore nelle
cooperative di produzione e lavoro, costituite allo scopo di svolgere un’attività
economica organizzata per il mercato mediante l’utilizzazione del lavoro dei soci.
Allo scopo di evitare finalità elusive, al socio lavoratore è riconosciuta la titolarità di
due rapporti: uno associativo e l’altro di lavoro con la cooperativa. Per assicurare un
trattamento equiparabile a quello del lavoratore subordinato, la legge 142/2001
impone la corresponsione al socio lavoratore di un trattamento economico
complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non
inferiore ai minimi previsti dai CCNL del settore o della categoria affine e
l’applicazione dello statuto dei lavoratori, con l’eccezione della disciplina protettiva
52
contro i licenziamenti ingiustificati e dei diritti sindacali (il cui esercizio deve essere
previsto dai CCNL del settore).
L’ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Modi di estinzione del rapporto di lavoro.
Abbiamo trattato fin’ora del rapporto di lavoro subordinato nei diversi aspetti della
sua esistenza, passiamo ora ad esaminarne, invece, il momento estintivo. Infatti,
come ogni altra vicenda, anche il rapporto di lavoro ha un termine nel tempo, e
l’estinzione può essere riconducibile sia alla volontà di una sola delle parti contraenti
che alla volontà di entrambe. Nel caso in cui l’effetto estintivo sia riconducibile ad
una sola parte contraente, si ha un atto unilaterale o recesso che se posto in essere
dal datore di lavoro si definisce licenziamento, se posto in essere dal lavoratore
consiste nella dimissione. Qualora l’estinzione del rapporto di lavoro venga decisa
di comune accordo da entrambe le parti si parla di risoluzione consensuale del
rapporto. Va considerata, inoltre, anche un’altra modalità di risoluzione dei rapporti
obbligatori: la sopravvenuta impossibilità della prestazione.
Sopravvenuta impossibilità della prestazione.
Il caso della impossibilità sopravvenuta della prestazione, così come intesa nel
diritto comune, è certamente applicabile al rapporto di lavoro anche se
drasticamente ridimensionata proprio per la natura delle obbligazioni oggetto del
sinallagma. Infatti, mentre nel diritto comune per sopravvenuta impossibilità della
prestazione il contratto si risolve ope legis, nel rapporto di lavoro quando
l’interesse alla prosecuzione della prestazione viene meno è sicuramente più
funzionale il recesso volontario. È possibile che per sopravvenuti eventi concernenti
l’impresa o concernenti la persona del lavoratore si verifichi una mancata
convenienza alla prosecuzione del rapporto di lavoro, ma secondo la dottrina tale
interesse può essere meglio salvaguardato attraverso il recesso volontario più
funzionale rispetto alla risoluzione automatica del contratto.
Natura delle obbligazioni oggetto del sinallagma.
La natura delle due obbligazioni oggetto del contratto di lavoro implica una
limitazione del concetto di impossibilità sopravvenuta rispetto al senso rigido
con cui questa nozione è intesa nel diritto comune. I due tipi di obbligazione,
infatti, sono molto diversi tra di loro sia in termini di funzione che di struttura.
L’obbligazione del datore di lavoro è tipicamente pecuniaria e in quanto tale non
può mai essere impossibile. D’altro canto l’obbligazione del prestatore di lavoro è
elastica ed a contenuto, almeno in parte, da definire, per cui certamente, anch’essa
non è impossibile come rigidamente si intende nel diritto comune. Infatti, se
prendiamo ad esempio il caso di perimento dello stabilimento ove il lavoratore svolge
la propria prestazione, questo rappresenta soltanto una difficoltà per il datore di
lavoro di ricevere la prestazione potendo, il lavoratore, essere adibito ad un altro
53
stabilimento; oppure se il lavoratore a causa di inidoneità fisica o professionale non
può più svolgere le mansioni a cui era originariamente adibito non si verifica una
impossibilità ad adempiere l’obbligazione lavorativa in quanto potrebbe essere
adibito ad altre mansioni.
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
La risoluzione consensuale è uno dei modi in cui il datore di lavoro ed il lavoratore
possono giungere di comune accordo alla estinzione del rapporto. Infatti, sia la
dottrina che la giurisprudenza riconoscono il diritto di entrambe le parti a voler
sciogliere il contratto, e le rispettive obbligazioni assunte. Va sicuramente accertato
che il negozio di risoluzione non sia in realtà un modo per aggirare le disposizioni
sempre più stringenti in materia di licenziamento, in tal caso, infatti, si
configurerebbe la fattispecie del negozio in frode alla legge, di per sé nullo. La
giurisprudenza, proprio per rafforzare la tutela del lavoratore, ha previsto che, in
caso di risoluzione consensuale, vengano ritenuti insufficienti i comportamenti
concludenti o acquiescenti del lavoratore, e sia posta particolare attenzione alla
manifestazione di volontà delle parti contraenti intesa all’estinzione del rapporto di
lavoro.
Il recesso.
Il recesso, come disciplinato dall’art. 1324 del Codice Civile, è un atto unilaterale
recettizio. È un negozio unilaterale in quanto espressione di una sola delle parti
contraenti; ed è recettizio perché diretto a produrre effetti nella sfera giuridica
dell’altro contraente ed ovviamente perché questo avvenga è necessario che il
destinatario ne sia a conoscenza. Nei contratti di durata il recesso ha la tipica
funzione di delimitare nel tempo l’efficacia del contratto, attraverso la fissazione ex
post di un termine, ed inoltre di perseguire l’interesse meritevole di tutela ai sensi
dell’art. 1322 c.c. alla risoluzione unilaterale del rapporto. In altri termini ciascuno
dei contraenti ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso (recesso ad
nutum o ordinario) anche contro la volontà dell’altro contraente, solo in particolari
casi di inadempimento di un’obbligazione sinallagmatica il recesso avviene senza
preavviso e con effetto immediato (recesso straordinario).
Il recesso nel rapporto di lavoro.
Nel rapporto di lavoro il recesso si distingue a seconda degli interessi tutelati: il
recesso del lavoratore (dimissione) è espressione della libertà morale
dell’individuo, data l’implicazione personale nella prestazione di lavoro; il recesso
del datore di lavoro (licenziamento) è espressione di un interesse patrimoniale e
incide sul diritto al lavoro dell’altro contraente. La nozione codicistica del recesso,
che si basa sulla perfetta eguaglianza giuridica tra i due contraenti, nell’ambito del
rapporto di lavoro ha subito profonde modifiche nel tempo che hanno limitato il
potere di recesso del datore di lavoro introducendo limiti, sia di carattere formale che
sostanziale, volti a tutelare il lavoratore non solo in quanto contraente debole ma
anche in quanto soggetto socialmente sottoprotetto. Di seguito esamineremo
54
innanzitutto le fattispecie previste dal codice civile, quali il recesso ad nutum ed il
recesso per giusta causa, per poi passare alla disciplina del licenziamento introdotta in
seguito dalle leggi speciali.
Il recesso ad nutum.
L’art. 2118 del Codice Civile prevede la possibilità per entrambi i contraenti di
recedere dal contratto di lavoro liberamente con il semplice preavviso senza
essere tenuti ad alcuna giustificazione. L’obbligo di dare il preavviso deve essere
esercitato nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva o, in mancanza,
secondo gli usi o l’equità. Nel caso in cui il recedente non rispetti l’obbligo del
preavviso è tenuto a corrispondere alla controparte un’indennità di carattere
risarcitorio: l’indennità di mancato preavviso. L’importo di tale indennità è pari
alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per la durata del periodo di
preavviso. Argomento dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza è la natura
dell’indennità di mancato preavviso, se reale o obbligatoria; gli orientamenti
dominanti propendono per la natura reale certamente più funzionale rispetto alla ratio
della norma.
Il recesso per giusta causa.
Il codice civile accanto al recesso ad nutum prevede il recesso per giusta causa
disciplinato dall’art. 2119. Il recesso per giusta causa è un recesso straordinario
che comporta l’immediata interruzione del rapporto di lavoro, senza preavviso,
in quanto si viene a verificare una causa talmente grave da non consentire la
prosecuzione “anche provvisoria, del rapporto”. Va segnalato che la recente
giurisprudenza di legittimità ha ravvisato la necessità di non distinguere il recesso in
due tipi, ma di considerare un unico negozio rispetto al quale la giusta causa
costituisce solo un presupposto che fa venir meno l’obbligo del preavviso. Va altresì
segnalato che l’art. 2119 c.c., in caso di dimissioni per giusta causa, prevede per il
lavoratore il diritto a vedersi corrisposta l’indennità di mancato preavviso, in
quanto il rapporto si interrompe in ragione di un inadempimento del datore di lavoro.
Applicabilità della disciplina codicistica del recesso ad nutum.
La disciplina codicistica del recesso ad nutum è sempre applicabile per quanto
concerne le dimissioni del lavoratore, per cui vige sempre e soltanto l’obbligo di
preavviso. In merito al recesso del datore di lavoro, la disciplina codicistica del
recesso ha subito notevoli limitazioni nel tempo, intese a tutelare maggiormente il
lavoratore, pertanto resta ancora applicabile, soltanto per quelle categorie di
lavoratori escluse dal campo di applicazione delle leggi speciali in materia di
licenziamento individuale. Infatti, con l’introduzione del c.d. licenziamento
vincolato previsto dalla Legge 108 del 1990, il licenziamento ad nutum ha assunto
una funzione meramente residuale passando da regola ad eccezione. L’esclusione di
alcune categorie dalla tutela contro i licenziamenti ingiustificati può avere diverse
ragioni insite nel rapporto di lavoro stesso e legate ad esempio al contenuto specifico
55
della prestazione, alla natura fiduciaria del rapporto di lavoro o al presunto venir
meno dell’interesse del lavoratore per la stabilità del rapporto.
I lavoratori per cui si applica il recesso ad nutum.
Il regime del recesso ad nutum è applicabile ai lavoratori domestici e agli
sportivi professionisti esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione delle tutele
previste dalle leggi speciali in materia di licenziamenti individuali. Sono soggetti al
regime del recesso libero anche i lavoratori in prova in virtù della loro esplicita
esclusione dalla disciplina limitativa dei licenziamenti. Inoltre il recesso libero vige
per quanto concerne i lavoratori che abbiano maturato la pensione di vecchiaia ed
abbiano compiuto i 65 anni di età. Tale limite di età vale anche per la donna
sebbene l’età pensionabile sia fissata ad una soglia inferiore rispetto all’uomo. Infine
un’altra categoria assoggettata ancora al regime del libero recesso è quella dei
dirigenti esclusi dalla disciplina dei licenziamenti come disposto dalla Legge 604 del
1966 che è espressamente rivolta ad operai, impiegati e quadri intermedi.
Il licenziamento del dirigente.
Rispetto alle altre categorie, escluse dal campo di applicazione delle tutele previste in
materia di licenziamenti individuali, la categoria dei dirigenti merita attenzione
perché presenta delle particolarità. Infatti, sebbene la Corte costituzionale si sia
pronunciata sulla legittimità della legge che esclude i dirigenti dal campo di
applicazione delle tutele previste per i licenziamenti individuali, la giurisprudenza
ha affermato l’applicabilità del recesso ad nutum soltanto per i c.d. dirigenti
apicali, cioè coloro che occupano posizioni ai vertici dell’organizzazione d’impresa.
Inoltre, per i dirigenti è previsto l’obbligo di comunicazione in forma scritta del
licenziamento ed opera la tutela contro il licenziamento discriminatorio. Va
segnalato altresì il ruolo della contrattazione collettiva che da tempo ha previsto
l’obbligo di giustificazione per il licenziamento del dirigente e la possibilità per lo
stesso di ricorrere ad un collegio arbitrale per accertare l’inesistenza della
giustificazione. In tal caso, il datore di lavoro può essere condannato al pagamento di
una indennità di natura risarcitoria che va ad aggiungersi all’indennità di mancato
preavviso.
Ipotesi di limitazione temporale del licenziamento.
Il codice civile, oltre a prevedere le due tipologie di recesso, ordinario e
straordinario, dal contratto di lavoro, ha stabilito che vi siano dei periodi di
limitazione temporale della facoltà di recesso da parte del datore di lavoro. In
tali periodi è espressamente escluso il recesso ad nutum, mentre è consentito il
recesso per giusta causa. Più esplicitamente la facoltà di recedere da parte del datore
di lavoro incontra un limite nei casi in cui il prestatore si trovi nella condizione di
impossibilità ad eseguire la prestazione per causa di infortunio, malattia,
gravidanza o puerperio (art. 2110 c.c.). Tale disciplina continua ad applicarsi a tutti
i lavoratori, non soltanto a quelli per cui opera ancora il principio codicistico della
56
libera recedibilità, anche dopo l’introduzione della disciplina limitativa dei
licenziamenti.
La sospensione del rapporto di lavoro.
Durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro fissati dall’art. 2110 c.c. il
datore di lavoro non può licenziare a meno che non intervenga una giusta causa, e nel
caso delle lavoratrici madri il fatto determinante il recesso deve essere ancora più
grave. Superato il periodo indicato dalla norma, durante il quale il lavoratore ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro, il datore di lavoro può licenziare ai
sensi dell’art. 2118 c.c.. Il periodo di sospensione è determinato dalla legge nel
caso delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri e dalla contrattazione
collettiva nel caso di infortunio e malattia. Il diritto alla conservazione del posto
vige anche per le ipotesi di chiamata alle armi, per i lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive e per i lavoratori che hanno diritto a congedi per motivi di
cura e formativi.
Il licenziamento nei casi di sospensione.
Gli orientamenti dominanti di dottrina e giurisprudenza ritengono che il
licenziamento comminato durante il periodo di sospensione del rapporto di
lavoro privo di giusta causa sia da ritenersi inefficace, purché formalmente e
sostanzialmente valido. L’inefficacia è legata all’impossibilità del provvedimento di
produrre effetti durante i periodi di sospensione, potendoli produrre soltanto dopo la
scadenza dei medesimi. Va segnalato che nel caso in cui il licenziamento venga
comminato alla lavoratrice madre o al lavoratore padre o ancora per motivi di
cura e formativi è da ritenersi nullo, come vedremo meglio nella prossima lezione.
La disciplina limitativa dei licenziamenti.
Più volte è stato ribadito che nel corso degli anni la disciplina codicistica è stata
integrata da una serie di disposizioni successive intese a rafforzare la tutela del
lavoratore e a salvaguardare il suo diritto alla stabilità del posto di lavoro. Gli
interventi in oggetto si sono sovrapposti alla normativa degli art. 2118 e 2119 del
codice civile così che, attualmente, la disciplina generale dei licenziamenti nei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato è contenuta in una serie di fonti
legislative succedutesi ed integratesi nel tempo.
Il ruolo della contrattazione collettiva.
Già la contrattazione collettiva, a partire dal dopo guerra, seppure con interventi
limitati al settore dell’industria, aveva cercato di limitare il potere di recesso del
datore di lavoro introducendo non solo vincoli di carattere formale, quale la forma
scritta del provvedimento di licenziamento, ma anche vincoli di carattere
sostanziale come la necessità di giustificare il licenziamento o attraverso la giusta
causa o mediante un giustificato motivo. Il licenziamento privo di giustificazione
era da ritenersi illegittimo ed il datore di lavoro era obbligato alla riassunzione del
lavoratore o al pagamento di una somma a titolo risarcitorio (tutela
57
obbligatoria). Purtroppo la disciplina collettiva aveva un’efficacia ridotta dati:
l’applicabilità degli accordi interconfederali alle sole parti stipulanti; l’ambito di
applicazione ristretto (l’accordo era applicabile ai datori con più di 35 dipendenti) e
l’accertamento della giustificazione posta non in capo ad un giudice ma ad un
collegio di conciliazione ed arbitrato.
La Legge 604 del 1966.
Il primo intervento legislativo, inteso a limitare il potere di recesso del datore di
lavoro, è la Legge 604 del 15 luglio 1966. Questa norma ha recepito integralmente
la disciplina della contrattazione collettiva ed in particolare la c.d. tutela
obbligatoria che prevede, in caso di licenziamento ingiustificato, l’obbligo in capo al
datore di lavoro di riassumere il lavoratore oppure il pagamento di una penale a titolo
di risarcimento del danno. Oltre a recepire la disciplina contrattuale la legge in esame
ha accolto anche i limiti applicativi previsti dall’autonomia collettiva consentendo
l’applicazione della tutela alle sole imprese con più di 35 dipendenti.
L’art. 18 della Legge 300 del 1970.
La Legge 300 del 1970, meglio nota come Statuto dei lavoratori, ha rappresentato un
momento fondamentale sul piano dell’effettività della tutela del lavoratore contro il
licenziamento illegittimo, in quanto ha introdotto, all’art. 18, il principio, che
corrisponde in effetti ad una sanzione per il datore di lavoro, della reintegrazione
nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno. L’art. 35 della stessa legge,
stabiliva il campo di applicazione della tutela limitandolo alle sole unità produttive
con oltre 15 dipendenti. Questo comportava che un gran numero di lavoratori
restavano esclusi dalla tutela contro i licenziamenti in quanto il campo di
applicazione lasciava fuori tutte quelle fasce di lavoratori dipendenti dalle piccole
imprese.
La Legge 108 del 1990.
L’esigenza di estendere la tutela contro i licenziamenti illegittimi anche alle fasce di
lavoratori dipendenti delle piccole imprese è stata ravvisata dalla stessa Corte
Costituzionale che con una sentenza del 1986 ha sottolineato l’importanza di
offrire ai lavoratori esclusi dai campi di applicazione delle discipline allora
vigenti una forma di tutela contro i licenziamenti ingiustificati, anche in
considerazione del crescente numero di occupati in imprese di ridotte dimensioni.
L’impulso dato dalla citata sentenza ha portato all’emanazione della Legge 108 del
11 maggio 1990, che ha ridisegnato ampiamente la disciplina preesistente in
particolare ridefinendo il campo di applicazione sia della tutela obbligatoria sia di
quella reale e sancendo espressamente il principio della giustificatezza del
licenziamento, o anche recesso vincolato, salvo alcune eccezioni esplicitamente
definite.
GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO
58
Limiti sostanziali al potere di licenziare.
Come abbiamo già visto nel corso della precedente lezione il più importante limite
posto al potere di recedere del datore di lavoro è di carattere sostanziale o causale, in
quanto la legge 604 del 1966 all’art. 1 dispone che affinché un licenziamento possa
essere ritenuto legittimo deve necessariamente ricorrere una giusta causa o un
giustificato motivo. Entrambi hanno la funzione di legittimare il recesso del datore
di lavoro che non è più libero di recedere mediante il solo preavviso, bensì è
vincolato in ogni caso all’obbligo di fornire una causa giustificatrice del
provvedimento di licenziamento. La distinzione tra il recesso ordinario o
straordinario comporta effetti differenti solo sul piano del preavviso che spetta
soltanto al lavoratore licenziato per giustificato motivo.
Illegittimità del negozio per mancanza dei requisiti causali.
Le conseguenze all’illegittimità del negozio di licenziamento per mancanza dei
requisiti causali di cui sopra non sono sempre le stesse ma variano a seconda
dell’applicazione della tutela reale o obbligatoria. Nel caso di applicabilità della
tutela reale prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori la legge prevede
l’annullabilità del licenziamento intimato in assenza di giustificazione. Nel caso
di applicabilità della tutela obbligatoria prevista dalla legge 604 del 1966 il
licenziamento privo di giustificazione, seppure illegittimo, non è annullabile.
L’illegittimità del provvedimento comporta comunque l’erogazione di sanzioni in
capo al datore di lavoro.
La nozione di giustificato motivo.
L’art. 3 della legge 604 del 1966 definisce la nozione di giustificato motivo di
licenziamento disponendo che “il licenziamento per giustificato motivo con
preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali
del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Si evince un
netta distinzione tra una motivazione di carattere puramente soggettivo data dal
notevole inadempimento di obblighi contrattuali da parte del lavoratore e una
motivazione di natura oggettiva legata esclusivamente a motivi inerenti
l’organizzazione del lavoro.
Il giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
Per determinare il giustificato motivo soggettivo di licenziamento si fa ricorso all’art.
1455 c.c. secondo cui, affinché il contratto possa essere risolto, deve tenersi conto
della rilevanza che l’inadempimento ha nei confronti della controparte, nel senso che
non può essere un inadempimento “di scarsa importanza”. Secondo il dettato
normativo perché vi sia giustificato motivo soggettivo di licenziamento deve
verificarsi un notevole inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
del lavoratore. Nella definizione della casistica delle motivazioni assume
particolare importanza il ruolo della contrattazione collettiva, che esercita un ruolo
di chiarificazione della legge, in quanto individua le ipotesi in cui può configurarsi un
59
giustificato motivo soggettivo di licenziamento, sebbene tali indicazioni non siano
vincolanti per il giudice. Infatti, l’opinione dominante in dottrina e in giurisprudenza
nega l’efficacia preclusiva alle previsioni collettive dovendosi fare riferimento alla
nozione legale di notevole inadempimento.
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Il giustificato motivo oggettivo si verifica in seguito a ragioni legate
all’organizzazione del datore di lavoro e al suo regolare funzionamento.
L’ordinamento in questo caso fa prevalere le esigenze tecniche ed economiche
dell’organizzazione produttiva sull’interesse del lavoratore alla conservazione del
posto di lavoro, fermo restando che tali esigenze sono definite in base a criteri
obiettivi di regolare svolgimento dell’attività produttiva e non in base al libero
arbitrio del datore di lavoro. Inoltre, una consolidata giurisprudenza di legittimità
ritiene che possa essere ravvisato il giustificato motivo oggettivo solo come extrema
ratio per il datore di lavoro, il quale deve essere nella condizione di non avere
alcun’altra alternativa.
La carcerazione preventiva.
La giurisprudenza nell’interpretazione delle ipotesi collegate alle esigenze
dell’impresa, tali da giustificare un motivo oggettivo di licenziamento, ha
ricompreso anche quelle modificazioni nell’attività organizzativa del datore di
lavoro connesse alla persona del lavoratore. Uno di questi casi è la carcerazione
preventiva del lavoratore. In tal caso non si può parlare di giustificato motivo
soggettivo in quanto non si configura un inadempimento da parte del lavoratore, che
non contravviene agli obblighi contrattuali, ma per ragioni personali viene sottratto
dal contesto lavorativo. Si tratta di un motivo oggettivo in quanto il datore di lavoro è
costretto, per l’assenza del lavoratore, ad una riorganizzazione dell’attività
dell’impresa.
La sopravvenuta inidoneità del lavoratore.
Secondo la giurisprudenza, e in taluni casi anche secondo l’autonomia collettiva,
un’altra ipotesi legata alla persona del lavoratore, ma configurante pur sempre un
giustificato motivo oggettivo di licenziamento, è la sopravvenuta inidoneità del
lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli. È il caso dell’inabilità da
infortunio o malattia prevista dalla legge 68 del 1999, che disciplina il diritto al
lavoro dei disabili. Tale normativa, che integra le disposizioni della legge 604 del
1966, prevede che i lavoratori divenuti inabili al lavoro per causa di infortunio o
malattia non possono essere licenziati per giustificato motivo oggettivo qualora vi
sia la possibilità di adibirli ad altre mansioni equivalenti oppure inferiori, in
deroga a quanto previsto dall’art. 2103 del Codice Civile. Di conseguenza in caso di
impossibilità ad adibire il lavoratore ad altre mansioni è legittimo il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo per sopravvenuta inidoneità del lavoratore.
Superamento del periodo di conservazione del posto.
60
Diverso dalla sopravvenuta inidoneità del lavoratore per ragioni di malattia è il
licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di conservazione del
posto di lavoro, c.d. periodo di comporto. In tal caso non si integra l’ipotesi di un
giustificato motivo oggettivo di licenziamento ma quanto previsto dall’art. 2110
c.c. secondo cui il datore di lavoro può recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118,
decorso il periodo di conservazione del posto di lavoro fissato dalla legge o dalla
contrattazione collettiva.
Il controllo giudiziale: merito o legittimità.
In materia di giustificato motivo oggettivo si rileva un notevole contrasto sia in
dottrina che in giurisprudenza circa la natura del controllo che dovrebbe esercitare
il giudice rispetto ad un provvedimento di licenziamento impugnato. Una parte
minoritaria ritiene che al giudice spetti un controllo di merito sulla necessità del
licenziamento e sulla razionalità delle scelte imprenditoriali del datore di lavoro.
Mentre l’orientamento dominante ritiene che il giudice debba limitarsi ad
accertare la legittimità del licenziamento senza entrare nel merito delle scelte del
datore di lavoro, anche in considerazione del fatto che la libertà di iniziativa
economica del datore di lavoro in quanto imprenditore è un principio sancito dall’art.
41 della Carta costituzionale. Il controllo di legittimità è inteso a verificare la
sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro valutando altresì l’esistenza o
meno di un nesso di causalità tra il provvedimento di licenziamento e le scelte
organizzative di quest’ultimo.
La nozione di giusta causa.
Abbiamo già visto che la nozione di giusta causa è contenuta nell’art. 2119 c.c. e
consiste in una causa talmente grave da non consentire nemmeno la prosecuzione
provvisoria del rapporto di lavoro. L’interpretazione di tale norma da parte di
dottrina e giurisprudenza, prima della legge 604 del 1966, faceva ritenere che si
potesse configurare come giusta causa di licenziamento ogni fatto in grado di
giustificare il recesso in tronco da parte del datore di lavoro, e che quindi dovesse
consistere in un inadempimento, o anche altro accadimento estraneo al rapporto di
lavoro, obiettivamente idoneo a menomare il rapporto di fiducia personale,
intrinseco nel rapporto sinallagmatico, anche indipendentemente dalla colpa del
lavoratore.
Evoluzione interpretativa della nozione di giusta causa.
In seguito all’entrata in vigore della legge 604 del 1966, sebbene parte della
giurisprudenza continui a ravvisare il venir meno del nesso fiduciario alla base del
licenziamento in tronco, altra parte della giurisprudenza e la dottrina maggioritaria
hanno ritenuto che la definizione di giusta causa non debba essere più quella
generica del codice ma vada puntualizzata in rapporto alla nuova nozione di
giustificato motivo soggettivo di licenziamento, dal quale dovrebbe differenziarsi
soltanto per la particolare e maggiore gravità. Secondo tale orientamento la
differenza tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo, riconducibili entrambi
61
ad un inadempimento del lavoratore, è apprezzabile da un punto di vista
meramente quantitativo nel senso della maggiore o minore gravità del fatto
compiuto o meno dal lavoratore, e non sul piano qualitativo escludendo la possibilità
di fare esclusivamente riferimento alla nozione di fiducia come elemento rilevante ai
fini del licenziamento, anche se questo non comporta l’assoluta esclusione della
rilevanza del nesso fiduciario.
La forma del negozio di licenziamento.
Oltre ai vincoli causali osservati fin’ora, la legge impone un ulteriore limite al
potere di recesso del datore di lavoro, infatti è richiesta la forma scritta del
negozio di licenziamento. La legge 604 del 1966 all’art. 2 stabilisce che il
licenziamento deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta. I motivi del
licenziamento non devono essere comunicati contestualmente, in ogni caso il
lavoratore può richiederli entro 15 giorni dalla comunicazione del recesso ed in
tal caso il datore di lavoro è tenuto a notificarli entro 7 giorni dalla richiesta.
L’indicazione dei motivi costituisce l’elemento fondante dell’effettività dell’intera
disciplina, in quanto la loro comunicazione è indispensabile per determinare il thema
decidendum dell’eventuale controversia.
Immodificabilità della motivazione.
Circa i motivi addotti al provvedimento di licenziamento vige il principio della
immodificabilità della motivazione, infatti il datore di lavoro non può in nessun
caso, in sede di controversia, addurre motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli
originariamente comunicati. In virtù di tale principio il giudizio di impugnazione del
provvedimento di licenziamento viene delimitato esclusivamente dal contenuto
della comunicazione scritta. Il giudice potrebbe ritenere che i fatti contestati al
lavoratore non siano tali da integrare una giusta causa di licenziamento ma un
giustificato motivo soggettivo, in tal caso si procede ad una conversione del
licenziamento con l’obbligo del preavviso in capo al datore di lavoro, che dovrà
risarcire il lavoratore con l’erogazione dell’indennità di mancato preavviso.
Inefficacia del licenziamento per motivi di forma.
L’inosservanza degli adempimenti formali previsti dalla Legge 604 all’art. 2
comporta l’inefficacia del provvedimento di licenziamento. In questo caso si deve
ritenere che l’inefficacia corrisponda alla nullità del negozio, in quanto non si è di
fronte ad un caso di inopponibilità degli effetti negoziali, ma di fronte ad un negozio
privo dei suoi effetti per la mancanza di un requisito essenziale: la forma. È bene
comunque precisare che, siccome si tratta di inefficacia dell’atto negoziale, il datore
di lavoro potrà legittimamente rinnovare il provvedimento di licenziamento viziato
nella forma, naturalmente tale negozio avrà efficacia ex nunc.
Le ipotesi di nullità del licenziamento.
Oltre alle ipotesi di nullità del provvedimento di licenziamento per mancanza del
requisito formale (forma scritta), la legge vieta espressamente alcune tipologie di
62
licenziamento disponendone la nullità. È il caso del licenziamento
discriminatorio, del licenziamento per causa di matrimonio e del licenziamento
della lavoratrice madre. La sanzione prevista per queste tipologie di licenziamento
è indice della maggiore gravità del recesso del datore di lavoro in tali situazioni che
viene inteso non solo come lesivo del diritto del lavoratore alla stabilità del posto di
lavoro, ma come lesivo di principi sanciti espressamente dalla Carta Costituzionale.
Le ipotesi di nullità del licenziamento: licenziamento discriminatorio.
L’art. 4 della legge 604 del 1966 dispone che “il licenziamenti determinato da
ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato e
dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo indipendentemente dalla
motivazione adottata”. Tale tutela è stata successivamente integrata dalle previsioni
dell’art. 15 dello Statuto dei lavoratori che prevede la nullità anche per quei
licenziamenti intimati per ragioni di sesso, razza e lingua. Infine il dettato di queste
disposizioni trova la conferma definitiva nella legge 108 del 1990 che all’art. 3 non
solo ribadisce la nullità del licenziamento discriminatorio in tutti i casi disposti
dalle previsioni vigenti, ma stabilisce che in tali casi è sempre applicabile la tutela
reale.
Le ipotesi di nullità del licenziamento: licenziamento per causa di matrimonio.
La legge 7 del 9 gennaio 1963 prevede la nullità delle c.d. clausole di nubilato,
dette clausole potevano essere previste sia dai contratti collettivi che dai contratti
individuali e prevedevano la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici a
causa del loro matrimonio. La stessa legge prevede altresì la nullità del
licenziamento intimato a causa del matrimonio. La nullità è sancita a far data dal
giorno delle pubblicazioni del matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione
dello stesso. Il datore di lavoro ha la facoltà di dimostrare che il licenziamento non è
stato intimato a causa del matrimonio, ma affinché il provvedimento sia legittimo
devono necessariamente ricorrere le cause che consentono il licenziamento della
lavoratrice madre, alla cui trattazione si rinvia. Va segnalato che è prevista la nullità
anche delle dimissioni della lavoratrice nel periodo indicato, a meno che la stessa
non le confermi entro un mese presso gli uffici della Direzione Provinciale del
Lavoro.
Le ipotesi di nullità del licenziamento: licenziamento della lavoratrice madre.
La disciplina a tutela della lavoratrice madre è contenuta nel testo unico emanato
con D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001, il quale dispone altresì la nullità del
licenziamento a partire dal momento di inizio della gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino.
Il licenziamento ontologicamente disciplinare.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 1982 ha stabilito che ogni
licenziamento riconducibile a comportamenti soggettivi del lavoratore deve
rientrare nell’ampia nozione di licenziamento “ontologicamente” disciplinare e,
63
come tale, deve essere assoggettato alla disciplina procedurale prevista dall’art.
7 dello Statuto dei Lavoratori. Qualsiasi licenziamento che non osservi le
garanzie procedurali di cui all’articolo citato viene ritenuto illegittimo in quanto
non giustificato. Questo vuol dire che ogni licenziamento disciplinare deve essere
preceduto dalla contestazione dell’addebito e dalla concessione, al lavoratore, di un
termine per potersi difendere. Va altresì segnalato che il licenziamento disciplinare
non può essere comminato se non dopo che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione dell’addebito.
Illegittimità del licenziamento disciplinare.
Il licenziamento disciplinare intimato senza l’osservanza delle garanzie
procedimentali stabilite dall’art. 7 L. 300 del 1970 è illegittimo in quanto
ingiustificato. Infatti, il comportamento addebitato al lavoratore, ma non fatto valere
attraverso il suddetto procedimento, non può essere addotto dal datore di lavoro per
sottrarsi dall’applicazione della tutela reale e della tutela obbligatoria o ancora
dall’obbligo del preavviso fissato dall’art. 2118 del Codice Civile.
TUTELA REALE E TUTELA OBBLIGATORIA
Le tutele contro il licenziamento illegittimo.
Nel nostro ordinamento è illegittimo qualsiasi licenziamento che non corrisponda
al modello legale e dunque sia privo di giusta causa o di giustificato motivo,
oppure sia in contrasto con le norme poste a tutela di diritti fondamentali del
lavoratore, o ancora venga intimato senza il rispetto dei vincoli formali o procedurali
previsti dalla legge.
L’ordinamento prevede due diverse forme di tutela contro il licenziamento
illegittimo, la cui applicazione dipende innanzitutto dalle dimensioni aziendali, che
costituiscono la principale discriminante per la scelta della tutela da porre in essere.
La tutela reale prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro; la tutela obbligatoria, invece, prevede la
possibilità per il datore di lavoro di scegliere se riassumere il lavoratore oppure
pagare una penale a titolo di risarcimento del danno.
La tutela reale: ambiti di applicazione.
La tutela reale è prevista dall’art. 18 della legge 300 del 1970 (Statuto dei
lavoratori), si applica a quei datori di lavoro, sia imprenditori che non, che
abbiano alle dipendenze più di quindici lavoratori nell’unità produttiva in cui è
occupato il lavoratore licenziato, oppure nell’ambito dello stesso comune, e
comunque che abbiano alle dipendenze, globalmente, più di sessanta lavoratori.
Il limite numerico è di soli cinque dipendenti per quanto concerne le imprese
agricole.
64
È bene precisare che nel computo dei lavoratori, al fine della determinazione del
limite per l’applicazione della tutela reale, sono esclusi: il coniuge ed i parenti entro il
secondo grado del datore di lavoro; i lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
i lavoratori con contratto di lavoro interinale, naturalmente se si tratta di impresa
utilizzatrice. Inoltre, i lavoratori con contratto part-time a tempo indeterminato vanno
computati in proporzione all’orario di lavoro svolto.
L’art. 18, in merito all’unità produttiva, non indica una specifica delimitazione
geografica o organizzativa in quanto fa riferimento a “sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo”.
La reintegrazione nel posto di lavoro.
Nell’ambito dell’applicazione della tutela reale quando un licenziamento è
illegittimo e dunque inefficace per la mancata osservanza dei requisiti formali,
annullabile per mancanza di giustificazione o nullo perché discriminatorio o
vietato dalla legge, il datore di lavoro è obbligato alla reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro e a risarcire il lavoratore del danno subito a causa
del licenziamento. L’obbligo, in capo al datore di lavoro, di reintegrare il lavoratore
illegittimamente licenziato deriva dall’ordine contenuto nella sentenza di condanna.
Esecuzione dell’ordine di reintegrazione
L’esecuzione di tale ordine è affidata allo stesso datore che è tenuto a
ripristinare il rapporto di lavoro rivolgendo al lavoratore l’invito a riprendere
servizio.
A sua volta il lavoratore dovrà riprendere servizio entro trenta giorni dall’invito,
decorso il periodo anzidetto senza che lo stesso abbia ripreso la sua attività lavorativa
il rapporto si ritiene risolto per dimissioni.
Se, invece, il datore di lavoro non adempisse l’obbligo di reintegrare il
lavoratore, attraverso l’invito a riprendere servizio, verrebbe a trovarsi in una
situazione di mora credendi, da cui scaturirebbe, per il lavoratore, il diritto alla
retribuzione nonostante l’inattività.
In sostanza, la reintegrazione oltre ad essere una sanzione del licenziamento
illegittimo, si configura quale obbligo di fare che, pertanto, è infungibile ed
incoercibile.
Il risarcimento del danno.
Nell’ambito della tutela reale, e dati i requisiti della reintegrazione, la tutela
risarcitoria rappresenta una forma di coazione indiretta, infatti, quando
l’esecuzione della prestazione non è possibile per volontà del datore di lavoro, di
fatto non si ha la prosecuzione materiale del rapporto ma la prosecuzione come
vinculum iuris.
In tal senso, l’art. 18 stabilisce che il datore di lavoro sia tenuto, oltre alla
reintegrazione, al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione
globale di fatto, e comunque non inferiore a cinque mensilità, a titolo di
65
risarcimento del danno per il periodo che va dal licenziamento fino al momento
dell’effettiva reintegrazione.
L’indennità ha natura plurifunzionale in quanto da un lato è sanzione del
licenziamento illegittimo (illecito c.d. primario), dall’altro lato è sanzione
dell’inottemperanza dell’ordine di reintegrazione (illecito c.d. secondario). Nel primo
caso ha natura risarcitoria del danno subito dal lavoratore, nel secondo caso ha natura
di pena privata o comminatoria dell’inadempimento dell’obbligo di reintegrazione.
L’indennità risarcitoria sostitutiva della reintegrazione.
Oltre all’indennità risarcitoria di cui abbiamo già parlato e cui ha diritto il lavoratore
per l’intero periodo di estromissione dal posto di lavoro, l’art. 18 prevede anche una
indennità sostitutiva della reintegrazione.
Tale indennità, pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, spetta al
lavoratore che entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza di
reintegrazione voglia optare per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Secondo la dottrina, la facoltà riconosciuta al lavoratore di scegliere tra la
reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità sostitutiva, si configura come un
diritto potestativo dello stesso avente per contenuto la sostituzione della prestazione
secondaria (l’indennità) a quella dovuta in via principale (la reintegrazione) e allo
stesso tempo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il procedimento cautelare d’urgenza.
Dal punto di vista processuale, sia la giurisprudenza sia la dottrina dominante
escludono che la soddisfazione del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro
sia suscettibile di esecuzione specifica.
Inoltre, al fine di accelerare i tempi della sentenza è diffusa una prassi giudiziaria che
combina, sotto il profilo processuale, la disciplina ai sensi dell’art. 18 dello Statuto
dei lavoratori con il procedimento cautelare d’urgenza ex- art. 700 del Codice di
Procedura Civile, in tal caso il lavoratore ha l’onere di dimostrare l’esistenza di un
“pregiudizio imminente ed irreparabile” per sé o la sua famiglia.
Qualora il licenziamento sia illegittimo in quanto basato su una discriminazione
sindacale, la reintegrazione nel posto di lavoro può essere ottenuta anche attraverso la
procedura prevista dall’art. 28 legge 300 del 1970.
La tutela rafforzata per i dirigenti delle rappresentanza sindacali.
L’art. 18 prevede una tutela rafforzata a favore dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali articolata su due diversi livelli.
Da un lato è previsto che la sentenza di condanna alla reintegrazione possa essere
anticipata da un’ordinanza del giudice, che può intervenire in qualunque stato o
grado del giudizio. La stessa può essere emessa soltanto su istanza congiunta del
lavoratore e del sindacato quando il datore di lavoro abbia addotto prove insufficienti
a giustificare il licenziamento.
Dall’altro lato è previsto che l’inadempimento dell’ordine di reintegrazione sia
maggiormente oneroso per il datore di lavoro il quale è obbligato, oltre al
66
versamento delle retribuzioni a titolo risarcitorio, a versare una somma a titolo
di penale al Fondo pensione dei lavoratori e dunque all’INPS.
La tutela obbligatoria.
La tutela obbligatoria, prevista dall’art. 8 della legge 604 del 1966, si applica a
tutte le ipotesi di licenziamento illegittimo escluse dal campo di applicazione
della tutela reale, ed in particolare a quelle ipotesi di illegittimità derivanti dalla
mancata giustificazione del licenziamento stesso.
Come più volte ribadito, il datore di lavoro è obbligato a giustificare il
licenziamento, in caso contrario la tutela obbligatoria impone che lo stesso sia
tenuto alla riassunzione del lavoratore entro un termine di tre giorni, o in
alternativa al risarcimento del danno attraverso il versamento di una indennità,
a titolo di penale, il cui importo è fissato dal giudice e può variare da un minimo di
2.5 ad un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Illegittimità del licenziamento privo di giustificazione.
Nell’ambito di applicazione della tutela obbligatoria, il licenziamento illegittimo
per mancanza di giustificazione non è annullabile ma soltanto illecito. Infatti, a
differenza di quanto avviene nella tutela reale, dove il licenziamento è definito
espressamente annullabile dallo stesso art. 18 della legge 300 del ‘70, nella tutela
obbligatoria il licenziamento, seppur illegittimo, ha comunque l’effetto di
estinguere il rapporto di lavoro.
La sanzione comminata dal giudice comporta, infatti, la riassunzione del lavoratore,
di conseguenza c’è una novazione contrattuale con l’instaurazione di un nuovo
rapporto di lavoro.
La tutela del lavoratore nelle altre ipotesi di invalidità del licenziamento.
È bene ribadire ancora una volta che la tutela reale prevista dall’art. 18 dello
Statuto dei lavoratori riguarda:
a) il licenziamento inefficace per ragioni di forma;
b) il licenziamento annullabile per mancanza di giusta causa e di giustificato
motivo
c) il licenziamento nullo per motivi discriminatori.
Inoltre, la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto la forza espansiva di questa
tutela che la rende applicabile a tutte le ipotesi di invalidità ed inefficacia del
licenziamento.
In ogni caso è possibile applicare detta tutela solo entro precisi limiti
dimensionali, al di sotto dei quali interviene la tutela obbligatoria. Siccome
quest’ultima, come previsto dall’art. 8 della legge 604 del 1966, trova applicazione
alle sole ipotesi di licenziamento ingiustificato, si rende necessario stabilire quali
siano le forme di sanzione da applicare nelle altre ipotesi di invalidità del
licenziamento le cui motivazioni siano diverse dal difetto di giustificazione.
67
La tutela del lavoratore nelle altre ipotesi di invalidità del licenziamento: la
nullità.
Tra le fattispecie di licenziamento illegittimo, diverse da quelle intimate senza
giustificazione, abbiamo quelle ipotesi in cui il licenziamento è nullo, ovvero:
a) il licenziamento della lavoratrice madre o del lavoratore padre;
b) il licenziamento intimato per ragioni legate alla fruizione di congedi per motivi
di cura familiare o di formazione;
c) il licenziamento per causa di matrimonio.
In tutti questi casi è da ritenersi che, nell’ambito di applicazione della tutela
obbligatoria per via dei limiti dimensionali, debba farsi ricorso al regime di diritto
comune, secondo il quale dalla sentenza che accertata l’illegittimità del licenziamento
ne dichiara la nullità deriva di fatto la continuità giuridica del rapporto di lavoro ex
tunc, configurando pertanto una situazione di mora credendi del datore di lavoro ai
sensi dell’art. 1206 del Codice Civile.
La tutela del lavoratore nelle altre ipotesi di invalidità del licenziamento:
inefficacia per ragioni di forma.
Per quanto concerne l’ipotesi di licenziamento illegittimo per mancanza dei requisiti
formali, nell’ambito di applicazione della tutela obbligatoria, la giurisprudenza ha
stabilito con chiarezza che esso non produce alcun effetto.
Pertanto, il licenziamento intimato senza il rispetto delle formalità è da considerarsi
nullo, anche se è rinnovabile ex nunc secondo i principi generali.
Quest’orientamento è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nei
casi di mancanza del requisito della forma scritta, ma è stato considerato applicabile
anche alle ipotesi di inosservanza da parte del datore di lavoro dell’onere di
comunicazione dei motivi richiesti dal lavoratore. Tale orientamento dominante è
stato infine confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali hanno
chiarito che l’inefficacia del licenziamento, e la conseguente continuità del rapporto
di lavoro, fa sorgere in capo al lavoratore il diritto al risarcimento del danno e non
alle retribuzioni.
La tutela del lavoratore nelle altre ipotesi di invalidità del licenziamento:
illegittimità per violazione di garanzie procedurali.
Un’ultima ipotesi di licenziamento illegittimo, nell’ambito della tutela obbligatoria,
diverso dal licenziamento illecito perché non giustificato, è quello per violazione
della procedura prevista ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. La
giurisprudenza ha ritenuto di equiparare tale licenziamento illegittimo al
licenziamento ingiustificato e pertanto risulta essere direttamente applicabile la tutela
obbligatoria prevista dall’art. 8 della legge 604 del 1966.
68