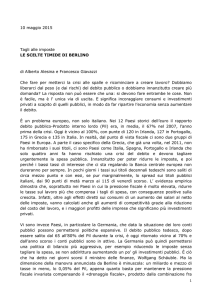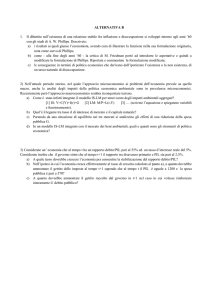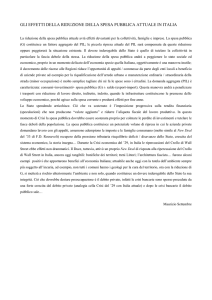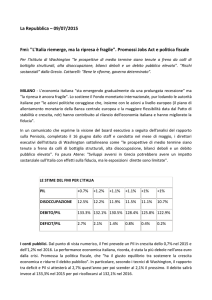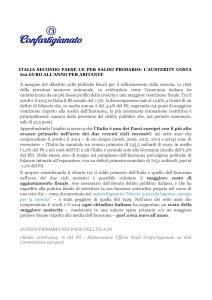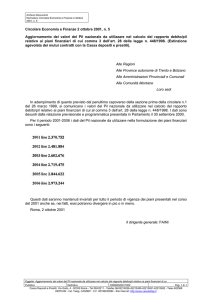AVVISO AI NAVIGANTI N. 40
18 DICEMBRE 2013
VIRTUALE OMICIDIO
Il 3 giugno del 1999 The Economist va in stampa con un editoriale titolato “The sick man of the euro”. Il malato è
un paese ingessato, sindacalizzato, con alto costo del lavoro, disoccupazione vicina all’undici per cento, un
sistema fiscale bizantino e inefficiente, un welfare pletorico e crescita economica da prefisso telefonico. E’ lo
stesso paese, però, che solo dieci anni prima ha inghiottito l’indigesto boccone della Germania Est e nel quale
il sistema manifatturiero, ancora basato come in Italia sulla piccola impresa, sta furiosamente delocalizzando
la base produttiva nei vicini paesi dell’est. Per crescere e rimanere competitivo. Passati quindici anni,
digerita la bolla dell’internet economy e quella dei subprime, entrambe originate oltreoceano da un eccesso di
debito, le multinazionali tedesche dominano i mercati internazionali, la disoccupazione è ai minimi storici, al
5,4 per cento e la crescita attesa del PIL per il 2014 è di poco inferiore al 2 per cento annuo. La Germania
scoppia di salute e, forse anche per questo, rimane sempre al centro del mirino. L’accusa è di imporre il suo
modello di governo economico ai partners europei: terapie killer che uccidono il paziente. Sotto attacco sono
il rigido approccio legale di cambiamento dei trattati, le politiche fiscali inflessibilmente restrittive, il rifiuto
di socializzare il debito con gli Eurobonds, l’estrema ortodossia monetaria, la visione autoreferenziale degli
sbilanci commerciali. La Germania non è amata, ma soprattutto non è capita. La politica economica di
Berlino è disprezzata dall’agguerrita pattuglia dei neokeynesiani che influenzano i policy makers di mezzo
mondo, ma poco apprezzata anche dai liberisti radicali, individualisti e antistatalisti. In Italia aveva un solo
estimatore: l’ex Presidente del Consiglio Mario Monti. Che, per ora, non ha fatto una bella fine.
IL VAMPIRO DI EUROLANDIA
E’ il Dipartimento del Tesoro americano nel suo semiannual currency report del 30 ottobre scorso a dar
fuoco alle polveri, sponsorizzando una tesi datata ma sempre di moda: il modello economico tedesco, tutto
export e frugalità pubblica e privata, non solo rallenta il riequilibrio interno dell’Eurozona, già frenato dalla
cura da cavallo imposta ai periferici europei, ma zavorra perfino la crescita dell’economia globale,
accentuando una deriva deflazionistica che dal vecchio continente si espande ovunque. Sotto tiro è lo
i
“scandaloso” e inattaccabile avanzo dei conti con l’estero che sarebbe causato (si veda Martin Wolf, Germany
is a weight on the world - FT.com) da un eccesso di risparmio (di famiglie, imprese e settore pubblico) sugli
investimenti: l’esuberanza delle esportazioni teutoniche, lungi dal riflettere esclusivamente vantaggi
competitivi, deriverebbe quindi da un surplus di produzione sulla domanda interna, tenuta deliberatamente
sotto freno dalle scelte di politica economica del governo. La Germania, come un vampiro, succhierebbe
dall’estero la domanda che non genera all’interno; ruolo scomodo, paragonabile a quello attribuito anni
addietro, in ambito finanziario, a Goldman Sachs. Un comportamento politicamente ed economicamente
scorretto, una vocazione mercantilistica - “beggar thy neighbour policy” – da condannare, a maggior ragione
nelle attuali condizioni di cronico eccesso di offerta globale e di trappola della liquidità, cioè di relativa
inefficacia della politica monetaria. Anche perché la Germania è la maggiore beneficiaria di un Euro troppo
forte per i paesi dell’Eurozona meno competitivi (la parità dei poteri d’acquisto dovrebbe comportare un
cambio con il dollaro a 1,25), ma certamente troppo debole rispetto al valore che avrebbe il marco se fosse
ancora la valuta nazionale (cfr. fig. 1).
1
Figura 1: tasso di cambio reale tedesco basato sul costo unitario del lavoro
Certo, i burocrati di Washington non hanno
grandi titoli per distribuire attestati di buona
condotta in campo economico, ma anche FMI
e OCSE, seppure con toni molto più sfumati,
sollevano analoghe critiche. Perfino l’algido
Commissario economico EU Olli Rehn è
costretto a richiamare all’ordine il governo di
Berlino. Ma la Germania è sotto attacco
soprattutto per come ha influenzato le
politiche di gestione della crisi in ambito
comunitario. Le contestazioni in merito,
soprattutto provenienti da economisti di
ii
etnia keynesiana, ma non solo, sono radicali. In un recente studio commissionato dalla Commissione
Europea, si stimano gli effetti cumulativi sul reddito dei singoli membri dell’Eurozona derivanti dalla scelta
di imporre una restrizione di bilancio simultanea e collettiva, sia pur di diversa intensità, a tutti i partners
comunitari, Germania inclusa. Tale politica,
attuata in un periodo caratterizzato da alto
stress finanziario, con spread in aumento,
difficoltà di accesso al credito e bilanci
familiari
in
sofferenza,
comporta
effetti
demoltiplicativi sul PIL, cioè di riduzione, ben
superiori
a
quelli
considerati
normali.
L’impatto negativo sarebbe inoltre amplificato
dall’effetto contagio, lo “spill over effect”
derivante sia dal canale della domanda interna
sia da quello della competitivitàiii. Nella tabella
a
fianco,
si
espone
la
dimensione,
in
percentuale del PIL, delle restrizioni fiscali
cumulate nel triennio 2011-2013, imposte dalla
Germania a se stessa e a tutti gli altri paesi. In Italia il consolidamento è pari a quasi il 4% del prodotto, in
Grecia al 9%, in Germania al 2,6%. La ricerca econometrica dimostra che gli effetti di travaso derivanti dalla
decisione di adottare politiche di bilancio restrittive in tutti i paesi simultaneamente, compresi quelli
virtuosi, contribuiscono in modo decisivo ad approfondire la caduta dei redditi e dell’occupazione, più che
proporzionalmente proprio nei paesi più compromessi (Grecia, Portogallo, Spagna). In Italia, ad esempio,
l’impatto diretto sul PIL della restrizione fiscale interna, cumulato su tre anni, sarebbe pari a poco più del 3
per cento; sommando gli effetti di travaso si supera il 5 per cento (cfr. Fig. 2). Va osservato che lo studio
conferma gli altri ben noti aspetti negativi delle politiche di contenimento fiscale attuate durante un periodo
recessivo. La calo del reddito riduce le entrate fiscali e aumenta il costo dei sussidi di disoccupazione; ne
consegue che le riduzioni ex post dei deficit di bilancio sono molto inferiori del previsto. Anche il rapporto
debito/PIL aumenta per qualche anno, confermando che le politiche di austerità, nel breve termine sono
controproducenti e autolesionistiche. Sono necessari almeno cinque anni prima che il rapporto dia segni di
miglioramento.
2
Figura 2. Linea blu: effetto sul PIL delle misure assunte in
Italia (stand alone). Linea rossa: contributo dell’effetto
“travaso”.
Rimarrebbe anche confermato che in una prospettiva di
quasi due lustri la terapia a base di olio di ricino possa
rimettere in piedi i malati (almeno quelli che non sono
nel frattempo passati a miglior vita). Inoltre se lo shock
fiscale è realizzato prevalentemente con tagli di spesa
piuttosto che con aumenti delle tasse, l’impatto
negativo
è
più profondo
nell’immediato
ma
la
successiva ripresa dei redditi e dell’occupazione più
brillante. Le conclusioni: una politica fiscale ottimale
nell’area
Euro
avrebbe
dovuto
comportare
un’espansione di bilancio nella Repubblica Federale
Tedesca, invece di una restrizione di oltre due punti e mezzo di PIL. I paesi periferici, a parità di sacrifici,
avrebbero subito penalizzazioni molto meno rilevanti e anticipato nel tempo i risultati positivi. Ma l’intera
Europa ne avrebbe tratto minore danno. In definitiva, la Germania avrebbe scelto deliberatamente di
adottare un atteggiamento punitivo nei confronti dei paesi devianti, ai limiti dell’autolesionismo.
MODELLO DA IMITARE
Anche gli avvocati della difesa non mancano di far sentire la loro voce. Qualcuno, esagerando, arriva perfino
a sostenere che la patria di Ghoete, lungi dall’essere il killer dell’Europa, ne sarebbe, viceversa il salvatore
(America’s misplaced lecture to Germany | The World Gideon Rachman) essendo il primo contributore ai
vari fondi di salvataggio europei per un importo pari al bilancio pubblico di un anno. iv La stessa solidità
della moneta unica sarebbe garantita dalla rigorosa difesa derivante dall’ortodossia monetaria imposta dalla
Bundesbank, ferocemente avversa a politiche di manipolazione dei mercati a partire da quello valutario, tanto
utilizzate negli ultimi anni dalle altre banche centrali. Non manca chi (United States Blames Germany? What
Nonsense. - The Globalist) rigetta l’accusa di mercantilismo rivolta ai tedeschi. Per gli economisti che fanno
riferimento al liberismo di matrice individualista l’idea che gli squilibri di tipo macroeconomico a livello
internazionale possano essere risolti utilizzando le politiche monetarie e fiscali trascurerebbe il ruolo centrale
dell’impresa e dell’imprenditore e i veri fattori alla base dello sviluppo economico. Il principio mercantilista
che il commercio è un gioco a somma zero è falso, lo scambio implica un reciproco vantaggio, in caso
contrario le transazioni non avrebbero luogo. Lo sviluppo dei commerci internazionali aumenta la ricchezza
di tutti. L’esempio degli Stati Uniti, paese dominante avendo trascorso 350 degli ultimi 400 anni con un
deficit della bilancia commerciale, in proposito sarebbe illuminante. Ne consegue che l’inattaccabilità del
surplus teutonico è determinata in primo luogo dalla competitività e dalla flessibilità del sistema produttivo,
validato dal rapporto qualità-prezzo vincente del “made in Germany”. Uno dei fattori, spesso citati, ma poco
apprezzati, all’origine della competitività dell’industria tedesca e del basso livello di disoccupazione, è la
riforma del mercato del lavoro realizzata in Germania nei primi anni 2000.
LA RIFORMA DEL LAVORO
Lavorare meno, a salari inferiori, però, ma lavorare tutti. Ecco, in due parole, il succo della storica riforma
Hartz del mercato del lavoro, realizzata dal Governo socialdemocratico di Gerhard Schroeder tra il 2003 e il
2005. Obiettivi: disincentivare la disoccupazione cronica, alimentata da ricchi sussidi pubblici, incoraggiare
3
il lavoro part time e temporaneo, agevolare le imprese in difficoltà permettendo una maggiore flessibilità nei
rapporti di lavorov. Già in precedenza, dalla fine degli anni ’90, le imprese tedesche potevano utilizzare il
“working time account”, strumento che permette al lavoratore di accumulare sul suo “conto” ore di lavoro
extra non retribuite nelle fasi di alta domanda produttiva, da consumare in seguito, senza riduzioni
retributive, nelle successive fasi negative del ciclovi. In Germania, politica e parti sociali, a fronte delle sfide
poste prima dalla riunificazione e poi dalla globalizzazione, consapevoli del rischio sociale derivante dalla
delocalizzazione produttiva nei paesi dell’est, realizzano un grande compromesso tra lavoro e impresa.
Perdente per i lavoratori, se valutato con le metriche miopi di certo sindacalismo affascinante ad altre
latitudini: maggiore flessibilità del lavoro, decentralizzazione delle negoziazioni salariali, riduzione del
potere di contrattazione, aumento del lavoro precario e part time, sostanziale stagnazione, se non riduzione
dei salari reali. Ma con effetti virtuosi di lungo termine, verificabili soprattutto nei periodi di “vacche
magre”. Il notevole investimento governativo che ha finanziato la riforma Hartz è stato ripagato nel tempo
dal crollo del tasso di disoccupazione; inoltre la riduzione della spesa per i sussidi ha finanziato una
riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie. Nel frattempo la struttura industriale del paese si è rafforzata
ampliando la base produttiva e i livelli di occupazione in patria e all’estero, portando a compimento quel
processo di aumento della dimensione aziendale che è uno dei principali catalizzatori di ricerca e
innovazione.
L’IDEOLOGIA TEDESCA
Non è un caso che la lettura delle cause della crisi e le soluzioni proposte dalla Germania siano molto diverse
da quelle invocate dai mercati finanziari e dalla stampa internazionale. Derivano da principi considerati
sacrosanti in patria, che affondano le radici nella storia del paese e ne condizionano la psicologia collettiva.
Alle spalle dell’ortodossia economica tedesca c’è la tradizione intellettuale dell’ordoliberalismo, dal titolo della
rivista "Ordo", fondata dal professor Walter Eucken nel 1940, attorno al quale si coagula il gruppo di studiosi
che dà vita alla “ Scuola di Friburgo”. Tale dottrina, meglio conosciuta come teoria dell’economia sociale di
mercato, si sviluppa come reazione al liberismo privo di regole dei primi anni del 900 e al successivo
interventismo monetario e fiscale dell’epoca nazista. Il mercato è un sistema di relazioni il cui ottimale
funzionamento non dipende dall’opera della “mano invisibile”, come nel liberalismo del laisser-faire, ma
piuttosto dalla conformità a una "costituzione economica" attuata dallo stato; la concorrenza diventa un
"bene pubblico" da proteggere contro lo sviluppo di posizioni dominanti. Il paradigma liberale assume
quindi una dimensione istituzionale negata o assente in gran parte della letteratura di matrice libertaria. La
qualità dei processi di mercato dipende dalla natura del quadro giuridico e istituzionale all'interno del quale
essi si situano, dalle regole adottate, dalle scelte effettuate. Lo stato regola ma non modifica, nel solco della
tradizione liberale, i risultati che provengono dai processi di mercato. Questa visione implica che ciclo
economico non debba essere manipolato e gli squilibri tra domanda e offerta siano assorbiti con la flessibilità
di prezzi e salari. Se questi ultimi sono, come spesso accade, caratterizzati da rigidità verso il basso,
diventano necessarie le tanto evocate “riforme”, finalizzate a migliorare flessibilità ed efficienza dei mercati.
La via tedesca al liberalismo si basa quindi sulla definizione delle relazioni stato-mercato, sulla non
interferenza del settore pubblico una volta che le regole siano definite e sull’assoluta indipendenza della
banca centrale che ha come unico obiettivo la stabilità dei prezzi. Questa sovrastruttura ideologica comporta
una lettura lineare ma rigida della crisi europea e delle possibili soluzioni. Sul fronte del coordinamento
della politica economica, come abbiamo visto, s’ignorano gli effetti che il miglioramento dell’assetto
competitivo di un paese esercita sui fattori che determinano la domanda degli altri. Per i tedeschi non c’è
4
necessità di coordinamento se tutti realizzano politiche ortodosse. Solo il tema delle finanze pubbliche
merita una stretta sorveglianza sovranazionale ma solo perché una cattiva gestione può portare a una crisi
del debito, alla richiesta di salvataggi e, in definitiva alla tanto temuta fragilità finanziaria. Sul fronte degli
squilibri commerciali, esplosi all’interno dell’Eurozona dal 1999, la ricetta è altrettanto semplice: sono da
evitare deficit eccessivi, ma non i surplus. I primi favoriscono l’accumulazione di pericoloso debito estero; i
secondi sono il meritato frutto di una sana competitività, da migliorare, quando necessario, contenendo
l’espansione salariale. L’equilibrio del bilancio pubblico diventa un vincolo ideologico imprescindibile, la
garanzia almeno parziale dei limiti della funzione pubblica che regola, ma non interviene nell’economia di
mercato. Lo squilibrio dei conti va eliminato attraverso riduzioni di spesa o aumenti d’imposizione fiscale;
una dinamica del debito fuori controllo distrugge la crescita economica e aumenta i rischi di crisi finanziarie
e di soluzioni forzose o inflazionistiche. D’altra parte meno nuovo debito e meno spesa oggi, significano
minori tasse domani, un aumento della fiducia e dell’investimento privato. Dure misure di austerità fiscale
non portano necessariamente a pesanti recessioni, piuttosto migliorano le prospettive di crescita (è la teoria
dell’“expansionary fiscal consolidation”). I ritardi nel raggiungimento del consolidamento fiscale sono visti
come un fallimento della classe politica. I tedeschi vedono le difficoltà dei periferici come un esempio di
mancanza di volontà. La crisi del debito in periferia è il risultato di overspending di governi irresponsabili che
hanno utilizzato i bassi tassi d’interesse associati all’Euro. Da qui l’avversione per i salvataggi che
alimentano l’azzardo morale e per gli eurobonds, strumenti d’iniqua socializzazione del debito.
VERITA’ SVELATE
E allora chi ha ragione? Da una parte i neokeynesiani paragonano la crisi attuale alla grande depressione
degli anni trenta e temono il ripetersi degli stessi errori di allora. Invocano quindi l’utilizzo del bilancio
pubblico per aumentare la domanda e ridurre la disoccupazione. Dall’altra i neoliberisti chiedono a gran
voce la liberalizzazione dei mercati, il ridimensionamento dell’intervento statale nell’economia, la riduzione
di spesa pubblica e tasse. In definitiva quelle che sono note come riforme dell’offerta. Nelle questioni
economico-sociali, come nella vita, bisogna diffidare delle verità assolute. La realtà è opaca e spesso
indecifrabile; le soluzioni condizionali e complesse. Non si tratta di esperimenti in vitro ma di un continuo
processo di trial and error. Le politiche ideali e ricette miracolose, da utilizzare in tutte le epoche e a tutte le
latitudini, purtroppo non sono a portata di mano. Sbagliano i tedeschi nel credere che le cause della crisi
europea siano ascrivibili esclusivamente al comportamento irresponsabile dei paesi periferici, peraltro non
omologabile univocamente. D’altra parte chi ha finanziato le esportazioni germaniche verso i paesi con
eccesso di domanda nel primo decennio di moneta unica? Le banche di Francoforte e Berlino. Sbagliano i
neokeynesiani a non capire che solo gli Stati Uniti si possono permettere di usare con estrema disinvoltura la
leva monetaria e che, in presenza di bilanci statali che cubano quasi il 50% del PIL, l’utilizzo della spesa
pubblica per sostenere la domanda è la via più diretta verso la deindustrializzazione o la perdita della
sovranità. Fuor di dubbio la Germania porta sulle spalle la responsabilità di avere frenato, con un
atteggiamento dogmatico e di estrema rigidità, la soluzione della crisi europea, portando l’Europa sull’orlo
del baratro e rendendo inutilmente più gravoso il processo di stabilizzazione. I tedeschi hanno ragione, però,
a indicarsi come modello di riferimento per i partners comunitari. Il paese economicamente più forte
dell’Unione Monetaria ha “fatto i compiti a casa”, in tempi non sospetti, prima del diluvio. Probabilmente il
modello dell’economia sociale di mercato non è replicabile a latitudini inferiori. Rimane però il paradigma al
quale avvicinarsi, soprattutto per l’Italia, che ha raccolto il testimone del “paese più malato d’Europa”copyright sempre dell’Economist – già nel lontano 2005. La penisola ha un bisogno disperato di una nuova
5
"costituzione economica", di un quadro giuridico e istituzionale che difenda i processi di mercato, da
realizzare ancor prima di mettere mano a una seria riforma del mercato del lavoro. Riforma che non può e
non deve essere limitata alla politica. Deve riguardare tutti i gangli vitali del paese, a partire dalla pubblica
amministrazione, l’unico incontrollato e perpetuo potere che si alimenta del declino di tutti gli altri. Non si
tratta di riforma ma di rivoluzione e i tempi sono maturi.
i Il surplus delle partite correnti tedesco (la somma del saldo commerciale e dei redditi da capitale) ha superato il 6%
del PIL in sei degli ultimi sette anni. Nel 2012 ha toccato il 6,3%. Nel periodo della grande crisi si è ridotto dal 5 al 2%
del PIL nei confronti dei paesi comunitari ma è aumentato in pari misura verso il resto del mondo. Sempre nel 2012 il
solo avanzo commerciale è stato pari a 188 miliardi di Euro, per dimensioni il secondo maggiore dal 1950; circa il 70%
dell’interscambio (import-export) è con i paesi europei. Va notato che le regole di monitoraggio fiscale europeo
includono, tra gli sbilanci meritevoli di correzione, gli avanzi di parte corrente della bilancia dei pagamenti, quando
eccedano il 6% del PIL per tre anni consecutivi.
ii
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp506_en.pdf
Studio
per
la
Commissione Europea di Jan In ‘t Veld “Economic consolidations and spillovers in the Euro area periphery and core”,
Economic Paper 506, October 2013.
iii Il primo misura quanto il consolidamento fiscale realizzato da un paese riduce la domanda interna dei partners
commerciali; il secondo misura quanto l’impatto deflazionistico di un calo di prezzi e salari in un paese (miglioramento
della competitività) peggiora le condizioni competitive degli altri, alimentando un circolo vizioso.
iv Tesi spericolata ai limiti della provocazione. Si dimentica che l’Italia è il terzo contributore ai fondi di salvataggio,
con una quota proporzionale alla sua dimensione economica ma subisce un onere relativo sproporzionato. Non solo non
ha beneficiato di aiuti, ma si indebita al 4% per finanziare la sua quota nel fondo che investe in obbligazioni risk free,
prevalentemente tedesche, con rendimenti inferiori almeno di due punti.
v La riforma riduce il costo del lavoro eliminando i contributi sociali per le retribuzioni fino a 400 euro al mese (i
cosiddetti mini-jobs) e riducendolo per quelli fino a 800 euro (i midi-jobs). Limita il ricorso ai sussidi di disoccupazione
e riduce la durata degli stessi scoraggiando la disoccupazione di lunga durata; privatizza la gestione delle agenzie di
collocamento e di ricerca di lavoro temporaneo. La responsabilità per la ricerca della nuova occupazione è spostata sul
disoccupato e sono introdotte sanzioni per chi rifiuta offerte di lavoro. Infine si prevede la possibilità per le aziende in
difficoltà di ottenere riduzioni degli orari di lavoro e degli stipendi in alternativa ai licenziamenti. Parte dello stipendio
perso, il 60-67%, è recuperato dal lavoratore grazie a sussidi pubblici.
vi La percentuale di lavoratori che hanno utilizzato questo strumento è aumentata dal 33% nel 1998 al 48% nel 2005,
permettendo un’efficace riduzione delle ore lavorate per addetto nella recessione del 2008-2009, senza un parallelo
aumento della disoccupazione, come viceversa è accaduto altrove.
6