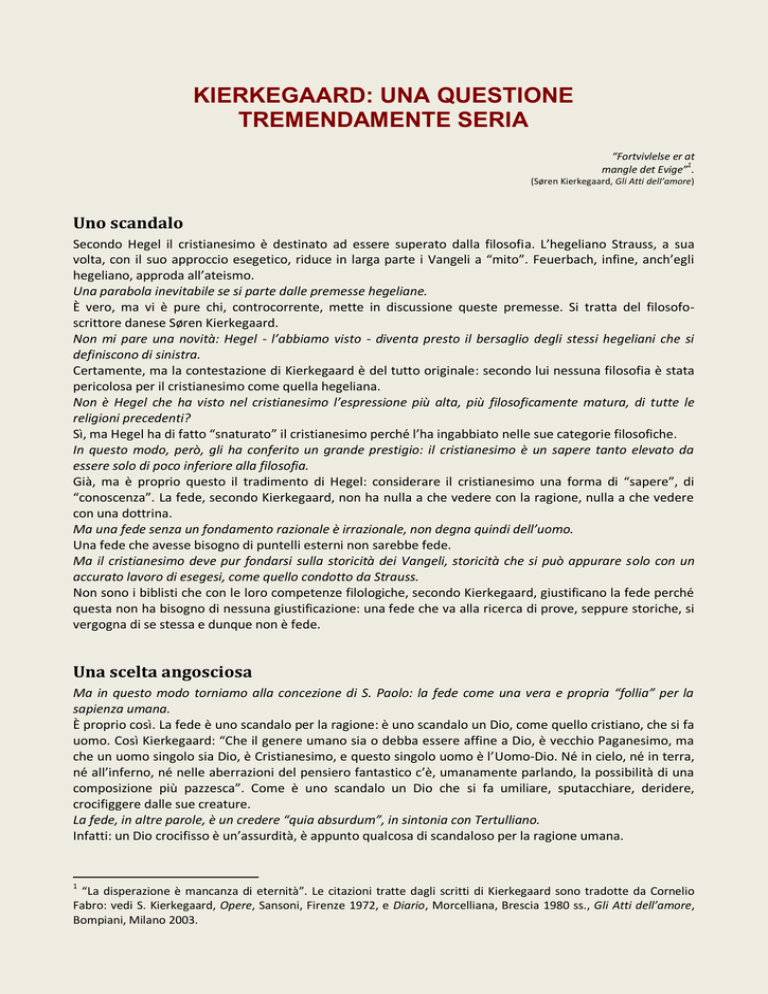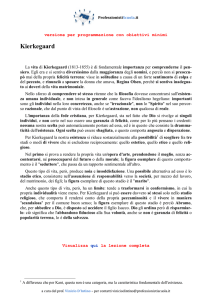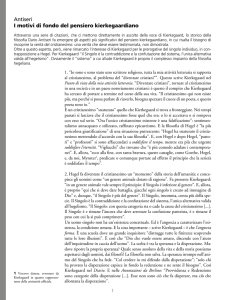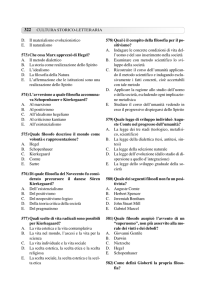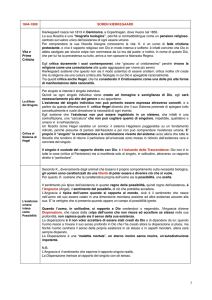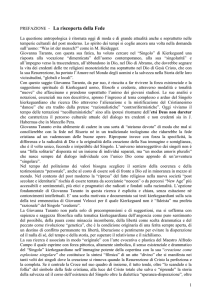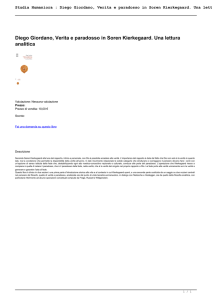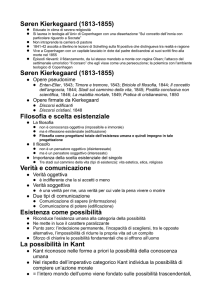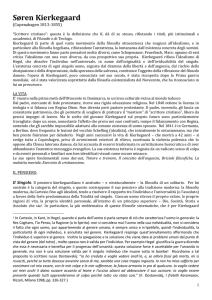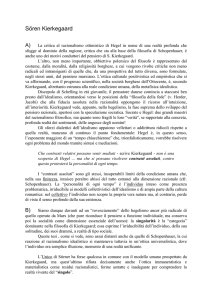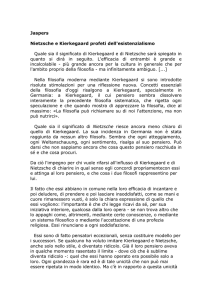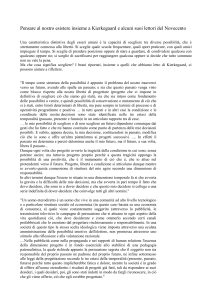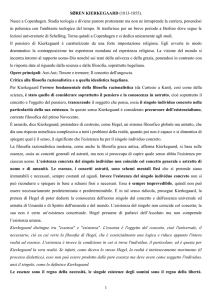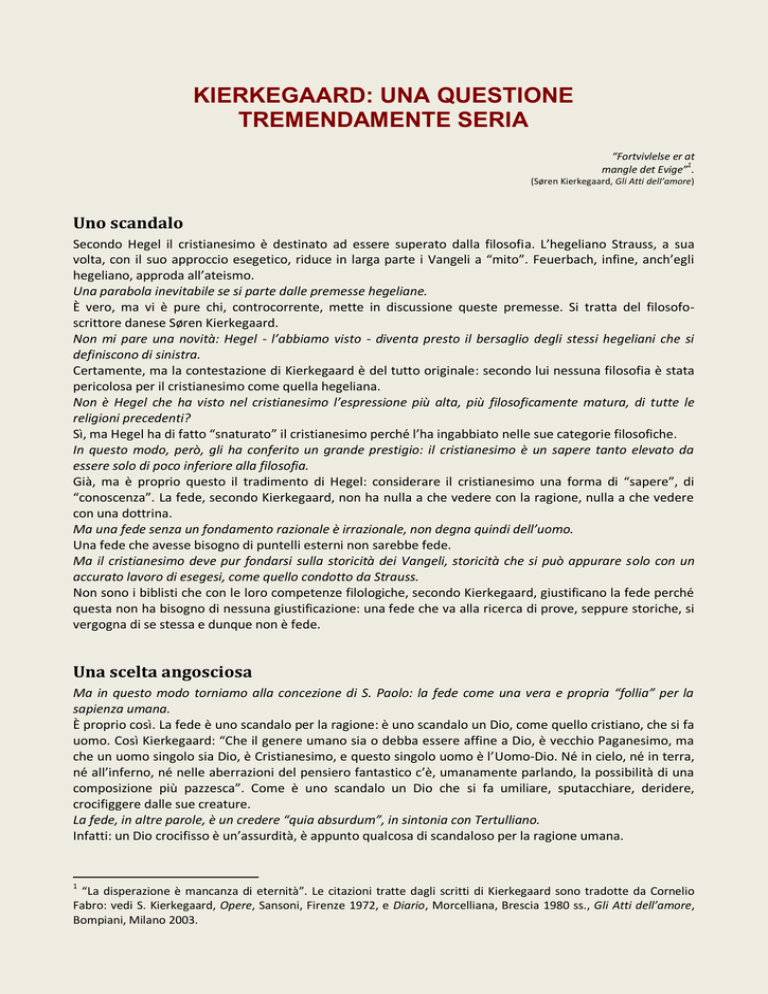
KIERKEGAARD: UNA QUESTIONE
TREMENDAMENTE SERIA
“Fortvivlelse er at
mangle det Evige”1.
(Søren Kierkegaard, Gli Atti dell’amore)
Uno scandalo
Secondo Hegel il cristianesimo è destinato ad essere superato dalla filosofia. L’hegeliano Strauss, a sua
volta, con il suo approccio esegetico, riduce in larga parte i Vangeli a “mito”. Feuerbach, infine, anch’egli
hegeliano, approda all’ateismo.
Una parabola inevitabile se si parte dalle premesse hegeliane.
È vero, ma vi è pure chi, controcorrente, mette in discussione queste premesse. Si tratta del filosofoscrittore danese Søren Kierkegaard.
Non mi pare una novità: Hegel - l’abbiamo visto - diventa presto il bersaglio degli stessi hegeliani che si
definiscono di sinistra.
Certamente, ma la contestazione di Kierkegaard è del tutto originale: secondo lui nessuna filosofia è stata
pericolosa per il cristianesimo come quella hegeliana.
Non è Hegel che ha visto nel cristianesimo l’espressione più alta, più filosoficamente matura, di tutte le
religioni precedenti?
Sì, ma Hegel ha di fatto “snaturato” il cristianesimo perché l’ha ingabbiato nelle sue categorie filosofiche.
In questo modo, però, gli ha conferito un grande prestigio: il cristianesimo è un sapere tanto elevato da
essere solo di poco inferiore alla filosofia.
Già, ma è proprio questo il tradimento di Hegel: considerare il cristianesimo una forma di “sapere”, di
“conoscenza”. La fede, secondo Kierkegaard, non ha nulla a che vedere con la ragione, nulla a che vedere
con una dottrina.
Ma una fede senza un fondamento razionale è irrazionale, non degna quindi dell’uomo.
Una fede che avesse bisogno di puntelli esterni non sarebbe fede.
Ma il cristianesimo deve pur fondarsi sulla storicità dei Vangeli, storicità che si può appurare solo con un
accurato lavoro di esegesi, come quello condotto da Strauss.
Non sono i biblisti che con le loro competenze filologiche, secondo Kierkegaard, giustificano la fede perché
questa non ha bisogno di nessuna giustificazione: una fede che va alla ricerca di prove, seppure storiche, si
vergogna di se stessa e dunque non è fede.
Una scelta angosciosa
Ma in questo modo torniamo alla concezione di S. Paolo: la fede come una vera e propria “follia” per la
sapienza umana.
È proprio così. La fede è uno scandalo per la ragione: è uno scandalo un Dio, come quello cristiano, che si fa
uomo. Così Kierkegaard: “Che il genere umano sia o debba essere affine a Dio, è vecchio Paganesimo, ma
che un uomo singolo sia Dio, è Cristianesimo, e questo singolo uomo è l’Uomo-Dio. Né in cielo, né in terra,
né all’inferno, né nelle aberrazioni del pensiero fantastico c’è, umanamente parlando, la possibilità di una
composizione più pazzesca”. Come è uno scandalo un Dio che si fa umiliare, sputacchiare, deridere,
crocifiggere dalle sue creature.
La fede, in altre parole, è un credere “quia absurdum”, in sintonia con Tertulliano.
Infatti: un Dio crocifisso è un’assurdità, è appunto qualcosa di scandaloso per la ragione umana.
1
“La disperazione è mancanza di eternità”. Le citazioni tratte dagli scritti di Kierkegaard sono tradotte da Cornelio
Fabro: vedi S. Kierkegaard, Opere, Sansoni, Firenze 1972, e Diario, Morcelliana, Brescia 1980 ss., Gli Atti dell’amore,
Bompiani, Milano 2003.
Ma così Kierkegaard spazza via l’intera filosofia cristiana, in primis la stessa filosofia tomistica che è stata
per secoli un punto di riferimento solido per la Chiesa cattolica e la stessa concezione ufficiale di oggi sul
rapporto tra ragione e fede (vedi l’enciclica di Giovanni Paolo II, Fides et ratio).
Sicuramente: una filosofia cristiana è una contraddizione nei termini perché il cristianesimo, in quanto tale,
non ha bisogno di dimostrazioni filosofiche. Una fede che ha bisogno di dimostrazioni è già morta. Così
scrive Kierkegaard: “Il cristiano che vuole per suo conto dare una dimostrazione, ha cominciato a dar partita
vinta all’incredulo col volere anch’egli dimostrare”.
Ma S. Tommaso non ha preteso di dare un fondamento filosofico ai misteri del cristianesimo, ma ha solo
cercato di spianare la strada alla fede.
È vero, ma Dio è inaccessibile all’uomo.
Siamo sulla lunghezza d’onda di Pascal.
Infatti: tra l’uomo e Dio l’abisso è infinito. Secondo Kierkegaard, però, la fede non è solo un salto nel buio,
ma è anche un atto angosciante. Su questo concorda con Lutero: senza angoscia non c’è fede (“elimina la
coscienza angosciosa, e tu puoi chiudere le chiese e farne delle sale da ballo”).
Ma non è la fede che, al contrario, dona la speranza e di conseguenza il conforto?
La fede non è una pillola tranquillante, non è un porto sicuro, non è la roccia a cui aggrapparci: “Il
Cristianesimo è inquietudine, l’inquietudine dell’eternità: qui ogni paragone zoppica, a tal punto
l’inquietudine dell’eternità è inquietante”.
Ma allora è proprio Kierkegaard che snatura il senso della fede.
Egli sa bene di combattere contro una concezione della fede che ha alle spalle una tradizione consolidata,
ma sa altrettanto bene che sono le stesse Chiese cristiane, la stessa Chiesa protestante danese del suo
tempo, ad avere sovvertito l’autentico senso della fede quale emerge dalle Sacre Scritture: la cristianità è
“un immenso treno, da cui la locomotiva” si è “staccata da molto tempo”. Pensa alla figura di Abramo: è lui
che ha vissuto fino in fondo il dramma angosciante della fede.
Una fede, la sua? Un padre che leva il coltello contro il figlio è il peggiore degli assassini.
Se guardiamo Abramo con le nostre categorie umane, sì, ma la fede trascende il nostro punto di vista,
trascende la stessa morale a cui sono soggetti tutti gli uomini.
Una “terribile solitudine”
Ma questa è un’interpretazione aberrante che può giustificare qualsiasi delitto in nome di Dio: è solo
fanatismo, non fede!
Tu continui a leggere la fede con le nostre categorie di mortali. Essa non ha nulla di comprensibile e “il
massimo a cui si può arrivare è poter comprendere che non si può comprendere. Così anche per un
Assoluto non si possono dar ragioni, al massimo si possono dar ragioni che non ci sono ragioni”. Del resto,
se non fosse così, sarebbe “semplice saggezza di vivere, non Fede”.
La fede di Abramo è davvero emblematica. Dio gli ha promesso di diventare il capostipite di una
generazione infinita.
Ciò che contrasta con la sterilità della moglie Sara.
Infatti. E ciò nonostante Abramo crede. Crede nell’impossibile: per ben “settant’anni” rimane in “fedele
attesa”. Così scrive il nostro: “Egli non ha numerato con tristezza i giorni mentre il tempo passava, non ha
guardato Sara con sguardo sospettoso per vedere se invecchiava, non ha fermato il cammino del sole […]
perché Sara non invecchiasse e con essa non invecchiasse anche la sua attesa […]. Abramo diventò vecchio
e Sara la burla del paese!”.
Continua a credere nonostante non vi sia nessuna ragione umana per credere.
Certamente.
Il miracolo poi accade.
Ma ecco qualcosa di ancora più inquietante: Dio gli ordina di sacrificare il figlio Isacco, il figlio a lungo
atteso, il figlio della promessa.
Un ordine sconvolgente.
Un ordine che non solo viola lo stesso comandamento di Dio di non uccidere, ma profondamente
disumano: come è possibile che Dio comandi a un padre di uccidere l’unico suo figlio, il figlio tanto amato?
Anche Agamennone si è trovato di fronte a una situazione analoga, la scelta cioè di sacrificare la figlia
Ifigenia.
È vero, ma l’eroe tragico greco non è solo (sacrifica, sì, l’amore per la figlia ma per salvare il suo popolo da
cui è confortato), mentre Abramo è solo: solo davanti a Dio, solo di fronte al comando assurdo e antiumano di Dio. È lo stesso Kierkegaard che parla di “terribile solitudine”.
Ma il nostro non tiene minimamente conto della dimensione comunitaria della fede, una dimensione che
caratterizza tutta la tradizione cattolica a partire dalle prime comunità cristiane e che è stata confermata
dall’enciclica scritta a due mani da papa Benedetto XVI e da papa Francesco “Lumen fidei”.
Kierkegaard, che vive in un paese di confessione protestante, vede nella fede un rapporto personale di un
singolo uomo con Dio: è in questo rapporto che l’individuo si trova di fronte alla “possibilità” di dire sì o no
a Dio.
La fede come scelta.
È così: non si nasce cristiani, lo si diventa scegliendo, assumendo per intero la responsabilità della
decisione.
Nessuna garanzia
Scegliendo nell’angoscia.
Sì: quella di Abramo è un’angoscia lacerante. Così scrive Kierkegaard: “Tutto ora stava per essere perduto! Il
ricordo magnifico della posterità, la promessa nel seme di Abramo, tutto questo non era stato che un
capriccio, un pensiero fuggevole che Iddio aveva avuto e che ora Abramo doveva cancellare […] questo
frutto doveva ora essere strappato prima del tempo e diventare insignificante: poiché quale significato
avrebbe avuto se Isacco doveva essere sacrificato!”.
Una fede unica.
Ecco la grandezza di Abramo. Così ancora Kierkegaard: “A lui era riservata una più dura prova e il destino di
Isacco era il coltello in mano ad Abramo. Ed egli rimase lì, il vegliardo con la sua unica speranza! Ma non
dubitò, non si mise a sbirciare a destra e a sinistra con angoscia, non importunò il cielo con le sue
preghiere. Sapeva ch’era Dio, l’Onnipotente, che lo metteva alla prova […] Chi dette forza al braccio di
Abramo, chi tenne sollevata la sua destra perché non cadesse impotente? A contemplare una scena simile,
si resta paralizzati! Chi fortificò l’anima di Abramo, perché i suoi occhi non si abbassassero e non vedessero
Isacco e l’ariete? Al vedere una cosa simile, si diventa ciechi”.
Una decisione terribile, anche perché Abramo non ha alcuna garanzia, neppure la garanzia che quello che
ha ricevuto è un ordine di Dio.
Già: tutto è possibile, anche che la “voce” che sente non sia altro che una sua allucinazione.
Un atto quindi, la fede, ancora più assurdo.
Infatti.
Ma i primi seguaci di Cristo, quelli a lui contemporanei, avevano di sicuro qualche garanzia in più: l’avevano
visto, sentito.
No: un conto è “vedere” l’uomo-Cristo e un conto “credere” che tale uomo sia il Figlio di Dio. La fede è
sempre un salto nel buio, sia per i contemporanei di Gesù sia per coloro che vivono dopo. Neppure la
durata del cristianesimo costituisce una prova a favore del cristianesimo stesso. Così scrive Kierkegaard:
“diciotto secoli non hanno maggior forza dimostrativa di un giorno rispetto alla verità eterna”.
Ma credere nel figlio di Dio non è angoscioso come credere nel Dio di Abramo.
Un Dio crocifisso appare alla ragione umana come una follia: non vi è alcuna… ragione al mondo che possa
sostenere tale fede.
Ma noi tutti questo l’abbiamo ereditato dalla tradizione: siamo stati battezzati, cresimati… Il cristianesimo,
cioè, l’abbiamo respirato nella nostra infanzia, l’abbiamo interiorizzato, è diventato parte di noi stessi.
Kierkegaard lo ribadisce più volte: il cristianesimo è una scelta, non un’eredità, e la scelta, come nel caso di
Abramo, ha sempre qualcosa di inquietante: proprio perché non abbiamo alcuna garanzia né alcuna prova,
siamo nel regno della pura possibilità dove tutto è ugualmente possibile, dove “la perdizione,
l’annientamento, abita con ogni uomo porta a porta”.
Possibile che la cosiddetta Parola di Dio contenuta nei testi sacri non sia la Parola di Dio.
Infatti.
Capisco meglio ora la portata della scommessa di Pascal: proprio perché non vi sono ragioni pro e contro,
non ci resta che la scommessa.
Ma Kierkegaard, in questo, non è per nulla in sintonia con Pascal: la scommessa ha un che di utilitaristico,
mentre la fede, secondo Kierkegaard, no. I contesti, poi, sono molto diversi: un conto è suggerire a un
libertino una ragione per credere in Dio e un conto è accettare lo scandalo del cristianesimo. In Pascal,
infine, l’approdo a Dio non ha nulla di angoscioso, ciò che invece caratterizza la fede, secondo Kierkegaard.
Scoppi di risa degli dèi
Ed è ciò che caratterizza anche la figura di Giobbe.
L’uomo dei dolori che si ribella a Dio.
Sì, l’uomo che si trova sulle spalle un insopportabile carico di sofferenze. La sua è una vera e propria lotta
con Dio. E anche in questo caso siamo in presenza di un rapporto personale. Giobbe è solo. Ci sono, sì, dei
suoi amici che lo invitano a vedere nel suo immenso dolore il castigo divino per i peccati commessi, ma lui
non ci crede: non ci crede perché gli sembra assurdo concepire Dio come un tiranno e non ci crede, in
primo luogo, perché è convinto di essere innocente.
Siamo in presenza di un’altra figura che chiarisce bene l’inquietudine tipica dell’uomo di fede.
Siamo agli antipodi della fede come è vissuta da molti cattolici.
Ma anche, secondo Kierkegaard, dalla fede vissuta e predicata dalla stessa Chiesa protestante danese. Il
nostro è fortemente critico nei confronti dei pastori di cultura hegeliana - vere e proprie “canaglie” - che
sono impegnati più a “soddisfare il tempo” piuttosto che a soddisfare l’eternità: un cristianesimo borghese,
accomodante, che privilegia i potenti, che consacra l’Ordine stabilito, che ha perso tutta la radicalità
presente nei testi biblici, un cristianesimo che, sulla scia di Hegel, divinizza lo status quo, un cristianesimo
appiattito, annacquato.
Un cristianesimo, però, che tiene conto dell’uomo comune: la fede di Abramo è inaccessibile ai più.
Ma l’essere cristiani è una questione serissima, tremendamente seria: “Il Cristianesimo è una serietà
tremenda: è in questa vita che si decide la tua eternità”.
Una questione che riguarda sempre il singolo uomo.
Sì: ecco perché la filosofia hegeliana è la più pericolosa per la fede.
Perché ha demolito di fatto l’individuo.
Infatti: ha demolito il singolo in nome di una concezione dell’uomo come genere umano, ma il singolo vale
immensamente di più della specie.
È lo stesso Hegel, però, che sottolinea la preziosa eredità del cristianesimo, vale a dire il valore infinito di
ogni individuo.
È vero, ma poi questo individuo, nel sistema hegeliano, viene fagocitato dal Tutto: diventa un momento
dello Stato, un momento della storia dello Spirito. È per questo che, secondo Kierkegaard, è “qui che si
deve dare battaglia”.
Un anti-Hegel, il nostro, come Schopenhauer, Marx…
Sì, ma da una prospettiva diversa: Kierkegaard combatte la filosofia hegeliana per salvare il “singolo” senza
il quale il cristianesimo stesso non potrebbe reggere. Il nostro usa nei confronti di Hegel parole non meno
pesanti di quelle di Schopenhauer: parla del suo sistema come di un “brillante spirito di putridità”, della
“più ripugnante di tutte le forme di libertinaggio”, di “marcia pomposità”, di “abominevole pompa
corruttrice”. Arriva addirittura a considerare Hegel una figura comica: è letteralmente ridicolo pretendere
di vedere le cose con gli occhi di Dio, di parlare in nome dell’Assoluto. E non risparmia al filosofo tedesco un
tocco di ironia: “Ma Hegel! Qui ho bisogno del linguaggio di Omero. A quali scoppi di risa devono essersi
abbandonati gli dei. Un così sgraziato professorino che pretende semplicemente di avere scoperto la
necessità di ogni cosa […] ed ora eccolo intento a suonare tutta la sua musica nel suo organetto: ascoltate,
dunque, o dei dell’Olimpo!”.
“Quel Singolo”
Un’ironia, a mio avviso, tutt’altro che gratuita, anzi ben fondata: è un atto di hýbris ergersi al punto di vista
dell’Intero.
Certamente. Nonostante sia abissalmente distante da Feuerbach, Kierkegaard prova simpatia per lui: quello
del filosofo “materialista”, infatti, è un attacco più che al cristianesimo agli stessi cristiani che, invece di
essere tali, si divertono a giocare al cristianesimo. Un attacco, quindi, seppur brutale, di sicuro salutare. Egli
è convinto che l’ateismo moderno nasca proprio all’interno del cristianesimo, o meglio all’interno delle
organizzazioni ecclesiastiche che hanno tradito il cristianesimo stesso. È dell’avviso, inoltre, che l’ateismo
che ora è solo elitario, diventerà col tempo di massa.
Preveggente.
Si tratta di un fenomeno che si diffonde col processo di massificazione dell’uomo moderno. Laddove c’è la
massa, lì il singolo si spegne. Da qui il pericolo, in politica, di un Leviatano capace di ingoiare tutti. E la
massa è un nemico mortale dello stesso cristianesimo: le Chiese hanno costruito un cristianesimo di massa
in cui ciò che conta è il livellamento dei singoli, la loro uniformità. Ma così il cristianesimo, massificando il
cristiano, è morto.
Un giudizio unilaterale, quello di Kierkegaard.
Un giudizio coerente con la sua visione del cristianesimo. Egli non ha dubbi: «“Il Singolo”: con questa
categoria sta o cade la causa del cristianesimo […] Il Singolo è e rimane l’àncora che deve arrestare la
confusione panteista».
L’individuo.
Kierkegaard ritiene che il termine “individuo” abbia a che vedere col numero, con il criterio cioè della
quantità: ecco perché sceglie di usare la parola “singolo”. Parola che diventa il concetto centrale della sua
filosofia, tanto centrale che egli giunge ad affermare: «questa categoria è così legata al mio nome, ch’io
vorrei che sulla mia tomba si scrivesse “Quel Singolo”».
“Hai sputato su di Lui”
È a favore del singolo che egli tuona contro la folla da lui definita “il male del mondo”. Così, tra l’altro,
scrive, rievocando l’episodio della folla che sputava su Gesù: “Ma pensa di essere tu contemporaneo di
questo fatto. Osi tu credere che avresti avuto il coraggio di prendere apertamente la difesa di Cristo, di
prendere partito per un uomo che ogni sguardo scherniva, che tutti tradivano, su cui la Folla sputava?
Eppure tu eri presente! Tu forse ti sentivi mosso a pietà al vedere il maltrattamento di questo uomo:
eppure tu stavi fra la Folla! Lungi da te la volontà di prender parte a quell’empietà. Ma ecco che i
circostanti s’accorsero che tu non gridavi con gli altri. Furiosi, nella loro passione bestiale, alcuni di quelli
che stavano più vicino ti afferrarono – era in gioco la tua vita più che se tu fossi stato attaccato da una belva
– e tu non avesti il coraggio e la risolutezza di arrischiare subito la tua vita, specie per un Uomo così
disprezzato ed aborrito da tutti. Tu hai ceduto, tu pure hai gridato scherno e hai sputato su di Lui!”.
Mi trovo di fronte a uno scrittore non meno efficace di Schopenhauer.
Effettivamente Kierkegaard è uno scrittore e tale si professa: “Io sono e sono stato uno scrittore religioso”.
Uno scrittore che nell’arco di un decennio scrive ben 33 libri, firmandoli per lo più con degli pseudonimi.
Non se la sente di esporsi in prima persona?
La sua è una scelta letteraria che mira a rappresentare personaggi che, oltre a fare riferimento a sue
vicende personali, incarnano possibili modelli di esistenza.
Sono tutti libri di carattere religioso?
Non tutti direttamente perché in alcune opere il cristianesimo rimane sullo sfondo. Qua e là, poi, egli
allarga il suo orizzonte. Anche a proposito della folla: secondo lui è questa l’unico tiranno. L’ha “imparato
da Socrate”, l’“antico saggio”.
Socrate – lo sappiamo – era un antidemocratico.
Lo era perché era convinto che a governare dovessero esserci dei competenti della politica, non degli
ignoranti. Kierkegaard, sulla stessa scia, dice: “In ogni campo, per ogni oggetto ecc. sono sempre le
minoranze, i pochi, i rarissimi, i Singoli, quelli che sanno: la Folla è ignorante”.
Ma in questo modo lui, cristiano convinto, dimostra di disprezzare l’uguaglianza degli uomini che è l’anima
della democrazia.
Kierkegaard ha un solo obiettivo: difendere il singolo, liberarlo dalla schiavitù della massa. Ecco perché
punta il dito contro gli stessi moti liberali e democratici che nel 1848 agitano diversi Paesi europei.
Un reazionario, allora.
Non è un nostalgico dell’assolutismo, ma ciò che lo preoccupa è la prevaricazione della massa sul singolo e
il criterio di maggioranza che conduce ad annientare l’individuo in nome di un principio puramente
quantitativo, numerico.
Ma uno Stato liberale e democratico non può che reggere su tale criterio: non vi sono alternative.
Kierkegaard non offre indicazioni alternative, ma ciò che vede verso la metà dell’Ottocento è ciò che
vediamo noi oggi nel XXI secolo: il primato dell’opinione pubblica sul singolo, il primato del numero sulla
qualità. Non a caso accusa ferocemente i giornalisti: “mai nessun despota orientale è stato servito così
servilmente e lusingato da simili rettili di cortigiani, come lo è la ‘Folla’ dai giornalisti”. E ancora: sono i
giornalisti che creano l’opinione pubblica e sono sempre loro che danno in pasto “magari a una nazione
intera” e con una “leggerezza orrenda” il “falso”; “un certo grado di disonestà è inseparabile anche dal
giornalista più onesto”.
Parole durissime.
Senza dubbio. Egli arriva a chiamare i giornalisti i “notturni”: “essi non portano via le immondezze di notte,
ciò ch’è cosa onesta e una buona azione; essi immettono le immondezze di giorno o, per essere ancora più
precisi, riversano sugli uomini ‘la notte’, le tenebre, la confusione”.
Il “testimone della verità”
Un attacco feroce, senza mezzi termini.
Un attacco comprensibile se pensiamo al fatto che Kierkegaard è stato letteralmente scottato dalla stampa.
Avviene quando, nell’ultima fase (1854-1855) della sua breve vita, diventa bersaglio di un giornale satirico
danese (“Il Corsaro”) che lo ferisce nel profondo. Da qui una battaglia culturale condotta con una verve
impareggiabile, ben superiore a quella di Voltaire, che divide praticamente in due il Paese.
Una battaglia religiosa.
Sì: una battaglia aperta contro il cristianesimo tradito dalla Chiesa danese. L’occasione è l’elogio funebre
del vescovo Mynster pronunciato dal suo successore Martensen: questi, commemorando l’alto prelato, lo
definisce “testimone della verità”. Kierkegaard reagisce scrivendo che non può essere chiamato così “chi ha
avuto la vita in godimento, al sicuro dalle sofferenze, dalla lotta dell’interiorità, dal timore e tremore, dagli
scrupoli, dalle angustie dell’anima e dalle pene dello spirito”, mentre il testimone della verità è “un uomo in
povertà, in umiltà e abbassamento è misconosciuto, odiato, aborrito, disprezzato, schernito”. Un intervento
impietoso che suscita un’accesa polemica il cui clou avviene quando il nostro sferra un attacco al “silenzio”
del vescovo Martensen che giudica “inescusabile, ridicolo, sciocco, e spregevole sotto molti aspetti”.
Una durezza che sconcerta.
Si tratta, secondo lui, di autorità religiose (in particolare il teologo Martensen) che hanno come background
la filosofia hegeliana, quella filosofia che coniuga, senza alcun pudore, cristianesimo e mondo.
Una battaglia culturale, la sua, che lo coinvolge così intensamente sul piano emotivo da condurlo al
collasso: persi i sensi in strada, lo trasportano in ospedale. Qui, a pochi giorni dalla morte, continua ad
esprimere giudizi sferzanti nei confronti del vescovo Mynster: al pastore luterano Emil Boesen confida che il
vescovo in questione è stato una “pianta velenosa” che ha prodotto, col “suo virus malefico”, un danno
“immenso”.
Neppure l’avvicinarsi della morte attenua i toni della sua polemica.
Kierkegaard non ha dubbi sulla sua lettura del cristianesimo. Ritiene, anzi, di morire “contento” perché è
certo di “aver assolto” al suo “compito”: “rendere i cristiani cristiani”. Un compito destinato a lasciare una
traccia: “Le parole di un defunto spesso sono ascoltate meglio di quelle di un vivo”.
Che presunzione!
Di sicuro è convinto di essere un unico, un’eccezione rispetto agli altri uomini: non è un caso che non abbia
fatto ciò che fanno tutti come amare, sposarsi, avere figli, fare carriera…
Un misantropo.
Durante gli anni universitari - che prolunga per un decennio - fa la vita di gaudente; grazie alla sua non
ordinaria personalità, poi, viene eletto presidente del “”Circolo degli studenti”. Sono gli anni in cui è
impegnato in una vivacissima attività giornalistica.
Un misterioso senso di colpa
Una vita, quindi, ricca di relazioni.
Sì, ma dietro lo scintillio esteriore, dietro gli anni vissuti da eterno studente, vi è qualcosa che lo rende
diverso.
Una malinconia di fondo come quella di Schopenhauer?
Sì, ma anche una sofferenza profonda, addirittura un’inquietudine. È proprio per sfuggire a tutto questo
che si getta nell’attività giornalistica prima e in quella di scrittore dopo. Per sfuggire di fatto alla
disperazione.
È la figura del padre che lo segna: un padre anziano (ha avuto Søren a 56 anni) che gli inculca un’educazione
tanto severa da negargli la gioia di vivere fin dall’infanzia. Di qui la malinconia, una malinconia acutizzata
dal cristianesimo cupo e angoscioso vissuto dal padre.
Tutto, allora, quadra: è qui la genesi del’interpretazione kierkegaardiana del cristianesimo.
Ma questo non è ancora nulla. Kierkegaard avverte nel padre un misterioso senso di colpa per un peccato
commesso, un peccato che egli a un certo punto scopre e ciò provoca in lui un “gran terremoto”.
Un peccato mostruoso.
No, se lo giudichiamo con la sensibilità morale prevalente nel mondo cattolico oggi. Søren, in questo, è solo
allusivo. Forse il senso di colpa che schiaccia come un macigno il padre è una imprecazione scagliata contro
Dio da bambino, quando pastorello in una vasta zona deserta dello Jutland, si è sentito drammaticamente
abbandonato.
Un’imprecazione del tutto innocente pronunciata da un bambino.
Ma non per il padre di Kierkegaard che, diventato un ricco commerciante, viene perseguitato da questo
peccato. Un senso di colpa che viene accentuato quando il padre a pochi mesi dalla morte della prima
moglie, seduce la cameriera che poi sposa e da cui avrà ben sette figli (Søren è l’ultimo).
Un “pungolo nella carne”
Nel frattempo Kierkegaard si innamora di una ragazza deliziosa, solare, “graziosa nel suo abbandono”,
“commovente nel senso nobile”, dallo “sguardo adorante”, tutta gioia di vivere: Regina Olsen.
Un carattere che contrasta fortemente con il suo.
È vero.
Un rapporto che non dura, da quanto abbiamo detto.
Infatti. Anche in questo caso non conosciamo la causa della rottura. Forse egli si rende conto, malinconico
com’è, di non essere assolutamente in grado di rendere Regina felice. Ma forse c’è dell’altro: sul letto di
morte dirà a un pastore luterano di avere avuto, come S. Paolo, il suo “pungolo nella carne”.
Vale a dire?
Non si sa: forse una leggera epilessia o forse un’impotenza sessuale. Ecco perché, a un certo punto, fa di
tutto per rompere il rapporto rendendosi odioso agli occhi di Regina.
Tutti fattori che lo conducono a considerarsi un’“eccezione”.
Sì, ma c’è di più: nel giro di pochi anni la morte entra prepotente nella sua casa e ghermisce la vita di cinque
dei suoi fratelli, ancora in giovane età. Eventi luttuosi che egli, sulle orme del padre, interpreta come il
segno di una maledizione divina che incombe sulla famiglia.
Una vita di sofferenza, la sua.
Sempre al pastore luterano di cui prima Kierkegaard dirà che la sua vita è stata “una grande sofferenza,
sconosciuta agli altri e incomprensibile”, che non ha potuto “condurre la vita degli altri uomini” e questo lo
ha convinto di aver avuto un compito “straordinario”, di essere “un gioco della Provvidenza” che gli ha
steso la mano e lo ha preso nell’“arca”.
Sempre più presuntuoso.
Dobbiamo calarci nella temperie religiosa in cui è vissuto.
Kierkegaard muore il 21 novembre 1855 a 42 anni. Appena prima l’unico fratello sopravvissuto, Pietro,
diventato vescovo luterano, gli fa visita e gli chiede se intende ricevere la comunione, ma egli rifiuta
categoricamente l’offerta: la riceverebbe non da un pastore, ma da un laico in quanto i pastori, proprio
perché sono “funzionari governativi […] non rappresentano il cristianesimo”.
Quando muore, Kierkegaard non solo è pressoché sconosciuto dalla grande cultura europea, ma neppure
da quella danese. E rimane sconosciuto per altri sessantacinque anni fino alla cosiddetta “KierkegaardRenaissance” tedesca che si registra nel primo dopoguerra, una scoperta ma anche nello stesso tempo un
fraintendimento.
In che senso?
Viene considerato una sorta di esistenzialista ante litteram, un semplice teorico della possibilità. In effetti
per certi aspetti lo è: vedi la sua battaglia culturale a difesa del singolo.
Contro Hegel.
Sì.
È tutto qui il suo esistenzialismo?
In qualche misura sì, ma è il caso di approfondire questa categoria centrale di Kierkegaard. È qui che
troviamo il concetto di “esistenza”: le cose sono, ma è solo l’uomo, il singolo uomo, che “esiste”. In altre
parole le cose sono nel senso che sono ciò che sono, mentre l’uomo è ciò che sceglie di essere.
Il peccato dell’esistere
La scelta, quindi, ha a che vedere con l’uomo, non solo con l’uomo religioso.
Infatti. Possiamo dire che l’uomo diventa uomo quando decide chi essere. Guarda alla figura di Adamo. Fino
all’ordine di Dio di non mangiare il frutto dell’albero della scienza del bene e del male, egli è innocente, cioè
ignora il bene e il male. È solo in seguito al comando divino che gli si spalancano delle “possibilità”,
possibilità senza le quali la scelta non sarebbe possibile.
La possibilità di conoscere il bene e il male, la possibilità – questo è lo scenario che gli prospetta il serpente
tentatore – di diventare come Dio.
Ma anche la possibilità di perdizione. Da qui l’angoscia della scelta. Angoscia che non è semplicemente
paura: si ha paura di un pericolo ben definito, mentre l’angoscia ha come oggetto il regno del possibile,
dove tutto è ugualmente possibile.
Stiamo riprendendo in chiave religiosa tutti i concetti che abbiamo già visto.
Infatti. Nella misura in cui Adamo decide di liberarsi dalla tutela di Dio per camminare da solo nella vita
scegliendo di realizzare la sua singolarità, si stacca da Dio, quindi “pecca”. È questo un corollario essenziale
dell’esistenza: per esistere, il singolo deve “staccarsi da”, “peccare”.
Come è il caso di un figlio: si realizza nel momento in cui decide di staccarsi dai genitori per diventare chi
vuole liberamente essere.
Sì, esistere è staccarsi da tutto ciò che dà sicurezza: Dio, i genitori, la tradizione, l’opinione pubblica.
La tanto condannata folla.
Sì, un uomo esiste nella sua singolarità solo se si stacca dalla massa, dal gregge, dal comune sentire.
Qui, finalmente, stiamo volando oltre il ristretto ambito religioso.
È vero, ma lo sfondo - è il “Diario” (ben 12 volumi tradotti in italiano), non ancora conosciuto al tempo della
“Kierkegaard-Renaissance”, che lo rivela - è sempre religioso: Kierkegaard è e rimane uno scrittore
religioso.
Siamo davvero agli antipodi di Hegel.
Sì: Hegel non solo stritola il singolo, ma annulla anche ogni “possibilità”.
Secondo lui, infatti, tutto è necessario: lo stesso individuo è un semplice momento di un processo dialettico
che ha come soggetto lo Spirito.
Non solo: in Hegel gli opposti vengono conciliati nella sintesi (che è un superare, ma nello stesso tempo un
conservare gli opposti), mentre secondo Kierkegaard il singolo si trova sempre nelle condizioni di scegliere
tra opposti: mai et-et, ma aut-aut. Un aut-aut che caratterizza la nostra “esistenza”. Si può fare la vita del
playboy, la vita di chi non si pone problemi esistenziali e cerca di godere tutto il godibile da questa vita.
Il principio del piacere
È lo stesso Kierkegaard che da giovane vive questo stile di vita.
Senz’altro. Kierkegaard definisce tale stile di vita “estetico”, uno stile che ha avuto la sua espressione
artistica nel don Giovanni di Mozart: l’uomo che assapora attimo per attimo la gioia di vivere, senza
tormenti. È la vita del carpe diem oraziano, la vita di chi passa da una donna all’altra, la vita caratterizzata
dal principio del piacere.
Si tratta di una scelta: ognuno ha diritto di scegliersi il suo destino.
Kierkegaard non la considera proprio una scelta: don Giovanni non sceglie o, meglio, sceglie di non
scegliere perché si lascia scegliere di volta in volta dalle circostanze, dalle occasioni. Non prende mai in
considerazione la possibilità di impegnarsi, di assumere delle responsabilità. La sua è una vita dispersiva,
dissipata, una vita in cui egli di fatto “non esiste”: non esiste non solo perché sceglie di non scegliere, ma
anche perché, proprio per questo, non ha alcuna identità.
Uno stile di vita, dunque, che alla lunga lascia un vuoto.
Sì: don Giovanni vive alla giornata alla ricerca esasperata di piaceri effimeri. Una ricerca tesa a sfuggire alla
ripetizione.
A sfuggire alla noia.
Sì: la vita dell’esteta, infatti, è destinata a trasformarsi in monotonia, noia, disperazione.
Disperazione?
L’esteta a un certo momento si rende consapevole di avere una vita che non ha un centro, che non ha un
senso unitario.
La scelta del dovere
È qui allora che deve decidersi.
Infatti. È la decisione che sta per prendere Kierkegaard quando si fidanza con regina Olsen: prendere un
impegno con una donna, sposarla, rimanerle fedele, assumersi tutte le responsabilità di un marito e,
domani, anche di un padre. Una vita all’insegna dell’etica, di norme universali.
Una vita di sicuro più ripetitiva di quella dell’esteta.
Indubbiamente: è la scelta non del piacere ma del dovere, non dell’effimero ma della stabilità, non della
leggerezza ma della responsabilità. Allora sì che la vita acquisisce un centro, che il singolo sceglie di essere
se stesso, di essere una ben definita identità.
Vita estetica e vita etica, dunque, sono opposti inconciliabili.
Infatti: aut-aut (Aut-aut è anche il titolo di un libro fortunato di Kierkegaard). Non esiste una via di mezzo.
Se la si cerca, tradendo il coniuge, si prova inevitabilmente il senso di colpa che conduce al pentimento.
In “timore e tremore”
Possiamo dire che Kierkegaard non è solo un don Giovanni mancato, ma anche un marito mancato: la sua
unica scelta è quella religiosa.
La vita religiosa, in realtà, è un’altra possibilità di esistenza: se don Giovanni sceglie di non scegliere, se il
marito sceglie di impegnarsi a rispettare delle norme etiche universali, l’uomo di fede (di cui Abramo è il
simbolo) è chi, in timore e tremore, è disposto a violare gli stessi valori morali con tutto il rischio che questo
comporta in nome di un “rapporto assoluto all’Assoluto”.
Anche qui siamo di fronte a un aut-aut.
Sì: vita etica e vita religiosa non sono coniugabili.
Ma questo è assurdo!
È assurdo dal punto di vista di chi ha tradito il cristianesimo, di chi l’ha conciliato con le esigenze del mondo,
di chi non ha compreso il paradosso della fede.
Che cosa mai dovrebbe spingere un singolo uomo a credere in tale paradosso?
Secondo Kierkegaard, siamo noi che prima o poi ci interroghiamo sul senso del nostro esistere, sulle nostre
radici. Ed è questo interrogarci che ci conduce a scoprire il nostro essere finiti, non autosufficienti. È in
questo interrogarci che cogliamo la nostra inquietudine, l’inquietudine dell’eternità, che cogliamo la nostra
fragilità morale, il nostro sentire il senso di colpa. Da qui l’abbandono a Dio, la fiducia in Dio.
La speranza in una vita ultraterrena.
La speranza di liberarsi da quella “malattia mortale” dell’uomo che è la disperazione: “solo chi ha provato la
disperazione capisce in fondo la Redenzione, perché ne sente il bisogno”. Disperazione che è proprio
questa mancanza di infinito, di eterno.
Ma l’abbandono a Dio non ha alcuna garanzia.
Già, è senza garanzie, ma la fede non sarebbe fede se poggiasse su delle certezze. La fede è sempre un
rischio. Ma chi non rischia, si annienta perché si stacca dalle sue radici, da “quell’unico pozzo da cui si può
attingere acqua”.
Solo un “poeta”
Un rischio che Kierkegaard vive fino in fondo.
Kierkegaard – lo confida lui stesso – è tutt’altro che un modello di cristiano: un cristiano mediocre, un
penitente, un “poeta” degli ideali.
Quindi il suo cristianesimo tormentato è solo un gioco letterario.
Vi è chi ha accusato Kierkegaard di avere vissuto la scelta religiosa da “esteta”, seduto sulla sua scrivania e
circondato dalla servitù che ha potuto permettersi grazie all’eredità del padre.
Anche lui insincero come Schopenhauer.
Forse no: ha combattuto contro un cristianesimo accomodante, snaturato, tradito e l’ha fatto con le uniche
carte che possedeva, quelle dello scrittore.
Sarà stato sincero, ma ciò che mi colpisce è che tutte le sue riflessioni sono segnate da vicende biografiche.
Questo accade a ciascuno di noi. La verità - Kierkegaard ne è profondamente convinto - non è qualcosa di
oggettivo, ma appartiene al proprio percorso interiore, esistenziale.
Un’altra stoccata contro Hegel.
Sì. La stessa fede non ha nulla a che vedere con istituzioni, riti, dogmi, ma con una “decisione”, una
decisione sofferta.
Questo, sì, che è in sintonia con la sensibilità del nostro tempo.