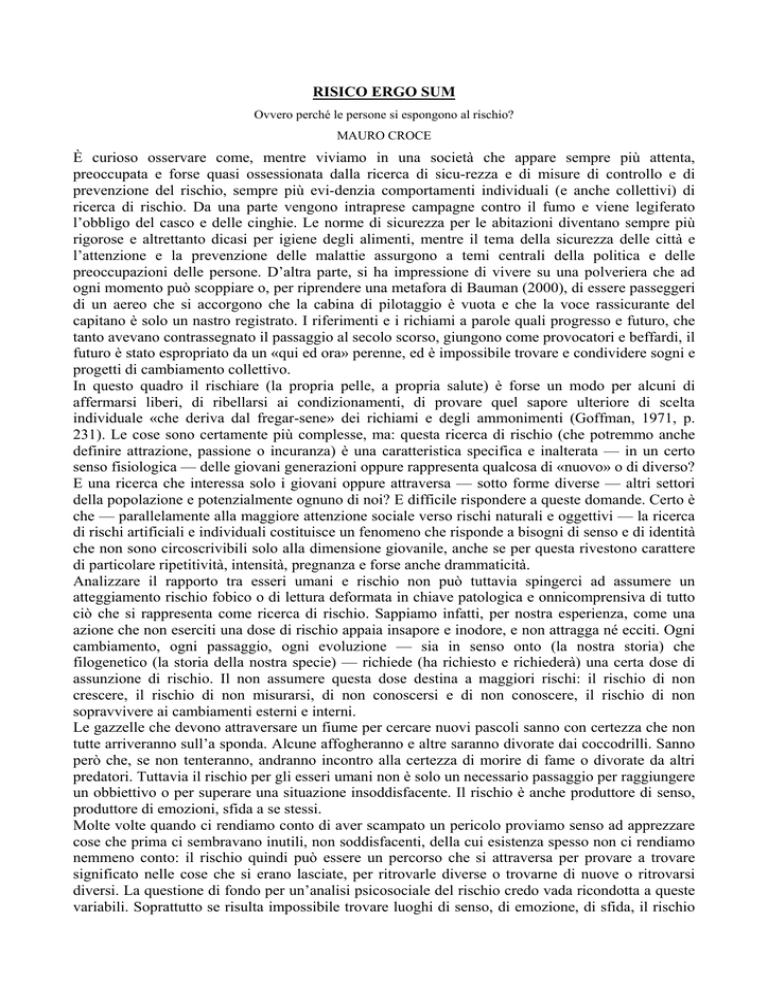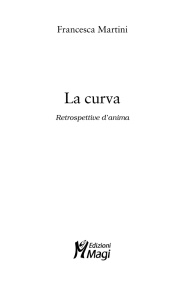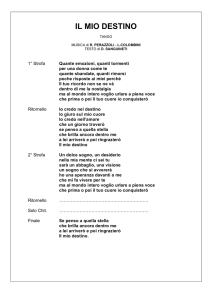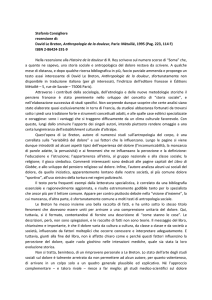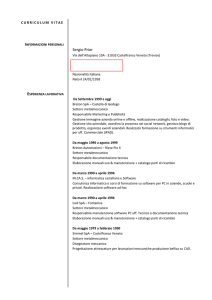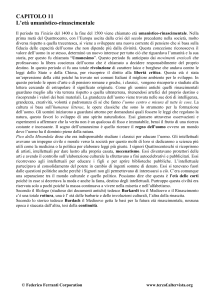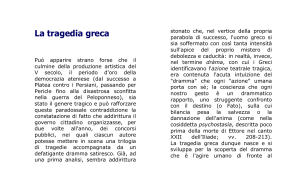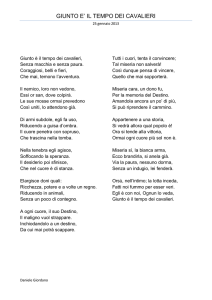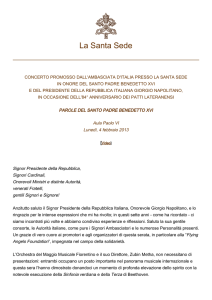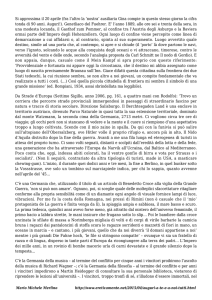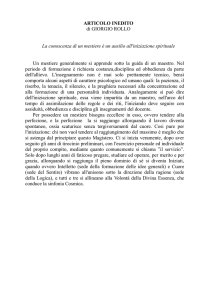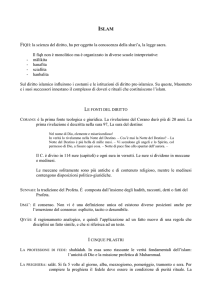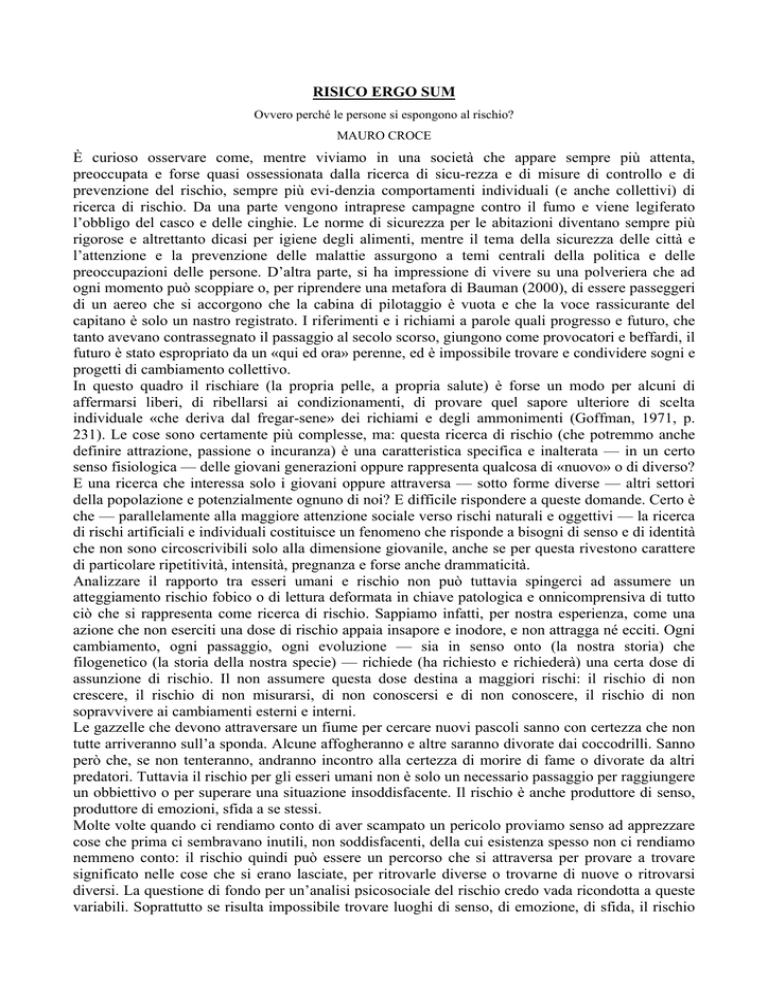
RISICO ERGO SUM
Ovvero perché le persone si espongono al rischio?
MAURO CROCE
È curioso osservare come, mentre viviamo in una società che appare sempre più attenta,
preoccupata e forse quasi ossessionata dalla ricerca di sicu-rezza e di misure di controllo e di
prevenzione del rischio, sempre più evi-denzia comportamenti individuali (e anche collettivi) di
ricerca di rischio. Da una parte vengono intraprese campagne contro il fumo e viene legiferato
l’obbligo del casco e delle cinghie. Le norme di sicurezza per le abitazioni diventano sempre più
rigorose e altrettanto dicasi per igiene degli alimenti, mentre il tema della sicurezza delle città e
l’attenzione e la prevenzione delle malattie assurgono a temi centrali della politica e delle
preoccupazioni delle persone. D’altra parte, si ha impressione di vivere su una polveriera che ad
ogni momento può scoppiare o, per riprendere una metafora di Bauman (2000), di essere passeggeri
di un aereo che si accorgono che la cabina di pilotaggio è vuota e che la voce rassicurante del
capitano è solo un nastro registrato. I riferimenti e i richiami a parole quali progresso e futuro, che
tanto avevano contrassegnato il passaggio al secolo scorso, giungono come provocatori e beffardi, il
futuro è stato espropriato da un «qui ed ora» perenne, ed è impossibile trovare e condividere sogni e
progetti di cambiamento collettivo.
In questo quadro il rischiare (la propria pelle, a propria salute) è forse un modo per alcuni di
affermarsi liberi, di ribellarsi ai condizionamenti, di provare quel sapore ulteriore di scelta
individuale «che deriva dal fregar-sene» dei richiami e degli ammonimenti (Goffman, 1971, p.
231). Le cose sono certamente più complesse, ma: questa ricerca di rischio (che potremmo anche
definire attrazione, passione o incuranza) è una caratteristica specifica e inalterata — in un certo
senso fisiologica — delle giovani generazioni oppure rappresenta qualcosa di «nuovo» o di diverso?
E una ricerca che interessa solo i giovani oppure attraversa — sotto forme diverse — altri settori
della popolazione e potenzialmente ognuno di noi? E difficile rispondere a queste domande. Certo è
che — parallelamente alla maggiore attenzione sociale verso rischi naturali e oggettivi — la ricerca
di rischi artificiali e individuali costituisce un fenomeno che risponde a bisogni di senso e di identità
che non sono circoscrivibili solo alla dimensione giovanile, anche se per questa rivestono carattere
di particolare ripetitività, intensità, pregnanza e forse anche drammaticità.
Analizzare il rapporto tra esseri umani e rischio non può tuttavia spingerci ad assumere un
atteggiamento rischio fobico o di lettura deformata in chiave patologica e onnicomprensiva di tutto
ciò che si rappresenta come ricerca di rischio. Sappiamo infatti, per nostra esperienza, come una
azione che non eserciti una dose di rischio appaia insapore e inodore, e non attragga né ecciti. Ogni
cambiamento, ogni passaggio, ogni evoluzione — sia in senso onto (la nostra storia) che
filogenetico (la storia della nostra specie) — richiede (ha richiesto e richiederà) una certa dose di
assunzione di rischio. Il non assumere questa dose destina a maggiori rischi: il rischio di non
crescere, il rischio di non misurarsi, di non conoscersi e di non conoscere, il rischio di non
sopravvivere ai cambiamenti esterni e interni.
Le gazzelle che devono attraversare un fiume per cercare nuovi pascoli sanno con certezza che non
tutte arriveranno sull’a sponda. Alcune affogheranno e altre saranno divorate dai coccodrilli. Sanno
però che, se non tenteranno, andranno incontro alla certezza di morire di fame o divorate da altri
predatori. Tuttavia il rischio per gli esseri umani non è solo un necessario passaggio per raggiungere
un obbiettivo o per superare una situazione insoddisfacente. Il rischio è anche produttore di senso,
produttore di emozioni, sfida a se stessi.
Molte volte quando ci rendiamo conto di aver scampato un pericolo proviamo senso ad apprezzare
cose che prima ci sembravano inutili, non soddisfacenti, della cui esistenza spesso non ci rendiamo
nemmeno conto: il rischio quindi può essere un percorso che si attraversa per provare a trovare
significato nelle cose che si erano lasciate, per ritrovarle diverse o trovarne di nuove o ritrovarsi
diversi. La questione di fondo per un’analisi psicosociale del rischio credo vada ricondotta a queste
variabili. Soprattutto se risulta impossibile trovare luoghi di senso, di emozione, di sfida, il rischio
diventa esso stesso obiettivo, emozione, sfida. Diventa a possibilità, quella vera e unica, in cui si
può e si deve «giocare per un attimo la propria sicurezza o la propria vita, a rischio di perderla, per
finalmente guadagnare la legittimità della propria presenza nel mondo, o semplicemente per
strappare infine, nella forza di questo attimo, il sentimento di esistere, di sentirsi fisicamente
contenuti e assicurati nella propria identità» (Le Breton, 1995, p. 11).
DAL DESTINO AL PROGETTO
Dal non poter scegliere ai dover scegliere
Ancora non molto tempo fa Il nascere r una determinata famiglia, in un determinato luogo, l’essere
il primogenito di sesso maschile o femminile, costituiva un destino già segnato. La professione e
spesso anche il matrimonio erano infatti già decisi. È noto infatti come nelle famiglie
dell’aristocrazia l’uno o l’altro figlio fosse destinato alla carriera militare, ecclesiastica, ecc., mentre
nelle famiglie di basso ceto la professione dei figli fosse decisa dal lavoro, dagli impegni o dalle
scelte del padre. Era difficile ribellarsi a queste consuetudini e chi, strenuamente, voleva costruirsi
un destino proprio doveva andare incontro non solo a enormi difficoltà materiali, ma anche
all’ostracismo della propria famiglia.
Le cose ora sono molto cambiate. Se nel passato si poteva parlare di una organizzazione sociale
«del destino» (dove questo se proprio non era segnato, certamente canalizzava e costruiva le
aspettative, i desideri e anche le paure dei soggetti), ora si può forse parlare di una organizzazione
sociale attenta non a «destinare» e persone, ma a cercare di favorire e promuovere in loro la ricerca
e la costruzione del proprio destino, del proprio progetto di vita: professionale, sociale, amicale,
familiare. Mentre nel passato le persone potevano avere motivi e nemici esterni contro cui ribellarsi,
e potevano combattere per le limitazioni sociali avverse alle proprie inclinazioni e ai propri desideri,
ora possono trovare una organizzazione sociale e miliare più attenta ai propri desideri e bisogni.
Tutto ciò costituisce un indubbia progresso. Le persone hanno impressione (ma sarà vero?) di non
essere più ingabbiate nelle maglie della classe sociale e dei desideri/frustrazioni del geni-tori;
apparentemente ognuno sembra più libero di scegliere e d costruire il proprio progetto. Si può anche
dire che oggi sia non solo possibile, ma anche obbligatorio costruirsi il proprio destino: il che
costituisce una grossa responsabilità e un grosso rischio.
Finché gli altri decidevano per me potevo arrabbiarmi, potevo pensare di avere un progetto
splendido e irrealizzabile (forse splendido proprio perché irrealizzabile) e potevo avere elementi di
consolazione per il destino avverso. Potevo colpevolizzare altre persone o la società in generale del
fallimento delle mie aspirazioni, e coltivare l’idea che se le condizioni fossero state diverse, diverso
sarebbe stato anche il mio destino e la mia felicità. La mia colpa e la mia responsabilità per la
riuscita o il fallimento erano molto relative e tanti potevano essere gli elementi di consolazione. Gli
impedimenti poi potevano anche convincermi che valeva la pena di costruire un proprio progetto e
lottare per quello.
L’apparente apertura di possibilità che ora si apre e la possibilità/obbligo «di essere felice, di
realizzarsi, di avere successo», se a molti appare come una splendida opportunità, per altri (e forse i
più) appare come un tremendo spazio sconfinato privo di segni da interpretare, di luoghi ove
proteggersi, di senso da attribuire ai propri progetti. Poter scegliere il proprio destino, potersi
costruire autonomamente, poter avere spazi sconfinati a disposizione per molti diventa una
situazione agorafobica, dove la paura è per gli spazi sconfinati e nelle enormi possibilità che questi
rappresentano. Contrariamente a quanto poteva accadere nel passato, dove le paure erano dl tipo
claustrofobico e il mondo era percepito per gli impedimenti, gli spazi angusti che venivano destinati
alle persone.
Dalle nevrosi alle dipendenze
Se le persone prima potevano sviluppare patologie e comportamenti di tipo eteroaggressivo contro
padri, istituzioni, relazioni che impedivano e opprimevano l’espressione e la realizzazione dei
propri desideri, in questo nuovo quadro le persone sono portate a sviluppare patologie e
comportamenti di tipa depressivo o autoaggressivo, dove «il colpevole sono io perché non riesco ad
avere progetti, desideri, obiettivi per i quali lottare». Robert Merton sottolineava molti anni fa come
la società ponga gli individui di fronte a obiettivi, mete comuni per tutti, mentre le possibilità e gli
strumenti per il raggiungimento di tali obiettivi in realtà sono molto diversificati tra le persone, in
ragione (ad esempio) della classe sociale di appartenenza. Tutto ciò è ancora indubbiamente vero,
per molti gli impedimenti sociali, culturali, economici esistono e sono evidenti. Tuttavia come non
considerare il fatto che per taluni aspetti la contraddizione evidenziata da Merton appare capovolta,
ovvero che molte persone hanno strumenti a disposizione, ma non obiettivi pregni di simboli e di
senso da raggiungere? Gli obiettivi si accavallano gli uni agli altri e il senso e l’importanza degli
stessi decade man mano che ci si avvicina ad essi parimenti alla beffarda aspettativa degli altri che
si aspettano tu stia raggiungendo «la tua felicità». In questo enorme spazio vuoto e fobico il
soggetto cerca di aggrapparsi o fuggire ad ogni cosa, possibilità, ad ogni oggetto, persona,
situazione.
Aggrapparsi o fuggire: facce opposte della stessa medaglia. Aggrapparsi per poter dipendere, per
avere qualcosa che richiami a una relazione (fosse anche di dipendenza e di sofferenza per
l’assenza), a un obbligo, a un impegno: «a qualcosa che ti aspetta e si aspetta determinati
comportamenti da te». Ma questa tendenza è ovviamente ambigua e il desiderio è anche di fuggire,
di sentirsi autonomi, non dipendenti. Il sentirsi spinti, determinati e non padroni degli eventi, può
portare allora al desiderio di «far succedere qualcosa» (Matza 1964, p. 189), di dimostrare che si
può essere causa degli eventi stessi e non solo loro effetto. Ma non basta un’azione qualsiasi, non
basta un’azione che possano compiere tutti: ci vuole qualcosa di particolare, una nuova infrazione
mai sperimentata» (Traverso, Verde, 1981, p. 67). Se la fine dell’ottocento (il periodo, se non della
nascita, certamente della formalizzazione di psicologia, psichiatria e sociologia) vide l’emergere
delle nevrosi come maggiore preoccupazione -in particolare l’isteria, che con la nascita della
psicanalisi doveva essere la chiave di volta per un nuovo approccio della psiche- la fine del
Novecento ha visto invece, come ricorda Valleur (in corso di stampa), una crescita preoccupante
verso «nuove» forme dl patologia che vengono definite dal ricorso all’azione.
Se isteria descritta da Freud costituiva la forma esemplare di un disturbo dovuto a un eccesso di
rimozione, di ritegno, alla carenza di soddisfazione degli istinti e dei desideri, le nuove forme
patologiche, nella nostra società dei consumi, sono le tossicomanie, le dipendenze, i comportamenti
a rischio, che costituiscono, almeno nelle rappresentazioni dominanti, problemi legati ad una
mancanza di controllo, alla ricerca del piacere immediato, al ricorso all’azione: non tanto eccesso
quanto piuttosto difetto d’inibizione. In questa evoluzione occorre indubbiamente riconoscere il
segno di un cambiamento degli imperativi della società età nei confronti degli individui che la
compongono: al «contegno richiesto dal secolo scorso si sostituisce oggi la necessità di consumare,
di godere pienamente, addirittura di prendere dei rischi» (Valleur, ibidem).
RITI DI INIZIAZIONE O TENTATIVI DI SIGNIFICAZIONE?
Rischiare in un certo senso vuoi dire anche rinascere, vuole dire attraversare e toccare zone buie e
vicine alla morte per poi ritrovare senso e presenza nella quotidianità, magari con l’illusione di
essere più forti, di avere superato un rito di iniziazione. Ma difficilmente questi possono dirsi riti di
iniziazione. Per essere tali avrebbero bisogno di essere riconosciuti tali da parte di una collettività.
Presupporrebbero cioè una comunità che ha bisogno di persone divenute adulte o, come poteva
essere in società d guerrieri, che queste persone si possano differenziare dalle altre: che esista
insomma un prima e un dopo rito e che le persone che l’hanno attraversato siano visibili e trovino
una diversa collocazione sociale. Ma oggi non ci troviamo in questa situazione.
L’adolescenza oggi incomincia prima e finisce molto dopo. Anzi non si sa nemmeno quando, se e
come finisca e -per quanto sociologicamente se ne riesca a dare una conclusione anagrafica,
comunque oltre i trent’anni- cori difficoltà se ne riesce a dare una conclusione clinica. È quindi
chiaro che quando si parla di «giovani» sempre meno ci si riferisce ad una determinata, confinata e
precisa condizione anagrafica e sempre più ci si riferisce ad una indifferenziata condizione che
attraversa e interessa, in molte sue tensioni, intenzioni e bisogni, persone che anagraficamente e
socialmente non rientrerebbero nella categoria dei «giovani». Parimenti in altre società extraeuropee
e in molti giovani immigrati possiamo trovare chi anagraficamente rientrerebbe nella categoria di
giovani, ma clinicamente non ne presenta le caratteristiche.
La nostra società non ha bisogno di adulti, di forza lavoro, e i giovani restano «sempre giovani» e se
ne amplifica a dismisura la loro formazione che, ovviamente, è direttamente proporzionale al non
bisogno di adulti da parte della società. La ricerca del rischio per molti può allora essere l’occasione
per provare non solo se si è forti, se si riescono a superare determinati ostacoli e limiti, ma anche e
soprattutto se si è degni e se vale la pena di vivere. In questo senso molte condotte di rischio
sembrano essere più riti o tentativi di significazione (di ricerca di significato) che di iniziazione in
quanto, tra l’altro, non si saprebbe per iniziare che cosa. Nel rito di iniziazione, come ricorda Zoja
(1985), esiste una condizione dì partenza da trascendere perché insignificante.
Come l’adolescente della società primitiva per essere strappato a quella insignificanza sì
affi-dava alla iniziazione che gli dava finalmente una identità completa e adulta, così
l’uomo della nostra società, sperduto, passivo, capace solo di consumare e ripetere gesti
compiuti da milioni di altri uomini, sogna segretamente una trasformazione che lo faccia
adulto, inconfondibile, protagonista, creatore e non più solo consumatore. (Zoja, 1985,
pp. 8-9)
Il secondo punto del rito di iniziazione è quello della morte iniziatica, che contraddistinta da una
fase di chiusura al mondo, di rinuncia alla precedente identità e di ritiro libidico dagli investimenti
usuali che, secondo Zoja, dovrebbe consistere soprattutto in una astinenza dalle pratiche
consumistiche. Il terzo e ultimo passaggio è costituito dalla «rinascita iniziatica, favorita
psicologicamente dalla condivisione dell’esperienza con altri, dall’accompagnamento di rituali»
(ibidem). Forse nel caso di molti comportamenti di ricerca di rischio che possono portare a morte, a
limitazioni o a forme di dipendenza, il meccanismo può essere quello dell’ordalia.
GIOCHI AL LIMITE
Dalle ordalie ai comportamenti ordalici
Con il concetto di ordalia si usa intendere la prova attraverso la quale, in epoca medioevale, una
comunità si appellava a Dio per avere la certezza dell’innocenza o della colpevolezza di un suo
membro. La prova spessa richiedeva un forte rischio di morte (annegamento, ferro rovente, ecc.),
metteva l’individuo in una situazione di solitudine di fronte al destino e «il giudizio di Dio» si
esprimeva in maniera inappellabile. Un giudizio che, al di là della colpa, al di là del bene e del
male, legittimava chi veniva sottoposto o si sottoponeva alla prova nella sua qualità di uomo
conferendogli una accettazione divina.
Secondo alcuni studiosi francesi (Charles-Nìcholas, Valleur, 1987; Le Breton,1995), in assenza di
riti istituzionali validi e riconosciuti, gli adolescenti delle società occidentali ricorrerebbero a forme
di iniziazione simili all’ordalia, attraverso prove che essi si impongono, sfide alle quali si
sottopongono, esperienze che vivono intensamente:
Cercando rischi sempre maggiori (....) il comportamento ordalico culminerà in un
tentativo di suicidio apparentemente inspiegabile o accidentale. Possiamo, pertanto,
definire la condotta ordalica come la ripetizione di una prova che comporta un rischio
mortale, nella quale il soggetto si impegna alla fine, per la sua sopravvivenza, a mettere
alla prova il suo valore intrinseco, e ottenerne il riconoscimento delle potenze
trascendentali del destino. (Charles-Nicholas, Valleur, 1987, pp. 68-69)
Ti sentimento di essere garantiti favorisce l’impegno di una rinnovata energia nello svolgimento
della vita, la conquista d un significato più colmo per un’avventura personale che fino ad allora era
stata vissuta in maniera più indecisa, senza sostegno, spesso in una sorta di candore. (Le Breton,
1995, p. 59) persona è isolata, quanto più debole e sparpagliata la sua rete sociale, tanto meno le sue
decisioni saranno sottoposte all’esame pubblico, e tanto più si stabilirà da sola le proprie norme sul
rischio ragionevole. Ma non appena c’è una comunità, le norme sull’accettabilità vengono discusse
e fissate socialmente» (Dauglas, 1991).
In assenza di questa definizione socialmente condivisa, il passaggio nel rischio potrebbe essere
interpretabile quale disperato tentativo per staccarsi da modelli alienanti e cercare quel tanto che è
spontaneo, individuale, autonomo. Questa prospettiva -quella culturale- mette in secondo piano le
variabili individuali e patologiche così come gli elementi di ordine strumentale legati ai rischio per
focalizzarsi su un elemento: quello del bisogno di identità e di auto ed etero riconoscimento sociale.
Secondo l’ipotesi di Le Breton (1995) (che peraltro, riguardo all’ordalia, riprende tesi di Valleur e
Charles-Nicholas e concetti di fondo riferibili a Simmel e Caillois), le forme di rischio osservabili
sarebbero riconducibili ad alcuni concetti chiave.
La vertigine. Come si è già osservato ne caso degli sky divers, la ricerca della vertigine costituisce
un dato saliente in molte forme di rischio nonché il filo che collega azioni anche diverse tra loro
quali: a velocità, il salto nel vuoto, la ricerca di sensazioni intense, sport estremi e anche -secondo
Le Breton- la tossiccodipendenza. La vertigine offre al soggetto la possibilità di scompigliare i punti
di riferimento, di creare un provvisorio disordine delle coordinate nella «ricerca dell’oltre». «Si
tratta di accedere ad una specie di spasmo, di trance, di smarrimento che annulla la realtà con
vertiginosa precipitazione» (Caillois, 1981). «La morte che talvolta irrompe al momento
dell’incidente segna (tuttavia) il ritorno brutale del rimosso» (Le Breton, 1995, p. 27).
L’affrontamento. L’affrontamento definisce le pratiche che segnano il bisogno di toccare l’estremo
della propria potenza fisica e può essere assimilabile ad una forma di ascetismo che tende al
dominio, al controllo, all’esaurimento delle forze. Se la chiave della vertigine sta nello «sfogarsi»,
quella dell’affrontamento sta nello «stravolgersi». Cioè nel dimostrare a se stessi la propria capacità
di andare sino in fondo nell’attraversare mari, percorrere deserti a piedi, scalare montagne a mani
nude, ecc. Apparentemente opposte tra loro, resistenza e vertigine si mescolano tra loro talvolta in
maniera inestricabile.
Il candore. Le figure della vertigine e dell’affrontamento evidenziano la scelta di un rapporto
volontario con il rischio, dove la ricerca del senso del soggetto si esercita attraverso un accesso
provvisorio, deliberato -simbolico o reale- con la morte che riveste l‘esistenza di una nuova
legittimità e offre la possibilità all’individuo di immaginare di ottenere un sovrappiù di significato
che la comunità nella quale vive non è in grado di fargli condividere. La scelta tuttavia può anche
essere quella opposta e l’attrazione provenire dai meno anziché dal più. La figura del candore può
rivelare allora il desiderio di assenza, di sospensione del legame sociale che lascia il corpo altrove,
sconnesso. Secondo Le Breton, il candore può essere la chiave per interpretare alcuni «giochi
eufemistici con la morte» quali alcool, droga, fuga, vagabondaggio, sino al desiderio di raggiungere
il coma (in particolare attraverso forme di tossicomanie da farmaci), così come forme di dipendenza
da computer, videogiochi, ecc. «Davanti allo schermo, il giovane ricompone il mondo mediante una
gamma ridotta di variabili semplici Senza aver bisogno di affidarsi agli altri, egli si soddisfa con
una forma d autismo provvisorio che gli procura un senso di vertigine e in cui entra e da cui esce a
piacere. Si sottrae per un attimo alla persistenza del simbolico spingendosi verso il vuoto. Combatte
l’assenza prendendo l’iniziativa dell’assenza» (Le Breton, 1995, p. 39).
La sopravvivenza. La figura della sopravvivenza poggia sulla fantasia (desiderio?) della persona o
dei gruppo di amici disperati nei loro sforza di cavarsela in balia degli elementi avversi. Corsi di
sopravvivenza, attività che fanno ricorso alle capacità dell’individuo nell’affrontare le avversità e
superare i pericoli (offrendo al soggetto una migliore conoscenza di sé, un migliore affiatamento del
gruppo, un qualcosa che si è superato da ricordare, da raccontare, da esibire) sono sempre più
diffusi e vengono proposti anche quale mezzo di formazione. Tali «avventure» possono
rappresentare un tentativo di scongiurare a paura del futuro mimando la catastrofe e di ritrovare
dentro di sé la capacità e la volontà di iniziativa di controllo. Secondo Le Breton il ricorso a tali
esperienze può rappresentare la trasposizione simbolica su un diverso piano dell’affrontare la paura.
Perché l’efficacia simbolica funzioni su questo piano non è necessario tuttavia che la paura venga
chiaramente verbalizzata. Rimane sospesa nell’aria e questo è sufficiente.
L’ordalia. Sulla figura dell’ordalia abbiamo già detto.
La folla. Accanto alle dimensioni citate, credo possa assumere interesse anche la dimensione della
folla. Si pensi, ad esempio, al fenomeno discoteca (ma non solo) e all’evidenziarsi in molti contesti
della perdita della dimensione individuale e gruppale in favore di un bisogno di «anima collettiva».
Gli studi sulla psicologia della folla (Le Bon, 1927) ci hanno resi edotti di come la folla possa
assumere la dimensione di contenitore «Volevo vivere, perciò dovevo morire», diceva Nietzche.
Quando la propria esistenza non riesce ad essere una sfida, quando gli obiettivi appaiono sempre più
opachi e non importanti, oppure tanto distanti e non condivisibili con alcuno, quando le emozioni
sono assopite, il cercare il rischio, il toccare la morte, il vivere emozioni diventa la possibilità,
quella vera, quella unica in cui si può e si deve giocare per un attimo la propria sicurezza o la
propria vita, a rischio di perderla.
Edgework: I nuotatori del cielo
Il termine edgework ( sul bordo») è stato utilizzato per descrivere una varietà di esperienze umane
che si possono situare al confine tra salute e malattia, tra vita e morte, tra coscienza e incoscienza.
In tale ambito Lyng (1990) ha condotto un interessante studio sui cosiddetti sky divers, ossia i
nuotatori o meglio «tuffatori del cielo», coloro che buttandosi dall’aereo aprono il paracadute
all’ultimo istante: tali azioni al limite comportano una minaccia alle proprie sicurezze fisiche e
mentali e quindi al significato che una persona attribuisce alla vita ordinaria.
Una delle motivazioni più salienti riguarda le sensazioni che vengono sperimentate durante una
azione rischiosa. Secondo i risultati ottenuti da Zuckerman (1979), attraverso la somministrazione
della scala SSS (Sensation Sceking Scale) a soggetti in età adolescenziale, è emerso come
l’attrazione dei giovani nei confronti dei comportamenti «spericolati» (ad esempio, guida in stato di
ubriachezza e rapporti sessuali non protetti) sia interpretabile come manifestazione di un tratto di
personalità connotato dal desiderio di vivere sensazioni nuove ed eccitanti. Nell’attimo del rischio
gli individui si sperimentano come entità che agiscono per istinto, il che offre loro un senso
«purificato e magnifico» del proprio io. In questo senso l’attività al limite fornisce sensazioni limite
perché implica altera-zioni nella percezione e nella coscienza. Quando si è giunti al culmine
dell’esperienza la percezione diventa focalizzata e gli edgework non solo dimenticano tutti i fattori
ambientali estranei al loro obiettivo, ma perdono anche la nozione di tempo perché la capacità di
percepire il trascorrere del tempo rallenta o si velocizza.
Lyng insiste su una particolarità che personalmente reputo fondamentale per comprendere il
significato e il bisogno di rischio per molti soggetti: l’ edgework non intraprende azioni rischiose
per amore di esse come nei caso dei gamblers, i giocatori d’azzardo, o di ricerca di sensazioni di
paura (thill seekng). Egli si pone in situazioni al limite, ma non ama mettersi in situazioni pericolose
che implicano circostanze che non può controllare e di fatto evita accuratamente tutte quelle attività
in cui non può avere padronanza. L’edgeworker quindi non si affida al destino, ma negozia una
sfida: non ricerca uno stato di perdita di coscienza, ma un senso di cosciente, profonda onnipotenza.
Scrive Messner, a proposito degli alpinisti, come il rischio della vita nulla abbia a che fare con il
suicidio, ma anzi «attraverso la follia calcolata delle loro arrampicate essi non vogliono arrivare alla
morte, ma alla vita e al fondo di se stessi» (Messner, 1980).
LE FIGURE DEL RISCHIO
Il modello culturale, al quale in questo articolo ci rifacciamo, propone di interpretare il bisogno di
rischio in relazione al contesto antropologico della modernità e alle forme contemporanee di
individualismo.
In questa prospettiva il rischio, elemento fisiologico e di crescita per una persona, per un gruppo,
una comunità, viene letto come elemento individuale di sfida, rito di passaggio ad una adultità
socialmente negata e probabilmente internamente vissuta come luogo privato in entrambi i sensi del
termine - di passioni. Donati (1991) si domanda se la società attuale non sia, almeno per vasti
ambiti, uno spazio rarefatto dove gli individui hanno la sensazione di nuotare nel vuoto, vuoto di
valori e di norme nel quale mettono alla prova se stessi. Le condotte a rischio, intese quindi come
comportamenti al limite, sarebbero più diffuse in quelle società che offrono ai propri membri un
ambiente anonimo, impersonale, in cui è più facile percepirsi come separati dai propri simili
piuttosto che come membri della medesima comunità.
Le strategie che i soggetti si darebbero sarebbero quindi da ricercare nel tentativo di riconquistarsi,
in chiave individuale, la propria scelta di senso e destino. Ricorda Douglas come «quanto più una
rassicurante e uniformizzante, non solo in grado di appianare diversità e inquietudini di genere,
storia, cultura, classe, identità, ma anche di favorire un sentimento di potenza invincibile che
permette ai partecipanti di cedere a quegli istinti che –soli- altrimenti reprimerebbero. Il soggetto
ritroverebbe pertanto nella folla anonima e irresponsabile il luogo del trasporto emozionale e della
suggestionabilità dove le dimensioni e i controlli tradizionali scompaiono per dare luogo ad un
senso di tutt’uno primordiale. In questa dimensione quindi le cautele, le difese, i controlli interni ed
esterni rischiano di venire messi da parte, a favore della risposta a bisogni altrimenti repressi o
inaccettabili.
ALCUNE CONCLUSIONI
Il più grave credo sia quello di considerare la scelta del rischio una decisione autonoma, razionale,
quasi meditata a tavolino da parte del soggetto. In realtà altri fattori giocano e, pur non potendo
trattarli con la necessaria articolazione, cercherò quantomeno di renderne presenti alcuni. Da un lato
occorre considerare le influenze e le microculture del gruppo, da un altro lato come il soggetto in
alcuni casi possa preparare, desiderare, sognare, immaginare «il rischiare» ma, e non di rado, possa
anche «trovarsi» nella situazione di rischio e in questa trovare nuovi sensi, risposte e significati a
bisogni prima non consapevoli. Oppure ancora trovare senso e risposta una volta uscitone. In questa
prospettiva credo vadano considerate anche le strategie che il soggetto utilizza «in un certo senso
per autoingannarsi» e quindi per trovarsi o farsi trovare -per giustificarsi o per farsi giustificare- in
situazioni che altrimenti non affronterebbe o affronterebbe in maniera diversa. Mi riferisco in
questo senso forse a ciò che gli psicoanalisti chiamerebbero corruttibilità del super-io e gli
interazionisti tecniche di neutralizzazione.
In questa prospettiva, credo possano essere illuminanti gli studi di Rhodes e coll. (Rhodes e
Stimson, 1994; Rhodes e Quirk, 1995) del «Center for research on drug», soprattutto la loro analisi
riguardo l’uso di sostanze quale mezzo di razionalizzazione sociale per giustificare comportamenti
altrimenti visti come cattivi, folli o dannosi. Il pensare tuttavia il «nostro mondo» guidato da
razionalità è un errore che ci impedisce di comprendere non solo perché le persone rischino la vita
«semplicemente» per trovare senso e giustificazione della vita stessa, ma anche come certi
meccanismi non siano specifici di «alcune persone», ma possano essere presenti anche in chiunque
di noi quando sì sentono inefficaci o lontani i sensi e le possibilità della propria esistenza. Daltro
canto, diceva Malraux, «non ci si uccide se non per esistere».
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Balint M., Balint E., La regressione, Cortina, Milano 1983.
Bauman Z., La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2000.
Caillois R., I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, Bompiani, Milano
1981.
Donati P., Famiglia e infanzia in una società rischiosa: come leggere e affrontare
il senso del rischio, in «Bambino incompiuto», 2, UNICOPLI, Milano 1991.
Douglas M., Come percepiamo il pericola. Antropologia del rischio, Feltrinelli,
Milano 1991.
Goffman E., Modelli d’interazione, Il Mulino, Bologna 1971.
Le Breton D., Passione del rischio, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1995.
Le Bon G. (1927), Psicologia delle folle, Longanesi, Milano 1980.
Lyng S., Edgework: a social psycological analysis of voluntary risk taking, in
«American Journal of Sociology», 4, 1990, pp. 851-886.
Matza D., Delinquency and Drift, John Wiley & Sons, New York 1964.
Messner R., Il limite della vita, Zanichelli, Bologna 1980.
Rhodes T., Stimson G.V., What is the relation between drug taking and sexual
risk? Social relations and social research, in «Sociology of Health and Illness»,16,
1994, pp. 209-228.
Rhodes T., Quirk A., Drug use, sexual risk and sexual safety, in «Druglink», 10,
1995, pp. 15-18.
Traverso G. B., Verde A., Criminologia critica, CEDAM, Padova 1981.
Valleur M., Per una analisi critica del gioco patologico, in Atti del congresso «Il gioco e l’azzardo»
(in corso di stampa), Forte dei Marmi, 6-8 aprile 2000, a cura di ALEA (www.gambling.it).
Valleur M., Charles-Nicholas A., «Le condotte ordaliche», in Olievenstein C. (a cura di), La cura
del tossicomane, Ed. Lauretane, Loreto 1987, pp. 6471.
Zoja L., Nascere non basta, Cortina, Milano 1985.
Zuckerman M., Sensation Seeking: Beyond the Optimal Level of Arousal. Erlbaum, Hilisdale -N. J.
1979.