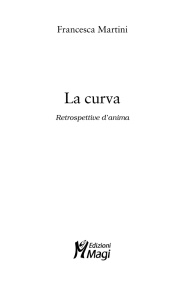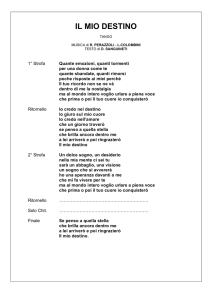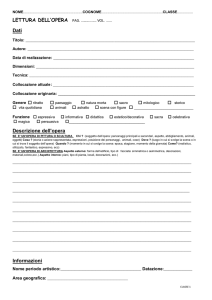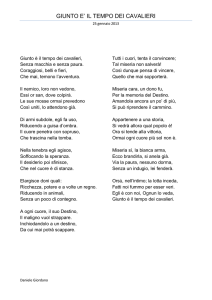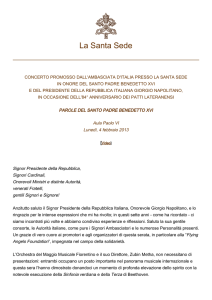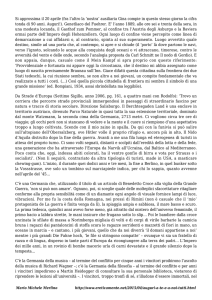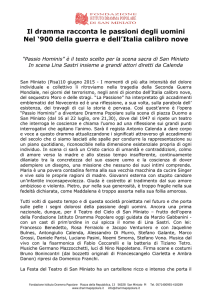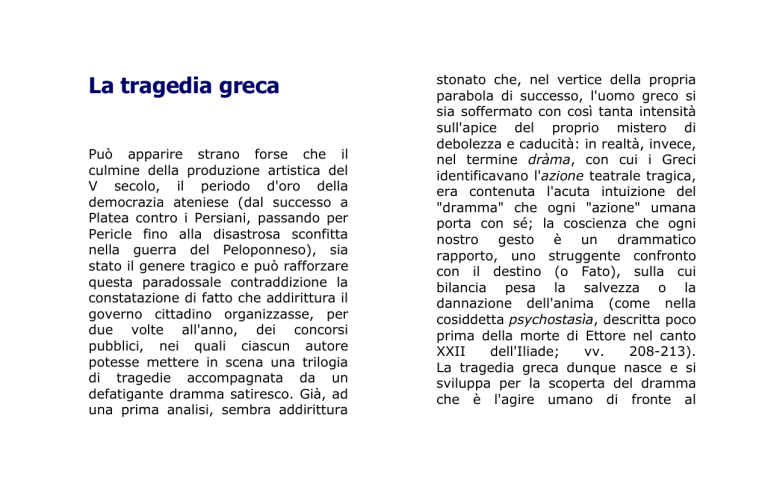
La tragedia greca
Può apparire strano forse che il
culmine della produzione artistica del
V secolo, il periodo d'oro della
democrazia ateniese (dal successo a
Platea contro i Persiani, passando per
Pericle fino alla disastrosa sconfitta
nella guerra del Peloponneso), sia
stato il genere tragico e può rafforzare
questa paradossale contraddizione la
constatazione di fatto che addirittura il
governo cittadino organizzasse, per
due volte all'anno, dei concorsi
pubblici, nei quali ciascun autore
potesse mettere in scena una trilogia
di tragedie accompagnata da un
defatigante dramma satiresco. Già, ad
una prima analisi, sembra addirittura
stonato che, nel vertice della propria
parabola di successo, l'uomo greco si
sia soffermato con così tanta intensità
sull'apice del proprio mistero di
debolezza e caducità: in realtà, invece,
nel termine dràma, con cui i Greci
identificavano l'azione teatrale tragica,
era contenuta l'acuta intuizione del
"dramma" che ogni "azione" umana
porta con sé; la coscienza che ogni
nostro gesto è un drammatico
rapporto, uno struggente confronto
con il destino (o Fato), sulla cui
bilancia pesa la salvezza o la
dannazione dell'anima (come nella
cosiddetta psychostasìa, descritta poco
prima della morte di Ettore nel canto
XXII
dell'Iliade;
vv.
208-213).
La tragedia greca dunque nasce e si
sviluppa per la scoperta del dramma
che è l'agire umano di fronte al
destino misterioso delle cose, un
dramma che scaturisce dall'intrecciarsi
contraddittorio e complesso del canto
del tràgos (il capro immolato, un uomo
nel cui destino si riflette il destino
dell'intera umanità) con la impellente
necessità che le cose vadano come è
prestabilito (l'ineluttabilità del mito).
Come nell'esperienza tragica di Giobbe
e Qoelet, anche i drammaturghi greci
soffermarono la propria riflessione
sull'anelito di bene che muove l'uomo
dentro la vita e sull'inevitabile presa di
coscienza del vanitas vanitatum che è
l'uomo di fronte alla propria incapacità
di determinare il destino ultimo degli
eventi. Il presagio di questa debolezza
diventa,
parallelamente
con
l'esperienza di Giobbe, dapprima una
vera e propria tracotanza (ùbris), la
blasfemia verso gli Dei per il dono
stesso della vita. In un secondo
tempo, proprio per il male nato da
quest'ultima ribellione verso l'esserci
delle cose, l'uomo è spinto a
sovvertirne l'ordine, compiendo il
peccato: chi giacendo nel letto con la
propria madre dopo aver ucciso il
padre (Edipo), chi uccidendo i propri
figli come rivalsa contro il marito
infedele (Medea), chi uccidendo il
proprio marito sulla porta di casa
(Clitemnestra). La scoperta della
propria inaspettata capacità di male e
la ribellione verso l'ordine costituito
sono il nocciolo del tragico e viene
focalizzato dai tragediografi in maniere
diverse: Eschilo interpretò questa
condizione umana dentro la chiave
provvidenziale del pàthei màthos
(apprendere
con
la
sofferenza);
Sofocle intuì in essa la misteriosa
2
possibilità
di
una
rivelazione,
inarrivabile agli occhi umani di Edipo
(nell'Edipo
a
Colono),
e
solo
profeticamente evocata da Isaia nel
canto biblico del servo sofferente (Is,
53, 1-12); Euripide, infine, non vide
possibilità di salvezza dal male umano
se non nella dignità titanica di un eroe
che, come la leopardiana Ginestra,
non ha altra difesa dall'ineluttabile
dolore dalla vita se non nella "social
catena" della
solidarietà
umana.
Nelle sue varie interpretazioni dunque,
al
fondo,
rimane
sempre
la
constatazione che il vivere sia il luogo
dello scontrarsi tra la nostra volontà,
la nostra libertà (come capacità del
bene) e la necessità inevitabile della
morte: medesimo è il dissidio supremo
della vita tra libertà e necessità, tra
desiderio della felicità e destino.
Questo paradosso viene rappresentato
nella
tragedia
attraverso
la
sovrapposizione sulla scena del tempo
del necessario (il già accaduto del
mito),
con
quello
dell'accadere
arbitrario (l'istante in cui l'attore dice
io nel presente dell'avvenimento): in
questa
sovrapposizione
dunque
l'accaduto accade, l'istante è il già
stato e la libertà dell'attore si gioca
nell'obbligo necessario che le cose
vadano,
secondo
copione,
come
prestabilito. Questa è la ragione per
cui, nella rappresentazione non è tanto
importante il cosa accade sulla scena
(perché tutti già lo sanno), ma il
come. Il vero e proprio rito di questo
accaduto che riaccade, sempre nuovo
e sempre uguale, ripropone in scena il
paradigma della condizione umana: se
la vita, infatti, è un destino già deciso
3
dalla necessità della morte, come può
un uomo essere libero? E come può
guadagnarsi la felicità dentro il
doloroso cammino di ogni giorno?
La "messa" in scena è dunque una
forma di educazione, che spinge gli
uomini ateniesi al limite del mistero
profondo che è il proprio essere al
mondo - nel successo più florido del
proprio apogeo politico come nel
baratro più cupo della propria caduta
(dopo il 404 a.C.) - e offre un modello
di dignità eroica alla lotta che è la vita,
anche nella coscienza dell'insondabilità
dell'Essere. Il loro sforzo per ascoltare
anche il più flebile bisbiglio dall'Atteso
o per toccare anche solo il lembo della
sua veste rimane per noi, come lo fu
per san Paolo all'Areopago di Atene, la
testimonianza più monumentale e più
audace di un'umanità vera e grande,
conscia del proprio limite di peccato
ma indomita nella propria ricerca e
nella propria sete di verità. Diceva
bene Dante di fronte ai geni della
cultura greca, quando, pieno di carità
nei loro confronti, scrisse: "se possuto
aveste veder tutto, mestier non era
parturir Maria" (Pg, III, 38-39).
Davvero furono così acuti che, se quel
mistero avessero potuto vederlo ad
occhio nudo, non sarebbe stata
necessaria l'Incarnazione.
4
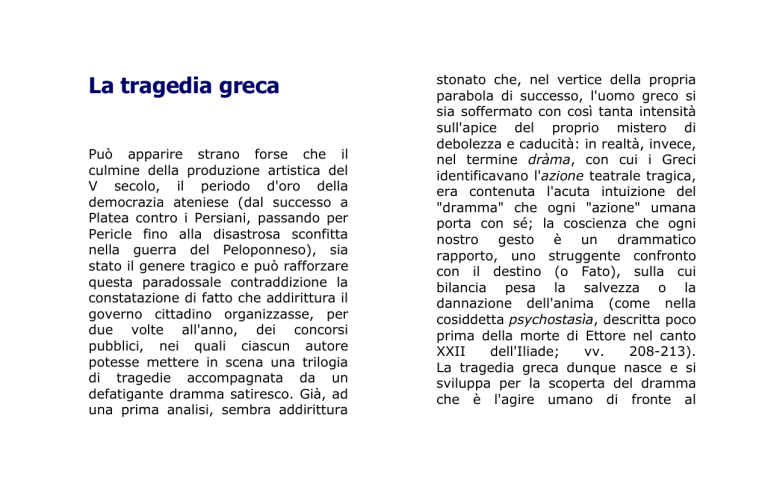
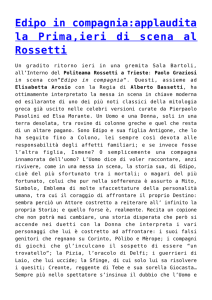
![Musica_e_immagine.pps [modalità compatibilità]](http://s1.studylibit.com/store/data/007566322_1-58d70b56b536a079f8882415348ab4fa-300x300.png)