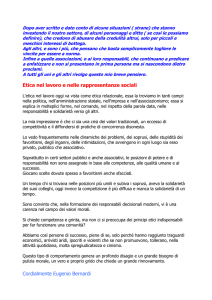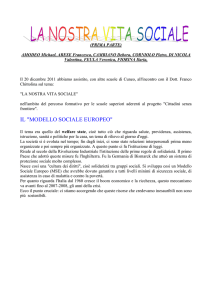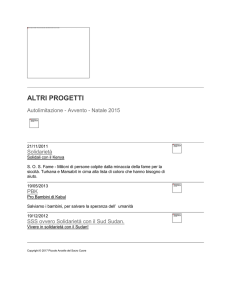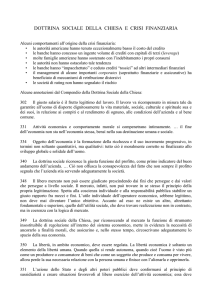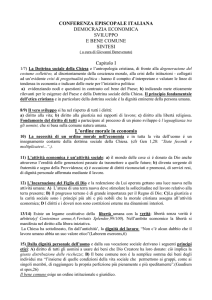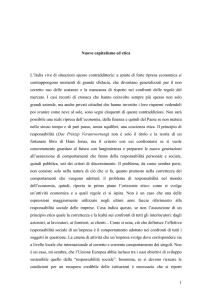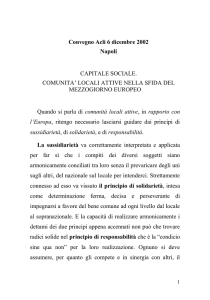Una "grammatica etica" comune, di P. Bartolomeo Sorge
Nessun progetto, nessuna proposta sociale si può elaborare, né tanto meno si può tradurre in
pratica o trasformare in «programma politico», se manca il fondamento di una cultura politica
unanime. A sua volta, non è possibile convergere in una medesima cultura politica, se non c'è
un comune sentire morale, cioè se la maggioranza dei cittadini non è d'accordo su alcuni
Principi e valori etici fondamentali. A sua volta, infine, il comune sentire morale non regge, se
non è sorretto dalla coscienza religiosa.
Più che una tesi teorica da dimostrare, questa affermazione è un'esperienza storica che è
sempre possibile verificare.
Già Benedetto Croce (per citare una insospettabile autorità della cultura laica) riconosceva il
nesso necessario che lega i «programmi» alla «fede morale», cioè la proposta sociale alla
cultura politica, il senso morale al senso religioso. «Il rapporto tra programmi e fede (morale) scrive in un saggio del 1911 - è che questa precede quelli e li genera; e, quando essa manca,
invano si tenta di surrogarla con programmi grandiosi: come un edificio senza fondamenta non
si rafforza coi coronamenti architettonici e con le decorazioni. E’ da vedere, dunque, se i tanti
che si affaticano a costruire programmi non siano mossi dall'illusione di ottenere dall'esterno
quel che sentono di non possedere nell'interno; e, se la cosa sta così, bisogna provvedere
anzitutto, mi sembra, a liberarli (la tale illusione e a spingerli a rafforzare, in sé e negli altri, la
fede». Dunque, «prima la fede (morale) - conclude Croce – poi i programmi, prima l'amino
pronto, poi il braccio vigoroso». (B. CROCE, Cultura e vita morale, cap. XXII: Fede e
programmi, Laterza, Bari 1955, 161.166).
Tuttavia - prosegue il Filosofo partenopeo -, a sua volta, la “fede morale” si mantiene salda
solo se è sostenuta da un habitus religioso. Questa ammissione, fatta da un laico come Croce è
molto importante, nonostante che egli abbia una concezione meramente naturalistica della
religione, che lo porta a considerare tutte uguali tra loro le religioni positive e a metterle quindi
tutte sul medesimo piano.
In ogni modo, dopo aver richiamato l’importanza della religione, egli conclude così la sua
riflessione: «l’abito religioso è perciò immortale; ed esso fa d’uopo coltivare negli animi,
perché si mantenga salda ed efficace la fede morale». Croce, però, si rende conto quanto sia
difficile coltivare il senso religioso e pensa che non molti vi riusciranno; Si chiede perciò: «Una
disposizione d’animo come questa sarà di pochi, almeno in forma coerente e cosciente?» E
risponde: «Pochi o molti, non importa [...]. I programmi di azione seguiranno, e dovranno
seguire perché una religiosità e una fede morale che non si concretassero in azione sarebbero
falsa religiosità e falsa fede, parolaie e non reali». Se, invece, le proposte sociali poggeranno
su una comune cultura etica, fondata sul senso religioso - conclude Croce -, esse realmente
«saranno allora programmi e non fatuità, animati e non inanimati, pensieri seri e non trastulli
d'immaginazioni oziose».(ivi, 167s).
Non diversamente conclude Giovanni XXIII, in piena continuità con l'insegnamento tradizionale
della Chiesa: «L’ordine morale non si regge che in Dio: scisso da Dio si disintegra. L’uomo
infatti non è solo un organismo materiale ma è anche spirito dotato di pensiero e di libertà.
Esige quindi un ordine etico-religioso, il quale incide più di ogni valore materiale sugli indirizzi e
le soluzioni da dare al problemi della vita individuale e associata nell'interno delle comunità
nazionali e nei rapporti tra esse» (GIOVANNI XXIII, Mater et magistra, n. 208).
Giovanni Paolo Il ritorna con forza sull'esistenza di un nesso imprescindibile tra vita sociale e
cultura, tra morale e religione. Sono realtà - egli conclude - che o stanno insieme o cadono
insieme. Oggi la crisi sociale - rileva il Papa – è gravissima ma, proprio per questo, essa
produce come reazione un bisogno sempre più diffuso e acuto di rinnovamento innanzi tutto
culturale e morale; infatti - egli scrive -, «come la storia e l'esperienza di ciascuno insegnano,
non è difficile ritrovare alla base di queste situazioni cause propriamente ‘culturali' [...]. In
realtà, al cuore della questione culturale sta il senso morale, che a sua volta si fonda e si
compie nel senso religjoso» (GIOVANNI PAOLO II, Veritatis splendor, n. 98).
Così, cultura laica e cultura cristiana coincidono sulla necessità di dare un'anima etica e
culturale alla economia, alla politica e alla vita civile, se si vuole che il nuovo progetto di
società, richiesto dalla presente crisi di transizione, risponda effettivamente a una visione
integrale e trascendente dell'uomo. Su questo punto Giovanni Paolo Il è tornato con forza nel
suo discorso all'ONU, nel cinquantesimo di fondazione: «Non viviamo in un mondo irrazionale o
privo di senso ma, al contrario, vi è una 'logica' morale che illumina l'esistenza umana e rende
possibile il dialogo tra gli uomini e tra i popoli»; quindi il Papa ha aggiunto: «Se vogliamo che
un secolo di 'costrizione' lasci spazio a un secolo di 'persuasione', dobbiamo trovare la strada
per discutere, con un linguaggio comprensibile e comune, circa il futuro dell'uomo. La legge
morale universale, scritta nel cuore dell'uomo, è quella sorta di 'grammatica' che serve al
mondo per affrontare questa discussione circa il suo stesso futuro».(GIOVANNI PAOLO II,
Discorso all’ONU del 5 ottobre 1995, n. 3).
Nel contesto di questo bisogno largamente avvertito, la Chiesa oggi avanza la sua «proposta
sociale», indicandone alcuni principi e valori fondamentali, nonché alcuni criteri generali di
giudizio, e offrendo determinati orientamenti operativi.
Si tratta di «indicazioni» che mentre, da un lato, si ispirano al Vangelo, dall'altro, sono
pienamente conformi alla retta ragione e aperte al contributo e a integrazioni da parte degli
uomini di buona volontà. Una sorta, appunto, di «grammatica etica» comune, da cui partire
tutti per costruire insieme.
1. Il principio personalista Il primo principio, su cui fondare una comune cultura etica e politica,
al fine di costruire insieme la nuova società, è certamente il primato della persona umana.
L'uomo, cioè vale per quello che è, non per quello che ha o che fa. E questa la prima regola
d'una «grammatica etica».
Riconoscere questo primato significa accettare, in via teorica e pratica, che la persona umana
(uomo e donna) con la sua dignità trascendente è «l’autore, il centro e il fine di tutta la vita
economico-sociale».(GS 63).
Su questo punto, oggi, dopo tante divagazioni del pensiero moderno, si può dire che la
coscienza dell'umanità sia sostanzialmente unanime: «Credenti e non credenti - rileva lo
stesso Concilio - sono pressoché concordi nel ritenere che tutto quanto esiste sulla terra deve
essere riferito all'uomo, come a suo centro e a suo vertice».(ivi 12).
La rivelazione cristiana viene a dare stabilità e a rafforzare questa conquista della retta
ragione, insegnando «che l'uomo è stato creato 'a immagine di Dio', capace di conoscere e di
amare il Proprio Creatore, e che fu costituito da Lui sopra tutte le creature terrene quale
signore di esse, per governarle e servirsene a gloria di Dio»'. (ivi). Il senso religioso, quindi,
fonda e sorregge il senso morale.
Giovanni XXIII descrive efficacemente così il ruolo di questo principio personalista, oggi
universalmente accettato: «In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il
principio che ogni essere umano è persona, cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà
libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e
simultaneamente dalla sua stessa natura; diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili,
inalienabili» (GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 9).
Tuttavia, affermare che «l'uomo è anteriore allo Stato» (LEONE XIII, Rerum novarum, n. 6)
significa accettare realmente che al centro del sistema vi sia la persona umana con i suoi diritti
e con i suoi doveri, a cominciare dal diritto alla vita, che è il fondamento di tutte le libertà
fondamentali dell'uomo: la libertà di pensiero e di coscienza, di educazione e di associazione,
compresi il diritto al lavoro e tutti gli altri diritti civili.
Da questo primo principio derivano due fondamentali criteri di giudizio, universalmente validi.
Il primo è che sia lo Stato, sia la società dovranno perseguire il bene comune, subordinandolo
sempre alla piena realizzazione della persona. La società e lo Stato, quindi, possono sì disporre
dell'attività della persona per il raggiungimento dei fini comuni, ma non possono mal disporre
della persona stessa, né della vita dell'uomo, essendo questa il fondamento di tutti gli altri
diritti. I limiti morali e giuridici che ne derivano non mortificano perciò né i pubblici poteri, né
lo sviluppo, né il progresso della ricerca scientifica, ma sono semplicemente una garanzia di
civiltà. La persona umana infatti ha in sé valore di fine e non potrà mal, in nessun caso e per
nessuna ragione, essere considerata e trattata come una cavia.
Un secondo importante criterio di giudizio sta nel fa che neppure la stessa persona umana può
rinunciare, senza grave colpa morale, alla sua dignità trascendente; l'uomo stesso, infatti, non
la crea, ma la riceve da Dio e da natura. Perciò, la persona umana medesima sottostà a limiti
etici precisi nell'esercizio del diritto di disporre della propria vita.
A maggior ragione lo Stato e la società non potranno mai violare questi limiti etici, a cui è
soggetta la persona stessa. Ciò significa che sperimentazioni, mutilazioni e rischi terapeutici
dagli effetti devastanti e irreparabili, sproporzionati alla parvità della causa, l'eutanasia (o
«morte dolce») e interventi illeciti sui processi della vita fisica non sono moralmente
ammissibili (né si potranno legalizzare) neppure in presenza dell'eventuale consenso volontario
dell'interessato.
In altre parole, in virtù del principio che la persona e la sua vita sono un assoluto etico, occorre
respingere l'idea positivistica oggi molto diffusa, secondo cui ciò che è scientificamente
possibile sia per ciò stesso moralmente lecito.
Ecco perché, pur volendo prescindere dalla discussione filosofica se l'embrione sia o non sia
una persona umana, v no dichiarate moralmente illecite - alla pari dell'aborto - la produzione
in vitro di embrioni destinati alla ricerca o: so industriale, sia la generazione multipla di esseri
umani geneticamente identici (ricorrendo a fissione gemellare clonazione), sia la produzione di
ibridi (uomo-animale), tre forme di manipolazione genetica.
Insomma, la vita umana e la sua dignità trascendente sono ontologicamente e moralmente
inseparabili, dal primo al timo momento dell'esistenza. La vita umana è un continuum. Una
volta suscitata, dopo che è scoccata la prima scintilla, nessuno può più interromperla, per
nessuna ragione: né all’inizio, né durante il suo svolgimento, né alla fine, anche nell'ipotesi
«filosofica» (in sé inaccettabile) che l'embrione venti persona solo a partire da un certo
momento de sviluppo.
2. Il principio di solidarietà
Il primato assoluto della persona umana, però, non solo non contrappone l'individuo alla
società, ma anzi scorge nell’individuo il fondamento stesso della socialità. La società cioè viene
dopo la persona e in funzione della persona. La Società, anzi, nasce dalla persona; è una sua
risultante. E’ questa una seconda regola fondamentale della nostra «grammatica etica».
Infatti, la persona esiste e si realizza sempre in società; l’uomo è un essere insieme individuale
e sociale: «Fin da principio - tiene a sottolineare il Concilio – ‘uomo e donna (Dio) li creò’ e la
loro unione costituisce la prima forma di comunione di persone. L'uomo, infatti, per la sua
intima natura è un essere sociale, e senza i rapporti con gli altri non Può Vivere né esplicare le
sue doti» (GS 12).
Su questa essenziale socialità della persona si fonda, innanzi tutto, la piena uguaglianza di
diritti e di dignità tra l'uomo e la donna. Maschio e femmina sono due modi di esser “uomo”».
L’immagine di Dio si rivela insieme nell'uomo e nella donna: «Dio creò l'uomo a sua immagine;
a immagine creò» (Gen 1,27). Commenta Giovanni Paolo II: «L’uomo è una persona, in eguale
misura l'uomo e la donna: ambedue, infatti, sono stati creati a immagine e somiglianza del Dio
personale. [....] Possiamo comprendere ancora più pienamente in che cosa consista il carattere
personale dell'essere umano, grazie al quale ambedue - l'uomo e la donna - sono simili a Dio».
E conclude: «Nella 'unità dei due' l'uomo e la donna sono chiamati sin dall'inizio non solo a
esistere 'uno accanto all'altra' oppure insieme, ma sono anche chiamati a esistere
reciprocamente l'uno per l'altro».(GIOVANNI PAOLO II, Mulieris dignitatem, nn. 6-7)
Questa complementarità personale costituisce il primo cerchio della socialità dell'uomo: la
famiglia. Ma anche il secondo cerchio - quello della società civile - si radica nella persona, non
meno della famiglia. La società civile non è esterna alla persona, neppure le è superiore; né, a
sua volta, la persona può esistere al di fuori o al di sopra della società. La società infatti è
«personale», e la persona è «sociale». «Dall'indole sociale dell'uomo - conclude perciò il
Concilio - appare evidente come il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della
stessa società siano tra loro interdipendenti. Infatti, principio, soggetto e fine di tutte le
istituzioni sociali è e deve essere la persona umana, come quella che di sua natura ha
sommamente bisogno di socialità. Poiché la vita sociale non è qualcosa di esterno all'uomo,
l'uomo cresce in tutte le sue doti e può rispondere alla sua vocazione attraverso i rapporti con
gli altri, i mutui doveri, il colloquio con i fratelli» (GS 25).
Ancora una volta, il senso religioso rafforza ciò che la retta ragione afferma e la aiuta a
comprendere. E sia la ragione sia la religione traggono da questa intrinseca socialità della
persona un secondo fondamentale principio etico comune: il principio di solidarietà.
Nel discorso sociale della Chiesa, la maturazione di questo principio è andata di pari passo con
l'evolvere della «questione sociale». Sarà Pio XI a riprendere l'insegnamento di Leone XIII e a
mostrare che, come la persona ha una intrinseca dimensione sociale, così pure il diritto di
proprietà privata, strumento essenziale per tutelare la libertà della persona, ha una sua
intrinseca dimensione sociale; è il principio di solidarietà che, da un lato, impedisce di cadere
negli estremi opposti del collettivismo e dell'individualismo e, dall'altro, induce a «temperarne
l'uso (del diritto di proprietà) e armonizzarlo con il bene comune» (PIO XI, Quadragesimo
anno, n. 54).
Il discorso della Chiesa sulla solidarietà poi, evolvendo la questione sociale, continua ad
ampliarsi: si è passati così dalla natura intrinsecamente sociale della persona, alla dimensione
sociale della proprietà privata, alla solidarietà come esigenza intrinseca della universale
destinazione dei beni, alla solidarietà come valore in sé, come coscienza e virtù morale,
necessaria per dare dimensione umana all'interdipendenza che oggi unisce tra loro uomini e
nazioni.
Dunque, il «salto» dalla solidarietà della Rerum, novarum di Leone XIII a quella definita dalla
Sollicitudo rei socialis di Giovanni Paolo II è grande. Oggi - rileva il Papa - in seguito alla
«crescente consapevolezza della interdipendenza tra gli uomini e le nazioni», la solidarietà si è
«trasformata in C(Scienza e ha acquistato cosi connotazione morale». A questo punto, la
solidarietà non può più essere scambiata con «un sentimento di vaga compassione o di
superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la
determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di
tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti» (GIOVANNI PAOLO II,
Sollicitudo rei socialis, n. 38).
Anzi, la solidarietà si trasforma in strumento efficace di liberazione. Come dimostra la storia
dei profondi cambiamenti avvenuti nel 1989, «decisiva, per la riuscita di quelle rivoluzioni non
violente fu l'esperienza della solidarietà sociale: di fronte a regimi sostenuti dalla forza della
propaganda e del terrore, quella solidarietà costituì il nucleo morale dei 'potere dei non
potenti'» (GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’ONU del 5 ottobre 1995, n. 4).
A questo punto, il principio di solidarietà, già di per sé naturalmente condivisibile dalla retta
ragione e da tutti gli uomini di buona volontà, trova il suo sostegno nella coscienza religiosa.
Conie il senso religioso rafforza la coscienza della dignità trascendente della persona,
scorgendo in essa l'immagine stessa di Dio, parimenti il senso religioso rafforza pure la
coscienza naturale della solidarietà, trasformandola da filantropia in carità. Ancora una volta nota Giovanni Paolo II - appare dunque «l'importanza di risvegliare la coscienza religiosa degli
uomini e dei popoli», al fine di realizzare una società a misura dell’uomo (GIOVANNI PAOLO II,
Sollicitudo rei socialis, n. 39).
E difatti, «alla luce della fede, la solidarietà tende a superare se stessa, a rivestire le
dimensioni specificamente cristiana della gratuità totale, dei perdono e della riconciliazione.
Allora il prossimo non è soltanto un essere umano con i suoi diritti e la sua fondamentale
uguaglianza davanti a tutti, ma diviene la viva immagine di Dio Padre, riscattata dal sangue di
Gesù Cristo e posta sotto l'azione permanente dello Spirito Santo. Egli, pertanto, deve essere
amato, anche se nemico, con lo stesso amore con cui lo ama il Signore e per lui bisogna essere
disposti al sacrificio anche supremo: 'dare la vita per i propri fratelli'»; in una parola, la
solidarietà cristiana costruisce la comunità e porta alla «comunione» fraterna (ivi, n. 40).
Nella pratica, la carità - cioè la solidarietà potenziata dal senso religioso - spinge a compiere
scelte coraggiose e anche eroiche per il bene altrui (specialmente degli «ultimi»), fino alla
condivisione volontaria della indigenza, per aiutare i poveri a essere gli artefici della propria
elevazione. Nello stesso tempo, la solidarietà in certo senso completa e rende più umana la
giustizia.
Questa visione trascendente della solidarietà fa da sfondo a tutti gli orientamenti concreti che il
discorso sociale della Chiesa suggerisce. La Chiesa è convinta che soltanto la solidarietà può
essere il cemento di quella società più giusta e più fraterna che tutti auspichiamo. Infatti, come
spiega Giovanni Paolo II in due densi paragrafi dell'enciclica Sollicitudo rei socialis, la
solidarietà è il fondamento della concordia sociale, sia all'interno di ogni società, sia nelle
relazioni internazionali; a tal punto che, come ieri si poté definire la pace come frutto della
giustizia (opus iuxtitiae pax), così oggi noi possiamo dire che la pace è frutto della solidarietà
(opus solidaritatis pax) .(ivi, n. 39).
Anche da questo principio di solidarietà derivano per l'azione sociale e politica alcuni importanti
criteri di giudizio. Il Concilio ne richiama specialmente tre: in primo luogo, «Siano anzitutto
adempiuti gli obblighi di giustizia, perché non avvenga che si offra come dono di carità ciò che
è già dovuto a titolo di giustizia»; in secondo luogo, «si eliminino non soltanto gli effetti, ma
anche le cause (strutturali) dei mali»; infine, «l’aiuto sia regolato in tal modo che coloro i quali
lo ricevono vengano, a poco a poco, liberati dalla dipendenza altrui e diventino sufficienti a se
stessi» (Apostolicam actuositatem, n. 8).
Perché laici e cattolici non dovrebbero coincidere sulla validità di questi criteri operativi e sul
principio etico che li fonda?
3. Il principio di sussidiarietà
Il terzo principio fondamentale di una necessaria cultura etica comune è quello dl sussidiarietà.
Come la persona viene prima della società, così la società viene prima dello Stato. E’ questo un
punto centrale del pensiero sociale della Chiesa e della tradizione del cattolicesimo sociale.
Basti qui citare un testo classico con il quale don Sturzo si riallaccia appunto a tutto il pensiero
sociale cristiano.
«Per noi - egli disse al IV Congresso nazionale del Partito Popolare (Torino, 12 aprile 1923) - lo
Stato è la società organizzata politicamente per raggiungere fini specifici; esso non sopprime,
non annulla, non crea i diritti naturali dell'uomo, della famiglia, della classe, dei comuni, della
religione; solo li riconosce, li tutela, li coordina nei limiti della propria funzione politica. Per noi
lo Stato non è il primo etico, non crea l'etica, ma la traduce in leggi e le conferisce forza
sociale; per noi lo Stato non è libertà, non è al di sopra della libertà: la riconosce, la coordina e
ne limita l'uso, perché non degeneri in licenza. Per noi lo Stato non è religione- esso la
rispetta, ne tutela l'uso dei diritti esterni e pubblici. Per noi la nazione non è un ente spirituale
assorbente la vita dei singoli; è il complesso storico di un popolo uno, che agisce nella
solidarietà della sua attività, e che sviluppa le sue energie negli organismi nel quali ogni
nazione civile è ordinata» (L. STURZO, Il Partito Popolare Italiano, vol. II: Popolarismo e
fascismo (1924), Zanichelli, Bologna 1956; 107).
Il rapporto dinamico tra società e Stato si fonda quindi sul principio di sussidiarietà: i mondi
vitali, le classi, i comuni, le province e le regioni sono gli organi naturali della società. Ognuno
di questi organi ha le sue caratteristiche, la sua autonomia, la sua ragion d'essere che va
rispettata da tutti. La solidarietà dinamica di questi organi tra di loro e in vista del bene
comune fa si che le istituzioni dello Stato, rinnovandosi, siano sempre espressione adeguata
della società e delle sue esigenze.
Come dicevamo già del principio di solidarietà, dobbiamo dire che anche il principio di
sussidiarietà ha subito una notevole evoluzione dai giorni di Pio XI ai nostri.
Pio XI fu il primo a enunciare il principio di sussidiarietà: «Deve restare saldo questo principio
importantissimo della filosofia sociale -scrive nella Quadragesimo anno -: come è illecito
sottrarre agli individui ciò che essi possono compiere con le proprie forze e di loro iniziativa per
trasferirlo alla comunità, così è ingiusto affidare a una maggiore e più alta società quello che le
minori e inferiori comunità possono fare. E’ questo, insieme, un grave danno e uno
sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento
della società stessa è di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già di
distruggerle o di assorbirle» (QA n. 86s.).
La preoccupazione di Pio XI era quella di condannare la prepotenza dei regimi totalitari (del
comunismo, del fascismo e dell'incipiente nazismo); ciò spiega perché egli applichi il principio
di sussidiarietà soprattutto alla vita sociale, e lo faccia in termini prevalentemente negativi.
Mutato poi il contesto storico, la Chiesa non mancherà di estendere l'applicazione del principio
di sussidiarietà pure all'intervento dello Stato in economia (cf GIOVANNI XXIII, Mater et
magistra, nn. 51-58, con particolare riguardo allo sviluppo regionale, n. 152) e ai rapporti
internazionali (cf ID, Pacem in terris, n. 141).
Il Concilio, dal canto suo, insiste nell'applicare il medesimo principio al retto funzionamento
dello Stato sociale: i cittadini, da soli o associati, hanno il diritto e il dovere di partecipare
attivamente alla cosa pubblica; perciò, da un lato, «si guardino i governanti dall'ostacolare i
gruppi familiari, sociali o culturali, i corpi o istituti intermedi, né li privino della loro legittima ed
efficace azione, che al contrario devono volentieri e ordinatamente favorire»; d'altro lato, però,
«si guardino i cittadini singolarmente o in gruppo, dall'attribuire troppo potere all'autorità
pubblica, né chiedano inopportunamente a essa eccessivi vantaggi, col rischio di diminuire così
la responsabilità delle persone, delle famiglie e dei gruppi sociali» (GS 75).
In altre parole: lo Stato assistenziale, la burocrazia elefantiaca, il centralismo che soffoca le
autonomie locali sono da considerare deviazioni patologiche della società, e contrastano
apertamente con il principio di sussidiarietà.
Questa terza grande regola della «grammatica etica» comune non si può violare impunemente,
specialmente in una società complessa e policentrica, come l'attuale. Ogni volta che,
contravvenendo al principio di sussidiarietà, si assegnano allo Stato compiti che potevano
essere lasciati a livelli intermedi e decentrati della pubblica amministrazione o che avrebbero
potuto essere gestiti dalla società civile (senza escludere l'aiuto e il supporto dello Stato), non
si fa che spianare la via alla illegalità e alla corruzione. Queste, infatti, prosperano quando la
burocrazia cresce oltre misura e si carica di compiti troppo ampi e costosi.
Uno Stato a misura d'uomo dovrà invece basarsi sul primato della società civile, promovendo e
responsabilizzando l'associazionismo, la cooperazione, il volontariato. Perciò - conclude
Giovanni Paolo Il - «anche in questo ambito deve essere rispettato il principio di sussidiarietà:
una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine
inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e
aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene
comune» (GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 48).
4. Il principio del bene comune
Infine c'è un quarto grande principio, che in certo senso risulta dal rispetto degli altri tre, li
coordina e li realizza tutti insieme: è il principio del bene comune.
Tutti ne parlano, tutti lo invocano, ma molto spesso se ne dà una interpretazione riduttiva.
Una prima concezione - quella liberale classica - riduce il bene comune a una questione
privata. Ogni individuo deve pensare a se stesso, realizzarsi come meglio può, cercare di
raggiungere i fini che liberamente si propone. Nessuno glielo può impedire. La categoria della
«felicità» sarebbe essenzialmente personale e non avrebbe nulla che vedere con la categoria
della «solidarietà». Il bene comune, perciò, non sarebbe altro che la somma dei beni
individuali. Un gregge a pascolo - è stato scritto - raggiungerà il suo bene comune quando ogni
pecora avrà brucato liberamente, ciascuna per proprio conto, la quantità e la qualità di erba
che vuole. Il pastore (lo Stato) dovrà solo vigilare che nessuno glielo impedisca.
In una simile concezione, manca il riferimento alla dimensione etica obiettiva e trascendente
del bene comune. Infatti, non è solo questione di bene individuale. Esiste pure un «bene» che
è -nello stesso tempo - di ciascuno e di tutti; un bene indivisibile, che solo si può ottenere con
l'impegno comune, perché nello stesso tempo trascende e realizza il bene personale di
ciascuno. Come spiega Giovanni XXIII, questo bene comune «si concreta nell'insieme di quelle
condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani lo sviluppo integrale della
loro persona» (GIOVANNI XXII, Mater et magistra, n. 65). Dunque, il primato della persona è
essenziale anche nel bene comune, che però si può realizzare solo in società.
Infatti, la persona - come abbiamo visto - è intrinsecamente «sociale». Ciò significa che la
società umana non è paragonabile a un gregge di animali giustapposti gli uni agli altri! E’ una
comunità. C'è quindi una stretta connessione tra il bene della persona e il bene degli altri. E se
talvolta, come spesso accade, il «mio» bene (o quello di una categoria di cittadini) viene a
conflitto con il bene «tuo» (o di un'altra categoria di cittadini), vuol dire solo che c'è qualcosa
da correggere o qualche ostacolo da rimuovere; i conflitti «sociali» non si risolvono mai
attraverso il sopruso del più forte sul più debole, ma ricercando d'accordo il bene comune.
Purtroppo anche nelle democrazie più evolute - lamenta con realismo Giovanni Paolo Il - «le
domande che si levano dalla società a volte non sono esaminate secondo i criteri di giustizia e
di moralità, ma piuttosto secondo la forza elettorale o finanziaria dei gruppi che le sostengono.
[...] Ne risulta la crescente incapacità di inquadrare gli interessi particolari in una coerente
visione del bene comune. Questo infatti non è la semplice somma degli interessi particolari, ma
implica la loro valutazione e composizione fatta in base a un'equilibrata gerarchia di valori e, in
ultima analisi, a un'esatta comprensione della dignità e dei diritti della persona»" (GIOVANNI
PAOLO II, Centesimus annuns, n. 47).
Un'altra concezione riduttiva - opposta a quella liberale classica - è la visione collettivistica,
secondo la quale il ben comune invece riassorbe in sé ogni finalità sociale, a tal punto da
ignorare il carattere personale del bene stesso. Il collettivismo, in luogo dell'individuo, pone la
classe, il partito, lo Stato. Anche questa erronea visione del bene comune prescinde da
considerazioni di natura etica e spirituale. Il bene comune starebbe essenzialmente nella
maggiore produzione di beni, nel benessere economico, nei servizi forniti dallo Stato, senza
preoccuparsi della conseguente spersonalizzazione dei cittadini, ridotti a numero, livellati
attraverso una uguaglianza forzata e fittizia, che non tiene conto delle doti, delle esigenze,
della creatività di ciascuno.
Ora, sulla base appunto degli altri principi enunciati (il primato della persona, la solidarietà, la
sussidiarietà), una concezione adeguata del bene comune ha un respiro ben più ampio:
certamente comprende tutte le condizioni di vita materiale che si richiedono al
perfezionamento della vita umana, ma nello stesso tempo non può fare a meno di aprirsi ad
altri «beni» altrettanto essenziali per una vita veramente «umana», quali sono l'arte, la
cultura, l'educazione, la contemplazione, la dimensione spirituale e religiosa.
Il nostro tempo ne è consapevole: «Cresce la coscienza - nota il Concilio - della esimia dignità
della persona umana superiore a tutte le cose, e i cui diritti e doveri sono universali e
inviolabili. Occorre, perciò, che siano rese accessibili all’uomo tutte quelle cose che sono
necessarie a condurre una vita veramente umana, come il vitto, il vestito, l'abitazione, il diritto
a scegliersi liberamente lo stato di vita e a fondare una famiglia, all'educazione, al lavoro, al
buon nome, al rispetto alla necessaria informazione, alla possibilità di agire secondo il retto
dettato della sua coscienza, alla salvaguardia della vita privata e alla giusta libertà anche in
campo religioso» (GS 26).
Il bene comune, insomma, coincide soprattutto con la qualità della vita umana, più che con la
quantità delle disponibilità materiali. Pertanto si deve concludere che una concezione adeguata
del bene comune - dice Giovanni Paolo Il - esige, in primo luogo, il rispetto per l'ambiente
(«Non si può fare impunemente uso delle diverse categorie di esseri, viventi o inanimati,
animali, piante, elementi naturali, come si vuole, a seconda delle proprie esigenze
economiche»); richiede, in secondo luogo, la moderazione nell'uso delle risorse naturali
(«Usarle come se fossero inesauribili, con assoluto dominio, mette seriamente in pericolo la
loro disponibilità non solo per la generazione presente, ma soprattutto per quelle future»);
infine, una visione adeguata del bene comune impone la dovuta attenzione alla qualità della
vita, messa in pericolo soprattutto da un certo tipo di sviluppo disordinato, il cui risultato - lo
sappiamo tutti - «è, sempre più di frequente, la contaminazione dell'ambiente, con gravi
conseguenze per la salute della popolazione» (GIOVANNI PAOLO II, Sollicitudo rei socialis, n.
34).
Non solo. Il carattere essenzialmente «qualitativo» (morale e spirituale) del bene comune
impone che esso ormai venga tutelato e perseguito a livello planetario: la crescente
interdipendenza universale fa sì che ormai un singolo Stato non sia più in grado di garantire da
solo il bene comune. Siamo divenuti cittadini del mondo (cf GIOVANNI XXIII, Pacem in terris,
nn. 70-79).
Si aprono, dunque, capitoli nuovi ancora tutti da scrivere: come quello sul dovere di
«ingerenza umanitaria», introdotto da Giovanni Paolo II, di fronte a violazioni del bene comune
e dei diritti umani, che trascendono le possibilità di una sola nazione e interpellano la coscienza
e la comunità internazionale. E che dire di altri problemi di bene comune che (come quello
della salvaguardia dell'ambiente) ormai si possono affrontare e risolvere solo a livello
planetario: dalla tutela delle minoranze, ai flussi non più contenibili delle migrazioni, ai mercati
della droga e della mafia, alla lotta contro l’AIDS, alla necessità di fondare in modo nuovo lo
sviluppo e la pace?
Anche in tutti questi casi, le acquisizioni della retta ragione, che oggi consentono una visione
più comprensiva del bene comune, non possono che essere rafforzate dall'incontro con la
coscienza religiosa: il limite posto dal Creatore all'uso dei beni - commenta Giovanni Paolo Il -,
espresso simbolicamente con la proibizione di «mangiare il frutto dell'albero» (cf. Gen 2,16s.)
«mostra con sufficiente chiarezza che, nei confronti della natura visibile, siamo sottomessi a
leggi non solo biologiche, ma anche morali, che non si possono impunemente trasgredire»
Concludendo, dobbiamo dire che oggi non solo è possibile, ma è necessario e auspicabile, che
si realizzi l'incontro tra cultura cristiana e cultura laica, tra senso morale e senso religioso,
intorno ai principi fondamentali di una «grammatica etica comune» aperta a Dio. Infatti, solo
movendo dal primato della persona umana, condividendo la necessità della solidarietà,
ricercando il sussidio della partecipazione responsabile di tutti e perseguendo il bene comune
nella sua accezione più ampia sarà possibile dare una risposta alle grandi sfide che il XX secolo
ci lascia in eredità.
Queste si possono ricondurre sostanzialmente a due: «correggere» il capitalismo, creando una
società del lavoro libero, dell’impresa e della partecipazione; «correggere» lo Stato sociale in
crisi, coniugando efficienza con solidarietà. In una parola, si tratta di dare un'anima etica
all'era tecnologica, affinché la nuova società del XXI secolo nasca come «Civiltà dell’amore».