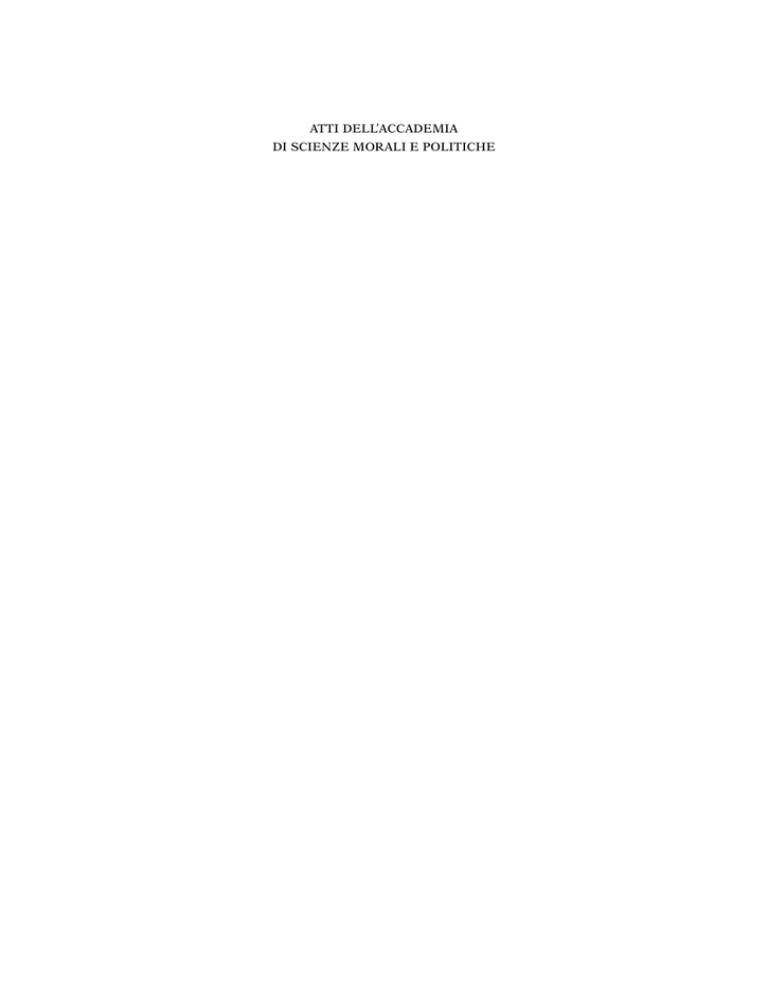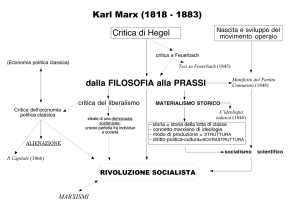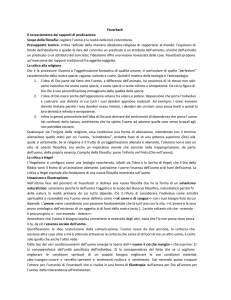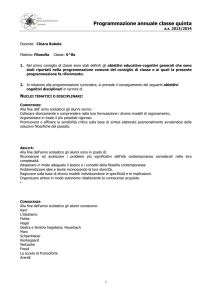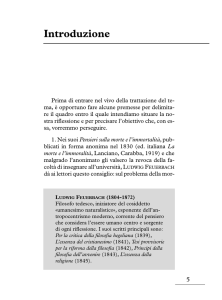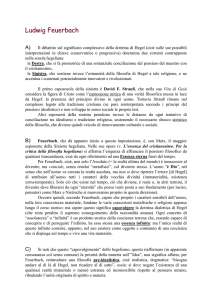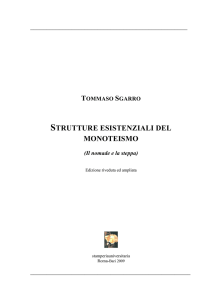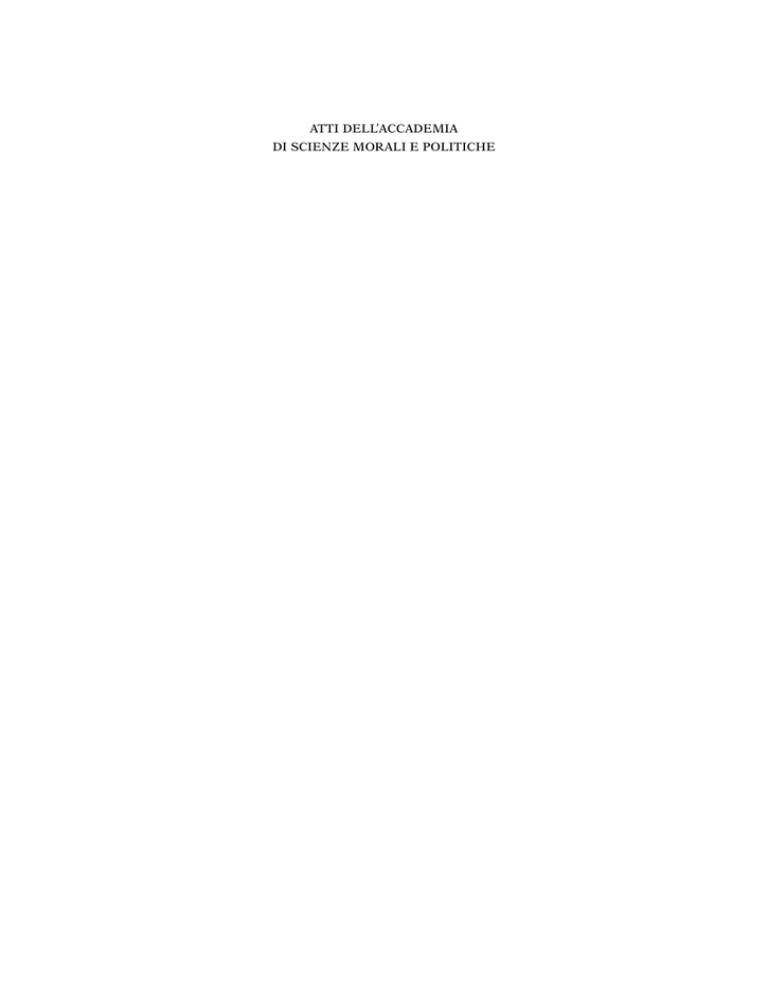
Atti dell’accademia
di scienze morali e politiche
Società nazionale di scienze, lettere e arti in napoli
Atti dell’accademia
di scienze morali e politiche
volume CXX - anno 2010
Giannini editore
napoli 2010
Con il contributo della Regione Campania e del Ministero dei Beni Culturali
Direttore responsabile: accademico Aldo Trione
L’Editorial Board della rivista è composto da tutti i Soci ordinari delle due sezioni
dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche.
Il Comitato di lettura della rivista è composto da tutti i Soci corrispondenti e da
tutti i Soci stranieri delle due sezioni dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche.
ISSN: 1121-9270
ISBN-13: 978-88-7431-513-0
Le memorie presentate per la pubblicazione sono preventivamente sottoposte
a una procedura di blind peer review.
Heidegger e l’urto del deinòn
5
Heidegger e l’urto del deinòn
Memoria di Andrea Della Monica
presentata dal socio naz. ord. res. Aldo Trione
(seduta del 25 marzo 2010)
tà dè pàntha oiakìzei Keraunòs.
(Eraclito, D-K, 22 B 64)
Il fulmine governa l’essente nella sua totalità1.
Abstract. In the age of dominion of Gestell as a global unfolding of technique and concealment of the Being’s inner character of disclosure (aletheùein), man’s works themselves are involved, reduced to mere objects for exhibition and to stimulators of lived
experiences inside the subject. Starting from this, Heidegger’s attempt consists in giving
its dimension back to work of art: no more object – Gegenstand – but Gegenüber, a “being in front of” as subject of exhibition, an opening for breaking out of truth of Being
as deinòn – how Greeks used to name the prodigious. While highlighting the verticality
of this thought as Gelassenheit – Heidegger’s version of ancient thaumàzein – the final
attempt of this work lies in following the line drawn by Peter Sloterdijk, that is making
the kinetic nature of Heidegger’s thought more suited to a horizontalism typical of the
irrevocable technical character of modern age.
1. Terra, opera, lotta
Il 30 ottobre 1955 Martin Heidegger tornò nella sua terra natia, a Meßkirch,
lì dove aveva le sue radici, per tenere un discorso in occasione delle celebrazioni
per il 175° anniversario della nascita del compositore Conradin Kreutzer, suo
conterraneo.
Proprio parole come “terra”, “radici”, “radicarsi” e “radicamento” sono al
centro del discorso heideggeriano, che qui prende il titolo di Gelassenheit, termine dall’eco eckhartiana felicemente tradotto in italiano come Abbandono2.
Scrive Heidegger: «concentriamo la nostra attenzione su questo fatto soltan1 Citiamo la traduzione heideggeriana del frammento presente in M. Heidegger, Heraklit
(1979), trad. di F. Camera, Eraclito, Mursia, Milano 19934, p. 107.
2 M. Heidegger, Gelassenheit (1959), trad. di A. Fabris, L’abbandono, Il melangolo, Genova
19893.
6
Andrea della Monica
to: una creazione dell’arte è sbocciata dal seno della nostra terra». E poco più
avanti:
meditiamo più a fondo e domandiamoci: lo sbocciare di un’opera ben
riuscita non comporta forse il suo radicarsi in seno alla propria terra?
Johann Peter Hebel ha scritto una volta: “Siamo disposti o no ad ammetterlo, noi siamo piante che debbono crescere radicate nella terra, se
vogliono fiorire nell’etere e dare i loro frutti”3.
Nel 1955 la guerra, finita da dieci anni, ha ceduto il posto allo sviluppo economico e tecnologico mondiale sul modello occidentale, quindi allo sviluppo
sempre più rapido dei sistemi di comunicazione su scala planetaria: la radio
è d’uso comune ormai da tempo, il cinema ha passato il giro di boa del mezzo
secolo dalla sua invenzione e la televisione sta prendendo piede come medium
d’intrattenimento di massa. La preoccupazione di Heidegger è evidente.
Ogni ora, ogni giorno, [i tedeschi] seguono incantati le trasmissioni
della radio e della televisione, ogni settimana il cinematografo li porta in
un mondo certamente meraviglioso, ma spesso costituito solo da ambiti
di rappresentazione ordinari, che simulano un mondo che non è un mondo. […] tutto ciò con cui i moderni strumenti tecnici di informazione
ogni ora, incessantemente, sorprendono, incalzano, stimolano la curiosità dell’uomo, è oggi molto più vicino […] del proprio mondo d’origine4.
Cosa comporta, o meglio, a cosa si accompagna la pretesa da parte di «un
mondo che non è un mondo» di essere a noi «molto più vicino» rispetto al nostro «mondo d’origine»? da cosa è caratterizzato per Heidegger l’“oggi” filosoficamente inteso? Dal fatto che «il radicarsi stabile dell’uomo d’oggi nel proprio
terreno è minacciato nell’intimo» e «questa perdita di radici, l’impossibilità
per l’uomo di radicarsi stabilmente nel proprio terreno dipende dallo spirito
dell’epoca in cui tutti noi ci troviamo a vivere»5. Ma noi chi? Noi uomini, che
«possediamo in fondo al nostro essere la capacità di pensare, […] siamo insomma determinati al pensiero». E cosa accade oggi al pensiero? A noi in quanto
esseri pensanti? «Tutti noi ci troviamo abbastanza spesso in una situazione di
povertà di pensiero, tutti noi cadiamo troppo facilmente nell’assenza di pensieIvi, pp. 31-32.
Ivi, pp. 32-33 (corsivo mio).
5 Ivi, p. 33.
3 4 Heidegger e l’urto del deinòn
7
ro. L’assenza di pensiero è un ospite inquietante che si insinua dappertutto nel
mondo di oggi»6. Povertà e assenza di pensiero sono quanto caratterizza la vita
dell’uomo sulla terra nel momento in cui il dominio del mondo da parte della
tecnica minaccia lo stesso radicarsi dell’uomo in quella terra che gli è propria e
dalla quale solamente possono sbocciare opere ben riuscite.
Vent’anni prima di tenere il discorso sopra menzionato, nel 1935, Heidegger aveva iniziato la redazione di un ciclo di tre conferenze sul tema dell’opera
d’arte, tenute l’anno seguente a Francoforte, che sarebbero poi state riunite
e pubblicate, oltre trent’anni dopo, sotto il titolo de L’origine dell’opera d’arte7
all’interno della raccolta di scritti Holzwege.
Heidegger interroga l’arte nella concretezza dell’opera, si chiede cosa sia
l’opera d’arte, ne chiede il “che è”. Seguendo il filo di un discorso che lo porta
a confrontarsi, come spesso accade, con la tradizione metafisica, egli si trova
a dover differenziare l’opera dalla cosa e dal mezzo. Proprio a proposito di
quest’ultimo, apparentemente prendendo ad esempio qualcosa di molto comune, tira in ballo un’opera d’arte figurativa, un quadro di Van Gogh raffigurante
un paio di scarpe da contadino. Il pretesto è quasi banale, il quadro non viene
citato in quanto opera d’arte, ma perché, dal momento che si tratta di descrivere queste scarpe da contadino, dice Heidegger, «può essere utile facilitare la
visione sensibile»8.
Parlando contro l’opera, Heidegger afferma l’impossibilità per l’osservatore
del quadro di cogliere in un tale osservare l’esser-mezzo del mezzo, che, consistendo nell’usabilità, si palesa solo nel campo dove il contadino, in questo caso
la contadina ne usufruisce. Tuttavia…
Nell’orificio oscuro dall’interno logoro si palesa la fatica del cammino percorso lavorando. Nel massiccio pesantore della calzatura è concentrata la durezza del lento procedere lungo i distesi e uniformi solchi
del campo, battuti dal vento ostile. [...] Per le scarpe passa il silenzioso
richiamo della terra […] Questo mezzo appartiene alla terra, e il mondo
della contadina lo custodisce. Da questo appartenere custodito, il mezzo
si immedesima nel suo riposare in se stesso9.
In virtù del mezzo per la contadina si configura e si rende sicuro un mondo,
ella si muove nella stabilità assicurata dal mezzo il cui essere si fa avanti come
Ivi, pp. 28-29.
M. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes in Holzwege (1950), trad. di P. Chiodi, L’origine dell’opera d’arte, in Id., Sentieri interrotti, La nuova italia, Firenze 1968, pp. 3-69.
8 Ivi, p. 18.
9 Ivi, p. 19.
6 7 8
Andrea della Monica
fidatezza [Verlässigkeit]. Siamo così in presenza di ciò che sembrava più improbabile raggiungere per il tramite dell’opera, cioè l’essere del mezzo. Tuttavia ciò
avviene proprio perché non siamo stati noi a raggiungerlo e perché l’opera non
è un tramite.
Che cos’è in opera nell’opera? Il quadro di Van Gogh è l’aprimento di
ciò che il mezzo, il paio di scarpe, è in verità. Questo ente si presenta nel
non-nascondimento [Unverbogenheit] del suo essere. Il non-esser-nascosto dell’ente è ciò che i Greci chiamavano alètheia. Noi diciamo: «verità»
[…], nell’opera è in opera l’evento della verità. Nell’opera d’arte la verità
dell’ente si è posta in opera. […] L’essere dell’ente giunge alla stabilità del
suo apparire. L’essenza dell’arte consisterebbe quindi nel porsi in opera
della verità dell’ente10.
La verità come evento, dunque, che si dà nell’opera come aprimento. Niente
di più lontano dalla concezione dell’opera d’arte come mìmesis, riproduzione del
vero, della verità la cui essenza si dà come omoìosis, adaequatio, corrispondenza.
Al contrario la concezione dell’arte e della verità delineate da Heidegger si
trovano prese nel cammino storico dell’essere che si dà come apertura epocale,
determinandosi in modi differenti nel corso della storia occidentale. Nell’epoca della modernità, in cui la verità come adaequatio raggiunge il suo massimo
dispiegamento, l’ente nella sua totalità si dà come oggettività e con esso fa il
paio l’uomo inteso come soggettività, che anticipa progettualmente l’ente nel
processo conoscitivo. In questo quadro anche l’opera d’arte ci viene incontro
come oggetto. Un quadro viene esposto in un museo, una tragedia greca tradotta e curata nella miglior edizione letteraria: queste opere si trovano poste di
fronte ad un osservatore o ad un lettore, ma il loro esser-oggetti non è il loro
esser-opere. Esse sono private del loro mondo, esso è stato loro sottratto. «La
sottrazione di un mondo o la sua scomparsa non sono fenomeni reversibili. Le
opere non sono più ciò che erano. Sono, sì, esse stesse a venirci incontro, ma
come essenti-state. […] Questo loro star-innanzi è certo ancora una conseguenza dello stare-in-se-stesse di un tempo, ma non è più questo stesso. Lo stare-inse-stesse è dileguato»11.
Ma come si configura un’opera che stia in-se-stessa, che si stagli nel suo
mondo non ancora dileguato? Quale opera renderebbe meglio quest’idea? Hei-
10 11 Ivi, p. 21.
Ivi, p. 26.
Heidegger e l’urto del deinòn
9
degger risponde: un tempio greco. Esso non riproduce nulla, non fa altro che
ergersi in una valle al fine di racchiudere la statua del dio. Questi è presente nel
tempio, in virtù di esso; e una tale presenza dispiega e allo stesso tempo dispone
il limite di una regione che racchiude ciò che è sacro per il popolo, una regione
sacrale.
Il tempio, in quanto opera, dispone e raccoglie intorno a sé l’unità di
quelle vie e di quei rapporti in cui nascita e morte, infelicità e fortuna,
vittoria e sconfitta, sopravvivenza e rovina delineano la forma e il corso
dell’essere umano nel suo destino [Geschick]. L’ampiezza dell’apertura
di questi rapporti è il mondo di questo popolo storico. In base ad essa e
in essa, questo popolo perviene al compimento di ciò a cui è destinato12.
È questo il compiuto sbocciare di un’opera ben riuscita: il suo stagliarsi rischiarando una regione dell’essere e lasciando sorgere ogni cosa nel suo limite,
quel sorgere che i Greci chiamavano physis, la cui traduzione latina con natura
ne misconosce il senso. «La physis nomina piuttosto ciò in cui in primo luogo
sorgono terra e cielo, mare e monti, alberi e animali, uomini e dei, e tutte queste
cose, in quanto sorgono e si mostrano in modo tale che possono essere nominate come enti proprio in riferimento a questo ambito del sorgere. Solo nella luce
della physis, diventano visibili per i Greci quelli che noi chiamiamo processi
naturali nelle modalità specifiche del loro sorgere»13. Il sorgere però, proprio in
quanto sorgere, necessita di una provenienza cui finisce per essere ricondotto
e per ricondurre ciò che è sorto: è ciò che Heidegger chiama la Terra, la quale,
configurandosi come nascondente-proteggente, proprio da quest’attività trae il
suo intimo statuto. «Eretto sulla roccia, il tempio apre un mondo e lo riconduce, nello stesso tempo, alla Terra, che solo allora si rivela come suolo natale.
[…] Stando lì eretto, il tempio conferisce alle cose il loro aspetto e agli uomini
la visione di se stessi»14.
Come il tempio così anche la tragedia non rappresenta nulla, ma in essa si
combatte la lotta tra gli dei vecchi e quelli nuovi. Non rappresentandola, nemmeno racconta questa lotta, bensì «trasforma il dire del popolo in modo tale
che ogni parola essenziale conduce questa lotta e porta a decidere che cosa sia
sacro e che cosa non lo sia, che cosa sia grande e che cosa sia piccolo, che cosa
Ivi, p. 27.
M. Heidegger, Eraclito, cit., p. 61.
14 Id., Sentieri interrotti, cit., p. 28.
12 13 10
Andrea della Monica
sia pregevole e che cosa sia vile, che cosa sia nobile e che cosa sia spregevole,
che cosa sia il signore e che cosa sia lo schiavo»15.
La vera esposizione dell’opera dunque è quella che essa compie, non quella che subisce. L’opera può essere esposta solo perché è essa stessa a esporsi e
nell’esporsi «apre un mondo e lo mantiene in una permanenza ordinata. Esser opera significa esporre un mondo»16. L’opera d’arte è l’esposta-esponente.
Il mondo che essa espone è il Mondo come l’inoggettivabile che non ci si può
mai gettare di fronte, perché sta a esso rendere possibile l’oggettivare stesso.
Nell’esporre il Mondo, l’opera pone-qui la Terra come ciò in cui il Mondo si ritira, e nel porre-qui la Terra espone il Mondo come ciò in cui la Terra si mantiene
aperta. «Il Mondo si fonda sulla Terra e la Terra sorge attraverso il Mondo»17.
Lungi dal riposare in una dialettica pacifica, Mondo e Terra si contrappongono in una lotta in cui la potenza autoaprentesi del Mondo lotta per dominare la
potenza coprente-custodente della Terra che vuole assorbirlo. In greco lotta si dice
eris: questa è una parola propria del linguaggio di Eraclito. La proprietà in questo
caso nomina l’appartenenza ad un pensiero, riconosce il dominio della parola sul
pensiero del pensatore, non di questi su di essa. La eris è presente in Eraclito anche
dove non la si legge, come nel frammento 123: physis kryptesthai phileì. Assodata
la traduzione di physis con sorgere e di kryptesthai con nascondersi, nel senso di
chiudersi, Heidegger propone la traduzione della philìa nominata nel phileì come
donare-il-favore. «Intendiamo qui il termine favore nel senso dell’originario concedere e accordare […]. L’originario concedere è un accordare ciò che all’altro è dovuto, perché appartiene alla sua essenza, in quanto la sostiene. L’amicizia, philìa, è
il favore del concedere all’altro l’essenza che egli ha, in modo che, attraverso questa
concessione, l’essenza donata all’altro si trasforma nella sua propria libertà»18. Nel
concedersi l’uno all’altro, il sorgere e il chiudersi si donano vicendevolmente la loro
reciproca essenza. Il donare-favore non si pone come terzo termine per una mediazione dialettica tra i due, ma si dispiega nel modo del sorgere e si piega in quello del
chiudersi. «Il favore è il tratto fondamentale della eris, della lotta, se però ci rappresentiamo quest’ultima in senso iniziale e non solo come litigio e come dissidio»19.
Qui la eris nomina il tratto fondamentale dell’essere e lo fa a braccetto, e non in
contrapposizione, con la philìa, proprio alla maniera di ciò che, seppur in termini
non ontologici, Nietzsche chiama il «vero amore per i propri nemici».
Ibid.
Ivi, p. 29.
17 Ivi, p. 34.
18 Id., Eraclito, cit., p. 86.
19 Ivi, p. 89.
15 16 Heidegger e l’urto del deinòn
11
Certo, quanto rispetto per i suoi nemici ha un uomo nobile! – e un tale
rispetto è già un ponte verso l’amore… Lo vuole anzi per sé il suo nemico, come un segno suo proprio di distinzione, non sopporta alcun altro
nemico se non quello in cui non ci sia nulla da disprezzare e moltissimo
invece da onorare20!
Pensando amicizia e inimicizia a partire dalla eris, appare chiaro come i
lottanti, che non si fanno la guerra ma dispiegano l’essere come lotta, non possano fare a meno l’uno dell’altro. «La Terra non può fare a meno dell’aperto
del Mondo se deve essa stessa, in quanto Terra, apparire nel libero slancio del
suo autochiudimento. Il Mondo, a sua volta, non può distaccarsi dalla Terra se
deve, come regione e percorso di ogni destino essenziale, fondarsi su qualcosa
di sicuro».
E se non vuole solamente essere la riproduzione di questa lotta nella coappartenenza di Terra e Mondo, come deve collocarsi l’opera d’arte nel nostro
discorso?
Nella misura in cui l’opera è l’esposizione di un mondo e il porre-qui
la Terra essa è, ad un tempo, l’attizzatrice di questa lotta. […] l’opera
produce questa lotta. […] la realizzazione della lotta è il raccoglimento, costantemente oltrepassantesi, del movimento dell’opera. È perciò
nell’intimo della lotta che trova la sua essenza anche la calma dell’opera
riposante in se stessa21.
L’opera è dunque ciò che continuamente di nuovo deve attizzare il fuoco
della lotta nel focolare dell’essere ed esporre questo nel suo dispiegamento.
La lotta è allora ciò che continuamente rischia di scemare e quindi abbisogna
dell’esserci dell’uomo per esser tenuta viva. Questo “abbisognare” è l’appello
dell’essere che si approssima all’orecchio… di chi? Dell’uomo… di ogni uomo?
La risposta non è univoca nel complesso dell’opera heideggeriana. Quella che
ci preme ora prendere in considerazione, Heidegger la dà nel testo del corso
universitario tenuto a Friburgo nel semestre estivo del 1935, quindi coevo alla
prima stesura delle conferenze sull’arte. Il corso reca il titolo di Introduzone
alla metafisica: qui l’atteggiamento del filosofo è prettamente decostruttivo, egli
20 F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (1887), trad. di F. Masini, Genealogia della morale. Uno scritto polemico, Adelphi, Milano 198414, pp. 28-29.
21 M. Heidegger, Sentieri interrotti, cit., pp. 34-35.
12
Andrea della Monica
porta avanti il progetto di destruktion22 della storia dell’ontologia annunciato
in Essere e tempo e già in parte perseguito in quella sede. Nel testo si ricerca
continuamente la nominazione dell’essere. Heidegger rintraccia una delle possibili nominazioni agli inizi del pensiero occidentale nel pòlemos eracliteo del
frammento 53. Qui pòlemos dice la stessa cosa della eris, la lotta. Basti citare la
traduzione interpretante del frammento da parte di Heidegger: la consonanza
con quanto già detto è lampante.
L’esplicarsi per via di contrasto (pòlemos) costituisce per ogni cosa
(presente) il principio generatore (ciò che produce lo schiudersi) ma (altresì) la predominante custodia. Esso infatti fa apparire gli uni come dei,
gli altri come uomini, fa essere gli uni come schiavi, gli altri liberi23.
Se qui si tiene presente che nelle parole di Eraclito si nomina l’essere, l’abbisognare che si palesa nell’appello non richiede che la lotta venga prodotta, ma
solamente alimentata, giacché la lotta di cui si parla «è un conflitto originario in
quanto anzitutto origina i combattenti come tali; essa non costituisce un semplice attacco a qualcosa di già sussistente. La lotta è ciò che delinea ed enuclea
inizialmente l’inaudito, quello che non è stato fino allora né detto né pensato.
Questa lotta viene sostenuta, in seguito, da chi crea: da poeti, pensatori, uomini
di Stato»24.
…l’orecchio di chi? Non di ogni uomo, ma… di «chi crea». Sono i creatori,
essi solamente, a mostrarsi capaci di attizzare la lotta nel grembo all’essere. E
sono creatori nella misura in cui portano alla presenza un’opera, la pro-ducono.
«Essi gettano innanzi al preponderante imporsi la massa compatta dell’opera e
in essa bandiscono il mondo così dischiuso. È solo con queste opere che l’imporsi, la physis, viene in posizione nell’esser-presente. Soltanto allora l’essente
diventa, in quanto tale, essente. Questo divenir- mondo costituisce la storia propriamente detta»25.
È per questo che l’origine dell’opera d’arte non è altro che l’arte in quanto
origine. «L’origine dell’opera d’arte […] – dell’Esserci storico di un popolo – è
l’arte. E ciò perché l’arte è nella sua essenza origine e null’altro: una maniera
22 Id., Sein und Zeit (1927), nuova ed. a cura di F. Volpi sulla trad. it. di P. Chiodi, Essere e
tempo, Longanesi, Milano 2005, § 6, pp. 33-41.
23 Id., Einführung in die Metaphysik (1953), trad. di G. Masi, Introduzione alla metafisica,
Mursia, Milano, 1990 (nuova ed.), cit., p. 72.
24 Ivi, pp. 72-73 (corsivo mio).
25 Ibid.
Heidegger e l’urto del deinòn
13
eminente in cui la verità si fa essente, cioè storica»26. L’arte è storica in quanto
fonda la storia e allo stesso tempo si configura come messa in opera della verità
dell’ente. Essa si concretizza come lo storicizzarsi della verità.
Ma cosa accade nel momento in cui la lotta non viene alimentata? cosa
succede se l’arte non assolve più il suo compito? «La lotta come tale non fa solo
sorgere l’essente, ma lo custodisce, essa sola, nella sua stabilità. Quando cessa la lotta l’essente non scompare, ma il mondo si sottrae. L’essente non è più
sostenuto (vale a dire garantito come tale). Non è più, allora, che un dato, un
risultato». L’essente diventa il sussistente, «in cui nessun mondo più si mondeggia», diventa oggetto. Così l’opera d’arte non riposa più in se stessa.
Ciò che originariamente mondeggia la physis, diventa allora un dominio a sé, in contrapposizione all’arte e a tutto ciò che si può fabbricare
e organizzare. L’originario erigersi, in atto di schiudersi delle potenze
dell’imporsi, il phaìnesthai inteso come apparire, nel senso più elevato
dell’epifania di un mondo, diventa allora visibilità palese di cose sussistenti. La visione intuitiva, originaria, che seppe intravedere, per la prima volta, in ciò che emergeva, l’abbozzo, il progetto, e così, individuandolo, produsse l’opera, diventa ora semplice considerare, semplice guardare e rimirare. Il vedere rappresenta ora soltanto qualcosa di ottico27.
L’apparire epifanico si riduce a visibilità palese e la visione originaria dell’essere
si trasforma in un fenomeno meramente ottico. Il venire alla presenza dell’essere
e la vista, che ne coglie l’apertura, vengono meno con il venir meno della lotta e si
perdono nella dimenticanza dell’essere stesso. Coloro che creano, i creatori, dunque, sono propriamente coloro che si mantengono in quell’apparenza e che sono
capaci di quella vista. Essi sono capaci di cogliere e alimentare la lotta che l’essere
conduce per l’apparenza, per non cadere nell’oblio. Cosa comporta allora per un
popolo il venir meno o la messa in disparte di questi individui?
Allorchè i creatori si sono allontanati dal popolo e vengono appena
tollerati come delle semplici curiosità, degli ornamenti, come degli originali estranei alla vita; quando il conflitto autentico si arresta e si trasferisce in pure polemiche, in intrighi e macchinazioni umane nell’ambito del
sussistente, è segno che la decadenza è già incominciata28.
Id., Sentieri interrotti, cit., p. 61.
Id., Introduzione alla metafisica, cit., p. 73.
28 Ivi, pp. 73-74.
26 27 14
Andrea della Monica
Se tutto ciò è decadenza, cosa vuol dire, per questo stesso popolo, mantenersi nello splendore?
2. Lo splendore greco
Nella grande cultura greca la lotta dell’essere per l’apparenza si configura
anche come una lotta dell’essere con l’apparenza, mentre si mantiene la consapevolezza della profonda coappartenenza dei termini in lotta.
I Greci […] dovettero sempre strappare l’essere all’apparenza e proteggerlo contro di essa. (L’essere è, infatti, come non latenza.) Solamente nel
perdurare della lotta tra essere e apparenza essi sono giunti a conquistare
l’essere all’essente e a condurre l’essente alla stabilità e alla non latenza: gli
dèi e la città, i templi e la tragedia, gli agoni ginnici e la filosofia; ma tutto ciò
nel bel mezzo dell’apparenza ovunque in agguato, assumendola seriamente,
coscienti della sua potenza. È solo con la sofistica e con Platone che l’apparenza viene intesa come mera apparenza e così declassata29.
Per quanto in questo passo il giudizio su Platone appaia lapidario e inappellabile, come spesso in Heidegger, non è lecito farlo passare per l’unica e univoca
interpretazione heideggeriana del testo platonico. Nel corso su Nietzsche del
1936/37 intitolato La volontà di potenza come arte, Heidegger infatti si produce
in una lettura puntuale del Fedro, al fine di rintracciare una diversa concezione del bello e dell’arte rispetto a quella declassante esposta nella Repubblica.
Platone prende in esame la questione non più a partire dalla verità dell’essere
come idèa per discendere i gradini che, tramite il processo di mìmesis, assegnano l’arte, e la bellezza che le pertiene, al rango inferiore di mera riproduzione
del vero. Nel Fedro, dove non l’arte è posta a tema, ma direttamente la bellezza,
quest’ultima viene discussa nell’ambito del rapporto che l’uomo intrattiene con
l’ente in quanto tale, quindi posta allo stesso livello della verità: ad essa viene
conferita un’importanza capitale, che emerge palesemente dai passi scelti e tradotti da Heidegger nel corso.
[…] «ogni anima di uomo ha già scorto, schiudendosi da sé, l’ente
nel suo essere, o non sarebbe (altrimenti) mai venuta in questa forma
29 Ivi, p. 115.
Heidegger e l’urto del deinòn
15
di vita»30. Per poter essere quest’uomo che vive in carne e ossa, egli deve
avere già scorto l’essere. […] È l’ « anima » dell’uomo che deve aver scorto l’essere, giacchè l’essere non è coglibile con i sensi. È dell’essere che
l’anima si nutre, trèphetai31.
Tale capacità di vedere, questa vista nell’essere, che Platone chiama theà, non
si esplica, però, in tutta la sua potenza, non coglie l’essere «nel suo inoffuscato
splendore, ma sempre e soltanto in occasione di questo o quell’ente». E questo
perché una tale vista si trova ad ogni modo sempre calata in un corpo. Ma tale
parzialità di per sé non è l’inconveniente maggiore, poiché «quanto più la maggior parte degli uomini soccombe nella quotidianità alla rispettiva sembianza e
alla vedute correnti sull’ente, sentendovi a proprio agio e trovandovi conferma,
tanto più l’essere «si occulta» loro (lanthànei)»32. Vista dell’essere e quotidianità, dunque, si trovano in una contrapposizione essenziale, perché se nella
seconda l’uomo crede di riposare nel sé assicurato della propria essenza, non
appena, «nella sua vista dell’essere, si lascia vincolare da quest’ultimo, viene
rapito e trasportato al di là di se stesso, sicché, per così dire, egli si estende tra
sé e l’essere, ed è fuori di sé. Questo essere-elevato-al-di-là-di-sé, via-da-sé, ed
essere attratto dall’essere stesso è l’èros. Solo in quanto l’essere è capace di sviluppare in riferimento all’uomo la potenza erotica, solo in questa misura l’uomo
è in grado di pensare all’essere stesso e di superare la dimenticanza dell’essere».
Ma nella misura in cui la vista dell’essere è un possesso dell’uomo, allora egli
può anche perdere questo possesso, e quindi doversi affaticare per riconquistarlo. «Ne consegue la necessità di ciò che rende possibile la riconquista, il
rinnovamento e il mantenimento costanti della vista dell’essere. Può essere tale
soltanto quella cosa che più facilmente di tutte le altre, nella prima sembianza
di quanto capita di incontrare, fa apparire al tempo stesso l’essere più lontano.
Ma questo è, secondo Platone, il bello»33.
Non più esiliato come terzo livello d’essere in quanto imitazione dell’ente
copia dell’idea, qui il bello è nobilitato dal prezioso ufficio che svolge, la riconduzione della vista alla sommità dell’essere proprio a partire da ciò che sembrava soffrire la più dolorosa lontananza da esso: l’apparenza sensibile. «Quanto
più la sembianza come tale viene percepita splendente, lucente, tanto più vi
30 Citiamo qui, come in seguito, la traduzione operata direttamente da Heidegger dei passi
platonici. Il riferimento è al passo 249e del Fedro. Per il testo greco rimandiamo all’edizione
italiana, Platone, Fedro, trad. di R. Velardi, Rizzoli, Milano 2006, p. 198.
31 M. Heidegger, Nietzsche (1961), trad. di F. Volpi, Nietzsche, Adelphi, Milano 19944, p.190.
32 Ivi, p. 191.
33 Ivi, pp. 192-193.
16
Andrea della Monica
appare lucente ciò di cui essa è sembianza: l’essere. Il bello è nella sua essenza più propria, la cosa più appariscente nell’ambito sensibile, ciò che più di
tutto brilla, talché, essendo questa luce, fa che vi riluca contemporaneamente
l’essere»34. Platone, infatti, chiama il bello ekphanèstaton kaì erasmiòtaton, la
«cosa più lucente» e che, in quanto tale, «più trasporta e rapisce». Esso porta
l’essere a svelarsi e, in quanto tale, si trova in un rapporto di coappartenenza
con la verità intesa come dis-velamento dell’essere. Un tale rapporto, però, in
Platone si configura come discrepanza, in quanto la bellezza, calata nel sensibile, riconduce all’essere sempre a partire dal mè òn, da «ciò che non è propriamente l’essere», mentre la verità è l’attingimento originario ed è appannaggio
della filosofia. «Ma questa divisione, la discrepanza in senso lato, non è per Platone una discrepanza che suscita sgomento, ma è una discrepanza che rende
felici. Il bello eleva oltre il sensibile e riporta al vero. Nella divisione è preponderante la consonanza, poiché il bello, in quanto splendente, sensibile, ha fin
da principio messo in salvo la sua essenza nella verità dell’essere inteso come il
soprasensibile»35.
Pur non stravolgendo il testo platonico, Heidegger mostra come la stessa filosofia platonica affondi le proprie radici nello splendore del mondo greco e nella
sua concezione della bellezza, come lo stesso Platone non si presti univocamente
ad una lettura platonista, ma sia egli stesso indice di quel travagliato rapporto che
l’essere e l’apparenza intrattengono nella cultura greca che lo precede.
Scrive Heidegger che «nella concezione dei primi pensatori greci l’unità e
l’antagonismo dell’essere e dell’apparenza possedevano una potenza originaria.
Ma è nella poesia tragica che tutto questo è stato presentato nella forma più
alta e pura». E successivamente, nello stesso testo, si lancia in una breve quanto
intensa interpretazione dell’Edipo re di Sofocle come «tragedia dell’apparenza».
Edipo, che all’inizio è il salvatore e il capo dello Stato, nel pieno splendore della sua gloria e della sua benevolenza accordatagli dagli dei, viene
in seguito discacciato da questa apparenza – la quale non è una semplice
veduta soggettiva che Edipo ha di se stesso, ma ciò in cui si verifica l’apparire del suo esserci – fino a che si verifica la non-latenza del suo essere
come uccisore del padre e profanatore della madre. La via intercorrente
da quell’inizio glorioso a questa fine orribile è tutta una lotta fra l’apparenza (latenza e contraffazione) e la non-latenza (essere).
34 35 Ivi, p. 194.
Ivi, p. 196.
Heidegger e l’urto del deinòn
17
Edipo si trova prima facie nell’apparenza, che non è ancora contraffazione,
ma un farsi avanti nello splendore mentre l’essere si mantiene nella latenza.
È solo con il verificarsi della non-latenza dell’essere di Edipo come uccisore e
profanatore che l’apparenza diventa contraffazione, richiedendo tutta la furia
di Edipo stesso per essere annientata nella rivelazione del segreto. Ma è questo
stesso segreto e questa non-latenza dell’essere, in cui Edipo stesso si è portato,
che egli non riesce in seguito a sopportare «che a patto di cavarsi gli occhi da
se stesso, sottraendosi così a ogni luce e lasciando ricadere intorno a sé la tenebra che tutto nasconde, e come uomo abbacinato gridando di spalancare tutte
le porte per rivelarsi al popolo per quello che è». Lungi dal portare “semplicemente” in scena la straziante sofferenza di un uomo, la vicenda estrema, tragica
di Edipo diventa per Heidegger paradigmatica del fondamento metafisico che
sorregge la vita dei Greci. E può esserlo solo perché Edipo si colloca in questa
estremità come «quel tipo di uomo greco in cui quella che è la sua passione
fondamentale, la passione per la rivelazione dell’essere, ossia la passione della
lotta per l’essere stesso, risulta spinta al massimo e nel modo più selvaggio»36.
Quel tipo d’uomo di cui Hölderlin ha detto che «ha forse un occhio di troppo».
Ora, quando Heidegger parla dell’esser come non-latenza, bisogna tenere
a mente come questo sia il medesimo modo in cui è designata la verità, verità
dell’essere che i Greci, si è detto, concepiscono come physis, venire-alla-presenza. È solamente sul fondamento di quest’ultimo che «tanto la verità, nel senso
della non-latenza, quanto l’apparenza, come modo determinato del mostrarsi
schiudentesi, appartengono necessariamente all’essere». Da questo punto di vista l’apparenza mostra un candore ed un’innocenza inusitati, al limite dell’ingenuità, nulla a che vedere con l’abisso di Edipo. «Ma l’apparenza non si limita a
far sì che l’essente appaia quello che propriamente non è, essa non si contenta
di dissimulare l’essente di cui è apparenza, ma occulta, come tale, se stessa, in
quanto si mostra come essere». È dunque questo pericolo rappresentato dalla
dissimulazione dell’apparenza, che Heidegger chiama lo sviamento (die Irre),
ciò che i Greci si trovarono a dover fronteggiare. «Così, all’inizio della filosofia […] lo sforzo principale del pensiero è stato quello di cercare di dominare
il rischio dell’essere insito nell’apparenza e di cercare di distinguere l’essere
dall’apparenza. […] Siccome, peraltro, ciò che si richiede è di separare l’essere
dall’altro da sé e consolidarlo come physis, avviene che con la separazione di
essere e non-essere si compia anche quella del non-essere e dell’apparenza».
Questo è lo sforzo di pensiero di Parmenide e delle tre vie da lui indicate, le
36 Id., Introduzione alla metafisica, cit., pp.115-116.
18
Andrea della Monica
quali postulano la necessità «che l’uomo, se vuole assumere il suo esserci nella
chiarità dell’essere, collochi quest’ultimo al suo posto, lo sostenga nell’apparen
za e contro l’apparenza, sottraendo in pari tempo l’essere e l’apparenza all’abisso del non-essere»37.
Le tre vie sono note: 1) la via dell’essere, imprescindibile perché conduce
alla non-latenza, 2) la via del nulla, di fatto impercorribile, ma da conoscere e
pensare assieme alla prima, 3) la via dell’apparenza, quella della doxa, dell’opinione che abbisogna di essere saputa in quanto tale in modo che faccia segno
verso l’essere, o meglio, di modo che quest’ultimo in essa stessa si manifesti
all’uomo. È così che Heidegger può dire:
un uomo che veramente sa non è quello che persegue ciecamente una
verità, ma è semplicemente uno che si rende costantemente conto di tutte e tre le vie: quella dell’essere, quella del non-essere e quella dell’apparenza. Il sapere superiore – e ogni sapere comporta una superiorità
– viene concesso solo a colui che ha sperimentato, sulla via dell’essere, la
tempesta capace di trascinarlo via, a colui cui lo spavento della seconda
via, quella che conduce all’abisso del nulla, non è rimasto estraneo, e che
pure ha saputo accettare il rischio sempre incombente della terza via,
quella dell’apparenza38.
Non sappiamo se casuale o meno, ma ci sembra evidente il richiamo alla vicenda dell’Odissea come paradigma dell’esperienza greca delle tre vie: Odisseo,
che in seguito alla guerra di Troia viene continuamente risospinto per mare
dalla volontà degli dei, trascinato fuori dalla via dell’essere, è capace di discendere nel regno dei morti, affrontando l’abisso del nulla, per cercare la guida
di Tiresia, e si fa carico dell’apparenza quando, prima, nelle grotte del ciclope
Polifemo, si cautela dichiarando di chiamarsi Nessuno, poi, al ritorno ad Itaca, per riprendersi Penelope e il trono contro la minaccia dei Proci, si finge un
vecchio vagabondo, riconquistando così la via dell’essere nell’apparenza stessa,
e non a discapito di essa. Odisseo è colui che è in grado di «misurarsi insieme
con l’essere, con il non-essere e con l’apparenza: il che corrisponde ad assumere
su di sé l’esserci portandolo alla decisione fra essere, non-essere e apparenza»39.
Esempio eminente di quell’uomo greco protagonista di un rapporto con l’essere
la cui ricchezza Heidegger dice di non stancarsi mai di ammirare nel suo «conIvi, pp. 118-119.
Ivi, p. 122.
39 Ivi, p. 123.
37 38 Heidegger e l’urto del deinòn
19
figurarsi nella parola e nel marmo». Il marmo del tempio e la parola di quel
poetare pensoso che è la tragedia, che fa il paio con il pensare poetico dei primi
filosofi. In essa ne va dell’esserci nel suo rapporto all’essere. Nella tragedia greca
si palesano le coordinate di quell’ «umanismo nel senso più estremo», che nulla
ha a che fare con l’umanismo che vuole l’essenza dell’uomo come animal rationale, poiché, al contrario di quest’ultimo, quello «pensa l’umanità dell’uomo a
partire dalla vicinanza all’essere, ma nello stesso tempo è l’umanismo in cui in
gioco non è l’uomo, ma l’essenza storica dell’uomo nella sua provenienza dalla
verità dell’essere»40.
Commentando un’altra tragedia sofoclea, l’Antigone, Heidegger non prende
in esame il complesso dell’opera bensì una cinquantina di versi tratti dal primo
coro della tragedia, in cui è nominato il deinòn. Per i Greci il deinòn è l’ «inquietante», ciò che impone il proprio predominio, che sovrasta e fa violenza: è il violento nel duplice senso di ciò che ritiene in sé la propria potenza, imponendosi
nella remota possibilità del suo scatenamento, e di ciò che, invece, esercita la
violenza come estrinsecazione della sua stessa essenza.
L’essente nella sua totalità, in quanto si impone, è il predominante nel
primo senso. Ora, l’uomo è in un primo senso deinòn in quanto, appartenendo per essenza all’essere, risulta esposto a questo predominante.
Ma l’uomo è in pari tempo deinòn perché è colui che esercita la violenza,
il violento nel senso suddetto. (Egli raccoglie l’imporsi e lo reca in una
apertura). L’uomo è colui che […] usa la violenza contro il predominante.
[…] egli è tò deinòtaton, il più violento, in quanto esercita la violenza in
seno al predominante41.
L’uomo, dunque, nel suo rapporto all’essere fa violenza a quest’ultimo. Taglia le onde del mare con la chiglia della sua imbarcazione, dissoda la terra da
cui pretende dei frutti, soggioga l’animale per porlo al suo servizio e si sente il
padrone di ciò su cui domina. Ma egli può essere il deinòn nel secondo senso,
il deinòtaton, solo perché in lui agisce il deinòn nel primo senso. Anche ciò che
l’uomo crede a sé più vicino « – la parola, l’intelletto, il sentimento, la passione,
l’attività costruttiva – non appartengono meno alla potenza del predominante
che il mare, la terra, l’animale. Unica differenza è che questo domina tutt’intorno l’uomo, lo trascina, l’opprime, lo stimola, mentre quello domina per entro a
Id., Brief über den «Humanismus», in Wegmarken (1976), trad. di F. Volpi, Lettera sull’
in Id., Segnavia, Adelphi, Milano 19875, p. 295.
41 Id., Introduzione alla metafisica, cit., p. 158.
40 «umanismo»,
20
Andrea della Monica
lui, in quanto si tratta di ciò che egli, da quell’essente che è, deve assumere in
proprio»42. Ma è proprio questo assumere in proprio, per Heidegger, che finisce
per celare la provenienza di quanto l’uomo estrinseca nell’azione (e dell’agire
fa parte anche la parola). L’uomo, pur riconoscendosi come il deinòtaton, rischia di dimenticare come non sia questo il superlativo relativo che nomina lo
svettare di un singolo in mezzo ad altri a lui estrinseci, bensì il punto apicale
che non verrebbe mai ad essere se non affondasse le proprie radici nel deinòn
considerato nel primo senso. A sua volta, però, nell’apicalità del deinòtaton non
è possibile vedere l’estrema propaggine dell’essere che esercita la propria violenza come appendice ribelle. L’essenza della violenza è un movimento la cui
complessità porta a compimento l’essenza dell’essere e quella dell’uomo nel
loro essere diretti l’uno verso l’altro.
Il far-violenza del dire poetico, del progetto del pensiero, del formare
costruente, dell’azione creatrice di stati, non è l’esercitarsi di poteri che
l’uomo possiede in proprio, ma un dominare e accordare le potenze grazie alle quali l’essente si schiude, come tale, per via dell’uomo che entra
in lui. Questo aprirsi dell’essente rappresenta la violenza che l’uomo deve
padroneggiare onde essere, in questo far-violenza in mezzo all’essente, se
stesso, vale a dire se stesso come essere storico.
L’essere si schiude nella potenza dell’uomo, che all’essere appartiene e che
in esso è ri-voltato, come una piega dell’essere che rientra nell’essere stesso per
portarlo all’apertura. In quanto è questo esser-voltato nell’essere l’uomo è già
sempre fuori dall’essere, è propriamente èk-stasis, è «e-sistente»43. In quanto
porta l’essere ad aprirsi e a stare, esercita una pro-duzione, lo pone in opera.
Ogni porre-in-opera si basa su una spinta dettata da un sapere.
Sapere è poter mettere in opera l’essere come questo o quell’essente.
I Greci chiamavano l’arte propriamente detta e l’opera d’arte techne, in
senso forte, perché l’arte è ciò che porta più direttamente in posizione,
in un essente (in un’opera), l’essere, ossia l’apparire in sé consistente.
L’opera dell’arte non è in primis un’opera in quanto operata, fatta, ma in
quanto realizza, in un essente, l’essere.
42 43 Ivi, pp.163-164.
Id., Eraclito, cit., p. 114.
Heidegger e l’urto del deinòn
21
La techne nomina qui qualcosa di fondamentale. Più che eccedere, trascende
la sua abituale caratterizzazione strumentale, in quanto «caratterizza il deinòn,
il violentante nel suo fondamentale e decisivo carattere; giacché il far violenza è
un usare violenza contro il predominante: è acquisire all’apparenza, col sapiente combattere, l’essere dianzi precluso, quale essente»44. Questo «essere dianzi
precluso» è il deinòn nel primo senso espresso dalla parola greca dike, «l’ordine
disposto» che dà misura e tiene insieme le cose nel loro raccoglimento, nel logos. In quanto caratterizzato dalla techne che si erge contro la dike, il deinòtaton
è continuamente esposto al rischio della caduta nel disordine, alla rovina. «Il
violentante, il creatore, il quale avanza nell’inespresso e irrompe nel non-pensato, e che a forza ottiene il non-accaduto e fa apparire il non-veduto, questo
violentante sta continuamente nel rischio (tolma)»45. Quel rischio di cui l’Antigone dice che l’uomo è tale, è nel suo modo d’essere, il modo della techne, per
amore di esso, del rischio stesso. Quel rischio con cui noi andiamo, dice Rilke,
lo vogliamo46. Esso equivale, come già contemplato nel richiamo a Parmenide,
«ad assumere su di sé l’esserci portandolo alla decisione fra essere, non-essere
e apparenza». Il rischio da un lato è la possibilità che si presenta all’apice di
una violenza estrema contro l’ordine dell’essente, dall’altra è ciò a cui il più inquietante è già sempre esposto e soggetto, un’infrangersi che risulta inevitabile,
«se l’essere domina per quello che è, come physis, come schiudente imporsi»47.
Per i Greci dunque, che intendevano l’essere in questa maniera, l’uomo si trova
inesorabilmente portato dal rischio, «perché il predominante come tale, per apparire nella sua predominanza, ha bisogno di un luogo per la sua apertura. […]
Esistenza (Da-sein) dell’uomo storico significa esser posto come il varco in cui
la strapotenza dell’essere apparendo irrompe, affinché questo medesimo varco
si infranga alla fine sull’essere». L’essere un varco da parte dell’uomo é dunque
opera dell’essere stesso che «getta l’uomo sulla via di un tale trasporto che, costringendolo ad andare oltre se stesso, lo lega all’essere onde porlo in opera, e
con ciò mantenere aperto l’essente nella sua totalità». L’infrangersi dell’uomo è
anche l’infrangersi della sua opera, che pensata da Eraclito nel frammento 124
come ho kàllistos kòsmos, come «la più bella cosa ordinata», al cospetto dell’imporsi del predominante come physis, è hôsper sàrma, «simile ad un mucchio di
cose rovesciate»48. È così che Heidegger vede la mancanza di appagamento e
Id., Introduzione alla metafisica, cit., pp. 166-167.
Ivi, p. 168.
46 Citato da Heidegger in Wozu Dichter?, in Holzwege, trad. it. Perché i poeti?, in Id., Sentieri
interrotti, cit., p. 255.
47 Ivi, p. 169.
48 Id., Eraclito, cit., p. 110.
44 45 22
Andrea della Monica
tranquillità che per il violentante inteso come creatore rappresenta il prestigio
dell’opera creata, perché
la rovina rappresenta per lui il più profondo e ampio consenso accordato al predominante. Nella distruzione dell’opera compiuta, in quel rendersi conto che essa è un caos, che è quel sàrma (mucchio di spazzatura)
detto sopra, reintegra il predominante nel suo ordine. Ma tutto ciò, non
sotto forma di semplici «stati d’animo», da cui l’anima del creatore possa lasciarsi trasportare, […] bensì solo nella stessa maniera del porre in
opera. È come storia che il predominante, l’essere, trova operativamente
la sua conferma49.
Curioso destino quello dell’opera, presa in un movimento di eccedenza con
l’essere: plasmata da quel deinòtaton radicato nel deinòn, essa si configura come
eccedenza violenta sull’essere; a sua volta, però, è l’essere a porsi in eccedenza
sull’opera, presa come varco per il suo apparire. Varco destinato ad infrangersi
contro l’essere, eppure situazione privilegiata per il reintegramento di quello
nell’ordine che gli è proprio, un nuovo ordine che si configura come storia.
L’opera, come messa in opera della verità, è lo storicizzarsi della verità stessa,
ma non come inserimento della verità nell’ordine storico, bensì come origine
della storia stessa ad opera della verità dell’essere. L’opera, nel misurarsi con
l’essere come Ab-grund, abisso di cui non può rintracciarsi il fondamento, se
non può porsi appunto come fondamento dell’essere, può almeno riprenderlo
come scaturigine della sua verità. «L’arte fa scaturire la verità. L’arte fa scaturire la fondante salvaguardia della verità dell’ente nell’opera. Far scaturire qualcosa, porlo in opera con un salto che muova dalla sua provenienza essenziale,
tutto questo è racchiuso nel significato della parola origine»50.
Possiamo dunque dire quale ruolo giocano gli individui che creano, in quel
popolo che non li bandisce, che non li mortifica, che non li sminuisce, un popolo che vive l’epoca del suo splendore. Essi
usano la violenza in quanto attivamente situati nella violenza e divengono eminenti nell’essere storico come creatori, come uomini d’azione.
Eminenti in sede storica, divengono in pari tempo àpolis, senza città, né
Id., Introduzione alla metafisica, cit., p. 170.
Id., Sentieri interrotti, ed. cit., p. 61. Per il tema del fondamento, dell’Ab-grund e del salto,
cfr. anche M. Heidegger, Der Satz vom Grund (1957), trad. di F. Volpi, Il principio di ragione,
Adelphi, Milano 1991.
49 50 Heidegger e l’urto del deinòn
23
sito, solitari inquietanti, senza scampo frammezzo all’essente nella sua
totalità, e medesimamente senza istituzioni né frontiere, senza casa e
senza leggi, per il fatto che in quanto creatori debbono sempre di nuovo
fondare tutto ciò51.
In un popolo che viva il suo splendore, i creatori non possono essere allontanati, ma devono essi stessi tenersi lontano, essere apolidi, non perché rifiutino
la polis, bensì perché si collocano prima di essa, come ciò che devono sempre
di nuovo riprendere in un movimento di fondazione. Nella misura in cui attizzano la lotta tra Terra e Mondo, lottano essi stessi per la non-latenza, ne sono i
fautori, mentre «la non-latenza accade solo in quanto è realizzata con l’opera:
l’opera della parola che è la poesia, l’opera della pietra nel tempio e nella statua, l’opera della parola costituente il pensiero, l’opera della polis come luogo
della storia che fonda e custodisce tutto ciò»52. Il creatore, nella misura in cui
lotta per creare un varco aperto per l’erompere dell’essere, si trova ad essere
egli stesso quel varco in quanto esserci storico: Heidegger chiama questo varco,
che il creatore è, in-cidente (Zwischen-fall, letteralmente «crepa nel mezzo»).
Quell’incidente «in cui, d’un tratto, le forze della strapotenza scatenata dell’essere si liberano ponendosi in opera come storia. Di questa istantaneità e unicità
dell’esserci i Greci avevano un’intuizione profonda essendovi indotti dall’essere
stesso che si apriva ad essi come physis, come logos, come dike»53 entro l’epoca
del loro splendore.
3. Al di là dell’estetica
Chiederci a partire da quale situazione dobbiamo prendere le mosse per un
movimento futuro, nello stesso momento in cui diamo vita ad un confronto con
ciò che è stata la grecità, il suo pensiero e la sua arte, vuol dire, per Heidegger,
fare allo stesso tempo una ricognizione sullo statuto e sulla legittimità del nostro discorso sull’arte alla luce della storia della metafisica.
[…] riflettiamo come nell’epoca dell’arte greca non ci sia stato nulla di simile ad una letteratura sull’arte. Le opere di Omero e di Pindaro, di Eschilo e
di Sofocle, le opere architettoniche e scultoree dei grandi maestri parlavano
Id., Introduzione alla metafisica, cit., pp.160-161
Ivi, p.196.
53 Ivi, p. 170.
51 52 24
Andrea della Monica
da sé. Parlavano, ossia indicavano il luogo a cui l’uomo appartiene; consentivano di cogliere il luogo da cui l’uomo riceve la sua determinazione. Le loro
opere non erano espressione di situazioni esistenti e men che meno descrizioni di esperienze-vissute. Le opere parlavano come eco della voce che, nel suo
mostrare, determinava l’intero esserci di questo popolo eccezionale54.
Ne ricaviamo dunque, a proposito dell’arte greca, che 1) essa non era oggetto di un’estetica, almeno non come la intendiamo oggi, e questo perché 2) le
opere, le grandi opere non necessitavano di essere sorrette da un’impalcatura
teorica a loro esterna, bensì parlavano da sé; 3) nel far questo esse disponevano
uno spazio, creavano un luogo che fosse misura per l’uomo, 4) non potevano
dunque essere ridotte a mere riproduzioni di un’esistente, né tanto meno a semplici correlati di esperienze-vissute interne a dei soggetti, bensì 5) si costituivano
come eco di quell’appello, che abbiamo già detto provenire dall’essere, corrispondere al quale significava dare forma all’esserci storico dell’intero popolo: le
opere parlavano da sé, certo, ma a partire da voce altrui.
È innegabile però che una letteratura sull’arte sia stata quanto meno abbozzata
da Platone e Aristotele. Heidegger non nega questo fatto, ma lo interpreta come il
correlato inevitabile di quella modificazione del pensiero e dei suoi concetti, prodottasi alla fine dell’epoca greca con la nascita della metafisica ad opera di questi
due grandi pensatori. Furono essi ad approntare quegli strumenti concettuali decisivi per ogni pensiero dell’arte venuto in seguito. La coppia hyle-morphè, materia
e forma, caratteristica di Aristotele, si rende possibile solo sul fondamento della
concezione platonica dell’essere dell’ente come eîdos, idèa, aspetto. L’ente, concepito secondo il suo mostrarsi, il suo phaìnesthai, rende possibile l’apparire del bello
come ekphanèstaton, come ciò che si mostra eminentemente.
Il bello riposa, sì, nella forma [Form], ma solo perché la forma prese
la luce dall’essere come «entità» dell’ente. L’essere si attua allora come
eîdos. L’idèa si ordina nella morphè. Il synolon, il tutto unitario della morphè e della hyle, cioè l’èrgon, è [ist] nel modo della enèrgeia. Questo modo
dell’esser-presente diviene l’actualitas dell’ens actu. L’attualità diviene
realtà [Wirklichkeit]. La realtà diviene oggettività [Gegenständlichkeit].
L’oggettività diviene esperienza vissuta [Erlebnis]55.
E in poche righe siamo catapultati dalla grecità alla modernità via Tomma54 Id., Bemerkungen zu Kunst – Plastik – Raum (1996), trad. di F. Bolino, Corpo e spazio, Il
melangolo, Genova 2000, pp. 17-19.
55 Id., Sentieri interrotti, cit., p. 64.
Heidegger e l’urto del deinòn
25
so. Physis, eîdos, enèrgeia, actualitas, oggettività, esperienza vissuta sono determinazioni della verità dell’ente nella storia dell’Occidente. Heidegger sostiene
che «al mutamento dell’essenza della verità fa riscontro la storia dell’essenza
dell’arte occidentale»56. Non ci interessa qui ripercorrere tutte le tappe di questa
storia: la ricapitolazione si rende necessaria a partire da quella che Heidegger
individua come la situazione presente dell’arte.
Da quando ebbe inizio una considerazione specifica dell’arte e degli artisti, questa considerazione ha preso il nome di estetica. L’estetica
assume l’opera d’arte come un oggetto, e precisamente come l’oggetto
dell’aìsthesis, dell’apprensione sensibile nel senso più ampio. Oggi questa apprensione prende il nome di esperienza vissuta [Erlebnis]. Il modo
in cui l’uomo esperisce l’arte ne decide l’essenza. L’esperienza vissuta è
fatta valere come criterio originario non solo del godimento artistico, ma
della stessa produzione dell’opera. Tutto è esperienza vissuta. Ma, forse,
l’esperienza vissuta è l’elemento in cui l’arte sta morendo57.
Ne ricaviamo che oggi: mentre 1) l’estetica sussume sotto di sé il discorso
sull’arte, ponendoselo come compito, 2) l’opera è posta come oggetto di un’apprensione che arriva finalmente a configurarsi come esperienza vissuta, come
correlato oggettivo cioè di un’apprensione soggettiva – oggettività ed Erlebnis
non sono determinazioni successive della verità, ma due facce della stessa medaglia; 3) l’essenza dell’arte è decisa dall’esperienza che l’uomo ne fa come produttore e come fruitore, l’opera è prodotto e oggetto di fruizione; 4) l’esperienza
vissuta determina la morte dell’arte.
Comunemente il tema della «morte dell’arte» è associato alla figura di Hegel
e il più delle volte viene frainteso come decreto dell’impossibilità moderna di
dar vita ad opere d’arte. Ma la lezione hegeliana, secondo Heidegger, non intende scrivere la parola fine sulla storia dell’arte occidentale, bensì essere indice
di uno stato di fatto. E non può essere altrimenti se teniamo a mente la metafora hegeliana della filosofia che, come la nottola di Minerva, si leva solo sul
fare del crepuscolo, quando tutto è già avvenuto. Lo stato di fatto è che quello
di dare espressione ad un contenuto nella forma dell’arte non è più per noi un
bisogno assoluto, quindi possiamo guardare all’arte solamente come qualcosa
di passato. Hegel non avrebbe inteso negare né la possibilità di nuove opere
56 57 Ibid.
Ivi, pp. 62-63.
26
Andrea della Monica
d’arte all’interno di questa situazione, né soprattutto il recupero in futuro di
quel bisogno assoluto che ora manca a noi in quanto moderni. Quel bisogno
assoluto che Heidegger legittimamente legge come un bisogno di assoluto, e
per questo si domanda: «l’arte è ancora oggi una maniera essenziale e necessaria in cui si storicizza la verità decisiva per il nostro esserci storico, o non lo è
più?»58. La negatività della risposta rispecchia solo la retoricità della domanda.
È il retaggio inevitabile dell’epoca presente come compimento di quello che
altrove Heidegger chiama il Mondo Moderno, fra i cui tratti fondamentali annovera anche la riconduzione dell’arte, come esperienza vissuta, nell’orizzonte
dell’estetica59. Tale avvenimento è possibile solo sul fondamento di un cambiamento più essenziale che, determinatosi nella filosofia di Cartesio, dà inizio
dell’età moderna: «la certezza di tutto l’essere e di tutta la verità viene fondata
sull’autocoscienza del singolo io: ego cogito ergo sum. Il trovarsi lì nel proprio
stato, il cogito me cogitare, dà luogo anche al primo «oggetto» assicurato nel
suo essere. Io stesso e i miei stati siamo l’ente primo e autentico; su questo ente
così certo, e in base a esso, viene misurato tutto quello che deve poter essere
chiamato ente»60. Con Cartesio, con la modernità, l’uomo si costituisce come
soggetto, si pone come misura di tutte le cose.
Nel mondo greco questa stessa posizione è comunemente attribuita al sofista
Protagora. Heidegger però chiarisce l’equivoco e prende le distanze da quello che,
secondo lui, è un totale fraintendimento del pensiero protagoreo, e di quello greco
in generale. Pur mantenendo il riferimento al singolo come egò, il detto protagoreo vede quest’ultimo soggiornare nella cerchia del non-esser-nascosto che gli è
stata assegnata, all’interno della quale solamente può percepire l’essente-presente.
«L’uomo, come è inteso dai Greci, nel suo rapporto fondamentale all’ente e al suo
non-esser-nascosto, è mètron (misura) nel senso che assume su di sé la moderazione consistente nel tenersi dentro il non-esser-nascosto delimitato dall’io, e conseguentemente, nel riconoscere l’esser-nascosto dell’ente e la indecidibilità di quanto riguarda l’esser-presente e il non-esser-presente dell’ente, e parimenti di quanto
riguarda l’aspetto dell’essente». Uno stare greco nell’essere, di per sè indecidibile,
che nulla ha a che vedere con il soggettivismo moderno inteso come «procedere
nell’illimitata regione della possibile oggettivazione, mediante il calcolo del rappresentabile accessibile ad ognuno e vincolante per tutti».
Nel non esser-nascosto ha luogo la phantasìa, cioè il giungere all’apIbid.
Id., Die Zeit des Weltbildes, in Holzwege, trad. it. L’epoca dell’immagine del mondo, in Id.,
Sentieri interrotti, cit., p. 72.
60 Id., Nietzsche, cit., pp. 91-92.
58 59 Heidegger e l’urto del deinòn
27
parizione dell’essente-presente come tale in cospetto dell’uomo come essente-presente all’apparizione. Viceversa l’uomo, come soggetto rappresentante, fantastica – cioè si muove nella imaginatio – nella misura in cui
il suo rappresentare si immagina l’ente come la determinazione oggettiva
di un mondo concepito come immagine61.
Nella grecità, se è possibile “vedere”, lo è anzitutto grazie all’occhio dell’essere. E la visione che risulta determinante ha una direzione di senso inverso a
quella che procede dall’uomo. «L’ente non diviene essente per il fatto che l’uomo lo intuisca nel corso della rappresentazione intesa come percezione soggettiva. È piuttosto l’uomo ad essere guardato dall’ente, cioè dall’autoaprentesi
all’esser-presente in esso raccolto. Guardato dall’ente, compreso e mantenuto
nell’aperto dell’ente, sorretto da esso, coinvolto nei suoi contrasti e segnato dal
suo dissidio: ecco l’essenza dell’uomo nel periodo della grandezza greca».
In contrapposizione al percepire greco inteso come theorìa, puro vedere, la
modernità è dunque caratterizzata nella sua specificità dalla rappresentazione,
re-praesentatio, in tedesco vor-stellung: «portare innanzi a sé la semplice presenza come qualcosa di contrapposto, rapportarla a sé, cioè al soggetto rappresentante e, in questo rapporto, ricondurla al soggetto come al principio di ogni
misura. […] con ciò l’uomo pone se stesso come la scena in cui l’ente non può
che rappresentarsi, presentarsi, cioè esser immagine»62. Proprio questo porreinnanzi l’opera d’arte e ricondurla-a-sé sono l’orizzonte in cui si muove la proposta estetica della modernità, che vede nell’opera un oggetto di godimento e
un attivatore di emozioni, ponendo l’uomo e l’opera come esterni l’uno all’altra.
Heidegger lo dice chiaramente.
L’opinione fallace è quella per cui l’uomo è una cosa di fronte alla
quale sta una cosa. Tuttavia, nella misura in cui l’uomo si dirige in generale verso qualcosa, quest’ultima è già nel suo mondo, anche senza che
egli lo sappia. Non si può designare tutto ciò come «soggettivo». Questa
«immediatezza» dello «stare di fronte» è la parvenza di una considerazione meramente esteriore. È proprio il fatto di fare apparentemente il
meno possibile e di portar-si-vicino-in-questo-modo, è proprio questo ad
innalzare forse la barriera più rigida tra l’opera e l’uomo stesso. Proprio
questa apparente «immediatezza» è una degradazione dell’opera. Infatti
61 62 Id., Sentieri interrotti, cit., pp. 91-92 (nota 8).
Ibidem, pp. 89-93.
28
Andrea della Monica
ripongo in essa la pretesa che l’opera sia per me uno «stimolatore di esperienze vissute». Poiché proprio questa apparente immediatezza è l’impedimento fondamentale, c’è bisogno di una riflessione sul fatto che in generale vada creata la possibilità di un ambito, nel quale essere all’altezza
del compito di lasciare essere l’opera l’opera che essa è. L’uomo non è una
cosa che termina con la propria pelle. Né poi vi è un’altra cosa in quanto
opera d’arte e in mezzo il nulla, bensì: l’uomo è fin dall’inizio il tutto63.
E «l’uomo è fin dall’inizio il tutto» perché nel rapporto tra l’uomo e l’opera
ne và fin dall’inizio dell’uomo stesso. Nell’arte ne va dell’essenza dell’uomo nel
suo rapporto all’essere. Ed è proprio perché l’essenza dell’uomo è il suo stesso
rapporto all’essere che l’uomo «non è una cosa che termina con la propria pelle». Relazionarsi all’arte nella maniera criticata da Heidegger sarebbe dunque il
motore della decadenza, rintracciabile «nel fatto che l’arte perde la sua essenza,
il riferimento diretto al suo compito fondamentale di rappresentare l’assoluto, cioè di porlo in quanto tale, in modo determinante, nell’ambito dell’uomo
storico»64.
Se dunque la decadenza dell’arte si trova in perfetta corrispondenza con la
moderna nascita dell’estetica, ben capiamo due brevi annotazioni di Heidegger
datate 1934, addirittura precedenti, dunque, alla prima stesura della conferenza sull’arte.
Il fatto storico che ogni estetica fondata secondo un pensiero (cfr.
Kant) faccia saltare se stessa è allo stesso tempo il sintomo infallibile
che, da un lato, questa interrogazione sull’arte non è contingente, ma
pure, dall’altro, che essa non costituisce l’essenziale65.
Ogni qual volta l’estetica viene afferrata in modo essenziale e creativo,
essa fa segno al di là di sé66.
Questo fare segno al di là di sé da parte dell’estetica è la cifra del rivolgimento
possibile nella modernità per quel che riguarda la concezione dell’arte. Rimane
da chiedersi verso che cosa l’estetica, se fondata secondo un pensiero e afferrata
essenzialmente e creativamente, faccia segno. Qui c’è da pensare l’essenza stes63 Id., Introduzione all’estetica. Le Lettere sull’educazione estetica dell’uomo di Schiller, trad.
di A. Ardovino, Carocci, Roma 2008, pp.104-105.
64 Id., Nietzsche, cit., p. 92.
65 Id., Dell’origine dell’opera d’arte e altri scritti, a cura di A. Ardovino, Aesthetica Preprint,
Palermo 2008, p. 57. Cfr. anche Id., Nietzsche, cit., p.136.
66 Ivi, p. 58.
Heidegger e l’urto del deinòn
29
sa del segno, che, nel momento in cui si pro-pone nella presenza, è indice di una
non-presenza, o meglio, di una sottrazione. Ciò che per Heidegger più eminentemente si sottrae, all’inizio del compimento della metafisica occidentale, è proprio ciò che più va pensato, l’essere. Di esso e del suo sottrarsi Heidegger scrive:
Ciò che va pensato si distoglie dall’uomo. Gli si sottrae. Ma com’è mai
possibile venire a sapere qualcosa di ciò che da sempre si sottrae o anche
solo dargli un nome? Ciò che si sottrae rifiuta la sua venuta (Ankunft).
Ma: il sottrarsi non è un semplice niente. Esso è evento (Ereignis). Ciò
che si sottrae può concernere l’uomo in modo più essenziale e pretendere da lui un interesse più profondo di quanto non faccia qualunque cosa
presente che gli accada e lo tocchi67.
Concernere nella sottrazione è il massimo dispiegamento dell’attrazione.
Nella misura in cui ciò che si sottrae ci concerne, noi siamo attratti da esso e
portati via in un cammino. «Se, in quanto siamo così attratti, siamo in marcia
verso ciò che ci trae, la nostra essenza porta già l’impronta di questo essere
«in marcia verso…». Noi stessi, in marcia verso ciò che si sottrae, indichiamo
verso ciò che si sottrae. Siamo quelli che siamo perché indichiamo verso quella
direzione». Se indicare nella direzione di ciò che si sottrae ci rende quello che
siamo, allora non può trattarsi di nulla di contingente per l’essenza dell’uomo.
«L’uomo non è qui anzitutto l’uomo e in secondo luogo anche, e magari occasionalmente, uno che indica, ma: tratto verso ciò che si sottrae, in marcia verso
di esso e in tal modo colui che indica il sottrarsi, solo così l’uomo è uomo»68.
Ora, se dunque l’estetica è una manifestazione eminente di quel destinarsi
dell’essere che va sotto il nome di epoca moderna, se l’essenza di questa epoca è
di portare a compimento il sottrarsi dell’essere, se, infine, l’essenza di un’estetica portata alle sue estreme conseguenze è quella di fare segno al di là di sé,
questa non potrà fare segno che verso ciò che più eminentemente si sottrae,
l’essere stesso. Si è detto che il sottrarsi stesso dell’essere non è un niente, ma
un evento (Ereignis). Ebbene, evenemenziale non è solo il suo sottrarsi. «Il nonesser-nascosto dell’ente non è un suo stato abituale, ma un evento»69. Il non-esser-nascosto nella sua evenemenzialità è dis-velamento, a-lètheia, verità, e una
delle maniere in cui la verità si disvela è l’apertura propria dell’opera d’arte.
67 Id., Was heisst Denken? (1954), trad. di U. Ugazio e G. Vattimo, Che cosa significa pensare?, SugarCo, Varese 1996, vol. I, pp. 42.
68 Ivi, p. 43.
69 Id., Sentieri interrotti, cit., p. 39.
30
Andrea della Monica
Nella misura in cui questa apertura non è una possibilità tra le altre, ma l’unica
necessità che davvero esiste, si può dire che «sussiste nell’essenza della verità
un’attrazione verso l’opera». E quest’attrazione per l’opera si concretizza in un
fare che è un pro-durre, precisamente «una produzione [traente fuori] un ente
che prima non era ancora e che, successivamente, non sarà mai più. La produzione pone questo ente nell’Aperto in modo tale che ciò che nella produzione
viene prodotto illumina l’aprimento dell’Aperto in cui esso è prodotto. Quando
il produrre produce l’aprimento dell’ente, la verità, il prodotto è un’opera. Un
tal produrre è il fare dell’arte»70. Fin tanto che questo fare è un produrre l’aprimento dell’ente come verità, l’opera non è mai un oggetto, nel senso del tedesco
Gegen-stand, come ciò che sta di fronte. Il tedesco ha un altro termine caduto in
disuso, simile a Gegenstand, che indica una differente modalità del «di fronte»
la quale si attaglia bene all’opera d’arte: la parola è Gegenüber, che traduciamo
“essere di fronte”.
«Essere di fronte» e «ciò che sta di fronte» – Gegenüber e Gegenstand
– non sono la stessa cosa. In «ciò che sta di fronte», nell’oggetto, il «di
fronte» si determina in base al «gettare di fronte a sé» che rappresenta, operato dal soggetto. Nell’ «essere di fronte», invece, il «di fronte» si
manifesta in ciò che avviene all’uomo percipiente, vedente-udente, vale
a dire in ciò che sopravviene l’uomo, lo coglie – coglie lui, che mai si è
concepito in quanto soggetto per degli oggetti71.
Questo sopravvenire è ciò che meglio è reso dallo stare di fronte della statua
greca espresso nella parola greca antikeìmenon, che nulla ha a che fare con
l’oggettività, e che, nella sua versione più inquietante, il deinòn, manifestava
per i Greci la presenza degli dei. Se nel caratterizzare l’opera d’arte ci teniamo,
insieme ad Heidegger, all’interno di determinazioni così ampie, non è per amor
d’astrazione, bensì perché sia chiaro che «ciò che nell’opera deve esser tenuto
nell’aperto è il semplice factum est»72. Certo è innegabile che la constatazione di
una mera presenza sia per noi quanto di più accessibile fra le cose che abbiamo
intorno, ma questa possibilità non ha nulla di eccezionale. «Nell’opera, invece,
lo straordinario è proprio questo: che l’ente, in quanto tale, è»73. L’opera, rimescolando le carte in tavola nella partita tra la vicinanza e la lontananza, mette a
Ivi, pp. 46-47.
Id., Il principio di ragione, cit., p. 141.
72 Id., Sentieri interrotti, cit., p. 49.
73 Ivi, p. 50.
70 71 Heidegger e l’urto del deinòn
31
segno il suo colpo come urto del prodigioso. Questo urto non è una violenza che
ci mette al tappeto, bensì una mano tesa che ci trascina fuori dall’abituale e che
a sua volta si infrange nell’aprimento, che essa stessa ha determinato, a mo’ di
una immedesimazione in esso.
Acconsentire a questa immedesimazione significa: trasformare i nostri rapporti abituali col Mondo e con la Terra, sospendere ogni modo
abituale di fare e di giudicare, di conoscere e di vedere, per soggiornare
nella verità che si storicizza nell’opera. Questo soggiornare lascia che
l’opera sia l’opera che è. Questo lasciare che l’opera sia l’opera che è, lo
designamo come la salvaguardia dell’opera. È in virtù della salvaguardia che l’opera c’è (nel suo esser-fatta) come reale, cioè è presente come
opera74.
L’unico vero rapporto con l’opera, per Heidegger, è quello di soggiornare
nello spazio che essa stessa ha aperto. Questo soggiornare è un salvaguardare
la verità che nell’opera si è storicizzata. La salvaguardia dell’opera, dunque, è la
salvaguardia della verità stessa. E nella misura in cui è l’arte a porre in opera la
verità, Heidegger può dire che essa «è la producente salvaguardia della verità
in opera»75.
L’opera non produce causalmente degli effetti, la sua efficacia sul reale, la
sua efficienza consiste piuttosto «in quel mutamento del non-esser-nascosto
dell’ente che è concesso all’opera: cioè un mutamento dell’essere»76. Tale mutamento è l’incalcolabile e l’imprevedibile per eccellenza. È ciò che non può
essere preparato e previsto, non può essere programmato e tenuto di mira, in
esso si annida la componente propriamente creativa dell’arte. È un evento puro.
La verità, aprentesi nell’opera, non trova in ciò che è durato finora né fondamento né giustificazione. Ciò che è durato finora non trova
nell’opera che la confutazione della sua realtà esclusiva. Ciò che è instaurato dall’arte non trova né contrappeso né compenso in ciò che è immediatamente presente e disponibile. La fondazione è un traboccamento,
una donazione77.
Ivi, p. 51.
Ivi, p. 55.
76 Ivi, p. 56.
77 Ivi, p. 59.
74 75 32
Andrea della Monica
Ciò che, nella prospettiva heideggeriana, rende l’estetica insufficiente, è la
sua incapacità di pensare l’opera d’arte. Il punto è proprio che l’estetica, per
Heidegger, vuole pensare l’opera d’arte, rappresentarsela come un oggetto, mentre l’unica cosa che si può fare è pensare a partire dall’opera d’arte e per l’opera
d’arte, andare al di là della rappresentazione. I Greci, si è detto, per lo più mancavano di un’estetica, la loro arte era priva di un ripensamento speculativo ad
essa dedicato, ma questo non significa «che questa arte sia stata allora soltanto
«vissuta», nell’oscuro ribollire delle «esperienze vissute» non lambite dal concetto e dal sapere. Per fortuna i Greci non avevano le «esperienze vissute», ma
in compenso un sapere talmente originario e lucido, e una tale passione per il
sapere, da non avere bisogno, in tale lucidità del sapere, di una estetica»78. Un
sapere così lucido è quella capacità di pensare l’arte che esula dalle modalità
dell’estetica.
Si tratta […] della messa al sicuro di un sapere che crea lo spazio
entro il quale è possibile l’esser-sorpresi da una «magia». Proprio il
fatto che l’accesso all’opera ci riguardi, necessita di presupposti. Il
creare la «chance» è ciò che viene autenticamente prodotto nel sapere
relativo all’arte. Proprio la creazione di questo sapere è per noi, nel
nostro momento storico, l’intima necessità, perché questa creazione
si trova storicamente di fronte a nuove possibilità. Nel caso in cui dovesse riuscirci un simile accesso – non soltanto attraverso questo sapere e questo riflettere, bensì, presumibilmente, nel corso di essi – allora anche l’esperienza dell’opera e il parlare di quest’opera sarebbero
possibili, in quanto belli, solo nella forma dell’esibizione, che possiede essa stessa la propria configurazione: una legalità che noi ancora
non conosciamo autenticamente, ossia la legalità dell’interpretazione
dell’opera d’arte stessa79.
Il sapere intorno all’arte crea la chance di essere sorpresi da quel mutamento
dell’essere che l’opera è come evento. L’accesso ad essa non è il risultato di una
rappresentazione ben riuscita, ma è il pensiero stesso nel suo disporsi alla salvaguardia dell’evento. Questo pensiero non sarà più esponibile nelle modalità
dell’estetica ma in quelle del pensiero dell’essere, che, fedele alle sue origini fenomenologiche, si configura come esibizione, una ostensione. Per questo motivo
78 79 Id., Nietzsche, cit., pp. 88-89.
Id., Introduzione all’estetica, cit., p. 92.
Heidegger e l’urto del deinòn
33
possiamo dire che il saggio sull’opera d’arte, non è ancora per Heidegger quel
sapere cui egli mira, ma soltanto la sua preparazione. E lo stesso procedere sotto certi aspetti ellittico da parte sua appronta il terreno per il salto nel pensiero
dell’essere, cui non si giunge per gradi.
In un’annotazione intitolata Il superamento dell’“estetica”, Heidegger scrive:
La nostra domanda sull’opera non verte sull’oggetto per il soggetto,
bensì sull’accadimento di verità attraverso il quale noi stessi (i soggetti)
veniamo trasformati. Fondazione dell’esser-ci80.
Non tanto rispondere, quanto installarsi in questa domanda comporterebbe
già di fatto, per Heidegger, il superamento dell’estetica.
4. Poìesis, spazio e pensiero
Più volte impiegato finora, un termine ci rimane ancora inspiegato nella
sua essenza: produzione. La parola fa riferimento al greco techne. Quest’ultimo
designava sia il lavoro dell’artigiano sia quello dell’artista. La sintesi è possibile
solo perché techne non ha il significato di operare pratico, bensì quello di sapere intorno all’ente. Tale sapere rende possibile portare un ente nel non-essernascosto a partire dal suo esser-nascosto: questo portare è un trarre-fuori, un
pro-durre l’essente conducendolo alla presenza. In questo modo sia l’artigiano
sia l’artista si guadagnano l’appellativo di technìtes. Scrive Heidegger: «tanto la
produzione artistica quanto la produzione del mezzo avvengono in quel produrre traente-fuori, che, sin dall’inizio, lascia rivelarsi l’ente – in base al suo
aspetto – nel suo esser-presente. Tutto ciò ha […] luogo in seno all’ente che sorge da sé, la physis»81.
Ogni genere di atto, che realizzi il passaggio dal nascondimento alla presenza, per Platone è poìesis82. La physis si configura quindi come poìesis
nel senso più alto. Infatti, ciò che è presente physei ha in se stesso
(en eautò) il movimento iniziale (Aufbruch) della pro-duzione, come ad
esempio lo schiudersi del fiore nella fioritura. All’opposto, ciò che è prodotto dall’arte e dal lavoro manuale […] non ha il movimento iniziale
Id., Dell’origine dell’opera d’arte, cit., p. 59.
Id., Sentieri interrotti, cit., p. 44.
82 Platone, Simposio, trad. di F. Zanatta, Feltrinelli, Milano 2008, p. 105.
80 81 34
Andrea della Monica
della produzione in se stesso, ma in un altro (en àllo), nell’artigiano e
nell’artista83.
Il movimento iniziale, quello che in greco è chiamato archè, mentre negli
enti che sorgono secondo la physis è racchiuso in loro stessi, negli artefatti è
dislocato al loro esterno, nell’artista, che per questo è architècton, «colui che dispone della techne come arché»84. La physis, dunque, ha nell’ambito della poìesis
un carattere di precedenza rispetto alla techne. Questa nella sua piega artistica,
in quell’ambito cioè in cui il dis-velamento dell’essere è storicizzato nell’opera,
si concretizza come «fissazione della verità nella figura»85. Questa fissazione è
propriamente il raccoglimento della produzione al modo di un «lasciar pervenire nella linea di separazione»86: quella linea a partire dalla quale un ente inizia
a dispiegare il suo essere; quella linea che in greco è pèras, il limite dell’ente.
Tale raccoglimento è chiamato da Heidegger Ge-stell. Questo termine, che negli
studi heideggeriani è maeglio conosciuto per designare l’essenza della tecnica
moderna, «deriva dal lasciar giacere lì dinnanzi (logos) come lo intesero i Greci, dalla poìesis e dalla thèsis greche»87. La techne, dunque, è un modo dell’aletheùein, del disvelamento, precisamente di ciò che non si produce da se stesso.
La tecnica moderna, però, anch’essa una modalità dell’aletheùein, non lo è alla
stessa maniera della poìesis. Ha piuttosto il tratto dello Stellen, di un porre che
è un richiedere, una pro-vocazione. Ciò che viene portato allo scoperto, viene
messo in posizione e stabilizzato per essere utilizzato: la natura, e l’essente in
generale, perde anche il suo carattere di Gegenstand, di oggetto, per prendere
quello di Bestand, di fondo. Quel superamento dell’estetica precedentemente
auspicato, in questa situazione si attua in modalità impreviste e singolari, rispetto alle quali Heidegger appare tanto prudente nel tenersi lontano da ogni
giudizio di valore, quanto timoroso nel non arrischiare un serio tentativo di
comprensione.
Il fatto che in un’epoca simile l’arte diviene astratta, inoggettiva, testimonia la sua legittimità storica, e questo soprattutto nel momento in
cui la stessa arte inoggettiva capisce che le sue produzioni non possono
83 M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, in Vorträge und Aufsätze (1957), trad. di G.
Vattimo, La questione della tecnica, in Id., Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1976, p. 9.
84 Id., Vom Wesen und Begriff der physis. Aristoteles, PHYSIK, B,1, in Wegmarken, trad. it.
Sull’essenza e sul concetto della physis. Aristotele, FISICA, B, 1, in Id., Segnavia, cit., p. 206.
85 Id., Sentieri interrotti, cit., p. 48.
86 Ivi, p. 67.
87 Ibid.
Heidegger e l’urto del deinòn
35
più essere opere d’arte, ma divengono qualcosa per cui manca ancora la
parola adatta88.
L’ente nel suo complesso, che ora si presenta in tutta la sua disponibilità ad
opera dell’uomo, lascia che questi assuma il ruolo principale nel suo impiego.
Ma ciò che mai sarà opera dell’uomo è l’origine del disvelamento stesso, appannaggio dell’essere, nella cui apertura solamente è possibile l’impiego. Così il
disvelare, proprio dell’uomo, nella sua essenza non gli appartiene se non come
risposta all’appello del disvelamento stesso. Per questo Heidegger può dire che
«l’essenza della tecnica non è affatto qualcosa di tecnico»89.
Nella tecnica moderna l’appello del disvelamento è, come abbiamo detto,
una provocazione, che opera un raccoglimento dell’uomo stesso nell’impiegare il
reale come fondo. In tedesco il carattere di raccolta è espresso dal prefisso ge-,
mentre la provocazione dallo stellen: ed ecco così spiegato il passaggio del termine Ge-stell, im-posizione, a significare l’essenza della tecnica moderna come
«appello provocante che riunisce l’uomo nell’impiegare come fondo ciò che si
disvela»90. Trascinato via da questo appello, l’uomo è esposto in massimo grado
al pericolo «di perseguire e coltivare soltanto ciò che si disvela nell’impiegare,
prendendo da questo tutte le sue misure»91. L’essenza del Gestell è quella di
porsi come unica modalità del disvelamento, occultando quella della poìesis e
allo stesso tempo il proprio carattere di disvelamento, mettendo così l’ente in
mostra e al sicuro come il già-da-sempre-essente-a-disposizione. È questo il pericolo estremo cui l’uomo si trova esposto dall’essenza della tecnica.
Ora Heidegger, seguendo il dettame hölderliniano secondo cui «là dove c’è
il pericolo, cresce anche ciò che salva», si mette sulle tracce di un rivolgimento possibile all’interno della stessa situazione di pericolo. Una svolta simile è
possibile se l’uomo non si lascia più abbacinare dall’occultamento totalitario
dispiegato, ma si lascia «traspropriare all’evento della verità» come quel concedere che solo permette il destinarsi del disvelamento dell’ente come Gestell.
Questo lasciarsi è proprio la cosa più difficile, perché, lungi dall’essere una
mera presa di distanze dalla tecnica, deve prendere le mosse proprio da essa
e dalla sua ambigua essenza, in quanto il suo stesso occultare alla maniera
di un coprimento gigantesco nelle modalità «della pianificazione, del calcolo,
dell’organizzazione e dell’assicurazione porta il quantitativo a capovolgersi in
Id., Il principio di ragione, cit., p. 66.
Id., Saggi e discorsi, cit., p. 5 (corsivo mio).
90 Id., Saggi e discorsi, cit., p. 14.
91 Ibid., p. 19.
88 89 36
Andrea della Monica
una sua propria qualità»92. È questo il punto in cui il gigantesco, che fino a quel
momento era il calcolabile per eccellenza, diventa l’incalcolabile e si distende
come un’ «ombra invisibile». Quest’ombra è ciò che Heidegger chiama il nulla.
«Il nulla non è mai un mero niente, come non è affatto qualcosa, alla stregua di
un oggetto; il nulla è l’essere stesso, la cui verità sopravverrà all’uomo quando
si sarà oltrepassato come soggetto, cioè quando non si rappresenterà più l’ente
come oggetto»93. L’oltrepassamento della rappresentazione, già avvenuto in negativo con il dispiegamentoo del Gestell, sembra essere dunque suscettibile di
uno slancio in positivo come quel «disvelamento concesso più originariamente», che è stato al centro del nostro discorso finora. Heidegger vi fa riferimento
quando scrive che «tutto ciò che salva non può che avere un’essenza superiore, ma anche affine, a ciò che è messo in pericolo»94, come sta a testimoniare
la stessa parola techne nel senso delle belle arti, «produzione della verità nello
splendore di ciò che appare».
Proprio sottraendo all’oblio la coappartenenza emersa tra poìesis e techne
è possibile pervenire ad una nuova modalità dell’esserci umano come “abitare
la terra”. A un verso di Hölderlin che recita «…poeticamente abita l’uomo su
questa terra…» è intitolato infatti un breve testo heideggeriano, esercizio di
quel sapere lucido che è ricezione dell’opera del poeta. Da esso ricaviamo subito
due indicazioni fondamentali: 1) è il poetare che rende l’abitare un abitare, capovolgimento della consueta concezione del poetare, che vede in esso un luogo
ristretto nel mezzo del più grande spazio aperto dall’abitare; 2) è dunque necessario intendere il poetare come far abitare, pensando al tempo stesso l’esistenza
dell’uomo a partire dall’essenza dell’abitare stesso95.
L’uomo abita la terra affaccendandosi nell’ente che trova intorno a sé, ma a
differenza dell’animale che non può guardare in alto, a lui è concesso anche di
alzare la testa e volgere il viso al cielo per misurare, dice Heidegger, il frammezzo che lo separa dalla terra. Questa porzione che sta, appunto, tra la terra e il
cielo è quella assegnata all’uomo per il suo abitare; egli la misura ogni qual volta alza lo sguardo e si confronta con i celesti. Questa porzione assegnata all’uomo è la dimensione. Misurare la dimensione non è un’opzione tra le altre per
la vita dell’uomo, ad essa in ogni caso non può sottrarsi: anche trascurandola,
essa rimane latente nella sua essenza. Misurare la dimensione è ciò che solo dà
Id., Sentieri interrotti, cit., p. 100.
Ivi, p. 101(nota 14).
94 Id., Saggi e discorsi, cit., p. 26.
95 Cfr. M. Heidegger, «…Dichterisch wohnet Der Mensch…», in Vorträge und Aufsätze, trad.
it. «…Poeticamente abita l’uomo…», in Id., Saggi e discorsi, cit., p. 126.
92 93 Heidegger e l’urto del deinòn
37
le misure per il soggiorno dell’uomo. «Il misurare-disporre della dimensione è
l’elemento in cui l’abitare umano trova la sua garanzia, in base alla quale dura.
Il misurare-disporre è la poeticità dell’abitare. Poetare è un misurare»96. Questa misurazione, dunque, è vitale per l’abitare e essenziale per il poetare. Essa
concerne l’essenza stessa dell’uomo nella misura in cui egli non è il depositario
di questa. La misurazione, che prende piede in modalità bifronte, è un misurare sulla terra e allo stesso tempo, inscindibilmente, sotto il cielo: una misurazione diametrale. Questo prender-misure non avviene una volta e per tutte, non
mette al sicuro nessuna essenza, ma va costantemente sostenuto e ripetuto nel
percorrimento della dimensione. Colui che percorre la dimensione e prende le
misure per l’abitare, è colui che esercita la poeticità dell’abitare stesso, il poeta.
Questi non crea la misura, non la inventa, ma «lascia venire la misura che ci è
assegnata» e che altri non sanno accogliere perché non sono capaci di vederla.
Far-vedere la misura in immagini è la poeticità propria del poeta: le sue immagini non sono riproduzioni, bensì «immaginazioni come incorporazioni visibili
dell’estraneo nell’aspetto di ciò che è familiare»97. L’immagine fa segno verso
l’estraneo proprio perché la misura non viene da ciò che l’uomo tiene sotto di
sé, vicino a sé, ma dalla distanza che lo separa da ciò cui volge lo sguardo quando alza il capo. «Perciò il poeta deve necessariamente domandare: «C’è sulla
terra una misura?» E non può che rispondere: «Non ce n’è alcuna». Perché?
Perché ciò che nominiamo quando diciamo «su questa terra» sussiste solo in
quanto l’uomo abita la terra e nel suo abitare fa che la terra sia terra»98. Il cielo,
la distanza che ci separa da esso, è la misura. L’unica che, paradossalmente, ci
tiene con i piedi per terra. «Il poetare non trasvola oltre la terra né va al di là di
essa per abbandonarla e librarsi sopra di essa. Proprio il poetare porta invece
l’uomo sulla terra, lo porta ad essa, e lo porta così nell’abitare»99. È per questo
che possiamo finalmente «pensare l’essenza del poetare come far abitare, come
un costruire, e forse anzi come il costruire per eccellenza»100. Quel costruire cui
si può dar vita «in quanto vi sono dei poeti, uomini che prendono la misura per
l’architettonica, per la disposizione strutturata dell’abitare»101.
Tutto il discorso heideggeriano sull’abitare e sul costruire, sul misurare e
sul poetare è, in maniera lampante, un discorso sullo spazio, che, seguendo la
tesi di Peter Sloterdijk, si dispiega come l’inevitabile prosecuzione di ciò che,
Ivi, p. 131.
Ivi, p. 135.
98 Ibid.
99 Ivi, p. 128.
100 Ivi, p. 126.
101 Ivi, p. 136.
96 97 38
Andrea della Monica
nell’opera di Heidegger, è presente fin dall’inizio, in maniera neanche poi così
latente, se siamo d’accordo che «sotto il sensazionale titolo programmatico di
Essere e tempo, si nasconde anche una trattazione potenzialmente rivoluzionaria di essere e spazio»102.
In tedesco spazio si dice Raum, che, erede del più arcaico Rum, designa
qualcosa di sgombrato, di reso libero per un insediamento. «Ciò che così è
sgombrato, viene di volta in volta accordato e così disposto, cioè raccolto da un
luogo, cioè da una cosa del tipo del ponte. Di conseguenza, gli spazi ricevono la
loro essenza non dallo spazio, ma da luoghi»103. Ora questi luoghi, come lo è il
ponte, sono costruiti in maniera tale da poter accordare uno spazio che contiene numerosi posti. Questi posti si trovano tutti a determinate distanze gli uni
dagli altri; queste distanze sono intervalli tra punti. L’intervallo è ciò che è detto
nella parola greca stàdion e in quella latina spatium. Solo per mezzo di astrazione è possibile, è stato possibile, derivare la concezione dello spazio come
extensio, come spazialità misurabile scientificamente e trasponibile matematicamente in grafici. «Ma «lo» spazio in questo senso non contiene spazi e posti.
In esso non troveremo mai dei luoghi, cioè delle cose del tipo del ponte. Tutto
all’opposto, invece, è proprio entro gli spazi disposti e aperti dai luoghi che risiede ogni volta lo spazio inteso come intervallo, e a sua volta entro a questo lo
spazio inteso come pura estensione»104.
In un brevissimo testo del 1969 dal titolo L’arte e lo spazio, a sua volta rielaborazione di una conferenza tenuta nel 1964, Heidegger definisce lo spazio come
Urphänomen, fenomeno originario, che si configura in questa maniera perché
dietro di esso, «a quanto pare, non vi è nulla cui esso possa essere ricondotto. Di
fronte ad esso non è possibile distrarre la propria attenzione verso qualche altra cosa. Ciò-che-è-proprio dello spazio deve mostrarsi da se stesso»105. Dunque
l’essere sgombro, libero, aperto, dovrà avere origine dallo spazio stesso: questo
sarà allora un farsi libero, un aprirsi, un diradarsi. Ciò che, notoriamente, nella
filosofia di Heidegger si dirada, è quell’altro fenomeno originario nominato nella parola Lichtung106: apertura dell’essere, evento. Per quanto l’assonanza con la
parola Licht, luce, sia palese, Lichtung non fa riferimento ad una illuminazione,
102 P. Sloterdijk, Sphären I. Blasen (1998), trad. di G. Bonaiuti, Sfere I. Bolle, Meltemi,
Roma 2009, p. 325.
103 M. Heidegger, Bauen Wohnen Denken, in Vorträge und Aufsätze, trad.it. Costruire abitare
pensare, in Id., Saggi e discorsi, cit., p. 103.
104 Ivi, p. 104.
105 Id., Die Kunst und der Raum (1979), trad. di C. Angelino, L’arte e lo spazio, Il melangolo,
Genova 2000, p. 23.
106 Cfr. S. Regazzoni, Nel nome di chôra, Il melangolo, Genova 2008. In particolare il capitolo IV intitolato Essere e spazio, pp. 79-100.
Heidegger e l’urto del deinòn
39
bensì proprio all’aprirsi di uno spazio. «Il sostantivo Lichtung, radura, rinvia al
verbo lichten, diradare. L’aggettivo licht è la stessa parola che leicht, facile. Diradare qualcosa significa rendere qualcosa facile, aperto e libero, per esempio
liberare la foresta in un luogo dagli alberi. Lo spazio libero (das Freie) che così
sorge è la radura, Lichtung»107. La consonanza della Lichtung con il tema dello
spazio e la sua centralità nella tarda meditazione heideggeriana, ci confermano
dunque nella convinzione che il discorso sullo spazio dica qualcosa di essenziale per Heidegger.
Uno spazio, che, a differenza della staticità metafisica e scientifica della
extensio, è, possiamo azzardare, uno spazio in movimento, lanciato o inviato, si presenta nella sua evenemenzialità come un fare spazio. «Fare-spazio è
libera donazione di luoghi. Nel fare-spazio parla e si cela al tempo stesso un
accadere»108. Questo accadere appartiene all’ «evento che accorda luoghi». Solo
perché è l’accadere di un evento, dell’evento (Ereignis), esso può allo stesso tempo mostrarsi e celarsi. L’accordare dell’evento è una duplice disposizione, che
da una parte «lascia dominare l’aperto che fra l’altro assegna l’apparire delle
cose presenti cui un abitare umano si vede a sua volta assegnato», e dall’altra
«prepara per le cose la possibilità di appartenere a qualche luogo e a partire da
questo di porsi in relazione fra loro»109. L’evento del fare-spazio dispone quindi
un aperto e dei luoghi. In questo contesto l’aperto viene nominato da Heidegger
Gegend (o Gegnet, più arcaico), contrada, libera vastità in cui si dispongono,
nella loro coappartenenza, quelle che, giustamente, si è proposto di chiamare
cose-luoghi110, seguendo il suggerimento heideggeriano di «imparare a riconoscere che le cose stesse sono i luoghi e non solo appartengono a un luogo»111.
Nell’ambito di una discussione sull’arte figurativa, nel caso specifico della conferenza heideggeriana si tratta della scultura, il rapporto di questa
con lo spazio «dovrebbe essere pensato a partire dall’esperienza di luogo e
contrada»112, e quest’esperienza a sua volta pensata come un gioco «tra la libera
vastità di uno sfondo che si ritira e il venire alla presenza dei luoghi determinati
dagli enti»113. Mettere in atto tale proposito vuol dire pensare l’arte nella sua
duplice possibilità di porre o non porre in essere un confronto (Auseinanderset107 M. Heidegger, Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens, in Zur Sache des
Denkens (1969), trad. di E. Mazzarella, La fine della filosofia e il compito del pensiero, in Id.,
Tempo ed essere, Guida, Napoli 1998, p. 183.
108 Id., L’arte e lo spazio, cit., p. 27.
109 Ivi, p. 29.
110 S. Regazzoni, Nel nome di chôra, cit., p. 86.
111 M. Heidegger, L’arte e lo spazio, cit., p. 33.
112 Ibid.
113 S. Regazzoni, Nel nome di chôra, cit., ibid.
40
Andrea della Monica
zung) con lo spazio. Questo confronto ci appare qualcosa di ovvio: è il modo in
cui l’arte figurativa comprende se stessa, nel momento in cui si dispone a trovare di nuovo un luogo adeguato, inserendosi nella pianificazione territoriale
della civiltà industriale odierna114. Se però il confronto viene pensato nella modalità dell’Auseinander, come un porsi dei termini l’uno di fronte all’altro nella
distanza che li separa, allora l’arte, la scultura, non è «affatto un confronto con
lo spazio», né «una presa di possesso»115 di esso, bensì «il farsi-corpo di luoghi
che, aprendo una contrada e custodendola, tengono raccolto intorno a sé un
che di libero che accorda una dimora a tutte le cose e agli uomini un abitare in
mezzo alle cose»116.
Se dunque quello tra arte e spazio non è propriamente un confronto, il volume dell’opera non terrà più separati degli spazi, la superficie non delimiterà
il confine tra un interno ed un esterno dell’opera, tra l’opera stessa e il mondo
in cui si inserisce: proprio come «l’uomo non è delimitato dalla superficie del
suo presunto corpo»117 ma si configura come un essere-nel-mondo, l’opera, allo
stesso modo, è una modo di farsi del mondo stesso. Paradossalità di un circolo, per cui l’uomo si trova gettato in un mondo che si fa ad opera della sua
stessa opera. «L’uomo non fa lo spazio; […] piuttosto, lo spazio, per fare spazio
come spazio, necessita dell’uomo»118. Evenemenzialità dello spazio, apertura
della Lichtung, che si invia all’uomo come essere-per-l’uomo119, evenemenzialità
dell’opera d’arte come «farsi corpo della verità dell’Essere nella sua opera instaurante luoghi»120. L’istantaneità di quest’ultima Eraclito la coglie nell’immagine del Keraunòs, del fulmine di cui dice, nel frammento 64, che tà dè pàntha
oiakìzei, «governa l’essente nella sua totalità». Questo governare non è un comandare, ma un guardare dall’alto illuminando. L’illuminazione, come schiudersi della luce stessa, è alla base di un’altra immagine eraclitea, quella del pyr,
«fuoco che sorge eternamente» del frammento 30, il cui atto, secondo la traduzione interpretante di Heidegger, è quello di «dispiegare le distese» accendendosi e «ritrarre le distese» spegnendosi. «Distese» è la traduzione heideggeriana
di mètra, solitamente reso in maniera avverbiale con «secondo misura». Ora, tò
mètron in greco è l’ «unità di misura», ma, scrive Heidegger,
Cfr., M. Heidegger, Corpo e spazio, cit., p. 21.
Id., L’arte e lo spazio, cit., ibid.
116 Ivi, p. 33-35.
117 Id., Corpo e spazio, cit., p. 35.
118 Ivi, p. 37.
119 Ibid.
120 Id., L’arte e lo spazio, cit., p. 39.
114 115 Heidegger e l’urto del deinòn
41
ciò che è misurabile con l’unità di misura e con lo strumento di misurazione è la misura autentica, ciò che è misurato e che deve essere
misurato, vale a dire la dimensione, l’aperto, la radura luminosa, che si
distende e si dispiega. […] La locuzione mètra indica le misure nel senso
originario delle distese che si aprono e si chiudono, nelle quali si possono
perdere gli sguardi della vista umana […]. Il fuoco che sorge eternamente
non si regola «secondo» misure, ma dà la misura […]121.
L’opera d’arte non è il fuoco stesso, e non può esserlo perché questo fuoco
è quell’ordinamento, quel kosmos che Eraclito dice non essere stato prodotto
da «nessuno degli dèi o degli uomini». L’opera, però, può essere il varco in cui
questo fuoco dispiega le distese e dà le misure: l’arte non può fare altro che
prendere le misure a queste distese in vista di un auspicabile abitare poetico
della terra da parte dell’uomo.
Nell’ambito di questo rivolgimento poietico dell’abitare umano, il pensiero
stesso subisce una torsione di non poco conto, che gli conferisce nuova linfa
paradossalmente proprio a partire da quella situazione di sradicamento e assenza di pensiero evocata all’inizio, come l’emergenza che s’impone alla nostra
attenzione. Scrive Heidegger al termine di un saggio che lega a doppio filo la
questione dell’abitare con quella del pensare:
La vera crisi dell’abitare consiste nel fatto che i mortali sono sempre
ancora in cerca dell’essenza dell’abitare, che essi devono anzitutto imparare ad abitare. Non può darsi che la sradicatezza dell’uomo consista
nel fatto che l’uomo non riflette ancora per niente sulla autentica crisi dell’abitazione riconoscendola come la crisi? Tuttavia, appena l’uomo
riflette sulla propria sradicatezza, questa non è più una miseria. Essa
invece, considerata giustamente e tenuta da conto, è l’unico appello che
chiama i mortali all’abitare122.
Se dunque è nello sradicamento che si annida la possibilità di un richiamo
all’abitazione, se è nel capovolgimento del quantitativo in una sua propria qualità che il nulla del mondo tecnico fa segno verso l’essere, se è dove c’è il pericolo, insomma, che cresce anche ciò che salva, allora sarà proprio nella situazione
di assenza di pensiero che esisteranno per quest’ultimo nuove possibilità. Là
121 122 Id., Eraclito, cit., p. 113.
Id., Saggi e discorsi, cit., p. 108.
42
Andrea della Monica
dove la rappresentazione, portata alle sue estreme conseguenze, viene sublimata nel Gestell, là dove l’oggettività trapassa nell’inoggettività del Bestand, là dove
il mondo è coperto da un’ombra invisibile, là c’è terreno fertile per un nuovo
pensiero. Questo pensiero fonda la propria novità su un gesto allo stesso tempo
caparbio e umile. La sua caparbietà consiste nel ripercorrere storia ed essenza
del pensiero tradizionale, nel senso di quella destruktion della storia dell’ontologia come metafisica che si rende necessaria nella misura in cui «noi [moderni]
possiamo soltanto imparare a pensare, se disimpariamo radicalmente l’essenza
del pensiero che è durata fino ad oggi. Ma per far questo è necessario che noi al
tempo stesso ne facciamo la conoscenza»123. L’umiltà starebbe invece in un’opera di smitizzazione del pensiero stesso e delle sue potenzialità, che lo liberi da
quei compiti, cui il pensiero tradizionale credeva di dover attendere. Heidegger
li sintetizza in quattro punti celeberrimi:
1. Il pensiero non porta al sapere come vi portano le scienze.
2. Il pensiero non comporta una forma di saggezza utile alla vita.
3. Il pensiero non risolve gli enigmi del mondo.
4. Il pensiero non procura immediatamente forze per l’azione124.
Ma che cosa fa, allora, il pensiero, se esso si svincola dal tradizionale atteggiamento teoretico e non deve più approntare la giustezza di un comportamento pratico? Questo pensiero, nella misura in cui trova se stesso come pensiero
dell’essere (e non più dell’ente, dominio della rappresentazione e del Ge-stell),
«supera ogni contemplazione, perché si prende cura della luce in cui solo può
dimorare e muoversi un vedere inteso come theorìa. Il pensiero è attento alla
radura dell’essere in quanto colloca il suo dire dell’essere nel linguaggio come
dimora dell’e-sistenza. Così il pensare è un fare. Ma è un fare che supera ogni
prassi»125. Un’aver-cura dell’essere come risposta all’appello, che sola lascia essere l’essenza dell’uomo nel suo rapporto fondamentale: è solo in questo rapporto che l’uomo dispiega l’essenza che egli non possiede, perché traspropriata126 a quella verità che abbisogna dell’uomo stesso: «pretender di scorgere l’essenza dell’uomo senza rivolgere lo sguardo all’uomo! »127.
Anche il pensiero, che si è sempre pensato come domanda, è una risposta a
Id., Che cosa significa pensare?, cit., p. 42.
Ivi., p. 264.
125 Id., Segnavia, cit., p. 312.
126 Id., L’abbandono, cit., p. 71.
127 Ivi, p. 47.
123 124 Heidegger e l’urto del deinòn
43
qualcosa che lo precede. Anch’esso, dunque, non detiene in sé l’essenziale. «Se
è vero che il pensiero contraddistingue l’essenza dell’uomo, potremo scorgere
l’essenziale di questa essenza, cioè l’essenza del pensiero, soltanto volgendo lo
sguardo via dal pensiero»128. L’essenza dell’uomo e del pensiero via dall’uomo e
dal pensiero!
Volgere lo sguardo per afferrare l’essenziale, però, non può avvenire nella modalità abituale dell’indagine teoretica, ma solo installandosi in un’attesa.
Esso attende di essere fatto proprio dalla contrada, ed è quest’attesa di appropriazione che Heidegger chiama Gelassenheit, abbandono. Lungi dal determinare un lassismo del pensiero, l’abbandono è possibile solo come decisione, che
si decide, appunto, per il dispiegarsi della verità. Mantenersi decisionalmente
nell’attesa è il tratto distintivo di un perseverare nella sosta. Questo «perseverare in seno alla contrada, perseverare che in sé si acquieta», Heidegger lo
chiama Iständigkeit, insistenza. Il termine, però, non richiama la violenza di un
approccio, bensì lascia trasparire la dolcezza di un approssimarsi, alla maniera
della parola di Eraclito che da sola costituisce il frammento 122: Anchibasìe,
un andare-nella-prossimità, che è anche un lasciarsi-ricondurre-nella-prossimità. Anchibasìe è il ritmo di quel passo che noi «come viandanti, nelle vicinanze dell’essere»129, dobbiamo tenere, secondo Heidegger, per far fronte alla
condizione di spaesamento (Heimatlosigkeit) in cui ci troviamo e per ritrovare,
proprio in questa vicinanza, la patria (Heimat) di un possibile abitare storico. Questo cammino del viandante non deve avere paura di perdersi su sentieri interrotti, né il pensiero deve temere di «infrangersi sulla durezza della sua
cosa» perché «c’è un abisso tra il «filosofare» sul naufragio e un pensiero che
davvero naufraga. Non sarebbe un male se mai un pensiero del genere riuscisse a un uomo. Gli sarebbe fatto l’unico dono che possa venire al pensiero da
parte dell’essere»130. Ma il naufragio è possibile solo a chi si è già avventurato
sul mare, solo a chi si è aperto all’evento. E infatti, rispondendo ad un quesito
postogli da Jean Beaufret, che gli chiede «come salvare l’elemento d’avventura»
del pensiero «senza fare della filosofia una semplice avventuriera», Heidegger
esemplarmente risponde:
[…] il pensiero non è une aventure solo perché è un cercare e un interrogarsi sul non-pensato. In quanto pensiero dell’essere, il pensiero è
reclamato nella sua essenza dall’essere. Esso si rapporta all’essere come
Ibid.
Id., Segnavia, cit., p. 297.
130 Ivi, p. 296.
128 129 44
Andrea della Monica
all’ad-venente (das Ankommende, l’avenant). Il pensiero è legato in quanto pensiero all’avvento (Ankunft) dell’essere, all’essere come avvento131.
Questo legame all’essere come attesa del suo avvento è la vera e propria avventura del pensiero, un avventurarsi che non va da nessuna parte, che si avventura sul posto, potremmo dire, come riferimento «estatico» dell’essenza dell’uomo alla verità dell’essere132: declinazione ultima di quel thaumàzein, di quello
stupore dinanzi all’essente fin dalla grecità additato come origine del filosofare,
che con Heidegger si prolunga nel suo proprio télos.
5. Heidegger tra verticalità e mostruoso nella lettura di Peter Sloterdijk
Sloterdijk usa per Heidegger una formula insolita: egli sarebbe il pensatore
nel movimento. «Il suo pensiero originario o, per così dire, il suo modo di procedere, è il salto, o l’abbandonarsi a un essere situati, in cui egli non trova più,
in se stesso e “sotto i suoi piedi”, altro che la motilità. In lui la cinetica precede
la logica […]: il movimento è il suo fondamento»133. Sloterdijk vede nel Dasein
di Essere e tempo un cogito cinetico che, caratterizzato dal suo esser-gettato
(Geworfenheit), è già sempre messo in movimento, dal movimento preceduto
e agito. «La sua motilità è la ragione della sua storicità e del suo riferimento all’aperto. […] Dasein significa essere tenuto immerso nel sopravvenire del
movimento»134. In questa situazione, in cui già da sempre ci troviamo, la possibilità di pensare ci è data solo come corrispondenza al sopravvenire su di noi
della motilità stessa. Il pensiero non è più imitazione di un essere ipostatizzato
nella sua immobilità, bensì ripetizione del movimento che ci precede, reiterazione del caso. Nella ripetizione, però, il caso non permane a lungo in quanto
tale: «attraverso la ripetizione approfondiamo così tanto il caso, che esso comincia ad avvicinarsi a una necessità, forse persino a una “verità”. In tal modo,
la ripetizione diviene la madre della meditazione. La meditazione si introduce
nell’inaggirabile, nell’insovvertibile, in ciò che si fa evento una volta soltanto»135.
È evidente come si tratti di una ripetizione sul posto alla maniera del riferimento estatico all’aperto che abbiamo detto essere, per Heidegger, l’unica avventura
Ivi, p. 313-314.
Ivi, p. 286.
133 P. Sloterdijk, Nicht gerettet. Versuche nach Heidegger (2001), trad. di A. Calligaris e S.
Crosara, Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger, Bompiani, Milano 2004, p. 19.
134 Ivi, p. 20.
135 Ivi, p. 21.
131 132 Heidegger e l’urto del deinòn
45
possibile per il pensiero: una motilità vorticosa, concentrica, mai protesa. Il
movimento compiuto da Heidegger è propriamente un “soggiornare” nella contrada, mentre il suo andare per sentieri non ha nulla di simile al cammino del
viaggiatore. «I suoi “sentieri” non devono condurre in nessun altro luogo se non
là dove l’esistenza già da sempre è»136. Possono perdersi nella selva solo perché
sono già da sempre in essa, sono sentieri interrotti fin dall’inizio!
Questa particolarissima declinazione del pensiero denota, secondo Sloterdijk, un caratteristico disinteresse da parte di Heidegger per la dimensione orizzontale della motilità, a dispetto di un privilegio accordato a quella verticale. La
verticalità, discendente quanto ascendente, è la vera cifra del pensiero di Heidegger in entrambe le sue fasi: l’uomo in quanto Dasein discende in se stesso e
a se stesso approda come apertura dell’essere e all’essere, ma egli discende anche in quanto può decadere nella dispersione della molteplicità dell’ente; anche
l’essere, poi, può configurarsi in maniera discendente alla maniera dell’immagine eraclitea del fulmine, come evento che dà misura all’essente, oppure come
squarcio aprentesi nell’opera d’arte; ascendente è il moto compiuto dall’uomo
nell’effettuare la succitata misurazione poetica della dimensione, distanza da
abitare tra terra e cielo. Se Heidegger vuole presentarsi come un pensatore onto-cinetico, egli allora per Sloterdijk è ontocinetico solo a metà137, operatore di
una «profondità senza ampiezza»138. Mentre questa verticalità si configura per
l’essere-del-mondo come Ereignis, evento, e per il Dasein come essere-nel-mondo, Sloterdijk propone piuttosto di parlare di venire-al-mondo: «l’entrare nel
mondo dell’esistente non accade solamente o anche solo primariamente lungo
la verticale, e tale entrare non ha nemmeno soltanto o innanzitutto i tratti di un
dramma della perdita di sé. Piuttosto, il venire al mondo viene compreso come
un dispiegarsi sulla superficie»139. Questo dispiegamento è allo stesso tempo
caratterizzato dal movimento come trasferimento, esodo, progetto, conquista
o, in una parola retaggio di Hegel, Erfahrung, esperienza, un aver-a-che-fare
cumulativo che è il vero leitmotiv dell’umanità mondana.
La nascita infatti è sempre già una sintesi tra la caduta verticale e
l’entrata nel mondo orizzontale. Proprio per tale ragione i “mortali” possono essere definiti come coloro-che-vengono-al-mondo. Ma si potrebbe
anche dire, tenuto conto del potenziale tragico, creativo, criminale e tecIvi, p. 40.
Ibid.
138 Ivi, p. 30.
139 Ivi, p. 31.
136 137 46
Andrea della Monica
nico di questa specie eccentrica: coloro-che-vanno-lontano. L’esperienza,
che continuamente si arricchisce, mette sempre più in rapporto il casuale e il singolare con ciò che è interdipendente. Essa è il potere di inserimento par excellence: quanto più il pensiero dell’esperienza è consapevole della sua forza, tanto più decisamente esso tiene in scacco la verticale
attraverso l’orizzontale140.
Questo scacco è la presa dell’essere umano da parte dell’ulteriorità, di ciò
che eccede l’uomo stesso, il suo ambiente, la sua situazione: gli uomini sono
«esseri-del-trasferimento, che non possono sottrarsi a ciò che, di volta in volta,
li porta altrove».
Quando gli uomini entrano nell’ambito della storia degli stati e di
una tecnica più evoluta, fanno la scoperta di essere creature che, oltre
alle cure domestiche e concrete, vengono coinvolte anche in faccende
grandi, nobili e lontane. Anche se volessero limitarsi ai propri affari, il
grande e il senza misura non darebbero loro pace. E dal momento in cui
ciò li riguarda, essi sono condannati al divenire-padroni e a subire il loro
aumento di potere141.
Presi nella motilità di un Gestell positivo, gli uomini sono condannati a divenire adulti corrispondendo alla sfida della crescita: è questa corrispondenza il
compito più difficile e affascinante che è cifra della modernità, dalla quale non
siamo ancora stati salvati, secondo il titolo sloterdijkiano, perché non dobbiamo
esserlo. È proprio il potenziale tecnicamente creativo della specie umana, che
Heidegger non avrebbe voluto prendere del tutto positivamente in considerazione. «Egli si rivolge ai suoi uditori come se potessero essere colpiti in ogni
momento dall’impatto verticale del mostruoso»142. Ma non riconosce, o meglio,
non si riconosce nel fatto che «la modernità è l’epoca del mostruoso fabbricato
dall’uomo»143. Ungeheuer è la parola tedesca tradotta con mostruoso, ma a sua
volta essa traduce il greco deinòn, l’inquietante. Se l’uomo è il deinòtaton, nella
modernità è perché egli non è più solo la piega estrema dell’essere, del deinòn
originario che fende pur rimanendo ad esso rivolto, bensì è il-più-inquietante
perché è continuamente proteso verso una successiva piega che con l’essere
Ivi, p. 32 (corsivo mio).
Ivi, p. 31 (corsivo mio).
142 Ivi, p. 293.
143 Ivi, p. 294.
140 141 Heidegger e l’urto del deinòn
47
non ha più nulla a che fare, quel mostruoso da lui prodotto, che si concretizza
nelle opere del mondo globalizzato, nei prodotti della scienza, della comunicazione, della tecnica e dell’arte. Heidegger farebbe ancora parte, secondo Sloterdijk, di quella teorizzazione del mostruoso che appartiene alla metafisica classica, nella misura in cui questa intendeva guardare alla totalità dell’ente come
al «più grande tra tutti gli spazi domestici possibili», identificando il mondo
con la patria:
la metafisica classica infatti era rappresentata dall’impresa di rendere gli uomini innocui facendone degli abitanti temporanei di una casamondo eterna. Essa diede voce al mostruoso, indicandolo immediatamente come il dio che rivelandosi o avvenendo rende noi mortali completamente passivi. Nella metafisica classica il mostruoso è soltanto una
possibilità del dio, e perciò la teoria del sublime nell’epoca della metafisica può entrare in scena solo come teologia144.
Se non ce la sentiamo di ridurre l’eredità heideggeriana all’invocazione secondo cui «solo un Dio ci può salvare», dobbiamo almeno riconoscere che la
sua visione del mostruoso è ascrivibile a quella appena delineata, nella misura
in cui vede in esso qualcosa che, esulando totalmente dalle possibilità e capacità umane, può mostrarsi all’uomo solo colpendolo in una situazione in cui
egli si è appena predisposto, e nulla più, a quest’evento. «La teoria moderna
prende avvio invece dalla mostruosità delle possibilità umane», «la modernità
è essenzialmente l’epoca del trasloco fuori dalla casa dell’essere: essa è l’ora
del crimine del mostruoso»145. E se è di crimine che si parla, è perché l’officio
dell’uomo dinanzi al mostruoso non è più quello della testimonianza, bensì della corresponsabilità: da teste che era, l’umanità intera passa sul banco degli imputati. Sloterdijk vede nella modernità e nella sua crescente artificializzazione
una «progressiva conquista del nulla», e quest’ultimo «come l’elemento proprio
della capacità di progredire. Se all’essere si corrisponde attraverso il pensiero,
allora al nulla si corrisponde facendo dei salti arrischiati nelle operazioni del
volere, dell’agire, del comporre; […] nel nulla non c’è niente da riconoscere, ma
tutto da fare»146. Sarebbe questo il senso più genuino della critica iperbolica di
Nietzsche, il quale avrebbe sostituito «l’iperbole del logos con l’iperbole dell’arte». Secondo Sloterdijk la metafisica ha sempre mascherato i suoi eccessi, o
Ibid.
Ivi, p. 307.
146 Ivi p. 215.
144 145 48
Andrea della Monica
quanto meno li ha giustificati «attraverso la solidità dei fondamenti su cui costruiva i suoi sistemi discorsivi»: Heidegger avrebbe sì riconosciuto nell’obbligo
di fondazione «una macchinazione della soggettività, caratterizzata dall’aspirazione al potere e alla sicurezza», ma non avrebbe fatto propria la proposta
nietzscheana di «emancipazione dell’eccesso dall’obbligo di fondazione», secondo la quale, in sostanza, «l’hypokeìmenon deve essere inteso già come un
hyperkeìmenon, il subiectum come un superiectum, la volontà di potenza come
il capriccio dell’eccesso. Ciò che apparentemente sta alla base di tutto è in verità qualcosa che viene scagliato verso l’alto»�. E anche “in avanti”, secondo la
motilità orizzontale che si presta a strutturare l’era moderna più che qualunque
epoca precedente.
Sloterdijk non cela la consapevolezza di trovarsi, come Heidegger, nello
stato d’emergenza proprio della modernità, ma non può condividere fino in
fondo la via d’uscita heideggeriana come richiamo ad una nuova istanza di radicamento: con la sua tendenza all’abbandono e al soggiorno come sospensione
della volontà di potenza, quello di Heidegger è un pensiero che avrebbe il merito di non poter «finire in conquista o in un’opera missionaria poiché, visto il
suo carattere meditativo e di raccolta, esso è costituito in modo antiespansionistico»; la difficoltà sta nel fatto che si tratterebbe di «un pensiero per un’epoca
post-missionaria, post-scientista, post-universalistica, post-volontaristica. Ma
una tale epoca non c’è»147. Se la soluzione, dunque, non è da ricercare nel verticalismo dell’Heidegger più attendista, nemmeno il più sfrenato orizzontalismo
tecnico si dimostra capace di una sana autosufficienza nel modo in cui si trova declinato attualmente. Non di un passo indietro, ma di un potenziamento
d’autoconsapevolezza c’è bisogno, al fine di privilegiare le tendenze più genuine
internamente all’orizzontalismo stesso. Non si tratta allora di “tenere in scacco l’orizzontale attraverso la verticale” in una sorta di rivincita di un ipotetico
Dasein autentico, bensì di mettere al centro, nell’orizzontale stessa, la tendenza
strutturale della filosofia del movimento heideggeriana: non adagiarsi nel movimento che ci sopravviene, ma rilanciarlo all’ennesima potenza affinché qualcosa di straordinario avvenga. Sloterdijk porta alla nostra attenzione un’immagine sorprendente, che non esita a definire «il pensiero più sconvolgente dell’epoca moderna»: si tratta dell’impresa compiuta dai marinheiros portoghesi del
XV secolo, quando decisero di affrontare la sfida dei venti atlantici con l’idea di
trovare nel mezzo dell’oceano un’altra costa lontana da quella europea.
147 Ivi, p. 41.
Heidegger e l’urto del deinòn
49
I navigatori portoghesi si fidanzarono, tanto metaforicamente che in
senso reale, con i venti dominanti. Essi si affidarono – dapprima nei loro
pensieri e poi su delle vere navi – alle brezze che soffiano costantemente dalle coste occidentali dell’Europa lontano verso l’oceano. A bordo di
quelle imbarcazioni essi oltrepassarono quel confine dopo il quale non
c’era più una ragionevole speranza di ritorno, e si lasciarono portare
nell’aperto dall’aliseo, con un impegno senza condizioni delle loro navi e
delle loro vite. […] La loro idea, che si veniva chiarendo gradualmente,
era di percorrere il mare aperto tenendo ostinatamente una rotta verso
ovest dinanzi all’aliseo del nord, fino a imbattersi, vertiginosamente lontano, nelle zone del vento dell’ovest da cui si poteva guadagnare la spinta
del vento per il ritorno. Questa audace manovra, che presto divenne così
usuale (si dice che, eccetto i capitani, nessuno più ci fece caso), ricevette
dalla gente di mare portoghese un nome risonante: volta do mar, la svolta
del mare. Essa è, per così dire, la Kehre d’alto mare148.
Non di una svolta come capovolgimento, non di una rivoluzione nel segno
dell’“anti” – anti-tecnica, anti-capitalistica, anti-scientifica, anti-mediatica – abbiamo bisogno, ma di una svolta come superamento, la cui spinta propulsiva generi una piega ulteriore in avanti come «svolta della tecnica contro la tecnica»,
«del capitale contro il capitale», «delle scienze attraverso le scienze» e «dei media contro se stessi»149. Si tratta di reperire nella filosofia di Heidegger il propellente cinetico adatto ad un movimento utopico d’ampio raggio, di rintracciare
una protensione nella vorticosità, una differenza di potenziale nell’abbandono
e una tendenza al viaggio nella permanenza, facendo detonare dall’interno il
cuore infiammabile di questo pensiero. Soggiornare sì, ma senza fuggire, piuttosto abitando coraggiosamente l’occhio ciclonico dello spaesamento stesso;
guardare negli occhi il deinòn e da esso lasciarsi guardare, solo così l’uomo può,
perché deve, assumere coscientemente ed energicamente il deinòtaton come il
ruolo che solo a lui appartiene. Essere i marinheiros del XXI secolo, è questa la
sfida che ci attende.
148 149 Ivi, p. 59-60.
Ivi, p. 61-62.
La comune, assoluta solitudine delle cose. Jean Genet e l’opera di Alberto Giacometti
51
La comune, assoluta solitudine delle cose.
Jean Genet e l’opera di Alberto Giacometti
Memoria di Francesco Russo
presentata dal socio naz. ord. res. Aldo Trione
(seduta del 25 marzo 2010)
“Più siamo noi stessi, più diventiamo chiunque”
Alberto Giacometti
“Solo un certo genere di verità, quelle indimostrabili o
addirittura “false”, quelle che non possiamo spingere
all’estremo senza sfiorare l’assurdo e senza finire per
negarle negando insieme noi stessi – solo quelle l’opera
d’arte deve celebrare. Non avranno mai la fortuna o la
sfortuna di essere messe in pratica. Possano vivere nel
canto in cui sono mutate e che suscitano”
Jean Genet
Abstract. The paintings and sculptures of Alberto Giacometti through Jean Genet’s view:
Giacometti’s art and Genet’s writing are arranged within an aesthetic crossing that discloses
a cut that, by dissolving all the meanings, opens up the possibility for a different ethos, about
the sense of the making itself, outlined in the enigma of the being and the being here. The
enigma that is found in each of Giacometti’s heads, as in the smallest of his marks where the
common and radical solitude of all things can be found, that represents the zero degree of
the being, where each thing is without any reserve: from here all of the critical inquiry, from
Sartre to Bonnefoy and from Bataille to Nancy, begins.
1.
Sembra che ogni scultura, e in particolare la scultura di Giacometti, sia una
domanda che non smette di finire; questo non solo perché nessuna “scultura ne
spodesta mai un’altra”1, ma perché essa “non è un oggetto, è un interrogativo,
una domanda, una risposta. Non può mai essere né finita né perfetta. La que1
A. Giacometti, Scritti, Milano 2001, p. 112. Lo scritto, da cui le citazione sono tratte, è
L’automobile smitizzata, composto da Giacometti nel 1957 per rispondere alla domanda: “Che
relazione esiste tra l’arte della scultura e la bellezza dell’automobile?”.
52
Francesco Russo
stione non si pone nemmeno. Per Michelangelo, con la Pietà Rondanini, la sua
ultima scultura tutto ricomincia”2.
Essa è tale non solo in relazione a se stessa, al suo dismettere lo statuto
stabilizzato dell’oggettività, essendo come percorsa e legata, anche nella sua
ultima figura, anche nel suo apparire terminata, finita, al movimento del reiniziare – ma soprattutto perché non smette, in quanto opera d’arte, di porre in
questione il senso e la forma stessa della prassi, l’intero complesso della te@cnh
che l’uomo dispiega nel mondo.
Aprendo il suo saggio, L’atelier di Giacometti, Jean Genet inizia dalla pena, o
forse dal vero e proprio terrore, da cui si è colti nel momento in cui si riconosce
che la prassi umana non può che incidere sulle sole “manifestazioni visibili”3
del mondo, e che il mondo ne risulta alterato, modificato solo sulla superficie;
in quanto resistente alle molteplici pratiche messe in atto dall’uomo e svelante
così la sua costitutiva impotenza; l’orizzonte della manifestatività risalta nella
sua inumanità, nella sua inevitabile ineluttabilità.
Ma insieme al terrore nasce la nostalgia – come nostalgia di un differente, e
futuro regime della te@cnh, il quale “anziché accanirsi con tanto furore sull’apparenza visibile, si fosse applicato a sbarazzarsene, cioè a rifiutare non solo
qualsiasi intervento su di essa, ma a denudarsi quanto basta per scoprire, in
noi stessi, quel luogo segreto che avrebbe reso possibile un’avventura umana
del tutto differente”4.
Questa ancipite, ineliminabile consentaneità di terrore e nostalgia si presenta come uno dei nodi fondamentali per confrontarsi con l’opera di Alberto
Giacometti: in essa ogni persona, ogni cosa, anche la più piccola, o ciò che
soltanto appare tale, accresce l’intollerabile, l’inumano, si espone come un radicale antiumanismo, aprendosi a quella estraneità che emerge ogni qual volta lo
sguardo si libera dalle schermature che lo velano (e forse anche lo proteggono)
nell’atto stesso di incontrare una delle sue sculture o uno dei suoi quadri; ma
proprio in tale atto cresce di pari grado quella nostalgia di un altro, possibile
attraversamento del mondo: “E allorché gli riesce di spogliare l’oggetto o l’essere prescelto da ogni apparenza fallace e utilitaristica l’immagine che ne offre
non ha eguali”5.
È allora ancora una volta l’arte che, denudando il mondo della sua signifi-
Ibidem.
J. Genet, Il Funambolo, Milano 1997, p. 141. Il saggio di Genet è stato originariamente
pubblicato nel 1957, nel catalogo della mostra svoltasi presso la galleria Maeght.
4
Ibidem.
5
Ivi, p. 142.
2
3
La comune, assoluta solitudine delle cose. Jean Genet e l’opera di Alberto Giacometti
53
catività pratico-utilitaristica, misurabile ed economica, lo estranea seguendo il
darsi della cosa stessa, approfondisce la Unheimlichkeit della propria e comune dimora, ma così facendo rinviene un diverso abitare (Unheimlichkeit), un
altro, forse ou-topico, h±qov. Questa la possibile esperienza alla quale la pittura
e la scultura di Giacometti sembra concedere un accesso, e in cui la scrittura
di Genet indefinitamente indugia, si arresta e continua, ancora ed ancora, a
sostarvi.
2.
La solitudine appare esser la cifra del percorso artistico di Giacometti: non
certo nel senso storico-biografico (che non avrebbe alcun rilievo), dell’isolamento e della rottura, quella che maggiormente avrebbe potuto segnarlo, avvenuta con il gruppo surrealista, ma in quello che ne consegna, tra i suoi numerosi tentativi e le sue differenti prove, l’unicità assoluta: non solo in relazione
ai movimenti d’avanguardia del Novecento, ma all’interno dell’intero arco della
storia occidentale dell’arte.
Yves Bonnefoy ha scritto che se si dovesse riconoscere un carattere unificante di questa storia, esso dovrebbe esser rinvenuto nella “fiducia nel linguaggio, nei suoi aspetti concettuali”6; quella fiducia che impronta di sé l’età della
mimesi, in cui viveva “un’arte che amava rappresentare quello che credeva di
vedere”7; ad essa segue la rottura e la scomposizione della visione unitaria incardinata nel discorso concettuale e nei suoi modi di organizzazione; ora è
possibile che si esplorino “le virtualità del linguaggio”8, che ci si addentri nel
complesso plurale degli altri sistemi segnici, dove l’uno non si prospetta come
escludente gli altri, ma è rispetto ad essi compossibile. Per Bonnefoy la composizione della parola viene destrutturata nei segni che la formano, i quali, non
solo non sono afferrabili e determinabili da un unico centro, ma al contrario
sono proprio essi a porsi come fattori determinanti, e in fondo, perfettamente
autonomi: esperienza, che in particolare nella pittura novecentesca, ha lasciato
che “i loro elementi significanti si accordassero tra loro, decidessero tra loro”9,
in uno spazio astratto e puro, in quanto i segni non più subordinabili né ad una
presunta esteriorità naturale da imitare, né ad un’intenzionalità cosciente e creativa propria dell’artista.
Y. Bonnefoy, Osservazioni sullo sguardo. Picasso, Giacometti, Morandi, Roma 2003, p. 52.
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Y. Bonnefoy, Alberto Giacometti, Milano 2004, p. 12.
6
7
54
Francesco Russo
A tutto questo il progetto di Giacometti non prende parte (e non certo, come
erroneamente si potrebbe essere portati a credere, perché si porrebbe come
volto a restaurare forme figurative della tradizione o modelli ormai tramontati, ma operanti solo nell’impresa di un soggetto artistico volontaristicamente,
o caparbiamente, “prometeico”) : la sua necessità è di dirigersi “alla cosa che
esiste adesso”10 – all’evidenza dell’esistente, che vive di una strana trascendenza
non divina, e che è, in uno, l’esigenza del farne esperienza, nell’istantaneità del
suo offrirsi. In tal modo Giacometti è capace di evitare, sempre secondo quanto
scrive Bonnefoy, il pericolo a cui è esposta quell’arte, che ricombinando ludicamente forme e materiali segnici, rischia di obliare le inquietudini, i bisogni
dell’esistenza, e soprattutto il fatto che “questi segni non sanno più niente del
tempo, più niente del caso che condiziona la vita, più niente, in una parola,
della morte, ed essi non possono che distogliere l’artista da quell’enigma che è
il fatto di essere”11.
In una pagina dei taccuini, datata 1929, Giacometti annota come tutta la
“nostra attività non è che una continua interrogazione posta all’universo che
noi stessi siamo. Per ognuno di noi il mondo è come una sfinge di fronte alla
quale noi continuamente stiamo”12, ragion per cui è richiesto il più acuto sforzo
di attenzione e di apertura per registrare “ciò che sentiamo o ciò che crediamo
di sentire”13; questo mondo “può essere paragonato a un blocco di cristallo dalle
innumerevoli sfaccettature”14 e la difficoltà consiste nel cogliere, mediante un
quadro, una scultura, una poesia un’esatta sfaccettatura, e nel realizzare “un
esatto riflesso di questa diversità di angoli e posizioni”15. Quanto sarà ottenuto, nella pur costante reinvenzione, è “un taglio nuovo, uno spazio nuovo, la
più piccola porzione di uno spazio nuovo”16, percepito in penombra, appena
toccato dalla luce, stagliato e ritagliato “entro l’ignoto denso, opprimente, che
ci attornia, ci tocca, ci avviluppa e che colma ognuno degli atomi di cui siamo
fatti”17.
È la domanda del mondo dello spazio e dello spazio del mondo: “Lo spazio
– appartiene al dominio di quei fenomeni originari (Urphänomenen) che, secondo quanto dice Goethe, al loro contatto provocano nell’uomo una sorta di paura
Y. Bonnefoy, Ossevazioni sullo sguardo, cit., p. 53.
Y. Bonnefoy, Alberto Giacometti, cit., p. 21 (corsivo mio).
12
A. Giacometti, Scritti, cit., p. 159.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ivi, pp. 159-160.
10
11
La comune, assoluta solitudine delle cose. Jean Genet e l’opera di Alberto Giacometti
55
che si impadronisce di lui fino all’angoscia? Infatti dietro lo spazio, a quanto
pare, non vi è nulla cui esso possa esser ricondotto. Di fronte ad esso non è possibile distrarre la propria attenzione verso qualche altra cosa. Ciò-che-è-proprio
dello spazio deve mostrarsi da se stesso (muss sich vom ihm selbst her zeigen).
Ma ciò-che-è-proprio dello spazio lo si può ancora dire?”18.
3.
Assieme al problema dell’afferramento e della rimodulazione dello spazio,
nella scultura di Giacometti si raggruma una differente esperienza del tempo:
Genet scopre come tutte quelle statue siano insieme “familiari” e lontanissime:
“sono in fondo al tempo, all’origine di tutto, non cessano di avvicinarsi e indietreggiare in una sovrana immobilità”19: l’elementarità dei loro gesti (camminare, esser sul punto di cadere, sollevare un arto) e delle loro posture si flette
in un’immobile oscillazione temporale rivolta altrove, poiché ogni opera d’arte
“deve, sin dal momento della sua elaborazione, ripercorrere con pazienza e applicazione i millenni e raggiungere se può l’immemore notte popolata di morti
che in quest’opera si riconoscono”20.
Oscillando tra essere e nulla, aprendo un incontrollabile spazio di vibrazione è allora possibile che, benché “qui presenti, dove sono le figure di Giacometti, se non nella morte? Le sfuggono, a ogni richiamo del nostro occhio,
per avvicinarsi a noi”21: qui, vicine e lontanissime, sospese in una paradossale,
distante prossimità.
Ciò che lega intimamente il nostro corpo a quelle sculture sembra esser dovuto al permanere la scultura un’arte, in ogni caso, “fondamentale, originaria,
primitiva. Perché? Perché da essa nascono le cose. In essa, per mezzo di essa, il
18
M. Heidegger, L’arte e lo spazio, Genova 2000, p. 23 (prima edizione tedesca pubblicata
nel 1969, come rifacimento di una precedente conferenza del 1964, letta da Heidegger per la
mostra delle sculture di B. Heiliger, ed intitolata Raum, Mensch und Sprache. Riprendendo
questa stessa domanda: “Ma cos’è dunque lo spazio – in ciò-che-gli-è-proprio? Cosa dà allo
spazio la possibilità d’essere qualcosa che riceve, avvolge e trattiene? Su cosa si fonda ciò che
Aristotele determina come to@pov e cw@ra, e l’era moderna come extensio e spatium e la fisica
moderna come campo di forze?” (M. Heidegger, Corpo e Spazio. Osservazioni su arte – scultura
– spazio, Genova 2000, p. 31; qui si riproduce la prima forma del testo della conferenza letta
da Heidegger per la prima volta nel 1964).
19
J. Genet, Il funambolo, cit., p. 143.
20
Ibidem.
21
Ivi, p. 144.
56
Francesco Russo
corpo costituisce l’oggetto che di rimando costituisce il corpo con la morte per
intermediaria. Perché, da essa, possiamo abbozzare una genealogia dell’oggetto
in sé, solo e muto”22.
Lo spazio e il tempo della scultura, come scrive ancora Michel Serres, è
quello di un’arte prima, la quale “apre l’orizzonte su una storia che abbiamo
persa o che non abbiamo mai scritta, noi inondati di oggetti o di lingue e incapaci di manipolare i primi se non nominandole attraverso le seconde, poste in
gioco, feticci, merci.
Nella scultura si ordisce silenziosamente per la prima volta la trascendentale e rarissima adeguazione della causa e della cosa, dell’opera oggettiva e della
morte, madre della cultura”23.
Giacometti stesso, consapevole della diseguaglianza lumeggiata nel precedente passaggio, e alla ricerca di tale rara adeguazione nella somiglianza, tenta,
una volta messi fuori uso i modi operativi preorientati e/o predeterminati dai
paradigmi del segno linguistico, matematico o concettuale, di cogliere la sola
singolarità della cosa e della visione, per poi giungere a toccare “in modo nuovo
un fenomeno antichissimo”24:
“La somiglianza, cioè non una conformità formale, un’omotetia tratto per
tratto, un’equazione tra oggetto e soggetto, una sorta di omeostasi tra ciò che
sarebbe da un lato un viso di carne, dall’altro il blocco di pietra, un equilibrio
uguale durevole, permanente, eterno forse […]. No, è piuttosto uno squilibrio,
una catastrofe senza fine, un travaso, un uscire dagli argini, una starna inquietante oscillazione tra la vita e la morte, l’impossibile tentativo sempre ricominciato, di raccogliere il flusso tra due volti che si travaserebbero l’uno nell’altro”25.
Come afferma Giacometti: “Quando Rodin faceva i suoi busti, prendeva ancora
le misure. Non faceva una testa come la vedeva, nello spazio, ad esempio ad una
certa distanza […]. Dunque, in fondo, la sua non era una visione, ma un concetto. Sapeva che una testa è rotonda, prima di cominciarla, partiva già da una
certa convinzione, che è la convinzione di tutta la scultura europea dalla Grecia
in poi”26. Giacometti, azzerando i modi di un’arte legata al significato e alla sua
iconologia come alla sua epistemologia, avanza a tentoni per poter vedere: più
volte l’artista ha dichiarato che l’ “arte è solo un mezzo per vedere”27: ma ciò
22
M. Serres, L’ermafrodito: Sarrasine scultore, Torino 1989 (I ed. francese 1987), pp. 137138 (corsivo mio).
23
Ivi, p. 138.
24
A. Giacometti, Scritti, cit., p. 310 (conversazioni con A. Parinaud)
25
J. Clair, Il naso di Giacometti. Una scultura, un simbolo, Roma 1994, p. 23.
26
A. Giacometti, Scritti, cit., p. 315 (corsivi miei).
27
Ivi, p. 311.
La comune, assoluta solitudine delle cose. Jean Genet e l’opera di Alberto Giacometti
57
non può in nessun caso essere inteso come se l’arte venisse ridotta all’esteriorità
strumentale di un mezzo, di cui magari liberarsi una volta giunti alla meta definita, perché, obbedendo alla circolarità sempre rincomciante della creazione
che non conosce alcun te@lov ad essa sovraimposto, si deve aggiungere, come
dice lo stesso Giacometti, che: “Devo allora cercare di copiare, per rendermi
conto, almeno in parte di ciò che vedo”28, potendo la visione ampliarsi e approfondirsi solo in forza di ogni tratto scolpito e di ogni linea tracciata sulla tela;
scambievolmente la visione e l’opera crescono e si trasformano.
Il luogo circoscritto della pittura e della scultura è allora il rinvio a ciò in cui
esso stesso è inscritto, e cioè l’incircoscrivibile spazio della vita, la sua “immensità formidabile”29.
Jean-Paul Sartre ha colto, nel suo saggio dedicato a Giacometti, intitolato
La ricerca dell’assoluto, questo movimento immanente a tutta l’opera scultorea
e pittorica tanto da poterla rinominare kantianamente come una “rivoluzione
quasi copernicana”30: “Prima di lui si credeva di scolpire l’essere, e questo assoluto sprofondava in un’infinita di apparenze. Lui ha scelto di scolpire l’apparenza situata, e si è scoperto che così raggiungeva l’assoluto”, quell’assoluto che
si dà solo “accettando senza riserve la relatività”31 – e quei gessi e quei bronzi
parlano una lingua insieme familiare, già parlata, ed estranea, sempre ancora
da apprendere.
4.
Lo stile del saggio di Genet combina insieme il lampo di una scrittura
quasi aforistica, il dialogo con lo stesso Giacometti e un’analisi dei modi in
cui ci si dispone alla ricezione e all’attivazione dei sensi di un’opera d’arte, in un incontro ogni volta sorprendente: “la conoscenza di un volto per
essere estetica deve rinunciare ad essere storica”: nell’esame di un quadro
come di una scultura si deve rimodulare l’esperire in modo tale che si abbia “un’esperienza dello spazio non in quanto continuità, ma discontinuità.
Ogni oggetto crea il suo spazio infinito”32; non solo si deve spezzare il continuo della linearità cronologica dei significati, ma si deve cogliere ogni cosa
Ibidem.
Ibidem.
30
J-P. Sartre, Che cos’è la letteratura?, Milano 2004 (prima ed. francese 1947), p. 424 (corsivo mio).
31
Ivi, p. 423.
32
J. Genet, Il funambolo, cit., p. 148.
28
29
58
Francesco Russo
“nella sua solitudine assoluta”33. Questo sguardo non più storico non è mai
quello sospeso in un illusorio e panoptico “eterno presente”, ma al contrario
è “una corsa vertiginosa e incessante da un passato verso un futuro, un’oscillazione da un estremo all’altro, che non dà requie”34, trapassato da un’epoch@
quasi fenomenologica, per cui adesso anche se ci si rivolge ad un armadio,
questo atto si compie “per sapere finalmente che cosa è”; allora “io elimino
tutto ciò che non è l’armadio” per divenire io stesso “un essere, un osservatore che cessa persino di essere presente, e persino osservatore presente, per
indietreggiare senza sosta in un passato e in un futuro indefinito. Cessa di
essere lì affinché resti l’armadio, e ogni rapporto affettivo e utilitaristico fra
l’armadio e lui sia abolito”35.
Si apre così lo spazio tra differenze non commisurabili, quello che lega
solitudine e bellezza – come donazione della cosa, colma della “solitudine di
ogni essere” la quale è insieme la sua “gloria più certa”36. Genet supera quanto troppo comunemente viene inteso come il portato “esistenzialistico” (secondo malintese filosofie dell’esistenzialismo contemporaneo) dell’opera di
Giacometti: dall’isolamento, dalla solitudine vanno deposti tutti i significati
correlati a una “condizione miserevole”, o miserabile, vagamente angosciata, per ridisporli in un orizzonte in cui vengano colti come “la regalità segreta, incomunicabilità profonda e insieme consapevolezza più o meno oscura
di una inattaccabile singolarità”37. Solo così si comprende come: “Davanti a
un lampadario dice:
“È un lampadario, è Lui”. E nient’altro.
E questa constatazione improvvisa illumina il pittore. Il lampadario. Sulla
carta esisterà – nella sua nudità più spontanea”38.
È l’esperienza della più completa degerarchizazzione dell’essente – che mette fuori gioco ogni attribuzione valoriale propria del mondo storico e insieme di
quell’arte sociale la quale stabilisce “tra gli oggetti un legame d’ordine, appunto,
sociale – tra l’uomo e le sue secrezioni”39: invece Giacometti esercita “un’arte da
Ibidem.
Ivi, p. 157.
35
Ivi, pp. 157-158.
36
Ivi, p. 147.
37
Ivi, p. 152. Lo stesso Giacometti ha esplicitamente negato che la solitudine, se intesa a
livello storico e sociale, appartenga alla sua esperienza come alla sua opera. In fondo, si nasce
e si muore agli altri.
38
Ivi, p. 171.
39
Ibidem.
33
34
La comune, assoluta solitudine delle cose. Jean Genet e l’opera di Alberto Giacometti
59
barboni sublimi, puri”40 – dove la solitudine, quella propria e di tutti, è lo stesso
libero, inscalfibile esser-comune.
Qui – nella comune e necessaria solitudine di ogni cosa – sia essa una mela,
un bicchiere, un cane, un naso, una sola gamba, un solo braccio, una testa –
non si rimane prigionieri di un esser-solo che non dica null’altro se non il vuoto
di una sterile chiusura solipsistica o di una pretesa, quanto illusoria, intatta
naturalità della cosa che si vuole indipendente – ma viceversa proprio se ogni
cosa è sola, è essente senza riserve (ideali, storiche, naturali, assiomatiche, senza retro- e doppifondi occulti: è interamente nel suo essere esistente), per cui:
“Sono solo […] quindi stretto da una necessità contro la quale siete impotenti.
Se sono solo ciò che sono, sono indistruttibile. E poiché sono solo ciò che sono
senza riserve, la mia solitudine è consapevole della vostra”41. Con altre parole, e
questa volta con quelle di un poeta, si potrebbe dire:
Perché l’unico senso occulto delle cose
è che esse non hanno nessun senso occulto,
è più strano di tutte le stranezze
e dei sogni di tutti i poeti
e dei pensieri di tutti i filosofi
che le cose siano veramente ciò che appaiono essere
e non ci sia niente da capire.
Sì, ecco ciò che i miei sensi hanno appreso da soli
le cose non hanno significato: hanno esistenza.
Le cose sono l’unico senso occulto delle cose.42
40
Ibidem. In un altro luogo, ulteriormente approfondendo questo nucleo essenziale
dell’esperienza dell’opera di Giacometti, Genet scrive: “la parentela che le sue figure manifestano altro non è, mi pare, che il punto prezioso in cui l’essere umano può venir ricondotto a
quanto ha di più insopprimibile: la sua solitudine di essere equivalente e qualsiasi altro” (ivi, p.
151; corsivo mio). E relativamente alla straordinaria scultura in bronzo del 1951, Il cane, che
presentando una forma animale, rara nel lavoro di Giacometti, che dunque suscita lo stupore
di Genet, Giacometti dice: “Sono io. Un giorno mi sono visto per strada, così. Ero il cane.
Anche se all’inizio è stato scelto per evocare miseria e solitudine, mi sembra che il cane
sia disegnato come un ghirigoro armonioso, la curva della schiena che corrisponde alla curva
della zampa – ma questo ghirigoro è ancora la glorificazione suprema della solitudine” (ibidem;
corsivi miei).
41
Ibidem. Ci sarebbe molto da scrivere e pensare sul darsi dell’identità come pienezza tautologica dell’essente: è stato Martin Heidegger che con più rigore e profondità ne ha scandagliato tutte le implicazioni, da Der Satz vom Grund a Identität und Differenz: (senza dimenticare il
saggio Das Ding): per un’analisi teoretica di questi luoghi decisivi dell’identità, declinata come
originaria appartenenza a sé dell’essente cfr. F. Chiereghin, L’eco della caverna. Ricerche di
filosofia della logica e della mente, Padova 2004, pp. 47-62.
42
F. Pessoa, Il guardiano di greggi, in Id., Poesie di Alberto Caeiro, Firenze 2002, pp. 91-93.
60
Francesco Russo
Se questo è vero, allora quanto Genet (in un altro saggio) indica come il
segreto di Rembrandt, è dato di rinvenirlo, di coglierlo in nessun altro luogo se
non sulla superficie della tela; e in nient’altro, che non si condensi e resti raggrumato su di essa. Anche Rembrandt, al pari di Giacometti, soprattutto nella
pittura del suo ultimo periodo, non riconoscerà più alcun valore ordinatore o
una rigida scala gerarchica imposta alle cose: tutto ciò che ancora il giovane
Rembrandt poteva aver assunto come caratterizzante esclusivamente la convenzionalità del lusso e i ricchi soggetti ritratti, adesso proprio quel “bagliore
che li fa apparire preziosi, lo insinuerà nella materia più misera, in modo che
tutto si confonda”43. La pittura si è prefissa come suo scopo esattamente quello
di voler “rappresentare il mondo” contemporaneamente con il voler “renderlo irricoscibile”44; poiché, come ha scritto Jean-Marie Pontevia: “Se l’occultamento è rigorosamente solidale con l’ostentazione, se il fatto di nascondere, di
mascherare, di velare è uno degli elementi irriducibili della pittura, allora si
capisce bene in che senso non è possibile dipingere tutto, o più esattamente si
capisce che cosa vuol dire questa pretesa di dipingere tutto. Non si tratta in nessun modo di dipingere qualsiasi cosa. Dipingere tutto vuol dire ricercare a quali
condizioni sia possibile mostrare qualcosa”45, di poter far spazio nella raffigurazione a quell’impercettibile, o inimmaginabile dove il mondo non sia la mera
somma di tutte le cose, ma la condizione, già sempre esistente del mostrarsi di
qualcosa, di ogni cosa. Questa duplicità contenuta nella pittura conduce Rembrandt a rendere equivalenti il pittorico, la stessa “pittura in quanto materia”,
e il figurativo, gli “oggetti che essa deve raffigurare”46: l’esito è la liberazione di
tutto ciò che “potrebbe ricondurlo a una visione differenziata, discontinua, gerarchizzata del mondo: una mano vale quanto un viso, un viso quanto l’angolo
di un tavolo, l’angolo di un tavolo quanto un bastone, un bastone quanto una
mano, una mano quanto una manica…”47; qui è “accaduto qualcosa di importante: mentre riconosce l’oggetto, l’occhio riconosce la pittura in quanto tale”48.
43
J. Genet, Il funambolo, cit. p. 133; questo saggio è stato pubblicata per la prima volta nel
1958, solo un anno dopo rispetto a quello dedicato a Giacometti.
44
Ibidem.
45
J-M. Pontevia, Scritti sull’arte, Milano, 2001 (I ed. francese 1984-85), p. 45.
46
J. Genet, Il funambolo, cit., p. 133. Per la relazione aporetica tra la figurazione e il pittorico è fondamentale il libro in cui Georges Didi-Huberman ha affrontato tale questione attraverso il racconto di Balzac Il capolavoro sconosciuto: cfr. La pittura incarnata. Saggio sull’immagine vivente, Milano 2008 (I ed. francese 1985).
47
Ivi, pp. 135-136.
48
Ivi, p. 35. Questa citazione è tratta da un ulteriore saggio di Genet su Rembrandt, intitolato Che cosa è rimasto di un Rembrandt strappato in pezzi tutti uguali e buttato nel cesso, ed è
del 1967, pubblicato in “Tel Quel”.
La comune, assoluta solitudine delle cose. Jean Genet e l’opera di Alberto Giacometti
61
Il riconoscimento della forma dell’oggetto è ormai indissociabile dall’asignificanza del pittorico che deve essere colto in quanto tale, non essendo più unilateralmente asservito alla figurazione e quindi al dominio del significato, dovendo cancellarsi nell’emergere della figura, consentendone la piena leggibilità. È
la “crudele bontà” verso tutte le cose quella che Rembrandt manifesta quando,
in un’esistenza spogliatasi di ogni illusione come di ogni speranza, è ormai consapevole che “il pittore è tutto nello sguardo che va dall’oggetto alla tela, ma in
particolare nel gesto della mano che va dalla piccola pozza di colore alla tela”49:
il movimento, che si compie nello spazio che oscilla tra l’occhio e la mano, intreccia indissolubilmente figurazione e defigurazione: porta, indifferentemente,
alla luce le cose – e in questo apparire le cancella, come se le condensasse, le
comprimesse nello spessore del colore. La tela come luogo della figurabilità,
vive solo nella relazione alla piccola e profondissima pozza di colore, che nel
formare la figura la riassorbe in sé, per esporsi lei stessa come nuda materia,
refrattaria a ogni significato, instabile evento ormai eguale alle forme dipinte
dell’intera e definita composizione pittorica.
5.
“BRETON
Che cos’è il tuo atelier?
GIACOMETTI
Sono due piccoli piedi che camminano”50.
“Le dita percorrono la statua, e tutto l’atelier vibra e vive”: ogni statua riesce
a mutare lo spazio, a cristallizzarlo in modo nuovo; Genet rivolgendosi a Giacometti: “Basta una delle sue statue e la stanza si trasforma in un tempio.
LUI E a lei pare una cosa buona?
IO Non saprei. Lei che dice?”51. Ma in fondo è come se lo stesso atelier subisse una metamorfosi pari a quella del gesso e del bronzo delle statue, ed esso
stesso, di conseguenza, divenisse un luogo scolpito, una scultura polimorfa,
inabitato da una presenza diversa: è certo che “prima o poi crollerà. È di legno
tarlato, di polvere grigia, le statue di gesso mostrano le corde, le stoppe, o un
Ivi, p. 136 (corsivo mio).
A. Giacometti, Scritti, cit., p. 46 (la citazione è tratta dal Dialogo nel 1934, pubblicato lo
stesso anno in “Documentes”).
51
J. Genet, Il funambolo, cit., p. 144.
49
50
62
Francesco Russo
filo di ferro, le tele, dipinte di grigio, hanno da tempo perduto la pace di cui godevano nel negozio di colori, tutto è macchiato e buttato lì alla rinfusa, tutto è
precario e andrà in pezzi, tutto tende a dissolversi, tutto fluttua: insomma, tutto
è come colto in una realtà assoluta”52. Ciò che si presentava come la più povera
ed estenuata delle materie – richiamata al limite della polvere – è proprio esso
la sola realtà assoluta, perché in tale arte “quest’istante minacciato, in realtà
votato al disastro, ma condiviso, potrà comunque diventare realtà, eternità nel
tempo, salvezza – anche se nessun dio è presente per garantire questa salvezza in un altro mondo. Tutto è chiaro: l’arte diventa instaurazione d’essere”53,
e insieme traccia e residuo della visione che di essa rimane: “La vedo come
se sparisse…risorgesse…risparisse…ritornasse…si trova proprio e sempre tra
l’essere e il non essere. Ed è questo che si vuol capire…”54. Tutte le statue sono
sovranamente indifferenti alla sopravvivenza postuma nella dimensione storica
della posterità, non certo assoggettate all’idea di un’illusoria e ammirante stabilizzazione, che le valorizzi attraverso i propri giudizi tanto soggettivi quanto
esteriori, o a quella di una asettica musealizzazione, che le conservi secondo
una correttezza filologica, tanto più rigorosa quanto più ristretta: quelle statue
sanno il loro essere segno soltanto in quanto cenno, fuggevole e solo; e come
tutti i segni “non si stabilizzano mai. Affiorano. Scompaiono”55: figure dell’erranza, nessuna mai per sempre definita, salvaguardata o salva, dimentica, forse,
della possibilità stessa del potersi dare di una salvezza.
Cosa poi possa poter esser indicato nella risposta di Giacometti a Breton,
che lo interrogava sul suo atelier, è forse possibile che ci si approssimi ad esso,
anche solo se poco, attraverso quanto ha scritto Georges Bataille nel suo saggio
del 1929, L’alluce: “L’alluce è la parte più umana del corpo umano, nel senso
che nessun altro elemento di questo corpo è così differenziato dall’elemento
corrispondente della scimmia antropoide […]. Questo deriva dal fatto che la
scimmia è arboricola, mentre l’uomo si sposta sulla terra senza aggrapparsi ai
rami, essendo diventato lui stesso un albero, e tanto più bello se la sua erezione
è corretta. Così la funzione del piede umano consiste nel dare una base ferma
a questa erezione di cui l’uomo è tanto fiero (l’alluce, cessando di essere utile
alla prensione eventuale dei rami, si adatta al suolo sullo stesso piano delle altre
Ivi, p. 170.
Y. Bonnefoy, Alberto Giacometti, cit., pp. 37-38.
54
A. Giacometti, Scritti, cit., p. 310.
55
Ivi, p. 312.
52
53
La comune, assoluta solitudine delle cose. Jean Genet e l’opera di Alberto Giacometti
63
dita)”56. Nella “sua straordinaria anatomia fantasmatica”57 Bataille espone ed
indaga i modi attraverso i quali l’uomo, nel processo della sua formazione, ha
creduto di poter scindere la testa (come unico principio acrocratico del corpo)
dai piedi, i principi del bene (dell’elevazione) da quelli del male (dell’affondare
nel fango), una cosmologia supera scissa da una infera, ma soprattutto di voler intendere quell’elevazione come un movimento unidirezionale, irreversibile
“senza ritorno nello spazio puro”58, laddove, e ben al contrario, non c’è che un
“movimento di va e vieni, dall’immondo all’ideale, dall’ideale all’immondo”59,
dalla testa ai piedi, dai piedi alla testa, per cui il compito del pensiero implica
un “ritorno alla realtà”, e cioè “il riconoscere che si è sedotti bassamente, senza
trasposizione e fino ad urlare, spalancando gli occhi: spalancandoli così davanti
a un alluce”60.
Per Giacometti lo spazio più alto della creazione (il suo atelier) può allora
venire a coincidere con il più basso, i piedi e con il loro moto; così come le sue
statue appaiono crescere, al modo delle piante, dalla loro base iletica: infatti
Giacometti “non avrebbe mai mimato la produzione di una natura naturata,
ma si sarebbe regolato sui principi della natura naturans”61. Ancora una volta
le relazioni ordinanti la cosmologia e la teleologia della tradizione e del mondo
storico, nel suo processo trasformativo della natura in cultura, conoscono la
loro catastrofe (letteralmente: il loro volgersi al basso) la quale è però insieme
capace di illuminare altrimenti ciò che in essa, inabissandosi, scompare.
6.
“BRETON
Che cos’è la testa?
GIACOMETTI
È la nascita dei seni”62.
56
G. Bataille, Documentes, Bari 1974, p. 75 (la prima edizione di Les gros orteil è contenuta
nel numero sei della rivista pubblicata nel novembre del 1929). Sull’importanza di questa rivista nella formazione di Giacometti (in riferimento anche ai saggi sulla scultura, pubblicati in
questa stessa rivista da Carl Einstein): cfr. G. Didi-Huberman, Il cubo e il volto. A proposito di
una scultura di Alberto Giacometti, Milano 2008 (I ed. francese 1993), pp. 172-180.
57
J. Clair, Il naso di Giacometti, cit., p. 38.
58
G. Bataille, Documentes, cit., p. 76.
59
Ibidem.
60
Ivi, p. 84.
61
J. Clair, Il naso di Giacometti, cit., p. 38.
62
A. Giacometti, Scritti, cit., p. 46.
64
Francesco Russo
“Le teste, le persone non sono che un movimento incessante, da dentro, da
fuori, si rifanno di continuo, non hanno una vera consistenza, il loro lato trasparente. Non sono cubi, né cilindri, né sfere, né triangoli. Sono una massa in
movimento, [un’andatura], una forma cangiante e mai del tutto afferrabile. E
inoltre sono come vincolate a un punto all’interno che ci guarda attraverso gli
occhi e che sembra costituire la loro realtà, una realtà non misurabile, in uno
spazio illimitato, e che sembra essere altro da quello in cui sta la tazza di fronte
a me o che è creato dalla tazza stessa.
Esse non hanno – non più – un colore che sia definibile”63. In questa pagina,
databile attorno al 1960, Giacometti delinea le difficoltà implicate nel coglimento di una singola testa, la quale, liberata dalle sovraimposizioni di uno spazio geometricamente e prospettivisticamente costruito dal sapere, si rivela, per
la sua stessa mobilità, di una inconsistente trasparenza: Genet: “I tratti servono
solo a dare forma e solidità ai bianchi. […] Non è il tratto a essere pieno, ma
il bianco”64; oppure, come ha notato Sartre: “Scolpire, per lui, è depauperare
lo spazio, spremerlo per farne gocciolare tutta l’esteriorità”65, affrontare in tal
modo l’infinito della divisibilità spaziale. Anche la pittura di Giacometti, contrariamente a quella prodottasi negli ultimi cinque secoli saturata dal pieno, è il
tentativo di “dipingere il vuoto”66, quel vuoto che non è “l’inerzia della materia e
l’inerzia del nulla”, bensì “è pienezza distesa, spiegata; il pieno è vuoto orientato.
Il reale sfolgora”67. Riprendendo ora la direzione indicata dalla meditazione di
Martin Heidegger sul fenomeno originario dello spazio nel suo rapporto all’arte
plastica, si può vedere come: “Il vuoto non è niente (Die Leere ist nicht nichts).
Non è neppure una mancanza (Mangel). Nel farsi corpo della scultura il vuoto
entra in gioco nel modo dell’instaurare luoghi di cui arrischia e progetta l’apertura (in der Weise des suchend-entwerfenden Stiftens von Orten)”68. La scultura
non è allora “presa di possesso dello spazio (Besitzergreifung des Raumes)”69, ma
“un porre in opera incorporando di luoghi e con questi un aprire di contrade
per un possibile abitare di uomini, per un possibile dimorare delle cose che ci
attorniano e ci riguardano (möglichen Verweilens der sie umgebenden, sie angehenden Dinge)”70. Scintillio di un possibile, inumano, differente h±qov.
Ivi, p. 256.
J. Genet, Il funambolo, cit., p. 162.
65
J-P. Sartre, Che cos’è la letteratura, cit., p. 421.
66
Ivi, p. 479; la citazione è tratta dal secondo saggio scritto da Sartre su Giacometti, intitolato La pittura di Giacometti, pubblicato nel 1954 nella rivista “ Temps Modernes”.
67
Ivi, p. 481.
68
M. Heidegger, L’arte e lo spazio, cit., pp. 32-33.
69
Ibidem.
70
Ivi, pp. 38-39; (qui Genet è il reagente essenziale al pensiero heideggeriano nelle sue
63
64
La comune, assoluta solitudine delle cose. Jean Genet e l’opera di Alberto Giacometti
65
(Ma perché far coincidere la testa con la nascita dei seni? Proprio con
quell’elevazione del corpo, che secondo Sartre, sarebbe preclusa alle statue di
Giacometti, in particolare ai suoi nudi? Perché, scrive ancora Sartre, non “c’è
da sperare che quel seno sbocci […]. Eppure c’è tutto: la bianchezza, la rotondità, l’elastico cedimento di un bel seno maturo: tutto, ma non la materia”71, tutto
ma non il suo offrirsi e il suo tocco?
Bisognerebbe allora volgersi a quanto ha scritto Jean-Luc Nancy in La nascita dei seni, dove, pur non toccando questo luogo che accade tra la scultura
di Giacometti e il pensiero di Sartre, Nancy ci invita a cogliere nella nascita dei
seni la nuda presenza, l’essere puro, assoluto, altro dal linguaggio significante;
essere che “essendo implicato in sé, gli è necessario il suo ripiegamento, e il
suo ripiegamento lo solleva e lo spiega, lo dispiega e lo curva, lo esplica verso il
proprio enigma esposto.
La Sfinge ha dei seni e si espone come enigma”72; quell’enigma dell’essere
rappreso nella sua e nostra solitudine, come rappreso tanto nella statuaria arcaica ed egizia, quanto in una testa, quella che Giacometti non ha mai smesso
di affrontare e di indagare, di disegnare e di scolpire: “Riprender ogni cosa daccapo, così come vedo le persone e le cose, specialmente le persone e le teste, gli
occhi all’orizzonte, il globo degli occhi, la partizione degli occhi.
Non capisco più nulla della vita, della morte, di nulla”73).
componenti, che Philippe Lacoue-Labarthe ha suggerito di nominare come proprie di un discorso pio: di quel discorso che, per un certo periodo, ha creduto che l’estenuata e impiegabile
cosa tecnica, propria del Gestell, si riassorba, risignificandosi, in un vettore del Geviert).
71
J-P. Sartre, Che cos’è la letteratura?, cit., p. 423.
72
J-L. Nancy, La nascita dei seni, Milano 2008 (I ed. francese 2006), pp. 9 e 38. Qui il discorso dovrebbe ricominciare per seguire tutto quanto la scrittura del corpo, nel modo proprio
del pensiero e dello stile di Nancy, non smette di pensare e di pesare.
73
A. Giacometti, Scritti, cit., p. 261; dal taccuino del febbraio del 1963.
Hegel a Norimberga: la morale come dottrina dei doveri
67
Hegel a Norimberga: la morale come dottrina dei doveri
Memoria di Mariafilomena Anzalone
presentata dal socio naz. ord. res. Giuseppe Cantillo
(seduta del 29 aprile 2010)
Abstract. Object of this essay is a course of lessons held by Hegel in Norimberga that for
its articulation, it represents an ‘unicum’ inside the Hegelian production and it seems to
show many more points of contact than with the Hegelian systematic of the maturity.
Through an examination that will primarily focus on the second section of the course
entitled “Metaphysics of Morals” we will try to verify if it is possible a real resumption of
the perspective and the contents of the kantian moral, or if under a plant of die apparently
kantian, they can already catch sight of the original lines of development that will bring
Hegel to attribute in the “Elements of the Philosophy of Right” a new meaning, to the
‘Pflichtenlehre’, inserting it in the dimension of ethicality.
L’attività filosofica e didattica svolta da Hegel a Norimberga non ha
suscitato, generalmente, grande interesse tra gli studiosi del pensatore tedesco.
Il fatto che egli insegnasse in un Ginnasio e che, quindi, dovesse adattarsi alle
esigenze dei suoi giovani scolari ha spesso spinto gli interpreti a considerare
le lezioni di questo periodo prive di rilevanza nello sviluppo del pensiero
hegeliano e a vedere in esse, come nel caso di Haym, solo “un prodotto misto di
persuasione filosofica e accomodazione pedagogica”1. Negli ultimi anni, però,
il ritrovamento di alcuni quaderni2 appartenuti a Hegel ed utilizzati per le sue
lezioni ha gettato nuova luce sulla produzione norimberghese, consentendo,
attraverso il lavoro dei curatori dell’edizione critica3, di risalire “alle stesure
R. Haym, Hegel und seine Zeit, Gaertner, Berlin 1857, p. 281.
In questi quaderni sono contenuti sia i dettati che Hegel faceva a lezione, sia gli appunti
delle spiegazioni riportati dagli allievi, sia le correzioni e le rielaborazioni hegeliane. Lo stesso Rosenkranz ce ne dà notizia: “Come mostrano i numerosi quaderni che ci sono rimasti,
dapprima era solito rielaborare il suo corso da cima a fondo e riscriverlo ogni semestre, poi, a
partire dal 1812, apportarvi solo correzioni parziali. Egli dettava i paragrafi e li spiegava (…).
Gli alunni dovevano ricopiare in bella il dettato. Allo stesso modo dovevano cercare di stendere
per iscritto le spiegazioni orali. Di quando in quando Hegel chiamava l’uno o l’altro a leggere
ad alta voce quanto aveva scritto, sia per mantenere viva l’attenzione per le lezioni, sia per
controllare il dettato. Talvolta faceva ricopiare in bella anche questi appunti”, K. Rosenkranz,
Vita di Hegel, trad. it. a cura di R. Bodei, Vallecchi, Firenze 1966, p. 266.
3
Cfr. G.W.F. Hegel, Nürnberger Gymnasialkurse und Gymnasialreden (1808-1816), hrsg. v.
1
2
68
Mariafilomena Anzalone
originali della dottrina dello spirito hegeliana nelle diverse tappe del periodo
norimberghese”4. Si è potuto osservare come gli anni trascorsi a Norimberga
rappresentino un importante laboratorio teorico per ricostruire la genesi delle
varie parti del sistema che trovano, soprattutto nelle lezioni sull’enciclopedia5,
un assetto non lontano da quello definitivo.
Tra i corsi norimberghesi ce n’è uno che ha particolarmente attratto
l’attenzione degli interpreti: si tratta del corso su Rechts-, Pflichten und
Religionslehre6 che Hegel tenne con una certa regolarità tra il 1809 e il 1816 nella
classe inferiore7. Come ha osservato Norberto Bobbio, le lezioni di questo corso,
K. Grotsch, Meiner, Hamburg 2006 (d’ora in poi NG) in Id., Gesammelte Werke, Meiner, Hamburg, Bd. (in zwei Teilbänden).
4
U. Rameil, Der Systematische Aufbau der Geisteslehre in Hegels Nürnberger Propädeutik,
«Hegel-Studien» Bd. 23, 1988, p. 22.
5
Cfr. G.W.F. Hegel, Oberklasse Philosophische Enzyklopädie: System der besonderen Wissenschaften. Diktat 1809/10 mit Überarbeitungen aus den Schuljahren 1811/12, 1812/13 und
1814/15 in NG, pp. 311-365; trad. it. a cura di P. Giuspoli in Id., Logica e sistema delle scienze particolari 1810-1811, Verifiche, Trento 2001 (d’ora in poi SSP); G.W.F. Hegel, Philosophische Enzyklopädie. Nürnberg 1812/1813. Nachschriften v. C. S. Meinel u. J. F. Abegg, hrsg. v.
U. Rameil, in Id., Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte, Bd. XV, Meiner,
Hamburg 2002, ora anche in NG, pp. 641-792.
6
Di queste lezioni possediamo solo l’edizione del Rosenkranz, visto che è andata perduta
la fonte da lui utilizzata per elaborare il testo. Non è, quindi, possibile stabilire se si trattava di
una Nachschrift di allievi o di un quaderno compilato dallo stesso Hegel (per la storia redazionale di questo testo cfr. R. W. Henke, Hegels Philosophieunterricht, Königshausen&Neumann,
Würzburg 1989). I criteri con cui Rosenkranz ha redatto la Propedeutica, collazionando
quaderni risalenti ad anni diversi, consigliano una certa cautela nel riferirsi a questo testo.
Tuttavia “sarebbe altrettanto ingiustificato” trascurare un corso come questo che costituisce
“indubbiamente la base di quella che sarà la futura Enciclopedia” e che, “vuoi per la ricchezza tematica o per la felicità espressiva, ha maggiormente attirato su di sé l’attenzione degli
interpreti”, F. Menegoni, Elementi per una ‘teoria dell’azione’ nel ‘Grundkurs’ norimberghese
di G.W.F. Hegel, in AA.VV., Ethos e cultura. Studi in onore di Ezio Riondato, Liviana, Padova
1991, p. 771 e p. 769. Per le citazioni tratte dalla Rechts-, Pflichten und Religionslehre für die
Unterklasse faremo riferimento all’edizione presente in NG (pp. 369-420). Per la traduzione
italiana utilizzeremo G.W.F. Hegel, Propedeutica filosofica, a cura di G. Radetti, Milano 1977,
pp. 3-79 (d’ora in poi Pf).
7
Prendendo le distanze dal regolamento scolastico del Niethammer che al primo anno
prevedeva anche lezioni di logica, Hegel, nella classe inferiore, ritiene più opportuno trattare
argomenti che, essendo “determinazioni pratiche con le quali abbiamo da fare ogni giorno”
sono, secondo lui, più adeguati ad avvicinare gli studenti alla filosofia. Egli si preoccupa di offrire ai suoi giovani allievi concetti il cui contenuto, essendo più vicino all’esperienza quotidiana, è “sorretto dal naturale sentimento degli scolari” e ha “una realtà effettuale nell’interiorità
dei medesimi”. Ciò rende questi argomenti preferibili rispetto alle “logischen Bestimmungen”
che per delle giovani menti non avvezze al pensiero speculativo, risulterebbero solo “ombre
di fronte all’effettuale” (G.W.F. Hegel, Über den Vortrag der Philosophie auf Gymnasien. Privatgutachten für Immanuel Niethammer, 1812, in NG, pp. 824, 826-827; trad. it. in Id., Dell’insegnamento della filosofia nei Ginnasi. Un parere riservato per il R. Bav. Consigliere Superiore scolastico Emanuele Niethammer, 1812, in Pf, pp. 250-251). Sui principi che guidavano l’attività
didattica di Hegel cfr. almeno F. Ravaglioli, Hegel e l’educazione, Armando Editore, Roma 1968;
J. Rohbeck, La didattica della filosofia in Hegel, trad. it. a cura di U. Damiani in «Comunicazione filosofica. Rivista telematica di Ricerca e didattica», n° 2, novembre 1997; L. Sichirollo,
Hegel a Norimberga: la morale come dottrina dei doveri
69
pur nella loro schematicità, hanno “un’importanza decisiva” nell’itinerario
hegeliano, tanto che sia “l’Enciclopedia di Heidelberg (1817) quanto quella di
Berlino (1827) ne serbano visibilmente le tracce”8. Ed è proprio “a partire dai
corsi del ginnasio di Norimberga”, secondo Cantillo, che possiamo trovare “una
prima sistemazione della riflessione di Hegel sulle tematiche giuridiche ed eticopolitiche”9. In effetti, alcuni nuclei essenziali della matura filosofia hegeliana
sono già presenti in queste corso che ha, però, una struttura originale rispetto
a quella dei Lineamenti di filosofia del diritto e dell’Enciclopedia. L’articolazione
della materia in una dottrina del diritto, dei doveri e della religione costituisce,
in effetti, un unicum nel pensiero hegeliano e sembra mostrare molti più punti
di contatto con la kantiana Metafisica dei costumi (1796)10 che con la sistematica
hegeliana della maturità
In questo saggio, esaminando in particolare la seconda sezione del corso,
intitolata “Pflichtenlehre oder Moral”, cercheremo di verificare se e in che
termini si possa riscontrare in essa un’effettiva ripresa della prospettiva e dei
contenuti della morale kantiana.
1. Oggetto e scopo della morale
Ad aprire queste lezioni, che hanno per oggetto “la volontà umana, e
precisamente secondo la relazione del volere particolare col volere universale”11,
è un’introduzione, seguita dalle relative Erläuterungen, in cui Hegel, sviluppando
riflessioni già svolte nel periodo jenese12, definisce e caratterizza la struttura
della volontà. In questo modo, prima di analizzare i prodotti concreti dell’agire
umano, egli presenta ai suoi giovani studenti i principi che lo guidano delineando
un movimento che dall’impulso13, come autodeterminazione che trova nella
Sulla pedagogia di Hegel, in G.W.F. Hegel, La scuola e l’educazione. Discorsi e relazioni. Norimberga 1808-1816, a cura di L. Sichirollo, Franco Angeli, Milano 1985, pp. 121-127.
8
N. Bobbio, Hegel e il diritto in Id., Studi hegeliani, Einaudi, Torino 1981, pp. 54-55.
9
G. Cantillo, Individuo e comunità nella partizione della «Filosofia del diritto» di Hegel del
1819/20, in G. Bentivegna et Alii (a cura di), Filosofia, scienza, cultura. Studi in onore di Corrado Dollo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, p. 121.
10
In proposito cfr. F. Schneider, Hegels Propädeutik und Kants Sittenlehre in K. Hartmann
(hrsg. v.), Die ontologische Option. Studien zu Hegels-Propädeutik, Schellings Hegel-Kritik und
Hegels Phanomenölogie des Geistes, Walter de Gruyter, Berlin 1976, pp. 31-116.
11
NG, p. 369; Pf, p. 3.
12
Cfr. G.W.F. Hegel, Naturphilosophie und Philosophie des Geistes 1805/06, Jenaer Systementwürfe III, hrsg. v. R.-P. Horstmann, in Gesammelte Werke, Bd. VIII, Meiner, Hamburg
1976, pp. 185-287 (d’ora in poi JSIII); trad. it. a cura di G. Cantillo in Filosofia dello spirito
jenese, Laterza, Roma-Bari 1971, nuova ed. 2006 (d’ora in poi FSJ).
13
“La determinazione interiore della coscienza pratica è impulso [Trieb] o propriamente
volontà” (NG, p. 370; Pf, p. 4). Come osserva la Bonito Oliva: “secondo Hegel l’agire implica la
spinta dell’impulso. Nonostante esso abbia la forma di un volere ancora immediato, l’impulso
70
Mariafilomena Anzalone
naturalità l’immediato quanto limitato contenuto del suo agire, giunge alla
riflessione pratica assoluta14, in cui l’io ha come oggetto la relazione a sé. Il
culmine di questo processo è la volontà vera e propria, la facoltà superiore del
desiderare, che si caratterizza come autodeterminazione libera a partire dalla
“reine Unbestimmtheit des Ich”15.
La dottrina del diritto, dei doveri e della religione rappresenta proprio
“la più diretta determinazione e sviluppo di questi generali fondamenti del
volere”16. Il diritto ha per oggetto “l’uomo unicamente come un’essenza libera
in generale”17: non lo prende in considerazione nella sua particolarità, non
guarda a ciò che distingue un individuo da un altro, ma alla sua essenza di
volontà libera, che non è intaccata minimamente da tutte queste distinzioni. In
questo senso Hegel usa ed introduce la nozione di “persona” che sarà un vero
e proprio perno dei Lineamenti di filosofia del diritto: “In quanto ognuno venga
riconosciuto come un essere libero, esso è persona [Person]. Il principio del
diritto si può anche esprimere così: ognuno deve essere trattato dall’altro come
persona”18. Come sottolinea Cantillo, nel diritto noi abbiamo questo paradosso:
“il diritto si riferisce alla tutela dei singoli, ma questa tutela dei singoli, delle
persone, in tanto è possibile in quanto le persone sono, in fondo, per il diritto in
senso stretto, equivalenti, cioè in quanto hanno valore soltanto per il carattere
formale del loro essere autonomi e del loro essere quindi degni di essere rispettati
come persone autonome, secondo la definizione del diritto data da Kant”19. Il
è lo stesso un volere, che esprime la capacità originaria dell’uomo, in quanto essere spirituale,
a negare tutto, anche la sua propria immediatezza”, R. Bonito Oliva, La traduction spirituelle
du «Trieb» dans la philosophie hégélienne de l’esprit, in «Trieb», tendance, instinct, pulsion, «Revue Germanique Internationale», 18/2002, p. 191.
14
La riflessione, come “riduzione dell’immediato”, esprime quella capacità, propria dello
spirito, di trascendere ogni determinatezza. Riflettendo, il soggetto supera la sua volontà naturale, immediata, in direzione di una volontà che è già andata oltre gli impulsi e può anche
decidere di non soddisfarli. Nel suo primo apparire la riflessione si presenta come limitata,
finita, relativa: essa “oltrepassa, indubbiamente, un certo finito, ma arriva sempre, di nuovo,
a qualcosa di finito”, passa cioè da un impulso ad un altro, e così “ricade sempre soltanto in
un impulso, si aggira solo in mezzo ai desideri [Begierden] e non si solleva oltre tutta questa
sfera degli impulsi”. Ma, oltre alla riflessione pratica relativa, c’è anche una riflessione pratica
assoluta. Essa si realizza quando io non ho più a che fare con qualcosa d’altro, ma “con me
stesso”, o “sono oggetto a me stesso”. Nella riflessione pratica assoluta l’io, quindi, è pura relazione a sé, autoriferimento. Astraendo da tutto ciò che è finito, l’io, nella sua purezza, non ha
alcun contenuto immediato, naturale, ma soltanto se stesso come contenuto; perciò “Questa
relazione pura con me stesso è l’Io, la radice dell’essere infinito stesso”, (NG, pp. 380-381; Pf,
pp. 19-21).
15
NG, p. 370; Pf, p. 5.
16
NG, p. 371; Pf, p. 7.
17
NG, p. 389; Pf, p. 33.
18
NG, p. 390; Pf, p. 34.
19
G. Cantillo, Libertà, individuo e comunità nella filosofia del diritto di Hegel, in Id., Natura
Hegel a Norimberga: la morale come dottrina dei doveri
71
concetto di personalità astrae, dunque, da tutte le determinazioni particolari
del soggetto ed include in sé l’essere-io o la singolarità dell’individuo, il lato per
cui egli è un essere libero, ovvero universale.
Se il diritto si configura come l’ambito dell’obbligazione esteriore, esso,
però, “lascia libera in genere la disposizione interiore [Gesinnung]”20. La
morale, invece, include proprio quell’aspetto che il diritto non considera, il lato
soggettivo, interiore, dell’agire; essa, infatti, “si riferisce essenzialmente alla
disposizione interiore e richiede che l’azione accada per rispetto al dovere”21.
Sebbene morale e diritto possano rapportarsi l’uno all’altra, i loro ambiti di
riferimento restano distinti. Questo perché la considerazione dell’individuo che
mettono in campo è nettamente differente: l’io è oggetto del diritto solo in quanto
persona, come libertà astratta, come “il concetto puro dell’essere determinato
pratico”22; la morale, invece, guarda all’uomo “non come astratta persona ma
secondo le universali e necessarie determinazioni del suo essere determinato
particolare”23. Occupandosi del soggetto nella sua determinatezza particolare, la
moralità esplorerà una sfera del tutto ignorata dal diritto: la sfera degli impulsi,
dei desideri, dei sentimenti e delle passioni che caratterizzano il soggetto nella
sua effettuale concretezza. Essa, di conseguenza, “non richiede soltanto di
lasciare l’uomo nella sua astratta libertà, ma pure che venga promosso il suo
bene”24. Se obbiettivo della moralità è, dunque, anche il bene dell’uomo bisogna
spiegare in che cosa esso consista. E, di fatti, Hegel, prima di introdurre la
vera e propria dottrina dei doveri, dedica i primi paragrafi della sezione sulla
morale a chiarire che tipo di bene la moralità intende promuovere. A tale scopo
egli opera una distinzione tra Vergnügen (piacere), Glückseligkeit (felicità), e
Seligkeit (beatitudine). Per comprendere tale distinzione bisogna tener presente
l’analisi delle dinamiche che presiedono la struttura del soggetto agente che
abbiamo visto esser caratterizzate, in prima istanza, dagli impulsi. Essi sono
“determinazioni interne” e “in quanto sono soltanto interiori […] tendono a
togliere questa manchevolezza25, ossia richiedono la loro realizzazione, la
coincidenza dell’esterno con l’interno”26. In questa coincidenza tra l’interiorità
e l’esteriorità consiste appunto il piacere che si configura come qualcosa di
umana e senso della storia, Luciano Editore, Napoli 2005, p. 116.
20
NG, p. 404; Pf, p. 54 (trad. parzialmente modificata).
21
Ibidem (trad. parzialmente modificata).
22
NG, p. 404; Pf, p. 55.
23
Ibidem.
24
NG, p. 388; Pf, p. 31.
25
Sul concetto di impulso come “sentimento della mancanza”, cfr. JSIII, p. 203; FSJ, p. 87.
26
NG, p. 405; Pf, p. 56.
72
Mariafilomena Anzalone
formale, di assolutamente soggettivo e accidentale. E’ formale perché, potendo
sorgere da qualsiasi cosa, è indifferente rispetto al contenuto: “Esso non
dipende dal contenuto ma si riferisce solo alla forma, ossia è il sentimento di
una concordanza soltanto formale”27. Ma il piacere non è accidentale solo dal
punto di vista del contenuto: lo è anche dal punto di vista della sua realizzazione.
Infatti, non è assolutamente detto che l’impulso riesca a trovare o a produrre
l’oggetto che lo soddisfa. Ciò dipende dalla struttura stessa dell’operare umano
che ha a che fare anche con circostanze esterne, le quali danno luogo spesso a
conseguenze fortuite e non volute. Ciò che io produco “dipende come effetto della
mia attività, dalla mia volontà, ma soltanto l’azione come tale mi appartiene,
mentre al contrario il successo di essa non deve necessariamente tornare a mio
vantaggio, e conseguentemente nemmeno il godimento dell’azione”28.
Ma il soggetto non è solo impulso, non si esaurisce tutto nella ricerca
dell’immediato piacere: è anche riflessione, capacità di andare oltre la
naturalezza degli impulsi, di confrontarli tra di loro e di scegliere i mezzi più
adeguati alla loro soddisfazione. La riflessione, quindi, poiché non prende in
considerazione il singolo piacere prodotto dalla soddisfazione di un singolo
impulso, ma il piacere nella sua totalità, è alla ricerca della felicità. Quest’ultima
“non è soltanto un singolo piacere, ma uno stato durevole, in parte del piacere
effettivo stesso, in parte anche delle circostanze e dei mezzi, per cui si ha
sempre la possibilità, quando si vuole, di creare il piacere”29. Nonostante superi
l’immediatezza che caratterizza la dimensione pulsionale, la riflessione “rimane
ancora dentro al principio soggettivo ed ha ancora il piacere come fine, ma
solo quello più grande, più ricco”30. Sia l’impulso che persegue il piacere che
la riflessione rivolta al raggiungimento della felicità, sono sempre soggetti alla
fortuna, al caso, perché è del tutto accidentale che le circostanze esterne ne
favoriscano il conseguimento. Tale dimensione contingente è insuperabile per
l’individuo, il quale non può aspirare alla beatitudine, visto che essa “consiste in
questo, che non c’è in essa la fortuna, ossia che in essa l’adeguazione dell’essere
determinato esterno con l’esigenza interiore non è casuale”31. La beatitudine si
configura, osserva Fonnesu, come “il soddisfacimento non legato all’empirico
27
Ibidem. L’individuo può porre il suo piacere in questo o in quell’altro oggetto, in questo
quell’altro contenuto: la cosa è del tutto casuale e dipende da un’attribuzione di valore assolutamente soggettiva. Di conseguenza, “Quando io dico che così mi piace, o mi appello al
mio piacere, io esprimo soltanto che la cosa per me ha questo valore, ed ho tolto, con ciò la
relazione razionale con gli altri” (NG, p. 405; Pf, p. 57).
28
NG, p. 406; Pf, p. 57.
29
NG, p. 388; Pf, p. 32.
30
NG, p. 407; Pf, p. 58.
31
NG, p. 388; Pf, p. 32.
Hegel a Norimberga: la morale come dottrina dei doveri
73
e al finito e che non consiste di una distinzione irrisolta tra agire e godimento,
tra ragione e appagamento, tra moralità e felicità, ma piuttosto dell’identità di
questi termini”32. Intesa in questo modo, essa può essere attribuita soltanto a
Dio, ad un essere “nel quale volere e compimento della sua assoluta potenza
sono la stessa cosa”33.
Tuttavia, se è vero che per l’uomo la coincidenza tra interiorità ed esteriorità
è sempre limitata e casuale, è anche vero che essa riveste un ruolo significativo
per la realizzazione individuale. Proprio questa convinzione spinge Hegel
non solo a mitigare il giudizio fortemente critico sull’eudemonismo espresso
in Fede e sapere34, ma anche a mostrare che l’uomo, benché impossibilitato a
raggiungere la beatitudine, tende comunque ad essa e non rimane prigioniero
di una concezione del tutto soggettiva e quantitativa della felicità. Egli, infatti,
non è soltanto impulso e riflessione, ma anche ragione, e proprio la ragione
“toglie l’indeterminatezza che il sentimento piacevole ha riguardo all’oggetto,
purifica il contenuto degli impulsi dall’elemento soggettivo e fortuito, e
insegna, in relazione al contenuto, a conoscere l’universale e l’essenziale
del desiderabile”35. Il soggetto è dunque in grado di fare delle valutazioni di
tipo qualitativo: non compara solo gli impulsi alla ricerca di quello che può
procurargli maggior piacere, ma confronta la natura degli oggetti a cui si
rivolge la sua facoltà appetitiva, per individuare quello più degno, al di là di ogni
riflessione soggettiva. Anzi, nel prendere in considerazione solo il sostanziale,
la cosa stessa, il soggetto “non si ricorda di sé in esso, dimentica se stesso nella
cosa”36. Non bisogna, però, pensare che l’intervento della ragione nella ricerca
della felicità segni una cesura rispetto alla natura pulsionale del soggetto; anzi
proprio “L’impulso dell’uomo secondo il suo essere determinato particolare
[…] tende alla coincidenza dell’esteriorità in genere con le sue determinazioni
interiori, al piacere e alla beatitudine”37. Hegel sottolinea in modo particolare
che ragione e impulso non sono in opposizione tra di loro, anzi, come rileva
Rossella Bonito Oliva, “il riconoscimento del diritto alla felicità, nel determinarsi
32
L. Fonnesu, Sul concetto di «felicità» in Hegel, in R. Bonito Oliva, G. Cantillo (a cura di),
Fede e sapere. La genesi del pensiero del giovane Hegel, Guerini e Associati, Milano-Napoli 1998,
p. 59.
33
Ibidem.
34
Cfr. G.W.F. Hegel, Glauben und Wissen, in Jenaer kritische Schriften, hrsg. v. H. Buchner
u. O. Pöggeler, Gesammelte Werke, Bd. IV, Meiner, Hamburg 1968, pp. 318 e ss. (d’ora in poi
GW); trad. it. a cura di R. Bodei in Fede e sapere in Id., Primi scritti critici, Mursia, Milano 1990,
pp. 126 e ss. (d’ora in poi Fs).
35
NG, p. 406; Pf, p. 58.
36
Ibidem.
37
NG, p. 405; Pf, p. 56.
74
Mariafilomena Anzalone
pratico della volontà, ha legittimato la continuità tra l’universo pulsionale e
la tensione del volere”38. Infatti, “L’impulso del piacevole può coincidere con la
ragione, quando cioè tutti e due hanno lo stesso contenuto, quando la ragione
legittima il contenuto”39. Il soggetto non può e non deve essere visto come una
“gleichgültiges Doppelwesen”40, come un’entità “scissa tra impulsi e inclinazioni
da un lato e razionalità pura dall’altro, ma è la personificazione della volontà
supportata dalla ragione”41. Del resto, gli impulsi, le inclinazioni, in se stessi
non possono essere considerati né positivi né negativi: essi rappresentano
semplicemente la natura dell’uomo. La determinazione di ciò che è bene e di
ciò che è male avviene solo in ambito morale ed è compito della volontà. Essa,
come volontà morale che vuole realizzare il bene, cioè “ciò che corrisponde alla
ragione”42, viene spinta al raggiungimento di questo suo fine “anche dalla molla
della sensibilità e della singolarità”43.
Gli impulsi, allora, non rappresentano semplicemente qualcosa di limitato
e naturale che ostacola l’esplicarsi della volontà libera e razionale mediante
l’azione. Piuttosto c’è bisogno che la dimensione istintuale, passionale,
appetitiva si leghi a quella intellettiva, perché la volontà si possa oggettivare
in un’azione. è chiaro, che “Impulsi e inclinazioni non possono però essere
considerati senza relazione con la volontà”44 e che tale relazione non è affatto
fortuita o accidentale, ma anzi essenziale per il prodursi dell’agire45.
Già in questa prima parte della sezione sulla moralità emerge la significativa
distanza che separa Hegel da Kant riguardo al modo di intendere il soggetto. In
coerenza con una convinzione affermatasi già negli anni giovanili, Hegel rifiuta
ogni visione dicotomica della soggettività e, nell’affermare il ruolo essenziale
della sfera appetitiva per il determinarsi dell’agire, sembra molto più vicino
38
R. Bonito Oliva, La «magia dello spirito» e il «gioco del concetto». Considerazioni sulla
filosofia dello spirito soggettivo nell’Enciclopedia di Hegel, Guerini e Associati, Milano-Napoli
1995, p. 363.
39
NG, p. 406; Pf, pp. 59-60.
40
NG, p. 408; Pf, p. 60.
41
F. Menegoni, Soggetto e struttura dell’agire in Hegel, Verifiche, Trento 1993, p. 55.
42
NG, p. 407; Pf, p. 60.
43
NG, p. 389; Pf, p. 32.
44
NG, p. 408; Pf, p. 60.
45
“il darsi insieme della limitatezza dell’impulso e della passione e dell’illimitatezza della
volontà ha portato allo scoperto il luogo della loro convivenza, che è anche lo spazio del loro
governo: l’uomo come autodeterminazione” R. Bonito Oliva, La «magia dello spirito» e il «gioco
del concetto», cit., p. 361.
Hegel a Norimberga: la morale come dottrina dei doveri
75
ad Aristotele46 e ad alcuni esponenti dell’antropologia settecentesca47 che al
filosofo di Königsberg.
2. La dottrina dei doveri
L’esposizione hegeliana della dottrina dei doveri, che occupa la seconda
parte della sezione sulla morale, non prende le mosse, come accadeva
tradizionalmente, dalla suddivisione dei doveri in doveri perfetti o imperfetti.
A tale suddivisione, presente anche in Kant48, Hegel, in realtà, ha già fatto
riferimento nella prima parte della Morale, richiamandosi al De Iure Naturae
et Gentium di Samuel Pufendorf49. Essa riguarda i doveri di natura giuridica e
quelli morali: la perfezione dei primi è data dal fatto che essi “debbono accadere
ed hanno una necessità esterna”, a differenza dei secondi che, invece, si fondano
“su una volontà soggettiva”50. Ma Hegel ritiene che questa classificazione
tradizionale possa essere rovesciata: poiché “il dovere giuridico come tale
richiede soltanto una necessità esterna in cui può mancare la disposizione
46
La Menegoni ha messo in evidenza come ci siano in queste lezioni “non pochi elementi
di affinità” con la concezione pratica classica e più determinatamente aristotelica. Elementi che nel Grundkurs norimberghese “urgono sotto un impianto formalmente kantiano e ne
determinano l’oltrepassamento”, (Elementi per una ‘teoria dell’azione’ nel ‘Grundkurs’ norimberghese di G.W.F. Hegel, cit., p. 777). Per un confronto tra la concezione hegeliana dell’uomo
e l’opera di Aristotele, cfr. A. Ferrarin, Hegel and Aristotle, Cambridge University Press, Cambridge 2001, pp. 234 e ss.
47
Il modello antropologico illuminista dell’homme entier, in cui non c’è separazione dicotomica tra le varie facoltà dell’anima, in cui l’uomo è considerato nella sua vivente e armonica unità, sviluppatosi a partire dall’opera di Christian Thomasius (1655-1728), influenzò
certamente Hegel negli anni della sua formazione. Soprattutto a Jena, anche attraverso la
mediazione degli scritti fichtiani, questo modello continuerà a costituire per Hegel un termine
di confronto importante per l’elaborazione della sua visione della soggettività. Su questo tema
mi permetto di rinviare al mio Volontà e soggettività nel giovane Hegel, Luciano Editore, Napoli
2008.
48
Kant distingue innanzitutto tra Rechtspflichten, caratterizzati da una legislazione esterna, e Tugendpflichten riguardanti la libertà interiore. I due tipi di Pflichten differiscono per
il modo dell’obbligazione: mentre i doveri di diritto, detti perfetti o anche di obbligazione
stretta, sono un insieme di leggi che comandano in maniera inequivocabile una determinata
azione, i doveri di virtù, definiti “imperfetti” o di obbligazione larga, non ordinano cosa fare,
ma come agire. Essi riguardano le massime delle azioni e comandano al soggetto di assumere
determinati fini (che sono al tempo stesso doveri) affinché l’azione possa qualificarsi come
morale e non meramente legale. In realtà, nella Metafisica dei costumi, secondo quanto già
anticipato nella Fondazione (cfr. I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, in Id., Scritti morali, a cura di P. Chiodi, UTET, Torino 1770, p. 79) Kant ammette, in contrasto con le
suddivisioni tradizionali, anche l’esistenza di doveri perfetti all’interno dei Tugendpflichten: si
tratta di alcuni doveri verso se stessi. Cfr. I. Kant, La metafisica dei costumi, trad. it. a cura di
G. Vidari, Laterza, Bari 1983, pp. 19-23, pp. 47-48, pp. 228 e ss.; pp. 278 e ss.
49
S. Pufendorf, De Iure Naturae et Gentium, Frankfurt am Main 1694, III, IV, § 1, 8-9.
50
NG, p. 400; Pf, p. 54.
76
Mariafilomena Anzalone
interiore o io posso avere persino una cattiva intenzione”, esso può essere
considerato imperfetto rispetto al dovere morale in cui “si richiedono ambedue
i termini, tanto l’azione giusta secondo il suo contenuto, quanto anche, secondo
la forma, la soggettività della disposizione interiore”51.
L’orizzonte teorico a partire dal quale Hegel imposta e presenta la sua
Pflichtenlehre è invece quello di una morale che, messa da parte ogni visione
antinomica dell’essenza umana, prende in considerazione l’individuo nelle
sue determinazioni particolari. Con esse non si intende quanto di accidentale
distingue gli individui tra di loro, ma quell’aspetto per cui “nel particolare è
compreso insieme qualcosa di universale. La particolarità dell’uomo consiste
nella relazione con altri. In questa relazione ci sono anche determinazioni
essenziali e necessarie. Queste costituiscono il contenuto del dovere [Pflicht]”52.
Poiché le determinazioni particolari che caratterizzano, nella loro
essenzialità, l’individuo sono quella di essere un singolo, di appartenere
ad una famiglia, di vivere in uno Stato e di relazionarsi con altri individui,
anche i doveri si divideranno in doveri verso se stesso, doveri verso la famiglia,
verso lo Stato e verso gli altri uomini in genere. Siccome l’uomo “ha il doppio
aspetto della sua singolarità e della sua essenza universale”53, i doveri verso di
sé riguarderanno tanto la sua determinatezza naturale quanto la sua essenza
universale. Nel primo caso l’uomo deve mirare alla propria conservazione
fisica, nel secondo caso, invece, all’“elevazione della sua singolarità alla sua
natura universale, la sua cultura”54. Hegel radica la necessità di quest’ultimo
dovere nell’essere stesso dell’uomo55: a differenza dell’animale, l’uomo non è
soltanto un essere naturale e, soprattutto, “egli non è naturalmente ciò che deve
essere”56. Di conseguenza egli deve educarsi all’universale, portare alla luce
la sua stessa natura universale. Questo processo avviene tramite la cultura
(Bildung) e, in particolare, mediante la cultura teoretica. Ad essa “appartiene,
oltre alla molteplicità e determinatezza delle conoscenze e all’universalità dei
punti di vista dai quali bisogna giudicare le cose, il senso per gli oggetti nella
loro libera autosufficienza, senza un interesse soggettivo”57. La cultura teoretica
consente, dunque, di considerare le cose nella loro essenza, nella loro libera
Ibidem (trad. parz. modificata).
NG, p. 408; Pf, p. 60.
53
NG, p. 408; Pf, p. 61.
54
Ibidem.
55
Schneider, proprio in considerazione di ciò, ha visto in questo dovere una sorta di “ontologische Pflicht” (Hegels Propädeutik und Kants Sittenlehre, cit., p. 62).
56
NG, p. 408; Pf, p. 61.
57
NG, p. 409; Pf, p. 62.
51
52
Hegel a Norimberga: la morale come dottrina dei doveri
77
oggettività e non a partire dall’utilità soggettiva. è questo l’atteggiamento che
possiamo riscontrare nello studio delle scienze o nell’arte, e che è anche alla
base della capacità di produrre azioni “oggettive”58; azioni che sono libere dalla
particolarità individuale e rivolte non al soddisfacimento dei propri interessi
egoistici ma alla realizzazione della cosa stessa.
La cultura pratica riguarda, invece, la capacità dell’uomo di soddisfare
i propri bisogni e i propri impulsi naturali in modo misurato e teso alla
conservazione di sé. A questo riguardo, Hegel chiarisce ulteriormente il modo
in cui va inteso il rapporto tra impulsi naturali e volontà libera. Se è vero che
l’individuo, proprio perché non è determinato come l’animale, non deve essere
sottomesso alla sensibilità, anzi deve essere capace, a volte, di subordinarne il
soddisfacimento alla realizzazione di doveri più importanti, è anche vero che
questo non comporta l’annullamento della dimensione pulsionale e appetitiva.
Infatti “la libertà dell’uomo dagli impulsi naturali non consiste nel non averne
alcuno […] ma nel riconoscerli in generale come qualcosa di naturale e quindi
di razionale e, conformemente a ciò, nel compierli con la sua volontà”59.
Nell’ambito dei doveri verso se stesso, Hegel si preoccupa di chiarire anche
in che modo il singolo individuo deve vivere la sua professione. Quando essa
appare “come un destino” viene tolta “la forma di una necessità esterna.
Bisogna assumerla liberamente e con la stessa libertà sostenerla e portarla
al suo fine”60. Obbedendo al proprio destino, facendo della professione che
si svolge la propria essenziale sfera di espansione, il singolo non ne verrà
limitato, ma, anzi, ritroverà se stesso nell’esteriorità, elevandosi all’universale.
Poiché la professione “è qualcosa di universale e necessario”, l’uomo che ha
una professione “entra a partecipare e a collaborare all’universale. Diventa così
qualcosa di oggettivo”61. Nell’esercizio della sua professione, così, l’individuo è
portato ad “obliare la propria particolarità nel lavoro compiuto per il benessere
di tutti”62.
Una volta educatosi, mediante la cultura, all’universalità del sapere e del
fare, il soggetto è in grado di adempiere anche i doveri verso la famiglia, verso
gli altri uomini e verso lo Stato. Essendo la famiglia il luogo in cui l’individuo
entra per la prima volta in relazione con gli altri, i doveri verso la famiglia
(mantenimento ed educazione dei figli, ubbidienza e rispetto dei genitori da
Cfr. NG, p. 409; Pf, p. 63.
NG, p. 410; Pf, p. 64.
60
NG, p. 411; Pf, p. 65.
61
NG, p. 412; Pf, p. 66.
62
F. Menegoni, Elementi per una ‘teoria dell’azione’ nel ‘Grundkurs’ norimberghese di G.W.F.
Hegel, cit., p. 782.
58
59
78
Mariafilomena Anzalone
parte dei figli, ecc.) sono trattati per primi. La loro caratteristica è quella di
essere doveri che riguardano una relazione di tipo naturale, immediato, che
presuppone “un legame assoluto […], un legame che non è stretto da un
particolare arbitrio o caso”63.
Quando l’unità organica e naturale della famiglia si allarga fino a divenire
uno Stato, le relazioni tra gli individui diventano relazioni tra soggetti autonomi,
tra volontà indipendenti da ogni vincolo naturale. è interessante notare che, a
differenza di quanto accadeva nella dottrina del diritto, ora lo Stato non appare
più solo come società sotto leggi giuridiche ma anche come “più alto comune
ente morale”64. Se è vero che lo Stato deve essere indipendente dalle singole
volontà e, quindi, mira a “poter fare a meno della disposizione interiore dei
cittadini”65, è anche vero che se non vuole diventare uno Stato-macchina66, non
può rinunciarvi. Lo Stato è “Geist eines Volkes”, in cui ogni cittadino ritrova
la sua “geistige Substanz”67, la sua essenza spirituale e si oggettiva realmente.
Se lo Stato come universale sostanziale, come verità della libertà del singolo,
comanda e obbliga i cittadini, come comunità morale, come soggetto etico ed
effettualità dell’universale, esso guadagna ora la sua esistenza nella misura in
cui le sue parti, agiscono sulla base di una Gesinnung statale68. Nel momento
in cui i cittadini sentono che “La conservazione del tutto ha quindi la precedenza
sulla conservazione del singolo”69, e hanno coscienza che lo Stato è qualcosa di
assoluto, nella loro autonomia e libertà, obbediranno alle leggi e sacrificheranno
“proprietà e vita per il tutto”70.
NG, p. 413; Pf, p. 68.
NG, p. 414; Pf, p. 69.
65
Ibidem (trad. parzialmente modificata).
66
La critica al modello dello Stato macchina è presente in Hegel fin dagli anni giovanili
(cfr. in proposito G. Cantillo, «Privatleben» e senso dello Stato negli scritti giovanili di Hegel,
in Id., Le forme dell’umano. Studi su Hegel, Esi, Napoli 1996, pp. 6 e ss.) e riprende il motivo
schilleriano dell’alienazione propria dell’individuo moderno rispetto alla condizione vissuta
nell’antichità. Cfr. F. Schiller, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo, trad. it. a cura di G.
Pinna in Id., L’educazione estetica, Aesthetica, Palermo 2005, pp. 33 e ss.
67
NG, p. 414; Pf, p. 69.
68
Già nel corso jenese del 1805/06 Hegel, trattando lo Stato, non si è limitato a descriverne
“la salda organizzazione esterna” (FSJ, p.153; JSIII, p. 266), ma ha preso in considerazione,
per così dire, il lato soggettivo del suo esserci e del suo costituirsi quello per cui il singolo individuo, pur riconoscendosi in un ceto determinato e particolare, diviene consapevole della sua
appartenenza ad una comunità. In ogni Stand, in ogni ceto, lo spirito “ha un lavoro determinato, un sapere del suo esserci e agire in questo” (ibidem); ad esso corrisponde una Gesinnung
e, proprio attraverso l’analisi dei modi-di-sentire degli individui appartenenti ai singoli stati,
Hegel ha mostrato di volta in volta qual è il grado di autocoscienza, di sapere di sé, che lo
spirito ha raggiunto.
69
NG, p. 414; Pf, p. 70.
70
Ibidem.
63
64
Hegel a Norimberga: la morale come dottrina dei doveri
79
L’ultima parte della Pflichtenlehre, dedicata ai doveri verso gli altri, prende
in considerazione quei doveri che il singolo individuo ha nei confronti di coloro
con cui intrattiene relazioni casuali. Qui Hegel parte dal presupposto che
primario sia il rispetto della legalità. Esso, infatti, non si fonda su un sentimento
soggettivo, ma “è un dovere non arbitrario, valido per tutti”71. Una volta osservato
questo dovere, tutti gli altri si baseranno sul rispetto per gli individui che vanno
considerati nella loro essenza di volontà libere e, quindi “non solo come astratte
persone ma anche nella loro particolarità, uguali a se stessi”72. Hegel indica ai
suoi giovani scolari come doveri una serie di buoni comportamenti; criticando
l’ipocrisia, consistente nel “voler parlare moralmente ed agire effettivamente
con malvagità”73, afferma con forza la necessità di un’etica che dia luogo ad
azioni buone, e non solo ad eccellenti intenzioni. Se, kantianamente, è vero che
“Il principio morale sta specialmente nella disposizione interiore [Gesinnung]
o nell’intenzione [Absicht]”74, è anche vero che non si può rimanere fermi ad
esse, ma “è altrettanto essenziale che non solo l’intenzione ma anche l’azione
sia buona”75.
3. Ritorno a Kant?
L’ articolazione della morale in una dottrina dei doveri si pone certamente come
un episodio isolato rispetto al resto della produzione hegeliana. Nei Lineamenti
di filosofia del diritto Hegel sosterrà, piuttosto, che “un’immanente e conseguente
dottrina dei doveri”76 può darsi solo nello Stato. Essa, infatti, “non può essere
nient’altro che lo sviluppo dei rapporti che ad opera dell’idea della libertà sono
necessari, e pertanto reali nella loro intera estensione, nello Stato”77. Di conseguenza,
una Pflichtenlehre è indeducibile a partire dalla purezza della coscienza morale
ed è possibile solo nella sostanza etica dove il dovere astratto e indeterminato
del soggetto morale si riempie di un contenuto non accidentale ma universale e
necessario78. In questo modo i doveri divengono determinazioni necessarie in cui
NG, p. 415; Pf, p. 71.
Ibidem.
73
NG, p. 416; Pf, p. 73.
74
NG, p. 417; Pf, p. 73 (trad. parzialmente modificata).
75
Ibidem.
76
G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, hrsg. v. E. Weisser-Lohmann, in
Gesammelte Werke, Bd. XIV, Meiner, Hamburg 2006; trad. it. a cura di G. Marini in Id., Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari 2000, § 148, ann. (d’ora in poi GPR).
77
Ibidem.
78
Su questo punto cfr. A. Peperzak, Hegels Pflichten- und Tugendlehre. Eine Analyse und
Interpretation der „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ §§142-156, «Hegel-Studien», Bd.
17, 1982, pp. 97-117.
71
72
80
Mariafilomena Anzalone
si concretizza tanto la libertà quanto l’idea del bene. Essi appaiono al soggetto
non più come qualcosa di estraneo, di imposto, ma come aspetti essenziali della
convivenza in uno Stato e rappresentano ciò in cui l’uomo ha “la sua liberazione”
tanto dalla cieca dipendenza dal suo essere naturale, quanto “dalla depressione
nella quale esso è come particolarità soggettiva nelle riflessioni morali su ciò che si
deve fare e su ciò che si può fare”79.
L’esposizione norimberghese della morale nei termini di una Pflichtenlehre
sembra dunque porsi come un momento di discontinuità sia rispetto alle
posizioni assunte nelle Grundlinien che alle critiche rivolte a Jena al formalismo
del Sollen80. Nel contempo essa appare, invece, del tutto in linea con un tratto
caratteristico della riflessione morale moderna che vedeva proprio nella
trattazione sistematica dei doveri un momento fondamentale dell’etica81.
L’esigenza espressa da Samuel Pufendorf di trattare l’etica secundum officia
e non secundum virtutes82, recepita da Wolff83, come da Baumgarten84 si era
imposta saldamente all’interno della filosofia tedesca. Essa aveva, poi, trovato
in Kant non solo la sua massima espressione teorica ma anche un nuovo e
più profondo significato. Nella Metafisica dei costumi, innovando criticamente
struttura e contenuti della tradizionale dottrina dei doveri, Kant aveva inteso
andare al di là di una semplice catalogazione delle azioni moralmente giuste,
facendo emergere il fondamento diretto di determinati doveri nella moralità e
il loro valore per la sua realizzazione.
Considerata la profonda conoscenza hegeliana della filosofia kantiana, la
Pflichtenlehre presente in queste lezioni potrebbe essere considerata come
il segno di un “ritorno” a Kant, di una ripresa del suo pensiero, dovuta, se
GPR, § 149.
Cfr. almeno i capitoli della Fenomenologia dedicati a La ragione legislatrice, a La ragione
esaminatrice delle leggi e alla Concezione morale del mondo.
81
A questo proposito, Tugendhat ha sottolineato la svolta che il concetto di dovere introduce nell’etica: “la problematica dell’etica antica era: cosa voglio davvero per me; quella dell’etica
moderna è: cosa devo fare in rapporto agli altri”, E. Tugendhat, Antike und moderne Ethik, in
Id., Probleme der Ethik, Reclam, Stuttgart 1984, p. 44.
82
Cfr. Briefe Samuel Pufendorf an Christian Thomasius (1687-1693), hrsg. v. E. Gigas, München/Leipzig, Oldenburg 1897, p. 23.
83
Cfr. Ch. Wolff, Vernünftige Gedanken von der Menschen Thun und Lassen, zu Beförderung ihrer Glückseeligkeit (Deutsche Ethik), Frankfurt/Leipzig 1733. Come è stato osservato, il
tentativo di Wolff è quello di “dare esposizione sistematica ad una teoria generale e concreta
dei doveri derivandola deduttivamente da un unico, fondamentale principio morale”, H. W.
Arndt, Concetto e funzione dell’«esperienza morale» nell’etica di Christian Wolff, in G. Cacciatore
et Alii (a cura di), La filosofia pratica tra metafisica e antropologia nell’età di Wolff e Vico, Guida,
Napoli 1999, pp. 279-294.
84
Egli definisce l’etica “scientia obligationum hominis internarum in statu naturali”, cfr. A.
Baumgarten, Ethica philosophica, Halle/Saale, 1763, p. 5.
79
80
Hegel a Norimberga: la morale come dottrina dei doveri
81
non ad una vera e propria rivalutazione della morale kantiana, quantomeno
alla necessità di seguire le indicazioni del Normativ redatto da Niethammer85.
Esso, in effetti, prevedeva, per ciò che concerne “i concetti etici e giuridici del
sé”, l’utilizzo degli “scritti kantiani”86. Tra questi Hegel sembra prendere in
considerazione, nelle sue lezioni, la Metafisica dei costumi87 dove Kant articola
la Dottrina degli elementi dell’etica in due parti dedicate rispettivamente ai
“doveri verso noi stessi in generale” e ai “doveri di virtù verso gli altri”88.
In realtà, se, al di là della struttura generale delle lezioni hegeliane, si
guarda ai contenuti specifici, all’articolazione e all’impostazione della sua
Pflichtenlehre, si può osservare come i punti in comune tra i due filosofi
siano abbastanza esigui. Ciò appare chiaro già confrontando l’incipit delle
due dottrine dei doveri; Kant si preoccupa, in primo luogo, di giustificare, da
un punto di vista logico, la possibilità dei doveri verso se stessi, la loro non
contraddittorietà, individuando nella dignità dell’uomo, nel suo essere libertà e
fine in sé, il fondamento dell’obbligazione. Con questa operazione egli intende,
probabilmente, svincolarsi da chi, come Wolff89, Baumgarten90 Diderot91,
seppur con sfumature diverse, aveva considerato necessari i doveri verso se
stessi per lo più in una prospettiva eudemonistica. Per Kant fondare l’obbligo
morale verso se stessi sulla felicità significa non solo ostacolare l’adempimento
dei doveri verso gli altri, ma lasciare spazio all’egoismo e contraddire i principi
stessi su cui è organizzata la sua dottrina morale.
L’antieudemonismo kantiano sembra non essere accolto da Hegel che, anzi,
come abbiamo visto, mutando il giudizio espresso in Fede e sapere, riserva ora
una certa attenzione al tema della felicità, vista come un importante elemento
della realizzazione individuale. Ponendo come obiettivo della moralità anche
la promozione della felicità, e ammettendo che “si può dare un grossolano,
assolutamente rozzo eudemonismo, ma se ne può dare pure uno migliore” sul
85
In qualità di Consigliere superiore agli studi del regno di Baviera, F. I. Niethammer
aveva promosso un nuovo piano di studi generali allo scopo di riorganizzare l’insegnamento
scolastico: cfr. Allgemeines Normativ der Einrichtung der öffentlichen Unterrichtsanstalten in
dem Königreiche, in Monumenta germaniae Paedagogica, Berlin 1908, Bd. XLII, pp. 561-584.
86
Ivi, p. 574.
87
Secondo Schneider (Hegels Propädeutik und Kants Sittenlehre, cit.) le lezioni hegeliane
contenute in questo corso si strutturano quasi in un continuo confronto con l’opera di Kant.
88
I. Kant, La metafisica dei costumi, cit., p. 271.
89
Cfr. Ch. Wolff, Vernünftige Gedanken von der Menschen Thun und Lassen, cit., § 224.
90
Cfr. A. Baumgarten, Ethica philosophica, cit., § 150.
91
“non esiste parlando, che una virtù, la giustizia, e non esiste che un dovere, quello di
rendere felici se stessi”, D. Diderot, L’uomo e la morale, trad. it. a cura di V. Barba, Studio Tesi,
Pordenone 1991, p. 112.
82
Mariafilomena Anzalone
cui “principio possono fondarsi sia le azioni buone che quelle cattive”92, Hegel
di fatto istituisce un legame tra la prima parte dell’esposizione della dottrina
della morale in cui, come abbiamo visto, viene presentata la distinzione tra
piacere, felicità e beatitudine, e la seconda parte dedicata alla dottrina dei
doveri, legame che nell’ottica kantiana non è accettabile in questi termini93.
A differenza di Kant, Hegel non si preoccupa di giustificare, da un punto di
vista logico, la possibilità dei “doveri verso se stesso” e li fonda nelle determinazioni
particolari che caratterizzano, nella loro essenzialità, l’individuo: l’essere una
“singolarità” che ha nel contempo un’“essenza universale”94. Per corrispondere
a tale essenza il singolo ha da adempiere tutta quella sfera di doveri relativi alla
cultura e alla propria professione che si avvicinano più alle posizioni espresse da
Fichte nella Sittenlehre (1798)95 che a quelle della Metafisica dei costumi kantiana.
Per quanto riguarda invece la seconda parte della Pfichtenlehere hegeliana,
si può osservare che se Kant parla genericamente di doveri verso gli altri, Hegel
introduce una significativa distinzione: quella tra doveri verso la famiglia,
verso lo Stato e verso gli altri, intesi, genericamente, come coloro con cui si
intrattengono relazioni casuali. Il fondamento in base al quale si opera questa
NG, p. 406; Pf, p. 56.
Kant non esclude del tutto il legame tra dovere e felicità all’interno della morale. Nella
Metafisica dei costumi, allorché deve individuare quei “fini che sono nello stesso tempo doveri”
e che non sono mezzi per il raggiungimento di altri fini, egli afferma che solo due fini sono
tali: la propria perfezione e la felicità altrui. Tuttavia, “non si può qui invertire il rapporto dei
termini, vale a dire considerare come dei fini, che sarebbero in sé dei doveri per la stessa persona, la felicità propria da una parte, e la perfezione altrui dall’altra. Quantunque infatti la felicità
propria sia uno scopo a cui tendono tutti gli uomini (grazie all’inclinazione della loro natura),
non si può mai, senza contraddizione, considerare questo fine come un dovere”. Quest’ultimo,
infatti, “significa la coazione a conseguire uno scopo che non si accetta volentieri. E’ dunque
contraddittorio il dire che siamo obbligati a promuovere la nostra propria felicità con tutte
le nostre forze” (I. Kant, La metafisica dei costumi, cit., p. 235). La felicità può dunque essere
un fine e quindi un dovere su cui costruire una teoria delle virtù solo quando essa riguarda
gli altri e culmina, quindi, nell’amicizia come unione di due persone tramite amore e rispetto
reciproci.
94
NG, p. 408; Pf, p. 61.
95
Fichte distingue in effetti due tipologie di doveri: quelli universali e quelli particolari.
All’interno dei secondi introduce tutta una serie di doveri legati all’appartenenza ad uno Stand
e alla scelta di un Beruf. Se è vero che ogni individuo ha “l’obbligo di promuovere l’autonomia della ragione”, affinché le reciproche azioni non si ostacolino, è necessario che “diversi
individui si distribuiscano i diversi compiti che debbono essere attuati per promuovere il fine
ultimo”. Di conseguenza “devono esistere diversi ceti ed è dovere di ognuno fare in modo che
essi sorgano, oppure, se essi già esistono, scegliersene uno determinato. Chiunque scelga un
ceto, trasceglie un particolare aspetto nel quale egli si impegna a promuovere l’autonomia della ragione”, J. G. FICHTE, Sistema di etica secondo i principi della dottrina della scienza, trad.
it. a cura di C. De Pascale, Laterza, Roma-Bari 1994, § 19, pp. 238-239. Sull’influenza esercitata
da Fichte su Hegel relativamente a questi temi, cfr. C. Cesa, Doveri universali e doveri di stato.
Considerazioni sull’etica di Hegel, «Rivista di filosofia», n. 7-8-9, ott. 1977, p. 40.
92
93
Hegel a Norimberga: la morale come dottrina dei doveri
83
distinzione è rintracciato da Hegel in quella che abbiamo visto essere una
caratteristica essenziale e peculiare dell’uomo: il suo essere in relazione agli
altri. è dunque a partire da questa originaria intersoggettività che costituisce il
soggetto che vengono distinte le varie tipologie di relazioni possibili (naturali,
artificiali, occasionali) e individuati i doveri ad esse connessi.
Emerge qui una radicale differenza tra i due filosofi nell’impostazione stessa
del problema del dovere che, per Hegel, già a Norimberga, va collocato su un
piano ben più ampio di quello della singola coscienza morale; esemplare, in questo
senso, è proprio l’inserimento di una specifica sezione dedicata ai doveri verso
lo Stato96, doveri come l’obbedienza, il patriottismo, ecc., che scaturiscono dalla
consapevolezza che lo Stato non è solo Staatgesellschaft, istituto di diritto, ma
“vivente totalità”97, incarnazione dello spirito di un popolo. Trovandosi in questa
concreta situazione, il soggetto, cosciente del fatto che solo tenendo in vita l’intero
può salvaguardarne le parti, avverte tali doveri e si sente obbligato ad adempierli.
Al di là dell’impostazione generale della questione del dovere, sulla quale
avremo modo di ritornare, la distanza di Hegel da Kant si misura parimenti sul
piano di alcuni specifici contenuti. Anche lì dove Hegel, come nell’esposizione
dei doveri verso gli altri, sembra più vicino a Kant - visto che tratta i temi
dell’amicizia, della maldicenza, presenti anche nella Metafisica dei costumi in realtà non riprende l’esposizione kantiana e procede in maniera del tutto
autonoma. La sua autonomia si traduce spesso anche in una presa di posizione
critica rispetto a Kant, come avviene nel caso della sua idea di matrimonio
come contratto civile98. Ad essa Hegel, all’interno della trattazione dei doveri
verso la famiglia99, oppone la visione del matrimonio come “unione morale”100
grazie alla quale i due coniugi divengono una sola persona.
Se dovessimo rintracciare l’unico vero punto che accomuna le dottrine
96
“Il concetto dello Stato sta, dunque, a metà tra l’ambito dell’obbligo esterno e quello
dell’obbligo interno, esso entra in entrambi, però non solo secondo le astratte massime di
Kant per cui i doveri esterni sono anche doveri interni, egli (Hegel, nda), piuttosto, conduce
ai concreti doveri verso lo Stato e in ciò va oltre Kant”, F. Schneider, Hegels Propädeutik und
Kants Sittenlehre, cit., p. 44.
97
NG, p. 414; Pf, p. 70.
98
Cfr. I. Kant, La metafisica dei costumi, cit., pp. 95 e ss.
99
“la trattazione della famiglia nella sezione Moralità è da vedere tanto come una protesta
contro la trattazione ‘barbara’ dei rapporti familiari di Kant nella sua dottrina del diritto […],
quanto anche come espressione di più interne difficoltà concettuali”, C. G. Heidegren, Hegels
Nürnberger Propädeutik -eine wichtige Phase in der Entstehung der “Rechtsphilosophie”, «Archiv
für Geschichte der Philosophie», Bd. 70, 1988, p. 196.
100
NG, p. 413; Pf, p. 68. “il matrimonio non è essenzialmente né unione meramente naturale, bestiale, né un puro contratto civile” (ibidem). La critica all’idea kantiana di matrimonio
verrà riproposta nei Lineamenti dove Hegel accuserà Kant di aver esposto “nella sua turpitudine” la “sussunzione” del concetto di matrimonio sotto quello di contratto (GPR, § 75).
84
Mariafilomena Anzalone
dei doveri di questi due filosofi, potremmo individuarlo nella scelta,
compiuta da entrambi, di non prendere in considerazione i doveri verso Dio.
Tradizionalmente la sistematica dei doveri, articolata in base al destinatario
del dovere, si ripartiva in doveri verso se stessi, verso gli altri e verso Dio. In
Wolff101, così come in Baumgarten102 la cui Ethica philosophica era stata a lungo
oggetto di lezione da parte di Kant, agiva l’idea che anche i doveri verso se stessi
andassero ad inquadrarsi nell’orizzonte più ampio di una struttura dell’essere,
voluta da Dio e finalisticamente orientata al perfezionamento dell’uomo e al
conseguente raggiungimento della sua felicità. Kant invece, in coerenza con
l’affermazione dell’autonomia dell’etica rispetto alla religione, rifiuta questa
commistione di doveri mondani e ultra-terreni, sottolineando che “il soggetto
obbligato come il soggetto che obbliga è sempre soltanto l’uomo”103. In Hegel,
ugualmente, sono assenti i doveri verso Dio: la religione che, ad esempio in
Baumgarten rappresentava la prima parte dell’etica filosofica104, viene trattata
dopo la morale come momento in cui si giunge allo speculativo in una forma
che, però, non è speculativa, ma rimane quella della rappresentazione105. Hegel,
a differenza di Kant, non dà spiegazioni esplicite in merito a questa scelta, ma,
significativamente, presenta Dio come una figura che non vive la contraddizione
tra essere e dover-essere, ed è capace di mediare la soggettività del esser-persè con l’oggettività di un universale sostanziale. Di conseguenza, essendo
l’immagine positiva della libertà, che supera la contraddizione del punto di
vista del dovere, Dio non può che porsi al di là del piano della Pflichtenlehre.
4. Conclusioni
Come abbiamo visto, la scelta hegeliana di presentare parte della morale nei
termini di una Pflichtenlehre, pur mettendolo in rapporto diretto con uno dei
luoghi teorici più significativi e importanti della filosofia kantiana, non lo induce
ad un effettiva dipendenza da Kant. Al di là dei contenuti specifici delle due
dottrine dei doveri, che divergono in più punti, ciò che emerge con particolare
forza è quanto sia differente l’impostazione del problema del dovere nei due
Cfr. Ch. Wolff, Vernünftige Gedanken von der Menschen Thun und Lassen, cit., § 224.
Cfr. A. Baumgarten, Ethica philosophica, cit., § 150.
103
I. Kant, La metafisica dei costumi, cit., p. 273.
104
La parte generale dell’etica era suddivisa in Religio, Officia erga te ipsum e Officia erga
alia. Cfr. A. Baumgarten, Ethica philosophica, cit., § 2.
105
Così come accadeva già nella Fenomenologia, l’elevazione al piano della moralità induce a riscontrare “l’inadeguatezza della nostra individualità di fronte ad essa” e a riconoscerla
come “qualcosa di più alto che non siamo noi, come un essere indipendente da noi, autosufficiente, assoluto” (NG, p. 419; Pf, p. 77). Tale inadeguatezza, che da un punto di vista soggettivo
è la fede, dal punto di vista oggettivo è religione.
101
102
Hegel a Norimberga: la morale come dottrina dei doveri
85
filosofi. In Kant il problema del Sollen e del suo determinarsi in Tugendpflichten
verso se stessi e verso gli altri si gioca tutto nello spazio di una soggettività che
si interroga su quali fini deve proporsi, su quali fini possano essere considerati
nello stesso tempo doveri106. In Hegel, invece, il problema assume una fisionomia
diversa: anticipando una posizione che diverrà esplicita nei Lineamenti, egli a
Norimberga si mostra già consapevole del fatto che la questione del dovere non
può limitarsi all’ambito puramente soggettivo della singola coscienza morale,
ma investe lo spazio più ampio delle relazioni intersoggettive. Non solo perché,
ovviamente, ci sono doveri verso gli altri, cosa che riconosce anche Kant, ma
perché ci sono doveri che si costituiscono a partire da quelle che, anche nel corso
per l’Oberklasse del 1810-11, Hegel definisce “relazioni umane necessarie”107.
Esse non riguardano solo il rapporto “di ogni uomo particolare con se stesso
e propriamente della sua natura singola con la sua essenza universale”, ma
anche “l’unione naturale di individui” nella famiglia, “la relazione morale con
gli altri”108, e così via. Scrive Claudio Cesa: in Hegel “al perenne interrogarsi
dell’uomo kantiano su cosa sia il bene, si tende ad opporre il dovere o l’obbligo
che nascono dalla situazione data, dal nucleo sociale, naturale o artificiale, nel
quale il singolo si trovi a vivere”109. Se in Kant la Pflichtenlehre rispecchia la
natura morale del soggetto agente110 e a partire da essa soltanto individua i suoi
contenuti, in Hegel i doveri si presentano come derivanti da istanze fattuali, da
situazioni concrete che caratterizzano necessariamente la vita degli individui.
E’ al nucleo sociale, sia esso naturale come la famiglia o artificiale come lo
Stato, che sono collegati determinati doveri. In questo il filosofo non sembra
poi così lontano dalle posizioni che esprimerà nei Lineamenti, sostenendo che
“Che cosa l’uomo debba fare, quali sono i doveri ch’egli deve adempiere per
essere virtuoso, è facile a dire in una comunità etica”111. Certo, in queste lezioni,
così come in quelle dedicate all’esposizione dell’enciclopedia, non viene ancora
teorizzata la dimensione dell’eticità come sfera autonoma. Tuttavia, proprio
I. Kant, La metafisica dei costumi, cit., p. 235.
NG, p. 358; SSP, p. 158.
108
NG, p. 359; SSP, p. 158.
109
C. Cesa, Doveri universali e doveri di stato, cit., p. 37.
110
Esemplari sono in questo senso i doveri verso se stessi. “Tali obblighi rappresentano
un momento centrale e privilegiato da Kant nella sua costruzione proprio perché mostrano
bene una caratteristica di tutti i doveri etici: essi esprimono anzitutto il riconoscimento della
dimensione del soggetto morale, e il fatto che essa non rappresenti semplicemente il campo
di applicazione di valori che la eccedono, ma sia in effetti il solo ambito in cui essi hanno significato”, S. Bacin, Una nuova dottrina dei doveri. Sull’etica della “Metafisica dei costumi” e il
significato dei doveri verso se stessi, in L. Fonnesu (a cura di), Etica e mondo in Kant, Il Mulino,
Bologna 2008, p. 206.
111
GPR, § 150, ann.
106
107
86
Mariafilomena Anzalone
all’interno della trattazione della morale Hegel introduce un concetto di Stato
che anticipa alcune caratteristiche dello Stato etico. Nella sezione sulla Morale
lo Stato non è solo la Legge che ha potere112, non è solo istituto giuridico in cui ha
effettualità “il concetto del diritto come potenza fornita di autorità indipendente
dall’impulso della singolarità”113 e che, pur ritenendo “molto importanti
[…] moralità, religione, benessere e ricchezza di tutti i suoi cittadini”114, ha
come suo fine immediato solo il diritto. Esso si presenta, piuttosto, come una
comunità che media, “come un veramente più alto comune ente morale, l’unità
nei costumi, nella cultura e nell’universale modo di pensare ed agire (in cui
ognuno vede e riconosce nell’altro la sua universalità spirituale)”115. Così lo
Stato viene ad incarnare la volontà universale e sostanziale che non si fonda su
un contratto116, ma che, in quanto tale, è qualcosa di vincolante per il singolo ed
“obbligatoria in se per sé”117.
La connotazione essenzialmente giuridica che ha lo Stato nella dottrina
del diritto, più che il segno di una “svalutazione”118 della sua funzione, sembra
un diretto, seppur critico, riferimento alla concezione statale kantiana che
Hegel ritiene evidentemente limitata se sente la necessità di introdurre una
considerazione più propriamente etica dello Stato. Certo, come ha notato
Rosenzweig, l’aspetto etico della vita dello Stato compare in queste lezioni
Cfr. JSIII, p. 237 e ss; FSJ, p. 122 e ss.
NG, p. 399; Pf, p. 47.
114
NG, p. 400; Pf, p. 48.
115
NG, p. 414; Pf, p. 69.
116
“Lo Stato non è fondato su un contratto esplicito di uno con tutti e di tutti con uno, o
del singolo e del governo tra loro” (NG, p. 415; Pf, p. 70). La critica al contrattualismo compare
già negli anni jenesi quando Hegel, mettendo in luce la natura costitutivamente accidentale
del contratto, lo considera inadatto a spiegare l’origine e la costituzione di un rapporto etico
qual è l’unione politica (JSIII, pp. 257 e ss.; FSJ, pp. 144 e ss.). Bobbio osserva che Hegel rifiuta l’idea che il contratto possa porsi a fondamento dello Stato “non adducendo l’inesistenza
empirica del contratto, ma la sua inconsistenza razionale. […] il contratto sociale è da respingere, secondo Hegel, non perché empiricamente falso, ma perché razionalmente inadeguato al
raggiungimento dello scopo”, N. Bobbio, Hegel e il giusnaturalismo, in Id., Studi hegeliani, cit.,
p. 12. Su questo tema cfr. anche J. F. Kervégan, La théorie hégélienne du contrat: le juridique,
le politique, le social, in Hegel: droit, histoire, société, «Revue Germanique Internationale», 15,
Paris 2001, pp. 127-176.
117
NG, p. 415; Pf, p. 70.
118
Secondo Rosenzweig, la considerazione strettamente giuridica dello Stato che Hegel
presenta nella Rechtslehre è il segno di un ridimensionamento, se non addirittura di un “declassamento”, dello Stato (Hegel e lo Stato, trad. it. a cura di R. Bodei, Il Mulino, Bologna
1976, p. 252) dovuto alla delusione di fronte al potere napoleonico che, “lungi dall’introdurre
quella pubblicità in cui Hegel aveva sperato, […] aveva finito col mortificare ulteriormente la
vita pubblica”, D. Losurdo, Hegel e la Germania. Filosofia e questione nazionale tra rivoluzione
e reazione, Guerini e Associati, Milano-Napoli 1997, p. 266.
112
113
Hegel a Norimberga: la morale come dottrina dei doveri
87
“solo come parte della dottrina dei doveri”119, e non ne rappresenta nemmeno
il culmine. Tuttavia, il fatto che Hegel decida di introdurlo proprio nell’ambito
della dottrina dei doveri, induce ad ipotizzare che egli, già in queste lezioni
avesse preso coscienza del fatto che a partire dal punto di vista morale “non è
possibile alcuna immanente dottrina dei doveri”120. Rimanendo fermi al punto
di vista della pura moralità e quindi dell’interiorità, non potremmo mai sapere
“cosa” realmente dobbiamo fare per realizzare il bene. Solo il passaggio al
piano della Sittlichkeit come “concetto della libertà divenuto mondo sussistente e
natura dell’autocoscienza”121 garantisce la concretezza reale del bene e riempie
di un contenuto necessario e non accidentale l’astratta necessità kantiana di
compiere il dovere per il dovere.
Tale passaggio dal moralische Standpunkt al Begriff der Sittlichkeit122
non avviene in questo corso sia perché, probabilmente, Hegel non lo ha
ancora definito da un punto di vista teorico, sia perché queste lezioni sono
intenzionalmente impostate a partire da una prospettiva dicotomica123, secondo
un procedimento molto più simile a quello fenomenologico in cui, non a caso, è
la moralità a porsi come cifra esemplare della relazione tra il soggetto e il bene.
In conclusione, credo che la scelta di presentare la morale nei termini di
una dottrina dei doveri, influenzata certamente dalle prescrizioni del Normativ,
non induca Hegel a compiere una deviazione così sostanziale né rispetto al
suo precedente itinerario teorico né alla futura struttura del suo sistema. La
sua trattazione si configura, piuttosto, nei termini di un utilizzo critico della
forma della Pflichtenlehre in cui, tradizionalmente, veniva presentata l’etica.
Utilizzo che, sotto un impianto di stampo apparentemente kantiano, lascia già
F. Rosenzweig, Hegel e lo Stato, cit., p. 254.
GPR, § 135, Ann.
121
GPR, § 142.
122
Su questo passaggio cfr. almeno A. Nuzzo, Rappresentazione e concetto nella ‘logica’ della
“Filosofia del diritto” di Hegel, Guida, Napoli 1990.
123
A questo proposito cfr. R. W. Henke, Hegels Philosophieunterricht, cit. Spinto forse dalla volontà di adeguarsi, almeno formalmente, all’impostazione kantiana del Normativ, Hegel
assume come punto di partenza quello della coscienza della relazione soggetto-oggetto e del
suo differente configurarsi nella coscienza teoretica e in quella pratica (cfr. NG, pp. 369-70; Pf,
pp. 3-4). Questo procedimento, per molti versi vicino a quello fenomenologico, gli sembra più
adeguato e funzionale al suo obiettivo didattico: quello di far muovere agli studenti dell’Unterklasse un primo passo in direzione dello speculativo, della conoscenza “des Entgegengesetzten in seiner Einheit” (NG, p. 831; Pf, p. 260). Consapevole del fatto che questa conoscenza è
propria dell’elemento dialettico, “il più difficile”, il quale, per essere avvicinato alle menti di
così giovani studenti ha bisogno di presentarsi in una “forma più comune, più vicina al rappresentare” (ibidem), Hegel conclude le sue lezioni con la religione in cui lo speculativo si dà
in forma rappresentativa.
119
120
88
Mariafilomena Anzalone
intravedere le originali linee di sviluppo che porteranno Hegel ad attribuire nei
Lineamenti un nuovo significato alla Pflichtenlehre e ad oltrepassare il piano
della morale kantiana.
I rapporti politici luso-napoletani tra Cinque e Seicento
89
I rapporti politici luso-napoletani tra Cinque e Seicento
Memoria di Gilda Caprara
presentata dal socio naz. corr. Aurelio Musi
(seduta del 27 maggio 2010)
Abstract. A history of the modern political relations between Naples and Portugal still
has to be defined.
This work is inspired by the study of a famous Portuguese politician, António Vieira, as a secret agent sent to Rome planning a second revolt in Naples in 1650. My study
would show that this case of contact between Portugal and Naples is not the only one,
and indeed there are relations from 1580 to the second half of the XVIIth Century. Clearly, the type of contact wich emerges during the sixty years reign of Philippi is quite
different from that of the Guerra da Restauração years: in the first case we have a direct
contact – a contact that is manifested through military intervention of the kingdom of
Naples in the Portuguese affairs; in the second case there is instead an indirect contact
– a contact that is based on diplomatic actions. Historical sources reveal a particular
continuing interest by restored Portugal to the cousas de Nápoles: from 1640 to 1668
politicians and diplomats will be the protagonists of the luso-neapolitans relations.
Il profilo tematico manchevole di metodologia ed il dibattito storiografico
pressoché assente rendono lo studio della storia dei rapporti politico-diplomatici d’età moderna tra Napoli e Portogallo ancora in fieri.
L’impegno maggiore, in tal senso, è stato profuso esclusivamente per inquadrare la figura di un noto gesuita portoghese, António Vieira1, il cui nome è le1 Sulla vita e le opere del Vieira si segnala il recente lavoro di raccolta delle biografie esistenti sul personaggio, operato da J. P. Paiva in: Padre António Vieira, 1608-1697. Bibliografia,
(Coordenação Cientifica Josè Pedro Paiva), Ministério da Cultura, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1999. Nel 1997, l’IUO (Istituto Orientale di Napoli), con una mostra in onore del terzo
centenario della morte del Vieira, avviò lo studio dei rapporti tra Portogallo e Napoli che,
tuttavia, non ha avuto continuità. Gli spunti di riflessione sono stati raccolti in: AA.VV., Padre
António Vieira S.J. e Napoli, (a cura di M. L. Cusati), IUO, Atti del Convegno 12-22 Dicembre,
Napoli, 1997.
Nelle note si farà uso delle seguenti sigle ed abbreviazioni: BNL (Biblioteca Nacional de
Lisboa), CDP (Fondo: Corpo Diplomatico Português), ASPN (Archivio Storico per le Province
Napoletane), ANTT (Arquivo Nacional da Torre do Tombo-Lisboa), BNM (Biblioteca Nacional
de Madrid), BMC (Biblioteca Municipal de Coimbra), BMP (Biblioteca Pública Municipal do
Porto), BA (Biblioteca da Real Residencia da Ajuda-Lisboa), ARSI (Archivum Romanum So-
90
Gilda Caprara
gato alla storia napoletana della seconda metà del Seicento per aver tentato di
sobillare con una rivolta il Regno di Napoli.
Predicatore alla corte di Giovanni IV, il Vieira fu anche un uomo politico, un
agente diplomatico, una sorta di favorito del restaurato sovrano portoghese il
quale, essenzialmente per stima ed amicizia, gli affidò l’audace missione2 che,
per il suo fallimento, non ha mai dato concretezza alla storia delle relazioni
luso-napoletane.
Tuttavia, dalla ricollocazione della missione vieirese nel percorso politico
del Portogallo restaurato3 e dallo studio approfondito dell’attività paradiplomatica4 del personaggio è emerso che, effettivamente, esiste un contatto tra Portogallo e Napoli. Esistono, cioè, relazioni che, seppur esigue, non possono essere
trascurate nei loro aspetti storici, nei loro contesti politici e nel loro carattere
diplomatico, specialmente se mettono in evidenza una correlazione tra le sorti
politiche del Regno di Napoli e quelle del Regno di Portogallo, ed a maggior
ragione se si tratta di relazioni che si sostanziano all’interno di quel complesso
sistema5 politico che fu la Monarchia spagnola e che si perpetuano anche fuori
di esso.
L’indotto sistemico è condizione necessaria per la nascita e l’incremento, nel
lungo periodo, di relazioni politiche tra Portogallo e Napoli: prima del 1580,
di fatto, non esistono relazioni luso-napoletane; esistono, invece, relazioni lu-
cietatis Iesu), APINSL (Arquivo Parrochial da Igreja de Nossa Senhora do Loreto-Lisboa), AP
(Annales de Portugal).
2 Missão a Roma. Instrução que deu el-rei D. João IV ao P. Antonio Vieira para seguir nos
negócios a que foi a Roma, BNL, Cod. 1461, Fundo Antigo, fol. 98v. e seg., pubblicata da J. L. de
Azevedo, História de Antonio Vieira. Com factos e documentos novos, Lisboa, Libraria Classica,
1918-1921-1931, pp. 172-183; e successivamente da M. Batllori, L’ambaixada de Vieira a Barcelona i a Roma, 1650, in Catalunya a l’epoca moderna, Collecció Estudis i Documents, 17-ed.62,
Barcelona, 1970, sez. IV, cap. 12, p. 318.
3 Da me operata in: António Vieira, Napoli e il Portogallo: alcune ipotesi di ricerca, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXXVI, Società napoletana di storia patria, Napoli,
2008.
4 La locuzione è di J. Van den Besselaar, in: Van den Besselaar, António Vieira: o homem, a
obra, as ideias, Lisboa, 1981.
5 Nel riferirsi alla realtà spagnola del XVI-XVII-XVIII secolo, normalmente si utilizzano
categorie quali: impero, potenza, monarchia, sistema. In merito a quest’ultima, di più recente
acquisizione storiografica, si veda: AA.VV., Nel Sistema Imperiale l’Italia Spagnola, (a cura di
A. Musi), coll. L’identità di Clio, 7, ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 1994; G. Galasso, Il sistema imperiale spagnolo da Filippo a Filippo IV, in AA.VV., Lombardia borromaica, Lombardia
spagnola (1554-1659), (a cura di P. Pissavino, G. Signorotto), Roma, 1995, vol. I, p. 14; J. Maravall, Stato moderno e mentalità sociale, vol. I, Bologna, 1991, pp. 235ss.; A. Musi, L’Italia dei
Vicerè. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo, Ed. Avagliano, Cava de’ Tirreni,
2000; A. Musi, G. Vitolo, Il Mezzogiorno prima della questione meridionale, Le Monnier, Firenze, 2004, parte seconda: Il viceregno spagnolo; A. Musi, L’Europa moderna fra Imperi e Stati,
Guerini e Associati, Milano, 2006, capp. II e III.
I rapporti politici luso-napoletani tra Cinque e Seicento
91
so-italiane le quali, però, non sono di matrice puramente politica. Si tratta di
legami essenzialmente commerciali6. Il loro studio ha peraltro prodotto una
cospicua letteratura sulle relazioni economiche tra Portogallo ed Italia nel Cinquecento; il che non è valso invece per il Seicento che, significando storiograficamente una battuta d’arresto per le spinte imperialistiche di stampo commerciale portoghesi, ha interrotto il filone di studi sui contatti economici tra
Portogallo ed Italia.
Un contatto tra Portogallo e Napoli a livello mercantile fu nullo nel Quattrocento e quasi marginale nel Cinquecento, giacché Napoli, nonostante le sue potenzialità, non riuscì a proiettarsi nel commercio internazionale conservando, piuttosto,
una dimensione agricola dominata dalla considerazione degli interessi catalani7.
Nel 1580 qualcosa cambia: l’inserimento del Portogallo nella logica sistemica determina, necessariamente, un contatto che prescinde da quello che deriva
dall’ampliamento del mondo conosciuto, dalle nuove politiche economiche nate
da rapporti commerciali di vasta portata, dall’internazionalizzazione delle grandi monarchie d’età moderna. Portogallo e Napoli, infatti, pur continuando a non
avere rapporti commerciali, vivono un contatto politico che è diretta conseguenza
della loro mutata natura: nella logica imperiale questi due soggetti perdono sfere di
autonomia e divengono due realtà correlate e funzionali alla Spagna.
Nello studio dei rapporti politici tra Napoli e Portogallo è necessario, pertanto, tener presente il soggetto Spagna, vero protagonista delle relazioni internazionali di Cinque e Seicento, a cui i due regni sono legati come co-protagonisti di una serie di eventi interni, allo stesso tempo consequenziali a fattori
politico-internazionali e produttivi di nuovi e diversi rapporti politici.
Il sostantivo Spagna designa, nella tradizione classica portoghese, una regione europea cui si attribuiscono apologeticamente caratteristiche privilegiate
che sfociano nella sua elezione a cabeça do continente8: si postula, pertanto, una
convergenza tra i popoli che compongono la Monarchia spagnola. Con la sua
6 Mi riferisco al filone delle cosiddette “epopee mercantili”, che circoscrive i casi di studio
alle relazioni commerciali ed economiche che avvenivano sulle piazze di scambio mercantili
tra Quattro e Cinquecento, F. Piccolo, La letteratura portoghese, Sansoni/Accademia, Bologna,
1970; J. Cortesão, Os Descobrimentos Portugueses, Livros Horizonte, Lisboa, 1975; Id., A expedição de Pedro Álvarez Cabral e o Descobrimento do Bazil, Imprensa Nacional casa da Moeda, E.
P., 1994; per una ricognizione generale in tema di rapporti commerciali, AA.VV., Il Portogallo
e i mari: un incontro tra culture, Atti del Congresso internazionale, (a cura di M. L. Cusati),
Liguori, Napoli, 1998.
7 G. Galasso, Storia del Regno di Napoli, vol. I, Il Mezzogiorno angioino e aragonese (12661494), UTET, Torino, 2006, p. 831-832.
8 F. Dores Costa, A Guerra da Restauração 1641-1668, Livros Horizonte, Lisboa, 2004,
introduzione.
92
Gilda Caprara
tesi sulla misma familia historica9, F. E. de Tejada, nella seconda metà del Novecento, riprende questa tradizione classica ed impronta su di essa l’unico studio
attualmente conosciuto in tema di relazioni politiche luso-napoletane.
In Tejada, l’esistenza di conexiones di natura ideologico-culturale è accettabile, in prima istanza, laddove risultano innegabili alcune caratteristiche comuni tra le parti che compongono la Monarchia: dalle affinità geografiche, politico-economiche, sociali e culturali, in sostanza, deriverebbe, secondo lo storico
spagnolo, un sentido di appartenenza, alla nazione iberica ed alla respubblica
christiana, da cui prenderebbe vita una comunione di intenti tale da rendere
identiche le trame macchinate da Portogallo e Napoli ai danni del regime10.
La riflessione dell’autore è volta a raggruppare le sommosse degli anni ‘40
del Seicento, all’interno della citata famiglia storica, facendo ricorso a connessioni di natura politico-ideologico-culturali atte a giustificare il motivo del sollevamento popolare dei regni appartenenti alla Monarchia spagnola: essendo
questi elementi per natura parte di un tutto, la convergenza di spinte alla ribellione risulterebbe ineluttabile11.
Tejada si avvale della produzione giuridica cinquecentesca che dimostra la
validità dei diritti dei sovrani cattolici sul trono portoghese come naturalmente12 appartenenti alla storia del Regno di Portogallo. Nel 1580 i giuristi consacravano Filippo II come rey natural13 portoghese: erede legittimo e sovrano
appartenente “per sangue e per stirpe” al Regno lusitano.
9 F. E. de Tejada, Portugal en el pensamiento politico napolitano durante la unión de ambas
coronas (1580–1640), Separata do Vol. II das ACTAS do V Coloquio Internacional de Estudos
Luso-Brasileiros, Coimbra, 1965.
10 Nell’ottica – specifica F. E. de Tejada – della realizzazione di una “confederazione multinazionale”. Tale espressione, largamente utilizzata nei suoi lavori sulla Napoli spagnola, vol. I,
ed. Controcorrente, Napoli, 1999, è caduta ormai in disuso nel dibattito storiografico.
11 Scrive F. E. de Tejada: “l’impatto di valore politico – dovuto ad una forma di aggregazione
di tipo confederativo – insieme alle altre numerose affinità culturali, segnala la prima approssimazione tra due civiltà, la napoletana e la portoghese, che sembrano vivere una sorta di simbiosi
politica remota. E, poco alla volta, danno vita a qualcosa di più che ad una coincidenza transitoria
o esterna; sono indice di una convergenza di intenzioni per cui, entrambe, assumeranno identiche
trame ai danni del regime”, traduzione mia di F. E. de Tejada, op. cit. in nt. 9, p. 7.
12 F. E. de Tejada, ibidem, ivi.
13 Nel 1640, con lo scoppio della Guerra di Restaurazione, i giuristi portoghesi preferirono
l’utilizzo di una terminologia più specifica, quella cioè di rei proprio e natural, allo scopo di distinguere tale concetto, che divenne la formula della resistenza portoghese, da quello di rey natural
spagnolo. In realtà, fino a questo momento, i giuristi portoghesi non avevano mai avvertito la
necessità di distinguere la figura di un sovrano “naturale”, e cioè un sovrano legittimato al trono,
da un sovrano “proprio”, e cioè appartenente “per sangue e per stirpe” alla terra di Portogallo.
Questo perché, nel caso portoghese, i due termini si integravano. Tuttavia, negli anni quaranta del
Seicento, per giustificare la resistenza, i giuristi portoghesi invocarono la formula di “restituzione
di un re proprio e natural”, accusando di tirannia Filippo IV ed i re di casa d’Austria come sovrani
naturali ma non proprii della terra di Portogallo, F. Dores Costa, cit. in nt. 8, p. 14.
I rapporti politici luso-napoletani tra Cinque e Seicento
93
In realtà però, nonostante “parlare di Spagna rimandi indistintamente –
Tejada chiama in causa Campanella per comprovare il suo pensiero sull’essenza storica della grande famiglia ispanica – a li castigliani, aragonesi e portoghesi,
aggruppandoli con matrimoni et unione nel navigare”14, quanto sostiene lo storico non basta né ad accomunare sentimenti politici di due attori che si ribellano
con spinte indubbiamente diverse al fiscalismo spagnolo15, né a spiegare le successive dinamiche di contatto, nella seconda metà del Seicento, che sembrano
piuttosto scaturire da una reale intenzione di politica di potenza del Portogallo
restaurato16.
Senza dubbio, però, l’appartenenza dei due soggetti, Napoli e Portogallo, ad
una stessa realtà storica – il riferimento è al sistema imperiale spagnolo piuttosto che alla familia historica – innesca, inevitabilmente, meccanismi di funzionalità ed interdipendenza e forma una serie di coerenze politiche17 che legano i
due regni per oltre un cinquantennio (1580-1640) al punto tale da gettare le basi
per progetti di futura, seppur tacita18, collaborazione politica ed al punto tale
da influenzare le decisioni governative del centro del sistema stesso. Il governo madrileno, infatti, è costretto costantemente a fare i conti non soltanto con
le congiunture e l’evoluzione costante della politica internazionale, ma anche
con i cambi di direzione politica seguiti dalle parti che afferiscono al sistema.
Non a caso, nonostante gli obiettivi fissi tendenti al mantenimento della sua di14 T. Campanella, Opere, Torino, Cugini Pomba e Comp., 1854, tomo II, Della monarchia
di Spagna, pp. 165.
15 In tema di conflitti interni al sistema imperiale spagnolo, si segnalano: A. Musi, Le rivolte italiane nel sistema imperiale spagnolo, Mediterranea, Ricerche storiche, Anno II, Agosto
2005, n. 4, p. 212; A. Musi, La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca, Napoli, 1989,
2003; G. Galasso, Alla periferia dell’impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVIXVII), Torino, 1994; J. H. Elliott, The revolt of the Catalans. A study in the decline of Spain
(1598-1640), Cambridge, 1963; J. F. Schaub, La crise hispanique de 1640. Le modèle des «revolutions pèriphèrique» en question (note critique), in «Annales», XL, 1994, pp. 219-239; J. L. Palos
Penarroya, Il dibattito ideologico nella rivoluzione catalana del 1640: nuovi orientamenti storiografici, in «Il Pensiero Politico», XXXIII, 2000, pp. 117-132; R. Villari, La rivolta antispagnola
a Napoli. Le origini (1585-1647), Bari, 1967; L. A. Ribot Garcia, La revuelta antiespañola de
Mesina. Causas Y antecedentes (1591-1674), Valladolid, 1982; F. Benigno, Specchi della rivoluzione. Conflitto e identità politica nell’Europa moderna, Roma, 1999; F. Dores Costa, Guerra da
Restauração Portuguesa, 1641-1668, Livros Horizonte, Lisboa, 2004; J. V. Serrão, O tempo dos
Filipes em Portugal e no Brasil (1580-1668), coll. Estudos Históricos, Ed. Colibri, Lisboa, 1994.
16 Quanto dico, verrà corroborato in corso di stesura.
17 Espressione mia per indicare il rapporto tra le sorti politiche del Regno di Napoli e
quelle del Regno di Portogallo: è chiaro dalle fonti diplomatiche, infatti, che i fatti napoletani
s’inseriscano a pieno nella politica di potenza portoghese degli anni della Guerra di Restaurazione, più spesso plasmandone le decisioni politiche e le sorti belliche.
18 Nelle corrispondenze tra i vari ambasciatori, gli avvenimenti del Regno di Napoli sono
sempre motivo di grande interesse. Certo il Regno non partecipò mai direttamente alla Guerra
di Restaurazione ma, come si vedrà di seguito, il ruolo ad esso affidato risulta senza dubbio
centrale ai fini del buon esito del conflitto.
94
Gilda Caprara
mensione imperiale, la Monarchia spagnola farà i conti con i fronti comuni di
rivolte intestine e con la perdita di alcuni suoi territori. Ed è proprio lo scoppio
dei due conflitti interni alla Monarchia, la Guerra di Restaurazione portoghese prima e la rivolta napoletana poi, a costituire il limite per il quale i rapporti
Napoli-Portogallo cessano di essere rapporti per così dire sistemici – derivanti,
cioè, dall’interazione di soggetti politici che agiscono all’interno di un contesto
sistemico – e passano ad essere rapporti di diversa natura, completamente slegati da quelle stesse logiche che li hanno generati.
L’utilizzo della categoria di sistema, pertanto, permette non solo di assumere
il 1580 – l’annessione del Regno di Portogallo alla Spagna – come evento periodizzante per le relazioni politiche luso-napoletane d’età moderna, ma anche di
ipotizzare una tipizzazione del contatto Portogallo-Napoli su due livelli19: un
primo livello, di contatto diretto, per cui il contatto tra le parti si manifesta in
maniera tangibile ed è giustificato dall’inserimento di esse in una realtà sistemica20; i casi in questione sono identificabili in azioni militari, di fanteria, di
cavalleria, navali, tanto in territorio portoghese quanto in terra straniera; un
secondo livello, di contatto indiretto, che si consuma in azioni diplomatiche
relative ad eventi a sé stanti, scissi, cioè, dal contesto di un’unità prodotta per
effetto di un sistema, e localizzabili in ambito internazionale. Tale contatto si
estrinseca sotto forma di un particolare interesse da parte del governo portoghese per le cousas de Nápoles, come chiamate nei carteggi contenuti nel Corpo
Diplomatico Português21.
La questione brasiliana degli anni venti del Seicento fornisce un chiaro
esempio del concetto di contatto politico diretto, perché espressione di collaborazione militare tra le varie parti della Monarchia spagnola.
Il Regno di Portogallo come Portogallo spagnolo22 contribuì sia mediante il
suo impero coloniale sia come regione spagnola alla vita della Monarchia esplicando una serie di funzioni strategico-militari ed economiche.
Le prime sono legate alla difesa imperiale. Si tratta di un presupposto governativo per il quale i territori esterni all’impero difendono i territori interni
19 La duplice suddivisione, suggeritami nel corso dei miei studi dall’analisi dei documenti,
intende operare una possibile ricostruzione delle relazioni luso-napoletane nel Seicento, che
rappresenti la prima organizzazione di una materia così frammentata.
20 Per realtà sistemica si vuol intendere non soltanto il caso specifico del sistema imperiale spagnolo, ma qualsiasi sistema di rapporti internazionali.
21 BNL, CG32A, fundo CDP–Relação com a Curia Romana.
22 In quest’ottica, il Regno di Portogallo diviene un sottosistema del sistema Spagna. La
mia ipotesi applicativa deriva dallo studio condotto da A. Musi, Nel sistema imperiale,…cit.
in nt. 5.
I rapporti politici luso-napoletani tra Cinque e Seicento
95
in cambio di sostegno militare e finanziario dalla Monarchia: all’occorrenza,
anche i territori esterni godranno di difesa imperiale, anzi, tutti i soggetti imperiali si uniranno per far fronte al problema comune in quanto integrati 23 in
un tutto.
È nel periodo di Filippo IV, quello cioè che vede una vera e propria integrazione24 del Portogallo nel sistema, che si assiste al primo caso di presenza effettiva del Regno di Napoli nelle azioni belliche portoghesi.
A narrare il fatto storico è Gino Doria che esamina il caso delle guerre baiane in riferimento al numero dei capitani e dei soldati napoletani impiegati
contro gli olandesi25.
Il Doria ci ricorda che nella storia delle molteplici guerre europee, prima e dopo
il trattato di Vestfalia, i nomi di militari italiani ricorrono quasi di continuo26.
Nello specifico, soldati e capitani napoletani furono impiegati, dalla Corona
spagnola, nelle guerre in Brasile contro gli olandesi, incominciate nel 1625 e
conclusesi, dopo periodi di tregua, nel 164127.
La storiografia portoghese semplifica il periodo delle guerre baiane in due
date, 1625 e 1641, e in entrambi i momenti, interamente ricostruiti dal Doria,
l’impiego dei soldati napoletani risulta decisivo.
La presenza napoletana nei fatti baiani diviene un case-study che rientra nei
casi d’intervento diretto, i quali si inseriscono naturalmente in quell’ottica di
partecipazione “assistenziale-devozionale” dettata dalle contingenze: il Doria
nota quanto assistenza e servile devozione al re cattolico e al sacro romano impero28 siano caratteristiche che rendevano, al tempo, la domanda d’impiego di
militari napoletani molto alta.
La congiuntura internazionale, infatti, richiedeva una coesione maggiore
tra le parti di una potenza ormai in declino: è il momento in cui la Spagna deve
affrontare il peso militare e coloniale della Francia di Richelieu e di un nuovo
e temuto avversario estremamente competitivo in Oriente dal punto di vista
commerciale, gli Stati Generali.
Sul concetto di integrazione A. Musi, L’Italia dei Vicerè. Integrazione e resistenza…cit. in nt. 5
La storiografia lusitana è concorde nell’affermare che solo con l’avvento di Filippo III comincia l’integrazione portoghese nella Monarchia spagnola. I suoi tentativi di centralizzazione
giungeranno ai massimi livelli con la politica negatrice dei diritti portoghesi attuata da Filippo
IV e dal Conte-Duca, J.V. Serrão, op.cit. in nt. 15, parte I, Visões de Conjunto; J. H. Saraiva,
História de Portugal, ed. B.H., Lisboa, 1998, p. 207.
25 G. Doria, Mondo vecchio e Nuovo mondo, Napoli, Ed. Scientifiche italiane (ESI), 1966,
ma anche in ASPN, nuova serie, XVIII (1932), pp. 224-250.
26 G. Doria, Mondo vecchio e Nuovo mondo, p. 291.
27 Doria, ibidem, pp. 291-315.
28 Ibidem, p. 291-292.
23 24 96
Gilda Caprara
Il Portogallo non disponeva, in quel momento, di adeguati mezzi atti ad
impedire una così spietata concorrenza e si appellò allo statuto per beneficiare
degli aiuti spagnoli. La Spagna filippina, tuttavia, poco o nulla fece per preservare l’Oriente portoghese: d’altra parte il Brasile costituiva l’interesse primario
di una potenza a vocazione spiccatamente americana, che non voleva perdere
i benefici commerciali derivanti dall’unione con Lisbona. Già Filippo III, nel
1612, aveva reagito ad una squadra francese (la Reverdiére), che tentava di impossessarsi del Maranhao, inviando una serie di flotte che conseguirono esiti
positivi alcuni anni dopo, nel 161529. Si ha ragione di credere che già in questo
caso fosse convocata dal Governo centrale una flotta napoletana30.
Nel 1623 fu la volta degli Stati Generali che, sfidando il principio del mare
clausum con l’intento di creare un impero coloniale olandese a scapito portoghese e spagnolo, si appropriarono di São Salvador da Bahía, capitale del
Brasile31.
Pervenuta in Europa la notizia dell’audace colpo di mano degli olandesi,
Filippo IV ordinò l’invio di una flotta: di essa fecevano parte 4 navi napoletane,
agli ordini del Marchese di Cropani. Fra le truppe di sbarco era compreso un
tercio32 reclutato nel viceregno di Napoli e capeggiato da uno dei migliori militari del tempo, Carlo Andrea Caracciolo, Marchese di Torrecuso; al suo seguito,
una serie di ufficiali che si erano già distinti nelle guerre europee33.
Il Doria, nella sua trattazione, offre notizie dettagliate sia sull’operazione
baiana sia sugli attori che resero possibile la vittoria. La flotta spagnola era
composta da 5 armate; tra queste, la Escuadra de Nápoles era composta da 4 navi
e 1183 uomini, che andarono a coadiuvare la Armada de Portugal, composta da
22 navi e 4346 uomini. Interessante la composizione della squadra napoletana34
il cui comando era stato assunto dal Marchese di Cropani, maestro di campo
generale: nave ammiraglia era il galeone Nuetra Señora de la Anunciación, nave
capitana di Napoli era il galeone Concepción de la Siempre Virgen María; infine
J. V. Serrão, op. cit. in nt. 15, p. 25 e 26; J. H. Saraiva, op. cit. in nt. 24, p. 208.
I documenti, tuttavia, appaiono frammentati e privi di dettagli sul corpo della flotta,
ANTT, Collectanea, “Nápoles”, 1614-1616.
31 J. H. Saraiva, op. cit. in nt. 23, p. 208.
32 Un tercio, antico nome dei reggimenti spagnoli, era costituito da 12 a 15 compagnie
con un numero variabile di uomini, con totale degli effettivi da 1000 a 3000, G. Doria, op.cit.
in nt. 25, p. 297.
33 Ibidem, pp. 293-294.
34 La fonte del Doria è il Compendio Historial de la Jornada del Brasil di D. Juan de Valencia y Gusman, il quale aveva fatto parte dell’impresa. La relazione rimase a lungo inedita,
nella raccolta di F. Navarrete, finchè nel 1870, venne pubblicata nel tomo IV, p. 43ss., della
Collección de Documentos inéditos para la historia de España.
29 30 I rapporti politici luso-napoletani tra Cinque e Seicento
97
le ultime due navi El Carmen e San Jorje35. Della squadra di Napoli soltanto
l’ammiraglia conduceva effettivi del tercio napoletano; le altre forze napoletane
erano ripartite tra le 4 armate della flotta spagnola36. Il tercio napoletano si
componeva di 830 uomini, distribuiti in 20 compagnie, e di 50 ufficiali37,
comandati dal maestro di campo Marchese di Torrecuso e coadiuvato dal
sergente-maggiore Muzio Origlia38.
Insieme con il Marchese di Cropani viaggiava l’altro sergente-maggiore e
governatore Giovan Vincenzo Sanfelice, Conte di Bagnoli. “La imponente flotta
– scrive il Doria – dopo una lunga traversata non priva di incidenti, si ancorò
innanzi a Bahía il 29 marzo 1625”39. In ossequio al principio di mutuo soccorso, quindi, fu chiamato anche il Regno di Napoli a partecipare all’impresa di
reconquista40.
Nell’aprile del 1625 la forza congiunta luso-spagnola-napoletana41 riconquistò la città di São Salvador da Bahia de Todos os Santos42. Questo episodio
militare, che rimase noto come “l’Impresa dei Vassalli della Corona di Portogallo per recuperare la città del Salvatore, nella Baia di Tutti i Santi, presa dagli olandesi, l’8 Maggio del 1624 e recuperata il 1° Maggio del 1625”43, mette
G. Doria, op. cit. in nt. 25, p. 295.
Ibidem, p. 296.
37 Il Doria contesta le somme proposte da Menezes nella sua relazione di viaggio: Recuperação da Cidade do Salvador escripta por D. Mamuel [sic] de Menezes cronista e chrosmographo
[sic] de Sua Magestade e capitão geral da Armada de Portugal naquela empersa [sic], BNM. Il
documento è stato pubblicato da F. A. de Varnahgen in Rev. do Inst. Hist e Geogr. Brasil., XXII,
1859, pp. 357 e 527.
38 G. Doria, op. cit. in nt. 25, p. 295, citando il Compendio Historial de la Jornada del Brasil
di D. Juan de Valencia y Gusman.
39 Segue l’esposizione del fatto storico. Il Doria, tra l’altro, segnala anche le compagnie
di picchieri, una delle quali a carico di Ettore della Calce, di nobile famiglia salernitana che,
tempo dopo, nel 1636, condusse in Catalogna 600 uomini, G. Doria, op. cit. in nt. 25, p. 299.
40 La guerra contro gli olandesi fu vissuta, al tempo, come se fosse una guerra contro gli
infedeli. In merito il Doria, ibidem, p. 312, cita Filamondo, Genio Bellicoso, p. 381, che oppone alle “fiere calviniste” i “cattolici leoni”.
41 M. L. Cusati, introduzione agli Atti del Convegno Padre Antonio Vieira S. J. e Napoli,
IUO, 15-22 Dicembre, Napoli, 1997.
42 Il Doria scrive che gli olandesi si ritirarono dinanzi alla resistenza degli spagnoli e dei
napoletani. Lo storico enfatizza il ruolo di questi ultimi. Si tenga sempre presente che, in
ogni caso, l’operazione fu diretta, almeno in linee generali, dai portoghesi e nello specifico dal
governatore brasiliano Matias de Albuquerque, Menezes, cit. in nt. 37; J. Nogueira Jaguaribe,
O conde de Bagnuoli. Os Italianos na defesa da integridade do territorio do Brasil e na nossa
historia durante a guerra contra os Hollandezes, São Paulo, Empr. Typ. Editora o Pensamento,
1918; Brito Freire, Nova Luzitania, 1627; Tamayo de Vargas, Restauración de la Ciudad del
Salvador, Madrid, 1628, trad. por Ignacio Accioli de Cerqueira, Bahia, 1847.
43 Dal diario di Padre Bartolomeu Guerriero, Jornada dos Vassalos da Coroa de Portugal,
para se Recuperar a Cidade de Salvador, na Bahya de Todos os Santos, Tomada pellos Olandezes,
a Oito de Mayo de 1624 &Recuperada ao Primeiro de Mayo de 1625, Lisbona, 1629, ed. por
Matheus Pinheiro, ANTT, sez. manuscritos da livraria, ma anche in BNL.
35 36 98
Gilda Caprara
chiaramente in evidenza la collaborazione politica tra le varie parti del sistema
Spagna contro i nemici della Monarchia asburgica. Il fatto dimostra quanto
efficace potesse essere il concorso di forze nell’assistenza in caso di necessità:
all’epoca, infatti, era chiaro che El Castellano, el Portugués, el Napolitano como
unos en la lei i en el Rei, lo son de ordinario en el valor44.
In definitiva, dal fatto storico traspare un sentimento di fratellanza e di solidarietà tra napoletani e portoghesi che si andava raffinando col contributo del
battaglione di fanteria del Conte di Bagnoli, il quale operò di concerto per la
liberazione di Bahia dagli oppressori. “Alla fine di Aprile – scrive il Doria – gli
Olandesi, considerata inutile ogni resistenza, capitolarono, accettando le condizioni imposte dal Sanfelice, che fu l’ambasciatore del campo spagnolo per le
trattative”45.
Il fatto che proprio Napoli fosse chiamata ad impiegare risorse umane nella
vicenda brasiliana chiarisce, sicuramente, la posizione di preminenza e di fiducia accordata dal Governo centrale al Regno. Aldilà delle qualità tecniche della
flotta napoletana – tanto che si affidò ad essa la difesa di tutta l’ala sinistra di
São Bento46, convento edificato su un’altura non lungi dalle mura di cinta, che
fungeva da importante avamposto per l’esito della battaglia47 – infatti, Napoli
godeva della caratteristica di fedelissima e la risonanza di questa sua fedeltà era
giunta fino in Portogallo48.
Questo caso di convergenza tra il Regno di Portogallo ed il Regno di Napoli
potrebbe essere assunto come presupposto per le relazioni future: prima della
vicenda brasiliana, infatti, le parti in questione non avevano mai avuto contatti
paragonabili a quelli evidenziati in questo studio, nemmeno il Doria ha riscontrato casi precedenti a quello baiano.
In sostanza, ripeto, prima del 1580, era mancata qualunque possibile convergenza: Napoli e Portogallo non condividevano ancora la realtà sistemica, sebbene
fossero ravvisabili elementi di coesione quali affinità politico-culturali, istituzionali
e religiose; non esisteva, inoltre, proiezione del Regno di Napoli su scala atlantica,
nella quale si era già affermato, invece, da più di un secolo, il Portogallo.
Tamayo de Vargas in Doria, op. cit. in nt. 25, p. 301.
G. Doria, ibidem, p. 300.
46 Ibidem, p. 299.
47 Ibidem, p. 298.
48 Come si evince dai manoscritti anonimi divulgati in territorio portoghese al tempo della rivolta napoletana: BMC, sez. manuscritos, Relação verdadeira do levantamento de Napoles
e de Sicilia, com a copia dos capitulos acordados entre o Visor-rey e o Povo de Napoles, div. por
Lab. D. Lopes Rosa, 1648; BMP, sez. manuscritos, Relação verdadeira e diaria de todo o principio e sucesso e resolução que ouve em Napoles ate a morte de Thomas Aniello, 1648; ma anche
nei carteggi del CDP, più volte è nominato il fidelissimo povo de Nápoles.
44 45 I rapporti politici luso-napoletani tra Cinque e Seicento
99
Se il contatto dovuto all’appartenenza ad un sistema può essere assunto
come presupposto di una serie di contatti tra due sottosistemi49, il caso Bahia
diventa il terminus a quo della catena delle relazioni politiche luso-napoletane.
Casi diretti ed indiretti, infatti, seppur apparentemente privi di una corrispondenza logica, temporale, spaziale, vanno a costituire gli anelli di questa catena;
essi, nel loro insieme, non solo sfociarono, negli anni ‘50 del Seicento, in un
tentativo di rivolta portoghese nel napoletano, ma anche in una collaborazione tacita, per continuità di vedute, durante tutta la seconda metà del Seicento.
Dagli anni venti agli anni trenta del XVII secolo il Portogallo perdeva gran
parte dei suoi possedimenti coloniali: “l’Olanda non si rassegnò allo scacco del
1625”50 – scrive Doria, ricordando che nel 1630, gli olandesi si attestavano nel
Pernambuco, una delle regioni più popolose ed economicamente più ricche di
tutto il territorio coloniale51. Quella del Pernambuco fu una delle più grandi
questioni che, dalla Restaurazione in avanti, sovrani e ministri tentarono di
dipanare con qualsiasi mezzo.
Il governatore brasiliano Mattia de Albuquerque cominciò a raccogliere
gente armata per la difesa del territorio; nell’aprile del 1631 anche la “metropoli spagnola”52 mandava soccorsi: una flotta comandata da Don Antonio de
Oquendo, composta da 19 navi, di cui 5 portoghesi. Le forze di sbarco destinate
al soccorso del Pernambuco (altre erano destinate a guarnire Bahía e Parahiba)
furono poste, ancora una volta, sotto il comando del Sanfelice che aveva radunato gli ufficiali e i soldati che si erano distinti nel 1625 nel recupero di Bahía53.
Nella battaglia del 12 settembre gli spagnoli ebbero la peggio, ma ciò che
interessa sottolineare è che, anche in questo caso, furono impiegati nella vicenda baiana contingenti napoletani. Pare, infatti, che fossero chiamati alle armi
700 uomini, 300 dei quali napoletani, e che l’operazione fosse diretta, congiuntamente, dal Sanfelice e dall’Albuquerque. La cosa suscitò, in terra lusitana,
un vero e proprio dibattito su quanti osannarono le imprese del Sanfelice e su
quanti, invece, preferirono rendere merito all’Albuquerque54.
Si veda nt. 22.
G. Doria, op. cit. in nt. 25, p. 302.
51 J. H. Saraiva, op cit. in nt. 24, p. 208.
52 G. Doria, op. cit. in nt. 25, p. 303.
53 Ibidem, ivi, ma anche: BNM, Relación de la jornada que la armada cuyo Capitan Generale D. Antonio de Oquendo hizo al Brazil para cocorrer las plazaz de aquella Provincia, y batallas
que entre ellas y la de Olanda se dieron en doze de settembre de 1631, Madrid, 1632, n. 3203.
54 Nel suo lavoro il Doria sostiene, tra l’altro, che la disfatta del ‘31 fu dovuta proprio alla
poca intesa tra i due. Si pensa, infatti, che per seguire le disposizioni del governatore portoghese, il Sanfelice avesse perso tempo ed energia in più prestazioni mentre invece, secondo
il suo stesso parere, avrebbe potuto concentrare le forze al capo S. Agostino. L’Albuquerque
49 50 100
Gilda Caprara
Ricordare i militari napoletani al servizio della Spagna crea un precedente storico nella casistica delle relazioni luso-napoletane. L’episodio, pressocché
ignoto ovvero trascurato dagli storici, è stato quasi dimenticato “a causa – ci
dice il Doria – del suo svolgimento di là dall’Oceano”55. La politica di potenza
internazionale portoghese e spagnola, in realtà, non può prescindere da quella
extraeuropea dove Portogallo, Spagna e Napoli erano impegnate su un fronte
comune; anzi, è proprio la coesione in ambito territoriale che getta le basi per
una collaborazione militare extraterritoriale, anche quando, nel 1641, il Portogallo ha ormai dichiarato la sua indipendenza dalla Spagna: in quest’anno,
ancora una volta, si ha notizia di soldati napoletani impegnati nelle vicende
baiane56. E non è questo l’unico caso.
Sul piano interno, infatti, i documenti relativi agli anni ‘40 del Seicento
dimostrano che alcune vittorie portoghesi, nella prima fase della Guerra di
Restaurazione (1640-1646), dipendono dall’intervento diretto o indiretto
di Napoli nelle strategie belliche adottate dal governo lusitano. È il caso, ad
esempio, della battaglia di Valverde che, come già si è detto per il caso Bahia,
testimonia, ancora una volta, l’intervento napoletano nelle battaglie portoghesi:
si assiste, infatti, ad “un voltafaccia” da parte dei napoletani al Re di Castiglia,
volle invece che il Sanfelice rinforzasse con truppe napoletane Porto-Calvo. Il Doria pensa
che, proprio a causa della divergenza di vedute, nel 1635 gli olandesi avessero avuto la meglio.
Come nota lo stesso Doria, gli Albuquerque erano due: Mattia, maestro di campo generale, e
il fratello Duarte, donatario della provincia di Pernambuco e autore delle Memorias diarias,
che descrivono la disputa. Fu così che la Spagna, nel 1636, decise di inviare altri 1700 uomini
comandati da Luis de Rojas y Borja. Tra quegli uomini vi erano anche molti napoletani, tra i
quali il figlio del Conte di Bagnoli, Marcantonio Sanfelice. Morto Rojas, con la cedola di successione si trovò designato il Sanfelice maestro di campo generale. La cedola fu pubblicata
da Duarte d’Albuquerque Coelho, Memorias diarias della guerra del Brasil, Madrid, 1643. Gli
studi del Doria mettono in evidenza che il fatto fu accolto male dai portoghesi a causa delle
citate divergenze del Sanfelice coll’Albuquerque. Nogueira Jaguarribe, in op. cit. in nt. 42, pp.
42-44, tuttavia, stilò un vero e proprio panegirico del Conte di Bagnoli. Sulle opinioni discordanti, G. Doria, op. cit. in nt. 25, pp. 306-313.
55 Doria, ibidem, ivi.
56 Ibidem, pp. 313-315. Il Doria ricorda, inoltre, che “nell’ultimo periodo della guerra
contro gli olandesi, quando per la disunione del Portogallo dalla Spagna le truppe napoletane erano state già ritirate, gesuiti siciliani parteciparono attivamente alla campagna del
1643-‘45, sollevando il popolo contro gli Olandesi e incitando alla battaglia, con l’accampare
visioni profetiche, il generale Antonio Teixeira”, G. Doria, I gesuiti italiani nel Brasile e il
profetico padre Amodei, in «Rivista d’Italia e d’America», marzo 1925, p. 18ss. L’analisi delle
certidões proposta dal Doria risulta estremamente interessante sia come testimonianza del
mutuo soccorso, anche ad indipendenza portoghese dichiarata, sia come testimonianza del
profetismo gesuita che tese ad enfatizzare i personaggi implicati nelle vicende baiane tanto
da santificarli. Anche il Vieira espresse pareri politici in merito alle guerre baiane, come si
legge in: C. X. de Albuquerque, A remuneração de serviços da guerra holandesa, Recife, Univ.
Federal de Pernambuco, 1968; P. Agostinho, A política de Vieira e a entrega de Pernambuco,
Lisboa, Espiral, 1965, pp. 122-134; L. Avelino s. j., Vieira: Trilogia Literária na luta contra o
Holandês, in «Verbum», 16, Rio de Janeiro, 1959, pp. 235-249.
I rapporti politici luso-napoletani tra Cinque e Seicento
101
fatto del tutto singolare per un regno considerato da sempre il più fedele alla
Corona.
Nel 1643 incominciava la campagna d’autunno in tempi di gravi
contraddizioni strategiche. Si optò per la messa in atto di un episodio ad
orientamento militare offensivo. Pertanto l’iniziativa ebbe origine dal versante
portoghese: un esercito di 17 mila fanti e 2 mila cavalieri penetrò nel territorio
nemico agendo contro i Signori Valverde, provocazione che si concluse col
saccheggio della villa, poi rasa al suolo e incendiata. Una parte della guarnigione,
posta a tutela dell’edificio, era costituita da napoletani57, i quali entrarono a far
parte dell’esercito portoghese compiendo in tal modo il tradimento nei riguardi
dell’esercito spagnolo. Fu grazie al massiccio ingresso dei napoletani nelle
fila portoghesi che maturò la decisione, da parte dei capitani dell’esercito58,
forti di un consistente numero di uomini ormai nettamente superiore a quello
dell’esercito spagnolo, di attaccare anche Badajoz.
Grazie all’affluenza di risorse umane, si colse tempestivamente l’occasione
per sferrare la successiva offensiva: la mancanza di forze sottratte alla risposta
d’azione spagnola di Valverde avrebbe implicato che gli eserciti di Badajoz si
sarebbero mossi in soccorso di Valverde lasciando sguarnita la stessa Badajoz59.
L’esito positivo delle azioni belliche del 1643 fu dovuto alla partecipazione di
“quella guarnigione napoletana”60.
Questo caso diviene un ulteriore anello della già citata catena di relazioni
politico-militari luso-napoletane. È proprio su questa esperienza che, verosimilmente, si fonda il disegno politico-diplomatico del governo portoghese degli
anni Quaranta e Cinquanta del Seicento, finalizzato a tessere rapporti sempre
più fitti col Regno di Napoli per meglio attuare gli scopi della Restaurazione.
Parallelamente ai casi di contatto che derivano dal coinvolgimento del
Regno di Napoli in azioni militari, infatti, esiste un’altra casistica di relazioni
luso-napoletane che si estrinseca mediante l’azione diplomatica.
57 Si tratta di 400 uomini, secondo Gastão de Melo Matos, André de Albuquerque Ribafria,
in «Anais», Accademia Portuguesa de História, Lisboa, vol. XII, 1954, e BNL, AP [1643].
58 Ibidem. Tra i capitani, in ordine cronologico, si ricorda il dirigente massimo dell’esercito, Conte di Obidos, ed il suo successore, Matias de Albuquerque. Per i contrasti tra quest’ultimo ed il Vasconcelos (vicerè portoghese, una sorta di “valido del valido” Conte Duca d’Olivares) il quale non gradiva che l’attacco continuasse, l’operazione Badajoz fu accantonata,
ibidem.
59 ANTT, CG, consultas n° 242 e 285 de 1642, Maços n.° 2-D e n° 2-E.
60 Ibidem. Se ben si conoscono i nomi dei capitani portoghesi non si può dire altrettanto
per quelli napoletani.
102
Gilda Caprara
Il ruolo fondamentale della diplomazia, nella ricostruzione del prestigio in
ambito internazionale del Portogallo restaurato, è storicamente riconosciuto,
ma poco studiato in termini di connessioni stricto sensu.
Solo di recente, infatti, è stato notato che nel Seicento le relazioni culturali
tra Portogallo e Napoli furono veicolate dalle ambasciate portoghesi in territorio italiano61.
Lo studio del Corpo Diplomatico Portoghese ha messo in luce un forte contatto tra le due culture ed ha avviato un nuovo filone di studi che precisano
quanto le relazioni culturali tra Portogallo e Napoli nel Seicento fossero decisamente più forti rispetto a quelle del Cinquecento, proprio in virtù degli scambi
diplomatici compiuti dalle ambasciate62.
Ad incremento dei risultati raggiunti dalla storiografia portoghese in ambito
artistico-culturale, sembra opportuno rivalutare l’elemento politico-istituzionale
– come fattore strutturante e contestualizzante per le relazioni luso-napoletane
– giacchè l’internazionalizzazione delle relazioni politiche fu simultanea a quella
delle relazioni culturali63: la diplomazia, infatti, non solo divenne il mezzo di circolazione dei modi artistici italiani in terra lusitana, ma divenne anche e soprattutto
l’interprete del sovvertimento dello status quo portoghese al tempo della Restaurazione, mettendo in atto una strategia che prevedeva, tra le altre negoziazioni, un
contatto politico tra la realtà portoghese e quella napoletana.
La diplomazia caratterizza la struttura che fa la politica; è mediante la diplomazia che i soggetti si riconoscono sulla scena politica europea del XVII
secolo; è per mezzo di essa che il governo portoghese modulava le sue scelte,
fissava regole, elastiche, compatibili con la congiuntura che richiedeva un rico61 Le relazioni culturali di matrice artistica sono state di recente oggetto delle attenzioni di
T. L. Magalhães do Vale, Escultura italiana em Portugal no século XVII, Caleidoscópio, Lisboa,
2004. Tale scritto, in un vasto panorama di studi sulle ambasciate portoghesi, è l’unico ad aver
evidenziato rapporti culturali derivanti dal contatto diplomatico.
62 Le quali fecero circolare i modi scultorei italiani, del Bernini e del Borromini, in terra
lusitana, T. L. Magalhães do Vale, op. cit, introduzione.
63 J. H. Saraiva, op. cit. in nt. 24, p. 182. La qual cosa, all’atto pratico, in Portogallo non
si verificò in misura rilevante a causa dell’operato dell’Inquisizione che provocò un isolamento dell’attività culturale lusitana rispetto al movimento delle idee europee, movimento
che, proprio in quest’epoca, risultava estremamente intenso ed innovatore Saraiva, ibidem,
p. 187. Tali relazioni rimasero, nel caso letterario, assai elitarie tanto che l’Umanesimo sembrò toccare marginalmente il Portogallo, rimanendo confinato al mondo gesuita, ibidem, pp.
183-184. Da tali considerazioni, muovono gli studi religiosi tra Portogallo e Napoli a riguardo
dell’opera religiosa e politica dei gesuiti. Malgrado questa chiusura, paradossalmente, le relazioni tra Portogallo e Napoli nel XVI secolo furono, come si è visto, prettamente commerciali e culturali e, più specificamente, legate alla diaspora degli ebrei portoghesi rifugiatisi in
Italia. Questi, in città quali Napoli, Ferrara, Venezia e Bologna, intrapresero diverse attività;
in special modo, si dedicarono alla stampa dando vita ad un vero e proprio movimento editoriale, veicolando la cultura lusitana in terra italiana e viceversa, ibidem, pp. 189-190.
I rapporti politici luso-napoletani tra Cinque e Seicento
103
noscimento internazionale del Regno di Portogallo e del suo sovrano restaurato
e che richiedeva una revisione organizzativa di quella stessa struttura politica.
Tale inquadramento storico-politico ha prodotto, come logico effetto, una
particolare attenzione alle fonti diplomatiche seicentesche, fonti estremamente
complesse sia per loro natura, sia per il periodo cui esse appartengono: un’epoca dal conturbato scenario europeo in cui il Portogallo, con una nuova veste
ed un nuovo statuto, ricercava in tutti i modi una sua collocazione in ambito
internazionale64.
Dal 1640 in avanti, tali fonti mettono in evidenza un tipo di contatto fra
Portogallo e Napoli che, seppur indiretto, attribuisce un ruolo più specifico, direi
quasi di maggior peso, al Regno di Napoli, le cui vicende divennero strumentali al
buon esito della Restaurazione: alla fine della guerra, infatti, il Portogallo godrà di
prestigio internazionale anche e soprattutto grazie alle cousas de Nápoles.
Dal 1640 al 1668 – anno di chiusura della Guerra da Restauração Portuguesa
– tutte le scelte politiche della Corona Braganza furono compiute per acquisire
credibilità in ambito internazionale, in un momento di estrema debolezza di
un Portogallo che doveva a tutti i costi ricostruire il suo prestigio dopo l’uscita
dal sistema imperiale.
In questo frangente, le ambasciate assunsero come direttrice fondamentale
la riaffermazione della grandezza portoghese sia nel Mediterraneo sia nell’Atlantico: i diversi ambasciatori, con i loro percorsi tanto diplomatici quanto personali – rapporti cioè familiari e clientelari col monarca restaurato – diedero
forma ad una nuova manifestazione del Portogallo in Europa.
L’analisi dell’attività diplomatica portoghese65, immediatamente successiva
allo scoppio della Guerra, permette di riconoscere, come caratteristica essenziale
di questa azione, una molteplicità di direzioni. L’opzione strategica che presiedeva l’offensiva diplomatica, infatti, presentava come obiettivi e vettori essenziali:
il riconoscimento e l’accettazione del Portogallo come paese indipendente; la ricerca di alleati per sostenere il conflitto con la Spagna in Europa e nelle colonie;
il mantenimento dell’impero coloniale minacciato non soltanto dalla Spagna ma
anche dalle altre potenze europee con pretese espansionistiche.
Si riconoscono molteplici missioni diplomatiche, che partirono da Lisbona nel
1640: verso Catalogna, Inghilterra, Olanda, Francia, Danimarca e Svezia, Roma.
Le ambasciate erano di norma costituite da un vertice aristocratico, da un
corpo giuridico e, infine, da una segreteria. Tale struttura costitutiva, comune
64 65 Lo spiega bene T. L. Magalhães do Vale, in op. cit in nt. 61, p. 7.
Operata da T. L. Magalhães do Vale, ibidem.
104
Gilda Caprara
a tutte le ambasciate portoghesi del secolo XVII, risultava utilissima allo scopo
di affrontare, missione per missione, le reali esigenze cui il governo portoghese
andava incontro. Si presentava, così, una felice combinazione di: prestigio ed
autorità, che per consuetudine spettavano ad un elemento dell’aristocrazia; conoscenza tecnico-giuridica, utile al buon decorso delle negoziazioni; necessaria
pratica burocratica della segreteria, che, per giunta, assicurava comunicazioni
regolari con la Secretaria de Estado do Reino66.
La missione diplomatica a Roma non costituì eccezioni: si riconosce, all’interno della delegazione per l’Italia, un membro dell’aristocrazia portoghese, D.
Miguel de Portugal, di discendenza nobile oltre che di carriera ecclesiastica
(arcebispo de Lamego); un uomo di legge, Dr. Pantaleão Rodrigues Pacheco; ed
infine un segretario, Rodrigo Rodrigues de Lemos67.
Era assolutamente necessario che il Portogallo fosse riconosciuto dalla massima autorità presente nel panorama politico internazionale: il Papa. Il Pontefice avrebbe dovuto accettare l’argomento principale su cui il Portogallo stava costruendo il suo diritto a resistere68 e la sua indipendenza: vale a dire la proposta
di legittimità del nuovo sovrano di Casa Braganza, D. João IV. è per questo che
il compito dell’ambasciata a Roma si rivelava non solo il più importante per le
ripercussioni sulle altre missioni, ma anche il più delicato e difficile69.
Oltre agli incarichi svolti in ambito internazionale dalle ambasciate, si riconosce l’intervento di altri agenti diplomatici le cui azioni completano il panorama di fonti sulle relazioni luso-napoletane.
In altri termini, le relazioni luso-napoletane indirette, relative a questo
periodo, sono da ricondurre a uomini politici – ovverosia al nuovo sovrano
restaurato, ai suoi consiglieri ed ai suoi ambasciatori – e ad agenti diplomatici.
66 Su queste questioni J. C. de Magalhães, A Acção Diplomática no Pensamento dos Diplomatas Portugueses dos Séculos XVII e XVIII, in: AA.VV., A Diplomacia na História de Portugal,
Actas do Colóquio, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1990, pp. 15-27 e specialmente
pp. 16-18.
67 T. L. Magalhães do Vale, op. cit in nt. 61, p. 9.
68 Sul diritto di resistenza portoghese: J. Mattoso, História de Portugal, IV vol., Ed. Estampa, Lisboa, 1998, p. 393-394; A. M. Hespanha, Da “iustitia” à disciplina. Textos, poder e politica
no Antigo Regime, in: Estudos em Homenagem ao Prof Doutor Eduardo Correia, Coimbra, 1986,
1989, pp. 392ss.; Hespanha, As Cortes e o Reino. Da União à Restauração, in «Cuadernos de
historia moderna», Universidade Complutense, n.11, 1990, pp. 21-56; A. de Oliveira, Poder e
oposição política em Portugal no período filippino (1580-1640), Lisboa, Difel, 1991; J. V. Serrão,
op. cit. in nt. 15, p.30; L. F. de Almeida, Motins populares no tempo de D. João V, in «Revoltas
e Revoluções», 1984, vol. I, pp. 321-344.; J. V. Capela, Tensões sociais na região de Entre Douro
e Minho, in «O Districo de Braga», Vol. III, II série (VII), 1978, pp. 29-104; J. F. Marques, A
Parenética Portuguesa e a Restauração, INIC, Lisboa, 1989; F. Dores Costa, op. cit. in nt. 15,
pp. 14-23.
69 T. L. Magalhães do Vale, op. cit in nt. 61, p. 10.
I rapporti politici luso-napoletani tra Cinque e Seicento
105
Più spesso, infatti, furono proprio questi soggetti – incaricati dal sovrano
perché inviassero relazioni continue e dettagliate sulla rivolta di Thomas
Aniello e perché prendessero contatti con quelli che in Portogallo erano definiti
i descontentes70 napoletani – a seguire da vicino i fatti partenopei.
Anche se detentori di uno status diverso da quello degli ambasciatori, la
condotta di questi agenti risultò comunque determinante per gli scopi della Restaurazione. Si riconoscono71: encarregados de negocios; agentes do estado eclesiastico; enviados e/ou ministros residentes; enviados extraordinarios.
La designazione di “agente diplomatico” risulta piuttosto vaga per specificare il ruolo di queste figure politiche alle quali, di frequente, venivano affidate
missioni di fondamentale importanza, operazioni delicate e di solito a carattere
segreto, come si verificò nel caso vieirese. Purtroppo, l’azione di questi uomini
– e spesso anche identificazione e distinzione dei loro incarichi, status e funzioni – si rivela estremamente difficile e difficile, pertanto, risulta apprezzare a
pieno la loro azione.
In via ancora approssimativa si può affermare che almeno una decina tra ambasciatori, agenti ed inviati speciali furono inviati, nell’arco temporale di un ventennio (1640-1660), in territorio italiano per seguire da vicino i fatti napoletani.
Tra il 1640 ed il 1645 il Portogallo, mentre lottava per la sua indipendenza,
teneva sotto osservazione il Regno di Napoli72.
Dal 1646, per di più, il governo portoghese come pure quello francese intesero dare alle vicende napoletane un vero e proprio valore strumentale in funzione della nuova politica di potenza del Regno restaurato: un’azione nel Mediterraneo con ingresso nei porti di Napoli e Sicilia, infatti, avrebbe dimostrato la
grandezza del sovrano portoghese al Papa ed ai Principi italiani73.
Più volte, inoltre, i portoghesi tentarono di coadiuvare le spinte rivoluzionarie partenopee: tra il ‘46 e il ‘47 il governo portoghese si adoperò allo scopo d’in-
70 BA, 58-VIII-25, n. 26, Cartas de Pedro Vieira da Silva ao Visconde, sobre as novas da
armada de Nápoles, Lisboa a 19 de Agosto de 1651, f. 49.
71 T. L. Magalhães do Vale, op.cit in nt. 61, pp. 40-41.
72 BNL, CDP – Relações com a Curia Romana CG 32A, Tomo XIII, Cartas 1° Dezembro
1640-3 Maio 1645; ma anche: E. Gomes Dias, Gazetas da Restauração: 1641-1648. Uma revisão das estratégias diplomático-militares portuguesas, (edição transcrita), Colecção Biblioteca
Diplomática do MNE- Série A, Instituto Diplomatico, Ministério dos Negócios Estrangeiros,
Portugal, 2006.
73 BA, 51-VIII-29, Papel de D.Diogo de Lima sobre as duvidas que se levantaram no Conselho
de Estado acerca dos navios que o Rei de França pediu a el-Rei D.Joao IV para irem a alguns
portos de Italia, 1646, fl 52v-54. Inoltre questa azione avrebbe significato la concentrazione
delle forze spagnole nel Mediterraneo piuttosto che sul versante Atlantico allegerendo il fronte
di guerra portoghese, ibidem, f. 52.
106
Gilda Caprara
trodurre referenti gesuiti in territorio napoletano74; il 9 luglio del ‘47, due giorni
dopo lo scoppio della rivolta, i diplomatici portoghesi fecero leva, con i loro argomenti, affinchè il sovrano appoggiasse la politica francese nel napoletano, in
vista della stipula di una lega franco-portoghese ai danni del sovrano spagnolo75;
nel ‘48, l’ambasciatore portoghese a Roma, D. Miguel de Portugal, si recava a Napoli per seguire da vicino la rivolta e parteggiare per i rivoltosi76, mentre l’agente
Vieira premeva perchè s’intervenisse economicamente negli affari napoletani77;
nel ‘49 il Vieira riceveva una missiva78 in cui il sovrano dichiarava la priorità
assoluta delle cose di Napoli e dell’invio di forze per coadiuvare un’eventuale
sommossa79; in quello stesso anno si trovava a Napoli Cristovão Soares, un altro agente segreto, incaricato di trattare coi ribelli circa il denaro da impiegare
nell’impresa80; nel ‘50, infine, il Vieira giungeva a Roma con l’intento di recarsi a
Napoli per mettere in pratica il progetto ordito dal suo sovrano.
74 “[...]. Muito convem que Vossa Paternidade com certeza deste dinheiro que veyo de Portugal para Jerusalem e o General de S. Francisco deu ao Viso-Rei de Nápoles”, BNL, CDP – Relações
com a Curia Romana, CG 32A, Tomo XIII, Mss. I, 6/4 (corresp. Do Marques de Niza), Carta
do Marques de Niza, Embaixador em França, ao Pe Nuno da Cunha, Assistente da Companhia
de Jesus. 1647 – Março15 – Amiens, fol. 36. “[...]. Grande bem fora para tudo que as revoltas de
Napoles e Cicilia continuassem e tambem não fora mão ter Vossa Paternidade ahi o que deseja
visto a ocasiao presente. [...]”, BNL, CDP – Relações com a Curia Romana, CG 32A, Tomo XIII,
Mss. I, 6/4 (corresp. Do Marques de Niza), Carta do Marques de Niza, Embaixador em França,
ao P.e Nuno da Cunha, Assistente da Companhia de Jesus. 1647 – Junho 29 – Amiens, fol. 100.
75 “[...] e se as revoltas de Napoles e Sicilia forem por diante bom negoceo teremos, mas receio
que todas parem em nada.. [...] o Cardenal Mazarim anda muy enfadado com os roins successos
desta campanha porque Landrecis perder-se ha brevissimamente, e Deos sabe qual he melhor
para Portugal. [...]”, BNL, CDP – Relações com a Curia Romana, CG 32A, Tomo XIII, Mss. I, 6/4
(corresp. Do Marques de Niza), Carta do Marques de Niza, Embaixador em França, ao Pe Nuno
da Cunha, Assistente da Companhia de Jesus. 1647 – Julho 9 – Amiens, fol. 107. Si legge inoltre
“[...]Sustente Deus a Nápoles, e traga tão boas novas da armada de França que vá por diante a
prática da Liga, que folgo muito de ver admitida”, BPE, Cartas do P.e António Vieira S.J., Lisboa,
casa J.M.C. Seabra & T.Q.Antunes, 1855, carta XIII – Ao Marquês de Niza, 1647, dez. 23.
76 BNL, Res. 3393 P.; ANTT, Cartas do Governo do Reino, aa. 1645-1648, inviate dall’ambasciatore portoghese di Lamego. Il nome di Lamego appare anche in cronache del tempo che
circolavano sotto forma di manoscritti anonimi, divulgati in territorio portoghese, che descrivevano minuziosamente la rivolta sulla scia dei rendiconti italiani: BMC, Relação verdadeira...,
cit. in nt. 48; BMP, Relação verdadeira..., cit. in nt. 48.
77 “[…]. E ainda que estes sucessos do Brasil e o de Nápoles são bastantes a causar qualquer
mudanças, ainda em gente mais costante que os holandeses, não temos perdido a confiança de se
poder obrar alguma cousa: ao menos com esta paz de Castela, que já está ratificada em Münster,
termos cedo o último desengano, pois era o prazo que os confidentes tinham dado […]. Muito
sinto que o negócio de Nápoles atrazasse totalmente, como V.Ex.a diz, o de Veneza, e, suposto que
assim è, agora fica lugar de V.Ex.a nos socorrer com aquele dinheiro, do qual se não dispenderám
real senão fazendo-se o negócio; mas para que haja quem fie as promessas, e para que elas sejam
efectivas, è necessario que o dinheiro esteja cá…”, BPE, Cartas…, cit. in nt. 75, carta XXXIV - Ao
Marquês de Niza, 1648, maio 19.
78 BNL, Missão…, cit. in nt. 2.
79 Ibidem, f. 98v.
80 Ibidem, f. 99.
I rapporti politici luso-napoletani tra Cinque e Seicento
107
Durante quest’arco temporale – da me esaminato altrove81 – risulta molto
chiaro l’intento dei portoghesi di avvicinarsi il più possibile a Napoli.
Pare che l’interesse del governo portoghese derivasse da una presunta convergenza: l’arcivescovo di Lamego annotava che Napoli e Portogallo avevano un
nemico comune82; il Vieira ed il Marchese di Nizza, Conte di Vidigueira, ambasciatore portoghese a Parigi, nei loro carteggi si rivolgevano ai rivoltosi come
loro amici e compagni, come Signori cui era stata inferta una umiliazione che
li avrebbe spinti necessariamente alla ribellione83; João IV era ben cosciente di
quanto il Regno di Napoli, con il quale il Regno di Portogallo sarebbe diventato
strumento di sovvertimento del regime84, fosse necessario al sovrano spagnolo85.
Non è da sottovalutare, inoltre, l’eco che ebbe in territorio portoghese il
mito di Masaniello86: i carteggi lasciano intendere che una dinamica di fazione
prendeva piede, nel Consiglio di Stato portoghese, tra quanti erano a favore
di un intervento nelle cousas de Nápoles e quanti, prudentes87, preferivano non
affidare le sorti della Restaurazione alle oscillazioni delle rivolte del tempo88.
È da osservare, a tal proposito, quanto Francia e Portogallo lavorassero di
comune accordo per fomentare i focolai insurrezionali catalani, napoletani e
fiamminghi89: il diversivo, continuamente prodotto dalle due potenze, sottraeva
forze militari spagnole nella guerra contro il Portogallo e non permetteva alla
Castiglia la realizzazione di una massiccia e profonda invasione del territorio
lusitano.
G. Caprara, cit. in nt. 3.
BNL, Res. 3393 P.; ANTT, Cartas do Governo do Reino, aa. 1645-1648.
83 “[…]. Poderà ser que se humilhem um pouco com isto êsses senhores, e entrem em consideração de que lhes importa ter amigos e companheiros”, BPE, Cartas…, cit. in nt. 75, carta
XXXII – Ao Marquês de Niza, 1648, maio 4.
84 BNL, Missão…, cit. in nt. 2, fol. 99v.
85 In Missão…, cit. in nt. 2, fol. 99v si legge che il Regno di Napoli é il principal ed il mais
sostancial regno che la Castiglia possiede in Italia.
86 BMC, Relação…, cit. in nt. 48 e BMP, Relação..., cit. in nt. 48.
87 “[…]. Desgraçadissimo foi o sucesso de Nápoles, e ainda que sempre temido dos prudentes,
nunca esperada a brevidade e pouca resistência com que aquela cidade se entregou., BPE, Cartas…, cit. in nt. 75, carta XXXII – Ao Marquês de Niza, 1648, maio 4.
88 “[…]. Bem conheço que o accidente de Nápoles pode alterar muito todos os negoçios, mas
como o que se propôs a V.Ex.a era de qualidade que se não podia concluir sem ordem espressa
de S.M., não se tem perdido tempo e, quando se perca ocasião, foi esta uma de aquelas que não
está na mão dos homens o preveni-las, e em todo o caso V.Ex.a terá a glória de haver obrado
como convinha”, BPE, Cartas…, cit. in nt. 75, carta XXXIII - Ao Marquês de Niza, 1648, maio
11. E si legge anche: “[...]. Cada dia nos mete Nápoles em novas esperanças, e cada hora no-las
desmente. Ontem me escreveu Jeronimo Nunes que estava preso Genaro Aneze, e que se havia
descoberto uma inteligência que lá tinham os franceses: parece-me cousa inventada porque não
so-a por outra parte”, BPE, Cartas…, cit. in nt. 75, carta XLI - Ao Marquês de Niza, 1648, jul. 6.
89 D. Alden, The making of an Enterprise. The society of Jesus in Portugal, Its Empire, and
Beyond, 1540-1750, Stanford California, Stanford University Press, 1996, p. 105.
81 82 108
Gilda Caprara
Nello svolgimento delle sue missioni presso i vari paesi europei, l’intero corpo diplomatico portoghese aveva sollecitato l’invio di uomini, navi e armamenti, invio che, purtroppo, si risolse in una serie di spedizioni di esigui contingenti
formati da volontari olandesi, inglesi, francesi ma anche napoletani90.
La storiografia portoghese, per gli anni 1651-1656 – a partire, cioè, dal tentativo di espansione portoghese a Napoli di D. João IV e del Vieira, fino alla morte
del sovrano restaurato – non dà notizie circa nuove direttive di politica estera91.
Ciò è riconducibile al fatto che una guerra difensiva non richiedeva piani politico-strategici assai elaborati; al contempo, la stessa azione diplomatica subiva
dei rallentamenti: le trattative con la Santa Sede continuavano a non dare i frutti sperati, gli alleati non prestavano fede ai patti stabiliti e, soprattutto, i focolai
di rivolta nei domini spagnoli andavano attenuandosi.
Da alcuni documenti inediti, conservati nella Biblioteca della Real Residencia da Ajuda, si ha notizia, piuttosto, di una potenziale azione navale spagnola
ai danni di Casa Braganza.
Sembra infatti che Filippo IV, nel 1651, avesse intenzione di preparare
un’armata per concludere il conflitto ispano-portoghese e riannettere il Regno
di Portogallo nel sistema imperiale92. Venuta a conoscenza di ciò, la diplomazia
portoghese ritenne opportuno raccogliere quante più notizie possibili circa le
effettive intenzioni dei napoletani in merito all’impiego, o meno, di una loro
flotta al fianco dell’armata spagnola93.
Il 12 agosto 1651, il Segretario di Stato portoghese, Pedro Vieira da Silva, si
rese conto di quanto fosse delicata la questione napoletana: le notizie su Napoli, tanto anelate, non riuscivano a trapelare né dalle corrispondenze diplomatiche né da quelle degli agenti segreti94; per il loro peso politico, tuttavia, era
90 F. de Almeida, História de Portugal, Instituições políticas e sociais de 1385-1580; 15801816, II vol., Bertrand Editora, Lisboa, 2004, pp. 442-443. Il fatto che il Governo portoghese
reclutasse volontari anche tra le fila napoletane, a questo punto, non appare cosa anomala
data la tradizione militare partenopea e visto che più volte i napoletani avevano coadiuvato
le imprese belliche portoghesi.
91 La seconda metà del Seicento è un periodo storico scarsamente studiato in Portogallo.
Qualche notizia ci è data solo dall’analisi della Guerra di Restaurazione proposta dalla storia
militare. A riguardo del lasso di tempo da me preso in esame (1651-‘56) le fonti diplomatiche
contenute in CDP sono poco leggibili; quelle contenute nell’ARSI hanno subito gravi perdite
a causa delle purghe secentesche; le fonti ecclesiastiche contenute nell’APINSL, allo stesso
modo, sono andate perdute a causa di un incendio che colpì la chiesa di Loreto di Lisbona
negli anni cinquanta del Seicento.
92 BA, 58-VIII-25, n. 24, Cartas de secretarios de Estado para o Visconde de Villa Nova de
Cerveira, 1651, f. 47.
93 BA, 58-VIII-25, n. 25, Cartas de Pedro Vieira da Silva ao Visconde, sobre as novas da
armada de Nápoles, Lisboa a 12 de Agosto de 1651, f. 48.
94 “Hontem recebi 3 cartas de Vossa Senhoria uma como aviso do capitam Pedro de Faria,
I rapporti politici luso-napoletani tra Cinque e Seicento
109
necessario avere su di esse massima certeza in modo tale che il re, avendo più
chiaro lo stato delle cose in quei luoghi, potesse agire di conseguenza95.
Proprio perchè as novas de Nápoles erano ritenute, fra tutte, le più importanti, il Segretario di Stato esortò il Visconte di Villa Nova de Cerveira, inviato
speciale a Napoli, a far pervenire al più presto tutto quanto sapesse a proposito96.
Il sovrano spagnolo, in effetti, intendeva creare un’armata costituita da una
flotta di galeoni, i quali sarebbero dovuti partire dai porti del Mediterraneo di
Napoli e Sicilia, coadiuvati dalla flotta di D. Giovanni d’Austria97.
Venuto a conoscenza di questi intenti dal Visconte, il 19 agosto dello stesso
anno, Pedro Vieira da Silva informava D. João IV il quale, ancora una volta, si
dimostrava particolarmente interessato a quanto stava accadendo a Napoli98:
l’armata era partita, sì, ma senza il Conte di Oñate il quale – per paura che un
movimento latente di descontentes potesse di lì a poco concretizzarsi, dato l’ormai generalizzato coinvolgimento della popolazione – aveva ricevuto precisi
ordini, dal Governo centrale, di rimanere fisso in territorio napoletano99.
È evidente, ancora una volta, che le agitazioni nel Mezzogiorno spagnolo
vennero assunte dalla diplomazia portoghese come punto cardine delle strategie di consolidamento della Restaurazione: fino a quando Napoli continuava
ad essere “scontenta” e continuava ad essere in “disordine”, l’Oñate non era
autorizzato a partecipare all’armata; la defezione della flotta napoletana comprometteva il piano di attacco spagnolo100 e giovava alla conservazione dell’inoutra com a carta do alcaide mor de Caminha e outra com o escrito do correspondente que se
conforma maes com os avisos que Sua Magestade tem por outras vias; Havia dias que a Rainha
de Castella pario uma femea, e que el Rey de Inglaterra teve este bom sucesso contra os do Parlamento. As novas da armada de Nápoles não havia aqui e […]”, BA, ibidem, Ivi.
95 “[…] e são as maes importantes se Vossa Senhoria tiver dellas certeza sera conveniente que
Vossa Senhoria a envie logo a Sua Magestade, eu lhe li estas cartas de Vossa Senhoria e os papeis que
com ellas vinhão e tudo folgou muito de ver, e eu de saber boas novas da saude de Vossa Senhoria
que sempre deseio ver lhe com tudo a gosto e acresentamento. Deos de a Vossa Senhoria muitos
annos. Lisboa a 12 de Agosto de 651. Visconde Pedro Vieira da Sylva”, BA, ibidem, Ivi.
96 Ibidem, Ivi.
97 BA, 58-VIII-25, n. 26, Cartas de Pedro Vieira da Silva ao Visconde, sobre as novas da
armada de Nápoles, Lisboa a 19 de Agosto de 1651, f. 49.
98 “Logo que recebi estas duas cartas de Vossa Senhoria com os avisos de Castella as fui ler
a Sua Magestade que folgou muito de as ver particularmente o que toca a Nápoles; [...]”, BA,
ibidem, Ivi.
99 “[…] a armada que ali se fez era já saida daquelles portos mas sem o conde de Onhate que
mandarão fiquar com reseo de algum movimento dos descontentes que são quasi todos”, BA,
ibidem, Ivi.
100 “[…]. Sahio a armada a tomar a esquadra de Sisilia e nella Dom João de Austria mas
não sabemos ate agora com certeza onde fez a sua principal derrota. Se Vossa Senhoria por laa
o alcançar avise o a Sua Magestade. Pella(?) que Vossa Senhoria fez ao capitam Pedro de Faria
beijo muitas vezes as mãos de Vossa Senhoria e lembrese Vossa Senhoria que me daa ha muito
tempo o desgosto de não prestar em alguma cousa de seo serviço. Deos de a Vossa Senhoria
110
Gilda Caprara
dipendenza portoghese. Risulta evidente che la rivolta napoletana – la quale,
dopo essersi manifestata nel 1647-‘48, ora sembra prolungarsi in forma latente
– rallenta le azioni belliche di Filippo IV.
Napoli è, in definitiva, un tassello fondamentale della politica difensiva portoghese degli anni Cinquanta del Seicento.
Nel 1653, visti gli attriti tra le due potenze, un accordo tra Castiglia e Francia sembrava ormai improponibile; la cosa, di conseguenza, danneggiava anche
il Portogallo il quale sperava di beneficiare della pace101.
Dall’Italia, intanto, continuavano ad arrivare notizie circa l’imminente
realizzazione di una flotta. Doveva trattarsi di una squadra di vascelli napoletani, i quali sarebbero stati assistiti in un secondo momento da un’armata di galeoni spagnoli, con l’intento di penetrare la barriera marittima di
Lisbona, impedendone i commerci, sull’esempio di quanto facevano altrove
gli Inglesi102.
Le notizie su Napoli, ancora una volta, sono riportate nelle missive del Visconte di Villa Nova de Cerveira al Segretario di Stato Pedro Vieira da Silva, il
quale non sembra preoccuparsi in alcun modo del piano ordito dai nemici: il
danno che ne sarebbe derivato – secondo il parere del Segretario – sarebbe stato
di poco conto per i portoghesi e, invece, assolutamente oneroso per gli autori
dell’impresa; il mantenimento di navi in acque territoriali lusitane sarebbe stato insostenibile per la flotta napoletana103.
Il Segretario di Stato portoghese, in realtà, era già venuto a conoscenza del
vero intento cui era destinato il concepimento della flotta: gli stessi napoletani
avevano svelato i piani spagnoli, dichiarando che si trattava esclusivamente
muitos annos. Lisboa a 19 de Agosto de 651. Visconde Pedro Vieira da Sylva”, BA, ibidem, Ivi.
101 “Não escrevi a Vossa Senhoria no passado porque me não foi possivel, entre as novas deste(?) aviso do correspondente nem huma de grande consequencia, e he que o Emperador rompeo
a guerra a França, porque conforme a isto, parece, que se vão impossibilitando os meyos de acordos entre Castella, e aquelle Principe(?) que he o que mais convem a nossas cousas, nos tivemos
aqui este aviso por outra via.(?). O correspondente pelo que se viu do fim do seu papel está tão
contente e tão bem pago que não faltará em escrever tudo o que souber [...]”, BA, 58-VIII-25, n.
73, Cartas de Pedro Vieira da Silva ao Visconde, sobre as novas da armada de Nápoles, Lisboa a
31 de Março de 1653, f. 140.
102 “[…]. Conformasse com as noticias que temos de todas as partes em que não seremos
cometidos este verão por lo menos com muito poder, he bem verdade que escrevera de Italia,
que em Nápoles se fazia huma armada de differentes baixeis em que entram galeões, com voz
de se haverem de vir por na barra desta cidade para impedir o comércio seguindo o exemplo dos
ingleses [...]”, BA, ibidem, Ivi.
103 “[…] mas he este dano de tão pouca consideração e será tão custoso a nossos inimigos
com ter naos nesta barra que [...]”, BA, ibidem, Ivi. Sembra implicito che il Portogallo abbia
inteso che Napoli non avesse le risorse necessarie ad avviare azioni di pirateria sulla stregua
di quanto fatto dagli Inglesi, finanziati proprio dalla Corona.
I rapporti politici luso-napoletani tra Cinque e Seicento
111
di un escamotage104. I propositi di pirateria, infatti, dovevano celare una vera e
propria azione offensiva; il che spinse il Segretario di Stato, consigliato proprio
dal Visconte di Villa Nova de Cerveira, a fortificare la città e a tenersi all’erta105:
la conoscenza dei piani spagnoli con largo anticipo concedeva il tempo necessario per prendere le contromisure al caso.
I napoletani – i quali avrebbero dovuto essere gli esecutori di questo piano d’attacco – avevano svelato il disegno spagnolo perché, probabilmente, non
avevano nessuna intenzione di compromettersi in un’azione bellica; cosa che,
appunto, avrebbe giustificato la fuga di notizie. Si ricordi inoltre che, solo due
anni prima, il governo portoghese aveva percepito il malcontento latente che
ancora serpeggiava a Napoli contro il dominio spagnolo. Simulazione e dissimulazione napoletana sono da ricondurre alla situazione d’insoddisfazione in
cui versava il Mezzogiorno; avrebbe potuto perfino ravvisarsi, in questa circostanza, un tradimento ai danni della Spagna.
Qualunque fosse l’intento della “fedelissima”, il dato di fatto è che la flotta
napoletana non salpò mai dai porti partenopei.
Nel 1656 muore D. João IV.
Sul piano internazionale è da sottolineare lo sforzo profuso, nelle sue varie
missioni, dal Corpo diplomatico predisposto da questo sovrano, sforzo che produsse la firma di una serie di tregue e di trattati di pace106.
Bisognerà, tuttavia, aspettare gli anni Sessanta per la stipula di accordi più
solidi; ciò suggerisce che la comunità internazionale solo allora si mostrò disposta a riconoscere, quando ormai era inevitabile, il nuovo status politico del
Regno di Portogallo. In altre parole, fino a questo periodo, le potenze europee
consideravano la “rivolta” del 1640 come un mero incidente nel normale percorso del Portogallo degli Asburgo107.
Sicuramente, ciò che recò maggior beneficio alla Restaurazione furono i
fatti napoletani.
Tuttavia, anche se le fonti portoghesi confermano che le informazioni sulle
cose di Napoli giungevano in maniera veloce e puntuale in terra lusitana, lo
104 “[…] parece mais certo se fará armada com outro intento e que declaranos este será disfarce; [...] ”, BA, ibidem, Ivi.
105 “[…] na fortificação desta cidade seguindo o conselho de Vossa Senhoria se trabalha com
o calor que se pode. Deos nos ajude em tudo a Vossa Senhoria muitos annos como dezejo. Lisboa
a 31 de Março de 1653. Visconde Pedro Vieira da Sylva”, BA, ibidem, Ivi.
106 J. F. Borges de Castro, Colecção dos tratados, convenções, contratos e actos publicos
celebrados entre a Coroa de Portugal e as demais potencias desde 1640 até ao presente, Lisboa,
1856, t. I, p. 212 e ss.
107 J. Mattoso, op. cit. in nt. 68, p. 408.
112
Gilda Caprara
stesso non si può dire nel caso inverso: allo stato attuale dello studio sulle relazioni diplomatiche luso-napoletane non è dato sapere dell’esistenza di riscontri
nelle fonti italiane sui casi in questione.
Antonio Gramsci: cesarismo, ideologia, cultura unitaria
113
Antonio Gramsci: cesarismo, ideologia, cultura unitaria1.
Memoria di Andrea di Miele
presentata dai soci naz. ord. res.
Fulvio Tessitore e Giuseppe Cacciatore
(seduta del 1 luglio 2010)
Abstract. The aim of this work is to display Gramsci’s interpretation of the concept
of cesarism by means of a comparison with Marx’s analysis. The author focuses the
ideological character of cesarism and looks deeply into the relationship with the theme
of unitary culture, intended as a knowledge free from alienation.
Al termine della seconda edizione del 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, Marx
si serve, marginalmente, di due figure storiche, l’Arcivescovo di Canterbury
e il Gran Sacerdote Samuele, per mostrare l’inconsistenza della categoria di
cesarismo2. L’anacronismo si palesa chiaramente, secondo Marx, nel raffronto
tra le condizioni storiche dell’antica Roma, ove un proletariato passivo
assisteva inerme alla lotta di classe d’uno sparuto gruppo di liberi cittadini,
e una società moderna, in cui un proletariato attivo produceva ricchezza per
un’elite privilegiata. La ridefinizione del concetto di cesarismo era dunque
esclusa. Avventurarsi in tale inutile cimento, significava istituire un’analogia
impraticabile: quanto lo era quella tra l’ultimo dei Giudici d’Israele, Samuele, e
1
Relazione presentata al Congreso Internacional «Gramsci y la sociedad intercultural»,
svoltosi a Barcellona presso l’Università «Pompeu Fabra», nei giorni 03-05 Dicembre 2009.
2
«Io spero infine – dice Marx – che il mio scritto contribuirà a liberarci della frase scolastica, […] circa il cosiddetto cesarismo. Con questa superficiale analogia storica si viene a
dimenticare il fatto essenziale che, specialmente nell’antica Roma, la lotta di classe si svolgeva
soltanto all’interno di una minoranza privilegiata, tra i ricchi e i poveri che erano liberi cittadini, mentre la grande massa produttiva della popolazione, gli schiavi, costituiva soltanto
il piedistallo passivo dei combattenti. Si dimentica la profonda espressione di Sismondi: “il
proletariato romano viveva a spese della società, mentre, la società moderna vive a spese del
proletariato”. Data una differenza così completa tra le condizioni materiali ed economiche
della lotta di classe nel mondo antico e nel mondo moderno, anche i prodotti politici di essa
non possono avere in comune niente più di quello che l’arcivescovo di Canterbury non abbia in
comune con il gran sacerdote Samuele». Cfr. Id., Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte
[1851-1852], Hamburg, 18692, trad. it Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, Opere Complete, XI,
Editori Riuniti, Roma, p. 107 (MEW, Bd. 8, S. 111-207).
114
Andrea Di Miele
il primate della chiesa d’Inghilterra, l’Arcivescovo di Canterbury.
Questa è già una nota interessante perché Gramsci, pur conoscendo
tale giudizio3 sembra voler procedere proprio in questa direzione: parla
espressamente di cesarismo e anzi vi dedica, come è noto, una importante
riflessione4. Gramsci sembrerebbe, dunque, trasgredire la dura sentenza di
Marx ed anche recentemente, tale “disobbedienza” è stata rimarcata ed esibite
le ragioni di tale “violazione”5.
Il primo punto di riflessione, che qui poniamo, tenta di mostrare, invece,
l’attiguità delle due visioni e la conseguente inconsistenza dell’infrazione
gramsciana.
Un altro recente contributo sul tema del cesarismo, che ha concorso a
ravvivare il dibattito su tale categoria, formula l’ipotesi secondo cui, dalle
pagine gramsciane, affiorerebbe una nuova forma di «cesarismo progressivo»:
il «cesarismo collettivo»6.
Un secondo nodo di discussione tenterà di mostrare come questa tesi
suggestiva, lasci in ombra una parte del discorso gramsciano strettamente
3
Per questa e le successive citazioni: A. Gramsci, Quaderni dal carcere, edizione critica
dell’Istituto Gramsci, a cura di V. Gerratana, Editori Riuniti, Roma, 1975. D’ora in poi faremo
seguire alla sigla Q il numero arabo in corsivo assegnato al quaderno nell’edizione critica citata e, di seguito, il paragrafo e la pagina tra parentesi quadre.
Per i riferimenti gramsciani al 18 Brumaio: Q7, 24 [871]; Q13, 23 [1604], Q13, 27 [1620].
Q3, 51, [333].
4
In particolare: sotto il titolo «Cesarismo», due note del Q9, 133 [1195] e 136 [1197-1198],
poi fuse sotto il medesimo titolo nel Testo C: Q13, 27 [1619-1622]; sotto il titolo «Machiavelli.
Cesarismo ed equilibrio “catastrofico” delle forze politico-sociali» (Testo B): Q14, 23, [1680-1681];
sotto il titolo «Cesare e il cesarismo»: Q17, 21 [1924-1925]. Si vedano anche, sotto il titolo «Passato e presente. Agitazione e propaganda», gli accenni al cesarismo e al bonapartismo: Q3, 119,
[387-388] e sotto il titolo «L’elemento militare in politica»: Q4, 66 [510-511], poi ripreso in Q13,
23, [1608]. Per un’esaustiva definizione del termine e dei relativi riferimenti si veda il recente:
Dizionario Gramsciano 1926-1937, a cura di G. Liguori e P. Voza, Carocci, 2009, pp. 123-125.
5
Cfr. L. Canfora, Così Gramsci disobbedì a Marx, «Corriere della Sera», 28.08.2009, p. 38.
6
Cfr. A. Burgio, Per Gramsci. Crisi e potenza del moderno, DeriveApprodi, Roma, 2007,
pp. 107-119. Burgio segue, dapprima, l’analisi propriamente gramsciana distinguendo un «cesarismo regressivo» da un «cesarismo progressivo»: forme di autoritarismo profondamente
diverse e accomunate, tuttavia, da una leadership individuale. Applicando poi queste categorie
alla crisi novecentesca, coeva a Gramsci, Burgio ritiene si possa individuare nei Quaderni «una
riflessione che lascia intravedere un’ipotesi diversa» rispetto a quella tradizionale, «nella quale
il nuovo Cesare è un soggetto collettivo» [117]. L’ingresso, nella società moderna, delle grandi
organizzazioni di massa, il fenomeno stesso del sindacato, schiuderebbe l’ipotesi di un nuovo
tipo di «cesarismo progressivo»: un «cesarismo collettivo».
«Chi è – si chiede Burgio – e come si configurerebbe l’altro possibile Cesare, quello che,
qualora vincesse imprimerebbe alla crisi organica della società borghese uno sviluppo progressivo? […] si può sostenere che è precisamente questo “moderno Principe” il protagonista
potenziale del nuovo cesarismo progressivo: di un cesarismo collettivo e quindi, per dir così,
di un cesarismo senza Cesare, dove “autorità” e “decisione” sono funzioni di esercizio della
volontà collettiva e del self-governement» [p. 118].
Antonio Gramsci: cesarismo, ideologia, cultura unitaria
115
connesso al cesarismo: quello relativo all’ideologia.
Partiamo dunque da una breve ricognizione dell’analisi gramsciana sul
cesarismo e dei temi ad esso congiunti attraverso i Quaderni.
Anzitutto, il cesarismo nasce da una situazione di forze in lotta. Tale conflitto
permane anche in una fase di stallo, poiché il momentaneo bilanciamento ha
una prospettiva «catastrofica»: le forze, dice Gramsci «si equilibrano in modo
che la continuazione della lotta non può concludersi che con la distruzione
reciproca». L’epilogo è aperto a diversi scenari: può avvenire non solo che la
forza A vinca la forza B ma anche che «una terza forza C intervenga dall’esterno
assoggettando ciò che resta di A e di B». Dunque, il cesarismo assumerà un
carattere «progressivo» o «regressivo» secondo il carattere della forza che trionfa.
«Si tratta di vedere se nella dialettica “rivoluzione-restaurazione” è l’elemento
rivoluzione o quello restaurazione che prevale»7. Cesare e Napoleone I sono
esempi di «cesarismo progressivo», perché hanno introdotto un cambiamento
epocale, rivoluzionario. Napoleone III e Bismarck sono modelli di «cesarismo
regressivo» poiché, assecondando le forze conservatrici, hanno prodotto un
cambiamento di fase di piccolo cabotaggio. Può inoltre prendere forma un
«cesarismo senza un Cesare»8, senza cioè una forza «eroica» e rappresentativa.
Qui Gramsci riporta il caso di Mac Donald riferendosi, evidentemente, alla
contraddizione di un primo governo laburista nato con l’appoggio dei liberali.
Anche un sistema parlamentare, dunque, può assumere una forma cesarea,
anzi, in senso più esteso, «ogni governo di coalizione – rileva Gramsci – è un
grado iniziale di cesarismo», mentre «naturalmente l’opinione volgare è invece
che i governi di coalizione siano il più “solido baluardo” contro il cesarismo»9.
Avendo di fronte questi pochi, crudi elementi, si può certo riflettere su
numerose piccole o rilevanti derivazioni. Ci si potrebbe soffermare, per
esempio, sull’ambivalenza del giudizio di Gramsci su Napoleone III, che viene
talora chiamato in causa come esempio di «cesarismo regressivo», talaltra come
prova di cesarismo «parzialmente progressivo». Si potrebbe seguire l’intreccio
di due importanti criteri: le «cause della crisi» e il «segno politico impresso alla
crisi» dal cesarismo, per osservare a quali implicazioni conducano10.
Vi è tuttavia un’altra parte del ragionamento gramsciano che, a scapito delle
precedenti, è lasciata, a nostro avviso, ingiustamente in ombra: l’analisi sulla
Q13, 27 [1619]
Ibidem.
9
Q13, 27 [1620].
10
Ci riferiamo alla puntale analisi svolta da Burgio. Cfr. A. Burgio, Per Gramsci. Crisi e
potenza del moderno, cit., p. 114 e seg.
7
8
116
Andrea Di Miele
nota ideologica del cesarismo.
Quando Gramsci analizza le diverse forme di cesarismo, fa seguire, più
volte, un importante contrappunto che vorremmo rimarcare. Nel Quaderno 13,
dopo aver discusso delle forme «progressive» e «regressive» Gramsci scrive:
«il significato esatto di ogni forma di cesarismo, in ultima analisi, può essere
ricostruito dalla storia concreta e non da uno schema sociologico» e più avanti:
«Del resto il cesarismo è una formula polemico-ideologica e non un canone di
interpretazione storica» e ancora: «il cesarismo, è appunto un’ipotesi generica,
uno schema sociologico (di comodo per l’arte politica)»11.
Dunque, anzitutto, il terreno sul quale poggia il cesarismo è la storia, non la
sua interpretazione.
Come tutte le ideologie anche il cesarismo ha un’origine pratica. Le ideologie
nascono per la frizione tra gruppi umani con diverse esigenze economiche e sono
pertanto caduche, destinate a rinascere e perire finché permane lo scontro. La
fondazione e la sussistenza stessa delle classi è radicata in tale contraddizione.
Il cesarismo quindi, come “ideologia”, trae origine dal medesimo scontro, quel
conflitto a «prospettiva catastrofica» di cui, come abbiamo visto, Gramsci
riferisce.
In questo senso non esiste, se non come formula, un cesarismo astratto,
svincolato dalla sua precisa condizione concreta, perché il cesarismo dice
Gramsci «non ha sempre lo stesso significato storico». Non a caso Gramsci
affianca ad ogni preciso riferimento a questa categoria, una puntuale
corrispondenza. Cesare, Napoleone I, Napoleone III, Bismarck, i governi
«laburisti» ma anche l’Italia, a lui coeva, della quale indica rigorosamente gli
avvenimenti storici relativi al concetto in questione: «nell’ottobre del 1922,
fino al distacco dei popolari e poi gradatamente fino al 3 gennaio del 1925
e ancora fino all’8 novembre del 1926 in cui diverse forme di cesarismo si
succedettero fino ad una forma più pura e permanente»12. Finanche, in una
sorta di definizione per “sottrazione” del cesarismo, Gramsci chiama in causa
«un episodio storico – egli dice – molto importante da questo punto di vista»,
il noto affaire Dreyfus, e lo segnala non perché abbia condotto ad una forma
cesarea, ma al contrario «perché ha impedito l’avvento di un cesarismo che si
stava preparando, di carattere nettamente reazionario»13.
Dunque il cesarismo si connota, certamente, come fenomeno autoritario e
dittatoriale ma riferibile ad un circostanziato momento storico. Il cesarismo
Q13, 27 [1621]
Q13, 27 [1620].
13
Q14, 23,[1681].
11
12
Antonio Gramsci: cesarismo, ideologia, cultura unitaria
117
degli anni Venti in l’Italia, ci dice Gramsci, è già differente da quello degli
anni Trenta: esso si presenta sotto una forma diversa, per le mutate condizioni
storico-economiche. Di più: sarebbe errato esaminare i diversi fenomeni di
cesarismo considerando, esclusivamente, le forze «fondamentali» dalle quali
derivano. I rapporti che intercorrono tra i gruppi principali e quelli subordinati
sono parte integrante del ragionamento: «Così non si comprenderebbe il colpo
di Stato del 2 dicembre senza studiare la funzione dei gruppi militari e dei
contadini francesi»14.
In tal senso, Gramsci ci sembra operare più nella continuità che nel
“tradimento” del messaggio lasciato da Marx nella citata Introduzione al 18
Brumaio. Il monito marxiano s’appuntava, infatti, sull’incongruente utilizzo
d’un concetto nato alla metà del XIX sec.15, come quello di cesarismo, se
applicato alle condizioni storico-economiche di un’altra epoca. Il metodo storico
classico, non a caso, viene esplicitamente accusato d’astrarre categorie dal
proprio radicamento economico. Il cesarismo è dunque l’idea “esemplare” che
Marx adopera, nel peculiare contesto dei “napoleoni”, per riaffermare le nuove
direttrici della scienza storica. Direttrici che Gramsci conosce e applica: ben
consapevole della distanza tra l’Arcivescovo di Canterbury e il Gran Sacerdote
Samuele. Del resto, in un paragrafo poco ricordato del Quaderno 17, intitolato
Cesare e il cesarismo, Gramsci dopo aver contestato in vari punti l’analisi storica
proposta Emilio Bodrero, in L’umanità di Giulio Cesare, conclude dicendo «Dal
punto di vista della cultura è interessante notare l’attuale mito di “Cesare” che
non ha nessuna base nella storia, così come nessuna base aveva nel Settecento
l’esaltazione della repubblica romana come di una istituzione democratica e
popolare ecc.»16.
Ecco che quando il cesarismo non si configura come una circostanziata
ed attenta ricostruzione del tessuto economico di un’epoca resta, per usare
le parole stesse di Gramsci: «ipotesi generica», uno «schema sociologico», un
«mito»17.
Q14, 23,[1680-1681].
Fu introdotto, come noto, da A. Romieu nel 1850 in L’ère des Césars. Cfr. Arnaldo Momigliano, Per un riesame della storia dell’Idea di Cesarismo, «Rivista Storica Italiana», 68, 1956,
pp. 220-229; manca qui il riferimento a Burckhardt che viene aggiunto dal Momigliano in un
contributo successivo cfr. Id., J. Burckhardt e la parola cesarismo, «Rivista Storica Italiana», 74,
1962, pp. 369-371, ora in Id., Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico,
Vol. I, Edizioni di Storia della Letteratura, Roma, 1966, pp. 211 e 215.
16
Q17, 21 [1924-1925].
17
A questa idea di cesarismo ci sembra si riferisca l’analisi di Burgio. Egli, infatti, afferma
che «il cesarismo va valutato di volta in volta» ma, aggiunge, «alla luce del suo connotato politico». Ma il connotato, il lineamento, l’aspetto «politico» non è qui in gioco, poiché esso ha
14
15
118
Andrea Di Miele
Il carattere ideologico del cesarismo ci riconduce dunque non tanto al
generico tema dell’ideologia, il cui perimetro ampio e articolato richiederebbe
un’analisi estesa, quanto alla specifica questione della “funzione” dell’ideologia.
Nel Quaderno 7 Gramsci distingue due tipi di ideologie. Da un lato le ideologie
«arbitrarie» che «non creano altro che “movimenti” individuali, polemiche» e
sono dunque delle semplici «elucubrazioni mentali di determinati individui»:
esse hanno l’unico valore di «errore» che si «oppone alla verità e l’afferma».
Dall’altro le ideologie «storicamente organiche, che sono cioè necessarie ad una
certa struttura […] esse – ci dice Gramsci - hanno una validità “psicologica”,
esse “organizzano” le masse umane, formano il terreno in cui gli uomini si
muovono, acquistano coscienza della loro posizione, lottano ecc.»18.
Nel Quaderno 10, Gramsci aggiunge, a questa, un’altra notazione interessante
quando commenta la celebre considerazione di Marx, tratta dall’Introduzione
a Per la critica dell’economia politica19. Scrive Gramsci: «La proposizione […]
che gli uomini prendono coscienza dei conflitti di struttura nel terreno delle
ideologie deve essere considerata come un’affermazione di valore gnoseologico
e non puramente psicologico e morale»20.
Tale rilievo del valore «gnoseologico» dell’ideologia toccava un punto
sensibile della lezione di Gramsci: l’egemonia e l’interpretazione stessa del
marxismo. Non a caso, viene qui significativamente citato Lenin:21.
Seguire la linea di sviluppo dei rapporti Gramsci-Lenin, su questi temi,
ci condurrebbe lontano. Ciò che interessa è notare la trama inestricabile e
l’interdipendenza tra egemonia, ideologia, direzione culturale. L’ideologia è qui
il termine medio attraverso il quale l’egemonia si traduce in Weltanschauung:
una visione del mondo al servizio del progetto rivoluzionario, d’ausilio dunque
già una coloritura. In esame, semmai, è il crudo fatto economico. Gramsci, non a caso, non
parla di «cesarismo collettivo» poiché avrebbe dovuto rintracciarne le concrete fondamenta.
Dunque, la saldatura proposta da Burgio, tra il «cesarismo progressivo» e un «cesarismo collettivo» può anche essere legittimamente operata, ma come esplicito segno d’un un connotato
politico aggiunto. Di contro si paleserebbe proprio il rischio paventato da Gramsci: il cesarismo come «uno schema di comodo per l’arte», appunto, della «politica».
18
Q17, 19, [868-869].
19
«Con il cambiamento della base economica – dice Marx – si sconvolge più o meno rapidamente tutta la gigantesca sovrastruttura. Quando si studiano simili sconvolgimenti, è indispensabile distinguere sempre fra lo sconvolgimento materiale delle condizioni economiche
della produzione, che può essere constatato con la precisione delle scienze naturali, e le forme
giuridiche, politiche, religiose, artistiche o filosofiche, ossia le forme ideologiche che permettono agli uomini di concepire questo conflitto e di combatterlo». [K. Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort [1859], trad. it, Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti,
Roma, 19693, pagg. 4-6; MEW, Bd. 13, S. 9].
20
Q10, 12, [1249].
21
Q10, 12, [1250].
Antonio Gramsci: cesarismo, ideologia, cultura unitaria
119
alla prassi.
Nell’Introduzione a Per la critica della filosofia del Diritto di Hegel, Marx
scriveva: «Evidentemente l’arma della critica non può sostituire la critica delle
armi, la forza materiale non può essere abbattuta che dalla forza materiale ma
anche la teoria si trasforma in forza materiale quando penetra nelle masse»22.
Gramsci nel Quaderno 7 commenta: «Altra affermazione di Marx è che una
persuasione popolare ha spesso la stessa energia di una forza materiale o
qualcosa di simile e che è molto significativa»23.
Il presupposto teorico che sottende queste riflessioni, si può riassumere
nella critica gramsciana al «materialismo storico meccanico»: reo d’istituire
un’interdipendenza immediata, diretta e immune da errori tra momento
strutturale e superstrutturale. Una posizione ingenua e sterile24. La politica,
non è una derivazione deterministica dei rapporti economici: esprime
semplicemente delle tendenze di sviluppo passibili, come ogni intento umano,
d’errori ed esposte anche all’insuccesso. Ma se tale rapporto è mediato,
indiretto e tendenziale ciò rafforza e non sminuisce la necessità d’uno studio
e d’una comprensione delle radici storico-economiche che costituiscono
tale relazione, perché queste, in ultima analisi, sono le sue radici umane. Il
pericolo risiede, semmai, nello smarrimento della “funzione” dell’ideologia,
del ruolo specifico che riveste: ricondurre marxianamente alla rete di bisogni
economici. Scrive ancora Gramsci citando il 18 brumaio dal quale eravamo
partiti: «La pretesa […] di presentare ed esporre ogni fluttuazione della politica
e della ideologia come una espressione immediata della struttura, deve essere
combattuta teoricamente come un infantilismo primitivo, o praticamente deve
essere combattuta con la testimonianza autentica del Marx, scrittore di opere
politiche e storiche concrete. Per questo aspetto sono importanti specialmente
il 18 Brumaio e gli scritti sulla questione Orientale»25.
Se ora proviamo a ricondurre queste considerazioni ad un altro volto
dell’ideologia, quello scientifico possiamo osservare l’intima coerenza che lega
22
K. Marx, Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung [1844], trad. it Per la
critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione in Opere Scelte, Roma, 1966, p. 64, (MEW,
Bd. 1, S. 385).
23
Q7, 21 [869].
24
«Nella discussione tra Roma e Bisanzio – spiega Gramsci – sulla processione dello Spirito
Santo, sarebbe ridicolo cercare nella struttura dell’Oriente Europeo l’affermazione che lo Spirito Santo procede solo dal Padre, e in quella dell’Occidente l’affermazione che esso procede
dal Padre e dal Figlio […] ma poteva avvenire che ognuna delle due Chiese avesse affermato
ciò che invece aveva affermato l’altra» Q7, 24 [873].
25
Q7, 24 [871].
120
Andrea Di Miele
ideologie così diverse tra loro.
Le scienze, considerate nella loro dimensione meccanicistica, infatti, sono
anch’esse, per Gramsci, «ideologiche». La dimensione «molecolare» dei gruppi
umani e dei loro interessi particolaristici che conduce all’ideologia politica, non
è dissimile dalla separazione artificiosa dei saperi che conduce all’«ideologismo
scientifico». La critica è rivolta ad una scienza intesa come nuova religione cui
affidarsi per giungere ad una presunta realtà oggettiva, un progresso scientifico
che instilla la credenza d’un «nuovo Messia», capace con le sole sue forze di
sciogliere l’uomo da ogni bisogno, aprendogli la prospettiva d’un nuovo Eden:
d’una società dell’abbondanza26.
Questa «infatuazione», deve essere combattuta per riappropriarsi di ciò
che realisticamente può offrici. Affrontare la superstizione scientifica e la sua
pretesa oggettività, significa nient’altro che ritrovarne le radici umane, com’era
necessario rintracciare le radici economiche, storiche, umane del cesarismo
altrimenti votato all’astrattezza d’uno schema sociologico di presunta obiettività.
«Tutta la scienza – scrive Gramsci nel Quaderno 11 – è legata ai bisogni, alla
vita, all’attività dell’uomo. Senza l’attività dell’uomo, creatrice di tutti i valori,
anche scientifici, cosa sarebbe l’“oggettività”?»27. Ma l’“umanamente oggettivo”,
tramite lo “storicamente soggettivo”, si risolve, per Gramsci, nell’“universale
soggettivo”28. Assume così un senso forte, ci sembra, l’idea di un sapere inteso
come unitario, dove la coesione e l’unità si fondano proprio sull’«universalmente
soggettivo»: sull’uomo.
«L’uomo conosce oggettivamente – dice Gramsci – in quanto la conoscenza
è reale per tutto il genere umano storicamente unificato in un sistema culturale
unitario; ma questo processo di unificazione storica avviene con la sparizione
delle contraddizioni interne che dilaniano la società umana, contraddizioni che
sono la condizione della formazione dei gruppi e della nascita delle ideologie
non universali concrete ma rese caduche immediatamente dall’origine pratica
della loro sostanza»29.
La cultura unitaria, in Gramsci, è dunque cultura non alienata in cui la
dimensione parcellizzata delle scienze recupera la coscienza della totalità del
processo storico, con un fine specifico: la realizzazione d’un società di soggetti
umani liberi da ogni sorta di schiavitù. La futura umanità non è la comunità
Q11, 39, [1458].
Q11, 37, [1457].
28
Q11, 17, [1415-1416]. Questi termini sono resi, nell’originale gramsciano, tra virgolette.
29
Q11, 17, [1416].
26
27
Antonio Gramsci: cesarismo, ideologia, cultura unitaria
121
d’individui i cui bisogni immediati siano stati definitivamente risolti dalla
meccanizzazione, ma un eterogeneo insieme di soggetti consapevoli, affrancati
da ogni feticismo.
Forse, da un altro secolo, Gramsci parla anche alla nostra società globalizzata,
poiché non può sussistere, un’autentica prospettiva interdisciplinare ove i
singoli rami del sapere siano disgiunti dalla comune radice, la medesima
alla quale deve far appello ogni società multiculturale: l’uomo concreto e la
società armonica di soggetti da costruire. Cultura unitaria è dunque lotta per
recuperare l’oggettività, reale e storica delle scienze ma è, allo stesso tempo,
lotta per una soggettività libera da ogni infatuazione, da ogni cesarismo e da
ogni ideologia.
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
123
Raniero Panzieri:
Gli anni della formazione (1946-1955)
Memoria di Cristiana Boscarelli
presentata dal socio naz. ord. res. Giuseppe Di Marco
(seduta del 25 novembre 2010)
«Un pensiero libero, non ideologico,
non è un pensiero che prende coscienza
delle contraddizioni della realtà,
ma un pensiero che corrisponde ad una realtà
a cui siano state tolte le contraddizioni economiche»
R. Panzieri
Abstract. In the years 1946-1955 italian society is characterized by relevant changes. It
is also the period when Raniero Panzieri has his theoretical-practical background. This
is marked by italian and international marxist debate and by direct reading of marxian
writings, but also by his political activity as cultural officier of Socialist Party and then
as responsable for the reconstruction of the party in Sicily. Essential reference frame is
provided by Rodolfo Morandi, under whose influence Panzieri confronts the outcome of
theoretical discussion which develops between the Second and the Third International.
The search for a theoretical renewal of marxism, which claims the means-end coherence
and allows to overcome the anthisesis of reformism and revolutionary practice, is
Morandi’s methodological heritage, that Panzieri works out throughout his analysis of
neo-capitalism.
1. Premessa
Nel presente lavoro intendo mettere a tema, attraverso la ricognizione di
alcuni scritti di Raniero Panzieri, un momento cruciale della vita culturale
italiana che va dall’immediato dopoguerra alla metà degli anni cinquanta.
Entro questa cornice, infatti, il dibattito di matrice marxista e l’esperienza
del socialismo di sinistra vive un momento di grande intensità, e si confronta
e partecipa - dall’interno - ad importanti vicende culturali e politiche. Sono gli
anni della ricostruzione, dei piani industriali attraverso i quali è messo a punto
un preciso modello di sviluppo e si consolidano quei rapporti che decideranno
della storia futura dell’Italia.
124
Cristiana Boscarelli
è all’altezza di questi problemi che si colloca l’esperienza di Raniero
Panzieri, figura complessa del socialismo italiano, dirigente del partito
socialista, protagonista della stagione delle riviste e del dibattito politicacultura1, quadro morandiano impegnato nella ristrutturazione del partito2, e
ancora, acuto lettore di Marx e critico del neocapitalismo, animatore di diverse
stagioni di lotta dall’occupazione delle terre in Sicilia alle mobilitazioni delle
fabbriche torinesi dei primi anni sessanta, nonché fondatore e animatore della
rivista «Quaderni Rossi».
Una figura ricca quella di Panzieri3, della cui complessità non dicono né
la sua appartenenza o meno ad una organizzazione politica, né i suoi diversi
ambiti di intervento, fossero essi culturali, politici in senso stretto, o teorici;
forse anche per questo insieme ad altri protagonisti di quel periodo, spesso
intempestivamente riconosciuti come tali, è stato nella recente letteratura
designato come eretico.
Senza indulgere a suggestive letture che evocano, in un gioco di rimandi
tra internità ed esternità, la cifra dell’attualità di Panzieri nella sua alterità
rispetto ad un determinato contesto politico e teorico, rintracciando così un
filone del socialismo che proprio in quanto eretico non partecipò della crisi dei
partiti tradizionali, intendo indagare con questo studio proprio le radici del
socialismo panzieriano, quella salda e feconda base sulla quale si innestò la sua
particolare capacità performativa, e certamente, la vivacità e la curiosità che
gli consentirono di leggere le trasformazioni e le innovazioni del capitalismo in
quello scorcio di keynesismo italiano, adeguando, sempre senza avventurismi,
ad esse l’analisi teorica.
Ho ritenuto imprescindibile entrare nel merito del laboratorio entro cui
nasce a un tempo l’esperienza di Panzieri e si compiono i passaggi che chiudono
un ciclo storico politico e teorico, rispetto ai quali il complesso dell’elaborazione
di Panzieri stesso ebbe un carattere epigonale.
1
Panzieri fu condirettore dal 1957 al 1958 della rivista culturale del partito socialista Mondo Operaio. Impresse alla rivista un carattere sicuramente particolare riuscendo a entrare in
sintonia con il l’ampio clima di rinnovamento del quale il fiorire delle riviste era espressione e
sottraendolo al ruolo, fisiologicamente più autocentrato, di rivista ufficiale del partito socialista. Cfr. S. Carpinelli, Una nuova partenza.”Mondo Operaio” di Panzieri (1957-1958), in «Classe,
quaderni sulla condizione e sulla lotta operaia, numero tematico -Gli anni delle riviste (19551969)-», 17, (1980), pp. 63-107.
2
Cfr. D. Rizzo, Il Partito Socialista e Raniero Panzieri in Sicilia (1949-1955), prefazione di
S. Mancini, Soveria Mannelli, 2001.
3
Testimonia la ricchezza di interessi e l’atteggiamento culturalmente aperto al confronto
la stessa esperienza di Panzieri all’Einaudi. Cfr. L. Baranelli, Panzieri all’Einaudi in «L’ospite
ingrato», XI, (2006), 1, pp.199-214.
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
125
Il contributo, tutto il contributo di Panzieri, allo studio delle trasformazioni
del capitalismo, del neocapitalismo come si disse allora, la sua attenzione
rivolta tanto alle trasformazioni del proletariato di fabbrica quanto a quelle
lotte contadine che nel loro insieme connotarono un’epoca della storia del
paese, la capacità di cogliere, sempre al di là di ogni pregiudizio, liberamente
e con atteggiamento non dogmatico, il meglio delle elaborazioni teoriche
e del dibattito culturale italiano, e ancora più significativamente europeo e
internazionale, sempre con grande consapevolezza dei differenti presupposti
metodologici e ideologici, costituiscono un reale patrimonio per la comprensione
di una storia tutto sommato recente, un contributo che non è stato forse ancora
adeguatamente messo a valore.
Partire dunque dalla formazione di Raniero Panzieri per poter poi leggere
meglio, con la giusta consapevolezza, gli sviluppi ultimi della sua produzione,
gli studi sulla razionalità del neocapitalismo, i legami tra la trasformazione
della produzione e i meccanismi della produzione ideologica applicati alla
produzione stessa, la risposta dei soggetti coinvolti in questi meccanismi, quella
che allora, senza tanti giri di parole, si chiamava classe.
Senza dubbio è una riflessione che nasce nel cuore dell’introduzione del fordismo
in Italia e che getta un ponte con la riflessione promossa, partire dagli anni trenta,
da quegli studiosi che, in posizione critica nei confronti del marxismo ortodosso, e
vivendo prima analoghi processi, avvertirono l’esigenza di mettere a tema proprio la
razionalità capitalistica e lo stesso concetto di progresso che al suo interno si andava
compiendo; un ponte tra gli anni trenta e gli anni sessanta del novecento, un dialogo a
distanza, poiché credo che questa sia la maniera più corretta di riferirsi al rapporto tra
la produzione panzieriana e gli studi della teoria critica.
In questa sede prenderò dunque in esame i testi di Panzieri compresi tra
il 1946 e il 1955, che corrispondono ad un periodo che da più punti di vista
si può considerare di formazione. Si è trattato di una scelta precisa: nel 1955
muore infatti Rodolfo Morandi4, importante figura del socialismo italiano con
il quale Panzieri ebbe quel rapporto formativo e fecondo le cui implicazioni
4
Rodolfo Morandi fu un intellettuale e militante politico antifascista approdato a posizioni marxiste, impegnato nella Resistenza e dal 1945 alla presidenza CLNAI. Dirigente prima del
PSIUP e poi del Partito socialista italiano, prese parte alla Costituente e fu ministro dell’industria e del commercio dal 1946 al 1947. Fu un uomo animato da un forte slancio ideologico e
si confrontò politicamente e teoricamente con le correnti del socialismo italiano ed europeo. Il
socialismo di Morandi è senza dubbio un socialismo di ispirazione consiliarista e soprattutto
negli anni trenta esso si contraddistinse per gli accenti libertari. L’incontro tra Panzieri e Morandi avvenne nel dopoguerra all’interno del partito socialista, e fu decisivo per il percorso di
Panzieri. Per un’attenta ricognizione dell’itinerario politico teorico di Rodolfo Morandi, Cfr. A.
Agosti, Rodolfo Morandi: il pensiero e l’azione, Roma-Bari, 1971.
126
Cristiana Boscarelli
relativamente al percorso panzieriano tenterò di analizzare, e cominciano ad
agitare la società italiana quei processi di trasformazione economica culturale
e politica, emblematici i fatti d’Ungheria del 1956, che saranno il milieu del
pieno dispiegarsi del contributo di Panzieri.
2. Rodolfo Morandi e la ricezione del dibattito teorico tra la Seconda e la Terza
internazionale.
è sicuramente importante il segno lasciato dal pensiero e dalla prassi di
Rodolfo Morandi su Raniero Panzieri. Di questo forte riferimento ci dice lo
stesso Panzieri, che considera la lezione di Morandi imprescindibile, «che si
affaccia alta ed esemplare»5. Egli si esprime in questi termini significativamente
alla vigilia di uno scenario nuovo, complesso, ma sicuramente interessante, che
si voleva fecondo di opportunità6 come quello della destalinizzazione.
A Morandi Panzieri riconosce, e in questo precisamente rintraccia la cifra
inestimabile del suo contributo, di aver preservato, non le condizioni della
ripresa socialista attraverso la conservazione di uno strumento materiale, il
Partito7, quanto piuttosto una «condizione ideologica, una prospettiva»8.
è quindi, quella che Panzieri riceve da Morandi, un’eredità profonda,
metodologica, il riferimento costante del suo orientamento teorico9 e politico10.
5
R. Panzieri a F. Fortini, 18 dicembre 1957, in R. Panzieri, Lettere 1940-1964, a cura di
Stefano Merli e Lucia Dotti, introduzione di S. Merli, Venezia, 1987, pp. 112-115, p. 113.
6
La trattazione della produzione panzieriana coeva agli anni della destalinizzazione cade
fuori dall’ambito entro il quale intende muoversi questo studio. Cfr. R. Panzieri, Dopo Stalin,
una stagione della sinistra 1956-1959, a cura di S. Merli, Venezia, 1986. Per il periodo immediatamente precedente e di poco successivo faccio riferimento al testo, in vero non sempre
condivisibile , ma utile per un quadro storico complessivo di Massimo Teodori. Cfr. M. Teodori, Storia delle nuove sinistre in Europa, Bologna, 1976. Decisamente più condivisibile e
molto denso, orientato sull’evoluzione dei rapporti politica-cultura, M. Fugazza, Il marxismo
nel dopoguerra. La rivista «Società»(1945-1961), in «Classe, quaderni sulla condizione e sulla
lotta operaia, numero tematico -Gli anni delle riviste (1955-1969)-», cit., pp. 3-29.
7
Non a caso, essendo la prassi e la fedeltà di Rodolfo Morandi legata non già ad uno strumento, quale che fosse, ma alla classe. Più avanti si dirà della concezione del rapporto Partitoclasse in Morandi e di quanto di questa concezione sia debitore Panzieri.
8
R. Panzieri a F. Fortini, 18 dicembre 1957, in R. Panzieri, Lettere 1940-1964, cit., p. 114.
(Il corsivo è mio).
9
Rilevare una adesione metodologica, sottolineare l’ispirazione profonda che lega Panzieri a
Morandi non significa né ridimensionare il peso di altri riferimenti teorici, Marx, Gramsci, Lenin,
Luxemburg, che costituiscono peraltro referenti teorici condivisi dai due, né minimizzare le modalità originali in cui Panzieri traduce questa ispirazione di fondo, modalità e condizioni storiche che
lo portano a compiere un percorso autonomo e innovativo. Incorre forse nel rischio di marcare un
eccessivo ridimensionamento del contributo di queste figure del dibattito marxista cui si è accennato, rispetto alla costante morandiana Stefano Merli. Cfr. S. Merli, Introduzione a R. Panzieri, in
Dopo Stalin, una stagione della sinistra 1956-1959, cit., pp. VII- XXXIX.
10
Non è evidentemente possibile scindere il legame tra il momento politico e quello teori-
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
127
Erano peraltro ben presenti a Panzieri talune criticità delle elaborazioni
morandiane, e di più , la natura di queste: basti pensare alla riflessione su
una certa ipertrofia del concetto di classe11operante in Morandi, che nata
su un piano pragmatico, dall’«esigenza di svincolarsi dal democraticismo
socialdemocratico»12, aveva portato il socialista milanese ad una concezione
acritica dell’unità.13
Indubbiamente la concezione che Rodolfo Morandi ebbe della politica
unitaria come concezione unitaria del socialismo assunta nei suoi termini
generali, costituisce il presupposto e l’indirizzo programmatico che ci
consentono di rintracciare da una parte la forte sintonia, pur nelle diversità,
tra Morandi e Panzieri, e dall’altra di individuare il terreno su cui maturano
le diverse esperienze di Panzieri, a partire da quella di quadro della sinistra
socialista.14 Della concezione unitaria, così come la si trova espressa in Morandi,
co nel percorso di Raniero Panzieri, che istituisce tra essi un legame profondo che sostanzia
anche quello che sarà sviluppato come lavoro di inchiesta. È rilevante su questo l’intera produzione panzieriana degli anni Sessanta, in part. R. Panzieri, Sull’uso capitalistico delle macchine
nel neocapitalismo in Id., Spontaneità e organizzazione. Gli anni dei «Quaderni Rossi» 19591964, a cura di S. Merli, Pisa, pp. 25-41; Id., Lotte operaie nello sviluppo capitalistico, Ibid., pp.
73-92; Id., Uso socialista dell’inchiesta operaia, Ibid., pp. 121-128.
11
R. Panzieri a L. Della Mea, 24 Agosto1964, in Id., Lettere 1940-1964, cit., p. 408.
12
Ibid.
13
Il riferimento è all’unità della classe operaia, e alla obiettiva difficoltà della declinazione
di questa prospettiva, portata avanti da Morandi fin dal periodo del Centro Interno Socialista
negli anni Trenta, che costituì il cardine dell’impostazione data dallo stesso Morandi ai rapporti con il PCI nel dopoguerra, all’interno della complessa dinamica della contrapposizione
tra i blocchi della Guerra Fredda. Più avanti mi soffermerò su come la politica unitaria è interpretata da Panzieri.
14
Secondo Agosti è assente in Morandi ogni visione mitica dell’unità della classe operaia, del proletariato: «il problema non è quello dell’unificazione dei due partiti della classe
operaia, non è quello di introdurre meccanicamente nel movimento di massa lo schema
dell’unità precostituita rispetto a un sistema di valori astratti, ma di portare avanti una
azione intesa ad esercitare un impulso critico su tutti gli aspetti del movimento stesso,
perché proprio dalla loro autentica molteplicità emerga una unità organica nella lotta. Si
enuclea in tal modo la concezione che Morandi ha dell’azione di massa.(…) I rapporti tra
i due partiti operai si esplicano come concorso a realizzare tale visione organica e democratica delle lotte, quella che Morandi chiamava “l’unità delle lotte”». (A. Agosti, Rodolfo
Morandi, cit., p. 442).
Lo stesso Panzieri si riferisce alla politica unitaria così intesa, vivificata nell’azione di
massa, adottata criticamente contro ogni dogmatismo e dunque aperta alla critica delle
debolezze e degli errori dei partiti della classe, come a un contributo per lui estremamente
attuale. Il riferimento è ad un «rapporto dialettico, non meccanico tra i partiti operai e
l’azione degli organismi di massa: rapporto nel quale ai partiti viene tolta ogni prerogativa a priori di guida, di depositari della rivoluzione, mentre vengono restituiti alla loro
possibile funzione di spinta, di elaborazione, di consolidamento delle capacità autonome
della classe operaia, da cui scaturiscono le forme organizzative autonome, dal basso, di
democrazia diretta, nelle quali già oggi, nel corso della lotta contro il capitalismo si prefigura la nuova società socialista».(R. Panzieri, Le «opere» di Morandi, in Id., Dopo Stalin,
cit., p. 82).
128
Cristiana Boscarelli
Aldo Agosti ci dice che essa sostanzia l’azione di massa «intesa come capacità
di fare maturare nella lotta le esperienze della classe operaia per la costruzione
della democrazia socialista, la quale è per se stessa unità nell’articolazione e
nella molteplicità»15; ci sembra che questa sia precisamente la declinazione
panzieriana della concezione unitaria del socialismo.
Possiamo rilevare in questa concezione una preminenza del legame con la
classe rispetto al partito, tanto che, in fasi diverse, si avrà un uso più o meno
strumentale dello stesso, fino al suo abbandono, da parte di Panzieri, quando
quello strumento si rivelerà costitutivamente inadeguato a rispondere alle
esigenze della classe. Sembra, in questo senso, che anche la determinazione
teorica della funzione del partito e dei suoi rapporti con la classe, così come
maturò nel dibattito marxista tra la seconda e la terza internazionale in figure
come Lenin e Rosa Luxemburg, per quanto informi certamente le concezioni
del Nostro, venga recepita in termini più mobili.
Pur essendo cioè chiara la questione della relazione tra forma organizzativa
del partito e obiettivi rivoluzionari, nonché la sua funzione rispetto alla teoria
– , e in questo senso gli orientamenti di Panzieri come anche di Morandi
vengono chiariti16 -, emerge come il partito stesso, come forma specifica di
organizzazione della classe, non sia il centro della questione: vi è la convinzione
che esso sia solo una componente tra quegli istituti in cui il proletariato sviluppa
ordinamenti socialisti di vita; vi è dunque una aperture teorica, e una elasticità
A. Agosti, Rodolfo Morandi, cit., p. 442.
Sono noti i contributi di studiosi che legano il lavoro di Raniero Panzieri in particolar modo al Morandi degli anni Trenta, quelli del Centro Interno Socialista. Su un piano
più squisitamente teorico Cfr., S. Mancini, Socialismo e democrazia diretta. Introduzione a
Raniero Panzieri, Bari, 1977. In questo senso è decisivo un importante scritto morandiano
del periodo in cui il Centro Interno Socialista matura l’orientamento organico al partito
socialista. Èinfatti qui visibile, dietro le esigenze di presa di distanza dalla teoria e dalla
prassi socialista che culminò con l’Aventino, la fedeltà di fondo ad una ispirazione classista
che può trovare la sua prassi in diversi partiti e ciò nonostante rimanere l’invariante, il
criterio di orientamento. Così Morandi: «Mentre riteniamo che la lotta contro il fascismo
non possa ormai essere condotta se non nella linea socialista, ricollegandosi allo sviluppo
storico del movimento e alle sue origini scientifiche, crediamo però che il nostro compito
specifico non possa identificarsi con la riclassificazione di quadri che non esistono concretamente più, o colla semplice ripresa di una continuità ininterrotta. Quello che urge oggi
è una riclassificazione delle premesse politiche della lotta socialista, che si attui nella rigenerazione dei suoi motivi fondamentali, e perciò nella identificazione degli elementi che
ne hanno determinato il temporaneo declino, sia nella ricerca di un punto fermo verso il
quale si posano orientare, con garanzia di concretezza, tutte le forze socialiste. Se la nostra
posizione è, e non può non essere, di partito in fieri , non può essere, viceversa, quello di un
partito che semplicemente ritrova e ricostruisce i suoi quadri prima di porsi il problema di
se stesso, e della propria legittimazione politica».(R. Morandi, Presentazione ai contributi
della redazione di “Politica socialista”, in Id., La democrazia del socialismo 1923-1937, a
cura di S. Merli, Torino, 1961, pp. 118-119).
15
16
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
129
da essa conseguente, tale da consentire, nelle condizioni storiche particolari
in cui questo strumento non è a disposizione della classe, che il percorso di
costruzione dell’unità di classe si strutturi diversamente, su un terreno che gli
è ugualmente proprio.
Per chiarire la specificità della funzione del partito nel socialismo di
sinistra17nella versione morandiana prima, e poi in Panzieri, è utile fare
riferimento ad uno scritto dello stesso Morandi, in cui emerge tutta la
distanza critica rispetto alla tradizione dominante nella cultura comunista
e in particolare lo smarcamento rispetto alla svolta operata da Palmiro
Togliatti, che viene letta come una prassi politica che presuppone nella
teoria la divaricazione assoluta tra un programma minimo e un programma
massimo. A questo proposito Morandi rileva quanto i socialisti portino
«anche nel fuoco dell’azione, delle esigenze che i comunisti non provano.
Essi debbono assegnare un orizzonte agli sforzi che chiedono alla massa
lavoratrice, non possono limitare le prospettive a successivi traguardi di
tappa. E quest’ orizzonte è rappresentato dalla finalità di classe. Secondo
la concezione poi che i socialisti hanno del partito, è la massa che nel
partito esprime i suoi interessi e per mezzo del partito si dirige. Invece
nella concezione comunista il partito è strumento per manovrare la massa,
conforme alle direttive che ai quadri compete di assegnargli. Tutto questo
comporta naturalmente una dinamica diversa. È qualcosa di simile alla
differenza che si stabilisce tra gli ordinamenti militari e quelli civili. Per
gli uni basta un ordine, per gli altri occorre una motivazione, ossia la
consapevolezza delle ragioni che muovono ad una data azione, e dei fini
non soltanto immediati che sono da raggiungere(…)La classe deve prendere
posizione come tale. Nessuno vuol dubitare che l’intento che i comunisti
portano nella lotta sia il bene della classe, ma essi svolgono una politica per
la classe, noi conformemente al metodo democratico cui ci ispiriamo, non
possiamo fare che una politica di classe»18.
è fin troppo chiaro il richiamo alla polemica sul partito esplosa a partire
dal secondo congresso del POSDR (Partito Operaio Socialdemocratico Russo)
17
Di recente pubblicazione sul rapporto di Morandi con il Socialismo di sinistra, M. Sacchi, G. Artero, Rodolfo Morandi e il socialismo rivoluzionario tra le due guerre, in appendice a,
G. Artero, Il punto di Archimede. Biografia politica di Raniero Panzieri, da Rodolfo Morandi ai
“Quaderni Rossi”, Cernusco sul Naviglio, 2007, pp. 161-182.
18
R. Morandi, Lettera aperta ai compagni comunisti, in Id., Lotta di popolo 1937-1945,
Torino, 1958, pp. 61-64.
130
Cristiana Boscarelli
del 1903, e in particolare, alle posizioni espresse in quella circostanza da Rosa
Luxemburg19.
19
Per un quadro del dibattito marxista della seconda internazionale, cfr. Aa.Vv, Storia del
marxismo,Torino, 1979, vol. 2, Il marxismo dell’età della seconda internazionale, Torino, 1979;
in part., O. Negt, Rosa Luxemburg e il rinnovamento del marxismo, in Storia del Marxismo,
Ibid., pp. 318-355. Nella riflessione morandiana la questione dell’organizzazione ricopre un
ruolo decisivo, proprio in relazione alla definizione dei rapporti tra classe e partito; d’altra
parte nel noto scritto del 1904 circa i problemi della socialdemocrazia russa Rosa Luxemburg,
nel chiarire la specificità delle condizioni su cui poggia l’azione socialdemocratica, sostiene
che essa nasce dalla lotta di classe elementare: «Nel movimento socialdemocratico, a differenza dei precedenti tentativi utopistici di socialismo, anche l’organizzazione non è un prodotto
artificioso della propaganda, ma un prodotto storico della lotta di classe, in cui la socialdemocrazia introduce soltanto la coscienza politica»(R. Luxemburg, Problemi di organizzazione
della socialdemocrazia russa, in Scritti politici, a cura di Lelio Basso, Roma, 1967, p. 218). Rosa
Luxemburg sostiene che la socialdemocrazia «si muove in questa contraddizione dialettica,
che da un lato l’esercito proletario si recluta solo nel corso della lotta, e dall’altro, è ancora
soltanto nella lotta che ne chiarisce a se stesso gli scopi. Organizzazione, chiarificazione e lotta
non sono qui momenti divisi, meccanicamente e anche temporalmete separati, come in un
movimento blanquista, ma sono soltanto facce diverse di un medesimo processo (…) Risulta,
già da questo, che la centralizzazione socialdemocratica non può basarsi sull’obbedienza cieca, sulla subordinazione meccanica dei militanti di partito alla loro autorità centrale, e che,
d’altra parte, nessuna paratia stagna può essere eretta fra il nucleo del proletariato cosciente,
già saldamente inquadrato nel partito, e lo stato circostante, già afferrato dalla lotta di classe
e in pieno processo formativo della coscienza (...) Lenin ha forse caratterizzato il suo punto di
vista in modo più drastico di quanto potesse farlo qualunque dei suoi oppositori, definendo il
suo “socialdemocratico rivoluzionario” come “il giacobino legato all’organizzazione degli operai coscienti”». (Ibid., p. 218 e ssg.). Negli stessi mesi anche Trotskij partecipa al dibattito sul
partito con uno scritto dal titolo I nostri compiti politici, in cui sviluppa la polemica con Lenin.
In questo testo fa riferimento, con abbondanti citazioni tanto allo scritto di Lenin del 1904,
Un passo avanti e due indietro (cfr, V. I Lenin, Un passo avanti e due indietro: la crisi del nostro
partito, Id., Opere scelte, Roma, vol. I, pp. 465-545.) che a Karl Marx, (cfr. K. Marx, Das Kapital.
Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band: Der Produktionsprozeß des Kapitals (18904), in K.
Marx – F. Engels, Werke, herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Berlin/Ost, 1957 sgg., Bd. 23, p.
447; tr. it. Il Capitale. Critica dell’economia politica, a cura di Delio Cantimori, Roma, 1974, libro I, tomo 2, p. 468.), riprendendo in particolare le riflessioni marxiane su macchine e grande
industria sviluppate nel capitolo dedicato alla produzione del plusvalore relativo. In polemica
con Lenin Trotskij scrive: «secondo la nuova filosofia di Lenin […] al proletariato basta essere
passato per la “scuola della fabbrica” per dare all’intellighèntzia, che sino ad allora ha assolto
nel suo Partito il ruolo direttivo, delle lezioni di disciplina politica! In base a questa nuova
filosofia, chi non vede nel partito un’ “immensa fabbrica”, chi trova questa idea “mostruosa”,
chi non crede affatto nella forza immediatamente educativa (politicamente) della macchina,
“tradisce di colpo la psicologia dell’intellettuale borghese”, incapace per natura di distinguere
il lato negativo della fabbrica (“disciplina basata sulla paura di morire di fame”) e il suo lato
positivo (“disciplina basata sul lavoro in comune dettato dalle condizioni di una produzione
molto sviluppata”)[…]Senza temere di tradire la nostra “psicologia d’intellettuale borghese”,
affermiamo innanzi tutto che le condizioni che spingono il proletariato a metodi di lotta concordati e collettivi non si trovano nella fabbrica, bensì nelle condizioni sociali generali della
sua esistenza; affermiamo inoltre che tra queste condizioni oggettive e la disciplina cosciente
dell’azione politica si stende una lunga strada di lotte, errori, di educazione - non la “scuola di
fabbrica”, ma la vita della scuola politica (…) ci dichiariamo [...] completamente solidali con
l’idea che “la subordinazione tecnica dell’operaio al movimento uniforme del mezzo di lavoro
(= “disciplina basata sul lavoro in comune risultante da una tecnica altamente sviluppata”) e
la particolare composizione del corpo lavorativo, in cui si riuniscono individui di ambo i sessi
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
131
L’ampio dibattito che vede protagonisti, tra gli altri oltre alla Luxemburg,
Lenin, Trockij, Martov, si concentra sulla piattaforma organizzativa del partito.
Nel definire la specifica relazione dell’organizzazione socialdemocratica
con la classe, Rosa Luxemburg sottolinea come in effetti «la socialdemocrazia
non [è] legata all’organizzazione di classe operaia, ma [è] il movimento
specifico della classe operaia»20, e che, sul piano della ricaduta organizzativa,
«il centralismo socialdemocratico deve quindi essere di qualità essenzialmente
diverso da quello blanquistico. Esso non può essere altro che il momento
imperativo in cui si unifica la volontà dell’avanguardia cosciente e militante
della classe operaia di fronte ai suoi singoli gruppi e individui, e questo è per
così dire un autocentralismo dello strato dirigente del proletariato, il dominio
della maggioranza nella propria organizzazione di partito (….) la formazione
di un’avanguardia proletaria cosciente e capace di giudizio autonomo (…) deve
essere considerata lo scopo principale del prossimo lavoro sia di agitazione che
di organizzazione»21.
La Luxemburg nota quanto Lenin tradisca «una concezione troppo
meccanica della organizzazione socialdemocratica quando (…) vanta
l’importanza educatrice della fabbrica che farebbe il proletariato maturo dalla
nascita per «disciplina e organizzazione»22, sottolineando che «la disciplina a
e d’ogni età, generano una disciplina da caserma (da caserma e non già una disciplina coscientemente politica!); che si perfeziona e diviene un regime di fabbrica completo”(Ibid., tr.it. cit.,
p. 319). Se Lenin crede nella disciplina del proletariato russo come un’entità reale, confonde
effettivamente, per usare la sua stessa espressione, una questione d’ordine “filosofico” con una
questione d’ordine politico. Naturalmente la “produzione tecnicamente assai sviluppata” crea
le condizioni materiali dello sviluppo e dello spirito di disciplina politici del proletariato, come
in genere, il capitalismo crea le premesse del socialismo. Ma la disciplina di fabbrica tanto
poco si identifica con la disciplina politica e rivoluzionaria quanto il capitalismo si identifica
col socialismo» ( L. Trockij, I nostri compiti politici, in, V. I. Lenin, L. Trockij, R. Luxemburg,
Rivoluzione e polemica sul partito, introduzione di Giuseppe Bedeschi, Roma, 1973, pp. 310312). È interessante notare come allo stesso passo dal Capitale farà riferimento Panzieri nella
famosa Relazione sul neocapitalismo, tenuta al campo valdese di Agape nel 1961, e come ancora Panzieri, sempre sulla scorta di Marx, porrà l’accento su come, proprio all’interno del
codice di fabbrica, avvenga, completamente al di fuori della divisione dei poteri borghese, la
caricatura capitalistica della divisione sociale del processo lavorativo. Saranno questi gli studi
che Panzieri dedicherà al nesso tra razionalità, intesa come estensione delle regole insite nel
macchinario, e dispotismo, ossia struttura autoritaria gerarchica della fabbrica. Questi studi,
condotti su quella che venne definita fabbrica moderna altamente meccanizzata, la catena
di montaggio dell’impianto fordista, che caratterizzava il neocapitalismo, incrociarono, come
è noto, le analisi coeve di Friedrich Pollock sull’automazione. Cfr. F. Pollock, Automation.
Materialien zur Beurteilung der ökonomischen und sozialen Folgen, Frankfurt/Main, 1956, pp.
93 e sgg., tr. it., Automazione. Dati per la valutazione delle conseguenze economiche e sociali,
traduzione di P. Bernardini e R. Solmi, Torino, 1956, pp. 107 e sgg.
20
R. Luxemburg, Scritti politici, a cura di Lelio Basso, cit., pp. 222 e sg.
21
Ibid.
22
Ibid.
132
Cristiana Boscarelli
cui Lenin pensa non viene inculcata al proletariato soltanto dalla fabbrica ma
anche dalla caserma, anche dal moderno burocratismo, in una parola da tutto
il meccanismo dello stato borghese centralizzato».23
Non vi è, in questo schema comune alla Luxemburg e a Morandi, spazio per
la contrapposizione leniniana tra classe e partito consapevole24, non vi è nessuna
contrapposizione «tra una classe come immediatezza sociale, come massa
indifferenziata e un partito portatore della coscienza dall’esterno»25, tanto che
Morandi avverte l’esigenza di introdurre un termine medio «l’organizzazione
politica di massa che si dà autonomamente i propri obiettivi e autonomamente
esprime i propri quadri dirigenti»26.
23
Ibid. Nonostante esuli in parte dagli obiettivi che questo studio si pone segnalo come un
significativo riverbero di questo tema sarà presente nelle analisi delle strategie di integrazione
della classe operaia messe in campo dal neocapitalismo negli scritti di Panzieri a ridosso degli
anni Sessanta. È anche interessante notare il riferimento alla burocrazia, quando ancora in
Stato e rivoluzione Lenin parla di una disciplina “di fabbrica” che il proletariato estenderà alla
società una volta rovesciati gli sfruttatori, identificandola con il contenuto della dittatura proletaria, e come, diversamente, proprio Rodolfo Morandi abbia elaborato una concezione libertaria della dittatura del proletariato intesa come autogoverno della classe. Cfr. V. I. Lenin, Stato
e Rivoluzione, in Id., Opere scelte in sei volumi, vol. IV, tr. it., Roma, 1970, pp., 231- 323, p. 309;
R. Morandi. Ricostruzione socialista. Il socialismo integrale di Otto Bauer, in Id., La democrazia
del socialismo, cit., pp. 177-185. Sandro Mancini sostiene che l’assunzione della via consiliare
da parte di Morandi, l’interpretazione della democrazia come democrazia diretta e la critica
alla liquidazione stalinista del valore a autonomo della libertà, implicano una contraddizione
con le tesi della dittatura del proletariato. Egli chiarisce che se pure questa contraddizione
non è esplicita in Morandi, essa si trova alla base della sua necessità di precisare che appunto
la dittatura del proletariato ha senso solo in quanto reale autogoverno della classe. (Cfr. S.
Mancini, Socialismo e democrazia diretta: introduzione a Raniero Panzieri, cit., p. 36). Agosti
nota che Otto Bauer si occupò della concezione libertaria espressa dal Centro Interno, e che si
espresse criticamente sulla possibilità di una dittatura libertaria di massa dalle colonne della
rivista “Der Kampf” con saggi pubblicati tra il 1937 e il 1938. Un riassunto di un saggio di
Bauer dal titolo Diktatur und Freiheit in der Ideologie der Illegalen apparso su “der Kampf” nel
febbraio del 1938, fu pubblicato in Francia nello stesso anno. (Cfr. O. Bauer, Dittatura e libertà
nel pensiero dei socialisti militanti in Italia in Quaderni [di] Problemi della rivoluzione italiana,
seconda serie, Nancy, n. 3, 1938).
24
V. I. Lenin, Che fare?, in Id., Opere scelte in sei volumi, vol. I, cit., pp. 246-394, p. 275. Per
un’interessante lettura del rapporto tra la concezione luxemburgiana e quella leninista della
spontaneità cfr. S. Bologna, Composizione di classe e teoria del partito alle origini del movimento
consiliare, in AaVv, Operai e Stato. Lotte operaie e riforma dello stato capitalistico tra la rivoluzione d’Ottobre e il New Deal, Milano, 1972. In questo saggio Sergio Bologna sostiene che «quello
che per la Luxemburg era un problema di strato sociale nel partito, per Lenin era un problema
do programma, diciamo pure di statuto, del partito. La direzione operaia e rivoluzionaria
si aveva, per Lenin, vincolando i militanti a questo programma, dunque disciplinandoli alla
centralizzazione. Rosa e Lenin parlavano a due tipi diversi di classe operaia, contro due tipi
diversi di socialriformismo”. (Ibid., p. 33)
25
A. Agosti, Rodolfo Morandi, cit., p. 268.
26
Ibid.
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
133
3. I primi scritti: Il Marx di Panzieri e il marxismo teorico del dopoguerra.
Gli scritti panzieriani che per primi ci preme analizzare, risalgono a un
periodo che inizia nella metà degli anni Quaranta, sempre del secolo scorso, e
si estende per un decennio. Il tema portante è la critica alla socialdemocrazia,
unitamente dal punto di vista teorico e storico-politico, questo in modo
particolare negli scritti coevi al periodo della scissione dell’ala guidata da
Saragat, o immediatamente precedenti. Panzieri, ancora una volta concordando
con Morandi, ritiene essersi esaurita la parabola della socialdemocrazia,
nel senso specifico della maturazione della sua sconfitta storica, e tratteggia
diffusamente un parallelo tra il vecchio e nuovo revisionismo. Questo tema si
connette ad alcuni scritti, nati tra il 1944 e il 1946 che, meno legati a questioni
più immediatamente legate al dibattito interno al partito, hanno la forma di
riflessioni intorno a nodi teorico-problematici più specificamente marxiani. 27
Già in alcuni appunti della prima metà degli anni quaranta, non si
tratta infatti di scritti organici, Panzieri si sofferma su un parallelo tra i
limiti della concezione dell’emancipazione che si trova in Rousseau, la sua
contraddittorietà28, e la qualità specifica dell’emancipazione proposta da Marx.
Nel rivendicare il compito di un’ effettiva liberazione dell’umanità nell’uomo,
il marxismo investe, con la sua critica, la servitù fondamentale, che è quella
economica, ossia rivela come la fase economica dell’azione umana sia quella
che corrisponde al carattere fondamentale della civiltà borghese. Il marxismo
riconosce dunque in questa necessità dell’economia la schiavitù dell’uomo, e nel
prodursi di questo riconoscimento «il principio di liberazione dell’uomo da essa»29.
Immediatamente Panzieri sottolinea che proprio il riconoscimento - la
possibilità di pervenire a questo tipo di conoscenza - è «condizionato dal fatto
dell’esistenza di una forza, di una classe, cioè di un gruppo di azioni umane
qualificate, che lottano per l’effettiva liberazione da quella schiavitù»30. Nel
leggere l’emancipazione umana, sostiene che «la schiavitù dell’uomo nella
27
Cfr. R. Panzieri, Utopismo e marxismo 1944-46, in Id., L’alternativa socialista. Scritti scelti
1944-1956, a cura di Stefano Merli, Torino, 1982, pp. 3- 52.
28
R. Panzieri, Primi appunti, in Id., L’alternativa socialista, cit., p. 4. Panzieri legge nel
Contrat social di Rousseau, espressa nella stessa nozione di contratto «una sorta di intuizione dialettica come salto dalla necessità alla libertà: in termini religiosi come conversione, in
termini politici come rivoluzione.» (Ibid., p. 5), notando come lo stato di natura nulla abbia
più a che vedere con la condizione fondata dal contratto. Panzieri riconosce peraltro un limite
strutturale in Rousseau, quando sostiene che «Il pensiero dualistico non può che constatare la
schiavitù ma non andare oltre.» (Ibid., p. 4)
29
Ibid., p. 5.
30
Ibid.
134
Cristiana Boscarelli
sfera economica [sia] la sua schiavitù in ogni ordine di attività» e che «liberare
l’economia è liberare l’uomo stesso»31, e non a caso il carattere che egli
definisce di preminenza della rivoluzione proletaria rispetto a quella borghese impostando così il problema della relazione tra di esse – poggia sull’acquisizione
che «tutte le rivoluzioni fino alla rivoluzione borghese sono state rivoluzioni
nella sfera economica, la rivoluzione proletaria è l’uscir fuori (l’emancipazione)
dell’uomo dalla storia economica»32.
È estremamente evidente33quanto in questa sua riflessione sulla specificità
della emancipazione umana34 in Marx, siano presenti i temi caratteristici del
clima di elaborazione che ha come punto di riferimento la lettura che Galvano
della Volpe diede di Marx in quegli anni35., non vi è dubbio che quella lettura
rappresentò una alternativa alla cultura neoidealistica, e che giocò un ruolo
Ibid.
R. Panzieri, Rivoluzione borghese e rivoluzione proletaria, in Id., L’alternativa socialista,
cit., p. 11. Cfr., K. Marx, Misère de la philosophie. Réponse à la philosophie de la misère de M.
Proudhon, preface de Fr. Engels, Paris, 1950; tr. It., Miseria della filosofia. Risposta alla «Filosofia della miseria» di Proudhon, introduzione di Nicola Badaloni, Roma, 1993. Raniero Panzieri
nel 1944 faceva riferimento direttamente all’edizione originale in francese.
33
Giovanni Artero è autore di uno dei saggi più recenti su Panzieri. Egli, nell’analizzare
l’influenza del pensiero di Della Volpe su Panzieri, alla luce anche del fatto che fu proprio Della
Volpe a favorire la chiamata di Panzieri alla cattedra di Filosofia del diritto dell’Università di
Messina nel 1949, nota come in Galvano Della Volpe si trovi la tematizzazione di un punto
centrale per la problematica marxista: ossia il rapporto tra la democrazia borghese e le sue
più avanzate forme ideologiche e la democrazia socialista a partire dai riferimenti teorici più
appropriati, Kant, Rousseau, e il Marx della Questione Ebraica e della Introduzione alla critica
della filosofia del diritto di Hegel. Cfr., G.Artero, Il punto di Archimede, biografia politica di Raniero Panzieri da Rodolfo Morandi ai «Quaderni Rossi», Cernusco sul Naviglio, 2007, pp. 24-25.
34
C. Corradi, Storia dei marxismi in Italia, Roma, 2005. Corradi ci ricorda come proprio
Della Volpe ritenesse che la teoria marxiana dell’emancipazione non potesse essere confusa
con la teoria roussoviana della democrazia che concepisce «l’uguaglianza in funzione della libertà (=persona), ma non anche viceversa» (Cfr. G. della Volpe, La teoria marxista dell’emancipazione umana. Saggio sulla trasmutazione marxista dei valori, in Opere, a cura di I. Ambrogio,
Roma, 1976, vol. III, p. 312).
35
È proprio in questo periodo, precisamente il 30 Ottobre 1945, che Raniero Panzieri
discute la sua tesi di laurea, dal titolo L’utopia rivoluzionaria nel settecento, presso la facoltà
di giurisprudenza dell’Università di Urbino, relatore Arturo Massolo. Sulla scorta di questi
studi lo stesso Panzieri si sofferma sulle differenze tra Rousseau e gli utopisti e riformatori
del settecento, ponendo l’accento su come la novità del primo stia proprio in un’impostazione
larvatamante dialettica del problema politico, che seppure infinitamente meno consapevole
dello storicismo hegeliano, come quello non può non risolversi in una diversa teologizzazione,
sostituendo ad una «teologizzazione della ragione un teologismo della storia». (R. Panzieri,
Utopismo e Marxismo in Id., L’alternativa socialista, cit., p. 3).
È interessante, sempre nella ricostruzione del quadro culturale nel quale si mosse il giovane Panzieri, ricordare che il Nostro prese parte al “Convegno di studi hegeliani-marxisti”, che
vide, tra gli altri, la partecipazione di «Della Volpe, che lesse una comunicazione su l’equivoco
ideologico del socialriformismo, Arturo Massolo con la relazione Schema per una discussione
del rapporto Hegel-Marx, Ugo Spirito, e Sebastiano Timpanaro».(G. Artero, Il punto di Archimede, biografia politica di Raniero Panzieri da Rodolfo Morandi ai «Quaderni Rossi», cit., p. 26.)
31
32
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
135
importante nella rinascita di un certo marxismo teorico36, proprio nell’avocare
a Marx un’autonoma problematica filosofica, individuando all’interno del
marxismo un «luogo teoretico specifico»37 scevro di residui ideologici38.
Accentua indubbiamente la distanza di Della Volpe da Panzieri sottolineare
che gli esiti della lettura dellavolpiana di Marx, nella messa in discussione
dell’idealismo hegeliano, coinvolgono la stesso marxismo inteso come filosofia
della prassi, e attraverso l’abbandono del «dispositivo teorico costruito attraverso
l’interpretazione del pensiero di Gramsci come storicismo»39, pervengono alla
lettura del marxismo come scienza.40
Soffermandoci però unicamente sul dettaglio dei legami tra l’elaborazione
di Raniero Panzieri e il marxismo di Della Volpe e solo da questa prospettiva
allargando lo sguardo alla più generale vicenda del marxismo degli anni
sessanta41, registriamo che se indubbiamente una certa parte della riflessione
di Della Volpe, e di una parte della sua scuola rappresentata da Colletti, abbia
tematizzato, in luogo di uno smascheramento della socialdemocrazia, il
legame tra certe suggestioni di democrazia diretta di ascendenza roussoviana
e la problematica del controllo operaio42, che pure è terreno privilegiato
dell’intervento panzieriano recante il segno della continuità morandiana,
occorre segnalare la distanza tra queste prospettive e quella in cui si muovono
Panzieri e Morandi. In tal senso recepisco, tra le altre le indicazioni di Fugazza43,
secondo la quale gli elementi a sostegno di una sostanziale omogeneità del
quadro del marxismo degli anni Sessanta si presentano decisamente generici,44
Cfr. C. Corradi, Storia dei marxismi in Italia,. cit., pp. 95-105.
M. Fugazza, Il marxismo nel dopoguerra. La rivista «Società», in «Classe», cit., p. 22.
38
Stefano Merli sostiene che l’influenza dellavolpiana su Panzieri vada limitata alla pars
destruens, intendendo con ciò l’operazione di deideologizzazione del marxismo, e che invece
ben oltre questo punto di convergenza, vada tenuta di conto la distanza tra l’enfatizzazione
della subordinazione della classe al partito che contraddistingue Della Volpe, e la divaricazione operante nello stesso di tattica e strategia. In definitiva Merli rimarca come sia operante in
Panzieri una concezione del marxismo che chiaramente non si riduce a scienza analitica ma si
dà come scienza della lotta, e che questo momento sì propriamente rappresentato dall’innesto
morandiano. Cfr. S. Merli, Introduzione a S. Mancini, Socialismo e democrazia diretta, cit., pp.
10-11; M. Alcaro, Dellavolpismo e nuova sinistra, Bari, 1977.
39
G. Lissa, Il marxismo italiano tra scienza e filosofia, in Aa.Vv., La cultura filosofica italiana
dal 1945 al 1980, Napoli, 1982, p. 229.
40
Ibid., p. 229. Più avanti Lissa traccia un quadro sintetico del percorso attraverso il quale
si perviene, attraverso molteplici contributi tra i quali Della Volpe, Colletti, Banfi, Cases, ad
una vera e propria revisione dello statuto teorico del marxismo.
41
Interessante, sempre nella ricostruzione critica del dibattito marxista , questa volta evidentemente dal punto di vista di quello che era il marxismo ufficiale. Cfr. N. Badaloni, Il marxismo italiano degli anni sessanta, Roma, 1971.
42
Ibid., p. 47.
43
Cfr., M. Alcaro, Dellavolpismo e nuova sinistra, cit.
44
M. Fugazza, Dellavolpismo e nuova sinistra. Sul rapporto tra i «Quaderni Rossi» e il mar36
37
136
Cristiana Boscarelli
alla luce della «contrapposizione tra l’intellettualismo dellavolpiano e la
rottura dei Quaderni Rossi con quella stessa ipotesi d’uso della teoria che esso
poteva rappresentare»45. Ritengo che gli elementi portati a supporto di questa
lettura siano validi al di là dell’esperienza dei Quaderni rossi e coinvolgano
complessivamente l’elaborazione di Raniero Panzieri, le cui acquisizioni degli
anni Quaranta e Cinquanta, reagendo con le mutate condizioni politiche e
socio-economiche maturate con gli eventi determinatesi a partire dal 1956
apriranno al suo apporto più originale.
4. L’Ideologia, lo Stato e gli istituti autonomi del proletariato.
Una acuta sensibilità classista sostanzia già le critiche panzieriane alle
enunciazioni del valore universale della libertà che ritroviamo negli scritti
della metà degli anni quaranta, gli unici scritti, oltre a quelli che costituirono
l’oggetto delle lezioni universitarie da lui tenute all’Università di Messina,
che non nascono nel cuore della lotta politica per quanto, come nota Stefano
Merli46, si inseriscano comunque nel clima culturale di una nuova generazione
di sinistra portatrice di un marxismo alternativo rispetto alle interpretazioni
deterministiche e umanistiche ma anche altro rispetto a quello della terza
internazionale.
È interessante notare come in questi scritti Panzieri passi da una riflessione
sulla presenza del pensiero ideologico anche nel proletariato ad un parallelo
tra la posizione dello Stato nella società borghese e la posizione della cultura.
Soffermandosi sull’accezione di ideologia in Marx, Panzieri distingue due
sensi di essa: da una parte il pensiero si definisce ideologico allorché, riflettendo
comunque la dominazione di una classe, esso ignora di fatto, o pretende di
xismo teorico, in «Aut Aut», n. 149/150, 1975, speciale Panzieri e Quaderni Rossi, p. 128.
45
Ibid., p. 125. Tenendo di conto questo saggio, e considerando più specificamente la produzione panzieriana degli anni dei Quaderni Rossi, Giuseppe Lissa così tratteggia l’operazione
panzieriana: «l’esigenza centrale di questa corrente del marxismo è essenzialmente politica.
Non è il problema filosofico della dialettica, del rapporto teoria-prassi, a mettere in moto il
processo di conoscenza, né è il primato della prassi, dialetticamente mediato da altre esigenze
non pratiche, a costituire il risultato di tale processo. È invece l’esigenza immediata dell’intervento pratico, dell’organizzazione e della lotta, a far sì che la conoscenza sia una semplice
funzione dell’iniziativa politica della classe dominata (…) l’istanza del marxismo come scienza
viene rovesciata e radicalizzata nel marxismo come politica.»( G. Lissa, Il marxismo italiano
tra scienza e filosofia,. cit., pp. 249-250. Emilio Agazzi nell’introduzione al saggio di Mario
Alcaro sottolinea a sua volta la mancanza in Della Volpe di una precisa finalità operativa rintracciando «l’incapacità di usare la riscoperta teorica di Marx da lui stesso proposta come strumento di interpretazione scientifica della realtà odierna in una prospettiva di trasformazione
pratica». (Cfr. E. Agazzi, Introduzione a Dellavolpismo e nuova sinistra, cit., p. 9).
46
S. Merli, Introduzione a L’alternativa socialista, scritti scelti 1944-1956, cit., p. IX-XIII.
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
137
ignorare, la contraddizione, dall’altra è ancora ideologico il pensiero che
«prende coscienza della contraddizione e vuole risolverla da sé e in sé»47, sicché
«esso ha coscienza della contraddizione in genere, una confusa e imperfetta
coscienza»”48.
Panzieri si interroga su quanto un pensiero che abbia preso marxisticamente
coscienza della contraddizione sia ancora ideologia, pervenendo alla conclusione
che sempre vi è la possibilità di una ideologia di «marca proletaria»49: se infatti
il proletariato è lo strumento della emancipazione questa emancipazione non è
compiuta ad opera del pensiero, e di più, «un pensiero libero, non ideologico,
non è un pensiero che prende coscienza delle contraddizioni della realtà, ma un
pensiero che corrisponde ad una realtà a cui siano state tolte le contraddizioni
economiche»50.
Ci sembra di capire dunque che, se l’ideologia si configura come falsa
coscienza si pone comunque la problematicità di un pensiero che, seguendo la
prassi ed essendo determinato da questa, è sempre esposto alla falsa coscienza
(o ideologia) fintanto che si produce entro condizioni alienate. Quali sono
dunque le condizioni di possibilità di un pensiero libero, non alienato, stante le
contraddizioni economiche della società in cui esso si produce?
Esse risiedono nella prassi, risponderà Panzieri in tutto il suo percorso,
seguendo la lezione morandiana, negli istituti del proletariato, così come la
libertà socialista sarà da fondare unicamente negli ordinamenti socialisti di vita.
Gli elementi che caratterizzano questo passaggio matureranno in Panzieri,
ma sembra di potere scorgere un preciso filo di ragionamento: se il passaggio
ad un modo di produrre le proprie condizioni di vita in forma non alienata si
presenta come una transizione, nella quale il proletariato costruisce, comincia
a costruire i suoi propri istituti - questo ad ogni livello, dalla produzione alla
cultura- e, in questi istituti, attraverso l’esercizio costante della critica, educa se
stesso, allora la teoria e la prassi non si scindono e il marxismo recupera nella
critica delle ideologie la sua forza di emancipazione.51
È interessante su questo tema il confronto con uno scritto di Morandi, una
prolusione al corso di cultura marxista tenuto alla federazione di Milano nel
1952, in cui, all’interno di un ragionamento su politica e cultura, egli sostiene
R. Panzieri, Accezione marxista dell’ideologia, in Id., L’alternativa socialista, cit., p. 8-9, p. 9.
Ibid. Il corsivo è dell’autore.
49
Ibid.
50
Ibid.
51
Cfr., R. Panzieri, Sette tesi sulla questione del controllo operaio, in Id., La crisi del movimento operaio. Scritti, interventi, lettere, 1956-1960, a cura di Dario Lanzardo e Giovanni
Pirelli, Milano, 1973, pp. 104-117.
47
48
138
Cristiana Boscarelli
che «l’ideologia marxista non costituisce per se stessa un fatto di coltura, non
appartiene al mondo della coltura, nel senso che essa non è una proiezione
mediata, attraverso l’elaborazione astratta di pensiero, degli interessi e dei
moventi che sono connessi alla evoluzione dei rapporti sociali. L’ideologia
marxista è piuttosto lo strumento di rottura con la coltura di classe, [del quale
si munisce] la parte più consapevole del proletariato costituendosi in partito di
classe52. È un atto primigenio di lotta che incorporandosi nell’azione concresce
con l’esperienza e la processualità di questa lotta»53.
52
Morandi si addentra in questo testo in una dura discussione circa il rapporto tra ideologia marxista e cultura. Il fortissimo richiamo al leninismo che serpeggia in queste pagine, i
toni indubbiamente diversi da quelli che caratterizzano gli scritti degli anni trenta e quaranta,
non devono però trarre in inganno. Senza addentrarsi nella analisi della difficile fase del lavoro del gruppo morandiano negli anni bui della guerra fredda, occorre sottolineare come qui
l’intento precipuo sia quello di affermare l’autonomia conoscitiva del proletariato e la specificità
degli strumenti, delle modalità che la classe si dà. Il processo di chiarificazione ideologica nel
marxismo non avviene infatti «nella sfera astratta pensiero, ma nella realtà viva sociale».( R.
Morandi, Ideologia marxista e partito della classe,in Id., Il partito e la classe 1948-1955, Torino,
1961, pp. 264-281, p. 274). Resta sempre vero che per Morandi prima del partito vi è la classe:
opera in lui una concezione che vede nelle lotte unitarie di massa il nesso con l’azione anticapitalistica, ed in questo quadro la critica all’irrigidimento dogmatico del marxismo resta comunque una chiave di interpretazione valida. Certamente però emerge in Morandi una diversa
esigenza nel periodo coevo a questo scritto, che Agosti in un passaggio così chiarisce: «se fino
a questo momento Morandi si era limitato ad affermare l’esigenza di un rapporto unitario con
i comunisti fondato sul terreno delle lotte (…)ora egli intende dare una giustificazione e una
conferma della politica unitaria anche sul piano ideologico»(A. Agosti, Rodolfo Morandi, cit.,
p. 446). Morandi infatti sostiene che le differenze tra socialisti e comunisti non sono da rintracciare in campo ideologico, dove la comune adesione al leninismo costituisce un elemento
di omogeneità, bensì nelle condizioni storiche e ambientali nelle quali si determina l’azione
dei due partiti. Ma, se l’adesione al leninismo sta per la rottura con la socialdemocrazia e la
riconquista dell’autonomia del partito della classe rispetto alla borghesia, allora è chiaro che
si pongono problemi rispetto alla subalternità al partito comunista e le metodologie staliniane.
Eppure le motivazioni di adesione al leninismo sono così precise, e tra esse determinante è
l’assunzione dell’innovazione di Lenin rispetto a Marx della necessità di concepire il partito
come forma organizzata, che fanno sostenere ad Agosti che, seppure siano ipotizzabili motivazioni tattiche di adesione al leninismo, permangono certamente in Morandi motivazioni
più profonde, sullo sfondo però di un equivoco non sciolto tra leninismo e stalinismo, che accomuna il marxismo europeo di quel periodo. Peraltro in Rosa Luxemburg, che funziona qui
come riferimento teorico rispetto a Morandi, non opera, come bene ha chiarito Oskar Negt,
alcuna contrapposizione tra organizzazione e spontaneità proprio perché «esse non stanno
tra loro in un rapporto esteriore, bensì contengono una loro dialettica immanente; se si cerca
di isolarle l’una dall’altra o di stabilire tra di esse una piatta identità, risulta che esse nel loro
movimento storico possono trasformarsi nel loro contrario». (Oskar Negt, Rosa Luxemburg
e il rinnovamento del marxismo, in Storia del Marxismo, cit., p. 343 e sg.) L’organizzazione è
per Rosa Luxemburg una forma di mediazione tra essere sociale e coscienza: «Organizzazione,
partito, socialdemocrazia: sono gradi di mediazione cui si adeguano le teorie rivoluzionare del
movimento operaio,in cui si rendono coscienti le attività rivoluzionarie delle masse e cui si
riferisce ogni singolo passo di movimento reale verso l’obiettivo finale, la caduta del dominio
di classe.»(R. Luxemburg, Riforma sociale o rivoluzione?, prefazione di Lelio Basso, Roma,
1976, p. 7)
53
R. Morandi, Ideologia marxista e partito della classe,in Id., Il partito e la classe 1948-1955,
cit., p. 268.
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
139
Negli anni del dopoguerra Panzieri si inserisce nel dibattito esistente in
Italia sulla definizione e l’individuazione dei compiti della cultura marxista,
sono gli stessi anni in cui, all’interno del partito socialista, si consuma la
scissione saragattiana.
In un momento in cui all’ordine del giorno sembra essere il rinnovamento
culturale, Panzieri è impegnato in una critica serrata che coinvolge le illusioni
di una cultura marxista che non pienamente cosciente della propria autonomia
pensa di potere innestarsi sul tronco della tradizione liberale e radicale italiana,
che egli inquadra come un fenomeno caratteristico di una cultura piccoloborghese incapace di ogni partecipazione diretta alla realtà storica. In questo
senso sono fortemente avversate le tesi che assegnano all’opera crociana una
funzione demistificatrice, esse al più costituiscono il simulacro di illusioni che
non hanno retto il confronto con la storia.54
Segnatamente Panzieri lamenta che «anche gruppi intellettuali socialisti e
comunisti evidentemente si muovono, e con un alto grado di inconsapevolezza,
entro la nube ideologica in cui li ha posti la grande cultura, di cui accettano
dogmaticamente l’eredità (…) per cui se da una parte si giunge a discorrere
di una eredità della cultura liberale che dovrebbe essere fatta propria dal
movimento operaio (…)si propone dall’altra parte(…)una “nuova sintesi” di
cultura, per la quale si offrono i più comuni e rozzi materiali della tradizione
piccolo-borghese e si mettono in moto tutte le intelligenze della bohème»55.
Panzieri, citando la lettera del testo marxiano56, si riferisce a quelle correnti
di intellettuali che, proponendo innovazioni nella continuità con la tradizione,
ricoprono il ruolo di una opposizione interna nella classe dominante dovuta
alla vigente divisione del lavoro, ma che mai può essere produttiva di nessuna
modificazione reale, poiché nell’imminenza di un conflitto pratico cadono le
illusioni che queste posizioni siano qualcosa d’altro se non precisamente le
idee delle classi dominanti, e che possano seguire un’altra forza d’agire. Nello
specifico il riferimento è ad un «legame permanente che collega ogni strato
della cultura borghese (…) che ancora una volta ha chiaramente operato nel
caso del fascismo»57, dal che Panzieri desume che solo una adesione esclusiva ai
54
R. Panzieri, Cultura borghese, in Id., L’alternativa socialista, cit., pp. 87-89. Panzieri fa
riferimento alle illusioni di Gobetti su Croce.
55
R. Panzieri, Nuova cultura, in Id., L’alternativa socialista, cit., p. 93.
56
K. Marx – F. Engels, Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in
ihren Repräsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen
verschiedenen Propheten (1845), in K. Marx – F. Engels, Werke, cit., Bd. 3, p. 47; tr. it. di Fausto Codino, L’ideologia tedesca. Critica della più recente filosofia tedesca nei suoi rappresentanti
Feuerbach, B. Bauer, e Stirner, e del socialismo tedesco nei suoi vari profeti, Roma, 1958, p. 36.
57
R. Panzieri, Nuova cultura, in Id., L’alternativa socialista, cit., p. 94.
140
Cristiana Boscarelli
valori del proletariato, ossia la sua emancipazione, crea realmente le condizioni
per una nuova cultura.
Panzieri interpreta la funzione della cultura marxista come un veicolo di
approfondimento delle contraddizioni della cultura italiana, sulla quale ricade
il precipuo compito di «portarla a qual limite in cui la conoscenza ristabilisce
l’uomo in tutti i suoi diritti (…) nella sfera concretamente universale della
coscienza di classe.»58
L’intervento di Panzieri in merito ai rapporti tra rinnovamento della cultura
e marxismo è caratterizzato, negli scritti che stiamo esaminando, dal legame
istituito tra il «rifiuto del marxismo volgare di ispirazione materialisticopositivistica [e il ] rifiuto più profondo, di qualsiasi revisionismo e quindi anche
di quello idealistico».59
Panzieri si richiama a Gramsci60 nel sostenere che «la filosofia della prassi
non ha bisogno di sostegni eterogenei, essa stessa è così robusta e feconda di
nuove verità che il vecchio mondo vi ricorre per fornire il suo arsenale di armi
più moderne ed efficaci»61.
L’autosufficienza del marxismo è individuata da Panzieri nella coscienza che
esso ha raggiunto del «fondamento assolutamente storico della sua rottura con
58
Ibid., p. 97. Questa posizione, che viene sviluppata da Panzieri in connessione con la
polemica verso la partiticità della cultura, e che fa appello da questo preciso orizzonte alla
nozione di autonomia della cultura, sarà successivamente, come nota anche Sandro Mancini,
in parte rivista dallo stesso. Cfr., S. Mancini, Socialismo e democrazia diretta, cit., p. 49 e ssg.)
59
Tutto il procedere dell’argomentazione panzieriana di questi scritti tiene presente il tema
gramsciano della filosofia della prassi come veicolo di una integrale civiltà Cfr. A. Gramsci,
Concetto di ortodossia (Q11), in Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, nuova
edizione riveduta e integrata sulla base dell’edizione critica dell’Istituto Gramsci, a cura di V.
Gerratana, Roma, 1975, p. 199.
60
Nell’articolo cui si fa riferimento Panzieri è sollecitato alla discussione all’interno di un
dibattito con Ernesto De martino, aperto da alcuni articoli da lui scritti su L’Avanti. Siamo
tra l’agosto e il settembre 1949, ed è ben visibile la vivace impressione che la lettura dei testi
gramsciani, portati recentemente a conoscenza, doveva aver prodotto su Panzieri. È facile rinvenire nel testo panzieriano l’eco della riflessione gramsciana su filosofia della prassi e cultura
moderna. «La filosofia della prassi è diventata anch’essa “pregiudizio”, “superstizione”; così
come è, è l’aspetto popolare dello storicismo moderno, ma contiene in sé un principio di superamento di questo storicismo (…)L’affermazione che la filosofia della praxis è una concezione
nuova, indipendente, originale, pur essendo un momento dello sviluppo storico mondiale, è
l’affermazione della indipendenza e originalità di una nuova cultura in incubazione che si svilupperà con lo svilupparsi dei rapporti sociali»(A. Gramsci, La filosofia della prassi e la cultura
moderna (Q. 16), in Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, cit., pp. 107-109).
61
Ibid., p. 200. Significativamente questo passaggio è preceduto da un’analisi della funzione della separazione della filosofia della prassi rispetto alle altre filosofie. «Una teoria è appunto
“rivoluzionaria” nella misura in cui è elemento di separazione e distinzione consapevole in
due campi, in quanto è un vertice inaccessibile al campo avversario. Ritenere che la filosofia
della prassi non sia una struttura di pensiero completamente autonoma e indipendente, in
antagonismo con tutte le filosofie e le religioni tradizionali, significa in realtà non aver tagliato
i legami con il vecchio mondo, se non addirittura aver capitolato». (Ibid.) .
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
141
le ideologie e della fondazione di una vera scienza dell’uomo, una scienza non
più limitata nell’estensione e nella qualità ma estesa a tutti i campi dell’attività
moderna e perciò resa critica da questa concreta universalità»62, in questo senso
-come abbiamo visto sulla scorta di Gramsci- Panzieri sostiene che invece sia il
vecchio mondo a ricorre al marxismo per appropriarsi di armi più moderne ed
efficaci, e a questa operazione riconduce quella fatta da Croce63, precisando che
se la storia della più recente cultura è comandata dall’esigenza storicistica, «è
soltanto nel materialismo storico che tale esigenza trova il suo fondamento»64.
Panzieri rileva dunque come, per il marxismo, sia imprescindibile la critica
di quello che definisce lo pseudo-storicismo crociano, individuando in esso un
momento di lotta alle ideologie, in questo senso infatti «il materialismo storico
si presenta sul piano teorico come salto e rottura, e il momento della continuità
che ad esso certo appartiene, va cercato in una zona più profonda che non
siano i legami e i rapporti di filiazione diretta delle ideologie. L’instaurazione
del nuovo nesso - concretamente operante non semplicemente asserito – del
nesso teoria-prassi sommuove sconvolge tutti gli schemi teoretici tradizionali
e conduce ad una concezione completamente nuova della cultura, per la
quale i rapporti dei suoi vari campi tra loro e con le attività pratiche vengono
sottratti alla deformazione ideologica e finalmente restituiti ad una oggettiva
umana verità»65. La critica dello storicismo crociano si comprende come difesa
dell’autonomia del marxismo, autonomia dal pensiero ideologico borghese,
difesa del marxismo dal tentativo di innesto dello storicismo idealistico nella
cultura marxista66.
Centrale nell’affermare l’autonomia teorica del marxismo è chiaramente la
critica al revisionismo, e il materiale panzieriano relativo nasce nel confronto
politico-teorico con Saragat e la sua corrente all’interno del partito socialista67.
R. Panzieri, Scilla e Cariddi, in, L’alternativa socialista, cit., p. 98.
Ibid. «il crociano civettare con lo storicismo è in immediato rapporto con la sua specifica funzione ideologica nella più recente storia del mondo borghese, in quanto illusoria
assimilazione e falso superamento del marxismo»(Ibid.) Essa costituirebbe null’altro se non
«l’interessato omaggio presentato alla filosofia della prassi al fine di ottenere quell’apparente
trionfo di cui la classe dominante ha necessità per il mantenimento della propria ideologia
culturale». (Ibid., p. 98 e sg.)
64
Ibid.
65
Ibid., p. 100.
66
Cfr., G. Artero, Il punto di Archimede, cit., p. 37.
67
Dall’11 al 16 Aprile 1946 si svolse a Firenze il XXIV congresso nazionale del Psiup (nome
assunto nell’Agosto 1943, venuto fuori dalla fusione tra il PSI e il movimento di unità proletaria di Lelio Basso). I rapporti tra il partito comunista e il partito unico della classe operaia e
il dibattito tra socialismo “umanista” e socialismo “classista” furono tra i temi principali del
dibattito.
62
63
142
Cristiana Boscarelli
Nello scritto Osservazioni a un nuovo revisionismo68 Panzieri sostiene che
sul piano teorico il revisionismo di Saragat si presenta come eclettico, una
combinazione del revisionismo classico europeo69ed italiano e una ripetizione
di certi temi dell’austromarxismo.
A quello che Panzieri definisce il patrimonio comune del revisionismo
è da riferirsi la concezione idealistica o universalistica del socialismo;
segnatamente Bernstein, nel celebre I presupposti del socialismo e i compiti
della socialdemocrazia70, alla domanda che cosa è la democrazia? risponde in
sequenza con queste definizioni: governo del popolo, qualcosa di più che una
forma di governo- assenza del dominio di classe- ossia assenza di un privilegio
di un classe rispetto ad un’altra. Bernstein rigetta dunque come inadeguato al
concetto stesso di democrazia moderna quello di oppressione di una maggioranza
sull’individuo, su una minoranza, che indica invece come caratteristico delle
correnti del blanquismo, e sottolinea come «nel concetto di democrazia [sia]
implicita, proprio in relazione alla concezione odierna, una rappresentazione
giuridica, ossia l’uguaglianza dei diritti di tutti i membri della comunità, nella
quale trova i suoi limiti quel governo della maggioranza in cui si risolve in
ogni caso concreto il governo del popolo. Quanto più quell’uguaglianza diventa
il clima naturale, e domina la coscienza generale più la democrazia diventa
sinonimo di massimo grado di libertà per tutti.»71.
In questo senso Bernstein si preoccupa di specificare che ciò che differenzia
la democrazia dagli altri sistemi politici non è l’assenza di leggi, ma di quelle leggi
che «ratificano privilegi fondati sulle proprietà, sulla estrazione sociale e sulla
confessione religiosa»”72, di quelle leggi che «limitano l’universale uguaglianza
giuridica»73. La democrazia in Bernstein è al tempo stesso «il mezzo della lotta
per il socialismo ed è la forma della realizzazione del socialismo»74.
Nel tentativo di eludere la contraddizione esistente tra astrattezza formale
dei diritti del cittadino e condizione di disuguaglianza reale degli individui
68
R. Panzieri, Osservazioni a un nuovo revisionismo in Id., L’alternativa socialista, cit., pp.
54-62.
69
Per uno studio attento sul dibattito marxista della seconda internazionale Cfr. L. Colletti,
Bernstein e il marxismo della seconda internazionale, Introduzione a E. Bernstein, I presupposti
del socialismo e i compiti della socialdemocrazia, traduzione di E. Grillo, Roma-Bari, 1968,
pp.VII-LXXXII., ora in Id., Ideologia e società, Roma-Bari, 1975, pp. 61-145
70
E. Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Soazialdemokratie, Stuttgart, 1899, p. 122 ; tr. it , I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia,
cit., p. 183.
71
Ibid. p. 192, tr. it., pp. 183 e sg.
72
Ibid. p., 193, tr. it., p. 184.
73
Ibid. ,p.194, tr. it., Ibid.
74
Ibid. p.194, tr. it. p. 185.
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
143
nella società Bernstein introduce l’esigenza di una distinzione tra il «concetto
di cittadino pieno di diritto di una comunità» e il concetto di «cittadino
privilegiato»75, sostenendo che l’inesistenza di termini appropriati nella lingua
tedesca per questa distinzione concettuale, che è invece annullata dalla comune
denominazione borghese, sia al tempo stesso tanto un inconveniente quanto
una fonte di equivoci, essendo l’obiettivo principale della socialdemocrazia
quello di «elevare il lavoratore dalla condizione sociale di proletario a quella di
cittadino e quindi generalizzare il sistema civile [buergerthum] o la condizione
di cittadino [buergersein]»76 .
La socialdemocrazia, nella declinazione bernsteiniana, mira dunque non
a sostituire alla società civile una società proletaria, ma a sostituire all’ordine
sociale capitalistico un ordine sociale socialista, i cui contenuti in sintesi sono
immortalati da Bernstein nella definizione del socialismo come liberalismo
organizzatore.77
Ci siamo soffermati su questo aspetto delle teorie sviluppate da Bernstein,
prima che su altri elementi caratteristici del dibattito sul revisionismo per
la particolare rilevanza che riveste il confronto tra il concetto di democrazia
elaborato da Bernstein e il concetto di democrazia elaborato da Panzieri, e più
in generale dal quello che viene definito socialismo di sinistra.
Lucio Colletti, sempre nel famoso saggio introduttivo al testo di Bernstein
cui stiamo brevemente facendo riferimento, nel ricostruire i presupposti
75
Così replica Rosa Luxemburg a Bernstein nella sua recensione a I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia, imputandogli la rinuncia alla lotta contro il modo di
produzione capitalistico attraverso la lotta contro la ripartizione capitalistica: «la prima spinta
verso il movimento socialdemocratico, almeno nelle masse popolari, viene anche dalla “ingiusta” ripartizione dell’ordinamento capitalistica. E lottando per la socializzazione dell’economia nel suo complesso, la socialdemocrazia tende naturalmente anche a una “giusta” ripartizione della ricchezza sociale. Soltanto – grazie alla conoscenza raggiunta da Marx che in ogni
momento la ripartizione è solo la conseguenza naturale della forma di produzione di quel
momento- essa non indirizza la sua lotta verso la ripartizione nel quadro della produzione
capitalistica, bensì verso la soppressione della stessa produzione mercantile. La socialdemocrazia vuole insomma introdurre la ripartizione socialista mediante l’abolizione del modo di
produzione capitalistico; il procedimento bernsteiniano è invece esattamente l’opposto: esso
vuole combattere la ripartizione capitalistica e spera in questo modo di introdurre gradatamente un modo di produzione socialistico.(…) La ripartizione più giusta di Bernstein deve
quindi attuarsi grazie ad una libera volontà dell’uomo, che non sarà asservita ad una necessità
economica; o più precisamente, dal momento che una volontà non è altro che uno strumento,
grazie alla comprensione della giustizia, in breve grazie all’idea della giustizia.»( R. Luxemburg, Sozialreform oder Revolution?: mit einem anhang : Miliz und Militarismus, Berlin, 1967,
p. 27 tr. it., Riforma sociale o rivoluzione?, in Scritti scelti, a cura di L. Amodio, Milano, 1963,
pp. 135-230, p. 199 e sg.)
76
Ivi, p. 190.
77
E. Bernstein, Die Voraussetzungen des sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie,
cit., p.132, tr. it.,Id., I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia, cit., p. 194.
144
Cristiana Boscarelli
politico- sociali del revisionismo marxista e le aspettative riposte nelle
prospettive del suffragio universale in Germania, si sofferma su come l’avere
scelto - da parte della socialdemocrazia - ad Erfurt la via parlamentare non
fosse già immediatamente l’abbandono della concezione classista dello stato,
quanto piuttosto questa fosse la conseguenza di quella sua «fiducia “fatalistica”
e “provvidenziale” nel progredire automatico dell’evoluzione economica, che
dava la certezza del compiersi, attraverso un processo spontaneo, fisiologico,
della presa del potere come portato naturale della evoluzione economica».78
Secondo questa lettura è proprio «l’oggettivismo naturalistico che
contrassegna questo concetto di “evoluzione e economica” [ed] è ciò che svuota
di senso la teoria marxiana dello stato»79.
Uno tra gli elementi che sono messi in evidenza da Colletti è che, nella
variante socialdemocratico-revisionista, «il potere diviene indifferente a ogni
L. Colletti, Bernstein e il marxismo della seconda internazionale, cit., pp. LXXVII-LXXVIII.
Ibid., p. LXXVIII. Colletti sottolinea che la concezione dello stato caratteristica del
marxismo della seconda internazionale è quella espressa da Engels nel saggio L’Origine della
famiglia della proprietà privata e dello stato (F. Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateingentums und des Staats: im Anschluss an Lewis H. Morgans Forschungen, Berlin, 1984, tr. it.,
L’origine della famiglia della proprietà privata e dello stato: in rapporto alle indagini di Lewis H.
Morgan, Roma, 1993). In questo luogo, secondo Colletti avverrebbe una generalizzazione dei
«caratteri specifici dello stato rappresentativo moderno allo stato in genere». In questo luogo
avverrebbe una generalizzazione dei «caratteri specifici dello stato rappresentativo moderno
allo stato in genere»(Ibid.), che prescinde dall’epoca storica e dal regime sociale ed economico,
con la conseguenza che lo Stato non viene spiegato come un prodotto organico di una particolare società, ma come un travestimento, un inganno «consapevolmente perseguito dalle
classi dominanti»(Ibid.). Si opera in tal modo il passaggio ad una concezione volontaristica, che vede nello stato un prodotto intenzionale della classe dominante. Così sottratto alla
particolare struttura economico-sociale capitalistica, la forma dello stato diviene indifferente
al tipo dei rapporti sociali cui presiede. Questa precisa puntualizzazione di Colletti, che nei
suoi intenti coinvolge il complesso del marxismo della seconda internazionale, ossia anche
gli approdi - per altri versi differentissimi - delle elaborazioni di Rosa Luxemburg, sembrano
illuminanti in sintonia con l’approccio di Raniero Panzieri, nei passaggi che, se pure in termini
differenti, chiamano in causa la non neutralità della forma stato specifica del capitalismo, che
è un passaggio imprescindibile per pervenire alla critica alla neutralità delle forze produttive,
e dell’uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo. In particolare sono da sottolineare
gli studi panzieriano degli anni Sessanta su Stato e pianificazione. Ad un dato punto – osserva
Panzieri - si pone il problema della pianificazione dello sviluppo e l’agente fondamentale di
questa diviene lo Stato: «Quindi lo Stato non è più un guardiano , per così dire neutro per i
capitalisti, cui ricorrere per comporre i loro conflitti, ma lo stato diventa rappresentante in
prima persona degli interessi del capitale , gestisce in prima persona gli affari del capitale.»
(R. Panzieri, Lotte operaie nello sviluppo capitalistico, in Id., Spontaneità e organizzazione, cit.,
p. 86). Il riferimento di Panzieri è al neocapitalismo che come stadio di sviluppo avanzato
del capitalismo stesso tende a integrare sfere che nei primi stadi di sviluppo si presentano
maggiormente indipendenti fra loro. Proprio in riferimento all’intero processo di sviluppo del
capitalismo è interessante lo stesso Marx che sottolinea il nesso forma – specificità delle forze
produttive. Cfr, K. Marx – F. Engels, Die deutsche Ideologie, in K. Marx – F. Engels, Werke, cit.,
Bd. 3, pp. 64-65 (tr. it. cit., pp. 61-62).
78
79
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
145
contenuto di classe»80; proprio quest’ultimo elemento ci sembra importante
rispetto all’istanza specifica di fondo che muove la critica di Panzieri al
revisionismo socialdemocratico e che gli consente di stigmatizzare tanto la
versione saragattiana del richiamo proletario alla realizzazione dei valori
universali tanto la subordinazione del socialismo alla democrazia che è
presente in Kautsky81, senza rinunciare a qualificare diversamente la relazione
tra democrazia e socialismo.
Panzieri nota che proprio sul tema della continuità tra il socialismo e la
democrazia repubblicana e sulla inconciliabilità di democrazia e rivoluzione
sono evidenti nel revisionismo di Saragat elementi del riformismo francese di
Millerand ed echi del socialismo umanista francese nel suo complesso.82
Se è riscontrabile in Panzieri l’istanza verso il recupero della componente
soggettiva della rivoluzione, e precisamente la contrapposizione del socialismo
come teoria del proletariato rivoluzionario rispetto ad un processo che si
rivela essere nulla più di un “astratto processo di rovesciamento teorico
pratico”83, il contesto entro cui questa avviene è precisamente quello di un
esame della continuità storica del revisionismo sul piano stesso delle dottrine,
di disvelamento del suo contenuto politico generale che è la negazione del
proletariato come portatore di valori autonomi.
L’essenza del revisionismo socialdemocratico è caratterizzata dalla credenza
che «il capitalismo sia fondamentalmente progressivo e che perciò si possa
fare affidamento sulla grande borghesia»84, questo è precisamente il senso del
L. Colletti, Bernstein e il marxismo della seconda internazionale, cit., p. LXXIX.
K. Kautsky, Die Dictature des Proletarians, Hrsg. von H-J Mende, Bd. 1, Berlin, 1990,
(prima ed. 1918); tr.it., Id, La dittatura del proletariato, Roma, 1977.
82
Cfr. A. Millerand, Le socialisme riformiste francais, Paris, 1903, tr. it., Il socialismo riformista francese, traduzione e note critiche di J. Jaures, prefazione E. Vandervelde, Roma, 1903.
Tratto comune a tutta l’ideologia umanista, nella quale è ben radicata la tradizione del socialismo francese è, successivamente all’enunciazione di fede marxista, il porre l’analisi marxista
«su un piano astrattamente ideologico, considerandola come un esercizio speculativo e non
come il momento teorico (o l’aspetto negativo del momento teorico) della prassi rivoluzionaria
del proletariato, dalla cui apparizione sulla scena della storia essa è assolutamente condizionata». (R. Panzieri, Il socialismo “umanista” in Francia, in Id., L’alternativa socialista, cit., p.
63.) Vengono messe in rilievo in questo saggio le analogie tra gli umanisti francesi, Saragat,
e l’operazione di alcuni ideologi della socialdemocrazia tedesca e austriaca, che all’unisono
amano richiamarsi alle opere giovanili di Marx credendo di rintracciare in quegli scritti «i
quali viceversa forniscono la più approfondita critica dei “valori etici” come di qualsiasi tentativo ideologico di fondare astrattamente dei “valori universali”»,(Ibid., p. 66) proprio quei
riferimenti etici cui sottomettere il progetto di emancipazione. Pensando ad autori come Maximilien Rubel oltre che a Saragat, Panzieri sostiene infine che il vero scopo di ogni modernizzato revisionismo umanista è chiaramente «la deformazione del marxismo per dividere e
indebolire la classe operaia» (Ibid., p. 67).
83
Ibid., p. 57.
84
Ibid., p. 60
80
81
146
Cristiana Boscarelli
revisionismo bernsteiniano che mira a condurre il proletariato sulla piattaforma
dell’azione legalitaria, fornendo dunque secondo Panzieri «l’arma ideologica
per l’addomesticamento del movimento proletario mediante un controllo
“dall’esterno” da parte della borghesia». 85
Diversa è invece la funzione e la tipologia del revisionismo più recente, a
partire dall’austromarxismo, che a modo di vedere di Panzieri, porta un attacco
più profondo al proletariato, poiché tenta di conquistare dall’interno i partiti
socialisti attraverso quella che viene definita la massa di manovra e di assalto
dei ceti medi86.
L’obiettivo di questo revisionismo è quello di produrre una ideologia atta
a sedimentare su posizioni antisocialiste le classi medie presenti nei partiti
socialisti.
È chiaro come Panzieri veda nella presenza significativa proprio dei ceti
medi nel partito socialista la forza oggettiva delle posizioni saragatiane, e
una minaccia all’esistenza stessa del partito socialista. Non è certamente un
caso che nello sviluppare queste argomentazioni Panzieri faccia riferimento a
Lenin87, proprio sul tema del ripresentarsi in forma diversa, a gradi diversi dello
sviluppo del capitalismo e dello sviluppo dell’azione proletaria, del revisionismo,
in relazione proprio ad un processo di proletarizzazione che non si compie mai
del tutto all’interno del modo di produzione capitalistico.
5. La classe oltre il partito
L’assunzione della rivoluzione bolscevica del 1917 come un punto di
riferimento per il proletariato internazionale, l’affermazione chiara della natura
classista dello stato borghese e la necessità della dittatura proletaria sono le
coordinate all’interno delle quali si comprende il contrasto con le correnti
socialdemocratiche e l’attenuarsi della polemica con il partito comunista; nei
confronti di quest’ultimo vi è un appello che richiama alla comune esigenza
fondamentale del marxismo in quanto teoria del proletariato rivoluzionario,
alla unificazione del proletariato, che per Morandi88 -e per Panzieri- può
R. Panzieri, Osservazioni a un nuovo revisionismo, in Id., L’alternativa socialista, cit., p. 61.
Ibid. Corsivo mio.
87
V. I. Lenin, Marxismo e revisionismo, in Opere Scelte, vol. II, Roma, 1973, pp. 10-11.
88
Esula dai compiti di questo scritto chiarire il dibattito interno alle correnti socialiste,
le differenze tra le impostazioni di Morandi , Basso e Nenni, per tutto ciò facciamo come
sempre riferimento al testo di Agosti, che attraverso la biografia di Morandi ci offre la chiave
una chiave di lettura appropriata al ragionamento che qui si propone. Cfr. A. Agosti, Rodolfo
Morandi, cit.
85
86
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
147
realizzarsi, non tanto nella riduzione ad uno dei partiti della classe operaia
-ipotesi fusionista89- quanto, nell’ operare per una unità di lotta, avendo dunque,
insieme con i comunisti, come punto di riferimento costante il «concreto
terreno della lotta per la conquista del potere politico»90.
È significativo sottolineare che gli anni in cui si svolge la polemica panzieriana
con Saragat sono proprio quelli in cui Morandi, dopo avere ceduto allo schema
di lotta dei tempi successivi, apre in qualche modo aperto alla strategia
gradualistica, adottando - seppure in quanto scelta transitoria - quella linea che
era stata sempre rifiutata negli anni della clandestinità. La linea gradualistica
vedeva succedersi, per ordine di priorità, la lotta antifascista, l’abbattimento
della monarchia e infine le trasformazioni economico-sociali91; in armonia
con questa linea Morandi sembra leggere la dinamica sociale attraverso la
contrapposizione progresso-reazione, e -al di là di ogni interpretazione- di fatto
subordina ogni tipo di riforma strutturale ad una ricostruzione dell’apparato
produttivo. Ciò è stato letto come un elemento negativo, soggiacente ad una
concezione illuministica del progresso tecnico, che emerge poi nel particolare
ruolo assegnato ai consigli di gestione, cui Morandi affidava «il compito di
collaborare insieme alle forze capitalistiche per ricostruire l’industria nazionale
(…) perché pensava che il progresso tecnico possedesse una razionalità
intrinseca 92 ostacolata dal capitalismo monopolistico.»93
Rispetto a Morandi Panzieri opera dunque una più approfondita critica
della neutralità dello sviluppo delle forze produttive, svolgendo peraltro
coerentemente gli elementi già presenti nello stesso impianto morandiano.
È inevitabile considerare la complessità e anche la contraddittorietà
della proposta morandiana sui consigli di gestione94alla luce della particolare
89
“L’idea di un partito unico della classe operaia fu concepito in una prima fase da Morandi, che insieme con Pertini e Cacciatore si espresse in tal senso al congresso del P.S.I.U.P. del
1946. Il partito unico era però concepito in termini non strumentali o verticistici, esso doveva
costituire piuttosto l’effettivo superamento tanto del partito socialista che di quello comunista,
nell’idea che ciò corrispondesse alla fase attuale della lotta di classe, e a un rinnovamento delle
strutture del movimento operaio come prodotto delle esperienze della Resistenza. L’esigenza
di Morandi era di non affermare l’identità del partito in funzione anticomunista e antisovietica, ma comunque l’ipotesi di una fusione, nella quale probabilmente anche il partito comunista non aveva interesse fu presto abbandonata. Cfr. Ibid., p.436-437.”
90
R. Panzieri, Osservazioni a un nuovo revisionismo, cit. p. 62.
91
Cfr. A. Agosti, Rodolfo Morandi, cit., p. 418.
92
Corsivo mio.
93
S. Mancini, Socialismo e democrazia diretta, cit., p. 38.
94
R. Morandi, Piano economico e riforme di struttura, in Id., Democrazia diretta e riforme di
struttura, Einaudi, 1975; Id, I consigli di gestione sul piano della lotta, Ibid., pp.219-225. Notarianni, al quale fa riferimento già Agosti, rintraccia in Morandi un concetto ancora generico di
razionalità economica. Cfr. M. Notarianni, R. Morandi e il socialismo italiano tra la Liberazione
148
Cristiana Boscarelli
declinazione che assumeva il richiamo alla politica unitaria in quel frangente: la
specificità della fase della ricostruzione nell’Italia del dopoguerra, la partita sul
modello di industrializzazione, e - non da ultima- l’inadeguatezza strutturale
del partito socialista a far pesare il proprio ruolo fuori dal gioco parlamentare.
L’insieme di questi elementi concorrono ad un allontanamento di Morandi
dalla dalle analisi degli anni Trenta, durante i quali egli era riuscito a coniugare,
come Mancini ci ricorda95, l’istanza della produttività e la crescita della
democrazia diretta.
La contraddittorietà della proposta morandiana dei consigli di gestione96
è innestata sull’accettazione dell’identificazione degli interessi della classe
operaia italiana con quelli del campo socialista, e certamente in questo senso
possiamo parlare di subalternità rispetto al P.C.I., proprio perché gli istituti
della classe operaia, consigli di gestione, comitati di lotta per le terre, venivano
fatti rientrare di fatto all’interno di una strategia riformista, perdendo il proprio
potenziale di accumulazione di forze, di catalizzatore di energie di lotta unitarie,
come anche la possibilità di riuscire ad accrescere progressivamente il potere
che si concentra nelle mani dei lavoratori.
Agosti sostiene che Morandi nonostante sembrasse avere intuito che in Italia
si erano chiuse fin troppo velocemente le possibilità di «modificare l’equilibrio
capitalistico senza rovesciare lo stato che ne era espressione»97 assume in
buona parte la necessità di attaccare gli aspetti più retrivi del capitalismo,
ma al contempo, e in questo risiede la distanza del progetto morandiano dal
riformismo, rileva che rimane operante in lui una concezione transitoria della
presa del potere98, ed è all’interno di questa concezione che va inquadrata
l’assunzione, contraddittoria, delle riforme di struttura.
Panzieri dal canto suo, ancora agli inizi del 1956, esprimendosi sulla
necessità di porre in termini di continuità democratica le trasformazioni
la restaurazione capitalistica, in «Rivista storica del Socialismo», 1960, n. 9.
95
S. Mancini, Socialismo e democrazia diretta, cit., p. 39. Secondo Mancini Morandi è
portatore di una concezione neutrale dello sviluppo produttivo: «In lui la coppia progressoreazione coincideva con quella socialismo-capitalismo e non erano presenti più le aperture
del periodo del centro interno quando insistendo sul rifiuto di identificare il capitalismo con
l’anarchia produttiva egli aveva evitato di cadere nell’equivalenza di socialismo e pianificazione.» (Ibid.)
96
R. Morandi, I consigli di gestione, in , Id, Democrazia diretta e riforme di struttura, Torino,
1975, pp. 98-100; Id, Sotto accusa di corporativismo, Ibid., pp.101-103.
97
A. Agosti, Rodolfo Morandi, cit. p. 426.
98
Agosti riporta una dichiarazione di Livio Maitan: «difficilmente si troverà nei documenti
dei partiti operai, o negli scritti dei loro esponenti del primo dopoguerra un maggiore accostamento alla concezione leninista delle parole d’ordine transitorie.»(A. Agosti, Rodolfo Morandi,
cit. p. 428).
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
149
economiche e sociali commisurandole allo sviluppo effettivo delle forze
produttive, onde evitare un salto oscuro tra capitalismo e socialismo, sostiene
la necessità di «rompere i rapporti di produzione soltanto dove essi soffocano
questo sviluppo».99
Tutto il partito socialista da una parte, Morandi stesso nel ruolo di ministro
dell’industria e lo stesso Panzieri, erano impegnati nel dibattito sul modello
di sviluppo da imprimere al paese, sui margini entro i quali potere sviluppare
un’azione politica che appoggiandosi anche su riforme del sistema produttivo
potesse liberare energie vive nel paese e configurare un quadro sociale favorevole
alle lotte di operai e contadini. In questo ragionamento, e orientata ad un
bilancio complessivo, si inserisce la Prima conferenza economica socialista.
Essa raccoglie l’esperienza di governo del partito e quella di Morandi come
ministro dell’industria e del commercio. La conferenza fu promossa dall’Istituto
di Studi Socialisti, e a Panzieri venne affidata la segreteria del convegno100.
Divengono centrali da questo momento all’interno della riflessione
panzieriana la questione del piano socialista e la critica della astrattezza del
piano capitalista.
Questi stessi temi saranno oggetto di una lunga riflessione critica da parte di
Panzieri: essa verrà approfondita durante glia anni Cinquanta e Sessanta , ma,
già nel maggio del 1947, Panzieri parlerà di «così dette “riforme strutturali”»101,
sottolineando al tempo stesso l’impossibilità di una vera riforma della struttura
economica in ambito capitalistico, e il valore di «accentuar[n]e progressivamente
i modi del processo di trasformazione»102.
Nella riflessioni sul controllo operaio, prima ancora che negli studi sul
neocapitalismo, sono evidenti gli ulteriori passaggi panzieriani su questi temi,
ed è evidente quanto proprio i fermenti di lotta operaia tra la fine degli anni
Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta determinino l’abbandono da parte di
Panzieri delle incertezze ancora presenti tanto nelle sue analisi che in quelle
di Morandi. Se questo è vero però, non è altrettanto semplice ricondurre
incertezze e ambiguità, che pure sono rilevabili in Morandi, alla subalternità ad
99
R. Panzieri, Il salto da compiere, in Id., Dopo Stalin. Una stagione della sinistra1956-1959,
cit., p. 52. Nonostante esuli in parte dagli intenti di questo studio, poiché mette a tema scritti
risuccessivi al periodo che si è deciso di analizzare, segnalo l’interessante saggio di Mottura;
G. Mottura, Il “morandismo” in Panzieri: crisi del Psi 1956-1959, in M. Cini, G. Zingone, (a cura
di ), Ripensando Panzieri trent’anni dopo. Atti del convegno , Pisa 28/29 Gennaio 1994, 1995,
pp. 99-121.
100
Atti della prima conferenza economica socialista n. 14-18 (novembre-dicembre 1947)
del «Bollettino dell’Istituto di studi socialisti»
101
R. Panzieri, Il «Piano socialista» , in, Id. L’alternativa socialista, cit., p. 69.
102
Ibid.
150
Cristiana Boscarelli
uno schema riformista103, permanendo al fondo quel nucleo classista- libertario
che sostanzia già la riflessione morandiana degli anni trenta, orientata a
coniugare la prospettiva socialista all’istanza consiliare e perciò nella continuità
democratica, come spinta dal basso alla costruzione di capacità di controllo da
parte dei lavoratori.
Questi elementi matureranno in Panzieri che già nel 1956 questa volta saprà
leggere la chiusura della cultura marxista nella sua pratica partitaria, nella sua
incapacità di riconoscere l’autonomia della cultura così come essa si esprime
nella classe oltre il partito, come «chiusura e [nel] ritardo dell’azione delle
masse di fronte allo sviluppo della situazione economica e sociale del paese»104,
esplicitando il nesso tra autonomia della cultura e autonomia della classe.
Troviamo dunque sullo fondo della riflessione morandiana la non sciolta
questione dell’organizzazione internazionale della classe letta nei termini di una
perdurante trappola tra la falsa alternativa di riformismo e rivoluzione; negli
anni post-unitari e della guerra fredda peserà non avere sciolto politicamente
questo nodo.
Morandi ha indubbiamente declinato in un modo particolare l’esigenza
di superare le antitesi tra le posizioni riformiste e quelle rivoluzionarie così
come si erano andate consolidando nell’antitesi tra la seconda e la terza
internazionale, ravvisando la necessità al contempo di un bilancio storico
dell’opzione riformista, e di quella rivoluzionaria e tentando di superare quelli
che vedeva come delle contrapposizioni rigide che non coglievano le nuove
esigenze della lotta di classe.
Se il superamento della contrapposizione tra il riformismo e la via
rivoluzionaria alla presa del potere non poteva avvenire su un piano meramente
teorico, ciò non era possibile neanche esclusivamente su un piano tecnicoorganizzativo.
Sulle modalità di questo superamento Morandi interroga la proposta di Otto
Bauer sul socialismo integrale105 e ad essa replica in una saggio del 1937 appunto
103
R. Morandi, Piano economico e riforme di struttura in Id., Democrazia diretta e riforme
di struttura, cit., p. 258.
104
R. Panzieri, Azione politica e cultura, in Id., Dopo Stalin. Una stagione della sinistra1956-1959, cit., p. 52.
105
O. Bauer, Zwischen zwei Weltkriegen?: die Krise der Weltwirtschaf, der Democratie und
des Sozialismus, Bratislava, 1936;, tr. it., Tra due guerre mondiali?: crisi dell’economia mondiale,
della democrazia e del socialismo, traduzione di G. Panzieri Saija , Torino, 1979. Per un quadro
complessivo, cfr. Aa.Vv., Storia del marxismo, Il marxismo nell’età della terza internazionale,
III vol., cit., in part.; P. Merhav, Socialdemocrazia e austromarxismo, Ibid., pp. 219-238; G.
Marramao, Otto Bauer e la rivoluzione d’Ottobre, Ibid., pp. 239-297. Ancora sul rapporto tra
Rivoluzione d’Ottobre e austro marxismo; Id., «Tecnica sociale», Stato e transizione tra social-
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
151
Ricostruzione socialista. Il socialismo integrale di Otto Bauer. In questo saggio
Morandi individua i limiti della proposta di Bauer: pur poggiando questa su un
severo giudizio del riformismo, nello schema elaborato soffre di inadeguatezze
politicamente decisive, ossia si pone il problema della unificazione del
proletariato come risultato necessario di un nuovo conflitto mondiale, che
dovrebbe produrre le condizioni necessarie, ma soprattutto sufficienti tali da
determinare una unificazione delle organizzazioni internazionali come frutto
di una diminuita ostilità nonché della considerazione reciproca dei presupposti
storico-sociali che hanno determinato l’insorgere delle differenze. Morandi,
che rimprovera a Bauer di non muoversi nell’ambito della politica ma della
profezia, legge la politica come iniziativa calata negli eventi storici, sostenendo
che la questione del rapporto tra le due internazionali non si possa definire
nei termini di reciproca integrazione, attraverso la costruzione di «un sistema
di generalizzazioni premature»106. Il livello di astrazione su cui si mantiene
Bauer finisce per rendere nulle le premesse critiche iniziali, le quali possono
essere tenute ferme soltanto tentando di svilupparle, facendole «progredire a
determinazioni costruttive»107.
Là dove Bauer assegna ad una nuova guerra «la funzione di levatrice della
nuova unità proletaria»108, Morandi pensa ad una unità dell’azione di forze nuove
all’interno di una nuova concezione unitaria del socialismo. L’apporto costruttivo
adeguato all’evolversi della crisi del socialismo sta, per Morandi, nella ricerca
del metodo democratico della rivoluzione fuori dell’impianto riformista, come
superamento di quelli che vengono definiti «termini alternativi di una relazione
virtualmente esauritasi nella sua funzione e significazione storica»109.
Il riferimento è a un socialismo rinnovato che esca dalla contrapposizione
tra democrazia e autoritarismo, che rompa con lo statalismo, -visto come la
gravosa eredità del periodo della lotta legale- che ha condizionato tanto la
seconda quanto la terza internazionale, indicando la necessità di sviluppare la
critica marxista dello stato e della burocrazia.
Sulla burocrazia, sulla sua natura e sulla sua funzione Morandi rifletterà
negli anni della prigionia nelle carceri fasciste110, e ancora, negli anni
democrazia weimeriana e austromarxismo, in Id., Il politico e le sue trasformazioni, Bari, 1979.
106
R. Morandi, Ricostruzione socialista. Il socialismo integrale di Otto Bauer, in La democrazia del socialismo 1923-1937, cit., p. 183.
107
Ibid.
108
Ibid., p.181
109
Ibid., p.183.
110
R. Morandi, Analisi dell’economia regolata. (Giugno 1942) in Lotta di popolo1937-1945,
cit, pp. 37-49.
152
Cristiana Boscarelli
successivi, sostenendo che la burocrazia - che nasce all’interno dello stato
moderno- rivela la sua massima inadeguatezza nella organizzazione collettiva
della produzione, alla quale si conviene il metodo democratico, inteso come
promozione massima della partecipazione collettiva, che solo può portare a
quel contributo qualitativamente discriminante che risiede nella partecipazione
critica all’organizzazione collettiva, nelle forme più dirette e responsabili di
organizzazione, in una gestione centrale delle attività che non è necessariamente
centralizzazione.
Centrale è la funzione creatrice dell’esperienza per capire il ruolo
determinante che viene assegnato agli istituti della classe, al controllo
operaio e alla capacità di autoeducazione della classe, che riempie lo iato tra
l’abbattimento dello stato borghese e la costruzione di una società socialista.
Per Morandi le libertà proletarie non cessano di essere essenzialmente
istituti111, e dunque in questo senso si comprendono i legami che tengono in
una stessa prospettiva la declinazione mai tatticistica della politica unitaria,
l’assunzione dell’opzione consiliare e la critica ad ogni scissione tra il piano
ideologico e gli obiettivi di lotta immediati del proletariato, puntando alla
costruzione di una democrazia socialista.
Questi temi morandiani sono un riferimento fermo nella formazione di
Panzieri, e saranno ulteriormente sviluppati e vivificati, è con questa precisa
consapevolezza che Panzieri vi fa riferimento tra il 1956 e il 1958112; eppure già
in un periodo precedente113 nel rivendicare la necessità della lotta nelle strutture,
ossia sul terreno economico attraverso i consigli di gestione, i comitati della
terra, se pure con una certa curvatura oggettivistica, rintracciabile nel continuo
richiamo agli strati sani della produzione in contrapposizione alla strapotenza
dei grandi gruppi oligarchici, è sempre il tema della costruzione dal basso
di strutture di controllo, la strada per compiere quello che veniva definito il
superamento dialettico delle insufficienze della democrazia formale.
È stato già sottolineato114 che il legame esistente tra il richiamo alla politica
unitaria e la concezione morandiana del partito come strumento della classe
fosse giocato da Panzieri per mettere a nudo la “cattiva unità”, tutta tattica e
111
R. Morandi, Problemi di politica socialista, in Id., La democrazia del socialismo, cit.,
p.126.
112
Cfr. R. Panzieri, Un punto fermo nella visione ideologica di Morandi. La politica unitaria
del PSI, in Id., Dopo Stalin cit., pp. 75-80; Id., Le «opere» di Morandi, in Dopo Stalin, cit., pp.
81-82.
113
Dalla metà degli anni Quaranta alla metà degli anni Cinquanta.
114
P. Ferraris, Testimonianze, in Aa.Vv., Raniero Panzieri, un uomo di frontiera, a cura di
Paolo Ferrero, Milano, 2005, p. 140 .
Raniero Panzieri: Gli anni della formazione (1946-1955)
153
lontana dalle dinamiche della lotta di classe italiana, portata avanti dal partito
comunista, e come l’accento posto sulla necessità di tenere insieme politica ed
economia, venisse tacciato di revisionismo di sinistra dagli esponenti di quello
stesso partito115.
In realtà l’attenzione di Morandi verso l’austromarxismo, le note su Bauer
e l’attenzione critica nelle note di Panzieri del 1949, danno conto di quanto
seriamente la questione della ricomposizione della scissione tra mezzi e fini
fosse tenuto in considerazione dai nostri, e in questo senso l’austromarxismo
costituisce un importante elemento di confronto. Se è vero che nel pensiero
morandiano è presente una tematica che si può ricollegare ad Otto Bauer, ossia
«la convinzione che la presa del potere e l’instaurazione di un nuovo regime di
proprietà sono solo una componente e non la più importante della rivoluzione
socialista»116 e che essa necessita invece dell’attività cosciente del proletariato in
ogni sua fase e sviluppo, è vero anche che appare più netta e precoce l’esigenza
autocritica sulla rivoluzione d’Ottobre e la dichiarazione del fallimento storico
e teorico dell’opzione socialdemocratica. Tutto questo è decisivo nel distacco
precoce di Morandi da Rosselli117e da Giustizia e Libertà, organizzazione
entro la quale Morandi si era battuto, seppur brevemente, nel senso di una
riqualificazione in senso classista.
Come chiarisce Festa, «la scissione tra mezzi e fine, nell’età dell’imperialismo,
identifica, quindi, la scissione tra politica ed economia, fondamentale per
tener lontano i produttori, ingabbiati nell’immediato economico, dalla
riappropriazione degli strumenti di produzione e dalla direzione dello Stato
e della società civile. Si crea allora quella falsa alterità tra uomo ed ambiente
naturale che permetterà al Capitale di coprirla a livello di una scienza come
specialistica conoscenza dei mezzi e della tecnica per il dominio del mondo,
cioè del sapere organizzato in dominio».118
Paolo Spriano.
A. Agosti, Rodolfo Morandi, cit., p. 179.
117
Testimoniano la rottura con Rosselli la corrispondenza tra i due. Cfr. Lettera di Morandi
a Rosselli, settembre 1931 in Il dibattito socialista sotto il fascismo: lettere di Rodolfo Morandi a
Carlo Rosselli (1928-1931), a cura di S. Merli, 1963, estratto da «rivista storica del socialismo»,
n.19, (maggio – agosto 1963), e R. Morandi, La rivoluzione italiana dovrà essere una rivoluzione socialista, in «Avanti», 26 Settembre 1931, Ibid., pp. 344-346. Testimonia ulteriormente
l’impianto marxista assunto da Morandi la sua Storia della Grande industria, pubblicata per
la prima volta proprio nel 1931.; R. Morandi, , Storia della Grande industria in Italia, Torino,
1966.) Sempre del 1931 è il Memoriale di Morandi al PCI , datato 11 Dicembre e pubblicato da
Domenico Zucaro. (Cfr. D. Zucaro, Memoriale di Morandi al PCI, in Id, Socialismo e democrazia nelle lotte antifasciste: dalle carte di Nenni e dagli archivi di Giustizia e Libertà e del Partito
Comunista Italiano, Milano, 1988, pp.128-132.)
118
F. S. Festa, L’esperienza storico-teorica dell’austromarxismo, contributo scritto al con115
116
154
Cristiana Boscarelli
Questa ampiezza dell’accezione di scissione tra mezzi e fini tiene al suo
interno lo sviluppo della tematica consiliare dell’Austromarxismo, e nonostante
le differenze, delle concezioni transitorie delle ipotesi morandiane prima e
panzieriane.
Tenendo conto di una accezione più ristretta della coerenza mezzi-fine, che
è il richiamo alla continuità dei metodi e degli strumenti di lotta prima e dopo
la conquista del socialismo, Mancini giunge a concludere che «l’affermazione
di tale coerenza non esprime soltanto la sua [di Panzieri] preoccupazione che
sia garantita la natura democratica della società socialista, ma illumina un
altro rilevante aspetto del suo pensiero, anche se prevalentemente implicito:
l’importanza attribuita alla formulazione delle “basi etiche del socialismo”»119.
vegno Quali sono le prospettive del comunismo nell’epoca della globalizzazione? a cura dell’associazione T. Modotti, Brescia2-3-4-marzo2001. http://www.webalice.it/zinelli1/prelevamenti/
interventi_singoli_pdf/I_Presupposti_filosofici/Festa_contributo_scritto.pdf
119
S. Mancini, Socialismo e democrazia diretta, cit., p.128. Mi propongo in un prossimo
studio di tornare sugli sviluppi successivi del percorso panzieriano e sulla problematicità del
carattere etico delle implicazioni del socialismo.
Karl Barth interprete di Ludwig Feuerbach
155
Karl Barth interprete di Ludwig Feuerbach
Memoria di Teresa Caporale
presentata dal socio naz. ord. res. Giuseppe Antonio Di Marco
(seduta del 25 novembre 2010)
Abstract. This paper is dedicated to the comparison that the Protestant theologian Karl
Barth does with the atheist philosopher Ludwig Feuerbach, who has assumed a central
role in the elaboration of his positive theology. In fact this barthian lecture of Feuerbach
strictly underlines the sincere interest that Barth has for Feuerbach’s atheism, from
which he knows he can learn a lot, even if Barth doesn’t agree with Feuerbach’s Theology
of Man-God identity. Barth recognizes that Theology had become Anthropology time
ago, so that the responsibility of this passage cannot be attributed to Feuerbach himself.
The main intention of this essay is to clarify that the real polemic object of Barth is not
Feuerbach, but the whole XIX century neo-protestant Theology, which is responsible
for the process of humanization of Theology that dates back to Lutero’s thought. On
the contrary Barth admits that Feuerbach has had the merit to unmask the modern
protestant Theology, in particular Schleiermacher’s, who was its major theorizer. In this
case Feuerbach, in spite of himself, becomes Barth’s precious ally in the battle against the
Protestant modern Theology’s anthropocentrism, so that he is valorized for his critical
approach to Idealism and his research for the real man.
1. Il protestantesimo liberale del XIX secolo come vero obiettivo polemico della
lettura barthiana di Feuerbach
Nella storia della teologia Karl Barth occupa una posizione di assoluto rilevo
all’inizio del secolo XX, paragonabile a quella che Schleiermacher occupa al
principio del XIX.
A partire da lui datiamo una nuova epoca nella storia della teologia
protestante, al punto da sostenere che la teologia del secolo XX ha inizio
proprio con Karl Barth, teologo nel quale è confluita, con fedeltà sorprendente,
l’eredità della Riforma.1
1
Diversi studiosi di Barth, sia pure appartenenti a scuole differenti e distanti tra loro nel
tempo, si trovano concordi su questa tesi, sostenuta in particolare da Brunero Gherardini
nella Prefazione allo scritto di K.Barth Invocami! Prediche dal penitenziario di Basileia, tr.it.
B.Gherardini, Brescia 1969, p.7. Allo stesso modo H.Zharnt sostiene che «proprio con Barth
ha inizio la teologia protestante del XX secolo»; (H.Zharnt, Alle prese con Dio. La teologia
156
Teresa Caporale
Si potrebbe sintetizzare la novità del discorso barthiano con questa sua
osservazione nella Dommatica Ecclesiale: «Dio non è oggetto d’esperienza
religiosa e lo sforzo titanico di porsi Dio a propria disposizione equivale
all’ingenuo inutile gesto di colui che volesse attingere, per mezzo d’un vaglio,
il riflesso della luna nel lago».2 Dunque Barth ritiene che è Dio che dispone
incondizionatamente dell’uomo e si rivolge a lui sotto forma di una Parola
rivelatrice. Questo evento della rivelazione però non è qualcosa di cui gli uomini
possano disporre pur essendo di importanza decisiva per loro.
In conseguenza di questo assunto l’obiettivo polemico barthiano è il
Protestantesimo liberale, che egli accomuna al Cattolicesimo su questo punto:
la condanna dell’umanesimo, usurpatore dei diritti di Dio e soffocatore della
sua Parola.
Barth infatti è convinto della necessità di sradicare totalmente il discorso
intorno al “divino nell’umano” e per questo contrappone alla teologia della
coscienza umana, la sua teologia della rivelazione divina, ossia sostituisce
all’uomo, al suo parlare e pensare su Dio, Dio stesso, quanto egli stesso dice
e pensa dell’uomo. Infatti tra i due termini, a giudizio di Barth, sussiste una
infinita distanza e non c’è alcuna possibilità di passaggio, ponte o continuità, se
non per volere di Dio.
Da ciò deriva che l’uomo non può per nessuna via umana accedere a Dio, ma
è solo quest’ultimo che può decidere di volgersi all’individuo donandogli la fede
e dunque la salvezza. Quindi non si tratta di una divinità astratta e indifferente
rispetto all’uomo; per questo Barth si dibatte tra il desiderio di salvare tale Dio
ad ogni costo e nello stesso tempo si sforza di riabilitare sempre più l’uomo.
Proprio il riconoscimento dell’importanza della dimensione umana è tra i
principali motivi che hanno indotto Barth ad occuparsi paradossalmente del
pensiero di Feuerbach, ossia il filosofo che pur di affermare l’uomo arriva a
negare la realtà di Dio. Infatti il bersaglio polemico più immediato di Barth non
è Feuerbach, ma il protestantesimo liberale del XIX secolo e la sua tendenza a
ricercare il divino nell’uomo. Nei suoi personaggi più rappresentativi, il pensiero
protestante nel XIX sec.Una storia, Brescia 1976, p.5). Si tratta della medesima convinzione
che Andrea Milano esprime nelle prime pagine del capitolo dedicato a K.Barth nel suo scritto
Rivelazione ed ermeneutica, quando dice che quel teologo «ha inciso sull’intera cultura del nostro tempo, anche se per molti aspetti in antitesi alla comprensione che questa ha di se stessa,
tanto che Eberhard Jungel ha potuto tranquillamente dichiarare che senza di lui non è più
possibile pensare il 900»; (A.Milano, Rivelazione ed ermeneutica. Karl Barth, Rudolf Bultmann,
Italo Mancini, Urbino 1988, p. 476).
2
K.Barth, Kirchliche Dogmatik, Auswahl und Einleitung von Helmut Gollwitzer, Frankfurt
a.Main, Fischer Bucherei 1975, p. 226, tr.it. I.Mancini, Dogmatica Ecclesiale, Bologna 1968,
p.93.
Karl Barth interprete di Ludwig Feuerbach
157
protestante del secolo XIX era diventato religionista e quindi antropocentrico: la
sua dottrina di Dio equivaleva alla dottrina dell’uomo, precisamente dell’uomo
religioso; parlare di Dio significava parlare in modo certo più elevato, ma ancora
e sempre di questo uomo, anche se della sua fede e delle sue opere. L’uomo era
certo apparso grande, ma sempre a spese di Dio. Feuerbach, in quanto figlio di
quel secolo, non poteva che sostenere quella teologia dell’identità uomo-Dio.
Eppure Barth, pur non condividendo tale teologia, a suo avviso «pervertita»3
in antropologia, sa di poter imparare molto dall’ateismo feuerbachiano, ed esalta
il filosofo che afferma, loda, ama l’uomo nella sua pienezza, nella sua unità di
testa, cuore e stomaco. Così a Feuerbach Barth dedica un intero capitolo della
sua Teologia protestante nel XIX secolo4 e una celebre lezione pubblicata nel
1927 nel periodico Zwischen den Zeiten, e poi più volte ristampata e tradotta5.
Il riferimento a Feuerbach non è fatto in altro senso che quello di valorizzare
come «buon teologo»6 colui che ha portato alle estreme conseguenze atee il
movimento della più recente teologia romantica, che Barth nel suo saggio
chiama «l’insolente teologia dell’identità».7
In particolare, il programma feurbachiano consisteva nel far sì che i suoi
ascoltatori «da amici di Dio diventassero amici degli uomini, da credenti
divenissero pensanti, da oranti divenissero lavoranti, da candidati dell’al di
là divenissero studiosi dell’al di qua, da cristiani che seguivano il loro credo,
divenissero metà animali e metà angeli, cioè uomini, interamente uomini».8
In altre parole, Feuerbach vorrebbe sostituire alle realtà religiose fittizie,
attributi religiosi realmente forniti di significato: vorrebbe porre il mondo e
l’uomo al posto di Dio; l’amore al posto della fede; la terra al posto del cielo;
insomma al posto dello spettro inconsistente del soprannaturalismo egli vuole
porre la vita reale. A tal proposito così si esprime Feuerbach nell’ Essenza del
Cristianesimo: «all’acqua sterile del battesimo sostituisco effettivamente il
beneficio della vera acqua».9 Non a caso egli chiama scherzosamente la sua
dottrina “idroterapia pneumatica”. Infatti a giudizio di Feuerbach «l’acqua
Cfr. A.Milano, Rivelazione ed ermeneutica, cit., p.491.
K.Barth, Die protestantische Theologie im.19 Jahrhundert, Theologischer Verlag, Zurich
1946, p.484-489; tr.it. G.Bof, La teologia protestante nel XIX secolo, Milano 1972, pp.121-127.
5
Id., Die Theologie und die Kirche. Gesammelte Vortraege, Chr.Kaiser, München, 1928,
pp.11-40; tr.it. in K.Barth, Antologia, a cura di E.Riverso, Milano 1964, pp.105-134.
6
I.Mancini, Introduzione a La teologia protestante del XIX sec., cit., p.57.
7
K.Barth, Die Theologie und die Kirche. Gesammelte Vortraege, cit.p.40, tr.it. cit., p.134.
8
L.Feuerbach, Das Wesen der Religion, Kroner Verlag, Leipzig 1846, p.170, tr.it. C.Cesa,
Essenza della Religione, Bari 1993, p. 118.
9
Id., Das Wesen des Christentums, Lipsia 1841, p.19; tr.it. C.Cometti, L’essenza del cristianesimo, Milano 1994, p. 19.
3
4
158
Teresa Caporale
è l’immagine dell’autocoscienza, l’immagine dell’occhio umano, lo specchio
naturale dell’uomo. Nell’acqua l’uomo si spoglia coraggiosamente di ogni
aureola mistica; all’acqua l’uomo si affida nella sua forma nuda e genuina;
nell’acqua scompaiono tutte le illusioni soprannaturalistiche».10 In questo
modo Feuerbach intende dimostrare che nel preteso mistero della religione
è dell’uomo che si tratta, che l’uomo sogna quando crede che quel principio,
quell’origine, quella necessità, quella fonte da cui scaturiscono i suoi desideri ed
i suoi ideali e la meta verso cui egli tende per realizzarli, sia un altro essere, che
gli sta di fronte: «nell’essere infinito mi viene presentato in forma di soggetto
e come essenza oggettiva, ciò che è un mio predicato ed un mio attributo».11
Feuerbach mira ad esporre tale conoscenza e a destare in quante più persone è
possibile questa sua intuizione fondamentale.
A giudizio di Barth è questo il principale guadagno conseguito da Feuerbach:
l’aver smascherato la dimensione antropologica della teologia, ossia l’aver
dimostrato che l’essenza umana costituisce l’essenza originale della religione.
Da ciò deriva un ulteriore merito di Feuerbach: la rivalutazione del finito, del
concreto, l’aver puntato sull’uomo cuore e stomaco, contrastando così la teologia
cristiana, che fin dalla Riforma non ha dato la debita importanza alla speranza
cristiana. Anche Barth riconosce l’importanza della dimensione umana, infatti
nella sua teologia la realtà dell’uomo e i suoi valori non vengono negati di
fronte all’onnipotenza di Dio, che proprio all’uomo rivolge la sua misericordia.
Però, a differenza di Feuerbach, Barth non aderisce all’uomo per l’uomo, ma è
sempre Dio il centro da cui dipende ogni iniziativa umana. Egli è quell’ unico,
eterno valore nel quale ogni problema umano è risolto, dal momento che la
grazia divina è l’elemento sovrano, insondabile e incomprensibile a cui l’uomo,
comunque si volti, in ultimo è sottoposto. Quindi l’aver fondato in Dio i valori
creaturali non significa averli negati, semmai averli dilatati. Non a caso l’uomo
si è ritrovato, se non addirittura riscoperto, nella forte accentuazione barthiana
del rapporto vitale con esso stabilito da Dio mediante il Cristo.
Inoltre il saggio di Barth su Feuerbach va ricordato perché in esso egli
affermò l’attualità di questo autore12, sia pure in chiave polemica. Barth sapeva
Ivi, p.8.
Ivi., p.401.
12
Infatti Barth sostiene che è innegabile che Feuerbach abbia dato origine a un discorso,
provocatorio ed inquietante, cui il mondo d’oggi non ha saputo ancora offrire una risposta
del tutto soddisfacente. Così, dopo essere stato ignorato o disconosciuto per molti decenni,
l’insegnamento feuerbachiano è tornato, a partire dagli anni Sessanta, a suscitare notevole interesse, sia per gli apporti, che direttamente o indirettamente ha dato all’insorgere dell’ateismo
di massa, sia per gli interrogativi stimolanti che esso pone alla stessa cultura teologica della
modernità. In questo senso lo studio di Feuerbach è valso a mettere in chiaro definitivamente
10
11
Karl Barth interprete di Ludwig Feuerbach
159
bene che per colpire Feuerbach bisognava essere colpiti da lui, ed egli lo fu
senz’altro.
Così pur negando che Feuerbach avesse compreso cosa davvero fosse
il Cristianesimo, Barth gli assegnava un posto importante nella coscienza
contemporanea, e lo additava come un avversario cui la teologia doveva ancora
una risposta. Questa stessa osservazione era stata, per la verità, già formulata
da K.Leese in una sua dissertazione del 191213, ma l’intensità con cui Barth l’ha
riproposta, ha fatto sì che per gli studi successivi lo scritto barthiano diventasse
un punto di riferimento obbligato. In particolare Barth riconosce che Feuerbach
si pone come interrogativo acuto ovunque in teologia si faccia un uso incauto
che non vi è pensiero religioso senza consapevolezza dell’ateismo che lo accompagna sempre,
che non vi è possibilità di ripensare Dio, nella modernità, se non entro l’orizzonte, consegnatoci da Feuerbach, di una critica radicale delle rappresentazioni religiose, ovvero entro un orizzonte fondamentalmente secolare. Così M.Xhauffaire nel suo scritto Feuerbach et la thèologie
de la sècularisation sostiene la tesi che la negazione feuerbachiana di Dio comporti il rifiuto di
un’immagine sacrale della divinità, che occorre di fatto secolarizzare. Eppure, l’influsso che
Feuerbach esercita nella cultura moderna, non si limita unicamente alle correnti atee, ma investe anche alcune manifestazioni letterarie, filosofiche e teologiche del pensiero teistico della
modernità. In tali settori, si è andata generalmente sostituendo, ad un atteggiamento di condanna radicale, una posizione più saggia, fatta di volontà di comprensione e di ascolto. Non a
caso nel libro di Ugo Perone, Teologia ed esperienza religiosa in Feuerbach è dichiarato l’intento
di collocare Feuerbach «in una linea teologica che partendo dalla teologia di Schleiermacher
giunge fino alla teologia contemporanea; facendo emergere che vi è una fondamentale unità
tematica che va dai Pensieri alla Teogonia, e questa è data dalla religione come fede nell’uomo,
programma che Feuerbach addita per il futuro»; (U.Perone Teologia ed esperienza religiosa in
Feuerbach, Milano 1972, p. 37). Allo stesso modo H.Arvon nel suo scritto Ludwig Feuerbach ou
la trànsformation du sacrè, insiste sulla riscoperta del religioso in Feuerbach. Nello specifico,
la sua lettura di Feuerbach è imperniata sulla formula di un “umanesimo ateo” che deve la sua
ricchezza e la sua pregnanza alla riscoperta della religione in quanto concretizzazione di sentimenti umani. Dunque Feuerbach parte dalla religione per riscoprire l’uomo e per attribuirgli il
senso dell’assoluto. In questa linea, si sono dati vita a tentativi di rivalutare, in Feuerbach, ciò
che costituisce l’ “anima di verità” del suo pensiero, cercando nello stesso tempo di inverarne
le istanze di fondo e di superarne le innegabili aporie. Si è assistito così alla rivalutazione
dell’istanza umanistica e all’impegno di dimostrare che essa non è in antagonismo con una retta concezione della divinità, anzi che essa postula Dio come sua garanzia suprema. Nell’alveo
di questi tentativi, si situa anche la posizione di coloro che vedono in Feuerbach l’occasione
propizia per dare inizio ad un approfondimento del significato ultimo della religione. Anche
in questo contesto, Feuerbach viene valorizzato, non tanto per i contenuti oggettivi del suo
insegnamento, quanto per il compito che egli affida, tramite gli interrogativi che pone, alla
fede dell’uomo moderno. Nell’intento di dare una risposta a tali problemi, l’influsso di Feuerbach giunge talvolta a favorire forme di secolarizzazione e di “Cristianesimo senza Dio” tanto
accentuate, da generare l’interrogativo, se esse siano più vicine alle posizioni atee del loro interlocutore o alla visione di fede, di cui pure vorrebbero essere espressione. Altre volte, invece,
Feuerbach riesce a stimolare una vera comprensione rinnovata del fenomeno religioso, che
va da una presa di coscienza più approfondita, di ciò che è la fede, ad una sua trascrizione in
categorie più accessibili al mondo moderno. Cfr. A.Cardillo, Desiderio e destino. Saggio sulla
Teogonia di Ludwig Feuerbach, Napoli 2010.
13
K.Leese, Die Prinzipienlehre der neueren systematischen Theologie im Lichte der Kritik
L.F.s, Diss. Leipzig 1912.
160
Teresa Caporale
del pensiero della mistica, dell’unione tra Dio e uomo, dove si faccia un uso di
essi al di là di un contesto esclusivamente escatologico.
2. La presenza di una dimensione teologica anche nell’antropologia di Feuerbach
Ne La teologia protestante del XIX secolo Barth, nel capitolo dedicato a
Feuerbach, sostiene che anche quest’ultimo merita la qualifica di teologo
protestante.
Infatti, «anche se ciò che fece fu solo anti-teologia, lo fece con una tale
competenza, con un discorso così attuale per la situazione teologica, provocando
un’illuminazione così acuta di questa situazione, ed oltre a ciò offrendo anche
personalmente tali motivi di interesse, che siamo costretti a farlo parlare tra
i teologi»14, e dunque a considerare la sua posizione altrettanto teologica di
quella di molti teologi.
Sullo sfondo di questa osservazione non risulterà più così paradossale
l’interesse di Barth per il pensiero di Feuerbach, dal momento che egli
riconosce che nessuno tra i filosofi più recenti aveva affrontato, come ha
fatto Feuerbach, la teologia in una maniera così attuale e parlato di essa in
maniera così appropriata. Egli infatti intese proporre un’antitesi filosofica
ad ogni teologia, un’antiteologia che costituisce una possibilità così notevole
in seno alla problematica della nuova teologia15, una possibilità che illumina
così bene tutte le altre, da indurci, secondo Barth, a trovare in lui qualcosa di
teologicamente decisivo.
Feuerbach nega a buon diritto che la religione, secondo la sua dottrina, sia
sciocchezza, nullità, pura illusione; egli non intende dire questo. In altre parole,
Feuerbach conduce una critica serrata della religione, senza tuttavia ricollegarsi
a posizioni come quelle materialiste tradizionali e a quelle illuministe, che
vedono in essa un concentrato di false credenze, superstizioni ed errori.
Il suo obiettivo è più radicale: interrogarsi sull’essenza della religione e il
suo rapporto con l’uomo, con il proposito di aiutare quest’ultimo a conoscersi
meglio. Anzi la religione, e soprattutto il Cristianesimo (che, come Hegel,
egli considera la forma più alta ed evoluta della religiosità) ha una funzione
positiva in quanto consente all’uomo di scoprire la propria essenza, ovvero
che cos’è l’umanità. Infatti, intesa rettamente, la conoscenza di Dio non è altro
K.Barth, Die Protestantische Theologie im 19. Jahrundert, cit., p.485; tr.it. cit., p.122.
La nuova teologia è quella iniziata con Schleiermacher, che mirava a spiegare la religione e il divino solo o soprattutto in funzione dell’uomo e dei suoi sentimenti.
14
15
Karl Barth interprete di Ludwig Feuerbach
161
che la conoscenza che l’uomo ha di se stesso, una conoscenza però che non sa
ancora di essere tale. La religione è infatti per Feuerbach la prima e indiretta
autocoscienza dell’uomo, vale a dire una via più lunga che l’uomo prende per
giungere a se stesso. Feuerbach ritiene che questo fondamento antropologico
della teologia può essere svelato soltanto dalla filosofia. Così contro l’hegelismo,
ultimo rifugio, ultimo puntello razionale della teologia, egli propone una
filosofia dell’avvenire, il cui unico fondamento dovrà essere l’uomo concreto,
l’essere umano nella sua pienezza, considerato non solo come pensiero, ma
anche come natura fatta di bisogni e di sensibilità, come capacità di amore e di
relazione con gli altri esseri umani.
Dunque è proprio la fede e l’amore per l’uomo che costituiscono il centro
della filosofia di Feuerbach; e la liberazione di quest’uomo dai molti vincoli che
l’incatenano è il problema fondamentale del suo pensiero, che pur di questi
vincoli ha dolorosamente sofferto. Così Feuerbach accusa insieme la teologia,
la filosofia kantiana e quella hegeliana di avere assorbito nella ragione e nel
pensiero l’essenza divina, strappandola all’uomo; per questo egli non vuole far
altro che dare una buona volta all’uomo ciò che gli spetta. Per tale motivo,
Barth riconosce che il punto di vista di Feuerbach è tanto positivo quanto
quello di alcuni pochi teologi, cosa tanto spesso trascurata proprio dai teologi
che parlano di lui.
Egli non è dunque un mero scettico e nichilista, ma dice anche qualcosa di
positivo: Feuerbach nega solo per affermare, nega le illusioni fantastiche della
teologia e della religione, per affermare la reale essenza dell’uomo.
Dunque, dalla riflessione di Barth emerge che nel programma feuerbachiano
di trasformazione e dissoluzione della teologia nell’antropologia non bisogna
vedere solo la fine della teologia, ma anche la sua trasformazione ed il suo
proseguimento nell’antropologia. Infatti, Feuerbach stesso, nella Prefazione
alla seconda edizione dell’Essenza del Cristianesimo16, sostiene di innalzare
l’antropologia a teologia proprio in quanto abbassa la teologia all’antropologia.
Egli parla della concretizzazione e umanizzazione di Dio, ma parla pur sempre
di Dio. Pertanto si fraintenderebbe Feuerbach, se si vedesse nelle sue parole
un deprezzamento della teologia: l’essenza dell’uomo è proprio ciò che egli
solennemente e profeticamente afferma in opposizione alla teologia ed alla
filosofia idealistica. Egli identifica Dio con l’essenza dell’uomo e gli rende così il
massimo onore che può: questo è, a giudizio di Barth, «il meraviglioso omaggio
16
«Io abbassando la teologia all’antropologia, elevo piuttosto l’antropologia alla teologia,
appunto come il Cristianesimo, abbassando Dio all’uomo, ha reso l’uomo Dio»; (L.Feuerbach,
Das Wesen des Christentums, cit., p. 17, tr.it. cit., p.17).
162
Teresa Caporale
che Feuerbach rende al buon Dio»17. Per tale motivo, il pathos e la forza della
negazione di Feuerbach sono fondati in ciò che in lui c’è di positivo.
Chi volesse attaccarlo, dovrebbe attaccare la sua terapia, la sua dottrina
positiva dell’essenza dell’uomo, intesa come essenza divina. Se su questo punto
non è attaccabile, ogni critica mossa alla sua negazione ed alla sua antiteologia
può solo consistere nell’affermarla e nel ribadirla.
Barth dunque riconosce che l’intenzione di Feuerbach è semplice, ma di
importanza notevole: prendere Schleiermacher e Hegel con serietà nel punto in
cui essi affermano la non-oggettività di Dio. Trasformare dunque la teologia, che
già sembrava volerlo a metà, del tutto in antropologia, giungere dal cielo alla
terra, da Cristo a noi stessi, ma soprattutto da ogni forma di soprannaturalismo
alla vita reale: questo era ciò che voleva Feuerbach, il quale in realtà non
poteva non giungere a simili conclusioni, non poteva dire diversamente18, dal
momento che già da tempo la teologia era diventata antropologia.19 Secondo
Barth, questo processo affonda le sue radici nel pensiero di Lutero, il quale
fissò, forse inconsapevolmente, i binari su cui la teologia successiva si sarebbe a
poco a poco trasformata in antropologia. Dunque a giudizio di Barth, è motivo
di particolare riflessione il fatto che Feuerbach si sia appellato di preferenza
a Lutero: innanzitutto al concetto di fede luterano (in base al quale la fede è
intesa come un’ipostasi divina), nonché alla cristologia e alla dottrina luterana
dell’incarnazione. A tal proposito Lutero ha insegnato che la divinità non va
ricercata in cielo ma sulla terra, nell’uomo Gesù, il che equivale ad ammettere
la possibilità di un’inversione del sopra e del sotto, del cielo e della terra, di
Dio e dell’uomo20. Si tratta di un modo di procedere che Barth non condivide:
K.Barth, Die Theologie und die Kirche. Gesammelte Vortraege, cit. p.20, tr.it., cit., p.114.
« I veri teologi non gli avevano forse preparato il cammino in questa direzione? Pensiamo alla dottrina di Schleiermacher sul rapporto tra Dio e l’emozione pia, o alla sua cristologia e alla dottrina della riconciliazione, che sembrano essere proiettate all’indietro a partire
dall’esperienza propria del soggetto umano. Ripensiamo a Hegel e agli hegeliani, e alla potenza che il soggetto umano, nel suo automovimento dialettico, in essi riceve, in definitiva anche
sopra Dio e la sua rivelazione. Ma pensiamo anche a Tholuck, con la sua proclamazione del
cuore quale luogo della sapienza di Dio nell’uomo. Il problema è se Feuerbach non rappresenti il punto di incontro nel quale convergono tutte quelle linee, per quanto questo non fosse
inteso dai loro autori. A partire da quei presupposti si poteva efficacemente ovviare a queste
conseguenze? Potevano i teologi dire chiaramente a questo anti-teologo almeno che essi intendevano qualcosa di diverso?»; (Id., Die protestantische Theologie im.19 Jahrhundert, cit.,
p.486-87; tr.it. cit., p.124-25).
19
« Da lungo tempo la teologia è diventata antropologia, dopo che proprio il protestantesimo, soprattutto con Lutero, ha allontanato l’interesse da ciò che Dio è in sé, e con insistenza lo
ha volto a ciò che Dio è per gli uomini. L’evoluzione della teologia procede inarrestabilmente
nel senso che l’uomo contesta sempre più Dio, ed afferma sempre più se stesso »; (ibidem).
20
Feuerbach rivendica di fatto la necessità che la filosofia prenda le mosse dal finito e non
dall’infinito, dal particolare e non dall’universale, dal concreto e non dall’astratto. Egli intende
17
18
Karl Barth interprete di Ludwig Feuerbach
163
egli, al contrario, è convinto del fatto che fino a quando non avremo fissato
l’irreversibilità del rapporto tra Dio e l’uomo in modo assoluto, non avremo
pace, saremo ancora prigionieri di quella umanizzazione della teologia che
affonda le sue radici nel pensiero luterano. Occorre perciò che tale pensiero sia
rinnovato ed approfondito alla luce di Calvino. Eppure la teologia tedesca non
si era rivelata in grado di fare ciò, difendendosi per secoli vigorosamente contro
il correttivo calvinista e portando alla completa dissoluzione della teologia in
antropologia.
Eppure, a giudizio di Barth, Feuerbach fece un buon salto avanti rispetto
alla nuova teologia, rispetto a quella tradizione di pensiero che si è sviluppata
a partire dall’insegnamento luterano. Infatti, tutte le sue spiegazioni e
interpretazioni della dogmatica cristiana partono proprio da quel punto in cui
è collocata tutta la tradizione cristiana. Il suo deciso antispiritualismo, che
non risparmiava neanche il maestro Hegel, è un realismo antropologico, che
lo collega in modo straordinario, tra i predecessori, al teologo e predicatore
protestante, di tendenza conservatrice opposta all’indirizzo di Baur, ossia
Menken, e, tra i contemporanei, al predicatore pietista svevo J.T. Beck e a J.Chr.
Blumhardt.
A Feuerbach interessa l’intera realtà (cuore e stomaco) dell’uomo, perché
solo lì è possibile parlare veramente di Dio. A lui interessa l’esserci e l’esser tale,
l’esistenza dell’uomo, che apparentemente è così ovvia e priva di interesse. Non
gli importa della sua esistenza spirituale né di quella corporea isolatamente
intese; ma l’una e l’altra nella loro unità, in cui consiste appunto l’esistenza
dell’uomo.21 Egli vuole che si affermi questa esistenza umana così come si
dimostrare come l’inizio di essa non sia dunque Dio o l’assoluto, ma quel che è finito, determinato e reale. Da ciò la celebre affermazione: « Il segreto della teologia è la antropologia»,
che apre le Tesi provvisorie per una riforma della filosofia, e costituisce il principio che sta alla
base di tutta la critica di Feuerbach alla religione. Nella teologia si esprime dunque, in forma
mistificata e rovesciata, un’antropologia; cioè l’essenza umana costituisce l’essenza originale
della religione, le cui affermazioni sono fasulle, in quanto Dio è solamente la proiezione delle
qualità e dei desideri presenti nella mente degli uomini. In particolare, dice Feuerbach, ciò
che attribuiamo a Dio, la sua eternità, la sua infinità, la sua perfezione, non sono altro che
l’eternità, l’infinità e la perfezione che trovano dimora nella mente degli uomini sotto forma di
sentimenti. Si tratta allora di portare alla luce il meccanismo alienato che conduce alla scissione di Dio dall’uomo. Se l’uomo è l’unica entità esistente e Dio non è altro che un sentimento
contenuto nella coscienza degli uomini, allora non può essere che Dio e l’uomo siano entità
diverse; in realtà essi albergano in un’ identica essenza, l’unica, quella umana.
21
Questa concezione feuerbachiana dell’uomo fu criticata innanzitutto da Marx, per il
quale l’individuo di cui parla Feuerbach è in realtà soltanto un borghese, un uomo privato
senza una vita pubblica e comune. Marx pertanto accusa Feuerbach di non aver compreso la
necessità del rapporto tra l’individualità e la società, “nella quale l’uomo vive come un pesce
fuor d’acqua”, di essersi fermato alla intuizione naturalistica dell’uomo e a quella meccanica
della società. Per realizzare questa liberazione dell’uomo dalla società borghese, e per arrivare
164
Teresa Caporale
realizza nel rapporto dell’io e del tu con la coscienza di se stesso e del mondo.
Poiché nella religione si tratta proprio di questa affermazione, la religione è
per lui sensatezza e non insignificanza. In ciò Feuerbach procede in modo
umanamente onesto. Egli, a giudizio di Barth, considera con la debita serietà
ogni teologia specificamente accademica, che comincia con delle astrazioni e
si sviluppa in un’ideologia del tutto estranea alla vita reale, che l’uomo vive
nelle sue città, nei suoi villaggi, nelle sue botteghe e nelle sue osterie. Ma per
di più Feuerbach procede in modo oggettivamente cristiano; infatti pone come
inizio e fine della teologia Adamo ed Eva nella loro nudità ed in un certo modo
sembra intravedere la resurrezione della carne.
Barth riconosce che la teologia cristiana, fin dalla Riforma non ha dato la
debita importanza alla speranza cristiana; la sua mondanità spiritualistica l’ha
allontanata dalla vita reale e dall’uomo reale e proprio con ciò l’ha resa troppo
umana. Proprio nel suo più alto idealismo umano ha fatto nascere il sospetto
che il suo Dio, cioè il suo al di là, potesse essere un’illusione umana, rispetto a
cui fosse bene restar fedele alla terra. Con questo richiamo assai giusto, che è
necessario alla conoscenza del vero Dio, Feuerbach ha lavorato così bene, dice
Barth, da superare tutti i teologi nuovi e nuovissimi. Non c’è dubbio che la sua
dottrina è di un’evidenza impareggiabile. Barth ribadisce così che Feuerbach
non nega né Dio né la teologia.
A tal proposito così egli si esprime ne La teologia protestante del XIX secolo:
«Questo fu il movimento del pensiero di Ludwig Feuerbach, e fu un movimento
essenzialmente teologico, non solo, ma fu un movimento di buona teologia
critica, in quanto portò a legittima dissoluzione la “cattiva” impostazione
borghese, che aveva sottoposto alla imperialistica volontà di potenza dell’uomo
all’uomo comunista che si identifica con la sua comunità, Marx si rivolge al proletariato, poiché questo rappresenta l’antitesi totale rispetto alla realtà sussistente. Soltanto il proletariato,
come perdita completa dell’uomo, può essere anche capace di una totale riconquista dell’unità
e della totalità di esso. Proprio da questo, contrapposto alla società borghese, Marx attinge
la sua idea di un uomo universale, semplicemente umano. Anche Engels, nel suo scritto su
Feuerbach osserva: « Lo stesso Feuerbach, che ad ogni pagina va predicando l’immersione nel
concreto, si mostra ovunque astratto. Ci colpisce la stupefacente povertà di Feuerbach, se lo
mettiamo a confronto con Hegel. L’etica, ossia la dottrina dell’eticità di quest’ultimo, è sviluppata nella Filosofia del diritto, e comprende:1) il diritto astratto, 2) la moralità, 3) l’eticità, che
comprende a sua volta i tre momenti della famiglia, della società civile, e dello Stato. Qui è
tanto idealistica la forma, quanto realistico il contenuto. In Feuerbach avviene proprio il contrario. Nella forma egli è realistico e parte dall’uomo, ma non ci parla assolutamente del modo
in cui quest’uomo vive: siamo così sempre di fronte al medesimo uomo astratto, che dominava
nella filosofia della religione». ( F. Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen
deutschen Philosophie, Dietz, Berlino 1946, p.286; tr.it. P.Togliatti, Ludwig Feuerbach e il punto
d’approdo della filosofia classica tedesca, a cura di G.Sgrò, Napoli 2009, p.48).
Karl Barth interprete di Ludwig Feuerbach
165
i contenuti arcani della rivelazione».22 Dunque, la negazione di un’essenza
divina astratta, distinta dalla natura e dall’uomo, in Feuerbach è solo il
rovescio dell’affermazione dell’essenza di Dio quale vera essenza dell’uomo;
è la negazione di una teologia falsa, che distingue le proposizioni teologiche
da quelle antropologiche; è solo il rovescio dell’affermazione dell’antropologia
quale vera teologia.
Feuerbach afferma, loda, ama l’uomo nella sua volontà vitale, nei bisogni, nei
desideri e ideali, nei quali vuol superare la sua dipendenza, la sua limitatezza,
il suo stato di minaccia. Dunque egli vorrebbe solo che si comprendesse e si
riconoscesse che il nome “Dio”, nel quale si affollano per gli uomini i nomi più
elevati, più venerati e più amati, in origine e nella forma più autentica è sorto
dal cuore umano, che quindi nella religione si tratta, nel senso più profondo di
se stessi, che in Dio si tratta della propria volontà vitale e non di una seconda
realtà, diversa, che le sia contrapposta.
Eppure, l’interesse che Dio esista, è in Feuerbach una sola cosa con l’interesse
che l’uomo esista, e che esista eternamente, e questo interesse giunge al suo
compimento nella coscienza della specie alla quale io mi elevo, nell’atto in cui
io pongo Dio come essente. Dunque Barth, nella sua riflessione su Feuerbach,
fa emergere che per quest’ultimo la religione esiste, è possibile e necessaria; ma
l’uomo è l’inizio, il centro e la fine della religione: l’uomo è soltanto l’uomo. A
partire da questo presupposto Feuerbach vuole rendere i teologi antropologi.
Questo è quanto egli vuole esprimere come verità liberatrice, dopo che, come
non si stanca di ripetere, l’ha dimostrato con evidenza da lungo tempo il
processo effettivo della storia della religione, della chiesa e della teologia.
3. La critica alla concezione feuerbachiana dell’uomo: il problema del male e della
morte del singolo
A Feuerbach interessa l’esistenza dell’uomo, precisamente l’esistenza
sensibile dell’uomo. Egli voleva che l’al di là di Dio si trasferisse nell’al di qua
dell’uomo. Questo poteva significare una negazione dell’al di là di Dio, e perciò
di Dio stesso. Ma Barth nota che negare o ignorare il rapporto dell’al di là di
Dio con l’al di qua dell’uomo potrebbe, anch’esso, significare una negazione di
Dio. Così ci si domanda se ciò che corrisponde a Dio non sia effettivamente
quell’uomo integrale, anima e corpo, del quale manifestamente Feuerbach
22
I.Mancini, Introduzione a La teologia protestante nel XIX sec., cit., p.55.
166
Teresa Caporale
voleva parlare. A tal proposito Barth sostiene che se c’è una cosa che si deve
obiettare a Feuerbach è proprio il fatto che quell’ “essenza dell’uomo”, che
egli faceva misura di tutte le cose, cui egli voleva riconoscere la vera realtà
umano-divina, avrebbe potuto anch’essa essere nient’altro che una finzione
soprannaturalistica, al pari della ragione hegeliana o di qualsiasi altra astrazione.
Questo di fatto gli era stato obiettato da un altro hegeliano del suo tempo, che
procedeva ulteriormente a sinistra: Max Stirner.23 Quest’ultimo infatti porta alle
estreme conseguenze l’umanizzazione del mondo e dell’uomo stesso operata da
Feuerbach, distruggendo anche l’idea dell’uomo, dell’universalmente umano.
Egli accentua la carica critica nei confronti della religione, dello stato, di ogni
nobile idealità. A giudizio di Stirner infatti, tutti gli ideali che pretendono di
subordinare l’individuo devono essere rifiutati in nome della libertà individuale,
che ha la sua origine, il suo centro, il suo scopo nel singolo. La sua tesi di fondo
è che l’unica realtà effettiva è proprio il singolo, e che Dio è solo una creatura
dell’uomo, che in essa proietta le sue spinte egoistiche. Come Feuerbach, Stirner
rovescia il rapporto natura-spirito, ma a questo aggiunge il rovesciamento
del rapporto individuo-universalità: mostra la falsità dei grandi fini religiosi
e umanistici dietro i quali si cela, come unico fondamento, l’individuo con i
suoi egoismi e la sua ansia di scrollarsi dalle spalle ogni forma di soggezione
e di controllo24. Così, disgustato dalle idee teologiche, metafisiche, umane e
sociali di Dio e dell’uomo, Stirner finisce col fondare la sua causa sul nulla25, per
23
Stirner attacca le forme moderne di religiosità (compreso il pensiero di Feuerbach), che
pretendono di avere compiuto un gesto razionale e dissacratorio eliminando Dio e sostituendovi l’uomo: esse non si accorgono di aver riprodotto, mantenuto, a un livello laico, lo stesso
rapporto di dominio e subordinazione cui il singolo era sottoposto nel tradizionale rapporto
religioso. In altre parole, Stirner vuole mostrare che l’elevare l’uomo a essere supremo e universale, rappresenta soltanto un ultimo travestimento della fede cristiana nell’umanità di Dio.
Infatti il Dio cristiano, che è spirito, si è un po’alla volta volatilizzato nello spirito dell’umanità.
Egli arriva così alla conclusione che «in questo Cristianesimo del tutto umanizzato si ritorna
in realtà alla prima origine, cioè all’uomo semplicemente, che, in quanto Cristo, rappresentava
il principio e il fine sovraumano della storia. Tuttavia quanto più si ritrova un essere supremo
nell’uomo come tale, tanto più io debbo scoprire che quest’uomo assoluto è per me estraneo
come un tempo lo era il Dio assoluto o lo Spirito»; (K.Lowith, Dio, uomo e mondo da Cartesio
a Nietzsche, tr.it. dal ms. di A.L.Kunkler Giavotto, Napoli 1989, p.98).
24
«Ogni essere superiore a me stesso, sia Dio o l’uomo, indebolisce il sentimento della
mia unicità e impallidisce appena risplende il sole di questa mia consapevolezza. Se io fondo
la mia causa su di me, l’unico, essa poggia sull’effimero, mortale creatore di sé che se stesso
consuma, e io posso dire: Io ho fondato la mia causa su nulla»; (M.Stirner, Der Einzige und
sein Eigentum, Reclam, Stuttgart 1972, p.379; tr.it. L’unico e la sua proprietà, tr.it. Leonardo
Amoroso, Milano 1979, p.381).
25
«Dio e l’umanità hanno fondato la loro causa su nulla, su null’altro che se stessi. Allo
stesso modo io fondo allora la mia causa su me stesso, io che, al pari di Dio, sono il nulla di
ogni altro, che sono il mio tutto, io che sono l’unico»; (Ivi., p.7; tr.it. cit., p.13).
Karl Barth interprete di Ludwig Feuerbach
167
dichiarare il mondo, per quanto lo può sfruttare, sua proprietà.26 Egli sostiene
che dal momento in cui anche l’uomo è morto, l’agire dell’io non è altro se non
uno sfruttamento di sé e del mondo che gli appartiene. Infatti in quanto Io,
l’uomo non ha più in genere alcuna missione o destinazione, ma è ciò che ogni
volta può essere, nulla di meno e nulla di più. Questo Io nichilistico di cui parla
Stirner può apparire ai rappresentanti dell’uomo universale come un egoistico
“non uomo”, ma in realtà questo egoista particolarissimo si trova in ciascuno,
dal momento che ognuno pone se stesso al di sopra di tutto. Dunque Stirner non
sogna più la libertà e l’emancipazione, ma si decide invece per la particolarità:
«la mia causa non è né il divino, né l’umano, non è ciò che è vero, buono,
giusto, libero, ecc…, bensì solo ciò che è mio, e non è una causa generale, ma
unica, così come io stesso sono unico. Non c’è nulla che mi importi più di me
stesso!».27
Al contrario Feuerbach, con la teologia del suo tempo, ha operato con
l’uomo in generale, ed in quanto attribuiva a questo la divinità, non diceva nulla
di fatto sull’uomo reale.28
26
«Se noi vogliamo liberare il mondo da parecchie schiavitù, non è per il mondo, ma per
noi; siccome infatti noi non siamo redentori del mondo di professione o “per amore”, noi
vogliamo solo toglierlo agli altri. Noi vogliamo farne nostra proprietà: il mondo non deve più
essere schiavo di Dio (della Chiesa) o della legge (dello Stato), ma nostro proprio; per questo
vogliamo guadagnarcelo e accattivarcelo, perfezionando il suo potere e insieme rendendo superfluo che lo rivolga contro di noi. E in ciò riusciremo perché andremo incontro al mondo e,
appena apparterrà a noi, a esso ci arrenderemo. Quando il mondo sarà nostro, il suo potere
non sarà più contro di noi, ma con noi. Il mio egoismo ha interesse a liberare il mondo in modo
tale che esso diventi mia proprietà»; (Ivi., p.317; tr.it. cit., p.320).
27
Ivi., p. 13, tr.it. cit., p.17. Tale Io particolare vive nell’ “unione degli egoisti”, ossia in una
forma di associazione in cui ciascun individuo può liberamente svilupparsi e potenziare se
stesso (Stirner viene perciò considerato uno dei padri dell’anarchismo). L’Io di cui parla rappresenta la fine nichilistica dell’umanità cristiana, il cui ultimo uomo è un “non uomo”, come
il primo era stato un “superuomo”. Si tratta di un Io che vive secondo le proprie inclinazioni,
senza preoccuparsi dell’idea fissa di Dio e dell’umanità: «Dio si preoccupa solo di ciò che è
suo, si occupa solo di sé, pensa solo a sé e vede solo sé; guai a tutto ciò che a lui non è gradito! Egli non serve quindi qualcuno che stia più in alto di lui e soddisfa solo se stesso. La sua
causa è una causa puramente egoistica. Come stanno le cose per quel che riguarda l’umanità,
la cui causa dovremmo far nostra? Forse che la sua causa è quella di qualcun altro? L’umanità
serve una causa superiore? No, l’umanità guarda solo a sé, l’umanità vuole far progredire solo
l’umanità, l’umanità è a se stessa la propria causa. Per potersi sviluppare lascia che popoli e
individui si logorino al suo servizio, e quando essi hanno realizzato ciò di cui l’umanità aveva
bisogno, essa stessa li getta, per tutta riconoscenza, nel letamaio della storia. Non è forse la
causa dell’umanità una causa puramente egoistica?»; Ivi., p.6; tr.it. cit., p.12.
28
«Il difetto capitale di ogni materialismo fino ad oggi (compreso quello di Feuerbach) è
che l’oggetto, la realtà, la sensibilità vengono concepiti solo sotto forma dell’obbietto o dell’intuizione, ma non come attività umana sensibile, prassi. Feuerbach risolve l’essenza religiosa
nell’essenza umana. Ma l’essenza umana non è qualcosa di astratto, che sia immanente all’individuo singolo. Nella sua realtà essa è l’insieme dei rapporti sociali. Feuerbach non penetra
nella critica di questa essenza reale, è perciò costretto: 1) ad astrarre dal corso della storia, a
fissare il sentimento religioso per sé, ed a presupporre un individuo umano astratto, isolato.
168
Teresa Caporale
E se egli ancora confonde l’uomo singolo, reale con l’uomo in generale e
giunge al punto da attribuire la divinità all’uomo singolo, ciò dipende, secondo
Barth, dal fatto che Feuerbach non è stato seriamente ed effettivamente
consapevole né della malvagità del singolo, né della necessità che questo singolo
muoia.29
In uno scritto del 1830, Pensieri sulla morte e l’immortalità, Feuerbach fin
dalle prime pagine, afferma certamente la realtà della morte, intesa sempre
come morte dell’individuo in quanto singolo, ma l’uomo in quanto specie o
genere umano non muore mai.
Nella ironica dedica in versi che apre i Pensieri, Feuerbach invita il
“sapientissimo ed autorevolissimo pubblico colto” a voler ricevere la morte nel
corpo accademico, conferendole il titolo di dottore in filosofia. Egli sostiene
che il destino dell’uomo singolo è la morte; la gioia di vivere della natura è nello
stesso tempo gioia di uccidere; e la nascita di un ente è sempre anche la morte
di un altro. Questa è per Feuerbach la radice dell’infelicità dell’essere finito.
L’uomo sente che l’universo nel quale vive è pieno di fratture, e c’è il dolore che
glielo dimostra, ma soprattutto la morte: «è ben vero che il posto del morto
è sempre preso da un nuovo essere; ma questo ente, quello nuovo e diverso
che viene al posto del primo, non riempie il posto in cui quello si trovava, e
proprio perché è un altro; dovrebbe altrimenti essere del tutto identico a quello
trapassato»30. Quindi la morte è considerata da Feuerbach come niente più che
un aspetto del processo cosmico, continuamente negata dalla vita che risorge:
«nella natura noi assistiamo alla continua scomparsa di ciò che è esistito; ci
permette questo di concludere alla vanità della vita terrena? Al contrario: la
vita corporea rimane l’ultima forma di vita; la vita per esser tale deve avere
la propria radice in sé, e non in un creatore esterno».31 Dunque, a giudizio di
Feuerbach, non c’è fine, destinazione, che non sia individuale, e che non si
esaurisca quindi col singolo, il quale prende atto della propria finitezza e la
accetta, conscio che essa non è un mero nulla.
Infatti per Feuerbach la specie, l’uomo in quanto genere umano, è eterno:
«di ciò si fa garante lo stesso spirito infinito; eterno è lo spirito, incorruttibile
2) L’essenza umana può dunque essere definita soltanto come “genere”, cioè come universalità interna, muta, che leghi molti individui naturalmente»; (K.Marx, Tesi su Feuerbach, tr.it.
F.Codino, Roma 1985, p.84).
29
«Se Feuerbach avesse guardato l’uomo reale, e non la specie e l’essenza umana, se l’avesse visto come essere nella distretta, e per la morte, non l’avrebbe certo considerato come Dio»;
(I.Mancini, Introduzione a La teologia protestante del XIX secolo, cit., p. 58).
30
L.Feuerbach, Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, Lipsia 1876, p.86; tr.it. F.Bazzani,
Pensieri sulla morte e sull’immortalità, Roma 1997, p. 110.
31
C.Cesa, Introduzione a Feuerbach, Bari 1978, p.173.
Karl Barth interprete di Ludwig Feuerbach
169
ed infinita la coscienza, e sottratti ad ogni naturalità, e quindi anche alla morte,
sono la libertà e la volontà. Ma tu, in quanto persona determinata, oggetto della
coscienza e non coscienza, uscirai necessariamente una volta da essa, ed al tuo
posto una persona nuova si affaccia al mondo della coscienza».32
Alla luce di queste affermazioni, si può comprendere il senso della critica
che Barth muove a Feuerbach: egli non nega che quest’ultimo si sia confrontato
col tema della morte, ma vuole far emergere che l’uomo del quale Feuerbach
parla, si sente perennemente alle spalle questa esperienza; sa che la morte non
ha alcuna realtà per sé stante, né costituisce per lui un vero limite. Essa infatti
scomparirà senza lasciare alcun residuo, dal momento che è sempre morte
dell’individuo in quanto singolo, il quale però in quanto specie o genere umano
vivrà in eterno.
Diversamente da Feuerbach, Barth sostiene che solo chi riconosce che noi
uomini non siamo eterni, ma dobbiamo morire, e che siamo malvagi dalla testa
ai piedi, riconoscerà come la più grande illusione la tesi che l’essenza di Dio sia
l’essenza dell’uomo.
Eppure in questa sua critica a Feuerbach lo stesso Barth si rende conto del
fatto che anche la teologia del suo tempo non era consapevole né del singolo, né
del male, né della morte in maniera sufficientemente precisa da poter istruire
Feuerbach in tal senso.33 In questa maniera però, a giudizio di Barth, non si
poteva più andare avanti: perciò, contro qualsiasi tentativo di identificazione
tra Dio e l’uomo, egli si assume il compito di dimostrare che Dio è Dio, e lo è
non solo rispetto al cosmo naturale, ma anche rispetto all’uomo ed all’uomo
religioso e cristiano34.
L.Feuerbach, Pensieri sulla morte e l’immortalità in Opere, tr.it. C.Cesa, Bari 1965, p.67.
E allora quale alternativa? Chiudendo il suo capitolo su Feuerbach, Barth afferma: «ci si
poteva guardare da lui non con quella teologia che gli stava d’attorno; ma solo con la teologia
del grido: Dio ci guardi!»; (K.Barth, Die protestantische Theologie im.19 Jahrhundert, cit. p.462,
tr.it. cit., p. 127).
34
« Di derivazione apertamente kierkegaardiana è la differenza qualitativa che è alla base
della teologia barthiana. Del resto Barth stesso, nella seconda edizione del suo commento
all’Epistola ai Romani (1922) scriveva testualmente: “se ho un sistema esso consiste in questo,
che cerco di tenere presente, con la maggiore possibile costanza, nel suo significato negativo e
positivo, quella che Kierkegaard definisce: l’infinita differenza qualitativa tra il tempo e l’eternità. Dio è nel cielo, tu sei sulla terra. La relazione di questo Dio con questo uomo, la relazione
di quest’uomo con questo Dio è per me il tema della Bibbia e al tempo stesso la somma della
filosofia. I filosofi chiamano questa crisi della conoscenza umana: l’origine. La Bibbia vede a
questo incrocio di vie Gesù Cristo ”. Fondandosi su questa citazione, Barth è stato considerato
da molti critici, come uno dei promotori della Kierkegaard-Rènaissance. Ma questo non rende
ragione di tutto Barth, non degli sviluppi posteriori del suo pensiero: egli non va a sfociare in
una filosofia dell’esistenza, in una tormentosa escavazione del Dasein per estrarne la soluzione
immanente dell’enigma dell’esistenza. Dopo la riconquista del “totalmente altro”, si stabilisce
nella certezza di una concezione teocentrica. Forse i critici hanno esagerato sulla portata di
32
33
170
Teresa Caporale
Qualsiasi presunzione religiosa umana deve sparire e deve subentrarvi
soltanto la conoscenza che viene da Dio.
4. Il riconoscimento da parte di Barth della necessità di dover fare i conti anche
con l’umanità di Dio
Nonostante la sua convinzione circa la sussistenza di un’infinita distanza
tra Dio e l’uomo, Barth tuttavia riconosce che tra i due sussiste una dinamica
relazione tra partners posti uno di fronte all’altro: non c’è avvicinamento,
ma società, rapporto. Dunque nonostante restino due entità diverse, ciò non
esclude la possibilità della relazione, il rivelarsi di Dio in Gesù Cristo come
Dio per l’uomo, anzi nella cristologia la stessa teologia ammette che Dio è
senz’altro uomo. Barth si rende conto della necessità di dover fare i conti anche
con questa umanità di Dio35 e con tutto ciò che essa comporta, ma sa evitare il
questa dichiarazione di Barth, arrivando alla conclusione che Kierkegaard sia, se non proprio
l’unica, almeno la sorgente principale del pensiero barthiano. Noi, invece, pensiamo che vi
siano stati altri profondi influssi che hanno aiutato Barth a definire il rapporto tra tempo ed
eternità, tra uomo e Dio. Non si può negare, del resto, che egli abbia evitato volutamente un
aspetto essenziale del pensiero kierkegaardiano (l’orientamento verso l’esistenza!) e ciò sarebbe già sufficiente a non farlo considerare suo “discepolo”, oltre al fatto che negli anni successivi, Barth, in tante maniere, ha fatto intendere che il suo accostamento al teologo danese
è stato casuale o meglio ancora provvisorio. Così quando si rese conto che l’individualismo
esistenzialista è sulla stessa linea dell’esperienza mistica, per la quale già Kierkegaard s’era
piegato al pietismo, mantenne di Kierkegaard il contrasto dualistico- paradossale, il concetto
della differenza qualitativa tra Dio e la realtà cosmica, ma s’oppose all’intimità, al soggettivismo di lui. Insomma Barth attinge a Kierkegaard, ma non si tratta di una semplice ripetizione
dei principi teologici del Danese: Barth, prima che gli elementi del pensiero kierkegaardiano
passino nel suo sistema, li medita, li vaglia, li adatta alla sua maniera di concepire la teologia»;
(N.Longobardi, L’ecclesiologia di Karl Barth nel Romerbrief, Napoli 1973, pp.80-82).
35
Infatti con l’andar degli anni Barth ha maturato sempre più lucidamente una persuasione, ossia che il suo pensiero conteneva un errore profondo, consistente in una insufficiente,
parziale, imprecisa sottolineatura della “divinità di Dio”. Per questo, nel 1956, ad Aarau, egli
compie una pubblica retractatio, ossia un’autocritica della sua impresa giovanile, attestando
invece, questa volta, l’umanità di Dio. Molti studiosi di Barth si sono chiesti se sia possibile
distinguere nel pensiero di questo autore diversi periodi e addirittura parlare di una vera e
propria svolta avvenuta nel corso del suo iter teologico. Tra questi, Balthasar parla di una
“evoluzione” nell’ambito della teologia di Barth. È infatti per lui chiaro che il contenuto materiale della Dogmatica è diverso da quello dei saggi teologici della giovinezza, ma non per
questo Balthasar crede che siano mutati i principi formali di quella teologia. Anzi egli insiste
proprio sul fatto che nonostante la sua ampia evoluzione, Barth sia rimasto, nel più profondo,
fedele a se stesso. L’intuizione dell’inizio ha certamente assunto forme espressive, concettuali
e linguistiche diverse, ma in questo cammino essa si è chiarita, purificata, confermata. Anche
Italo Mancini è d’accordo sul fatto che il discorso di Barth col passare del tempo «si completa, ma non si spezza»; (I.Mancini, Il pensiero teologico di Barth nel suo sviluppo in K.Barth,
Kirchliche Dogmatik, cit., p.79). Più precisamente egli sostiene che il contenuto del pensiero
barthiano assume un nuovo orientamento, una nuova prospettiva, come ha riconosciuto egli
Karl Barth interprete di Ludwig Feuerbach
171
rischio del completo capovolgimento della “teologia in antropologia”. Egli ha
saputo soffermarsi su ciò che Dio è in sé, ma senza mai considerarlo un’ entità
astratta, anzi preoccupandosi gelosamente della concretezza del Dio biblico
che si rivela nel Figlio Incarnato. In Gesù Cristo non è presente un Dio lontano,
inattingibile, estraneo a tutto ciò che è umano e perciò persino disumano, ma
un Dio vicino, solidale, familiare. Al tempo stesso in Gesù Cristo non è neppure
stesso nel 1956: nella speculazione dell’ Epistola ai Romani era comparsa solo una metà della
verità cristiana, quella polemicamente legata al tema della divinità di Dio; ora si trattava di
recuperare l’altra metà: l’umanità di Dio; si badi, non l’umanità dell’uomo, il suo spazio, il che
significherebbe che il precedente discorso viene messo da parte; al contrario, facendo sempre
centro su Dio, si tratta di vedere come a lui competa anche il diventare uomo, e che solo in
questo diventare uomo, carne, mondo, storia, da parte di Dio, acquistano senso il mondo, la
storia, la naturalità dell’uomo. E Barth ha avuto chiaro tutto questo fin dall’inizio.Cornelio Fabro invece, distingue il pensiero di Barth in 3 periodi: nel primo (che abbraccia gli scritti fino
alla prima edizione dell’ Epistola ai Romani del 1919), egli non sembra escludere la possibilità
di una conoscenza del vero Dio a partire dalle cose sensibili ed in questo senso interpreta il
noto testo paolino; nel secondo periodo invece (che inizia con la seconda edizione dell’Epistola
ai Romani(1922), e continua con i primi due volumi della Dogmatica Ecclesiale(1932-1942),
Barth afferma che Dio può essere conosciuto soltanto con la fede. Uno dei principali e decisivi
influssi, responsabili di questo “importante cambiamento di rotta”, sarebbe venuto da Kierkegaard. C’è poi il terzo periodo, che va dal 1946, in cui Barth sembra tornare alla prima posizione di un atteggiamento più favorevole verso la capacità della ragione nella conoscenza di Dio
e quindi intende colmare l’abisso fra la ragione e la fede e ammettere una certa capacità della
prima nella presentazione di prove filosofiche per l’esistenza di Dio. Comunque Fabro, pur
distinguendo questi tre diversi periodi nel percorso teologico di Barth, non manca di precisare
che un lettore attento è capace senz’altro di avvertire la continuità e unità del suo pensiero sia
per il problema di Dio che per il concetto di fede teologica, sui quali Barth è sempre rimasto
dall’altra sponda della soluzione della metafisica realista e della tradizione cattolica.
Anche Andrea Milano fa emergere come «questo autore con l’andar degli anni abbia maturato sempre più lucidamente una persuasione: la necessità di abbandonare il metodo dialettico per praticare con crescente determinazione il metodo dell’analogia tra uomo e Dio (non
l’analogia fondata sull’essere, bensì sulla fede). Barth si rendeva conto che il suo errore consisteva in un’insufficiente, parziale, imprecisa sottolineatura della divinità di Dio. Ed ecco che
nel 1956 ad Aarau, compie un’autocritica della sua impresa giovanile attestando invece questa
volta l’umanità di Dio. Tutto questo però, sottolineava lo stesso Barth, sempre sulla base del
riconoscimento della sua divinità e a partire da essa. Il suo intento era dunque perfezionare
e completare la sua originaria posizione (che non veniva perciò negata) ». (A. Milano, Rivelazione ed ermeneutica. Karl Barth, Rudolf Bultmann, Italo Mancini, cit., p.505). A tal proposito
un’altra studiosa di Barth, Tina Manferdini, risulta molto vicina alla posizione di Milano, nel
sostenere che « quella svolta impressa da Barth al suo precedente pensiero teologico, è una
“ritrattazione” nel senso di un ritorno su ciò che fu detto e che aveva la sua parte di verità, per
allargare e approfondire il campo della riflessione e dire una parola più vera, perché più completa ». (T.Manferdini, Il problema della religione. Barth e Schleirmacher, Bologna 1984, p.363 )
Analizzate le posizioni dei vari studiosi di Barth presi in esame, possiamo concludere sostenendo che egli, giunto ad una fase più matura del suo pensiero, ridimensiona, senza però
mai smentire, l’aspetto della dualità, dell’alterità, dell’ “infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio”, e dà maggiore spazio al messaggio dell’incontro, dell’alleanza, dell’amicizia che si
stringe tra i due termini. Gesù Cristo assume allora una importanza centrale e al “paradosso”
si sostituisce la categoria dell’ “umanità di Dio”, che non significa però un ripiegamento, bensì
un nuovo inizio e attacco, nel quale ciò che fu detto in precedenza è più che mai da dire, è
soltanto da dire meglio.
172
Teresa Caporale
presente un uomo astratto, che pensa di essere autosufficiente e, in virtù della
sua religione e morale, si illude di diventare egli stesso Dio. Proprio in Gesù
Cristo non c’è nessuna chiusura di Dio verso il basso, ma neppure nessuna
chiusura dell’uomo verso l’alto. Per questo Barth sostiene che l’intera teologia
dovrà continuamente essere orientata in direzione cristologica.36
Da quanto detto fino ad ora emerge che è vero che Barth critica la riduzione
della teologia in antropologia e in generale la teologia liberale nella quale si
ha sempre a che fare con l’uomo, ma non per questo si fa portavoce di un Dio
astratto, al quale non interessa nulla del mondo umano. Anzi la causa dell’uomo
è ciò che sta più a cuore a questo Dio, il quale lo dimostra rivelandosi in Gesù
Cristo.37 Quest’ ultimo merita giustamente una posizione centrale nella teologia
di Barth perché gli permette di stare sì dalla parte di Dio, senza però trascurare
l’uomo, di tenersi in equilibrio tra i due termini, riconoscendo l’importanza di
entrambi, e soprattutto sfuggendo al rischio della negazione dell’uno a favore
dell’altro, con le conseguenze che ne possono derivare.
5. La critica di Barth a Lutero e a Schleiermacher, che ha portato fino alle estreme
conseguenze il discorso luterano
Da calvinista convinto quale era, Barth ha cercato incessantemente di
ribadire il “principio protestantico” riportandolo alla sua purezza ed alla
sua coerenza originaria, anche a costo di dichiarare di aver nutrito una non
poca diffidenza perfino nei confronti dello stesso Lutero. Quest’ultimo infatti
avrebbe, secondo Barth, insistito troppo sulla fede come fiducia che giustifica e
36
«Nella sua interpretazione della teologia di Barth, Balthasar ha paragonato il suo pensiero cristocentrico ad una clessidra. Come nella clessidra tutta la sabbia da un recipiente deve
scorrere in un unico stretto punto per depositarsi nell’altro, così in Barth tutta la realtà del
mondo è ricondotta all’unico avvenimento centrale della rivelazione di Cristo: questa è la “concentrazione cristologica” di Barth, altrimenti non vi è per lui alcun rapporto tra Dio e l’uomo;
e come nella clessidra la sabbia scorre solo dall’alto verso il basso, anche la rivelazione divina
ha un unico movimento dall’alto verso il basso. Ma come nella clessidra il moto dall’alto verso
il basso provoca un “contro” movimento, infatti la sabbia nel recipiente inferiore “cresce”, così
anche le rivelazione richiama un movimento contrario: infatti richiama a sé e in sé tutta la
realtà del mondo; questo è “l’universalismo intensivo” di Barth ». (H.Zahrnt, Alle prese con Dio.
La teologia protestante nel XX secolo. Una storia, Brescia 1976,p.106).
37
« Tra Dio e l’ uomo sta la persona di Gesù Cristo che, essendo egli stesso Dio e uomo fa
da mediatore. In lui Dio si rivela all’uomo. In lui l’ uomo conosce Dio. In lui Dio sta davanti
all’uomo e l’uomo sta davanti a Dio, secondo quella che è la volontà eterna di Dio e, conformemente a questa volontà, la destinazione eterna dell’ uomo. In lui Dio ha stabilito il suo piano
per l’uomo, ha eseguito il suo giudizio, ha compiuto la sua redenzione ». (K.Barth, Kirchliche
Dogmatik, cit. p.101, tr.it. cit., p.120).
Karl Barth interprete di Ludwig Feuerbach
173
salva, come qualcosa che emerge ed opera quasi automaticamente, trascurando
il suo aspetto di dono, e dunque il principio del finitum non capax infiniti, ossia
il principio secondo il quale l’uomo non può per nessuna via umana accedere
a Dio, ma è solo Dio che può decidere di volgersi all’uomo donandogli la fede e
dunque la salvezza. Quindi Lutero ha spostato drasticamente il nostro interesse
dall’oggettivo al soggettivo. Tuttavia, la celebrazione della metamorfosi
umanistica della teologia avviene trionfalmente con Schleiermacher, grazie al
quale si è verificata la svolta definitiva della teologia del secolo XIX verso il
“religionismo”38. Egli infatti rappresenta il principale obiettivo polemico di Barth
per aver portato fino alle estreme conseguenze il discorso di Lutero, dichiarando
che ciò che conta non è l’oggetto della religione, bensì esclusivamente il soggetto
religioso. A tal proposito, dal discorso di Barth su Schleiermacher emerge che
la sua teologia è fin dall’origine teologia della cultura: nella religione stessa,
che è l’oggetto vero e proprio di questa teologia, si tratta della elevazione della
vita, del perfezionamento della vita individuale e sociale. Egli infatti vuole
inserire gli uomini nel moto della cultura, dell’elevazione umana, che è in
fondo il moto religioso, cristiano. Dunque tutta la sua filosofia della religione è
stata un elemento secondario, una linea ausiliaria per la fondazione della sua
autentica istanza, quella etica. Egli ha appunto subordinato la teologia all’etica;
a lui non importa la dottrina, ma piuttosto la vita. Infatti il suo interesse
era rivolto in primo luogo alla vita attiva della religione; in secondo luogo al
sentimento come autentica sede di questa vita; e soltanto in terzo luogo alle
proposizioni nelle quali questa vita crea le sue forme di espressione. Non a caso
la sua presentazione della fede cristiana non poggia sul terreno di una suprema
conoscenza di Dio, bensì sul terreno di una conoscenza suprema del sentimento
umano o dell’autocoscienza immediata della sua correlazione con Dio.
A tal proposito, Schleiermacher considerò la religione come sentimento
e gusto dell’Infinito, facendola consistere fondamentalmente nell’ esperienza
mistica, il che gli consentiva di mantenere un notevole grado di indeterminatezza
circa l’oggetto proprio della religione stessa. Infatti Schleiermacher oscilla tra
molte determinazioni di questo oggetto, dal momento che parla di eterno, di
divino, di universo, di umanità, di sacro, di storia universale, e così via. Dunque
tutto questo è coerente con la riduzione della religione a puro sentimento:
in conseguenza di questa riduzione, la consistenza, nonché tutta la validità
oggettiva del contenuto della religione medesima, sono sostanzialmente ridotte
38
Si tratta di quella concezione secondo la quale la religione sarebbe una grandezza conosciuta e indipendente rispetto alla rivelazione. Dunque non la religione è stata compresa a
partire dalla rivelazione, bensì questa a partire da quella.
174
Teresa Caporale
a zero, poiché l’intera struttura oggettiva della religione vaga nel confuso e
nell’indeterminato e l’identità dell’oggetto religioso è ridotta al minimo, dal
momento che anche esso ondeggia nell’indeterminato. Da ciò deduciamo che
quando si assume ad organo della religione il sentimento, per quella religione
è finita; da essa si retrocede alla religiosità, che privata di ogni riferimento
oggettivo ben presto si dissolve.
Dunque il momento dell’oggettività è imprescindibile e fondante, e di ciò
si era già accorto Feuerbach, il quale sostiene che «l’essere divino, percepito
attraverso il sentimento, null’altro è in realtà che il sentimento stesso estasiato
ed innamorato di sé, il sentimento ebbro di gioia, in sé beato. Già da ciò si
comprende che là dove il sentimento viene elevato ad organo dell’infinito, a
soggetto della religione, l’oggetto della medesima perde il suo valore oggettivo.
L’oggetto del sentimento diventa indifferente proprio perché, una volta definito il
sentimento l’essere soggettivo, l’organo della religione, in realtà esso ne è anche
l’essere oggettivo reale, ossia il dio, benché non venga dichiarato tale, almeno
direttamente. Ma in questo modo non si viene a proclamare il sentimento quale
l’assoluto, il divino stesso? Se il sentimento è per se stesso buono, religioso, cioè
santo, divino, non ha il sentimento il suo dio in se stesso?39».
Pertanto Feuerbach tocca il punto più grave della teologia del sentimento:
ad opera di questa teologia il fondamento oggettivo e il contenuto del
Cristianesimo vengono completamente dissolti. Dunque Barth, pur
individuando in Feuerbach i limiti di fondo, per i quali egli, facendo centro
sulla soggettività religiosa umana, riduce la teologia ad antropologia,
gli riconosce tuttavia il merito di aver sviluppato fino alle estreme
conseguenze le implicazioni umanistiche e soggettivistiche della teologia
neo-protestante, di cui Schleiermacher è stato il più geniale teorizzatore.
Ecco perché Barth ha come suo principale obiettivo polemico il pensiero
schleiermacheriano, la teologia di questo principale responsabile della
degenerazione religionista, con la sua riduzione della rivelazione a religione,
e della religione a sentimento di dipendenza. Infatti più che la parola di
Dio in sé, è il suo riflesso sentimentale sull’uomo ciò che a Schleiermacher
interressa veramente. Pertanto ha ragione Barth quando paragona il pensiero
schleiermacheriano ad una ellissi con due fuochi, uno soggettivo attraente e
uno oggettivo attratto, e il cui movimento porta progressivamente il secondo
a venire fagocitato dal primo.
39
L.Feuerbach, Das Wesen des Christentums, cit. p.15-16; tr.it. cit., p. 30-31.
Karl Barth interprete di Ludwig Feuerbach
175
Nell’ambito della critica che Barth muove a Schleiermacher, egli però
lealmente riconosce anche degli aspetti positivi nel suo nemico per eccellenza.
Barth infatti sa che è impossibile occuparsi con profondità di Schleiermacher,
senza ricevere una fortissima impressione dalla ricchezza e dalla grandezza dei
compiti che quest’ uomo si è proposti, dalla preparazione morale e intellettuale
con la quale egli li ha affrontati, dalla perseveranza con la quale ha percorso
fino alla fine la via sulla quale si era incamminato, senza preoccuparsi del
favore o del disfavore dei decenni. Pertanto, Barth arriva a sostenere che nel
caso di Schleiermacher abbiamo a che fare con un eroe, come se ne offrono
di rado alla teologia. Dunque egli non nega che il suo nome, e nessun altro
accanto a lui, sta e starà in ogni tempo al culmine di una storia della teologia
dell’epoca contemporanea. E questo Barth lo sa bene, perché ha nutrito la
sua giovinezza «leopardianamente ingorda»40 delle pagine morali di Kant e di
quelle religiose e cristiane di Schleiermacher. Per quest’ultimo vale quello che
egli stesso, nel discorso accademico Sul concetto del grande uomo, ha detto di
Federico il Grande: Egli non ha fondato una scuola ma un’epoca. Infatti il XIX
secolo ha apportato alcuni sviamenti da Schleiermacher, alcune trasformazioni
della sua concezione sino a renderla irriconoscibile, alcune proteste contro
di lui, qualche trascuratezza e dimenticanza nei suoi confronti. Eppure, nel
campo della teologia, esso è stato il suo secolo. Dopo aver descritto curve di
ogni genere, grandi e piccole, è tornato sempre di nuovo a lui. A tal proposito
Barth sostiene che nessuno oggi può dire se effettivamente lo abbiamo già
superato, o se, nonostante tutte le proteste contro di lui, diventate sempre più
dispiegate e radicali, non siamo pur sempre nell’intimo figli del suo secolo.
Una cosa però è certa: il pensiero di Schleiermacher, secondo Barth, non potrà
mai essere minacciato da una qualche critica, magari acuta ma isolata, ma
soltanto da un’opera equivalente per suggestione e forza interiore. Non a caso al
Romerbrief Barth fa seguire la Kirchliche Dogmatik, contraddicendo punto per
punto Schleiermacher e la sua eredità liberale. Infatti Barth è convinto che fino
a quando non si sradica totalmente il discorso intorno al “divino nell’umano”,
non si ha motivo alcuno per criticare Feuerbach. Tutti i mali, infatti, per lui
nascono proprio da questa autoesaltazione dell’uomo. Barth comunque, come
già detto, apprezza Feuerbach per la sua competenza in campo biblico, in
campo patristico e soprattutto nella conoscenza di Lutero, colui che ha gettato
le basi per la futura umanizzazione della teologia.
40
I.Mancini, Introduzione a La teologia protestante del XIX sec., cit., p. 49.
176
Teresa Caporale
6. Il paradosso di una religiosità che contraddistingue l’ateismo feuerbachiano e
di una nuova forma di umanesimo cui approda la teologia di Barth
Per spiegare l’interesse di Barth per la riflessione feurbachiana non si può
prescindere poi da quell’ambiguità di Feuerbach, che spesso ha fatto parlare
di lui come di un “pio ateo”. Infatti occorre riconoscere che l’entusiasmo di
Feuerbach per l’uomo si avvicina all’entusiasmo del credente per Dio, per cui
in questo senso può essere detto “religioso”. È vero sì che la negazione religiosa
da parte di Feuerbach è recisa, senza mezzi termini; che la sua riduzione
del divino all’umano è perseguita con coerenza e senza arrestarsi di fronte a
nulla. Ma è anche vero che l’umano che in tal modo viene acquisito appare
così permeato della sua originaria forma religiosa che risulta difficile credere
a quanto Feuerbach assicura, ossia che essa fu un errore, una proiezione
dell’uomo inconsapevole. Dunque l’ateismo feuerbachiano è contraddistinto da
una coloritura religiosa, che connota il pensiero di Feuerbach. Questo aspetto
è già stato sottolineato da alcuni pensatori del secolo scorso e mette in luce che
l’avversione del filosofo verso il Dio della religione (e in particolare verso il Dio
del Cristianesimo soprattutto di matrice cattolica), pur assoluta, si intreccia
tuttavia con la tendenza a salvaguardare alcuni “attributi” più qualificanti della
divinità. Feuerbach cioè, sebbene da una parte neghi recisamente il “soggetto”
divino, d’altro lato ne vuole preservare le determinazioni di sapienza, di bontà,
di potenza. Tutto questo fa sì che per lo meno nelle opere più significative e
centrali del suo pensiero, l’ateismo si rivesta di un alone religioso e si imbeva di
un pathos quasi sacrale.
Insomma non si può trascurare che la negazione operata da Feuerbach
profuma ancora di religiosità. Proprio per questo egli diventerà compagno di
viaggio di Barth, occasionando quella grande svolta teologica del Novecento
che, liberandosi completamente di ogni antropologismo (abbandonandolo
appunto all’ateismo feuerbachiano) propone un dire di Dio che non è parlare
su Dio, ma parola di Dio stesso, rivelazione che irrompe e scompiglia ogni
pretesa umana di impadronirsi della relazione finito-infinito, e di svolgerla
mediante uno schema che, pensato dall’uomo, è secondo la sua misura. Il
materiale feuerbachiano è dunque materiale su cui, in svolgimenti e con nomi
diversi, gran parte della modernità si è confrontata.41 La sua riduzione di un
41
A partire dagli anni Sessanta del Novecento è stata generalmente riconosciuta l’importanza del pensiero filosofico di Feuerbach. Essa si fonda innanzitutto sul valore intrinseco che
la speculazione feuerbachiana riveste, indipendentemente da ogni funzione mediatrice da essa
esercitata nell’ambito della riflessione filosofica dell’Ottocento. In altri termini, di fronte alle
Karl Barth interprete di Ludwig Feuerbach
177
rigido assorbimento dell’infinito nel finito (e, di conseguenza, il suo ateismo
senza sfumature) appare largamente discutibile ed è stata infatti variamente
contestata. Tanto sul versante teologico, con il capovolgimento barthiano che
sottrae Dio all’essere parola umana, quanto sul versante umanistico, dove lo
smisurato potere dell’uomo è divenuto sospetto e persino inaccettabile. A tal
proposito proprio Feuerbach avrebbe condotto verso quella prospettiva che,
inglobando l’infinito nel finito, produce successivamente quel trasferimento
di consegne che, in ultima istanza, lascia al finito soltanto se stesso. L’uomo
moderno, infatti, negato Dio, e appropriatosi dell’infinito, procede poi oltre
a negare l’infinito che è in lui, e in ultimo approda al nulla come orizzonte
dell’esistenza. In questo modo Feuerbach rappresenterebbe un punto di
passaggio verso una linea che conduce oltre i suoi stessi risultati42.
Da quanto detto fino ad ora emerge che, al di là di ogni critica, Barth riconosce
a Feuerbach il merito di aver colto una tendenza insita nella teologia protestante
già a partire da Lutero e accentuatasi poi nell’Ottocento con Schleiermacher:
la riduzione della religione a determinazione dell’autocoscienza dell’uomo
e l’identificazione dei predicati teologici con i predicati umani. Feuerbach
avrebbe insomma strappato la maschera alla teologia moderna protestante, in
interpretazioni riduttive che soprattutto in passato se ne diedero, e che miravano a fare della
filosofia di Feuerbach un semplice momento di transizione tra la posizione espressa dall’idealismo hegeliano e il materialismo dialettico di Marx e di Engels, si contrappone, a partire dagli
anni Sessanta, la tendenza a rivalutare il significato autonomo del pensiero feuerbachiano.
Dall’analisi della più recente letteratura secondaria italiana, emerge che l’angolo visuale dal
quale Feuerbach viene guardato risulta, a partire da quegli anni, prevalentemente quello religioso: infatti molti degli studiosi che si sono occupati dell’argomento tra gli anni Sessanta e
Settanta del Novecento hanno mostrato un interesse marcato per problemi di filosofia della
religione, per il dibattito sull’ateismo, ecc.. Quel tipo di approccio tende quasi sempre non ad
ignorare, ma comunque a porre in secondo piano il solito, dibattutissimo tema del rapporto
Feuerbach-Hegel. Così, L.Casini, nel suo libro Storia e umanesimo in Feuerbach, sostiene che
quest’ultimo, più che negare radicalmente il cristianesimo (come fa invece Nietzsche), prende
atto dell’esaurimento delle forme in cui esso si era manifestato. Quindi la sua antropologia
vuole essere, in fondo, l’annuncio che i valori cristiani sono ridiventati umani grazie a un lungo travaglio storico. Contro queste tesi, e prima ancora che esse venissero sostenute in Italia, si
era già schierato, in numerosi contributi, C.Fabro, il quale aveva negato che si potesse trovare
in Feuerbach qualsiasi valutazione positiva del cristianesimo. L’antropologia feuerbachiana è
per lui l’esito ateo della pseudo-teologia di Hegel. Molte riserve sui caratteri religiosi dell’antropologia di Feuerbach sono state espresse anche da A.Caracciolo in una sua relazione (Dio
e spazio religioso in Feuerbach) al congresso di filosofia della religione svoltosi a Perugia nel
1976. Relazione che è notevole per almeno due motivi: il primo è la negazione che Feuerbach
abbia mai avuto di Dio una concezione davvero religiosa; il secondo è il chiedersi, sulla base
degli scritti della tarda maturità, se il razionalismo volgare ivi sostenuto da Feuerbach non
possa gettare qualche luce anche sul significato delle sue affermazioni dei decenni precedenti.
Il Caracciolo giunge così a negare una “attualità ideale” al pensiero di Feuerbach.
42
Cfr. la tesi sostenuta da Ugo Perone nell’Introduzione a Finito e infinito. Antologia dagli
scritti, tr.it. E.Guglielminetti-U.Perone, Torino 1992, p. 8.
178
Teresa Caporale
particolare a quella di Schleiermacher. Egli diventa così, suo malgrado, alleato
prezioso di Barth nella lotta contro l’antropocentrismo di quella teologia, e
viene valorizzato nella sua critica all’idealismo e nella sua ricerca dell’uomo
concreto.43 Non a caso, a giudizio di Barth, tutta la realtà teologica risulta
convergente sì verso Dio, ma costituita nella sua manifestazione tutta in
funzione dell’uomo. Egli finisce così, forse inconsapevolmente, con l’approdare
a una nuova forma di umanesimo, in quanto il Dio di cui parla non è un’entità
astratta, bensì un Dio che ha a cuore la causa dell’uomo e perciò essenzialmente
umano. A tal proposito Gesù Cristo è per Barth proprio il luogo in cui Dio si fa
uomo. Gesù Cristo è sì uomo, uomo vero, ma non solamente uomo, sia pure
straordinariamente dotato o particolarmente guidato dall’alto, né tanto meno
un superuomo; piuttosto essendo uomo è anche Dio44. Per questo motivo egli
risulta, a giudizio di Barth, necessariamente uomo in modo totalmente altro
da tutti noi: proprio in quanto Dio, egli ha il potere di essere “quest’uomo” al
posto di tutti noi e per il bene di tutti noi; ha insomma il potere di essere uomo
in modo totalmente diverso45.
La teologia di Barth perciò, più che un’antropologia (come quella di
Feuerbach), deve essere considerata una teo-antropologia, ossia una dottrina
di Dio e dell’uomo, del rapporto e della comunione tra i due, nel senso della
dedizione di Dio verso ogni essere umano. Sulla base di queste considerazioni
risulterà più facile comprendere la coincidenza del teologo evangelico col
critico del Cristianesimo nell’interpretazione in senso antropologico della
teologia protestante.
43
Una ricerca che però rimaneva, a giudizio di Barth, ancora inadeguata, non riconoscendo la morte e non abbandonando il piano essenzialistico.
44
È bene notare che « il cristocentrismo barthiano non fa torto per nulla al suo teocentrismo, data l’identità Cristo-Dio. Il vero Dio, come noi lo possiamo conoscere, è il Dio-che-rivela,
ma il Dio-rivelazione non è altro che Gesù Cristo. Si può dire che in tal modo è superato quel
dualismo Dio-Cristo che, malgrado gli sforzi dei riformatori, restava nella teologia protestante
»; ( E. Riverso, La teologia esistenzialista di Karl Barth. Analisi, interpretazione e discussione del
sistema, Napoli 1955, p.278 ).
45
Barth insiste molto su questo punto, facendo così emergere come sussista sempre una
differenza tra il piano umano e quello divino, diversamente da Feuerbach che invece si serve
della figura di Gesù Cristo per confermare ulteriormente la sua tesi secondo la quale” il segreto
della teologia è l’antropologia”.
Il “preanimismo” di Robert Ranulph Marett
179
Per un’interpretazione non intellettualistica della religione
primitiva: il “preanimismo” di Robert Ranulph Marett
Memoria di Tatiana Tabacchino
presentata dal socio naz. ord. res. Edoardo Massimilla
(Seduta del 16 dicembre 2010)
Abstract. The essay deals with the theory of pre-animism put forward by the English
anthropologist Robert Ranulph Marett in 1900, that is different from the animistic
theory formulated by E. B. Tylor principally because does not focus on the theoretical
and intellectual, but on the emotional and practical aspects of religion considered in its
social function. The paper describes the main qualities attributed to the supernatural
in the pre-animistic form of religion: the sacred considered as “forbidden” (tabù) and
the sacred consedered as “potent” (mana). Finally, it lingers over the influence of the
pre-animistic hypothesis upon some German scholars (Rudolph Otto, Max Weber) and
identifies, in the wake of E. De Martino, the main theoretical limitation of the notion of
pre-animism in its ambiguous collocation between categorial (extratemporal) plane and
historical (temporal) plane.
1. L’ipotesi preanimistica
L’antropologo inglese Robert Ranulph Marett (1866-1943)1 espone per la
prima volta la sua ipotesi del preanimismo al Convegno di Dover promosso, nel
1899, dalla Società Antropologica Britannica. Nella sua relazione, pubblicata
nel 1900 sulla rivista «Folk-lore» con il titolo Pre-animistic Religion, Marett
prende posizione in merito alla «definizione minima della religione»2 teorizzata,
1
Sulla vita e gli scritti di Marett, oltre all’autobiografia, R. R. Marett, A Jersmay at
Oxford, Londra, 1941, si possono consultare: AA. VV., Custom is King. Essays presented to R.
R. Marett on his seventieth birthday, June 13, 1936, Londra, 1936, pp. 3-8 e 303-325; AA. VV.,
Robert Ranulph Marett. A Report of a Memorial Meeting of the Oxford University Anthropological
Society, 4 March 1943, Londra, 1943; H. J. Rose, Robert Ranulph Marett, 1866-1943, in «Proceedings of the British Academy», 29, 1943, pp. 357-370; G. Cocchiara (a cura di), Introduzione
allo studio dell’uomo, Palermo, 1944, pp. 7-35; M. Nowaczyk, Robert Ranulph Marett (18661943), in «Euhemer», 7, 1963, pp. 5 e 23-35; J. Waardenburg, Classical Approaches to the Study
of Religion. Aims, Methods and Théories of Research, Berlino, 1992, vol. I (Introduction and
Anthology), p. 257 e vol. II (Bibliography), pp. 173-176.
2
«Quando si tratta di studiare le religioni delle razze inferiori, il punto essenziale preliminare da chiarire e da precisare è che cosa si intende per religione. Se si vuole far entrare nella
180
Tatiana Tabacchino
in Primitive Culture (1871), dal suo maestro, Edward Burnett Tylor (1832-1917).
Tylor aveva inserito la teoria sulla religione primitiva in un più ampio
progetto scientifico: la fondazione dell’antropologia come scienza, avente
come campo d’indagine il mondo delle produzioni culturali e storiche creato
dall’uomo, per il quale individuare leggi scientifiche determinate e generali al
pari delle leggi della fisica, della chimica, della biologia. Un progetto, questo,
che partiva dal presupposto, d’impronta comtiana, secondo il quale la storia
dell’uomo è essenzialmente la storia dei suoi modi di conoscere la realtà, una
storia di progresso avente come agente principale lo sviluppo intellettuale.
L’interesse di Tylor per la religione primitiva era, quindi, orientato dall’idea che
fosse possibile ritrovare nei principi del pensiero agenti nella religione, persino
ai suoi stadi più primitivi, degli elementi di continuità con i principi universali e
costanti della conoscenza umana in tutte le sue forme, anche le più progredite.
In questa prospettiva, la religione, sin dai suoi albori, è considerata da Tylor
come qualcosa di essenzialmente razionale: essa ha origine dall’osservazione
– seppur inadeguata – del mondo circostante, e dalle deduzioni logiche – per
quanto false, perché non comprovate sperimentalmente – ricavate da tale
osservazione. Per questo motivo, lo studio della religione primitiva assume
un’importanza fondamentale per comprendere le fasi successive non soltanto
della religione, ma anche delle altre ramificazioni dello sviluppo intellettuale.
Coerentemente col suo programma antropologico, Tylor descrive la religione,
nella sua forma elementare, come la risposta di tipo intellettuale dei primitivi
ad alcuni fenomeni oscuri della natura e ad alcune particolari esperienze della
vita (nascita, morte, sogni, visioni ecc.). Impressionato da questi eventi, l’uomo
primitivo – a partire dalle proprie esperienze soggettive – giunge a concepire
l’esistenza di un’anima indipendente dal corpo, in grado di sopravvivere ad esso
e di agire attraverso una volontà propria, per poi applicare tale concezione a tutti
gli aspetti misteriosi del mondo, attribuendo un’anima a ogni essere e oggetto
naturale3. Questa «credenza negli esseri spirituali» o animismo rappresenta per
definizione di religione la credenza in una divinità suprema, in un giudizio dopo la morte, o
l’adorazione di idoli e la pratica del sacrificio […], senza alcun dubbio, un certo numero di
tribù si troverà allora escluso dal mondo religioso. Ma questa definizione troppo ristretta ha il
difetto di identificare la religione con alcuni suoi sviluppi particolari, mentre è opportuno considerarla nel suo movente iniziale e nel suo elemento essenziale. Occorre risalire direttamente
alla fonte e porre semplicemente come definizione minima della religione la credenza in esseri
spirituali» (E. B. Tylor, Primitive Culture, New York, 1958, vol. II, p. 8).
3
Per comprendere l’origine dell’animismo occorre pensare, secondo Tylor, ai due ordini
di problemi «biologici» che attanagliavano l’intelligenza umana al suo stadio primitivo: 1) la
differenza esistente tra un corpo vivente e un corpo morto, la causa della veglia, del sonno,
della catalessi, della malattia, della morte; 2) la natura delle immagini che appaiono nel sogno
Il “preanimismo” di Robert Ranulph Marett
181
Tylor un paradigma intellettuale, d’ordine generale, entro il quale – seppure in
germe – sono presenti alcuni degli elementi fondamentali che hanno trovato nel
pensiero scientifico moderno la loro piena attuazione: la registrazione empirica
dei dati fenomenici, la ricerca di cause e spiegazioni, l’intento di controllo sulla
natura a proprio vantaggio. L’animismo è inteso, dunque, come una struttura
permanente, che interessa l’intero processo evolutivo, fino alle manifestazioni
della più sofisticata scienza moderna, giacché scienze come la fisica, la chimica
e la biologia non fanno altro che conquistare «intere province dell’antico
animismo, sostituendo il concetto di forza a quello di vita e il concetto di legge
a quello di volontà»4.
In Pre-animistic Religion, anche Marett, pur criticando nei contenuti l’ipotesi
animistica, ritiene utile determinare una “definizione minima” della religione.
Egli condivide l’assunto evoluzionistico secondo il quale la religione, così come
altri aspetti della vita socio-culturale, è qualcosa di estremamente complesso,
che per essere compreso va scomposto nei suoi elementi più semplici; vale
a dire, attraverso un riferimento alle sue fasi passate, o meglio, alle culture
primitive che stanno ancora attraversando tali fasi. Tuttavia Marett è convinto
che, quando si considerano fenomeni di natura religiosa, occorre sempre evitare
di assegnare limiti troppo rigidi al concetto di religione, senza «assicurarsi che
quei limiti siano stati definiti su basi ampie e generose, tali da non escludere
nessun aspetto che ha caratterizzato in qualunque momento la religione nel
lungo corso della sua evoluzione»5.
Marett ritiene che «la religione primitiva o rudimentale, quale realmente la
ritroviamo fra i popoli più selvaggi, sia nel suo insieme qualcosa di più ampio,
e per certi aspetti di più vago rispetto alla “credenza in esseri spirituali” della
famosa “definizione minima” di Tylor»6. «L’animismo, quale termine tecnico
e nelle visioni. Meditando su questi due ordini di fenomeni, i selvaggi sono giunti alla conclusione che in ogni uomo sono racchiusi una «vita» e un «fantasma». In seguito, riflettendo sul
legame che entrambi mostravano di avere col corpo, la «vita» e il «fantasma» furono riunificati nella concezione dell’anima («anima apparizionale» o «anima-spettro»), concepita come
un’immagine umana, sottile, immateriale, impalpabile, principio e causa direttrice della vita,
della coscienza e del pensiero. Su questi aspetti cfr. ivi, pp. 12 e ss.. Per comprendere in che
modo, secondo Tylor, i primitivi attribuiscano un’anima anche agli animali, alle piante e agli
oggetti cfr. ivi, pp. 51-80.
4
Ivi, p. 269. Non sono molti i luoghi in cui Tylor spiega esplicitamente in cosa consistano
gli elementi di continuità tra il pensiero primitivo e quello moderno. Colpiscono però alcune
considerazioni “gnoseologiche” presenti in Primitive Culture. Le ha messe in evidenza Emma
del Basso, sottolineando che Tylor riconduce a Democrito la moderna teoria della percezione
e la teoria di Democrito all’animismo. Cfr. E. Dal Basso, L’animismo di Edward Burnett Tylor,
Napoli, 1985, pp. 47 e s..
5
R. R. Marett, The Threshold of Religion (Londra, 1909), Edimburgo, 2004, p. 3.
6
Ivi, pp. VIII e s. (corsivo mio).
182
Tatiana Tabacchino
applicato alla religione, richiama l’attenzione sulla presenza di un credo o corpo
di idee più o meno definito. Secondo Tylor, che l’ha presentato all’antropologia,
esso significa “la credenza nell’esistenza di esseri spirituali”, ossia di “spiriti” nel
senso più ampio del temine, che include anche le “anime”»7. Ma tale “definizione
minima” può essere riferita a un preciso momento dello sviluppo della religione
e non alla religione nella sua forma elementare ed essenzialmente costante. In
altre parole, l’ipotesi animistica di Tylor incorre in una sopravvalutazione del
lato “teorico” della religione, mostrando di non comprendere che l’animismo,
inteso come “credenza nell’esistenza di esseri spirituali”, rappresenta per il
selvaggio solo «il mezzo tipico, pressoché universale, di rivestire i fatti della
propria esperienza religiosa di idee e di parole»8. Per non incorrere nello stesso
errore, bisogna invece mettere in rilievo quei fatti di natura emotiva e pratica
che contraddistinguono le esperienze religiose primitive, e chiedersi se «prima,
e in ogni caso a prescindere dall’animismo, l’uomo primitivo fosse sottoposto
a qualche esperienza […] che potremmo definire specificamente “religiosa”»9.
Per far ciò, Marett prende le mosse da quello che egli considera il punto
debole della teoria animistica. Tylor afferma che i selvaggi credono in un
numero svariato di entità spirituali e cercano di spiegare i fenomeni che più li
impressionano e li stupiscono facendo riferimento all’azione di queste entità.
Essi credono nello spirito della foresta, delle montagne, dei fiumi, dei capo
clan, nello spirito del mal di testa, nello spirito degli animali ecc.. Tutte queste
entità spirituali, osserva Marett, stando ad un’interpretazione rigorosamente
animistica, sono pensate su un prototipo originale: lo spirito dei morti. Ciò che
però l’animismo non spiega è il modo in cui «una coloritura animistica può
essere assegnata a un numero di cose che non sono connesse in primo luogo
o in maniera evidente con la morte e i morti»10. Quale carattere generalmente
inerente a queste cose, così diverse fra loro, suggerì alla mente del selvaggio
di raggrupparle insieme e di fornire loro una spiegazione comune? A questa
domanda è possibile rispondere solo ipotizzando che la spiegazione comune
in questione sia in realtà «l’esito […] di un comune e pur altamente specifico
sentimento o emozione»11.
Dalla spiegazione tipica e universale, che gli individui utilizzano per
comunicare la propria esperienza religiosa, bisogna risalire al sentimento
Ivi, pp. 5 e s..
Ivi, p. 8 (corsivo mio).
9
Ibidem.
10
Ivi, p. 9.
11
Ibidem.
7
8
Il “preanimismo” di Robert Ranulph Marett
183
comune sotteso a tale rappresentazione ideale, il quale ha un’incidenza
decisiva sul comportamento e le pratiche sociali. Il problema non è più quello
dell’origine della religione a partire dalle impressioni e dalle riflessioni del
singolo individuo, ma quello degli effetti che l’esperienza religiosa ha sugli
individui considerati non isolatamente, ma in quanto membri di una comunità.
Nello specifico, quando si riflette sulla religione primitiva, bisogna mettere da
parte il «“metodo di Robinson Crusoe” che consiste nel ricostruire le credenze
di un selvaggio solitario, come se fosse questi, nella sua solitudine, a sviluppare
la propria religione portandola al di fuori dell’ambito della propria coscienza
interiore»12. Occorre evitare di mettersi al posto del primitivo e di porsi quelle
che potrebbero essere le sue domande cercando di darvi le risposte che egli
vi darebbe, così da “simularne” il possibile ragionamento («“la montagna si
corruga, pertanto è viva; io mi muovo nei miei sogni mentre il mio corpo giace,
pertanto io ho un’anima” ecc.»)13. «Nessun dubbio – aggiunge Marett – che
qualcuno dovette pensare queste cose, dal momento che sono pensieri. Ma esse
non furono pensate, o meglio, non furono portate ad espressione da un individuo
solo. Gli uomini associati le portarono ad espressione; anzi, intere età di vita e
di pensiero hanno concorso a farle quali sono. Dunque è necessario un metodo
sociale per spiegarle»14: occorre che l’antropologia ponga l’accento sul «lato
sociologico della religione»15.
Che questo sia un assunto fondamentale e costante del pensiero di Marett
trova conferma nella prefazione alla raccolta del 1909, The Threshold of Religion,
laddove l’autore chiarisce il contesto teorico e metodologico entro cui leggere
i sui scritti sulla religione. «Ritengo – scrive Marett – che la religione nel suo
aspetto psicologico sia, fondamentalmente, una modalità di comportamento
sociale»16. Egli ribadisce, in seguito, il suo interesse per l’aspetto psicologico
della religione, ma prospetta nel contempo un nuovo modo per analizzarlo. Vi
sono «validi motivi per rispettare la tradizione britannica, la quale stabilisce
che la psicologia debba presiedere alle indagini di religione comparata», ma
«resta da rendere esplicito ciò che gli antropologi di scuola britannica hanno
riconosciuto solo vagamente, e cioè che soltanto una psicologia sociale, e non
già una psicologia individuale, può essere investita di questa funzione»17.
Ivi, p. 176.
Ivi, p. 178.
14
Ivi, p. 176 (corsivo mio).
15
Ibidem.
16
Ivi, p. XI.
17
Ivi, p. 155. La psicologia individuale o «ordinaria», come la chiama Marett, si basa
«sull’assunto secondo cui la vostra anima o la mia è qualcosa di individuale» (ibidem). Ciò
12
13
184
Tatiana Tabacchino
Partendo da questa prospettiva, Marett si sforza di «trovare una definizione
feconda della religione», come quella contenuta nella sua Antropologia (1912):
«una religione è lo sforzo di opposizione alla crisi, in quanto sforzo organizzato
dalla società in un modo particolare»18. Facendo riferimento alla vita selvaggia,
Marett mette infatti in luce che «la crisi è in essa un elemento frequente, anche
se intermittente. La fame, il morbo e la guerra sono esempi di crisi. La nascita
e la morte sono crisi»19. «Ora che cosa, nell’ambito del pensiero, significa crisi?
Significa che non si sa più che pesci pigliare e che l’ordinario e l’atteso sono
stati sostituiti dallo straordinario e dall’inatteso, che si è proiettati nel mondo
dello sconosciuto. E in quel mondo bisogna miserevolmente soffrire finché
in un modo o nell’altro, è ristabilita la sicurezza»20. Quindi, psicologicamente
considerata, la funzione della religione è quella di restaurare la sicurezza degli
uomini quando è scossa dalla crisi. «Ristabilire la fiducia quando l’uomo è
imbarazzato e impacciato, pauroso dei misteri che incombono sulla sua vita,
ma costretto, se non esattamente desideroso, di opporsi a essi, di liberarsi da
essi»21. «La religione è l’opposizione allo sconosciuto. È il coraggio di essa che
arreca conforto»22. Ma essa intanto può assolvere a tale funzione in quanto è
«parte della consuetudine del selvaggio, anzi è tutta la sua consuetudine in
quanto appare consacrata»23.
La religione, in quanto consuetudine sociale, s’interpone tra il selvaggio e ciò
che è a lui ignoto e lo fa esercitando una «suggestione»; essa «aiuta quando c’è
qualcosa che si deve fare e suggerisce che può essere fatta bene e felicemente;
anzi, che deve essere fatta così. E quando la religione è di una specie efficace,
i credenti rispondono alla suggestione e compiono quella data cosa. Come
il poeta latino dice “essi possono perché credono di potere”»24. Ma «dire che
la religione lavora con la suggestione equivale a dire – continua Marett – che
essa lavora attraverso l’immaginazione. C’è la fiducia di far bene o di far male;
per volere [per perseguire uno scopo] si deve necessariamente immaginare e
non sarebbe errato «se “individuale” significasse qui nient’altro che self-complete [compiuto in
sé]; ciò che è sbagliato è intendere il termine individuale, come spesso si fa inavvertitamente,
nel senso di self-contained», ossia nel senso di “autosufficiente” e “indipendente”. L’errore sta
nel fatto di non considerare che «le anime possono comunicare, […] e che comunicando esse
diventano più o meno complementari l’una all’altra, in un sistema sociale» (Ibidem).
18
R. R. Marett, Anthropology, Londra, 1912, tr. it. Introduzione allo studio dell’uomo, a cura
di G. Cocchiara, Palermo, 1944, pp. 175 e s..
19
Ivi, p. 176.
20
Ibidem.
21
Ivi, pp. 189 e s..
22
Ivi, p. 176.
23
Ivi, p. 177.
24
Ivi, p. 190. «Possunt quia posse videntur»: Eneide, libro V, verso 231.
Il “preanimismo” di Robert Ranulph Marett
185
credere in ciò che si deve fare»25. Dunque, «il fine e il risultato della religione
primitiva è, in sostanza, la consacrazione della vita, lo stimolo della volontà
di vivere e di agire»26, allorché essa è stata messa in crisi dallo straordinario e
dall’inatteso: è questa la sua funzione “vitale” per gli individui e per la società.
Ciò che più precisamente entra in crisi nell’esperienza di una realtà
percepita come sconosciuta, misteriosa e fuori dall’ordinario è proprio quella
capacità conoscitiva che nel modello animistico costituiva erroneamente il
centro dell’esperienza religiosa, ciò in cui in ultima istanza essa si risolveva.
Marett scrive a riguardo che «le credenze religiose dell’uomo sono un effetto
collaterale del suo sviluppo intellettuale […] dobbiamo ammettere il fatto
che, in risposta alle emozioni di timore reverenziale, meraviglia, e simili e,
in ogni caso, in connessione con tali emozioni, in cui il sentimento sembra
oltrepassare la capacità di una “naturale”, ossia ragionevole, spiegazione, sorge
nella sfera del pensiero umano un potente impulso ad oggettivare […] ciò che
è avvertito come misterioso o “soprannaturale”, e nella regione della volontà
un corrispondente impulso a renderlo innocuo o meglio ancora propizio»27.
Di qui la definizione del preanimismo come stadio elementare della religione,
entro il quale, all’esperienza di forze extra-ordinarie e in risposta ad emozioni
ambivalenti, sorge negli uomini, la cui capacità esplicativa risulta per il momento
compromessa, l’impulso ad oggettivare ciò che è avvertito e a instaurare dunque
con le potenze del soprannaturale rapporti che ne circoscrivano la forza entro
limiti compatibili con la normale vita collettiva. Ciò attraverso pratiche che
sono per l’appunto organizzate a livello comunitario28.
R. R. Marett, Anthropology, tr. it. cit., pp. 190 e s..
Ivi, p. 190. Qui e in altri passi, si riscontra l’influenza su Marett del pragmatismo di
William James. Per quest’ultimo, l’azione sociale della religione consiste nel dare conforto e
senso di sicurezza, fiducia e sollievo: è questa infatti per James «la più importante funzione
dell’umanità» (da una lettera alla sig. ra Morse, cit. in G. Filoramo, Religione e ragione tra Ottocento e Novecento, Roma, 1985, p. 127). Per James, «la religione era, storicamente, l’esito di un
continuo interscambio tra individuo e collettività. All’origine vi era, sì, la religiosità creativa di
singole personalità particolarmente dotate, ma era la collettività sociale, in funzione dei propri particolari bisogni e in rapporto al ruolo che quella determinata religione positiva era in
grado di svolgere, a decretare la continuità o la morte dell’esperienza religiosa del fondatore»
(ibidem). In questo senso «le religioni hanno approvato se stesse: hanno provveduto ai bisogni
vitali dominanti nel momento della loro apparizione. Quando esse hanno violato troppo energicamente altri bisogni, oppure quando sono sopravvenute altre fedi più idonee a soddisfare
i bisogni della società, quelle prime religioni sono state sostituite» (W. James, The Varieties of
Religious Experience: a study in human naturae, Londra, 1903, p. 331).
27
R. R. Marett, The Threshold of Religion, cit., p. 10 (corsivo mio).
28
Le potenze del soprannaturale possono essere dotate di personalità e volere, ma ciò non
implica che esse siano dotate anche di un’anima (anche se, come sostiene Marett, tendono di
frequente ad acquisirla nel corso dell’evoluzione della religione). Ciò che caratterizza primariamente tali potenze è «il carattere soprannaturale in esse presenti, che colpisce intimamente
25
26
186
Tatiana Tabacchino
Data questa definizione, resta però ancora da chiedersi, cosa più
propriamente mandi in crisi la capacità conoscitiva dei primitivi. Che cosa
spaventa, disorienta e sorprende l’uomo? Qual è il vero oggetto della religione?
2. L’oggetto dell’esperienza religiosa: il sacro come “proibito” (tabù) e il sacro
come “potente” (mana)
«Possiamo definire [
] – Marett scrive – l’oggetto religioso come il sacro,
e l’atteggiamento religioso come consistente in quella manifestazione del
sentimento, del pensiero e dell’azione nei riguardi del sacro che è ritenuta
foriera di benessere per la comunità o per gli individui considerati come membri
della comunità»29, essendo quest’ultima il vero soggetto beneficiario dell’agire
religioso. L’oggetto specifico della religione è il sacro30 o «soprannaturale
[…], così come distinto dal naturale o dal normale: ciò che […] “fa fallire la
spiegazione razionale”»31.
l’uomo», spingendolo al rispetto, al servizio, al compimento di atti propiziatori finalizzati a
limitare e delimitare l’effetto di tali potenze. In altre parole, nella forma preanimistica, alcuni
fenomeni naturali e alcuni aspetti della realtà sono carichi di potenza ed esperiti come manifestazioni del soprannaturale, ma non sono ancora personificati come anime e percepiti come
qualcosa di nettamente soprasensibile. Attribuire, ad esempio, caratteristiche di vita a rocce
o a fenomeni atmosferici, non vuol dire credere necessariamente che l’anima sia la causa del
comportamento delle prime o dei secondi. Possono esistere, infatti, forze soprannaturali le
cui manifestazioni non derivano dall’anima. Partendo da questa premessa, Marett definisce
il preanimismo anche come “animatismo”, ossia come la fede nell’esistenza di forze non animistiche o non primariamente animistiche che possono, tuttavia, conferire a oggetti, animali
e persone dei poteri straordinari. Le principali fonti etnografiche cui Marett rimanda sono: J.
Thomson, Through Masailand, Londra, 1885; W. Ellis, Polynesian Researches, Londra, 1826;
R.H. Codrington, The Melanesian, Oxford, 1891.
29
R. R. Marett, Primitive Religion (1909), in Encyclopaedia Britannica, vol. XIX, Londra,
1951, p. 103.
30
In The Conception of mana, Marett precisa: «il termine inglese “supernatural” sembra
adattarsi meglio a questo contesto [l’esperienza religiosa elementare] rispetto alla parola “sacred”. “L’idée du sacré” può essere abbastanza adatto in Francia, poiché “sacré” può significare
sia “benedetto” che “dannato”» (R. R. Marett, The Threshold of Religion, cit., p. 126). Nella
lingua inglese, spiega Marett, “sacred”, proprio come il “sacer” latino, si riferisce invece solo
al modo o senso “negativo” del soprannaturale (il tabù). Laddove Marett utilizza il termine
“sacro” come sinonimo di “soprannaturale” lo fa, quindi, ammettendo di compiere un “abuso”
linguistico, che attribuisce al termine inglese “sacred” il significato più ampio che ha l’espressione francese “sacré”. A dispetto dell’opinione di Marett, sulla cosiddetta “ambivalenza del
sacro” anche nell’ambito della lingua latina hanno insistito molti filologi, etnologi e studiosi di
storia delle religioni; in particolare M. Eliade il quale, nel Traité d’histoire des religions (1949),
sostiene, sulla scorta di Rudolph Otto, che l’aspetto attrattivo (fascinans) e quello repulsivo
(tremendum) sono entrambi racchiusi nell’aggettivo “sacer”, che in latino significa sia “santo”
che “maledetto”.
31
R. R. Marett, The Threshold of Religion, cit., p. 13.
Il “preanimismo” di Robert Ranulph Marett
187
Non bisogna dunque enfatizzare gli aspetti intellettuali dell’esperienza
del soprannaturale, ma descrivere piuttosto la natura di quest’ultimo a
partire dagli effetti – emozionali e pratici – che esso è in grado di suscitare.
Bisogna partire da quel comune, e pur altamente specifico sentimento, sotteso
all’esperienza religiosa e dalle pratiche collettive, magico-religiose, congiunte a
tale esperienza32.
La prima cosa che colpisce nella descrizione di questo «sentimento religioso
fondamentale», è il termine che Marett adopera per riferirsi ad esso: Awe. Esso
non equivale a “pure funk”, ossia al semplice timore, o alla semplice paura. Non
a caso Marett afferma che il detto «“Primis in orbe deos fecit timor” [Petronio,
Fram. 27] è vero solo se riconosciamo che anche lo stupore, l’ammirazione,
l’interesse, il rispetto e l’amore sono, non meno della paura, costituenti essenziali
di questo stato d’animo elementare»33. La descrizione dei sentimenti coinvolti
nell’esperienza del sacro è una caratterizzazione multipla e complessa, che
mostra la presenza e l’azione simultanea di stati emotivi non soltanto differenti,
ma il più delle volte anche contrastanti. Alla luce di ciò, se consideriamo il
proposito di Marett di descrivere l’oggetto religioso partendo dagli effetti che
esso è in grado di provocare, possiamo giungere a una prima conclusione
importante riguardo alla natura del sacro. Se qualcosa è in grado di suscitare
32
A differenza degli evoluzionisti classici, Marett ricongiunge la sfera religiosa e la sfera
magica, alla luce di alcuni elementi essenziali presenti in entrambe: 1) l’esperienza di una
realtà avvertita come misteriosa e soprannaturale; 2) le pratiche sociali volte alla normalizzazione di stati di tensione emotiva (individuali o collettivi). La magia, come la religione, ha
una funzione “catartica o stimolante”, fungendo, in situazioni di crisi, da fattore sociale di
“normalizzazione” e da stimolo alla volontà di vivere e di agire. Essa non può essere considerata (come in Frazer) un caso di applicazione errata delle idee di associazione. Si consideri un
esempio riportato da Marett in From Spell to Prayer (1904). Un uomo, che è stato tradito dalla
donna che amava e che vuole esercitare una magia contro di lei, brucia il ritratto dell’amata.
Per Frazer alla base di una simile pratica vige un errato ragionamento: bruciando il ritratto
brucerà anche la persona raffigurata nel ritratto e ciò perché chi pratica questo rito magico
crede che le due cose (il ritratto e la persona) siano in un rapporto omeopatico. Considerando
questo stesso esempio dalla prospettiva di Marett, la spiegazione è completamente differente:
egli mette al centro la consapevolezza di avere a che fare con un’attività simbolica da parte di
chi compie il gesto magico in questione. La persona che getta il ritratto sul fuoco «percepisce,
in maniera più o meno chiara, che si tratta di qualcosa di fantastico, e tuttavia se ne lascia
trasportare e lo lascia agire su di lui. E perché lo fa? Inizialmente, suppongo, perché sente che
la cosa gli procura piacere. Riuscire a dominare la propria furia con un espediente qualsiasi è
probabilmente liberante, cioè catartico. Sa che non fa niente di reale, e allora fa in modo di crederlo» (R. R. Marett, The Threshold of Religion, cit., p. 49). Alla luce di ciò, possiamo dire con
Evans-Pritchard che per Marett «la magia è piuttosto un’attività sostitutiva, in situazioni in cui
i mezzi pratici [tradizionali] sono inadeguati per raggiungere il fine: essa ha una funzione catartica o stimolante, dà agli uomini», proprio come la religione, «coraggio, sollievo, speranza e
tenacia» ed è in grado anche «di servire da sfogo all’energia superflua» (E. E. Evans-Pritchard,
Teorie sulla religione primitiva, tr. it. di J. Hilowitz, Torino, 1997, pp. 85 e s.).
33
R. R. Marett, The Threshold of Religion, cit., p. 13.
188
Tatiana Tabacchino
emozioni contrastanti, ciò può voler dire che l’oggetto in questione presenta esso
stesso delle caratteristiche contrastanti: il soprannaturale o sacro ha una natura
complessa e in sé ambivalente, “attrattiva” e “repulsiva” allo stesso tempo.
Ci sono sempre due aspetti da mettere in rilevo a proposito del soprannaturale:
1) il fatto che bisogna essere cauti nei suoi confronti; 2) il fatto che esso è carico
di potere. Il primo può essere chiamato «l’aspetto negativo del soprannaturale»,
il secondo il suo «aspetto positivo». Mentre il tabù corrisponde all’aspetto
negativo, dove “negativo” non significa altro che «proibitivo» o «minatorio»,
il mana rappresenta, invece, l’aspetto positivo del soprannaturale, ossia quello
«operativo» e «taumaturgico».
Prima di approfondire questi aspetti, è opportuno tuttavia precisare che
l’intento di Marett non è quello di porre l’accento sulla dimensione intellettuale
dell’individuazione di queste due principali “categorie” da parte dei primitivi.
È fuori dubbio che «il pensiero primitivo ha bisogno di una doppia serie
di concetti», in base ai quali, «il soprannaturale è negativamente tabù e
positivamente mana»34. Ma «presso i selvaggi, simili nozioni non sono state
costruite all’interno di una qualche teoria sistematica; né è possibile dire
a che stadio dello sviluppo mentale esse siano entrate in uso per la prima
volta»35. Nell’esperienza religiosa primitiva, simili nozioni hanno un loro
ruolo specifico e sono pertanto una realtà fattuale, ma ciò non autorizza a
cercare «determinatezza nelle categorie primitive, poiché esse non sono mai
oggetto di un procedimento d’astrazione né, in quanto idee, sottoposte ad un
esame riflessivo, ma rappresentano semplicemente associazioni, più o meno
arbitrarie, suggerite e sancite dal costume»36.
Marett sembra voler dire che le categorie sotto le quali i primitivi raccolgono
le loro esperienze religiose non sono il frutto di un’astrazione consapevole, ma
di un “pensiero emozionale”, di un pensiero “intrecciato” con le cose e con gli
oggetti e distante dalle forme del pensiero logico. Non ha quindi alcun senso
chiedersi in che modo queste categorie siano state logicamente formulate. Ciò
che conta è cercare di fornire ad esse una spiegazione in termini di psicologia
sociale, partendo da ciò che il soprannaturale è in grado di provocare a livello
collettivo, rilevando cioè gli effetti emozionali e pratici che esso è in grado di
sortire37.
34
R. R. Marett, Supernaturalism, in Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. XII, Edinburgo-New York, 1921, p. 120.
35
Ibidem.
36
Ibidem (corsivo mio).
37
A questo proposito è interessante notare che Fausto Curi, facendo riferimento all’interpretazione della magia di M. Mauss, sottolinea che per quest’ultimo «non si dà magia se non
Il “preanimismo” di Robert Ranulph Marett
189
Del resto la stessa distinzione tra sacro e profano, che è il fondamento
dell’esperienza religiosa38, non è stabilita dai primitivi in termini logici o di
pensiero astratto. Essa riguarda ancora una volta, da un lato, la specificità dei
vissuti emozionali connessi con l’esperienza del sacro e, dall’altro, le pratiche
sociali che ad essa si accompagnano. «Il supernaturalismo primitivo – scrive
a riguardo Marett – mostra se stesso primariamente in un gruppo di pratiche
tradizionali, attraverso le quali sentimenti e pensieri [connessi al soprannaturale]
trovano la loro soddisfazione. La questione, quindi, è capire fino a che punto
si determini una distinta sfera del comportamento, corrispondente all’interesse
per il soprannaturale»39.
sulla base di un “con-sentimento universale”. Intanto la magia esiste in quanto vi è una società
che la richiede e ne permette la realizzazione. “Atti alla cui efficacia non crede un intero gruppo non sono magici”. È infatti sulla “credenza” che la magia si fonda, ossia sulla “adesione
di tutto l’uomo all’idea”. S’intende che tale “adesione” ha alla radice non una convinzione
razionale, ma degli stati affettivi, e soprattutto il desiderio. Secondo Mauss, “la forza magica
del desiderio” ha una tale intensità che “la maggior parte della magia è costituita da desideri”.
Poiché il desiderio non è altra cosa dal pensiero emozionale, ne segue che pensiero magico e
pensiero emozionale sono organicamente congiunti» (F. Curi, Gli stati d’animo del corpo: studi
sulla letteratura italiana dell’Otto e del Novecento, Bologna, 2005, p. 132).
38
Marett affronta una questione sollevata da Frazer ne Il Ramo d’oro e inerente la mancanza di distinzione presso i selvaggi tra il naturale (o ordinario) e il soprannaturale (o extra-ordinario), alla quale fecero seguito diverse critiche. F. B. Jevons suggerì di non cadere
«nell’errore di immaginare che c’è stato un tempo in cui l’uomo non distingueva tra il naturale
e il soprannaturale. Errore che potrebbe indurre a sostenere che per l’uomo primitivo o tutto
era soprannaturale o tutto era naturale» (F. B. Jevons, Introduction to the study of Religion,
Londra, 1896, cit. in R. R. Marett, Supernaturalism in Encyclopaedia of Religion and Ethics,
cit., p. 119). Per Jevons, più semplicemente, «l’uomo primitivo si attribuisce il merito dei suoi
tentativi riusciti di far funzionare il meccanismo della natura a proprio vantaggio, ma quando il macchinario non funziona nel modo voluto egli attribuisce il fallimento ad un qualche
potere soprannaturale» (ibidem). Marett cita anche l’obiezione di Durkheim, contenuta ne Le
forme elementari della vita religiosa (1912), secondo la quale il pensiero primitivo opera sicuramente una distinzione tra la sfera del sacro e quella del profano, anzi, è questa distinzione
il fondamento dell’esperienza religiosa. Tuttavia, sebbene presso i selvaggi esista la nozione di
un ordine naturale o abituale, ammettere delle fratture al suo interno non equivale per loro ad
ammettere la rottura di un ordine necessario, del tipo di quello della scienza moderna. «Non
si può neppure dire», afferma Marett, «che il pensiero primitivo sia completamente privo di
un’idea corrispondente a quella di naturale o normale»; ad esempio, «nel caso del noa melanesiano (il non-sacro, il comune, o il permesso) abbiamo, proprio come accade per il termine
latino profano, l’equivalente del termine “natura”» (ibidem). Ma ciò resta valido nella misura in
cui, anche per Marett, tale espressione «non sta ad indicare un ordine meccanico [necessario]
ma la routine» ossia l’ordine abituale (ibidem).
39
R. R. Marett, Supernaturalism, in Encyclopaedia of Religion and Ethics, cit., p. 120. Senza
dubbio, scrive Marett, «presso alcuni popoli primitivi la divisione tra gli aspetti secolari e quelli
magico-religiosi sembra “fatta con l’accetta”» (ibidem). Citando Native Tribes of Central Australia
(1899) di Spencer e Gillen, egli aggiunge che «dal momento dell’iniziazione […] la vita di un primitivo è bruscamente divisa in due parti. Egli ha prima di tutto ciò che potremmo definire una vita
ordinaria, comune a tutti gli uomini e le donne, associata con la ricerca del cibo e la corrobboree
[danza rituale collettiva legata al rito della prolificità] e caratterizzata da una tranquilla monotonia
[…], rotta di tanto in tanto dall’eccitazione connessa a una lotta. Dall’altro lato, egli ha ciò che
gradualmente diviene sempre più importante per lui, ossia la parte della sua vita dedita a questio-
190
Tatiana Tabacchino
Fatta questa precisazione, si tratta anzitutto di mettere a fuoco la funzione
delle pratiche tabuistiche presso i primitivi. In esse «qualcosa viene separato
al fine di essere evitato, con l’annesso suggerimento di una mistica sanzione
o penalità che in fondo è ciò che fa rispettare l’astensione»40. Con questa
definizione, Marett evidenzia che nella maggior parte dei casi gli effetti nocivi
derivanti dall’infrazione di un tabù non hanno, come riteneva ad esempio Frazer,
un carattere “omeopatico” (a x segue x1)41. Essi, al contrario, sono piuttosto
vaghi e indefiniti (sventura, malattia ecc.): ciò che si teme non è qualcosa di
definito e prevedibile, ma è essenzialmente un potere misterioso, qualcosa di
arbitrario e inesplicabile nelle sue modalità di azione.
In connessione con ciò, Marett precisa inoltre che le esperienze tabuistiche
implicano sempre due aspetti o «sensi» fondamentali del tabù. «Da un lato,
poiché si ritiene che ciò che è oggetto di tabù punisca colui che infrange il tabù
per mezzo di una mistica infezione, il tabù viene a rappresentare l’impurità
e il peccato. Dall’altro lato, poiché l’isolamento del sacro […] può essere
interpretato come un’auto-protezione da parte del sacro contro forme di contatto
contaminante, il tabù prende i connotati della virtù ascetica, della purezza,
ni di natura sacra o segreta. Man mano che invecchia egli acquista un ruolo crescente in queste
faccende, finché alla fine questo lato della sua vita occupa di gran lunga la parte maggiore dei suoi
pensieri» (ibidem). Ma occorre tener conto anche dell’opinione di Malinowsky, il quale «ha messo in evidenza che una simile bipartizione delle attività non è una caratteristica universale della
società primitiva. Egli porta l’esempio dei Vedda e dei Melanesiani, presso i quali le attività e gli
interessi religiosi e secolari sembrano sfumare gli uni negli altri senza percepibili soluzioni di continuità» (ibidem). Secondo Marett, la teoria dei “due mondi” (quello sacro e quello profano), che
per Durkheim è alla base della vita religiosa, «è sufficientemente adeguata in alcuni contesti – ad
es., per spiegare quei “riti di passaggio” attraverso cui un uomo durante l’iniziazione, o una donna
al momento del parto, entra in contatto con un tabù e passa nuovamente alla vita ordinaria» (ibidem). Essa però «non deve essere eccessivamente forzata, alla luce del fatto che la sacralità è per
certi versi relativa, così che, per es., un uomo può essere egli stesso tabù, ma solo per gli stranieri
e non per i suoi amici» (ibidem). Per Marett «tutto ciò che qui deve essere dato per assunto è che
certe attività tendono ad essere organizzate attorno all’interesse per il soprannaturale, radicato in
uno specifico tessuto di sentimenti e credenze. La vita magico-religiosa è inesauribile dal punto di
vista di ciò che essa pretende dall’impegno umano e, dal punto di vista dei suoi effetti sulla salute
degli uomini, può essere quasi del tutto pervasiva. Ma l’attitudine mentale che essa richiede non
può essere continuamente mantenuta. Ogni qual volta la tensione [emotiva] si allenta, la “natura”,
nella forma del ruolo spontaneo e naturale dell’abitudine, si impegna a compensarla» (ibidem).
40
R. R. Marett, Primitive Religion, in Encyclopedia of Religion and Ethics, cit., p. 103 (corsivo mio).
41
Per Frazer la magia si basa su un meccanismo associativo fallace, non empiricamente
fondato, in virtù del quale i primitivi confondono l’ordine delle proprie idee con l’ordine della
natura. Tale meccanismo può essere espresso con la formula: “fai x per ottenere x1” (spruzza
dell’acqua sul tetto se vuoi che cada la pioggia). Alla luce di ciò, Frazer interpreta il tabù come
una forma di “magia negativa”, basandosi esso su un meccanismo analogo, esprimibile con
la formula: “evita x affinché non si produca x1” (non mangiare la carne di cervo se non vuoi
diventare una persona timida). Cfr. J. G. Frazer, Il Ramo d’oro (1890), tr. it. di L. De Bosis,
Torino, 1973, pp. 305-406.
Il “preanimismo” di Robert Ranulph Marett
191
della devozione, della dignità e della benedizione»42. Per questo, anche laddove
Marett si sofferma a descrivere “negativamente” le qualità del soprannaturale,
il senso “positivo” di quest’ultimo resta nel contempo altrettanto presente. La
proibizione, che è l’aspetto “negativo” del sacro per eccellenza, ha anch’essa un
lato “positivo”, laddove la si consideri come una sorta di autodifesa da parte del
soprannaturale nei confronti di oggetti e contesti ordinari o profani. Stando a
una metafora molto ricorrente nelle diverse interpretazioni del tabù, il sacro
contiene, o meglio, è esso stesso un’energia che, attraverso il contatto con
corpi estranei, può scaricarsi e perdere la propria originaria intensità. Di fatto,
quindi, la descrizione del soprannaturale come oggetto tabuistico s’intreccia
strettamente con la sua caratterizzazione, in termini “positivi”, come energia o
forza impersonale (mana).
Anche questa è una conseguenza dalla scelta di Marett di non indagare gli
aspetti intellettuali del soprannaturale, e di accentuare piuttosto la dimensione,
al tempo stesso sociale e mistica, che caratterizza il sacro e le pratiche ad
esso congiunte. Per tale motivo, riguardo al tabù, Marett dichiara che esso «è
sempre una questione mistica», aggiungendo di non riuscire «a capire perché vi
dovrebbe essere qualcosa di mistico nella magia simpatica intesa semplicemente
(così come Frazer la intende) quale erronea applicazione delle leggi delle
associazioni di idee. Dopo tutto le associazioni di idee (anche se da sole non
possono spiegare nessuno dei nostri pensieri) sono alla base del nostro modo
di pensare nella sua interezza, il quale non rientra certamente in una sfera
mistica»43. Marett si chiede se davvero, come ritiene Frazer, l’aspetto mistico
si esaurisca nell’erronea applicazione delle suddette leggi. Si domanda cioè se
davvero l’unica differenza tra un tabù e una norma di senso comune (“non
toccare il fuoco se non vuoi scottarti”) consista in una sbagliata applicazione del
meccanismo di associazione nel caso del tabù, che connette alla violazione una
conseguenza immaginaria e non reale (come lo è invece l’ustione di chi tocca
il fuoco). Perché non prendere invece in considerazione i motivi (sentimenti o
desideri) che spingono colui che rispetta il tabù non già ad operare un’erronea
associazione di idee, ma a credere che una certa pratica, seppur simbolica,
possa avere comunque su chi la compie un determinato effetto positivo e, per
la comunità, un preciso effetto di normalizzazione di stati di tensione emotiva
potenzialmente dannosi44.
42
R. R. Marett, Primitive Religion, in Encyclopedia of Religion and Ethics, cit., p. 103 (corsivo mio).
43
R. R. Marett, The Threshold of Religion, cit., pp. 95 e s. (corsivo mio).
44
Rispetto alla funzione di normalizzazione e disciplinamento dei tabù, Marett scrive:
192
Tatiana Tabacchino
Essendo contrario a parlare del tabù nei termini di una “magia negativa”,
Marett si preoccupa di rilevare come nelle pratiche tabuistiche ciò che si teme è
generalmente qualcosa d’indefinito e d’incomprensibile. Perciò, se si utilizza il
termine mana per descrivere questo qualcosa di misterioso che viene avvertito
ed evitato, il tabù può essere anche definito come un mana negativo.
Riguardo al mana, Marett preferisce evitare descrizioni che siano troppo
specifiche. Il mana è spesso operativo e taumaturgico, ma non sempre. Ciò
significa, richiamando nuovamente la metafora energetica, che esso può essere
latente o potenziale, nella misura in cui «mostra il soprannaturale nella sua
capacità positiva, ma non necessariamente in atto, di manifestarsi»45.
Marett non va molto oltre nella presentazione del mana. Tuttavia c’è un
aspetto che emerge chiaramente, e cioè che la nozione di mana, «per quanto
sia in grado di dar espressione precisa all’immateriale e all’invisibile, lascia
però come in sospeso [
] la differenza tra il personale e l’impersonale, e in
particolare non permette l’entrata in scena del concetto di individualità»46.
È questo uno dei motivi per il quale la nozione di mana si rivela più adatta,
rispetto a quella di animismo, per descrivere la religione primitiva. Di fatti la
nozione di animismo «tende a non avere alcuna relazione con le forme più
impersonali del soprannaturale, e in molti casi non è in grado di esprimere
la trasmissibilità e l’immaterialità di queste forze [impersonali]», potendo
soltanto «dar espressione sufficientemente distinta ad agenti soprannaturali
forniti di un’elevata individualità, laddove la condizione sociale dell’umanità si
è evoluta al punto tale da favorire una simile concezione»47. Invece, «laddove
«in primo luogo questi tabù [le proibizioni alimentari], non meno di tutti gli altri, sono delle pratiche consuetudinarie: una parte della legge non scritta della società. A ciò deve quindi essere attribuita almeno una parte della forza che li rende effettivi. Ci sono sempre delle
punizioni sociali di diversa natura temute da chi infrange un tabù; nei casi estremi viene
inflitta la morte, ma in ogni caso vi sarà sempre, in misura maggiore o minore, ciò che gli
aborigeni australiani chiamano “mormorio”, ed è risaputo che sostenere il peso dell’opinione pubblica è l’ultima cosa di cui il selvaggio è capace. D’altra parte la sanzione sociale
è nello stesso tempo anche religiosa; per usare il linguaggio di una cultura più avanzata si
potrebbe dire, poiché Stato e Chiesa sono indivisibili, che essere fuorilegge significa ipso
facto essere scomunicati […]. La disapprovazione sociale di ogni tipo tenderà ad adottare
il tono e i colori dell’ostilità religiosa, a causa della sensazione che il trasgressore sia la
fonte di pericoli spirituali per la comunità; mentre il potere di sanzionare rimane sociale,
nel senso che la società ha mezzi efficaci per allontanare da sé la maledizione» (R. R. Marett, The Threshold of Religion, cit., pp. 92 e s.).
45
Ivi, pp. 128 e s..
46
Ivi, p. 138.
47
Ibidem. Marett non mette in relazione la crescente complessità nello sviluppo
della religione con la crescente complessità del pensiero umano nel corso della sua evoluzione, ma con l’avanzamento della complessità sociale. In ciò emerge una differenza
fondamentale fra l’evoluzionismo di Marett e l’evoluzionismo antropologico classico,
Il “preanimismo” di Robert Ranulph Marett
193
mancano individualità marcate nella società, come ad esempio in Australia,
il supernaturalismo tende normalmente ad essere adottato sotto forme più o
meno impersonali»48.
Marett non intende dire che i portatori di culture primitive più elementari, in
cui prevale il supernaturalismo, manchino di qualsiasi esperienza o nozione di
individualità. Ovunque l’individualità, «nel senso dell’intima esistenza soggettiva,
è sufficientemente messa in rilievo»49. Egli vuole, piuttosto, fare notare che,
nelle culture primitive più elementari, si riscontrano difficilmente individui
dalla spiccata personalità e individualità: in esse «ogni uomo è estremamente
simile ad un altro»50, e ciò si proietta anche nelle preanimistiche concezioni del
mana. Nel preanimismo, infatti, l’oggetto del sentimento religioso elementare
e universale riflette, nella sua indeterminatezza e omogeneità, la caratteristica
conformazione del corpo sociale primitivo, entro il quale non emergono
individualità sorprendenti o eccezionali. Solo a un livello più «avanzato» della
società, si riscontrano, secondo Marett, entità religiose differenziate, definite
e coerenti. Tuttavia anche quando si passa «dalla religione primitiva a quella
che definiamo “avanzata”, l’animismo non riesce mai fino in fondo ad estirpare
completamente dal terreno le concezioni più impersonali del soprannaturale»51.
«Del resto lo stesso teismo antropomorfico, una prospettiva che si origina
sia dall’animatismo che dall’animismo vero e proprio, domina molte delle
credenze religiose più alte, ma non tutte. Si consideri ad esempio il Buddismo,
ossia un tipo di religione avanzata che esalta l’aspetto impersonale del divino, o
ancora, il modo in cui un pensatore come Platone, con tutto il suo interesse per
laddove egli, influenzato da autori come Durkheim e Lèvy-Bruhl (a loro volta eredi della Völkerpsychologie di Wund), ritiene che la differenza tra le culture primitive e quelle
più “avanzate” non debba essere pensata – intellettualisticamente – come differenza
di grado nello sviluppo mentale, ma principalmente come una differenza qualitativa,
determinata in senso sociale.
48
Ivi, pp. 139 e s.. Si confronti la posizione di Marett con quella di Mauss e Hubert, secondo i quali: «non bisognerebbe esagerare l’importanza della nozione di persona all’interno stesso della categoria delle rappresentazioni demoniache […] esistono demoni i quali
non rappresentano nulla al di fuori delle proprietà o dei riti che personificano imperfettamente. Nella loro definizione non rientra quasi niente altro, oltre la nozione di influenza e
di trasferimento dell’effetto. Essi sono a@porri@a@i, effluvi. Gli stessi nomi dei demoni indiani
dimostrano la loro scarsa individualità: siddha (coloro che hanno ottenuto il potere), vidyâdhâra (portatori di scienza) [….]. È ciò che si manifesta ancora nella frequente indeterminazione del numero e dei nomi dei demoni, i quali formano di solito delle bande,
delle moltitudini di esseri anonimi […] spesso designati con specie di nomi comuni» (M.
Mauss – H. Hubert, Teoria generale della magia e altri saggi, tr. it. di F. Zannino, Torino,
1991, pp. 106 e s.).
49
R. R. Marett, Anthropology, tr. it. cit., p. 198.
50
Ivi, p. 164.
51
R. R. Marett, The Threshold of Religion, cit., p. 140.
194
Tatiana Tabacchino
l’anima, la personalità umana e la dimensione soggettiva in generale, esiti tra
un’interpretazione personale e una impersonale del divino» 52.
3. La fortuna e i limiti dell’ipotesi preanimistica
«Anche se in Inghilterra i punti di vista di Marett furono accettati da
personalità notevoli […], essi trovarono un pubblico ben più ricettivo e sensibile
in Germania, prima in Wundt e Preuss, più tardi in Otto» e in Max Weber53.
Questa circostanza richiederebbe di considerare i motivi dell’interesse per
un’interpretazione della religione come quella di Marett alla luce di una storia
ben precisa, quella delle scienze religiose nei primi venti anni del Novecento,
dando particolare centralità agli sviluppi che tale storia ha avuto nell’area
culturale tedesca54.
Possiamo qui limitarci a costatare con Kippenberg che «il ventesimo secolo
iniziò in Germania con una discussione culturale improntata all’emotività. La
società moderna era ormai diventata, come figura e forza di industrializzazione,
burocratizzazione e scientificizzazione, visibile nella vita di ciascun singolo»55.
A fronte di ciò «l’attenzione particolare degli eruditi si indirizzava al destino
della “cultura”. La si vedeva minacciata dall’avanzante civilizzazione esterna»,
tanto che il termine stesso “cultura” «divenne “una parola d’ordine carica di
pathos”, con la quale i filosofi reagivano alla “preoccupazione per l’incombente
glaciazione dell’anima”»56. In questo «processo che opponeva gli eruditi
all’avanzante civilizzazione tecnica, i filosofi chiamavano a testimoniare anche
le religioni»: la rinascita dell’interesse per la religione era indicata come prova
del fatto che l’interiorità non si faceva «sconfiggere senza resistenza»57.
Ciò, dal punto di vista del modo di considerare e comprendere la religione,
ha avuto dei risvolti molto importanti. In generale è prevalsa la tendenza a
“sganciare” l’interpretazione della religione dai diversi approcci intellettualistici,
di stampo evoluzionistico e positivistico, i quali ritenevano che anche la
religione potesse essere integralmente ricondotta nell’ambito di una spiegazione
razionale, alla luce dei suoi aspetti teorici, riflessivi, intellettuali. Tuttavia questo
Ivi, pp. 140 e s..
D. R. Bengtson, R. R. Marrett and the Study of Religion, in «Journal of the American
Academy of Religion», XLVII, 1979, p. 654.
54
Cfr. H. G. Kippenberg, La scoperta della storia delle religioni, tr. it. di G. Ghia, Brescia,
2002, pp. 174-184.
55
Ivi, p. 235.
56
Ibidem.
57
Ibidem.
52
53
Il “preanimismo” di Robert Ranulph Marett
195
motivo antintellettualistico, comune a molte interpretazioni della religione dei
primi del Novecento, ha trovato nei singoli autori declinazioni tra loro molto
diverse che possiamo, in maniera molto generale, suddividere in due principali
orientamenti.
Da un lato, la posizione di coloro che hanno pensato di attribuire alla
religione un campo autonomo e inaccessibile all’indagine razionale, al fine
di sottrarre la religione (e con essa, e tramite essa, l’uomo) dal «giogo del
razionalismo». Di qui l’accentuazione degli aspetti mistici della religione, dei
suoi fattori d’incertezza e di mistero, oltre alla caratterizzazione dell’esperienza
religiosa come un’esperienza individuale sui generis (si pensi ad es. a Rudolph
Otto). Dall’altro lato, la scelta diversa di non enfatizzare in maniera eccessiva la
componente emozionale e irrazionale a scapito di quella razionale, e il proposito
di definire e qualificare un diverso tipo di “razionalità religiosa”, congiungendo
l’aspetto della razionalità a quello dell’efficacia dell’agire religioso, preso in
esame, almeno nella sua consistenza originaria, dal punto di vista della sua
capacità di orientare azioni volte al raggiungimento di scopi mondani (si pensi
ad es. a Max Weber)58.
È evidente che la teoria del preanimismo, riconducibile a un approccio
evoluzionistico critico e non intellettualistico, perché liberato dagli elementi
più marcatamente positivistici, può aver offerto elementi di spunto a entrambi
questi orientamenti. Da un lato, infatti, Marett aveva posto l’accento sull’aspetto
“mistico” della religione, connesso all’esperienza di forze soprannaturali
(rappresentate nella loro duplice natura “attrattiva” e “repulsiva”), e sugli
effetti emozionali che ad essa si congiungono (sentimenti essi stessi di natura
ambivalente, come la paura, l’amore ecc.). Di qui l’interesse per le sue idee da
parte di un autore come Otto, il quale fa esplicito riferimento a Marett ne Il
sacro: sull’irrazionale nell’idea del divino e il suo rapporto con il razionale (1917)59.
58
Tra questi due orientamenti si inseriscono tutta una serie di posizioni intermedie, come
quella di Nathan Söderblom (1866-1931), il quale «non traeva, a differenza di Otto, la conseguenza che ogni interpretazione razionale fosse secondaria e inadeguata rispetto a questa
esperienza irrazionale [l’Erlebnis religioso]. Per lui si poneva piuttosto la questione dell’ordinamento di rango di questi schemi interpretativi», questione in base alla quale, Söderblom
considerava ad esempio «la religiosità etica dei profeti di un rango superiore rispetto alla redenzione impersonale conseguita mediante la contemplazione»; ciò in controtendenza rispetto a Otto, il quale «aveva visto nella mistica naturale l’opzione per la salvezza della cultura del
suo tempo», laddove Weber vi aveva scorto invece «una fuga incosciente dalla responsabilità»
(ivi, pp. 244 e s.).
59
«La religione – scrive Otto – non è nata né da uno sgomento naturale, né da un’ipotetica,
generica angoscia cosmica. Poiché l’inorridire non è un timore naturale e ordinario, bensì un
primo apparire del misterioso sullo schermo dei sentimenti, un primo avvertirlo, seppure nella
forma dell’“inquietudine”, una prima valutazione secondo una categoria, la quale non è com-
196
Tatiana Tabacchino
Dall’altro lato, l’interpretazione della religione proposta da Marett è un esempio
di come si possa reintrodurre in questo campo il discorso sulla razionalità,
evitando però i limiti delle precedenti spiegazioni intellettualistiche. Ciò è
possibile giacché Marett cerca di evidenziare che la religione acquista senso
(e verità) alla luce degli scopi pratici sensati che essa persegue, ritenuti utili
nell’ambito della vita collettiva. Di qui l’interesse di Weber per il preanimismo,
al quale egli fa riferimento nello scritto sui tipi di comunità religiosa, che è
parte della stesura prebellica di Economia e Società 60.
Certo, lo schema interpretativo di Marett non è esente da limiti. Il
principale punto critico della sua teoria risiede nell’ambiguità tra il piano
storico e il piano categoriale che caratterizza la formulazione del concetto di
preanimismo, ambiguità messa in luce anche da Ernesto De Martino nel suo
Naturalismo e storicismo nell’etnologia61. Marett ritiene che l’animismo, inteso
presa nel consueto e ordinario ambito naturale, non si rivolge alla natura» (R. Otto, Il Sacro,
tr. it. di E. Buonaiuti, Milano, 1966, p. 25). È dal sentimento di terrore e al tempo stesso di
ammirazione e fascino che si prova di fronte a una cosa «che appare come nuova ed estranea
al senso primitivo, che è scaturito tutto lo sviluppo storico religioso» (ibidem). Detto ciò, Otto
aggiunge: «riscontro nelle indagini più recenti specialmente del Marett e del Söderblom una
gradita conferma delle tesi da me sostenute. È vero che né l’uno né l’altro pongono in risalto
con la energia piena che qui si richiede il carattere unico del “timore religioso” e la sua distinzione specifica da tutti sentimenti “naturali”. Ma in modo tutto peculiare il Marett si avvicina
alla realtà» (ivi, p. 184, n.).
60
In questo scritto Weber definisce la consistenza originaria dell’agire religiosamente o
magicamente orientato, come una forma di agire in comunità, che intende raggiungere scopi
in questo mondo, grazie allo stabilirsi di rapporti con forze extra-quotidiane. Questa forma di
agire si distingue dall’agire quotidiano e tradizionale in vista di scopi, a causa della straordinarietà dei mezzi impiegati e delle forze in gioco, alle quali «debbono venir associati particolari
nomi come mana, orenda (per gli Iraniani maga, da cui magico)» e che Weber intende «designare una volta per tutte con il termine “carisma”» (M. Weber, Economia e società: Comunità
religiose, tr. it. di M. Palma, Roma, 2006, p. 4). Di qui il riferimento esplicito al preanimismo,
laddove Weber precisa che una simile caratterizzazione dell’agire magico-religioso, che chiama in causa l’azione di forze straordinarie come il mana, è «una rappresentazione rigorosamente naturalistica (recentemente detta preanimistica)» la quale «persiste in modo ostinato
nella religiosità popolare» (ivi, p. 5).
61
L’errore di fondo dell’ipotesi preanimistica non deriva dal proposito classificatorio del
suo autore: «ogni classificazione – scrive De Martino – dentro certi limiti, ha la sua utilità» (E.
De Martino, Naturalismo e storicismo nell’etnologia, Bari, 1941, p. 87). «L’aberrazione deriva
piuttosto dalla confusione dei due piani della ricerca, del piano speculativo-storiografico e di
quello astratto e classificatorio. A questa confusione tien dietro l’altra, non meno grave, tra
ideale o categorico e reale o storico, ciò che è facilitato dalla corruzione del categorico nel
psicologico e dello storico nell’evoluzionistico. […]. Marett affronta l’indagine della religione
primitiva dal punto di vista psicologico. L’animismo, in quanto sistema di idee, trascura intellettualisticamente l’aspetto emozionale della vita religiosa […] fondamentale secondo Marett
[…]. I modi particolari di rappresentazione del soprannaturale – per es. la credenza in esseri
spirituali o animismo – sono accidentali e transitori: ma l’esperienza del soprannaturale […]
è l’universale del fatto religioso, cioè il suo elemento più semplice e più generale. Ciò posto
il soprannaturalismo è logicamente anteriore all’animismo: la definizione minima della religione come soprannaturalismo rivela qui il suo chiaro carattere di definizione media o tipica.
Il “preanimismo” di Robert Ranulph Marett
197
come la «credenza in esseri spirituali», debba essere considerato come una
rappresentazione ideale, peraltro piuttosto tardiva, dell’esperienza religiosa
elementare o preanimismo, entro la quale non ritroviamo «rappresentazioni
del soprannaturale sotto forme ideali chiare e durature», ma piuttosto «infinite
impressioni appena accennate del soprannaturale, non ben definite entro
l’ambito di un preciso pensiero sistematizzante»62. Tali impressioni sono
piuttosto il frutto di un pensiero emozionale e di un sentimento condiviso
di timore, meraviglia, ammirazione ecc. da parte dei membri di una società
primitiva. In altre parole, l’animismo, in quanto credenza negli esseri spirituali
e in quanto particolare rappresentazione del soprannaturale, è una declinazione
accidentale, transitoria, secondaria dell’esperienza religiosa elementare. Essa
consiste nell’obiettivazione immediata del sentimento di timore reverenziale
che costituisce l’elemento primario e universale del fatto religioso.
Fin qui il discorso di Marett sembra dunque voler enfatizzare l’anteriorità del
preanimismo rispetto all’animismo da un punto di vista esclusivamente logico
e psicologico. Tuttavia è lo stesso Marett a dichiarare: «sarebbe falso dire che il
termine preanimistico non ha alcun riferimento cronologico», e ad aggiungere
subito dopo che «c’è stata un’era preanimistica nella storia della religione in cui
l’animismo non c’era, ma esisteva un qualche tipo di religione»63. Proprio come
Tylor, Marett oscilla ambiguamente fra il piano categoriale e il piano storico,
perché, alla stregua del suo maestro, si sforza di giungere a una definizione
minima della religione retrocedendo nel corso del tempo, fino a un primo
cronologico che sia anche un prius categoriale, senza preoccuparsi in nessun
modo della legittimità di una trasposizione dall’uno all’altro piano. Senza cioè
Allorquando il categorico si deforma nel medio o nel tipico, subito si presenta un possibile senso
cronologico del categorico così deformato. Il Marett, infatti, si chiede se il più semplice e il più
generale del fatto religioso sia anche in senso cronologico anteriore all’animismo, se, cioè, la
religione sia cominciata in tempo prevalentemente come soprannaturalismo (obiettivazione e
personificazione immediata del timore reverenziale) per evolversi e differenziarsi poi come
animismo (credenza in esseri spirituali). E a questa domanda il Marett risponde che il suo
intento è di batter l’accento sulla esigenza psicologico-classificatoria e trascurare quindi il
problema genetico […]. Per concludere, secondo Marett, se il problema genetico deve esser
messo per ora in secondo piano, tuttavia nulla vieta che un giorno la classe si trasformi in fase
storica, e il preanimismo designi un’epoca: anzi allo stato attuale della scienza etnologica,
può affermarsi che il preanimismo è anteriore all’animismo not only logically but also in some
sense chronologically, e cioè nel senso che in una certa fase dell’umana evoluzione prevalgono fenomeni religiosi di tipo preanimistico. Insomma, secondo Marett, nulla vieta, nel fatto
o nella possibilità, che il categorico, corrotto nel psicologico, trapassi nello storico corrotto
nell’evoluzionistico, e che la definizione minima della religione divenga fase storica» (ivi, pp.
87-90, corsivo mio).
62
R. R. Marett, The Threshold of Religion, cit., pp. XI e s..
63
Ivi, p. 10.
198
Tatiana Tabacchino
preoccuparsi di approfondire quello che Weber definisce il «significato della
teoria e della formazione di concetti teorici per la conoscenza della realtà
culturale»64 e, nel caso specifico, della realtà religiosa.
64
M. Weber, L’«oggettività» conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale (1904),
in Id., Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali, tr. it. a cura di P. Rossi, Torino, 2001, pp.
182 e s..
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
199
ELENCO E RIPARTIZIONE DEI SOCI
PER ORDINE DI ANZIANITà
CONSIGLIO DIRETTIVO
Tessitore Fulvio, Presidente
Villani Pasquale, Vice Presidente
Assante Franca, Segretario
Massimilla Edoardo, Tesoriere
SOCI EMERITI (posti 4)
SEZIONE DI SCIENZE MORALI
SOCI NAZIONALI ORDINARI RESIDENTI (posti 14)
1) Guarino Antonio, prof. emerito di Diritto romano nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via Aniello Falcone, 403/ter - 80127 Napoli (tel.
081.667729).
2) Masullo Aldo, prof. emerito di Filosofia morale nell’Università di
Napoli “Federico II” - Viale Michelangelo, 21 - 80129 Napoli (tel.
081.5568328).
3) Del Treppo Mario, prof. emerito di Storia medioevale nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Manzoni, 228 - 80123 Napoli (tel.
081.7691432).
4) Casavola Francesco Paolo, Presidente emerito della Corte Costituzionale
- Via Vincenzo Padula, 2 - 80123 Napoli (tel. 081.5756522).
5) Ajello Raffaele, prof. emerito di Storia del Diritto italiano nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Napoli, 63 - 80078 Pozzuoli (NA) (tel.
081.5262554).
6) Venditti Antonio, prof. emerito di Diritto commerciale nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Petrarca, 40 - 80122 Napoli (tel.
081.5755436).
200
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
7) Cantillo Giuseppe, prof. ord. di Filosofia teoretica nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via San Giovanni Bosco, 47 - 84100 Salerno (tel.
089.790821).
8) Lissa Giuseppe, prof. ord. di Filosofia morale nell’Università di Napoli
“Federico II” - Via A. Trucillo, 34 - 84100 Salerno (tel. 089.230853).
9) Di Vona Piero, già prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Salita Arenella, 19 -80129 Napoli (tel.
081.366107).
10) Trione Aldo, già prof. ord. di Estetica nell’Università di Napoli “Federico
II” - Via Pietro Castellino, 141G - 80131 Napoli (tel. 081.5451035).
11) Vitolo Giovanni, prof. ord. di Storia medioevale nell’Università di
Napoli “Federico II” - Piazza Annunziata, 45 - 80142 Angri (SA).
12) Rao Annamaria, prof. ord. di Storia moderna nell’Università di Napoli
“Federico II” - Vico Canalone all’Olivella, 21 - 80135 Napoli (tel.
081.5648805).
13) Lomonaco Fabrizio, prof. ord. di Storia della Storiografia filosofica
nell’Università di Napoli “Federico II” - Via Pietro Giannone, 33/a 80141 Napoli (tel. 081.457603).
14)Di Marco Giuseppe Antonio, prof. ord. di Filosofia della Storia
nell’Università di Napoli “Federico II” - Gradini S. Nicola da Tolentino,
7 - 80135 Napoli (tel. 081.400202).
SOCI NAZIONALI ORDINARI NON RESIDENTI (posti 8)
1) Federici Vescovini Graziella, prof. ord. di Storia della Filosofia
nell’Università di Parma - Via dei Renai, 11 - 50122 Firenze (tel.
055.243019).
2) Vegetti Mario, prof. ord. di Storia della Filosofia antica nell’Università di
Pavia - Via Giambattista Bassoni, 6 - 20123 Milano (tel. 02.4694384).
3) Cotroneo Girolamo, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Messina - Via Maffei, 15 - 98100 Messina.
4) Cesa Claudio, prof. emerito di Storia della Filosofia nella Scuola Normale
di Pisa - Via Martiri di Scalvaia, 19 - 53100 Siena (tel. 0577.283687).
5) Nuzzo Enrico, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università di
Salerno - Piazza Porta Rotese, 18 - 84100 Salerno.
6) Levra Umberto, prof. ord. di Storia del Risorgimento nell’Università di
Torino - Via Casale, 143/2 - 10099 S. Mauro Torinese (TO).
7) Lenoci Michele, prof. ord. di Storia della Filosofia contemporanea
nell’Università Cattolica di Milano - Corso Genova, 16 - 20123 Milano.
8) Gambaro Antonio, prof. ord. di Diritto Civile nell’Università di Milano,
Piazza A. Mondadori, 3 - 20122 Milano (tel. 02.5465456).
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
SOCI CORRISPONDENTI NAZIONALI 201
(posti 14)
1) Labruna Luigi, prof. emerito di Storia del Diritto romano nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Chiaia, 149/A - 80121 Napoli (tel.
081.425885).
2) De Lorenzo Renata, prof. ord. di Storia contemporanea nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via Mosca, 4 - 80129 Napoli (tel. 081.5564464).
3) Figliuolo Bruno, prof. ord. di Storia medioevale nell’Università di Udine
-Parco Carelli, 62 -80123 Napoli.
4) Viti Cavaliere Renata, prof. ord. di Filosofia teoretica nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via Donizetti, 1/e - 80127 Napoli (tel. 081.5789878).
5) Montano Aniello, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università di
Salerno -Via Montessori, 19 - 80011 Acerra (NA) (tel. 081.5201483).
6) Pellegrino Bruno, già prof. ord. di Storia moderna nell’Università di
Lecce - Via delle Bombarde, 20 - 73100 Lecce (tel. 0832.309410).
7) D’Agostino Guido, prof. ord. di Storia moderna nell’Università di
Napoli “Federico II” - Parco Comola Ricci, 23 - 80122 Napoli (tel.
081.642217).
8) Muto Giovanni, prof. ord. di Storia moderna nell’Università di Napoli
“Federico II” - Via Ligorio Pirro, 20 - 80129 Napoli (tel. 081.5783609).
9) Musi Aurelio, prof. ord. di Storia moderna nell’Università di Salerno Via Canalone all’Olivella, 21 - 80135 Napoli (tel. 081.5496170).
10)Rambaldi Feldmann Enrico, già prof. ord. di Storia della Filosofia morale
nell’Università di Milano - Viale Argonne, 41 - 20133 Milano.
11)Giugliano Antonello, prof. ord. di Storia della Filosofia contemporanea
nell’Università di Napoli “Federico II” - Strada Gianturco Emanuele,
36 - 80055 Portici (Na) - (tel. 081.471053)
12)Verde Giovanni, già prof. ord. di Diritto processuale civile nell’Università
Luiss Roma - Via T. Angelini, 21/c - 80129 Napoli.
SOCI STRANIERI (posti 7)
1) Nowicki Andrej, prof. di Storia della Filosofia nell’Università di LublinSowinskiego 7 m. 25 - 20040 Lublino (Polonia).
2) Trinidade Santos José Gabriel, prof. di Filosofia nell’Università Nova di
Lisbona - Rua Soeiro Pereira Gomes, Ed. America, Bloco A, ap. 405 1600 Lisboa (Portogallo)
202
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
SEZIONE DI SCIENZE POLITICHE
SOCI NAZIONALI ORDINARI RESIDENTI (posti 13)
1) Galasso Giuseppe, prof. emerito di Storia medievale e moderna
nell’Università di Napoli “Federico II” - Via Napoli, 3/d - 80078 Pozzuoli
(NA) (tel. 081.5262947).
2) Tessitore Fulvio, prof. ord. f.r. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli“Federico II” - Via Santo Strato, 14 - 80123 Napoli (tel.
081.5755411).
3) Villani Pasquale, prof. emerito di Storia contemporanea nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via F. Cilea, 183 - 80127 Napoli (tel.
081.5604368).
4) Abbamonte Giuseppe, prof. emerito di Diritto amministrativo
nell’Università di Napoli “Federico II” - Viale Gramsci, 6/a - 80122
Napoli (tel. 081.663383).
5) Villone Betocchi Giulia, prof. emerito di Psicologia nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via dei Mille, 61 - 80121 Napoli (tel. 081.415741).
6) Cacciatore Giuseppe, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via L. Cassese, 12 - 84100 Salerno (tel.
089.222848).
7) Casertano Giovanni, prof. ord. di Storia della Filosofia antica
nell’Università di Napoli “Federico II” - Salita Sant’Antonio a Tarsia,
28 - 80135 Napoli (tel. 081.5445089).
8) Assante Franca, già prof. ord. di Storia economica nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Manzoni, 132 - 80123 Napoli (tel.
081.7145844).
9) Mazzarella Eugenio, prof. ord. di Filosofia teoretica nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via Orazio, 27 - 80122 Napoli (tel. 081.666279).
10) Acocella Giuseppe, prof. ord. di Etica sociale nell’Università di Napoli
“Federico II” - Via S. Giovanni Bosco, 47 - 84100 Salerno.
11) Massimilla Edoardo, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Matteotti, 18 - 80078 Pozzuoli (Na).
12) Conte Domenico, prof. ord. di Teoria e storia della storiografia
nell’Università di Napoli “Federico II” - Traversa Antonio Pio, 64 80126 Napoli (tel. 081.7281122).
13) Donadio Francesco, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Castiello, 20 - 80024 Cardito (NA) (tel.
081.8321387).
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
203
SOCI NAZIONALI ORDINARI NON RESIDENTI (posti 8)
1) Giarrizzo Giuseppe, prof. emerito di Storia moderna nell’Università di
Catania - Via Orto dei Limoni, 60 - 95125 Catania.
2) Bertolino Rinaldo, prof. ord. di Diritto ecclesiastico nell’Università di
Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino.
3) Rossi Pietro, già prof. ord. di Filosofia della Storia nell’Università di
Torino -Via Carlo Alberto, 59 - 10123 Torino.
4) Sasso Gennaro, già prof. ord. di Filosofia teoretica nell’Università di
Roma “La Sapienza” - Via Sant’Alberto Magno, 1 - 00153 Roma.
5) Graziani Augusto, prof. ord. f.r. di Economia Politica nell’Università di
Roma “La Sapienza” - Via Ascensione, 5 - 80121 Napoli (tel. 081.418329).
6) Scarcia Amoretti Bianca Maria, già prof. ord. di Islamistica
nell’Università di Roma “La Sapienza”, Via Cameria, 3 - 00179 Roma.
7) Piacentini Fiorani Valeria, prof. ord. di Storia e istituzioni dei paesi
islamici nell’Università Cattolica di Milano, Corso Porta Romana, 108
- 20122 Milano.
SOCI CORRISPONDENTI NAZIONALI (posti 14)
1) Rascio Raffaele, già prof. ord. di Istituzioni di Diritto privato
nell’Università di Napoli - Parco Comola Ricci, 21 - 80122 Napoli (tel.
081.660632).
2) Savignano Aristide, già prof. ord. di Istituzioni di Diritto pubblico
nell’Università di Firenze - Corso Mazzini, 15 - 50132 Firenze (tel.
055.2476301).
3) Barbagallo Francesco, prof. ord. di Storia contemporanea
nell’Università di Napoli “Federico II” - Riviera di Chiaia, 207 80121 Napoli (tel. 081.408346).
4) Gaetani D’aragona Gabriele, già prof. ord. di Economia agraria
nell’Università di Napoli Parthenope - Piazza S. Maria degli Angeli, 1 80132 Napoli (tel. 081.7645732).
5) Mazzacane Aldo, prof. ord. di Storia del diritto italiano - Via Orazio,
22 - 80122 Napoli.
6) Di Costanzo Giuseppe, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Girolamo Santacroce, 25 - 80129 Napoli
(tel. 081.5563963).
204
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
7) Papuli Giovanni, già prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università di
Lecce - Via Vecchia Manifattura Tabacchi, 34 - 73100 Lecce.
8) Scocozza Antonio, prof. ord. di Lingua, cultura e istituzioni dei paesi
di lingua spagnola nell’Università di Salerno - Via Delle Filande, 24 84080 Pellezzano (SA) (tel. 089.274189).
9) Mascilli Migliorini Luigi, prof. ord. di Storia moderna nell’Università
“L’Orientale” - Via A. D’Isernia, 31 - 80122 Napoli (tel. 081.661334).
10) Russo Luigi, prof. ord. di Estetica nell’Università di Palermo - Via
Giovan Battista Lulli, 4 - 90145 Palermo.
11) Mazzetti Ernesto, prof. ord. f.r. di Geografia politica ed economica
nell’Università di Napoli “Federico II” - Piazza Donn’Anna, 9 - 80123
Napoli (tel. e fax 081.7646467).
12) Santoni Francesco, prof. ord. di Diritto del lavoro nell’Università
di Napoli “Federico II” - Riviera di Chiaia, 264 - 80121 Napoli (tel.
081.7611341).
13) Jossa Bruno, già prof. ord. di Economia politica nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via G. Pisciscelli, 77 - 80121 Napoli (tel. 081
668326).
14) Cambi Maurizio, prof. di Storia della Filosofia nell’Università di Salerno
- Via Rota, 33 - 80067 Sorrento (tel. 081-8073723).
SOCI STRANIERI
(posti 6)
1) Stein Peter, prof. ord. di Storia del Diritto romano nel Queen’s College
di Cambridge - Queen’s College, Cambridge CB3.9ET (Gran Bretagna).
2) Vovelle Michel, prof. emerito di Storia moderna nell’Università di
Paris-Sorbonne - 3 avenue Villemus, 13100 Aix en Provence (Francia).
3) Kaufmann Matthias, prof. di Etica nell’Università di Halle-WittenbergBurgerstrasse, 57 - D91054 Erlangen (Germania)
4) Sevilla Fernández José Manuel, prof. ord. di Filosofia nell’Univerisità di
Siviglia - c/ Ganado, 20, 2°A - 11500 - El Puerto de Santa Maria (Cádiz)
(spagna) (tel. 0034 666745878).
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
205
Indice
Andrea della Monica, Heidegger e l’urto del deinòn....................... pag. 5
Francesco Russo, La comune, assoluta solitudine delle cose.
Jean Genet e l’opera di Alberto Giacometti...................................... »
51
Mariafilomena Anzalone, Hegel a Norimberga:
la morale come dottrina dei doveri.................................................. »
67
Gilda Caprara, I rapporti politici luso-napoletani
tra Cinque e Seicento....................................................................... »
89
Andrea Di Miele, Antonio Gramsci: cesarismo, ideologia,
cultura unitaria................................................................................ »
113
Cristiana Boscarelli, Raniero Panzieri:
gli anni della formazione (1946-1955)............................................ »
123
Teresa Caporale, Karl Barth interprete di Ludwig Feuerbach........ »
155
Tatiana Tabacchino, Per un’interpretazione non intellettualistica
della religione primitiva: il preanimismo di Robert Ranulph Marrett...... »
179
Regist. Tribunale di Napoli n. B/2317 del 14 agosto 1954
Officine grafiche napoletane Francesco Giannini & Figli S.p.A.
Proprietà della testata: Accademia di Scienze Morali e Politiche,
via Mezzocannone, 8 - 80134 Napoli
Direttore responsabile: accademico Aldo Trione
Finito di stampare nel mese di febbraio 2011