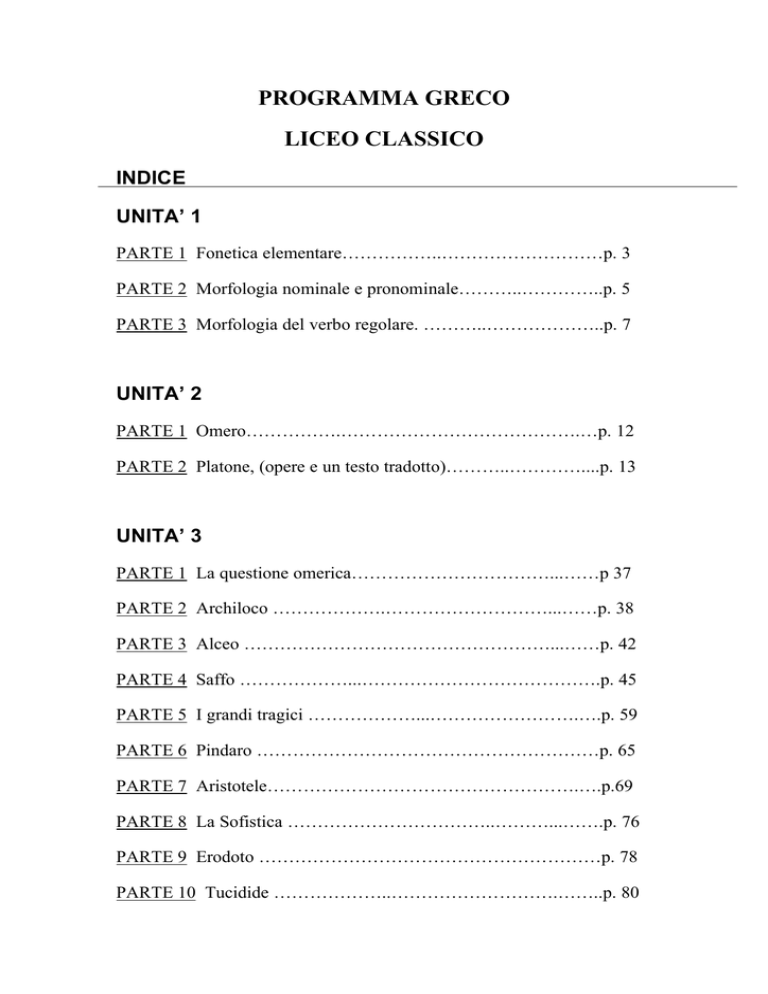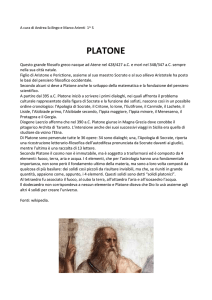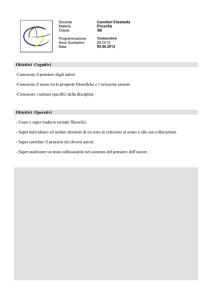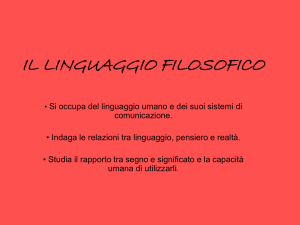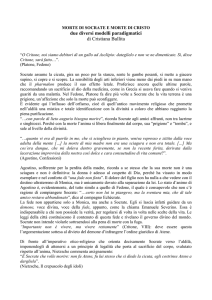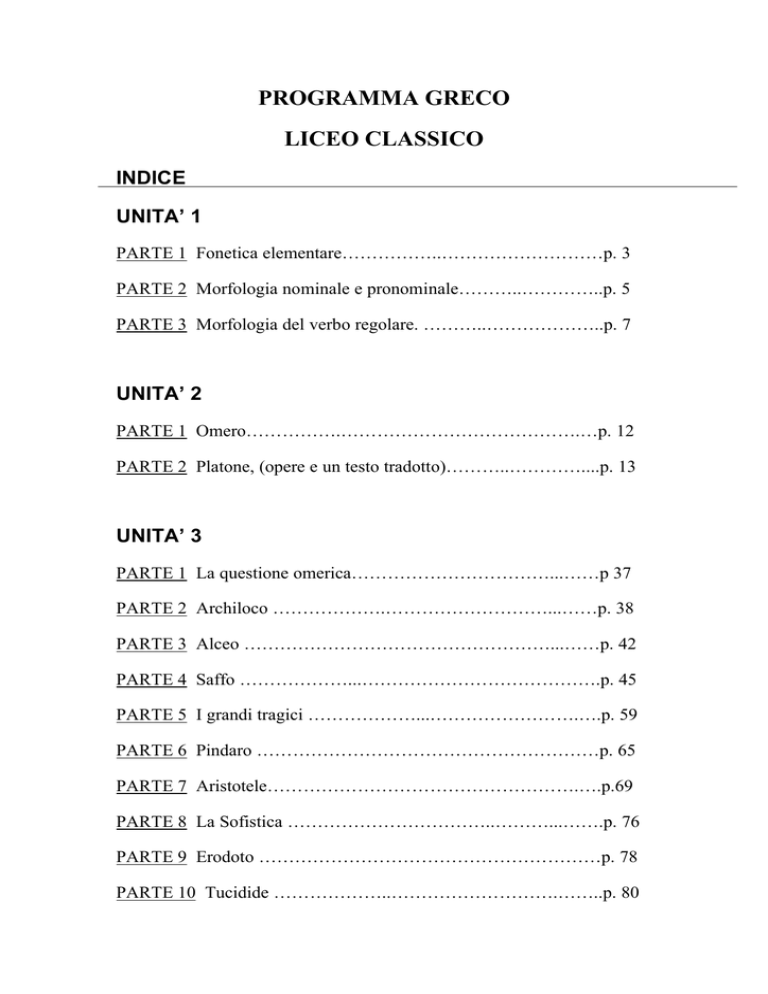
PROGRAMMA GRECO
LICEO CLASSICO
INDICE
UNITA’ 1
PARTE 1 Fonetica elementare……………..………………………p. 3
PARTE 2 Morfologia nominale e pronominale………..…………..p. 5
PARTE 3 Morfologia del verbo regolare. ………..………………..p. 7
UNITA’ 2
PARTE 1 Omero…………….………………………………….…p. 12
PARTE 2 Platone, (opere e un testo tradotto)………..…………....p. 13
UNITA’ 3
PARTE 1 La questione omerica……………………………...……p 37
PARTE 2 Archiloco ……………….………………………...……p. 38
PARTE 3 Alceo ……………………………………………...……p. 42
PARTE 4 Saffo ………………...………………………………….p. 45
PARTE 5 I grandi tragici ………………...…………………….….p. 59
PARTE 6 Pindaro …………………………………………………p. 65
PARTE 7 Aristotele…………………………………………….….p.69
PARTE 8 La Sofistica ……………………………..………...…….p. 76
PARTE 9 Erodoto …………………………………………………p. 78
PARTE 10 Tucidide ………………..……………………….……..p. 80
PARTE 11 Demostene …………………..…………………….…..p. 84
PARTE 12 Socrate ……………………..………………….…........p. 86
PARTE 13 Callimaco ………………………….…………………...p. 94
PARTE 14 Apollonio Rodio………………..…………………...….p. 98
PARTE 15 Teocrito………………...…………………………....…p. 102
PARTE 16 Menandro ……………………………………...………p. 104
PARTE 17 Polibio ……………………………….………………...p. 107
PARTE 18 Luciano ………………………….………………….…p. 110
PARTE 19 Plutarco ………………………………….…………..…p. 112
PARTE 20 ll nuovo testamento con cenni
sulla letteratura cristiana………………………..…..…p. 122
UNITA’ 1
PARTE 1 FONETICA ELEMENTARE
Regole di fonetica:
Parole atone:
Se una parola alla precedente si chiama: enclitica, se si appoggia alla
successiva invece si chiama: proclitica
Le enclitiche:
* Se la parola che precede un'enclitica Ë ossitona o perispomena (accento
acuto o circonflesso sull'ultima), l'accento non cambia e l'enclitica resta
priva d'accento.
* Se la parola che precede l'enclitica Ë parossitona: l'enclitica prende
l'accento sulla 2∞ sillaba solo se Ë bisillaba (acuto se Ë breve,
circonflesso se Ë lunga).
* Se la parola che precede l'enclitica ha l'accento acuto sulla terzultima
(proparossitona) o il circonflesso sulla penultima (properispomena) essa
prende un 2∞ accento acuto sull'ultima e l'enclitica resta privano
d'accento.
* Se si succedono due o pi˘ enclitiche: solo l'ultima non prende accento,
le altre invece hanno tutte l'accento acuto.
Le proclitiche:
* Sono parole atone e monosillabe, quando sono seguite da una o pi˘
enclitiche prendono un accento acuto.
Regole sugli accenti:
* L'accento circonflesso cade solo su vocali lunghe e dittonghi.
* L'acuto puÚ cadere solo sulle ultime 3 vocali. L'accento circonflesso
invece sulle ultime 2.
* Nel verbo l'accento Ë regressivo, cade cioË il pi˘ possibile vicino
l'inizio della parola.
* LEGGE DEL TROCHE FINALE: quando l'accento cade sull'ultima
vocale se questa Ë breve e l'ultima Ë lunga allora l'accento Ë circonflesso,
in caso contrario Ë acuto
* L'accento grave cade solo sull'ultima sillaba, sostituisce quello acuto
quando una parola Ë seguita da un'altra senza segni d'interpunzione.
Parole ossitone:
Accento acuto sull'ultima sillaba
Parole parossitone:
Accento acuto sulla penultima
Parole proparossitone:
Accento acuto sulla terzultima sillaba
Parole properispomene:
Accento circonflesso sulla penultima sillaba.
UNITA’ 1
PARTE 2 MORFOLOGIA NOMINALE E
PRONOMINALE
Come abbiamo già accennato sopra, la lingua greca è, sul piano
tipologico, una lingua flessiva e fusiva, caratteristica che eredita dalla sua
lingua madre, l'indoeuropeo. In quanto lingua flessiva, possiede un'ampia
articolazione di declinazioni nominali, che qui vedremo in sintesi.
Aspetti generali della flessione nominale e pronominale del greco
Nella flessione nominale, il greco si differenzia fortemente dal latino per
due ragioni essenziali.
Anzitutto, ha sviluppato un articolo determinativo, in tutto simile a quello
di molte lingue europee occidentali moderne, a partire da un'antica forma
di pronome dimostrativo, ὁ ἡ τό, che ancora in Omero significa "quello,
egli, ella, esso", e assume la sua funzione tipica a partire dalla fine
dell'VIII sec. a. C. Tale pronome dimostrativo - articolo è la filiazione
diretta dell'indoeuropeo *so *sā *tod, ed ha il suo omologo nel sanscrito
sa sā tad.
Il greco, come il latino e la stragrande maggioranza delle lingue
indoeuropee antiche, ha una declinazione a tre generi: maschile,
femminile e neutro.
Dal punto di vista della nozione del numero, il greco attico si differenzia
dal latino poiché possiede ancora, nel verbo e nel nome, come il
sanscrito, un duale ben differenziato, per indicare le coppie di oggetti. Il
mantenimento del duale è un tratto assai arcaico dell'attico, rispetto ad
altri dialetti greci, come lo ionico che lo perde molto per tempo, già nel
VII sec. a. C.
A differenza della lingua latina, quella greca conserva solo cinque degli
otto casi indoeuropei, e non sei. Questi casi sono:
•
•
Il nominativo, che indica il soggetto della frase, l'attributo e
l'apposizione del soggetto, il predicato nominale ed il complemento
predicativo del soggetto;
Il vocativo, indicante il complemento di vocazione;
•
•
•
L'accusativo, indicante il complemento oggetto, l'attributo e
l'apposizione e il complemento predicativo dell'oggetto; in certi
casi anche il complemento di limitazione (il cosiddetto "accusativo
alla greca");
Il genitivo, che esprime la specificazione possessiva, oggettiva etc.,
e riveste le funzioni dell'ablativo di origine e provenienza, di
estensione e di allontanamento, nonché di causa, mezzo e causa
efficiente;
Il dativo, indicante il complemento di termine, ma anche i
complementi di causa, di mezzo, di stato in luogo e di tempo
determinato.
Si sogliono definire, come anche in latino, casi diretti il nominativo, il
vocativo e l'accusativo, e casi obliqui il genitivo e il dativo.
Il greco di età classica ha ormai perduto lo strumentale, antico caso
indoeuropeo ancora vivo nel dialetto miceneo, di cui sopravvivono sparse
vestigia in Omero(cfr. ἶ-φι, ναῦ-φι...).
Sono rintracciabili, in alcuni nomi notevoli, relitti del locativo
indoeuropeo, ancora presente in altre lingue antiche, e tuttora categoria
sistematica in molte lingue slave.
In sostanza, il greco attua, rispetto all'indoeuropeo, un fortissimo
sincretismo dei casi.
UNITA’ 1
PARTE 3 MORFOLOGIA DEL VERBO REGOLARE
Il verbo greco conserva parecchi tratti arcaici del verbo indoeuropeo, ma
mostra altresì notevoli forme innovative, e in particolare, rispetto alla
lingua madre, è caratterizzato dalla generale tendenza a rendere coerente
il sistema della coniugazione verbale per tutti i tempi, le forme e i modi.
Il verbo in greco, come in ogni lingua flessiva, si modifica aggiungendo
in coda a una radice verbale una vocale tematica, un suffisso modale e/o
temporale una terminazione; talora la radice stessa è ampliata con dei
prefissi o degli infissi, per definire i vari temi temporali e le loro funzioni.
Si serve inoltre spesso dell'apofonia o gradazione vocalica per
distinguere i temi temporali fra di loro.
Qui di séguito esamineremo punto per punto i caratteri generali della
flessione verbale greca, prima di mostrarne alcuni esempi.
Coniugazioni del verbo greco
I verbi greci si dividono in due grandi coniugazioni, che si differenziano
solo e soltanto nel tema del presente:
•
•
quella tematica, che si distingue per la desinenza -ω della prima
persona singolare del presente indicativo, ed è caratterizzata dal
fatto che le desinenze del presente e dell'imperfetto sono inserite
sistematicamente su una vocale tematica, che mostra apofonia, ε ο
quella atematica, che si distingue per la desinenza -µι della prima
persona singolare del presente indicativo, ed è caratterizzata dal
fatto che le desinenze del presente si inseriscono direttamente sulla
radice verbale, la cui vocale mostra apofonia (grado allungato nel
singolare del presente indicativo, grado normale nelle altre forme).
Le due coniugazioni del greco corrispondono perfettamente alle due
coniugazioni del sanscrito. Una coniugazione atematica in tutto simile a
quella greca si rinviene anche in ittita. Il greco, nel presente e
nell'imperfetto, conserva al novanta per cento la struttura del verbo
indoeuropeo.
I verbi tematici: suddivisione in otto classi
Fanno parte della prima classe verbale tutti quei verbi che formano il
tema del presente aggiungendo direttamente la vocale tematica al tema
verbale.
Ottava Classe
Dell'Ottava Classe fanno parte i verbi politematici, cioè i sette verbi che
per la formazione di tempi diversi dal presente e dall'imperfetto utilizzano
diverse radici verbali; sono, in ordine alfabetico, αἱρέω "prendere", ἐσθίω
"mangiare", ἔρχοµαι "andare", λέγω "dire", ὁράω "vedere", τρέχω
"correre" e φέρω "portare".
αἱρέω t.v. ἑλ- > aoristo εἷλον (aumento in ει-)
ἐσθίω t.v. ἐδ-/φαγ- > futuro ἔδοµαι, aoristo ἔφαγον
ἔρχοµαι t.v. ἐλευθ-(ἐλυθ-)/ἐλθ- > futuro ἐλεύσοµαι, aoristo ἦλθον
λέγω t.v. ἐρ-(ῥη-)/ἐπ- > futuro ἐρῶ (fut. pass. ῥηθήσοµαι), aoristo εἶπον
(aoristo raddoppiato, con doppia caduta di w)
ὁράω t.v. ὀπ-/ἰδ- εἰδ- οἰδ- (apofonico) > futuro ὄψοµαι, aoristo εἶδον
τρέχω t.v. θρεχ-/δραµ(η)- > futuro δραµοῦµαι, aoristo ἔδραµον
φέρω t.v. οἰ-/ἐγκ- > futuro οἴσω, aoristo ἤνεγκον(aoristo raddoppiato)
La classificazione secondo la presenza o meno di jod nel tema del
presente
I verbi in -ω si possono dividere in due classi: verbi senza suffisso jod, e
verbi con suffisso jod.
Prima Classe
I verbi che appartengono alla prima classe possono avere o meno un
ampliamento e un raddoppiamento del presente (o entrambi).
Senza ampliamento
Per far vedere in modo chiaro come le vocali tematiche della
coniugazione si inseriscano tra le desinenze e il tema, verranno illustrate
le voci della 1° persona plurale.
•
•
•
temi in vocale e dittongo: λύ-ο-µεν; γεύ-ο-µεν.
temi in consonante muta(π β φ; κ γ χ; τ δ θ): ἀµείβ-ο-µεν, ᾄδ-ο-µεν,
πλέκ-ο-µεν
temi in nasale(µ ν) e liquida(λ ρ): ἀµύν-ο-µεν, ἐθέλ-ο-µεν.
Con ampliamento
I possibili suffissi che si possono incontrare sono: αν, ε, ισκ (σκ), ν e non
c'è una regola precisa per distinguere quali temi prendono questi suffissi.
Si possono fare degli esempi:
suffisso αν: ἀµαρτ-άν-ο-µεν.
suffisso ε: δοκ-έ-ο-µεν > δοκοῦµεν
suffisso σκ: ἱλά-σκ-ο-µαι; suffisso ισκ: στερ-ίσκ-ω
suffisso ν: τέµ-ν-ο-µεν.
•
•
•
il verbo πάσχω ha in realtà un ampliamento σκ; dal tema παθ- si
passa a *παθ-σκ-ω, nel quale la dentale θ si dissimila e passa
l'aspirazione alla velare κ(legge di Bartholomae).
i tre verbi θνήσκω, θρώσκω e µιµνήσκω si possono anche trovare
scritti: θνῄσκω, θρῴσκω, µιµνῄσκω. Questo perché possono avere
sia ampliamento σκ(primo caso) che ισκ(secondo caso).
L'ampliamento ισκ forma con le vocali lunghe η/ω dei dittonghi
impropri nei quali la ι si sottoscrive.
ci sono dei verbi che inseriscono un ulteriore ν(infisso nasale)
all'interno del tema; sono tutti apofonici: λαγχάνω(t.v. λαχ-/ληχ-),
λαµβάνω(t.v. (σ)λαβ-/ληβ-), λανθάνω(t.v. λαθ-/ληθ-),
πυνθάνοµαι(t.v. πυθ-/πευθ-), τυγχάνω(t.v. τυχ-/τευχ-) tra i più
importanti. Si noti come il ν interagisce diversamente con le
consonanti a cui è vicino.
Seconda Classe
Della seconda classe fanno parte temi verbali in consonante che
producono esiti diversi incontrandosi con il suffisso ϳ. Sono elencate di
seguito le terminazioni verbali che risultano dall'incontro delle consonanti
finali con il suffisso ϳ.
Terminazione
αιν ειν
αιρ ειρ
σσ
ζ
πτ
λλ
ιν υν (brevi)
•
•
•
•
•
Origine
φαν-j-ω > φαίνω; κτεν-j-ω > κτείνω
σπερ-j-ω > σπείρω
µαγ-j-ω > µάσσω; ἐρετ-j-ω > ἐρέσσω
κτιδ-j-ω > κτίζω; οἰµωγ-j-ω > οἰµώζω
κοπ-j-ω > κόπτω; σκαφ-j-ω > σκάπτω
θαλ-j-ω > θάλλω
κλιν-j-ω > κλίνω(ι lungo); πλυν-j-ω > πλύνω(υ lungo)
i primi due gruppi di verbi funzionano tutti allo stesso modo: il
tema in αν (o εν, αρ etc.) subisce metatesi qualitativa con il ϳ(αϳν)
che finisce per vocalizzarsi in ι.
nel greco attico i verbi in σσ si trovano assai spesso con la
terminazione ττ( es.: πράσσω > πράττω).
lo stesso gruppo σσ proviene molto di rado da una dentale, così
come è più difficile che un verbo in ζ provenga da un tema in
velare.
il verbo βλάπτω ha origine da *βλαβ-j-ω, come del resto è più
ovvio che sia(cfr. βλαβή, danno), ma si suole ritenere che la radice
vera sia βλαπ-.
i verbi che finiscono in -ίζω sono in gran parte causativi.
Precisazioni e particolarità
Molti verbi sembrano eludere le classificazioni proposte sopra, poiché
all'apparenza appartengono ad un altro gruppo piuttosto che a quello che
ci si aspetterebbe separando la desinenza dal tema. Si tratta di eccezioni e
casi particolari, che sono presenti in gran numero in qualsiasi lingua, e
sarebbe pretenzioso cercare di elencarli tutti esaustivamente; così si
ricorrerà a dare una visione generale dei vari fenomeni che possono trarre
in inganno.
Verbi con raddoppiamento
Verbi in -µι
I verbi in -µι sono divisi in due classi, le cui differenze si riscontrano nel
presente indicativo.
Prima Classe
Appartengono alla prima classe i verbi che uniscono le desinenze al tema
verbale senza alcun ampliamento; possono presentare il raddoppiamento
del presente. Es:δι-δωµι (δι raddoppiamento).
Seconda Classe
Della seconda classe fanno parte i verbi che al presente aggiungono al
tema verbale il suffisso -νυ-; -ννυ- se il tema finisce in ς Es: δεικ-νυ-µι.
I verbi tematici: suddivisione in due classi
La suddivisione dei verbi greci in classi si conduce a seconda della parte
finale del tema verbale, della presenza o meno di apofonia vocalica nel
tema verbale stesso, e della presenza (o assenza) e qualità dei suffissi
aggiunti nel tema del presente.Essa non ha fondamenti scientifici, ma
solo finalità didattiche e mnemoniche: è ritenuta molto comoda in quanto,
esaminando i meccanismi fonomorfologici di formazione del tema del
presente, offre dei paradigmi di coniugazione e soprattutto consente di
poter agevolmente ricavare il tema di un verbo partendo dal suo presente.
I verbi atematici: suddivisione in due classi
UNITA’ 2
PARTE 1 OMERO
Omero è il nome del poeta designato fin dall'Antichità come autore
dell'Iliade e dell'Odissea, antenato o più semplicemente fondatore della
gilda rapsodica degli Omeridi, a cui si riferisce Platone ne La Repubblica,
(X, 599 e - 600 b) come ad esperti con i quali si potrebbe discutere del
valore morale della paideia omerica. Il nome di Omeridi può essere
inteso sia come un gentilizio, anche se l'intera scuola non può
identificarsi con un solo genos, sia come un appellativo professionale.
Nel primo caso si tende a sostenere anche la realtà storica del poeta
Omero, nel secondo, viceversa, ad escluderla. Ignote restano le vicende
della sua vita. Ma tra i biografemi più significativi che lo riguardano, ne
ricordiamo uno, tramandato da Eraclito e da Aristotele - che rimanda al
carattere sapienziale e agonistico di ogni poesia - secondo cui Omero
sarebbe morto di dolore per non aver saputo sciogliere un enigma; e un
altro, che dobbiamo ad Isocrate, sull'ispirazione dei poemi: «Secondo gli
Omeridi, Elena apparve in sogno a Omero e gli ordinò di cantare gli eroi
della guerra troiana»: infatti l'epos omerico trae la sua origine dai più
antichi canti eroici, che consistono nella descrizione di tenzoni singolari o
aristiai. Su questa base è più facile intendere il taglio dell'Iliade, che non
finisce con la morte di Achille ma con la sua vittoria su Ettore.
Per quanto riguarda l'Iliade e l'Odissea, la maggioranza degli studiosi
ammette oggi che si tratta di opere unitarie sia dal punto di vista stilistico
che narratologico. Sull'epoca in cui sono state scritte la discussione è
aperta: secondo alcuni la loro composizione e redazione scritta sono
prossime, se non coincidenti, e vanno collocate tra il IX e l'VIII secolo;
secondo altri sono state tramandate oralmente fino al VI sec. cioè fino
alla loro pubblicazione per volontà di Pisistrato, tiranno di Atene.
L'Odissea comunque è con ogni probabilità successiva all'Iliade: segni di
un'età più recente sono la decadenza della monarchia di fronte
all'aristocrazia e l'importanza politica dell'assemblea. Per quanto riguarda
l'elemento linguistico, si può parlare di una lingua comune ai due poemi,
consistente in una mescolanza dei dialetti eolico e ionico, senza riscontro
nell'uso corrente, che dev'essere considerata, quindi come frutto di una
specifica tradizione poetica.
UNITA’ 2
PARTE 2 PLATONE
VITA
Platone nasce ad Atene nel 427 a.C. In quel periodo la città era dilaniata
dalla guerra contro Sparta e dalle incessanti lotte interne tra forze
democratiche, aristocratiche e oligarchiche. Di famiglia aristocratica,
Platone si interessa inizialmente soprattutto alla politica. L'incontro con
Socrate, nel 408, segna una svolta nella sua vita. Platone diviene suo
allievo e lo frequenta assiduamente fino al 399, anno del processo e della
condanna a morte di Socrate.
Deluso sia dal governo oligarchico dei Trenta Tiranni, sia da quello
democratico che aveva accusato il suo maestro, Platone compie numerosi
viaggi, frequenta la scuola megarica di Euclide, visita la scuola pitagorica
di Archita a Taranto e diventa amico di Dione, consigliere del tiranno di
Siracusa Dionigi I.
Nel 387 torna ad Atene e apre una scuola nei pressi del parco Academo.
Nasce così l'Accademia, istituto scientifico, scuola di formazione eticopolitica e anche associazione religiosa per il culto delle muse. Nel 367
torna a Siracusa per istruire il nuovo tiranno Dionigi II, ma fallisce così
come nel suo ultimo viaggio del 361. Platone muore nel 347, mentre
Atene era in guerra contro Filippo e si avviava verso la decadenza.
PENSIERO
Fortemente influenzato dal suo maestro, Platone continua l'indagine
socratica della verità attraverso una critica serrata delle opinioni. A
differenza di Socrate, però, Platone cerca una conoscenza universale e
necessaria. Questa ricerca lo spinge a riscoprire il pensiero di
Parmenide, che per primo aveva delineato una scienza dell'essere
assolutamente certa.
In quel periodo, la concezione parmenidea era stata fortemente mediata
dai pluralisti perché secondo loro penalizzava la conoscenza dei
fenomeni. Platone invece respinge questa mediazione e afferma
l'esistenza di due ordini di realtà e di conoscenza. Da una parte egli pone
la realtà e la conoscenza del mondo sensibile, fatta di cose, dall'altra la
realtà e la conoscenza di una dimensione situata oltre questo mondo,
costituita da idee di natura puramente intelligibile. Perché la nostra
conoscenza delle idee sia valida occorre che le idee siano realtà
universali e permanenti e non solo criteri regolativi interni all'intelletto.
Per Platone le idee sono valori verso i quali la realtà deve tendere
finalisticamente. L'universo delle idee è infatti gerarchicamente ordinato
dall'idea del bene.
È nell'Eutifrone che è possibile trovare un primo abbozzo della teoria
delle idee. In questo dialogo Platone cerca di distinguere ciò che è santo
da ciò che è empio e giunge alla conclusione che ciò che è santo deve
esserlo sempre, in ogni circostanza. Ciò che rimane identico è tale perché
ha una sua forma, una sua conoscibilità, ha cioè una sua idea. Se si vuole
conoscere ciò che è santo bisogna conoscere quel principio eidetico che
fa si che tutte le cose che sono sante siano tali. Le idee sono forme
universali su cui sono modellate le cose particolari, e quindi avere scienza
vuol dire servirsi dell'idea come di un modello intellettuale.
Questa concezione del sapere è nettamente opposta all'arte della
persuasione e della retorica promossa dai sofisti. Molti dialoghi platonici
sono infatti dedicati a smantellare alcuni precetti dei sofisti. Nel Gorgia
Platone definisce la retorica come pratica della persuasione mediante
discorsi fondati dalla credenza invece che dalla conoscenza. Nel Menone
invece, Platone dimostra che l'uomo ha in sé delle idee fin dalla nascita:
conoscere vuol dire ritrovare queste idee. Anche l'eristica, arte della
controversia finalizzata all'obiettivo di far prevalere la propria tesi giusta
o sbagliata che sia, diventa un suo bersaglio critico. Platone dedica
all'eristica l'Eutidemo, dialogo in cui si oppone nettamente al principio
che afferma l'impossibilità di cercare nell'uomo ciò che si sa o che non si
sa.
Il suo rifiuto della concezione gnoseologica dei sofisti lo spinge a
formulare la teoria della reminiscenza in cui sono presenti numerosi
riferimenti all'orfismo. Secondo la religione orfica l'anima è immortale e
rinasce più volte, conosce già sia il nostro mondo che il mondo degli
inferi. Per Platone la rinascita continua dell'anima dimostra che imparare
non è altro che ricordare. Inoltre, la ricerca della verità è una condizione
intermedia fra il pieno possesso di essa e la sua completa assenza.
Platone condanna anche la teoria di Protagora secondo cui le cose hanno
un nome per convenzione. Nel Cratilo, dialogo rivolto al linguaggio,
Platone sostiene che fra le cose e i nomi c'è una corrispondenza di natura.
Le cose hanno una loro natura che non può essere manipolata da noi.
Mettere nomi spetta solo a colui che sa, perché costruirà i vari nomi
tenendo presente la natura delle cose attraverso l'osservazione delle idee
di ogni cosa.
La dottrina platonica delle idee si sviluppa anche attraverso alcuni
dialoghi dedicati all'amore e a alla bellezza. Le idee sono il fine
dell'anima e l'anima è immortale proprio per il suo legame con le idee.
L'amore e la vita sono aspirazione al mondo soprasensibile e
all'immortalità.
L'amore descrive la condizione generale dell'uomo che tende a
conseguire il bene e la felicità di cui manca. Nel Simposio l'amore è
desiderio di bellezza e di bene, e quindi avvertimento della loro
mancanza. L'amore si presenta come qualcosa di natura intermedia, un
demone, figlio di Ingegno (abbondanza) e di Privazione (povertà).
Se la vita umana si muove tra un mondo sensibile e un mondo
intelligibile, l'amore spiega il passaggio e la tensione dall'uno all'altro.
L'amore è desiderio di possedere il bello e il bene. È intuizione
dell'esistenza del bello e del buono da parte di chi non li ha ma li
desidera.
Attraverso questo desiderio l'uomo oltrepassa i propri limiti, ascende
gradualmente la scala delle cose belle e arriva a contemplare il bello in
sé. L'ascesa amorosa ha come fine l'idea di bellezza. Il passaggio
dall'ignoranza alla scienza è delineato come l'evolversi del sentimento
d'amore per la bellezza sensibile di un corpo verso la comprensione che la
bellezza, presente in tutte le forme visibili, è unica e identica. L'amore per
la bellezza di un corpo non è che un passaggio per cogliere la bellezza
nelle
anime
e
per amare
la
bellezza
nelle
scienze.
Nel Fedro l'anima, principio di vita e di movimento, indipendente dal
corpo e immortale, è descritta come un carro guidato da due cavalli alati.
Quando prevale il cavallo bianco, che guida gli impulsi buoni e razionali,
l'anima vola nel mondo delle idee. Quando prevale il cavallo nero, che
guida le passioni sensibili e carnali, l'anima cade sulla terra ed è costretta
a reincarnarsi in altri corpi.
Secondo Platone l'anima conserva i ricordi del mondo divino anche dopo
la caduta nel corporeo e nel sensibile. La visione delle cose belle nel
mondo sensibile risveglia i ricordi delle essenze contemplate nel mondo
intelligibile e accende l'anima di un delirio divino, la forma più alta
d'amore.
Platone continua l'elaborazione della concezione di anima nel Fedone,
commovente racconto delle ultime ore di Socrate. In questo dialogo il
filosofo è descritto come colui che già in vita è sottoposto ad una sorta di
morte. La realtà sensibile è avvertita come una prigione. Il corpo è
impedimento dell'anima alla scienza. Al filosofo non resta quindi che
morire per liberare l'anima e la scienza dai vincoli corporei. Il vero
filosofo desidera morire per liberarsi dal carcere del corpo e per tornare
nel puro mondo delle idee, altrimenti raggiungibile solo con la ricerca
rigorosa e disinteressata della verità e l'esercizio della virtù.
Nella Repubblica Platone delinea una nuova concezione dello stato per
realizzare l'ideale della conoscenza universale e necessaria. Secondo
Platone lo stato si forma per soddisfare i propri bisogni con l'aiuto degli
altri, ma l'eccessiva brama di potere e il desiderio di espansione
territoriale provocano lotte continue e guerre. Occorre quindi creare un
esercito di soldati di professione per difendersi, i custodi dello stato, la
cui vita dovrà fondarsi sulla totale condivisione. È per questo motivo che
Platone ritiene indispensabile l'abrogazione di ogni possesso individuale,
abolizione che deve essere estesa anche alla famiglia. Inoltre, lo stato non
solo si occuperà dell'educazione dei figli, ma controllerà anche le unioni
sentimentali, e le donne dovranno essere educate per poter collaborare
con gli uomini in tutti gli uffici pubblici, compresa la guerra. Solo la
classe dei lavoratori è esentata dalla rinuncia alla famiglia e dall'obbligo
della formazione.
Se per Socrate era importante occuparsi soprattutto dell'anima, Platone
ritiene indispensabile non trascurare lo stato. Il superamento
dell'orientamento socratico è evidente proprio nella corrispondenza che
Platone realizza distinguendo le tre classi sociali che formano lo stato
sulla base di una teoria dell'anima composta da tre parti. La parte
concupiscibile, l'istinto, equivale alla classe dei lavoratori, uomini di
bronzo. La parte animosa, la forza emotiva, corrisponde invece ai custodi,
uomini d'argento, mentre la parte razionale, la ragione, spetta ai
governanti, uomini d'oro.
Lo stato deve essere governato da persone che racchiudono in sé filosofia
e potenza politica. Dominio politico e vera conoscenza, ispirata
dall'amore dell'idea, devono incontrarsi, e ciò accade solo con un
governo aristocratico, tutte le altre forme (timocrazia, oligarchia,
democrazia, tirannia) non sono che la degenerazione di questo modello
perfetto.
Le idee garantiscono non solo la possibilità di una conoscenza vera e
universale ma anche l'unità essenziale e permanente del molteplice e del
divenire. Attraverso il mito della caverna Platone mostra le tappe della
conoscenza umana. Secondo questo mito, gli uomini sono imprigionati
dentro una caverna, con le spalle rivolte verso la luce. Gli oggetti reali si
trovano fuori dalla caverna, ma gli uomini non si possono voltare per
guardarli direttamente. Possono solo osservare le ombre che gli oggetti
proiettano contro le pareti della caverna.
Per Platone gli esseri umani sono quindi condannati a poter cogliere
attraverso la sensazione solo le ombre delle idee. Solo pochi riescono a
uscire dalla caverna e ad accorgersi della bellezza del reale. Spetta ai
filosofi guidare gli esseri umani verso la conoscenza delle idee, mediante
lo studio della matematica e l'esercizio della dialettica che insegnano la
contemplazione del bello e del vero.
Nel Parmenide vengono affrontati i problemi relativi alla dottrina delle
idee. Le difficoltà sorgono quando si devono considerare insieme i
processi di unificazione e di divisione, perché le idee sono distinte dalle
cose (p.e. l'idea di bellezza non coincide con le cose, altrimenti
diverrebbe una e molteplice) ma allo stesso tempo somigliano ad esse
(sono infatti unificate da questa somiglianza). Per risolvere questi
problemi, Platone afferma la teoria della partecipazione: le cose
partecipano semplicemente delle idee. Il mondo dell'essere e il mondo
sensibile stanno nello stesso rapporto in cui si trovano l'uno e il
molteplice. Il molteplice non si può pensare senza riferimento all'unità, in
quanto è anch'esso costituito di unità, a sua volta l'uno è essere in quanto
unifica il molteplice sensibile e quindi è in connessione con il non essere
sensibile. Per Platone, la separazione parmenidea fra essere e non essere è
insostenibile, perché comporterebbe l'impossibilità di stabilire relazioni
conoscitive fondate. Ogni relazione conoscitiva implica diversità, cioè
non essere, indica dunque che un ente è qualcosa e insieme che non è
qualcos'altro.
Platone condanna anche la dottrina eracliteo-protagorea della conoscenza
come sensazione. Nel Teeteto sostiene infatti che la sensazione non
consente una conoscenza valida e vera basata sul mondo delle idee. È nei
dialoghi della vecchiaia che si compie il parricidio di Parmenide. Nel
Sofista Platone delinea il metodo dicotomico della dialettica e ripropone
il problema dell'esistenza del non essere. Per trovare una mediazione fra
mondo ideale dell'essere e conoscenza umana è necessario «uccidere
Parmenide». Il non essere è definito in quanto negazione relativa e non
come negazione assoluta, perché la diversità è una forma fondamentale
dell'essere stesso. Solo in questo modo si può rendere ragione del falso e
dell'errore. Escludere qualsiasi relazione fra l'essere e il non essere
significa rendere impossibile sia la conoscenza che il linguaggio.
La dialettica studia le forme dell'essere per stabilire fra di esse il rapporto
di identità e di diversità. Chiarendo quali forme della realtà si collegano e
quali si escludono, la dialettica è in grado di determinare la struttura del
reale, mostrando tutte le sue determinazioni e articolazioni. Il
procedimento della diaresi-divisione permette di determinare un genere
(nome che Platone preferisce ora a quello di idea), indicando le relazioni
di esclusione e inclusione in cui si trova con gli altri generi. Si parte
tagliando in due ogni genere (muovendo da generi diversi) fino a
raggiungere il genere da determinare, in modo tale che questo possa
essere colto in un numero sempre maggiore di relazioni.
Nel Filebo Platone ripete che i generi non devono essere intesi come
unità rigide ma in rapporto di partecipazione gli uni con gli altri. La
ricerca dei generi si muove sia nell'ambito dell'unità che nell'ambito della
molteplicità. I due generi massimi sono il finito e l'infinito.
Sempre nei dialoghi della vecchiaia troviamo il problema dell'origine
dell'universo e della formazione del mondo. Platone rifiuta la concezione
meccanicistica del mondo formulata da Democrito e delinea un discorso
sulla genesi e l'organizzazione del cosmo, correggendo il carattere
qualitativo della vecchia fisica con schemi e proporzioni matematiche che
gli conferiscono una precisa struttura qualitativa (di cui si serve per
dimostrare il fine razionale dell'universo).
L'universo è concepito come una cosa generata da un demiurgo, un
artefice divino, che opera imitando i modelli del mondo delle idee e le
proporzioni matematiche, ma non si tratta di un vero creatore perché le
cose gli preesistono.
L'intero universo (così come la citta-stato) è considerato un organismo
fornito di un'anima intelligente e di un corpo, come un grandioso essere
vivente e animato. L'anima del mondo è principio generale di vita,
mediazione fra il piano sensibile e il piano razionale-ideale della realtà,
realizzazione della compresenza di essere e divenire che caratterizza i
fenomeni.
Il finalismo del mondo è dimostrato dal suo rispondere al criterio del
meglio, di cui si fa realizzatore il demiurgo, mentre l'imperfezione del
mondo è causata dalla chora, materia sensibile sottoposta al mutamento e
alla corruzione. Il termine chora è usato per definire ciò in cui le cose si
generano, ma indica anche qualcosa di negativo, simile al non essere.
Nei dialoghi della vecchiaia è presente anche a una rielaborazione delle
affermazioni sullo stato e sulla politica. Mentre nella Repubblica Platone
analizzava lo stato come un modello ideale, fermo al di sopra
dell'esperienza umana, nel Politico lo stato si configura come una
mescolanza di cui bisogna trovare la giusta misura. L'arte della politica è
l'arte della misura, la ricerca del giusto mezzo di equilibrio fra eccesso e
difetto, ed è per questo che non bisogna dare troppa importanza a un
corpo di leggi scritte. La legge è paragonata ad un uomo autoritario e
ignorante. Eppure, nell'ultimo dialogo, rimasto incompiuto, Platone affida
proprio alle leggi il governo dello stato, rinunciando sia alla classe dei
governanti che a quella dei custodi e rivalutando la famiglia, in quanto
condizione abituale degli individui. Cambia anche il modello politico,
non più aristocratico, bensì combinazione di elementi monarchici e
principi democratici.
OPERE PRINCIPALI
Apologia di Socrate
Convito
Cratilo
Crizia
Eutidemo
Fedone
Fedro
Gorgia
Menone
Parmenide
Politico
Protagora
Repubblica
Simposio
Teeteto
Timeo
Testo tradotto: L’AUTODIFESA
[17a] Non so, o Ateniesi, che impressione (2) vi sia rimasta dei miei
accusatori; io, davvero, mi sono quasi dimenticato di me stesso, da
quanto parlavano persuasivamente. Eppure non hanno detto quasi niente
di vero. Ma mi ha stupito soprattutto una delle loro molte bugie: hanno
detto che dovevate cercare di non farvi ingannare da me, perché [17b]
sono abile (deinos) nel parlare. La cosa più vergognosa mi è sembrata
appunto il loro non aver ritegno di venir confutati da me con i fatti,
quando non apparirò per nulla abile (deinos) nel parlare - a meno che non
chiamino così chi dice la verità. In questo caso, sarei d'accordo: sono un
retore, ma non al modo in cui essi lo intendono. (3) Essi - dico - hanno
detto poco o nulla di vero, ma voi non sentirete da me null'altro che la
verità. E non userò affatto, o Ateniesi, discorsi come i loro, ben
fraseggiati [17c] nelle espressioni e nei termini, e bellamente disposti: voi
sentirete da me cose argomentate disordinatamente, con le prime parole
che mi capitano a tiro - infatti io credo che quello che dico sia vero - e
nessuno di voi si aspetti altro. Perché a questa età non starebbe bene
venire da voi facendo discorsi come un ragazzino.(4) E anzi, Ateniesi,
questo vi chiedo e vi supplico: se mi sentirete difendermi con gli stessi
discorsi che sono abituato a fare in piazza, presso i banchi dei trapeziti,(5)
dove molti di voi mi hanno udito, e altrove, [17d] non ve ne stupite e non
mormorate. Infatti così stanno le cose: sono quassù in tribunale per la
prima volta a settant'anni, e perciò sono del tutto estraneo a questo modo
di esprimersi (lexis). Perciò, come forse mi perdonereste, se fossi
veramente straniero, [18a] di parlare con la lingua e alla maniera in cui
sono stato educato, così ora vi chiedo - giustamente, mi sembra - di aver
comprensione per il mio modo di esprimermi, (6) buono o cattivo che sia,
e di considerare invece attentamente se dico o no cose giuste, perché
questa è la virtù (arete) del giudice, mentre quella dell'oratore è dire la
verità.
In ogni caso, Ateniesi, è giusto che mi difenda innanzitutto dalle prime
accuse false e dai primi accusatori, e poi dalle accuse e dagli accusatori
successivi. [18b] Infatti, molti miei accusatori sono venuti da voi in
passato senza dire nulla di vero, e raccontano il falso su di me già da
molti anni. Io ho più paura di loro che di quelli che stanno attorno ad
Anito,(7) per quanto siano anch'essi terribili. Ma gli antichi accusatori
sono più temibili, cittadini, perché vi hanno indotto a creder loro
prendendovi sotto controllo da bambini, e mi hanno accusato di più,
senza nessuna verità, dicendo: "C'è un certo Socrate, uomo sapiente, che
strologa (8) su quello che sta per aria e investiga su quello che sta
sottoterra, e che fa del discorso più debole il più forte" [18c] Questi, che
diffusero su di me una fama simile, sono i miei accusatori terribili,
cittadini ateniesi, perché il loro uditorio ritiene che chi fa simili ricerche
non creda negli dei. Inoltre, questi accusatori sono molti e mi accusano
già da molto tempo; per di più, hanno parlato con voi a quell'età in cui si
è più fiduciosi, quando alcuni di voi erano ragazzi e altri bambini, e mi
hanno portato in giudizio in contumacia, senza nessuno che mi
difendesse. Ma la cosa più assurda è che [18d] non si sappiano né si
dicano i loro nomi, a meno che a qualcuno non capiti di essere un poeta
comico. Quelli che vi hanno persuaso, attaccandomi con l'invidia e la
calunnia - e quelli che, una volta persuasi essi stessi, hanno persuaso altri
- sono tutti avversari intrattabili: infatti non è possibile far comparire qui
nessuno di loro per confutarlo, ma sono costretto a difendermi
semplicemente come se stessi combattendo con l'ombra, (9) e a
controinterrogare senza nessuno a rispondere. Considerate dunque la
duplicità dei miei accusatori: gli uni sono quelli che mi accusano ora, e
gli altri [18e] sono quelli che, come dicevo, lo hanno fatto in passato. E'
opportuno che mi difenda prima da questi ultimi, perché li udiste
accusarmi prima e molto più degli accusatori recenti.
Bene. Allora tocca difendersi, o cittadini ateniesi, e tentare di [19a]
sradicare da voi, in così poco tempo, una calunnia così antica. Mi auguro
che così sia, se è qualcosa di buono per me e per voi, e che riesca a
difendermi. Ma io stesso penso che sia difficile e non me lo nascondo.
Tuttavia, vada come a dio piace: c'è da obbedire alla legge e difendersi.
Riconsideriamo dunque dal principio quale sia l'accusa da cui [19b] è
derivata la calunnia, prestando fede alla quale Meleto ha intrapreso la sua
azione giudiziaria contro di me. Ebbene: dicendo che cosa mi hanno
diffamato i diffamatori? Bisogna leggere la loro deposizione come se
fosse una denuncia vera e propria. "Socrate è un criminale e un
perditempo, che indaga su quello che sta in cielo e sottoterra, fa del
discorso più debole il più forte, [19c] e insegna lo stesso agli altri." Si
tratta di qualcosa del genere. Anche voi vedevate nella commedia di
Aristofane un Socrate che, andando in giro per la scena, afferma di
camminare in aria e dice molte altre sciocchezze, di cui io non so né tanto
né poco. (10) E non lo dico per disprezzare una simile scienza, se c'è
qualcuno che ne è esperto - non vorrei che Meleto mi accusasse anche di
questo - ma io, Ateniesi, non ci ho niente a che fare. [19d] Su questo,
presento come testimone la gran parte di voi, e chiedo a tutti quelli che
una volta mi hanno ascoltato discutere - e ce ne sono tanti fra voi - di
mostrarvi e di indicarvi reciprocamente. Indicate dunque se c'è qualcuno
fra voi che mi sentì mai disputare, tanto o poco, su cose del genere. E
verrete a sapere che è così anche per il resto di ciò che i più dicono di me.
Ma niente di ciò è vero, e se avete sentito dire da qualcuno che io educo
la gente e [19e] faccio soldi, è falso anche questo. Anche a me, certo,
sembra bello se qualcuno sa educare gli uomini, come fa Gorgia di
Leontini, Prodico di Ceo e Ippia di Elide. Ciascuno di loro, Ateniesi, è in
grado di andare in ogni città e convincere i giovani - i quali potrebbero
anche, gratuitamente, stare insieme ai loro concittadini preferiti (11) [20a] ad abbandonare la comunità (synousia) di questi ultimi, a
frequentare loro a pagamento e ad essere pure grati. E c'è un altro esperto,
uno di Paro, che venni a sapere essere in città: infatti mi imbattei in Callia
figlio d'Ipponico, (12) un uomo che ha pagato ai sofisti più soldi di tutti
gli altri insieme, e gli chiesi - egli ha due figli -:
- Callia, se i tuoi due figli fossero un paio di puledri o di vitelli,
dovremmo prendere uno che li governi e stipendiarlo perché [20a]
sviluppi in loro l'eccellenza (arete) appropriata, cioè un esperto di cavalli
o di agricoltura. Ma, dal momento che sono uomini, chi hai in mente di
assumere? Uno che ha conoscenza della virtù (arete) umana e politica?
Penso, infatti, che tu ci abbia riflettuto sopra, dato che i figli sono tuoi.
C'è
qualcuno
di
questo
genere
o
no?
Certamente
disse
lui.
- Chi è? - dissi io - E di che paese è? E a quanto insegna? - E' Eveno di Paro - rispose - e si fa pagare cinque mine. Beato Eveno - mi congratulai io - [20c] se ha veramente quest'arte
(techne) e la insegna ad un prezzo così ragionevole. Anch'io, in ogni caso,
sarei fiero e vanitoso se sapessi insegnarla. Ma non ne sono capace,
Ateniesi.
(13)
Ora
qualcuno
di
voi
potrebbe
ribattere:
- Socrate, ma come la mettiamo? Da dove sono venute fuori queste
calunnie contro di te? Non avresti una reputazione di questo genere senza
immischiarti in niente di diverso degli altri, a meno che tu non faccia,
appunto, qualcosa d'altro. Dicci [20d] come stanno le cose, perché non
vogliamo
esprimere
giudizi
improvvisati
su
di
te.
Questa - mi sembra - è una obiezione giusta. Tenterò di mostrarvi le
cause della mia fama e della mia diffamazione. E perciò ascoltatemi. Ad
alcuni di voi sembrerà che io scherzi, ma - non dimenticatelo - dirò tutta
la verità. E' vero, cittadini ateniesi, io ho questa fama solo per una certa
mia sapienza (sophia). Ma che tipo di sapienza? Quella che è, forse,
sapienza umana. Oso dire, infatti, di essere esperto di questa sapienza.
Invece quelli [20e] di cui parlavo poco fa possono ben essere esperti di
una sapienza più che umana, su cui non ho nulla da dire, perché io stesso
non ne so nulla, e chi afferma il contrario mente e parla per diffamarmi.
Per favore, cittadini ateniesi, non interrompetemi, anche se quanto dico vi
apparirà presuntuoso, perché il discorso che vi riferirò non è mio, ma di
qualcuno ai vostri occhi più degno. Sulla mia sapienza - se di un qualche
genere di sapienza si tratta - presenterò come testimone il dio di Delfi.
Avete avuto modo di conoscere Cherefonte. [21a] Fu mio compagno fin
da giovane, e fu compagno vostro - del popolo - e condivise con voi
l'esilio e il ritorno. Sapete dunque com'era Cherefonte, così impulsivo in
tutto quello cui metteva mano. Bene, una volta si recò a Delfi e si permise
di interrogare l'oracolo su questo - non schiamazzate su ciò che dico,
cittadini - perché gli chiese se ci fosse qualcuno più sapiente di me. E la
Pizia rispose che nessuno era più sapiente. (14) Di questo vi darà
testimonianza suo fratello, dal momento che Cherefonte è morto.
[21b] E considerate perché vi dico questo: sto per spiegarvi da dove è
nata la calunnia contro di me. Io infatti, udito il responso dell'oracolo,
feci questa riflessione: "Che cosa vuol dire il dio? Che cosa nasconde il
suo parlare enigmatico? (15) Sono consapevole di non essere affatto
sapiente: che cosa intende, allora, dichiarando che sono il più sapiente?
Egli certo non mente, perché non può." Rimasi per molto tempo in
dubbio su quanto detto dal dio. Poi, con riluttanza, mi volsi a una ricerca
di questo genere: mi recai da qualcuno di quelli ritenuti sapienti, per [21c]
confutare l'oracolo (16) e dimostrargli proprio lì "Questo è più sapiente di
me, mentre tu dicevi che il più sapiente ero io." Esaminandolo con cura e
discutendo con lui - non occorre far nomi, ma colui dal quale ebbi questa
impressione, cittadini ateniesi, era un uomo politico - mi sembrò che
quest'uomo apparisse sapiente a molti altri e soprattutto a se stesso, ma
non lo fosse. Perciò cercai di dimostrargli che si riteneva sapiente, ma
non lo era. [21d] E così diventai odioso a lui e a molti dei presenti. Ma,
andandomene, pensai fra me e me: "Sono più sapiente di questa persona:
forse nessuno dei due sa nulla di buono, ma lui pensa di sapere qualcosa
senza sapere nulla, mentre io non credo di sapere anche se non so.
Almeno per questo piccolo particolare, comunque sia, sembro più
sapiente di lui: non credo di sapere quello che non so." Mi recai poi da un
altro di quelli che passavano per sapienti e [21e] ne ebbi la stessa
impressione, e divenni odioso a lui e a molti altri.
E continuai ad andare dall'uno all'altro: mi rendevo conto, con amarezza e
timore, di essere odioso, ma mi sembrava necessario trattare ciò che
concerne il dio come cosa della massima importanza. Per questo era
doveroso recarsi, per esaminare il senso dell'oracolo, proprio da tutti
[22a] quelli che sembravano sapienti. E per il cane, Ateniesi, - bisogna
che vi dica la verità - la mia esperienza fu davvero questa: a me, che
indagavo per il dio, (17) coloro che godevano di una migliore reputazione
sembrarono quasi i più carenti, mentre quelli che passavano per inferiori
risultarono uomini più dotati di discernimento. Occorre, allora, che vi
esponga la mia peregrinazione, cioè la storia delle fatiche che ho
affrontato per corroborare l'oracolo. Dopo essere stato dai politici, mi
rivolsi ai poeti, ai compositori di tragedie, [22b] di ditirambi e di altri
generi, per cogliermi sul fatto come più ignorante di loro. E prendendo in
mano i lavori che mi sembravano meglio composti, andavo chiedendo ai
loro autori che cosa volessero dire, anche per imparare qualcosa.
Cittadini, mi vergogno a dirvi la verità, ma lo si deve pur fare: sulle loro
composizioni quasi tutti i presenti ragionavano meglio di loro. Così, di
nuovo, mi resi subito conto che i poeti non fanno ciò che fanno per
sapienza, [22c] ma per una qualche disposizione naturale (physei) e come
divinamente ispirati (enthousiazontes), alla maniera dei profeti e dei
veggenti: anch'essi, infatti, dicono molte cose belle, ma non sanno nulla
di ciò che dicono. (18) Anche i poeti - mi divenne chiaro - sono soggetti a
una esperienza simile; nello stesso tempo mi accorsi che essi pensavano,
per la loro poesia, di essere i più sapienti degli uomini anche sul resto,
ove non lo erano. Così me ne andai anche da là ritenendomi superiore a
loro proprio come lo ero nei confronti degli uomini politici.
Per finire, andai dagli artigiani (cheirotechnes): (19) [22d] io stesso,
infatti, ero consapevole di non sapere quasi nulla, ma avevo avuto modo
di apprendere che li avrei trovati esperti in molte cose belle. E in questo
non mi ero ingannato, perché essi sapevano cose che io non sapevo e così
erano più sapienti di me. Tuttavia, cittadini ateniesi, mi sembrò che anche
gli artigiani bravi incorressero nello stesso errore dei poeti: ciascuno di
loro, dal momento che lavorava bene nell'ambito della sua arte (techne),
si stimava molto esperto anche in altre importantissime questioni e questa
stonatura tendeva a nascondere la loro sapienza. [22e] Allora interrogai
me stesso, per conto dell'oracolo, chiedendomi se preferissi essere come
sono io, né sapiente alla loro maniera, né ignorante al loro modo, oppure
come sono loro. E risposi a me stesso e all'oracolo che mi andava bene
essere come sono.
Da questa indagine, cittadini ateniesi, [23a] mi sono derivate molte
inimicizie, tanto aspre e violente da dare origine a numerose calunnie e
alla mia fama di sapiente. Infatti i presenti pensano ogni volta che io sia
esperto di quello su cui ho confutato un altro. Ma potrebbe darsi,
cittadini, che il dio sia effettivamente sapiente e che in questo oracolo
voglia dire che la sapienza umana vale poco o nulla; (20) è evidente che
questi menziona Socrate e [23b] ha dato il suo responso col mio nome,
prendendo me come esempio, come per dire: "Uomini, il più sapiente fra
voi è chi, come Socrate, ha riconosciuto che in verità non è di nessun
valore, per quanto concerne la sapienza." In ogni caso, anche ora,
andandomene in giro, cerco ed esamino secondo l'ordine del dio
chiunque, cittadino o forestiero, io creda sapiente; e ogni volta che non
mi appare tale, vengo in aiuto al dio e dimostro che non lo è. E a causa di
questa occupazione non ho avuto tempo di fare nulla di notevole né negli
affari della città, né in quelli di casa, ma, [23c] per il servizio al dio, sono
infinitamente povero.
Inoltre, i giovani che hanno più tempo libero, cioè i figli dei più ricchi, mi
frequentano per loro scelta, si divertono a sentirmi mettere alla prova le
persone, e spesso mi imitano essi stessi e tentano di esaminarne altre.
Così trovano - credo - una grande abbondanza di persone che sono
convinte di sapere qualcosa ma sanno poco o nulla. E quelli che essi
mettono alla prova si arrabbiano con me, invece che con se stessi, [23d] e
dicono che un certo Socrate è oltremodo abominevole e corrompe i
giovani. E se qualcuno chiede loro "facendo o insegnando che cosa?",
non sanno che dire e per non apparire in imbarazzo, dicono tutto quello
che hanno sottomano contro chi fa filosofia: insegna "ciò che sta per aria
e ciò che è sottoterra", a "non credere negli dei" e a "fare del discorso più
debole il più forte". Perché la verità - venire scoperti come persone che
fanno finta di sapere ma non sanno - non gli piacerebbe dirla. Ed essendo
- penso - ambiziosi, [23e] violenti e numerosi e parlando di me in
maniera concertata e persuasiva, vi hanno riempito gli orecchi di robuste
calunnie. Su questa base mi hanno attaccato Meleto, Anito e Licone:
Meleto irritato per i poeti, Anito per gli artigiani e [24a] gli uomini
politici, Licone per i retori. Così, come dicevo in principio, mi stupirei se
riuscissi a sradicare da voi, in così poco tempo, un pregiudizio divenuto
così grande. Questa è la verità, cittadini ateniesi, e vi parlo senza
nascondervi nulla, grande o piccolo che sia, e senza riserve. E so piuttosto
bene che in questo modo mi rendo odioso - ma ciò è anche prova che dico
la verità, che la calunnia contro di me è questa e queste ne [24b] sono le
cause. E se le cercherete, ora o in futuro, vedrete da voi che è così.
Su quanto dicevano contro di me i primi accusatori, basti, davanti a voi,
questa autodifesa. Ora tenterò di difendermi davanti a Meleto, l'uomo
perbene, il patriota, come dice di essere, e dagli accusatori più recenti.
Riprendiamo dunque ancora il loro atto d'accusa, come se essi fossero
altri accusatori.
L'atto di accusa è pressappoco così: Socrate - dice - è un criminale perché
corrompe i giovani e non crede [24c] negli dei in cui crede la città, ma ma
in altre entità divine di nuovo conio. (21) Questa dunque è l'accusa:
esaminiamola punto per punto. Dice che sono colpevole perché corrompo
i giovani. Ma io dico, cittadini ateniesi, che è Meleto a commettere
ingiustizia, perché fa lo spiritoso sulle cose serie, e con leggerezza porta
in giudizio le persone, fingendo di preoccuparsi e darsi pena di faccende
di cui non s'è mai curato per niente. Le cose stanno così, e cercherò di
dimostrarlo anche a voi. Vieni qui, Meleto, e dimmi: non consideri [24d]
della massima importanza che i giovani siano quanto possibile migliori?
Io
sì.
- Dillo allora a queste persone: chi li rende migliori? Evidentemente lo
sai, visto che ti interessa tanto. Hai trovato chi li corrompe, me, come tu
dici, e per questo mi conduci davanti a questi giudici e mi accusi. Su, di'
dunque chi li rende migliori, rivelagli chi è. Lo vedi, Meleto, che stai zitto
e non sai che dire? Non ti sembra vergognoso? Non ti sembra un prova
sufficiente di quello che dico io, e cioè che dei giovani non te n'è mai
importato nulla? Ma dimmi, caro, chi li rende migliori?
- I costumi e le leggi (oi nomoi). –
- [24e] Ma non ti chiedo questo, mio caro amico, bensì quale persona,
chi, (22) in primo luogo, conosce, appunto, i costumi e le leggi? –
- Loro, Socrate, i giudici. –
- Come dici, Meleto? Che sono capaci di educare i giovani e di renderli
migliori? –
- Certamente. - Proprio tutti, oppure alcuni sì e altri no? - Proprio tutti. - Ben detto, per Hera! C'è tanta gente ad aiutarli! Ma allora questi che ci
stanno ad ascoltare li rendono migliori, [25a] o no? - Si', anche questi. - Ed anche i membri della Bulé?
- Anche loro. - Ma, Meleto, non sono i componenti dell'ecclesia, (23) a corrompere i
più giovani? Oppure anch'essi, tutti insieme, li rendono migliori?
- Anch'essi. - Ma allora. a quanto pare, tutti gli Ateniesi li rendono migliori, tranne
me. Sono soltanto io a corromperli. E' così che dici? - Affermo proprio questo, con forza. - Mi hai condannato a una gran disgrazia davvero. Ma rispondimi: ti
sembra così nel caso dei cavalli, che [25b] a migliorarli siano tutti gli
uomini, e uno solo a rovinarli? Oppure, al contrario, a saperli migliorare
sono uno solo o pochissimi - gli esperti di ippica - mentre la
maggioranza, se ha a che fare con i cavalli e li usa, li danneggia? Non è
così, Meleto, per i cavalli e tutti gli altri animali? Certamente è così, lo
diciate o no tu e Anito. Perché, per quanto riguarda i giovani, sarebbe
davvero una bella fortuna che uno solo li corrompesse e tutti gli altri
[25c] fossero loro d'aiuto. No, Meleto, è abbastanza evidente che ai
giovani non hai mai pensato e la tua negligenza si mostra chiaramente:
non ti è mai importato nulla di quello per cui mi porti in giudizio.
Dimmi ancora, Meleto, per Zeus, è meglio vivere fra cittadini buoni o
cattivi? Rispondi, amico, non ti sto chiedendo nulla di difficile! I cattivi
non fanno forse del male a chi gli sta sempre vicino, mentre i buoni del
bene? - Senza dubbio. - [25d] C'è dunque qualcuno che voglia essere danneggiato dalle persone
con cui sta assieme, piuttosto che trarne vantaggio? Rispondi, mio caro
amico: anche la legge te lo impone. C'è qualcuno che vuole essere
danneggiato? - No di certo. - Su, allora: mi porti qui in tribunale in quanto corrompo i giovani e li
rendo più cattivi volontariamente o involontariamente? - Volontariamente. - E allora, Meleto? Alla tua età sei tanto più sapiente di me alla mia, da
aver riconosciuto che i cattivi fanno sempre del male a chi sta loro più
vicino, [25e] mentre i buoni del bene. Io, invece, sarei stato tanto
ignorante da non rendermi conto che se rendessi malvagio chi sta con me,
rischierei di ricevere del male da lui: tu dici che farei una simile cattiva
azione volontariamente? Meleto, io non ci credo, e penso che non ci
creda nessun'altro. Piuttosto, o non corrompo i giovani, o, se li corrompo,
[26a] lo faccio senza volerlo, e dunque tu menti in entrambi i casi. Se li
corrompo involontariamente, non è d'uso fare causa per simili errori, (24)
bensì prendere da parte chi sbaglia, per spiegargli perché e ammonirlo. E'
chiaro, infatti, che una volta resomi conto dell'errore, smetterò di fare ciò
che in ogni caso compio involontariamente. Ma tu hai evitato di stare con
me e di darmi insegnamento e non ne hai avuto voglia, e mi porti qui in
tribunale, dove si usa condurre chi ha bisogno di essere punito ma non chi
ha bisogno di imparare.
Ma quello che dicevo è ormai chiaro, Ateniesi: [26b] di queste cose a
Meleto non è mai importato né tanto né poco. Tuttavia, Meleto, dicci: in
che modo secondo te corrompo i più giovani? Oppure è evidente che,
secondo l'accusa che hai scritto, li corrompo insegnando loro a non
credere negli dei in cui crede la città, ma in altre e nuove divinità
demoniche? Non dici che corrompo insegnando? - Dico proprio questo, decisamente. - Allora. Meleto, per questi stessi dei di cui stiamo discutendo, dillo
ancora più chiaramente a me [26c] e a questi cittadini. Perché non riesco
a capire se tu dici che insegno a credere che ci sono degli dei - e io stesso
perciò credo che ci sono dei e non sono affatto ateo, né colpevole di
questo - i quali però non sono certo quelli della città, bensì altri, e per
questo mi citi in giudizio, oppure se sostieni che io non credo
assolutamente agli dei e insegno agli altri a fare altrettanto. - Dico che tu non credi assolutamente negli dei. - Stupefacente Meleto, perché dici questo? Dunque non credo, come le
altre persone, che il sole e la luna siano dei? - No, giudici, per Zeus, dato che dice che il sole è pietra e la luna terra! - Caro Meleto, credi di accusare Anassagora? Stimi così poco i giudici e
li credi così poco familiari con la scrittura, da non sapere che di questi
discorsi sono pieni i libri di Anassagora di Clazomene? Allora i giovani
imparano da me cose che si possono [26e] avere nell'orchestra (25) per
una dracma, talvolta, a dir tanto, così da mettere Socrate in ridicolo, se fa
finta che siano sue perché sono strane in un modo o nell'altro? Ma per
Zeus, ti sembro così? Non credo in nessun dio? - Assolutamente no, per Zeus! - Meleto, non sei credibile neppure a te stesso, mi pare. Perché a me
sembra, cittadini Ateniesi, che egli sia assolutamente presuntuoso ed
avventato, e che mi abbia accusato semplicemente per un qualche genere
di insolenza e per avventatezza giovanile, [27a] come per mettermi alla
prova con un enigma: "Socrate il sapiente si accorgerà che io parlo per
scherzo e contraddittoriamente, oppure riuscirò ad ingannare lui e tutti gli
altri ascoltatori?" Perché mi sembra che nell'accusa si contraddica, come
se dicesse: "Socrate è un criminale perché non crede negli dei, ma crede
negli dei." E questo è veramente da giocherellone.
Guardate con me, cittadini, in che modo mi sembra dire questo; e tu,
Meleto, rispondici. Voi, [27b] come vi avevo pregato all'inizio,
ricordatevi di non fare chiasso se argomento alla mia consueta maniera.
- Meleto, c'è qualche persona che crede che ci siano realtà umane, ma non
crede negli uomini? Lasciatelo rispondere, cittadini, e non schiamazzate
per una parte o per l'altra. C'è qualcuno che non crede nei cavalli, ma in
realtà ippiche? C'è qualcuno che non crede nei flautisti, ma in realtà
flautistiche? Non c'è, mio carissimo amico. E se tu non vuoi rispondermi,
lo dico io, a te e tutti gli altri presenti. Ma rispondi almeno a questo: [27c]
c'è qualcuno che crede che ci siano realtà pertinenti a divinità demoniche,
ma non crede nelle divinità demoniche? (26) - Non c'è. - Com'è utile che ti sia dato pena di rispondere, costretto dai giudici!
Dunque tu dici che io credo in realtà pertinenti le divinità demoniche nuove o vecchie che siano - e insegno in conformità a questa
convinzione: ma allora, in ogni caso, io credo davvero, secondo il tuo
discorso, in realtà pertinenti le divinità demoniche. Del resto, lo hai anche
giurato solennemente nella tua denuncia. Ma se credo in realtà
demoniche, devo certo credere necessariamente anche in divinità
demoniche, non è vero? E' così: suppongo che tu sia d'accordo, dal
momento che non rispondi. [27d] E queste divinità demoniche
(daimones) non li riteniamo forse dei o figli di dei? Sì o no? - Certamente. - Allora se io credo in delle divinità demoniche, come tu dici, e se queste
sono dei, può darsi, come sostengo io, che tu ci stia prendendo in giro con
un indovinello, dicendo prima che non credo negli dei, poi ancora che ci
credo, e poi che credo, in effetti, in demoni. Ma se questi demoni
(daimones) sono, come si dice, una specie di figli bastardi di dei e di
ninfe o di altre creature, chi potrebbe pensare che ci siano figli di dei, ma
non dei? [27e] Sarebbe tanto bizzarro quanto credere che ci siano figli di
cavalli e di asini, cioè muli, senza però credere che esistano cavalli ed
asini. No, Meleto, non può essere che tu abbia scritto questa accusa
altrimenti che per metterci alla prova, o perché non sapevi di quale vera
colpa accusarmi. Ma non c'è modo, così, di persuadere qualcuno, anche di
modesto intelletto, che alla stessa persona sia possibile credere che ci
siano cose demoniche e divine [28a] ma non demoni, dei ed eroi.
E davvero, cittadini ateniesi, mi sembra che per provare che non sono
colpevole secondo l'accusa di Meleto non occorra una grande autodifesa,
ma questa basti; e tenete ben presente che è vero anche quanto dicevo
prima, e cioè che è sorto nei miei confronti un odio grande e diffuso. Ed è
questo che causa la mia condanna: non Meleto, né Anito, ma il
pregiudizio e la gelosia dei più. [28b] Questo ha condannato molti altri
uomini buoni, e altri ancora - credo - ne condannerà; non c'è da temere
che io sia l'ultimo.
Ma forse qualcuno potrebbe dire:
- Socrate, non ti vergogni di esserti dedicato ad una attività per la quale
sei ora esposto al rischio di morire? Io avrei ragione di ribattere:
- Ragazzo, non ragioni correttamente, se pensi che un uomo, anche di
valore modesto, debba tener conto di essere vivo o morto, e non debba
invece considerare, quando agisce, solo questo: se agisce giustamente o
ingiustamente e se le sue opere sono da uomo buono o cattivo. [28c]
Infatti, a tuo dire, sarebbero dei mediocri tutti i semidei che hanno
concluso la loro vita a Troia, fra cui il figlio di Tetide, che preferì
affrontare il pericolo piuttosto che la vergogna. Tanto che, quando la
madre, che era una dea, disse a lui, ansioso di uccidere Ettore, qualcosa credo - di simile a questo:
Figlio, se vendicherai l'uccisione di Patroclo, il compagno, e
ucciderai Ettore, tu stesso morirai
perché subito dopo è per te preparato il suo destino funesto.
[cfr. Hom. Il. 18.96.]
egli, sentite queste parole, si curò poco della morte e del pericolo, [28d]
perché temeva molto più una vita da vile, senza vendicare l'amico, e
rispose:
Che possa morire immediatamente, dopo aver fatto pagare al
colpevole il fio,
per non rimanere ridicolo qui, presso le navi ricurve, peso
alla terra.
[cfr. Hom. Il. 18.98-104.]
Pensi che lui si sia preoccupato della morte e del pericolo? - (27)
Perché in verità è così, cittadini ateniesi: dove uno si sia schierato da sé,
perché lo riteneva il posto migliore, o dove sia stato messo da un
comandante, lì si deve - secondo me - avere il coraggio di restare, senza
curarsi né della morte né di altro di fronte alla vergogna. Cittadini [28e]
ateniesi, quando i comandanti che voi sceglieste per me mi schierarono in
battaglia a Potidea, ad Anfipoli e a Delio, rimasi dove mi avevano
disposto, come qualsiasi altro, e rischiavo di morire. Farei dunque una
azione terribile se, quando invece a schierarmi è il dio, come io ho
supposto e inteso, con l'ordine di vivere facendo filosofia ed esaminando
me stesso e gli altri, (28) avessi paura della morte [29a] o di qualunque
altra cosa e abbandonassi il mio posto. Sarebbe una cosa terribile, e mi si
potrebbe certo portare in tribunale giustamente, con l'accusa di non
credere che gli dei esistano, perché disubbidisco all'oracolo, ho paura
della morte e penso di essere sapiente senza esserlo. Infatti, cittadini, aver
paura della morte non è nient'altro che sembrare sapiente senza esserlo,
cioè credere di sapere quello che non si sa. Perché nessuno sa se per
l'uomo la morte non sia per caso il più grande dei beni, eppure la temono
come se sapessero bene [29b] che è il più grande dei mali. E credere di
sapere quello che non si sa non è veramente la più vergognosa forma di
ignoranza? Io, cittadini, sono diverso dalla maggior parte degli uomini
forse anche per questo, e se dovessi dichiarare che sono più sapiente di
qualcuno in qualcosa, direi che lo sono perché, non sapendo abbastanza
di quanto avviene nell'Ade, non penso neppure di conoscerlo. Però una
cosa la so: agire ingiustamente e disubbidire a chi è migliore di noi, uomo
o dio che sia, è cattivo e vergognoso. Di fronte a mali che so essere tali io
non mi spaventerò né fuggirò mai quello che non so se sia, per caso,
bene. Perciò, (29) [29c] anche se mi assolvete, senza credere ad Anito,
che affermava che o non dovevo assolutamente essere fatto comparire in
tribunale, o, una volta convenuto, non si poteva fare a meno di
condannarmi a morte, perché se verrò lasciato andare i vostri figli
metteranno in pratica quello che Socrate insegna e saranno tutti
totalmente
corrotti
se
voi
per
questo
mi
diceste:
- Socrate, per questa volta non daremo retta ad Anito, e ti assolviamo, ma
a questa condizione: che tu non sprechi più tempo in questa ricerca e non
faccia più filosofia; se [29d] verrai colto a farla, morirai. Se davvero voi mi assolveste alla condizione che ho detto, vi risponderei:
- Cittadini ateniesi, io vi amo e vi rispetto, ma ubbidirò al dio piuttosto
che a voi, (30) e finché avrò respiro e sarò in grado di farlo, non smetterò
di fare filosofia, di consigliarvi e di insegnare a chiunque incontri di voi,
dicendo, come sono solito: "O ottimo uomo, tu che sei Ateniese, della
città più grande e famosa per sapienza e forza, non ti vergogni di
preoccuparti dei soldi, per averne più che puoi, [29e] della reputazione e
dell'onore, senza però curarti e darti pensiero della saggezza, della verità
e dell'anima, perché sia la migliore possibile?" E se qualcuno di voi mi
contesta, affermando di prendersene cura, non lo lascerò subito andare né
me ne andrò io, ma lo interrogherò, lo esaminerò e lo confuterò, e se mi
sembrerà che non abbia virtù [30a] se non a parole, lo riprovererò perché
disprezza quello che vale di più e apprezza quello che vale di meno. Farò
questo a chiunque incontri, giovane e vecchio, forestiero e cittadino, ma
soprattutto ai cittadini, in quanto mi siete più vicini per nascita. Perché
questo è quello che mi ordina il dio - tenetelo presente - e io penso che
alla città finora non sia accaduto nessun bene più grande del mio servizio
al dio. Infatti io me ne vado in giro senza fare altro se non persuadervi,
giovani e vecchi, a non preoccuparvi né del corpo [30b] né dei soldi più
che dell'anima, perché sia quanto migliore possibile, dicendo:
"L'eccellenza (arete) non deriva dalla ricchezza, ma dalla virtù (arete)
provengono la ricchezza e tutti gli altri beni per gli uomini, sia sia come
privati sia in quanto comunità." E se dicendo questo corrompo i giovani,
consideratelo pure dannoso: ma se qualcuno afferma che dico cose
diverse da queste, dice il falso. E perciò dichiarerò: "Cittadini ateniesi,
siate o no convinti da Anito e mi assolviate o no, [30c] non mi
comporterò altrimenti, neppure se dovessi più volte morire." Non schiamazzate, cittadini ateniesi, ma continuate a comportarvi come
vi ho chiesto, ascoltandomi senza far chiasso su quello che dico, anche
perché - credo - ne trarrete beneficio. Infatti sto per aggiungere
qualcos'altro che forse vi farà schiamazzare; ma statevene zitti. Tenete
presente che se mi condannate a morte, perché sono come dico di essere,
non danneggerete me più di voi stessi: a me, infatti. niente mi può
danneggiare, né Meleto né Anito - non ne sarebbero neppure capaci - in
quanto, credo, [30d] non è permesso che un uomo migliore sia
danneggiato da uno peggiore. Forse mi può uccidere o esiliare o
disonorare; ma mentre egli e qualcun altro possono credere che questi
siano grandi mali, io non lo credo, e considero invece un male molto
maggiore fare ciò che sta facendo ora, cioè tentare di condannare
ingiustamente a morte un uomo. Perciò, cittadini ateniesi, io non parlo
per difendere me stesso, come qualcuno potrebbe supporre, ma per voi,
perché non abbiate ad errare su [30e] quello che il dio vi dato, votando
contro di me. Infatti se mi condannate, non troverete facilmente un altro
che - sia pur detto in modo ridicolo - venga assegnato dal dio alla città
come a un cavallo grande e nobile, ma pigro a causa della sua grandezza
e bisognoso di essere svegliato da un qualche tafano. Perché mi sembra
che il dio mi abbia posto sulla città con questa funzione: non smettere di
stare appresso a voi - a ciascuno di voi - tutto il giorno e dovunque per
stimolarvi, convincervi e rimproverarvi.[31a] Un altro tipo così, cittadini,
non vi rinascerà facilmente: risparmiatemi, se mi date retta. Ma può darsi
che voi, che vi irritate in fretta e mi picchiate, come gente che casca dal
sonno buttata giù dal letto, diate retta ad Anito e mi condanniate
facilmente a morte, per continuare a dormire, a meno che il dio,
preoccupato per voi, non vi rimandi qualcun altro. E che io sia qualcosa
di dato dal dio [31b] potreste comprenderlo da questo: non è umano che
io abbia trascurato tutto quel che mi riguardava, abbia continuato a non
curarmi degli affari di famiglia per tutti questi anni e invece abbia sempre
fatto i vostri, rivolgendomi a ciascuno privatamente, come un padre o un
fratello maggiore, per convincervi a preoccuparvi della virtù. Se io ne
avessi tratto vantaggio e avessi dato questi consigli a pagamento, la cosa
avrebbe avuto un qualche senso, ma ora vedete voi stessi che i miei
accusatori, pur accusandomi così spudoratamente in tutto il resto, in
questo caso non sono stati così sfrontati da [31c] presentare un testimone
ad affermare che io mi sia mai fatto pagare o l'abbia richiesto. Perché
credo che basti produrre la povertà come testimone a mio favore. (31)
Vi potrà forse sembrare strano che io me ne vada in giro e mi dia da fare
(polypragmoneo) a consigliarvi in privato, ma non abbia il coraggio di
alzarmi a parlare pubblicamente al popolo in assemblea per dar consiglio
alla città. La causa di questo, come mi avete spesso sentito ripetere, è che
mi accade qualcosa di divino [31d] e di demonico, (32) di cui appunto ha
scritto anche Meleto nella sua accusa, facendoci sopra della satira. E'
qualcosa che mi è cominciato da bambino, come una specie di voce, la
quale, ogni volta che si produce, mi trattiene sempre da quello che sto per
fare, senza però mai spingermi in avanti. Questo è ciò che mi impedisce
di fare politica, e mi sembra una opposizione sacrosanta. Perché - tenetelo
ben presente, cittadini ateniesi - se in passato mi fossi nesso ad occuparmi
di affari politici, sarei morto da un pezzo e non sarei stato utile né a voi
[31e] né a me stesso. E non prendetevela con me, che dico la verità: non
c'è nessuno che si possa salvare, se si oppone autenticamente a voi o a
un'altra maggioranza, impedendo che in città avvengano molte ingiustizie
e illegittimità, ed [32a] è anzi necessario che chi combatte per il giusto, se
deve sopravvivere anche solo per un po', rimanga un privato e non si
dedichi alla vita pubblica.
Ma di questo vi fornirò abbondanti prove: non discorsi, ma qualcosa di
cui voi avete rispetto, fatti. Ascoltate che cosa mi è successo, perché
possiate rendervi conto che non cederei a nessuno per paura della morte,
in violazione del giusto, ma morirei piuttosto che arrendermi. Vi dirò
cose grossolane e avvocatesche, ma vere. Infatti, cittadini ateniesi, io
[32b] non ho mai esercitato nessuna carica in città se non come membro
della Bulé; e capitò che la mia tribù Antiochide avesse la pritania quando
decideste di giudicare tutti insieme, illegittimamente (paranomos), come
sembrò in un secondo momento a tutti voi, i dieci strateghi che non
avevano raccolto [i naufraghi] della battaglia navale. Ma in quel
momento io solo fra i pritani mi opposi a voi, per non fare niente contro
la legge, e votai contro. E mentre c'erano oratori pronti a denunciarmi e a
trascinarmi in giudizio e voi gridavate e li incitavate, [32c] io pensavo
che era per me doveroso rischiare il tutto per tutto con la legge e la
giustizia, piuttosto che stare con voi deliberando cose ingiuste, per paura
della prigione o della morte. E questo fu quando la città aveva ancora una
costituzione democratica. Ma quando si affermò l'oligarchia, i trenta mi
rifecero chiamare al Tholo con altri quattro, e mi ingiunsero di portar via
da Salamina Leonte di Salamina per metterlo a morte. Essi davano molti
ordini del genere a numerosi altri, perché volevano contaminare con le
loro colpe più persone possibili. E anche allora, [32d] tuttavia, provai non
a parole ma con i fatti che della morte non m'importa - se non è detto
troppo rusticamente - proprio nulla, mentre non agire in modo ingiusto ed
empio mi sta del tutto a cuore. Perciò quel governo, pur essendo così
potente, non mi turbò tanto da indurmi a fare qualcosa di ingiusto, e,
uscito dal Tholo, mentre gli altri quattro erano andati a Salamina a
prendere Leonte, io mi ero allontanato e me ne ero andato a casa. E forse
per questo sarei stato messo a morte se quel governo non fosse stato
velocemente rovesciato. [32e] Anche di questo avrete numerosi
testimoni.
Credete dunque che sarei sopravvissuto per tanti anni se mi fossi
occupato di affari pubblici e, facendolo in modo degno di un uomo
buono, avessi sostenuto quello che è giusto e lo avessi considerato - come
si deve - della massima importanza? Assolutamente no, cittadini ateniesi;
né [33a] ci sarebbe riuscito qualcun altro. Ma - sarà chiaro - in tutta la
mia vita, se per avventura mi sono occupato di questioni pubbliche, io
sono stato così, e così sono stato anche in privato, senza mai cedere a
nessuno - né a quelli che i miei calunniatori dicono miei discepoli né ad
altri - contro quello che è giusto. E non sono stato maestro di nessuno: se
c'è qualcuno - giovane o vecchio - che desidera ascoltarmi quando parlo e
faccio ciò mi è proprio, io non me ne sono mai risentito. Discuto senza
farmi pagare [33b] e non evito di farlo se non prendo soldi, ma mi offro
ugualmente a ricchi e poveri per domandare e chiunque ne abbia voglia
può ascoltare quello che dico quando rispondo. Di questi, sia che
qualcuno diventi onesto, sia che non lo diventi, io giustamente non posso
essere ritenuto responsabile, perché non ho mai promesso istruzione a
nessuno, né ho mai insegnato. E se qualcuno dice di aver imparato
qualcosa da me o di aver ascoltato da me in privato cose non udite anche
da tutti gli altri, non dice la verità, siatene certi.
Ma perché allora ad alcuni piace [33c] passare tanto tempo con me?
L'avete sentito, cittadini, ateniesi, vi ho detto tutta la verità: a loro piace
ascoltarmi quando esamino quelli che si credono sapienti senza esserlo. E
in effetti non è spiacevole. Ma a me di compiere questo, ripeto, è stato
ordinato dal dio, con oracoli, con sogni e in tutti i modi in cui un qualche
destino (moira) divino prescrive all'uomo il da farsi. Questo, cittadini
ateniesi, è vero e anche facilmente dimostrabile. Infatti, se davvero [33d]
corrompessi dei giovani ed altri ne avessi corrotti in passato, certo alcuni
di questi, invecchiando, si sarebbero dovuti render conto che davo loro
cattivi consigli quando erano giovani e ora dovrebbero essere qui ad
accusarmi e a chiedere soddisfazione; e se non avessero voluto farlo
personalmente, qualche loro familiare - padri, fratelli e altri parenti - ora
se ne dovrebbe ricordare per chiedere soddisfazione, se veramente i
congiunti avessero patito da me del male. In ogni caso, ce ne sono molti
qui presenti - io li vedo -: ecco per primo Critone, mio coetaneo [33e] e
del mio stesso demo, padre di Critobulo - eccolo qui -; poi Lisania di
Sfetto, padre di Eschine - anche lui qui -; ed ecco ancora Antifonte di
Cefisia, padre di Epigene, e quest'altri i cui fratelli mi hanno frequentato,
Nicostrato figlio di Teozotide, fratello di Teodoto -e Teodoto è morto e
dunque non può essere qui per sua preghiera -, e Paralio figlio di
Demodoco, di cui era fratello Teage; e c'è [34a] Adimanto figlio di
Aristone, di cui è fratello Platone - eccolo -, e Aiantodoro, di cui è fratello
Apollodoro - eccolo qui -. E di molti altri avrei ancora da dire: Meleto
avrebbe dovuto innanzi tutto presentare come testimone qualcuno di
questi, nel suo discorso; se gli è passato di mente allora, lo faccia ora - gli
cedo il posto - e se ha qualcosa di simile, lo dica. Ma, cittadini, troverete
che è tutto il contrario, che tutti sono pronti a venire in aiuto a me, che li
corrompo e faccio del male ai loro familiari, come dicono Meleto e [34b]
Anito. In effetti quelli che sono già corrotti potrebbero aver motivo di
aiutarmi, ma quelli che non lo sono, gli uomini già anziani, i loro parenti,
quale altro motivo potrebbero avere se non ciò che è retto e giusto, perché
sanno bene che Meleto mente e io dico la verità?
Bene, cittadini; più o meno questo, e altro di simile, è quanto posso dire
in mia difesa. Forse qualcuno [34c] di voi potrà irritarsi al ricordo di se
stesso, se, sostenendo un processo anche più modesto del mio, ha pregato
e supplicato i giudici con molte lacrime e ha portato in tribunale i figli e
numerosi altri parenti ed amici per farli commuovere di più, mentre io,
anche se mi credo di fronte al pericolo estremo, non farò nulla di simile.
Forse qualcuno, riflettendoci su, potrebbe indisporsi nei miei confronti e,
adirato, potrebbe votare [34d] con ira. Se qualcuno di voi è così - non
penso che ci sia, ma se ci fosse - mi sembrerebbe appropriato dirgli: Amico mio, anch'io ho qualche familiare; proprio come dice Omero, non
sono nato "né da quercia né da pietra" ma da esseri umani e così ho
anch'io dei familiari e dei figli, tre, cittadini ateniesi, uno che è già un
ragazzo, e due bambini, ma, nondimeno, non porterò quassù nessuno di
loro e non vi pregherò di votare per la mia assoluzione. - E perché non lo
voglio fare? Non per arroganza, cittadini [34e] ateniesi, né perché vi
disprezzo; se io sia o no coraggioso di fronte alla morte è un altro
discorso, e tuttavia non mi sembra bello, per la fama mia e vostra e della
città intera, comportarmi così alla mia età e con la reputazione che ho,
vera o falsa che sia, poiché in ogni caso si crede [35a] che Socrate sia
diverso dalla maggioranza degli esseri umani. E sarebbe davvero una
vergogna se proprio quelli che fra voi si distinguono per sapienza o
coraggio o qualsiasi altra virtù si comportassero in questa maniera. Ne ho
vista molta di gente così, che se si trova in giudizio, pur avendo una
qualche reputazione, fa scene straordinarie, come se pensasse di dover
subire qualcosa di terribile se muore, quasi dovesse essere immortale se
voi non la condannaste a morte. A me sembra che questa gente copra di
vergogna la città: così - e lo potrebbe supporre anche un forestiero - [35b]
perfino chi fra gli Ateniesi si distingue per virtù e che essi stessi
prescelgono per le magistrature e le altre cariche onorifiche non è per
nulla diverso dalle donne. Perciò, cittadini ateniesi, non bisogna vi
comportiate così voi, se avete una certa qual reputazione, né permetterlo,
se siamo noi a farlo, ma vi conviene mostrarvi molto più propensi a
votare sfavorevolmente nei confronti di chi fa queste scene
strappalacrime e rende ridicola la città, che di chi rimane tranquillo.
Ma a prescindere dalla reputazione, cittadini, non mi sembra giusto [35c]
supplicare il giudice e farsi assolvere con le preghiere, invece di spiegare
e convincere. Il giudice non è qui per concedere quello è giusto come un
favore, ma per giudicarlo; e non ha giurato di far favori a chi gli pare, ma
di giudicare secondo le leggi e le consuetudini (kata tous nomous). E
perciò non bisogna né che noi abituiamo voi a non osservare il
giuramento, né che vi ci abituiate voi, perché nessuno, così, si
comporterebbe piamente. Non aspettatevi dunque, cittadini ateniesi, che
io faccia davanti a voi cose che non ritengo né belle, né [35d] giuste, né
pie, proprio io - per Zeus - che sono accusato di empietà dal qui presente
Meleto. E' chiaro che se convincessi e forzassi con le suppliche voi, che
avete fatto un giuramento, vi insegnerei a pensare che non ci sono dei e,
appunto con questa autodifesa, accuserei me stesso di non credere negli
dei. Ma è tutt'altro che così: io ci credo, cittadini ateniesi, come nessuno
dei miei accusatori (33) e permetto a voi e al dio di giudicarmi nel modo
migliore per me e per voi.
UNITA’ 3
PARTE 1 LA QUESTIONE OMERICA
La tradizione classica attesta che la più antica redazione scritta dell’Iliade
e dell’Odissea fu realizzata nel VI secolo a.C. ad Atene per iniziativa del
tiranno Pisistrato e di suo figlio Ipparco: si trattava di quella che
potremmo definire una sorta di edizione ufficiale, che ebbe infine il
sopravvento col sulle altre già esistenti. A partire dal III secolo a.C. e fino
al 150 a.C., vennero edite delle edizioni critiche dei due poemi, ad opera
di filologi alessandrini, come Zenodoto di Efeso, Aristofane di Bisanzio e
Aristarco di Samotracia, che lavoravano nell’ambito di grandi istituzioni
culturali come la Biblioteca e il Museo, sorte ad Alessandria d’Egitto su
espresso desiderio dei sovrani della dinastia Tolemaica. I filologi si
occuparono di ripartire Iliade e Odissea ciascuna in ventiquattro libri,
esattamente quante erano le lettere del nuovo alfabeto attico, ed
impiegarono le maiuscole per la prima opera e le minuscole per la
seconda: le comodità di consultazione, di citazione e di rimando furono
subito evidenti. Il lavoro di questi studiosi consistette sostanzialmente in
un'opera di rigorosissima conservazione, volta a conservare inalterate nel
testo anche parti di autenticità dubbia, limitandosi tuttavia a
contrassegnarle mediante un segno grafico speciale, l’obelos. I filologi si
occuparono anche del delicato lavoro di atetesi, cioè di espunzione dei
versi spuri. Sebbene la loro opera risultò infine davvero fondamentale
per la preservazione del testo omerico, i filologi alessandrini
contribuirono tuttavia a distruggerne definitivamente il carattere
originario di poesia destinata alla recitazione e quindi indissolubilmente
legata all’oralità. Dalla coesistenza di questi due elementi, redazione
pisistratea e composizione orale, oltre che dall’incertezza dei dati sulla
composizione, ed insomma da tutta la serie di problemi connessi
all'origine ed all'autore dei due poemi, prese avvio e venne a svilupparsi
la cosiddetta questione omerica, che, malgrado l’opera di molti studiosi,
resta a tutt’oggi un problema in gran parte insoluto.
UNITA’ 3
PARTE 2 ARCHILOCO
Archiloco (in greco Ἀρχίλοχος, Archílochos; Paro, 680 a.C. circa – 645
a.C. circa) è stato un poeta e militare greco antico. È considerato il
giambografo più famoso ed il primo grande lirico greco.
Biografia
Archiloco nacque alla fine dell'VIII secolo a.C. o nella prima metà del
VII secolo a.C. (probabilmente intorno al 680 a.C.) nell'isola di Paro nelle
Cicladi. Suo padre era un nobile, Telesicle; la madre era verosimilmente
una schiava tracia, chiamata Enipò, anche se tale nome potrebbe essere
fittizio, in quanto nato da un'assonanza con il sostantivo greco ἐνιπή,
enipè (ingiuria), e dunque riconducibile alla sua attività di poeta
giambico.
Il nonno (o bisnonno), Tellis, alla fine dell'VIII secolo a.C. partecipò al
trasferimento del culto di Demetra a Taso: per tale motivo Pausania, nel
descrivere la Lesche dei Cnidi, a Delfi, ricorda che in essa Polignoto di
Taso (V secolo a.C.) raffigurò anche lo stesso Tellis, posto accanto alla
sacerdotessa Cleobea, fautrice dell'introduzione a Taso del culto di
Demetra.
Archiloco visse probabilmente nel periodo che va dal 680 a.C. al 645 a.C.
in quanto in una sua opera viene menzionata l'eclissi di sole del 6 aprile
648 a.C., che sconvolse gli abitanti dell'Egeo e alla quale egli assistette
mentre si trovava a Taso, una colonia dei Pari.
Nella seconda metà dell'VII secolo a.C., durante il grande movimento di
colonizzazione ellenica, i Pari colonizzarono a nord l'isola di Taso, ma
dovettero sostenere lunghe lotte contro i barbari del continente e contro le
colonie delle città rivali tra cui la vicina Nasso. Archiloco, figlio del
fondatore della colonia tasia, combatté in tali guerre e ne cantò le
vicende.
Irrequieto nell'indole, trascorse buona parte della sua vita in mare. In una
sua famosa elegia si mostra rattristato per la perdita del cognato morto in
mare in un naufragio. Sua è la prima raffigurazione allegorica della
battaglia come di una "paurosa tempesta".
Archiloco condusse un'esistenza segnata da ogni tipo di stento, non
perché fosse vero ma solo per compiangersi. Invitava tutti a lasciare Paro
e a trattenerlo nella vicina Nasso non bastò né il dolce vino né il suo vitto
peschereccio. Giunse a Karpathos e a Creta; verso Nord visitò, l'Eubea,
Lesbo, il Ponto.
Come detto, Archiloco si guadagnò da vivere facendo il soldato
mercenario, cosa che afferma egli stesso nelle sue poesie. La tradizione
vuole che perse la vita in combattimento, ucciso da un certo Calonda,
mentre combatteva per la sua patria contro Nasso.
Personalità
I pochi frammenti rimasti dell'opera archilochea, ci consentono di
tracciare uno schizzo dell'uomo e dell'artista. Archiloco era individualista,
trasgressivo e anticonformista. Lui ebbe una spregiudicata reazione alle
convenzioni sociali e all'etica di quel tempo. Di lui si narra l'episodio nel
quale abbandonò lo scudo per salvare la sua vita contravvenendo ai
principi
morali
di
quel
tempo.
Si può affermare che sia il primo a mettere in crisi i fondamenti stessi
dell'etica eroica, in quanto:
•
•
•
nega la morte gloriosa
celebra il ῥιψασπίς (ripsaspis, colui che getta lo scudo)
rifiuta la καλοκἀγαθία (kalokagathia, sintesi di bellezza e virtù)
Da un uomo come Archiloco non ci si può aspettare la morale dei sette
Savi, è un uomo che sbaglia e si ribella alle eccessive preoccupazioni
umane. In lui, troviamo un realismo che lo avvicina molto al cinismo dei
nostri giorni. Egli appare sincero sia come uomo, sia come poeta. La
sincerità e l'audacia del cantore, il quale osa fare delle sue gioie e
sofferenze centro del suo canto, ha fatto in modo che sia considerato il
primo poeta moderno dell'antichità.
La sua figura è quella di un poeta-soldato come lo sarà anche quella di
Anacreonte; e proprio dal suo ruolo di addetto ai lavori Archiloco
polemizza ferocemente sulla vita militare ribadendo così la soggettività
propria della lirica arcaica.
L'amore
Si racconta che amò una fanciulla di Paro, di nome Neobule ("Oh, se
potessi così toccar la mano di Neobule"), promessagli in sposa dal padre
Licambe prima che quest'ultimo si rimangiasse la parola data. Archiloco
nei suoi versi attaccò così pesantemente il padre della fanciulla tanto da
indurre lui e la famiglia, secondo la leggenda, ad impiccarsi.
Archiloco è il primo poeta di tutta la letteratura occidentale a
rappresentare l'amore come tormento. Una parte della sua poesia,
violentemente erotica, narrava le oscenità più crude, il tutto descritto
secondo un'originale fantasia. Egli nei suoi versi dà sfogo al suo
temperamento focoso quanto nell'odio che nell'amore. L'amore gli ispira
le sensazioni più disparate dalla tenerezza, alla bellezza, fino alla
sensualità e agli sfoghi d'ira per gli amori delusi.
Opere
(GRC)
(IT)
« ὦ λιπερνῆτες πολῖται, τἀµὰ δὴ
συνίετε
ῥήµατ' »
« Miserabili cittadini, sforzatevi
almeno
di capire le mie parole »
(Frammento 109 West )
Delle sue opere restano circa 300 frammenti che furono ordinati dai
grammatici alessandrini secondo il metro utilizzato: Archiloco scrisse
elegie, giambi, tetrametri trocaici, asinarteti, epodi. Quanti libri abbia
scritto non è dato precisare ma si ritene almeno uno di elegie, tre di
giambi, e altri. La maggior parte dei frammenti a noi è pervenuta per via
indiretta, ma alcuni, i più estesi, in forma papiracea. I frammenti
superstiti di Archiloco vengono convenzionalmente raggruppati nel
seguente modo:
•
•
•
•
frammenti legati all'esperienza biografica
componimenti di carattere gnomico e riflessivo
versi caratterizzati dallo psògos e dall'invettiva
versi di stampo erotico
I destinatari principali della poesia archilochea erano gli ἑταῖροι
(hetàiroi), i membri della sua consorteria aristocratica, suoi compagni
d'armi. Le occasioni concrete di riunione erano i simposi.
Mito
Una parte di rilievo della lirica archilochea ebbe anche carattere
obbiettivo e addirittura narrativo. Archiloco sta a capo non solo della
lirica personale ma soprattutto di quella corale, ossia mitologica. Trattò le
leggende di Eracle, di Pirro, di Euripilo, del pario Coiranos salvato da un
delfino. Inoltre, c'è chi sostiene che Archiloco venisse considerato dagli
antichi come l'emulo di Omero.
Favola
Come il mito è considerato la rappresentazione ideale della vita umana,
allo stesso modo ne è la rappresentazione volgare il mito animale: la
favola. Gli scarsi frammenti ci dicono che le favole della volpe e
dell'aquila o della scimmia e della volpe erano trattate da Archiloco con
grande ampiezza a tal punto che consentiva discorsi diretti tra animali
protagonisti, invocazioni a Zeus e forse il riferimento esplicito alla realtà.
La figura della volpe compare per la prima volta proprio con questo
poeta.
Metrica
Archiloco è ritenuto l'inventore del giambo, ma probabilmente tale verso
è più antico dell'autore stesso. Egli fu il primo ad utilizzarlo in larga scala
e molti poeti successivi come Saffo, Alceo, Anacreonte e i latini Catullo e
Orazio lo presero come modello. I ritmi giambici e trocaici erano i più
vicini alla lingua viva, a quella parlata nelle processioni. Ad Archiloco si
deve inoltre la creazione della prima strofa (epodo). L'epodo archilocheo,
il distico della poesia giambica, risulta dall'accoppiamento di un verso
semplice o composto, con uno generalmente più breve.
Com'era tradizione per i poeti giambici della Grecia arcaica (in questo
caso si possono trovare analogie specialmente con la biografia di
Ipponatte), Archiloco aveva un nemico giurato contro il quale scatenava
tutte le proprie invettive. Costui era Licambe. Si tramanda che amò una
donna di Paro, Neobule. Il padre di questa, Licambe, gliela aveva
promessa in sposa, ma poi si rimangiò la parola. Archiloco, allora, nei
suoi versi attaccò così violentemente Licambe e la sua famiglia, al punto
da indurli, secondo la leggenda, ad impiccarsi per la vergogna.
Uno dei temi prediletti da Archiloco è il vino. Viene rappresentato come
lenimento o come liberazione catartica e orgiastica.
UNITA’ 3
PARTE 3 ALCEO
Alceo nacque nel 630 a.C. a Lesbo da una famiglia aristocratica. La sua
vita fu segnata dal vivo interesse politico e dalla lotta contro il potere
assolutistico dei tiranni Melancro, Mirsilo e Pittaco. Questi scontri lo
portarono più volte all'esilio, esperienza dolorosa che ricorre anche in un
lungo frammento che si apre con il rimpianto del poeta per il suo
allontanamento forzato dalle attività pubbliche che erano il prestigio della
sua famiglia. La sua opera destò l'attenzione degli alessandrini che la
sistemarono in dieci libri; oggi restano solo quattrocento frammenti per
giunta molto lacunosi.
La politica costituisce un nucleo fondamentale della poesia alcaica: in un
carme il poeta scaglia violente invettive contro Pittaco, accusandolo di
aver tradito la solidarietà dei suoi alleati,in quanto la lealtà era il principio
fondamentale dell'etica aristocratica. In un'altra poesia egli volge una
feroce maledizione al "pancione" (Pittaco appunto) che calpestò i patti, la
quale sfocia in un'esortazione a morire combattendo contro di lui o a
vincerlo per liberare la città. Allorché muore Mirsilo egli prorompe in un
esultante invito a bere fino all'ubriachezza: la passione politica viene qui
trattata all'interno del contesto conviviale; elemento politico e simposiaco
convergono spesso nella sua opera, ma questo non significa che siano
sempre legati: non si beve soltanto per parlare di politica: il vino é anche
gioia ed esaltazione delle sensazioni corporee; la sua estasi é verità dei
pensieri ed é proprio questo dolce unguento che lenisce l'animo e ristora la
mente dall'assillante preoccupazione del dolore.
Altri temi trattati nelle liriche di Alceo sono l'argomento mitico-religioso
(di cui mirabile esempio sono le tre strofe rimasteci dell'inno ai
Dioscuri,che descrive la fulminea apparizione dei due gemelli divini
durante una notte tempestosa sul mare, identificandoli nei fuochi di
s.Elmo che indicano salvezza ai naviganti), e l'argomento epico, presente
in vari carmi come quello che ricorda le nozze fra Peleo e Teti, o quello
che descrive le sciagure provocate dalla follia amorosa di Elena;
l'argomento mitico in qualche caso appare legato all'attualità, in
particolare alla lotta contro il potere tirannico: l'attenzione al presente e la
passione politica sono tratti peculiari della vita di Alceo che lo portano ad
attribuire una funzione pragmatica alla sua poesia. Essa è inscindibile dal
contesto e dall'occasione in cui viene cantata. L'eteria a cui il poeta si
rivolge infatti corrisponde alla sua attività artistica.
La forte aderenza del poeta alla realtà e alla particolarità dell'occasione si
riflette anche nel suo stile: esso è caratterizzato dall'alternanza di toni
espressivi, ora più raffinati e simili alla prosa, ora più forti e potenti. La
lingua eolica di cui si serve per comporre i carmi è arricchita inoltre di
parole rare provenienti forse dal parlato, che solo un pubblico maschile
aperto alla varietà dei rapporti sociali può comprendere e utilizzare.
In conclusione Alceo fu considerato iniziatore di un certo tipo di poesia
che troverà poi un degno successore nel poeta latino Orazio.
L'occasione che ci presenta Alceo in questo frammento è il simposio
invernale. La prima strofa descrive un gelido scenario caratterizzato da
pioggia, maltempo e gelo; ma la cattiva stagione viene scacciata, abbattuta
(k£bballe, v. 5) dall'atmosfera intima e raccolta del simposio, i cui
commensali si incontrano in un clima di amicizie e solidarietà reciproca.
Il motivo del bere vino accanto al fuoco appare topico già in età arcaica;
tuttavia in Alceo la situazione rappresentata è concreta e reale, legata ad
una precisa situazione simposiaca. Alceo esorta a bere senza moderazione
(¢feidšwj, v. 6), senza preoccuparsi di non esagerare. Questo è tipico
dell'atmosfera simposiaca da lui vissuta, anche se essa non sarà da tutti
condivisa (un esempio è Anacreonte).
Nei carmi riportati percorriamo le tappe fondamentali del simposio
secondo la tradizione greca arcaica, attraverso l'interpretazione poetica di
Alceo. I convitati erano riconosciuti come gruppo sociale dalle ideologie e
dalle aspirazioni comuni, e dunque, il simposio veniva vissuto come un
momento di dialogo tra i diversi membri. L'eteria era riunita e i
partecipanti attendevano che fosse dato inizio al rito. Generalmente il
simposio cominciava dopo l'accensione delle lucerne, ma Alceo apre uno
dei suoi carmi con un'insolita esortazione al bere prima dell'ora consueta
(fr. 346), ciò ci fa dedurre che si trattasse di un simposio differente dagli
altri, e che probabilmente la riunione fosse stata convocata per un motivo
particolare, a noi però ignoto. Il poeta esortava, dopo il brindisi iniziale,
ad ubriacarsi e dunque non ad un bere pacato, e questo porta a
presupporre che la causa della convocazione dell'eteria non fosse del tutto
lieta (fr. 346). Altro elemento di fondamentale importanza, che
riscontriamo in tutti i passi riportati è il vino. Questo rappresentava la
gioia della pura fisicità, l'esaltazione delle sensazioni corporee, messe in
rilievo dalla corrispondenza con il variare delle stagioni: l'arsura
dell'estate (fr. 347), il gelo invernale (fr. 338). Veniva definito come
laqik£dea, ovvero "oblio d'affanni", normalmente infatti i Greci
ritenevano che il vino avesse particolari valori sociologici e simbolici,
legati alla strana metamorfosi che lo portava a modificare completamente
le sue peculiarità. Ma il vino, dono di Dioniso, nella tradizione simposiaca
greca non era soltanto questo, era anche ciò che garantiva la verità dei
pensieri, in cui si rivelava la sincerità dell'amico, era il ristoro della mente
soffocata dal peso del dolore (fr. 346). Da qui derivava il concetto di
simposio come spazio simbolico della bellezza, in cui l'uomo trovava il
risarcimento della sofferenza. Altri elementi strettamente legati alla
cultura arcaica vengono identificati, oltre che nella particolare
considerazione del vino, anche nel modo di bere. Alceo utilizzava il verbo
miscelare, e questo derivava dal fatto che il vino, donato da figlio di
Semele e Zeus per sciogliere l'animo umano dai dolori, non poteva essere
bevuto puro, ma veniva mescolato all'acqua per diminuirne la densità e
dunque gli effetti sulla mente umana (fr. 346). Non era una tradizione
comune di tutti i popoli, dal momento che Anacreonte ci riporta la
tradizione del popolo Scita, bere smodato e scomposto, lungamente
scongiurato dal popolo greco. Quello di Alceo era indubbiamente un
simposio differente dagli altri, riconosciamo infatti che il poeta attribuì
dignità espressiva a questo tema che diventerà con il passare degli anni un
vero e proprio tÒpoj letterario, arrivando ad istituire uno stretto
parallelismo tra la foga con la quale egli invita a bere e il famoso carpe
diem di Orazio. Una breve analisi stilistica ci mostra un andamento
fortemente paratattico, con frequenti allitterazioni e numerose assonanze.
UNITA’ 3
PARTE 4 SAFFO
La divina Saffo, l’hagné, considerata la più grande poetessa di tutti i
tempi, nacque ad Ereso, nell’isola di Lesbo, da una nobile famiglia, ma la
sua vita si svolse a Mitilene dalla quale, ai tempi della caduta dei
Cleanattidi, a causa delle lotte politiche, fu esiliata per qualche tempo, e
di ciò resta testimonianza nel "marmo pario", un’iscrizione che attesta la
sua presenza in Sicilia tra il 607 e il 590 a. C., perché, a parte un
frammento superstite in cui ne accenna genericamente, …te Cipro e Pafo,
oppure Palermo, non ne fa menzione. Rimpatriò poi durante il regno di
Pittaco, per il quale non nutriva simpatìa, considerandolo promotore delle
restrizioni che mortificavano l’amore per il lusso della classe
aristocratica, come prova un’ode nella quale si rivolge alla figlia (bella,
dall’aspetto simile ai fiori dorati) inducendola a rinunciare alla mitra
variegata che la fanciulla desidera per le sue chiome perché Pittaco si
scandalizzerebbe, chiamando a testimone il poeta Alceo, con quale vi fu
un vincolo di solidarietà e simpatia, e che di lei in modo lusinghiero
scrisse: Saffo, veneranda, dal soave sorriso, dal crine di viola.
Ben poco sappiamo di Saffo, che ebbe un marito e una figlia, che
raggiunse la vecchiaia (infatti, in un papiro troviamo allusioni ad una
pelle senile e a capelli bianchi), che era amante del bello, raffinata ed
elegante nei modi e nell’aspetto ma, soprattutto, che amò molto e che
l’amore riversato nei versi fu un
canto limpido e toccante.
Saffo fu stimata ed ammirata a Mitilene da molte sue concittadine, che
erano solite riunirsi intorno a lei in un centro femminile del culto di
Afrodite e delle Muse, una sorta di cenacolo intellettuale, una comunità
tra il sacro e il profano definita "tiaso", costituita di sole fanciulle,
aristocratiche e nubili, giovani donne che subivano il fascino della
superiorità spirituale di Saffo, che da lei apprendevano la musica e la
danza, e che l’abbandonavano solo quando poi prendevano marito e
seguivano il loro destino, lasciando nell’animo della poetessa l’amarezza
del distacco, che non tardava a riversare nei versi ricchi di pathos, intrisi
di rimpianto per l’amicizia perduta.
Nei suoi frammenti ricorrono parecchi nomi di queste fanciulle, Attide,
Girinna, Arignota, Gongila, Dice, Anattoria, che Saffo ammirava,
stimava e celebrava, esaltandone le lodi e la bellezza, festeggiandone con
gioia le nozze e lamentandone la partenza per terre lontane, con versi
armoniosi e di rara bellezza, testimonianza preziosa del suo canto e dei
suoi sentimenti. Di Gòngila esaltò soprattutto la bellezza, che era tale da
offuscare quella della stessa dea:
O mia Gongila, ti prego
metti la tunica bianchissima
e vieni a me davanti: intorno a te
vola desiderio d’amore.
Così adorna, fai tremare chi guarda;
e io ne godo, perché la tua bellezza
rimprovera Afrodite.
Per Arignota, bella come la luna tra gli astri, che aveva sposato un uomo
potente ed ormai abitava lontano, e che malinconicamente supplicava la
poetessa di raggiungerla, Saffo si struggeva di nostalgia perché avrebbe
voluto
rivedere
il suo
bel volto
e
le
movenze
aggraziate.
Ad un’altra amica, esitante nel congedarsi, Saffo, pur afflitta
dall’amarezza del distacco, ricordava le ore trascorse insieme in soave
intimità e, frenando la commozione, e trattenendo il pianto, recava
conforto:
"Vorrei essere morta, sai,davvero"
era così disfatta nel congedo
e parlava parlava:"Oh, Saffo,
è terribile quello che proviamo!
Non son io che lo voglio se ti lascio",
e io le rispondevo: addio,
su, vai, e ricordati di me,
perché lo sai come ti seguivamo:
e se no-allora io lo voglio
che ti ricordi, perché tu dimentichicom’era bello ,ciò che provavo,
quante corone di viole
ti posavi sul capo,insieme a me,
di rose, croco, salvia, di cerfoglio,
e quante s’intrecciavano ghirlande
per il tuo collo delicato
fatte dei fiori della primavera…
Oppure si lasciava prendere da una furiosa gelosia come nella celebre ode
tradotta da Catullo e imitata da Foscolo, quella in cui descrive le
sofferenze al cospetto della coppia felice, dell’uomo beato come un dio di
fronte alla fanciulla che parla e sorride con dolcezza, mentre, impotente
spettatrice, si tortura al loro cospetto.
Il colloquio dell’amica con l’uomo amato suscitava infatti in lei il
sentimento violento e appassionato della gelosia, che la rapiva nella sua
ardente visione e le impediva di udire qualsiasi altra cosa intorno a sé,
espresso con tale potenza mai eguagliata da nessun altro poeta. Ecco,
allora, l’ode considerata il capolavoro della poesia erotica, già famosa ai
tempi di Saffo, che descrive proprio lo sconvolgimento dell’animo
turbato dalla gelosia, esaltata già nel I secolo d. C da un poeta anonimo
sul Sublime, rielaborata nella letteratura greca da Apollonio Rodio e da
Teocrito e, in quella latina, da Lucrezio, Orazio e persino da Catullo, la
cui versione è famosa quasi quanto l’originale:
Mi appare simile agli Dei
quel signore che siede innanzi a te
e ti ascolta,tu parli da vicino
con dolcezza,
e ridi, col tuo fascino, e così
il cuore nel mio petto ha sussultato,
ti ho gettato uno sguardo e tutt’a un tratto
non ho più voce,
no, la mia lingua è come spezzata,
all’improvviso un fuoco lieve è corso
sotto la pelle, i miei occhi non vedono,
le orecchie mi risuonano,
scorre un sudore e un tremito mi prende
tutta , e sono più pallida dell’erba,
è come se mancasse tanto poco
ad esser morta;
pure debbo farmi molta forza.
Il mondo poetico di Saffo può apparire chiuso ed impenetrabile ma non è
difficile comprendere la genesi dei versi sensibilissimi e delicati; il suo
animo femminile non poteva certo cantare secondo i motivi usuali della
lirica del suo tempo,le lotte politiche non l’attraevano, non sono donna di
pertinaci rancori, ma l’anima ho mite, armi e apparecchi militari non le
interessavano, chi una schiera di cavalli,chi di fanti,chi uno stuolo di
navi dice essere la cosa più bella su la nera terra, io invece ciò che si
ama, e tanto meno era portata per l’esaltazione del simposio o delle
espressioni dei piaceri effimeri collegati, ad esempio, alle gioie del vino.
Portata per l’introspezione Saffo, coltivò soprattutto la vena intimistica,
ed è appunto con lei che nella poesia nasce l’interiorità, favorita proprio
dalla condizione femminile nel mondo greco, condizione che per lei non
era di chiusura giacché, nata in una famiglia aristocratica, aveva rapporti
di società, viaggiava, scambiava versi con Alceo, era anche moglie e
madre dalla vita normale, senza che ciò interferisse con la sua attività nel
tiaso e col suo essere poetessa. In un’epoca e in un ambiente in cui la
donna godeva di una certa autonomia e indipendenza, Saffo si ripiegava
in se stessa, si creava un suo mondo poetico, in una cerchia diversa da
quella dell’uomo, quasi in isolamento, cercando calore per la sua anima
soprattutto nel bello della natura: i fiori, gli usignoli, i paesaggi notturni e
le scene di primavera la deliziavano con uno stupore quasi infantile,
facendole apprezzare della bellezza soprattutto la leggiadria e la grazia,
virtù squisitamente femminili.
Da un epigramma sepolcrale che scrisse per lei Tullio Laurèa, un amico
di Cicerone, si apprende che gli antichi conoscevano una raccolta dei
carmi di Saffo divisa in ben nove libri: dell’enorme produzione lirica
sono stati tramandati scarsi brani, quasi tutti incompiuti, tuttavia
sufficienti a rilevare nelle sue composizioni una tecnica unica, un
sentimento che sgorga dal profondo dell’anima assetata di amore e di
bellezza,
che
investe
ed
anima
personaggi
e
cose.
Tecnica caratteristica è quella di trarre materia ed occasione del suo canto
dalle scene di vita quotidiana per trasfigurarle in un mondo fantastico, in
cui trionfano, in perfetta armonia ed equilibrio di colori ed immagini, la
bellezza, l’amore e la luce.
Saffo, come tutti gli antichi, viveva la natura in un ‘aura di sacralità, sole,
luna, mare, fiori, erano considerati entità sacre che pure le suggerivano
immagini intime di raccoglimento e contemplazione della bellezza.
Ecco, allora, che in un giorno di primavera rievoca un tempio dell’isola di
Creta visitato di persona o che solo le è stato descritto, ed al ricordo si
sovrappone una visione smagliante di colore:
Qui da noi: un tempio venerando,
un pomario di meli deliziosi,
altari dove bruciano profumi
d’incenso, un’acqua
freddissima che suona in mezzo ai rami
dei meli, e le ombre dei rosai
in tutto il posto, e dalle foglie scosse
trabocca sonno,
poi un florido prato, coi cavalli,
i fiori della primavera, aliti
dolcissimi che spirano…
dove Cipride coglie le corone
e delicatamente mesce un nettare
che si mescola nelle grandi feste,
in coppe d’oro…
E nella solitudine di una notte senza luna e senza stelle si riflette la
solitudine del suo animo:
E’ tramontata la luna, e le Pleiadi;
e la notte è a metà, ed il tempo trapassa,
ed io riposo in solitudine.
Anche l’idea della morte nella poesia di Saffo suggerisce armoniose
immagini di serenità e di bellezza, perché per Saffo il regno delle tenebre
non può non avere giardini coperti di fiori e bagnati di rugiada:
E mi prende un desiderio di morire,
e di vedere le rive dell’Acheronte
coperte di rugiada,fiorite di loto.
E grande sensibilità vibra anche nelle liriche dedicate alle amiche del
tiaso; la bellezza di un ‘amica assente, Attide, che spicca a Sardi fra le
donne lidie, suggerisce una visione di cielo notturno in cui brilla l’astro
lunare:
Forse in Sardi
spesso col pensiero qui ritorna
nel tempo che fu nostro: quando
eri per lei come una Dea rivelata,
tanto era felice del tuo canto.
Ora in Lidia è bella fra le donne
come quando il sole è tramontato
e la luna dalle dita di rose
vince tutte le stelle e la sua luce
modula sulle acque del mare
e i campi presi d’erba:
e la rugiada illumina la rosa,
posa sul gracile timo e il trifoglio
simile a fiore.
Solitaria vagando ,esita
A volte se pensa ad Attide:
di desiderio l’anima trasale,
il cuore è aspro.
E d’improvviso: "Venite!"urla;
e questa voce non ignota
a noi per sillabe risuona
scorrendo sopra il mare.
Il tema predominante affrontato è sempre quello dell’amore, considerato
da Saffo il più potente dei sentimenti umani, il cui ruolo è determinante
nella vita e nell’educazione del tiaso, e colto in tutte le sue sfumature, sia
quello travolgente della passione sia quello del turbamento adolescenziale
della fanciulla che lo confida alla madre:
Mammina mia,
non posso più battere
il telaio,
stregata dall’amore
per un ragazzo
per opera della languida Afrodite.
Il tiaso diretto da Saffo era consacrato alle Muse e ad Afrodite, non
stupisce perciò che nei versi della poetessa compaia spesso la dea come
presenza benevola. Famosa fin dall’antichità è la composizione dedicata
appunto ad Afrodite, un inno d’invocazione, una preghiera tradizionale
nella forma ma innovativa nel contenuto, poco religiosa, giacché poetessa
e dea sono poste in diretto rapporto confidenziale, in dolce patto
d’alleanza, fino ad annullare, con complicità tipicamente femminile, la
distanza tra umano e divino:
Afrodite immortale dal trono variopinto,
figlia di Zeus, insidiosa, ti supplico,
non distruggermi il cuore di disgusti,
Signora, e d’ansie,
ma vieni qui, come venisti ancora,
udendo la mia voce da lontano,
e uscivi dalla casa tutta d’oro
del Padre tuo:
prendevi il cocchio e leggiadri uccelli veloci
ti portavano sulla terra nera
fitte agitando le ali giù dal cielo
in mezzo all’aria,
ed erano già qui: e tu, o felice,
sorridendo dal tuo volto immortale,
mi chiedevi perché soffrissi ancora,
chiamavo ancora,
che cosa più di tutto questo cuore
folle desiderava: "chi vuoi ora
che convinca ad amarti? Saffo,dimmi,
chi ti fa male?
Se ora ti sfugge, presto ti cercherà,
se non vuole i tuoi doni ne farà,
se non ti ama presto ti amerà,
anche se non vorrai".
Vieni anche adesso, toglimi di pena.
Ciò che il cuore desidera che avvenga,
fa’ tu che avvenga. Sii proprio tu
la mia alleata.
Nei versi che seguono, frammenti intensi e suggestivi che pure esaltano il
sentimento amoroso, l’amore s’impone invece come forza, in profonda
analisi psicologica:
Eros mi ha squassato la mente
come il vento del monte
si scaglia sulle querce.
Nel canto di Saffo, come in tutta la letteratura greca, ritroviamo anche la
caratteristica
dell’erotismo,
spesso
censurata
dall’interpretazione
moderna, eppure l’eros, da Omero fino alla produzione ellenistica, fu
elemento ben presente in molteplici aspetti, eliminato dalla letteratura
ufficiale solo con l’avvento dell’ebraismo e soprattutto del Cristianesimo.
Per meglio comprendere il rapporto che i Greci avevano con l’eros è
necessario ricordare che differente fu il loro concetto di morale, la nostra
cultura confina l’eros nel tabù, invece i Greci lo legavano alla religiosità
tradizionale e lo vivevano come rito della fecondità e celebrazione
misterica; inoltre non separavano rigidamente l’eros eterosessuale da
quello omosessuale, frequenti sono infatti nell’Iliade le allusioni ai
legami omoerotici, come quelli tra Achille e Patroclo, e la stessa figura di
Elena
è
rappresentata
come
intrisa
di
irresistibile
sensualità.
Per quanto riguarda gli uomini sono i dialoghi di Platone ad attestare
l’esistenza dell’erotismo maschile, ma anche in molte commedie di
Aristofane, come la Lisistrata, si ritrova conferma della libertà
dell’erotismo nella cultura greca, come pure è testimoniata la pratica
dell’incesto nella riflessione della poesia tragica, dall’Edipo Re di
Sofocle agli epigrammi e al romanzo dell’età ellenistica, che affrontavano
l’eros in tutti i suoi aspetti.
Fu, poi, con la diffusione della cultura giudaico- cristiana, e soprattutto
con quella del cristianesimo, che le tematiche dell’erotismo vennero
emarginate e addirittura eliminate fino a compromettere la stessa corretta
comprensione del patrimonio culturale greco.
E’ con Saffo che, per la prima volta nella storia della letteratura, abbiamo
la rappresentazione dell’erotismo femminile (definito col tempo, con
connotazione
denigratoria,
"saffico"),
ma
che
è
semplicemente
espressione dell’eros vissuto legittimamente e in normalità nella cultura
greca, ed è per questo che cantò con schiettezza l’amore, anche verso le
sue amiche del tiaso, senza veli e ritrosie, proprio per la diversa moralità
della cultura greca .
Saffo esercitò una notevole influenza sui suoi contemporanei, soprattutto
su Alceo, Teognide, Bacchilide e Teocrito, e Strabone così si espresse su
di lei: Saffo, un essere meraviglioso! Chè in tutto il passato, di cui si ha
memoria, non appare che sia esistita mai una donna, la quale potesse
gareggiare con lei nella poesia, nemmeno da lontano; la sua fama
eguagliò quella di Omero eppure, proprio quando era più ammirata,
cominciò ad essere infangata.
I suoi versi, in cui la rievocazione delle scene è sempre limpida e chiara,
come sincero fu il sentimento ispiratore dei versi, l’amicizia che la legava
alle sue compagne, furono spesso denigrati fin dall’antichità: basti
pensare ad Orazio che definì Saffo dispregiativamente mascula.
Il processo denigratorio nei suoi confronti risale, però, ai commediografi
attici, che l’accusarono di cattivi costumi, di bruttezza fisica e che
arrivarono persino ad attribuirle un suicidio per amore dalla rupe di
Leucade (come riprende Leopardi) perché invaghitasi senza speranza del
bellissimo Faone; più onesti e sinceri gli entusiasmi di Platone, che
chiamarono Saffo bella e saggia, di Teofrasto che ne rilevò la grazia, e di
Plutarco
che
ne
attestò
l’ardore
del
cuore.
Grazia, soavità e passione: sono queste le caratteristiche della poesia di
Saffo. Il suo amore fu squisitamente femminile, investì tutto ciò che la
circondava, in delicatezza e levità, tanto che ancora oggi può essere
considerata la più grande poetessa di tutti i tempi perché nessuna donna
ha saputo cantare l’amore come lei, in purezza e sincerità.
UNITA’ 3
PARTE 5 I GRANDI TRAGICI
La tragedia greca è un genere teatrale nato nell'antica Grecia. Sorta dai
riti sacri della Grecia e dell'Asia minore raggiunse la sua forma più
significativa nell'Atene del V secolo a.C.. Precisamente, la tragedia è
l'estensione in senso drammatico, cioè secondo criteri prettamente
teatrali, di antichi riti in onore di un dio. Come tale fu tramandata fino al
romanticismo, che apre, molto di più di quanto non avesse fatto il
Rinascimento, la discussione sui generi letterari.
In seguito a questa lunga evoluzione nel corso di oltre duemila anni,
riesce arduo dare una definizione univoca al termine più generale di
tragedia, a seconda dell'epoca storica o dell'autore. Nel medioevo, quando
poco o nulla si sapeva del genere, il termine assunse il significato di
opera a stile tragico, e stile tragico divenne sinonimo abbastanza generico
di poesia o stile alto, illustre, come traspare nel De Vulgari Eloquentia di
Dante Alighieri.
Il motivo della tragedia greca è strettamente connesso con l'epica, cioè il
mito, ma dal punto di vista della comunicazione la tragedia sviluppa
mezzi del tutto nuovi: il mythos (µύθος, parola, racconto) si fonde con
l'azione, cioè con la rappresentazione diretta (δρᾶµα, dramma, deriva da
δρὰω, agire), in cui il pubblico vede con i propri occhi i personaggi che
compaiono come entità distinte che agiscono autonomamente sulla scena
(σκηνή, in origine il tendone dei banchetti), provvisti ciascuno di una
propria dimensione psicologica.
I più importanti e riconosciuti autori di tragedie furono Eschilo, Sofocle
ed Euripide, che in diversi momenti storici, affrontarono i temi più sentiti
della loro epoca.
Origine ed evoluzione della tragedia
Il «canto caprino»
L'origine della tragedia greca è uno dei tradizionali problemi irrisolti
della filologia classica. La fonte primaria di questo dibattito è la Poetica
di Aristotele. L'autore poté raccogliere una documentazione di prima
mano, a noi oggi inaccessibile, sulle fasi più antiche del teatro in Attica,
la sua opera è dunque contributo inestimabile per lo studio della tragedia
antica.
All'origine della tragedia gli antropologi avrebbero individuato, come
appunto sembrerebbe confermare l'etimologia stessa della parola, un rito
sacrificale propiziatorio in cui molte popolazioni tribali offrono ancora
oggi animali agli déi, soprattutto in attesa della messe o di una partita di
caccia. Momenti cruciali che scandivano la vita degli antichi erano infatti
i mutamenti astrali (equinozi e solstizi che segnavano il passaggio da una
stagione all'altra). I sacrifici avvenivano dunque in questi momenti, ad
esempio poco prima dell'equinozio primaverile, per assicurarsi l'avvento
della buona stagione. In epoca preistorica recente, tali sacrifici dovettero
trasformarsi in danze rituali in cui era raffigurata la lotta primordiale del
bene, il giorno, la luce, quindi la bella stagione, contro il male (la notte e
l'inverno), e il trionfo finale del bene sul male.
Rimangono però molti punti oscuri sull'origine della tragedia, a partire
dall'etimologia stessa della parola trago(i)día (τραγῳδία): si distinguono
in essa le radici di "capro" (τράγος / trágos) e "cantare" (ᾄδω / á(i)dô),
sarebbe quindi il "canto per il capro". Il senso da attribuire al "capro" è
ancora oggetto di numerose interpretazioni; di certo, l'animale (sia esso
capretto o agnello) è da intendersi come primizia da offrire, come bene
del quale l'uomo si priva in un momento sacro (sia che esso venga offerto
al dio stesso come vittima sacrificale, e si ricordi che il capretto è animale
sacro a Dioniso , sia che esso sia premio consegnato al vincitore dell'
agone tragico che si svolgeva durante le feste in onore di Dioniso). Una
teoria più recente (J. Winkler) fa derivare "tragedia" dal vocabolo raro
traghìzein (τραγὶζειν), che significa "cambiare voce, assumere una voce
belante come i capretti", in riferimento agli attori. A meno che,
suggerisce D'Amico, tragoidía non significhi più semplicemente «canto
dei capri», dai personaggi satireschi che componevano il coro delle prime
azioni sacre dionisiache. Altre ipotesi sono state tentate, in passato, tra
cui una etimologia che definirebbe la tragedia come un'ode alla birra.
Quello che è possibile affermare con certezza è che la radice trag- (τραγ), anche prima di riferirsi al dramma tragico, fu utilizzata per significare
l'essere "simile ad un capro", ma anche la selvatichezza, la libidine, il
piacere del cibo, in una serie di parole derivate che gravitano intorno alla
«zona» linguistica del rito dionisiaco.
Dal ditirambo al dramma
Scrive Aristotele nella Poetica che la tragedia nasce all'inizio
dall'improvvisazione, precisamente "da coloro che intonano il ditirambo"
(ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντων τὸν διθύραµβον, apò tōn exarchòntōn tòn
ditýrambon), un canto corale in onore di Dioniso. All'inizio queste
manifestazioni erano brevi e di tono burlesco perché contenevano degli
elementi satireschi; poi il linguaggio si fece man mano più grave e
cambiò anche il metro, che da tetrametro trocaico, il verso più prosaico,
divenne trimetro giambico. Questa informazione è completata da un
passo delle Storie (I, 23) di Erodoto e da fonti successive, in cui il lirico
Arione come è definito inventore della tragedia e compositore di
ditirambi
Il Ditirambo, in origine improvvisato, assume poi una forma scritta e
prestabilita. Il coro s'indirizzava a thymele (θυµέλη), l'ara sacrificale, e
cantava in cerchio, disponendosi intorno ad essa.
Ad un certo momento dal coro che intonava questo canto in onore di
Dioniso il corifeo, cioè il capocoro, si sarebbe staccato e avrebbe
cominciato a dialogare con questo, diventando così un vero e proprio
personaggio; in seguito il coro stesso, sdoppiandosi in due semicori,
diede vita a un dialogo tra i due corifei, e venne introdotto un hypocritès
(ὑποκριτής, risponditore, in seguito significherà attore), che pronunciava
le parole di Dioniso, rivolte al coro: è la nascita del dramma. Da canto
epico-lirico, il ditirambo diventa teatro.
Mentre nasceva e si strutturava la tragedia vera e propria, lo spirito più
popolare dei riti e delle danza dionisiache sopravvissero nel dramma
satiresco.
Le prime tragedie
La tradizione attribuisce a Tespi la prima rappresentazione tragica,
avvenuta nel 534 a.C. durante le Dionisie. Si presuppone che fosse attico,
appartenente al demo di Icaria. Delle sue tragedie sappiamo poco, se non
che il coro era ancora formato da satiri e che fu certamente il primo a
vincere un concorso drammatico; Aristotele sostiene che introdusse
l'attore (ὑποκρίτης) che rispondeva al coro. Inoltre Temistio, scrittore del
IV secolo a.C., riferisce che sempre secondo Aristotele Tespi inventò il
prologo e la parte parlata (ῥῆσις). Gli altri drammaturghi dell'epoca
furono Cherilo, autore di probabilmente centosessanta tragedie (con
tredici vittorie), e Pràtina di Fliunte autore di cinquanta opere di cui 32
drammi satireschi, di cui però sono pervenuti solo i titoli. Da quel
momento i drammi satireschi affiancarono la rappresentazione delle
tragedie. Pratina gareggiò sicuramente con Eschilo e operò dal 499 a.C.
Di Frinico cominciamo ad avere maggiori informazioni. Aristofane ne
tesse le lodi nelle sue commedie, nelle "Vespe" lo presenta come un
democratico radicale vicino a Temistocle. Oltre a introdurre nei dialoghi
il trimetro giambico e ad utilizzare per la prima volta personaggi
femminili, inventò il genere della tragedia ad argomento storico (La presa
di Mileto), introducendo una seconda parte: ci si avviava, quindi alla
trilogia, che sarà definitivamente adottata da Eschilo e dai suoi
contemporanei. La sua prima vittoria in un agone accadde nel 510 a.C..
Eschilo: la codificazione
Sarebbe stato Eschilo a fissare le regole fondamentali del dramma
tragico. Regista, oltre che poeta, a lui viene attribuita l'introduzione di
maschera e coturni e inoltre è con lui che prende l'avvio la trilogia.
Introducendo un secondo attore, rese possibile la drammatizzazione di un
conflitto. La rappresentazione della tragedia assume una durata definita
(dall'alba al tramonto, nella realtà come nella finzione), e nella stessa
giornata viene presentata una trilogia, nella quale le tre parti sono
"puntate" della medesima storia.
Nella sua opera, confrontando le prime tragedie con quelle di anni
successivi, notiamo una evoluzione e un arricchimento degli elementi
propri del dramma tragico: dialoghi, contrasti, effetti teatrali. Questo si
deve anche alla competizione che il vecchio Eschilo deve sostenere nelle
gare drammatiche: c'è un giovane rivale, Sofocle, che gli contende la
popolarità, e che ha introdotto un terzo attore, ha complicato le trame,
sviluppato caratteri più umani, nei quali il pubblico può identificarsi.
Tuttavia, anche accettando in parte, e con riluttanza, le nuove
innovazioni, Eschilo rimane sempre fedele ad un estremo rigore, alla
religiosità quasi monoteistica (Zeus, nelle opere di Eschilo, è
rappresentato talvolta come un tiranno, talvolta come un dio onnipotente,
con qualche somiglianza con il biblico Yahweh). Nonostante i personaggi
di Eschilo non siano sempre unicamente eroi, quasi tutti hanno
caratteristiche superiori all'umano. Se ci sono elementi reali, questi non
sono mai rappresentati nella loro quotidianità, ma in una suprema
sublimazione.
Le riforme di Sofocle
Plutarco, nella Vita di Cimone, racconta il primo trionfo del giovane
talentuoso Sofocle contro il celebre e fino a quel momento incontrastato
Eschilo, conclusasi in modo insolito, senza il consueto sorteggio degli
arbitri, e che provocò il volontario esilio di Eschilo in Sicilia. Le
innovazioni che Sofocle introdusse, e che gli guadagnarono almeno venti
trionfi, riguardarono molti aspetti della rappresentazione tragica, dai
dettagli più insignificanti (come i calzari bianchi e i bastoni ricurvi) fino a
riforme più dense di conseguenze. Introdusse un terzo attore, che
permetteva alla tragedia di moltiplicare il numero dei personaggi
possibili, aumentò a quindici il numero dei coreuti, ruppe l'obbligo della
trilogia, rendendo possibile la rappresentazione di drammi autonomi,
introdusse l'uso di scenografie. Rispetto a Eschilo, i cori tragici sofoclei si
defilano dall'azione, partecipano sempre meno attivamente e diventano
piuttosto spettatori e commentatori dei fatti. È di Sofocle l'introduzione
del monologo (ad es. quelli di Aiace o di Edipo), le lunghe 'tirate' che
permettono all'attore di mostrare la sua abilità, e al personaggio di
esprimere compiutamente i propri pensieri. La psicologia dei personaggi
si approfondisce, emerge una inedita analisi della realtà e dell'uomo.
Sofocle tentò di togliere l'enfasi (ónkos / ὄγκος) ai suoi personaggi, per
restituirgli completamente la drammaticità, in un mondo descritto come
ingiusto e privo di luce. Nell'Edipo a Colono, il coro ripete «la sorte
migliore è non nascere». Gli eventi che schiacciano le esistenze degli eroi
non sono in alcun modo spiegabili o giustificabili, e in questo possiamo
vedere l'inizio di una sofferta riflessione sulla condizione umana, ancora
attuale nel mondo contemporaneo.
Il realismo euripideo
Le peculiarità che distinguono le tragedie euripidee da quelle degli altri
due drammaturghi sono da un lato la ricerca di sperimentazione tecnica
attuata da Euripide in quasi tutte le sue opere e la maggiore attenzione
che egli pone nella descrizione dei sentimenti, di cui analizza l'evoluzione
che segue il mutare degli eventi narrati.
La novità assoluta del teatro euripideo è comunque rappresentata dal
realismo con il quale il drammaturgo tratteggia le dinamiche psicologiche
dei suoi personaggi. L'eroe descritto nelle sue tragedie non è più il
risoluto protagonista dei drammi di Eschilo e Sofocle, ma sovente una
persona problematica ed insicura, non priva di conflitti interiori.
Le protagoniste femminili dei drammi, come Andromaca, Fedra e Medea,
sono le nuove figure tragiche di Euripide, il quale ne tratteggia
sapientemente la tormentata sensibilità e le pulsioni irrazionali che si
scontrano con il mondo della ragione.
Struttura della tragedia
La tragedia greca è strutturata secondo uno schema rigido, di cui si
possono definire le forme con precisione. La tragedia inizia generalmente
con un prologo (da prò e logos, discorso preliminare), che ha la funzione
di introdurre il dramma; segue la parodo (ἡ πάροδος), che consiste
nell'entrata in scena del coro attraverso dei corridoi laterali, le pàrodoi;
l'azione scenica vera e propria si dispiega quindi attraverso tre o più
episodi (epeisòdia), intervallati dagli stasimi, degli intermezzi in cui il
coro commenta, illustra o analizza la situazione che si sta sviluppando
sulla scena; la tragedia si conclude con l'esodo (èxodos).
UNITA’ 3
PARTE 6 PINDARO
Biografia
Il più grande esponente della lirica corale arcaica nacque a Cinocefale,
vicino a Tebe, attorno al 520 - 518 a.C., dalla nobile famiglia degli Egidi,
originari di Sparta e fondatori del culto gentilizio di Apollo Carneo.
Secondo una tradizione, che non siamo in grado di confermare con
certezza, egli sarebbe stato avviato alla poesia da due poetesse beotiche,
Mirtide di Antedone e Corinna di Tanagra (la prima è praticamente ignota
e la seconda, soprannominata “mosca”, forse per il suo cicaleccio, fu
autrice per gli alessandrini di almeno cinque libri, comprendenti in
prevalenza nomoi monodici, “canti da vecchierelle”, epigrammi); ma se
anche gli aneddoti tramandati in proposito dalle fonti antiche
corrispondessero a verità è indubitabile che gli ideali panellenici di
Pindaro e la funzione da lui attribuita al suo canto si siano trovati in
contrasto con quella poesia dalla coloritura spiccatamente locale. Per
questo, il poeta cercò ad Atene altri e più famosi maestri come
Apollodoro, Agatocle e Laso di Ernione; da quest’ultimo, valente
musicologo ed autore di ditirambi, il giovane Pindaro apprese anche il
virtuosismo
tecnico
per
cui
era
meritatamente
famoso.
Nel 498 a.C. il genio precoce di Pindaro diede buona prova di sé,
cantando nella Pitica X, il più antico epinicio giunto fino a noi, la vittoria
del tessalo Ippocle, conquistata a Delfi nella corsa dei ragazzi.
Celebrando la gloria del giovanissimo discendente della nobile stirpe
degli Alevadi, Pindaro iniziava la sua illustre carriera di poeta
aristocratico, cantore dei trionfi agonari degli atleti e degli epigoni delle
più antiche famiglie.
Tuttavia, il periodo centrale della sua lunga esistenza coincise con un
profondo mutamento morale, politico e religioso dell’Ellade, destinato a
scardinare molti dei principi su cui si fondava l’educazione dell’età
arcaica. Erano gli anni delle guerre persiane e l’attenzione del mondo
greco era attratta dalle vicende del conflitto e dalla politica di Atene, che,
grazie al ruolo avuto nella guerra, si avviava a divenire un punto di
riferimento per l’intera Ellade. Pindaro, invece, tutto preso dalla volontà
di celebrare il passato, si sentiva estraneo a questo presente i cui ideali si
andavano sempre più allontanando dai suoi. Neppure l’epico scontro di
Maratona (490 a.C.), destinato ad essere argomento di tanta letteratura
nazionalistica, lasciò traccia nella sua poesia; nella Pitica VI databile
appunto al 490 e dedicata a Senocrate di Agrigento, fratello del tiranno
Terone, per la vittoria nella corsa delle quadrighe, ottenuta dal suo
giovane figlio Trasibulo, non c’è neppure un accenno alla celebre
battaglia. Anzi, dieci anni dopo, nel 480 a.C., la politica di Tebe divenne
apertamente filopersiana; la città, governata da una gruppo di
aristocratici, accolse pacificamente gli inviati di Serse e mandò perfino un
contingente militare a Platea al fianco delle milizie persiane. Pindaro,
appartenente alla medesima classe sociale, venuta a patti con il nemico,
condivise anche l’atteggiamento dei sacerdoti di Delfi, che avevano
interpretato gli oracoli a favore della politica di non opposizione ai
persiani.
Tuttavia i motivi del dissenso di Pindaro erano indipendenti allo sfondo
politico della patria e molto più profondi: si sentiva attratto dall’ideale di
vita eroico, oramai remoto ed in contrasto col regime democratico greco.
Il concetto dell’aristocrazia di razza dominava ancora il suo cuore e lo
spingeva a distaccarsi dalla realtà storica in cui viveva, per ricongiungersi
alla dimensione senza tempo del mito. In essa, il poeta ritrovava gli
archetipi divini o semidivini che accendevano la sua fantasia e che egli
credeva di veder rivivere nelle figure degli atleti vincitori delle gare
olimpiche, sospendendo temporaneamente i contrasti esterni.
Gli anni fra il 476 ed il 460 a.C. furono quelli di più intensa attività: le
città sicule erano una presenza costante nei giochi ed il poeta non esitò ad
esaltarne i tiranni, giungendo a porli sullo stesso piano degli antichi
monarchi, discendenti di Zeus. Con alcuni di loro instaurò profondi
rapporti di amicizia, favoriti dal carattere aperto e dai molteplici interessi
culturali e religiosi di questi ultimi.
Fra gli illustri committenti di Pindaro ricordiamo Ierone di Siracusa, per
il quale compose l’ Olimpica e la Pitica I (476-470). Ma l’amicizia non
durò, sia per il carattere orgoglioso del tiranno, sia per la simpatia che
questi
accordò
a
Simonide
e
Bacchilide
di
Ceo.
Nel 468 Pindaro lasciò la Sicilia, ma nonostante la partenza non gli
vennero a mancare nè celebri protettori nè l’ammirazione del pubblico.
Nel corso dei suoi numerosi viaggi ad Egina, Rodi, Corinto e Ceo, onorò
Telesicrate e Arcesilao, signori di fiorenti colonie.
Dopo il 460 la produzione di Pindaro si fece meno intensa e la sua
creatività poetica assunse un diffuso pessimismo: il mondo ellenico era
profondamente mutato e la democrazia ateniese aveva assunto
definitivamente la funzione di polo politico dell’Ellade, Tebe era stata
sottomessa ed il santuario di Delfi era dominato dai Focesi. Non poteva
cosi sottrarsi ad una visione sempre più triste e delusa dell’esistenza: la
forza creatrice della fantasia era ormai solo un ideale.
Dell’ultima fase della vita di Pindaro non abbiamo notizie certe: secondo
la tradizione antica, il poeta si sarebbe spento ad Argo, ormai ottantenne,
nel 438 fra le braccia di Teosseno, giovane compagno teneramente
amato.
Le opere
Pindaro usa la lingua della lirica corale, ossia il dialetto dorico misto a
elementi eolici, dove compare anche qualche fenomeno del beotico.
Nell’edizione alessandrina la sua produzione, eccezionalmente ampia,
occupava diciassette libri ordinati per generi: Inni, Peani, Prosodi,
Parteni, Iporchemi, Encomi, Treni, Epinici. Sopravvivono integralmente
solo quattro libri degli Epinici, divisi secondo le gare panelleniche di cui
celebravano i vincitori: essi contengono rispettivamente 14 odi
Olimpiche, 12 Pitiche, 11 Nemee, 8 Istmiche. Le altre opere sono note
solo da numerosi frammenti in cui appaiono grandiose descrizioni del
mondo divino, racconti mitici, solenni enunciati etici ed anche tratti di
arguta grazia e voci d’amore.
L’epinicio di Pindaro si articola secondo tre linee tematiche svolte con
grande varietà di motivi: l’elogio, che contiene un succinto riferimento al
vincitore e all’occasione sportiva; il mito, collegato sovente con la
famiglia o con la patria del celebrato, che costituisce la parte di maggiore
ampiezza ed impegno poetico; e la gnome, ossia l’enunciazione di
sentenze religiose e morali. A collegare questi elementi interviene il
richiamo alla performance, ossia all’occasione in cui il carme viene
eseguito.
A fondamento del mondo pindarico sta la convinzione che nella poesia si
manifesti la perfezione assoluta del cosmo e della divinità. Essa istituisce
la gloria del vincitore, esaltando il momento supremo del successo
atletico in cui egli raggiunge la pienezza della sua qualità umana. Questa
circostanza lo allinea agli eroi del mito; e il presente viene così attratto in
una sfera di valori assoluti ed eterni. Alla sublimità di tale concezione
corrisponde uno stile di inaudita tensione, ricco di immagini dotate di
emozionante evidenza. In ampi periodi si collocano enunciati sintetici e
definitivi, che si susseguono secondo drastiche ellissi logiche, affidando
la loro suggestione al sentimento della bellezza, in cui coincidono
l’interpretazione pindarica dell’esistenza umana e della natura divina e
l’esito della sua creazione artistica.
UNITA’ 3
PARTE 7 ARISTOTELE
VITA
Aristotele (Stagira, Macedonia 384 - Calcide, Eubea 322 a.C.), filosofo e
scienziato greco, all'età di diciotto anni si trasferì ad Atene per studiare
presso l'Accademia platonica, dove rimase per vent'anni, dapprima come
allievo di Platone e poi come maestro.
Nel 347 a.C., dopo la morte di Platone, Aristotele si recò ad Atarneo, città
governata dal tiranno Ermia, scolaro dell'Accademia e suo amico; andò
successivamente ad Asso e Mitilene per insegnarvi e svolgervi ricerche
empiriche.
Dopo la morte di Ermia, che venne catturato e ucciso dai persiani nel 345
a.C., Aristotele si recò a Pella, la capitale macedone, dove divenne il
precettore del giovane figlio del re, il futuro Alessandro Magno. Nel 335,
quando Alessandro fu nominato re, Aristotele tornò ad Atene e fondò la
sua scuola, il Liceo. Poiché, secondo la tradizione, gran parte delle lezioni
nella scuola aveva luogo mentre insegnanti e allievi passeggiavano nel
giardino del Liceo, la scuola aristotelica finì per essere soprannominata
"Peripato" (dal greco peripatéin, "camminare" o "passeggiare").
Nel 323 a.C., dopo la morte di Alessandro, ad Atene si diffuse una
profonda ostilità verso la Macedonia, e Aristotele ritenne più prudente
ritirarsi in una tenuta di famiglia in Eubea, dove morì l'anno seguente.
PENSIERO
Nei suoi primi anni all'Accademia, Aristotele, come Platone, si servì
regolarmente della forma argomentativa del dialogo; in questa forma
scrisse le opere cosiddette "esoteriche", rivolte cioè a un pubblico di
allievi selezionati: questi scritti non ci sono pervenuti. Possediamo,
tuttavia, alcuni appunti di cui Aristotele si servì per le lezioni e che fanno
riferimento a insegnamenti aventi come oggetto quasi ogni campo del
sapere.
I testi ai quali Aristotele deve la sua fama si basano in larga misura su
questi appunti, che il curatore Andronico di Rodi dispose in un'edizione il
cui ordine rimase quello noto fino a oggi.
Metodi
Forse a causa degli insegnamenti del padre, che fu medico alla corte del
re macedone Aminta III, la filosofia di Aristotele dà rilievo alla biologia e
alle ricerche di filosofia naturale in contrapposizione all'importanza
attribuita da Platone alla matematica. Aristotele considerò il mondo come
costituito da individui (sostanze) che appartengono a determinati generi
naturali (specie). Ogni individuo ha inscritto in se stesso un preciso
modello di sviluppo e cresce cercando di realizzare convenientemente il
proprio fine naturale: sviluppo, fine e direzione risultano così intrinseci
alla natura di ciascuno.
Secondo Aristotele, anche se la scienza è dedita all'identificazione dei
generi fondamentali, questi generi si possono cogliere nell'esperienza
solo studiando le sostanze individuali; scienza e filosofia pertanto devono
bilanciare le pretese dell'empirismo (osservazione ed esperienza
sensibile) e quelle del formalismo (deduzione razionale).
Uno dei contributi più caratteristici della filosofia aristotelica fu la
nozione di causalità. Secondo Aristotele, a ogni ente o evento si deve
assegnare più di una "ragione" in grado di spiegare che cosa, perché e
dove esso sia. Gli antichi pensatori greci erano inclini a supporre che un
solo genere di causa potesse rendere conto delle cose; Aristotele ne
propose quattro. (Il termine da lui usato, aítion, "un fattore di spiegazione
responsabile della condizione di qualcosa", non è sinonimo del termine
"causa" nel suo significato moderno.) Queste quattro cause sono la "causa
materiale", la materia di cui è costituito un oggetto; la "causa efficiente",
il principio del movimento, della nascita, o del mutamento; la "causa
formale", che coincide con la specie, il genere o il tipo; e la "causa
finale", il fine, il pieno sviluppo di un individuo o la funzione propria di
una costruzione o invenzione.
In ogni ambito della ricerca, Aristotele insiste sul fatto che si può
comprendere meglio qualunque cosa quando è possibile stabilire le cause
che la riguardano in termini specifici piuttosto che in termini generali.
Così, è più preciso sapere che una statua è stata cesellata da uno scultore
piuttosto che da un artista; ed è ancora più preciso sapere che l'ha
cesellata Policleto piuttosto che, semplicemente, uno scultore non meglio
identificato.
Dottrine
Il seguente sunto delle dottrine di Aristotele illustra alcuni degli aspetti
principali del suo pensiero.
Metafisica
In metafisica, Aristotele affermò l'esistenza di un essere divino, definito
"motore immobile", che è causa dell'unità e del fine che si prefigge la
natura. Questa entità è perfetta ed è perciò l'aspirazione di tutte le cose
del mondo, poiché tutti gli enti desiderano essere partecipi della
perfezione.
Esistono anche altri motori - le intelligenze motrici dei pianeti e delle
stelle; tuttavia, il motore immobile, che nella tradizione filosofica
medievale è stato identificato senza alcun dubbio con Dio, nella
descrizione di Aristotele non è suscettibile di interpretazioni religiose,
come hanno osservato molti filosofi e teologi più recenti. Il motore
immobile, ad esempio, non è interessato a ciò che accade nel mondo, né
ha creato il mondo. Aristotele limitò, comunque, la sua "teologia", a ciò
che la scienza, a suo parere, richiede e può dimostrare.
Logica
In logica, Aristotele enunciò regole di inferenza che, se rispettate, non
avrebbero mai condotto da premesse vere a conclusioni false (regole di
validità). Gli elementi fondamentali dell'inferenza in questione sono
sillogismi: proposizioni che, se considerate una in relazione all'altra,
generano necessariamente una determinata conclusione. La scienza è il
risultato della costruzione di sistemi più complessi di ragionamento.
Nelle sue opere logiche Aristotele distinse tra dialettica e analitica. Egli
sostenne che la dialettica esamina gli argomenti unicamente in merito ai
criteri di coerenza; l'analitica procede invece deduttivamente a partire da
principi che si fondano sull'esperienza e su una scrupolosa osservazione.
Fisica, o filosofia naturale
In astronomia Aristotele concepì un universo finito di forma sferica, con
la Terra posta in un centro costituito da quattro elementi: terra, aria,
acqua e fuoco. Nella fisica aristotelica ognuno di questi elementi occupa
un luogo particolare, determinato in base alla sua pesantezza relativa, o,
come diciamo oggi, al suo "peso specifico". Ognuno di essi si muove
secondo la sua natura in linea retta - la terra verso il basso, il fuoco verso
l'alto - verso il suo luogo specifico, dove raggiungerà lo stato di quiete;
sulla Terra il moto locale, pertanto, è sempre lineare e ha sempre termine.
I cieli, invece, ruotano incessantemente per loro natura secondo un
complesso moto circolare e devono, pertanto, essere costituiti da un
quinto elemento diverso dagli altri, denominato aither (etere). Essendo un
elemento superiore, l'aither è incapace di qualunque altro mutamento che
non sia un mutamento di luogo con moto circolare.
Biologia
In zoologia, Aristotele si riferì a un determinato sistema di generi naturali
("specie"), ciascuno dei quali si riproduce in conformità al proprio tipo,
tranne nel caso di alcune eccezioni. I cicli tipici di vita sono epicicloidali:
si ripete il medesimo modello, ma attraverso una successione lineare di
individui. Questi processi sono dunque collocati a metà tra il movimento
circolare e costante dei cieli e il semplice movimento lineare degli
elementi terrestri.
Le specie costituiscono una scala graduata che si estende dal semplice
(vermi e mosche al gradino più basso) al complesso (esseri umani al
gradino più alto), pur nell'impossibilità di qualsiasi evoluzione.
La psicologia aristotelica
Per Aristotele, la psicologia era lo studio delle funzioni dell'anima.
Sottolineando che "forma" (l'essenza o gli elementi invarianti
caratteristici di un oggetto) e "materia" (il comune e indifferenziato
substratum delle cose) non possono esistere l'una senza l'altra, Aristotele
definì l'anima come "quella particolare funzione del corpo che è costituita
in modo tale da poter svolgere le operazioni vitali". La dottrina di
Aristotele è una sintesi tra la concezione più arcaica secondo la quale
l'anima non può esistere indipendentemente dal corpo e la concezione
platonica dell'anima come entità separata e immateriale.
Etica e politica
Le scienze pratiche come la politica o l'etica assunsero invece lo status di
"scienza" unicamente per analogia, come dimostrano le nozioni
aristoteliche di "natura umana" e "realizzazione di sé": l'appartenenza alla
natura umana comporta per ognuno la capacità di assumere abitudini che,
tuttavia, dipendono dalla cultura e dalle scelte individuali; tutti gli uomini
desiderano la "felicità", una piena realizzazione delle loro potenzialità,
ma questo fine può essere conseguito in molteplici modi.
L'Etica nicomachea è un'analisi del carattere e dell'intelletto in relazione
alla felicità. Aristotele distinse due tipi di "virtù", o perfezione umana:
morale e intellettuale. La virtù morale è una disposizione del carattere,
prodotta da abitudini che riflettono l'adozione permanente di scelte
considerate moralmente preferibili, e costituisce sempre il giusto mezzo
fra due estremi meno consigliabili. Le virtù intellettuali, invece, non sono
soggette a questa dottrina del giusto mezzo.
In politica, ovviamente, si possono trovare molte forme del vivere umano
associato; quale sia quella conveniente dipende da circostanze contingenti
e mutevoli.
Aristotele non considerò la politica come una ricerca del modello ideale
di comunità politica, ma piuttosto come un esame del rapporto fra esempi
concreti di comunità politica da una parte e leggi, costumi e
caratteristiche ideali dello stato dall'altra. Così, benché avesse accettato
l'istituzione a lui contemporanea dello schiavismo, egli moderò la sua
approvazione insistendo sul fatto che i padroni non dovrebbero abusare
della loro autorità, poiché gli interessi dei padroni e quelli degli schiavi
sono i medesimi.
La biblioteca del Liceo conteneva una raccolta di 158 costituzioni sia
greche sia di altri stati, tra le quali la Costituzione degli ateniesi scritta
dallo stesso Aristotele, della quale fu scoperta una copia scritta su papiro
nel 1890. L'opera è stata di grande aiuto a vari storici nella ricostruzione
di molte fasi della storia di Atene.
Poetica
Così come la retorica, esaminata nell'omonimo scritto aristotelico, è
considerata estremamente importante per la prassi politica e la vita
quotidiana del cittadino, la Poetica, di cui possediamo un solo libro
rispetto ai due di cui si componeva originariamente, presenta la visione
dell'arte (in particolare dell'arte tragica) dello stagirita.
L'arte è considerata un'imitazione della natura secondo verosimiglianza,
che arreca diletto e nel contempo trasmette conoscenza. L'arte tragica, in
particolare, mette in scena le passioni umane, lasciando comunque
trapelare un ordine razionale nel susseguirsi degli eventi. Lo spettatore,
per via della verosimiglianza del materiale tragico, è spinto a
immedesimarsi nella vicenda fino a ottenere la "catarsi", un liberatorio
distacco dalle passioni rappresentate, che interviene nel momento in cui si
coglie la razionalità celata negli eventi. Proprio per questo valore
conoscitivo la poesia è "più filosofica" della storia.
Aristotele è anche noto per aver formulato la dottrina delle "tre unità"
della tragedia (di luogo, di tempo e di azione) che hanno dominato
incontrastate la storia della drammaturgia fino al nostro secolo.
Nella tradizione filosofica occidentale gli scritti di Aristotele furono
tramandati soprattutto grazie all'opera di Alessandro di Afrodisia, Porfirio
e Boezio.
Durante il IX secolo d.C. alcuni studiosi arabi diffusero le opere di
Aristotele nel mondo islamico in traduzione araba. Il filosofo arabo
Averroè è il più noto fra gli studiosi e commentatori arabi di Aristotele.
Nel XIII secolo, proprio a partire da queste traduzioni, l'Occidente latino
rinnovò il proprio interesse per gli scritti di Aristotele e san Tommaso
d'Aquino trovò in essi un fondamento filosofico per il pensiero cristiano.
L'influenza della filosofia aristotelica è stata notevole e ha perfino
contribuito a forgiare il linguaggio e il senso comune della modernità: la
sua dottrina del motore immobile quale causa finale ha esercitato un ruolo
fondamentale in ogni sistema di pensiero basato su una concezione
teleologica dei fenomeni naturali e per secoli il termine "logica" fu
sinonimo di "logica aristotelica".
Si può dire che Aristotele abbia contribuito in modo determinante a
costituire frammenti dispersi nelle discipline sistematiche e nei saperi
metodologicamente ordinati quali l'Occidente li intende.
Nel XX secolo si ebbe una nuova reinterpretazione del metodo
aristotelico che fu una riscoperta della sua rilevanza per la cosmologia, la
pedagogia, la critica letteraria e la teoria della politica.
OPERE
Le opere di Aristotele pervenute fino a noi fanno parte delle lezioni
tenute all'Accademia ed al Liceo. In parte furono redatte dai suoi allievi,
lo stile non è quindi sistematico, e talvolta oscuro, anche, se nel
complesso, si presentano come un tentativo di sistematizzare tutto il
sapere filosofico e scientifico del tempo, e di fissare le regole del
ragionare e dell'esprimersi.
Si possono suddividere in due grandi categorie:
- scritti acromatici o esoterici (rivolti agli allievi)
- scritti essoterici (destinati al pubblico)
Le opere essoteriche, destinate alla pubblicazione, sono andate in buona
parte perdute (ci restano solo pochi frammenti e alcuni titoli) e ci sono
note solo attraverso testimonianze e citazioni di altri autori.
Ci sono invece pervenuti gli scritti (detti esoterici) dei quali Aristotele si
servì nelle sue lezioni, rivolte a un pubblico selezionato di allievi. La
fama di Aristotele è dovuta essenzialmente a questo secondo gruppo di
opere, che fanno riferimento a insegnamenti relativi a quasi ogni campo
del sapere.
Gli scritti acromatici possono essere così raggruppati:
1. I Trattati di logica
denominati Organon ("strumento"), poiché forniscono i mezzi mediante i
quali è possibile ottenere una conoscenza certa: Categorie,
Interpretazione, Analitici primi (sul sillogismo), Analitici secondi (sulla
dimostrazione), Topici (sulla dialettica) e Confutazioni sofistiche (lo
studio dei metodi contraffatti del confutare).
2. Opere di fisica:
Fisica (fenomeni della natura e la loro interpretazione), Il cielo
(astronomia e cosmologia), Nascita e morte, Meteorologia, Storia degli
animali, Generazione degli animali (genetica), Parti degli animali
(anatomia e fisiologia), Locomozione degli animali, L'anima (brevi
trattati di psicofisiologia), Il senso, La memoria.
3. Metafisica (sui problemi filosofici della fisica).
Riguardano il fine e gli attributi dell'essere, la trattazione del motore
immobile, o causa prima, che nell'opera aristotelica viene inteso come
intelletto puro, perfetto nella sua unità, immutabile (nell'edizione di
Andronico furono raccolti sotto il titolo di Metafisica, poiché erano
collocati dopo, in greco méta, la Fisica)
4. Opere morali, politiche, di poetica e di retorica:
Etica eudemea, Etica nicomachea, Grande etica, Politica (l'arte del
governare lo stato), Poetica (l'arte e le regole di scrivere in versi),
Retorica (l'arte del parlare e dello scrivere, consistente nel sapere esporre
con eleganza le proprie idee, disponendole secondo schemi logici),
Costituzione degli ateniesi.
UNITA’ 3
PARTE 8 LA SOFISTICA
Si possono individuare sette caratteri dominanti della sofistica (il nome
deriva da sophía: sapienza, in quanto coloro che la professano si
proclamano "sapienti").
1. I sofisti colgono il momento di crisi della filosofia della natura, che
non trova alcun accordo sui principi di fondo, e spostano l'asse tematico
della filosofia dallo studio del cosmo a quello dell'uomo, come essere
individuale e come membro della società (interpretando così l'evoluzione
storica di molte città-stato, e in particolare di Atene, con l'ascesa della
classe popolare).
2. Dal punto di vista metodologico sostituiscono il metodo deduttivo (che
da una proposizione generale "deduce" gli aspetti particolari) con quello
induttivo (che costruisce la proposizione generale a partire dagli aspetti
particolari), prestando una particolare attenzione all'esperienza e
all'osservazione dei fatti umani.
3. Alla conoscenza, pertanto, attribuiscono finalità pratiche, di
conoscenza morale, e non più teoretiche, di speculazione sulla natura e
sull'essere.
4. Questa prospettiva pratica si traduce per lo più in un impegno
educativo e pedagogico, rivoluzionario perché teso a insegnare la virtù
(areté), che fino ad allora era ritenuta ereditaria e non insegnabile.
5. I sofisti si qualificano come educatori professionisti, maestri di virtù,
che pretendono un compenso per le loro prestazioni.
6. I sofisti sono portatori di un ideale panellenico, di per sé innovativo,
perché non si sentono legati a una data pólis e viaggiano di città in città in
tutto il mondo greco.
7. Infine, il decisivo carattere della sofistica può essere identificato
nell'uso spregiudicato della ragione, rivolto alla critica di ogni istituzione,
convenzione e anche dogma filosofico che non sia completamente
fondato. Il risultato di questa loro attitudine è un prevalente relativismo in
ambito etico, conoscitivo e culturale (il bene e il male, il vero e il falso
non sono ritenuti assoluti, poiché i valori che presiedono alle diverse
civiltà umane sono i più disparati) e un'attitudine utilitaristica (solo la
ricerca dell'utile per sé e per la pólis può ragionevolmente guidare
l'azione umana).
UNITA’ 3
PARTE 9 ERODOTO
Figlio di Lisse e congiunto del poeta epico Paniassi, nacque ad
Alicarnasso di Caria nel 484 ca a.C., all'epoca in cui la regione era
dominata da una dinastia fedele alla Persia. La famiglia di Erodoto prese
parte alla insurrezione contro il regime; Paniassi vi perse la vita ed
Erodoto dovette riparare a Samo. Dopo numerosi viaggi di studio che lo
portarono dalla Mesopotamia alla Scizia, all'Egeo settentrionale, giunse
ad Atene. Conobbe Sofocle ed entrò in contatto con la cerchia
d'intellettuali attivi intorno a Pericle, per impulso del quale, tra l'altro, fu
fondata nel 444-443 a.C. la colonia di Turi in Magna Grecia, nella quale
Erodoto si trasferì, all'atto della fondazione della città o forse subito
dopo. Non è nota la data della sua morte, che dovette comunque essere
posteriore al 430, visto che Erodoto mostra di conoscere vicende relative
alla prima fase della guerra del Peloponneso. È anche discusso se sia
morto a Turi o ad Atene, dove forse avrebbe fatto ritorno.
• Le Storie
L'opera erodotea non possedeva all'origine un titolo: il termine “storia”
(in greco historía, ricerca, indagine) è desunto delle prime righe della sua
introduzione. Non è dovuta a Erodoto, bensì ai filologi alessandrini, la
partizione dell'opera in nove libri, ciascuno dei quali fu intitolato al nome
di una musa. L'articolazione della materia e soprattutto la frequenza delle
digressioni ha fatto ritenere che l'opera erodotea non sia nata da un
progetto unitario, ma sia il risultato della giustapposizione di unità
narrative (i lógoi) nate autonomamente e incentrate su interessi
etnografici e geografici, secondo l'uso dei logografi. Secondo altri
studiosi, invece, Erodoto avrebbe inteso comporre una storia della Persia,
della sua ascesa e delle sue vittoriose conquiste fino allo scontro con la
Grecia; l'incontro dello storico con il mondo ateniese e le profonde
suggestioni assorbite avrebbero poi determinato uno spostamento di
interesse e le ampie digressioni.
• L'eredità dell'epos
Qualunque sia stata la genesi dell'opera, è certo che essa fu diffusa
oralmente, in recitazioni pubbliche. Sotto questo aspetto Erodoto è erede
della tradizione epica: come gli aedi antichi, anche lo storico muove
dall'esigenza di sottrarre all'oblio le “opere grandi e meravigliose”.
Anch'egli avverte il fascino del raccontare, l'esigenza di suscitare in chi
ascolta commozione e stupore: per questo indulge all'elemento fantastico
o dà spazio a numerosi inserti novellistici, ricordo di antiche forme di
narrazione popolare, spesso di origine orientale. Ma, a differenza di
quanto avviene nell'epos, gli eventi narrati sono ormai di uomini e di
popoli: per questo richiedono una documentazione. Erodoto distingue tra
le notizie conosciute per visione diretta (ópsis) e quelle acquisite per
testimonianza orale (akoè); se le testimonianze raccolte contrastano fra
loro, sceglie quelle che sembrano più attendibili. Raramente opera su
fonti scritte o documenti ufficiali e, nella congerie di dati talvolta
contraddittori, si limita a segnalare “quanto si racconta” senza operare
una selezione critica. La sua storia, mossa da una curiosità inesauribile e
sensibile a criteri di verosimiglianza, non possiede però ancora una
metodologia scientifica rigorosa.
• Erodoto e il suo tempo
Se la ricchezza della narrazione erodotea rimanda alla cultura ionica di
cui lo storico è figlio, lo sfondo concettuale della sua opera si collega alla
cultura attica. Contigua a quella della tragedia, in particolare di Sofocle, è
la sua visione pessimistica della vita umana; il fato determina le vicende
dell'esistenza e la libertà dell'uomo sta nell'accettazione consapevole,
dunque responsabile, del proprio destino. Il superamento del limite porta
all'accecamento della colpa e alla desolazione della pena; allora, dal
massimo livello di felicità e fortuna, l'uomo precipita al massimo
dell'infelicità. Dalla sofistica Erodoto mutua il concetto di relatività dei
costumi e delle leggi, mentre sostiene i concetti di libertà, di democrazia,
di eguaglianza dei cittadini sotto la legge. Erodoto in generale, condivide
con l'ambiente politico e culturale dell'Atene di Pericle l'orgogliosa
consapevolezza dei meriti della città nella vittoria sull'aggressore
persiano.
• La lingua e lo stile
Erodoto scrisse in dialetto ionico, con numerosi inserti attici e frequenti
forme attinte al linguaggio epico e poetico. Lo stile, con le sue frequenti
paratassi, è semplice e piano: la sua mirabile fluidità fu già celebrata dagli
antichi. Il piacere di raccontare a volte cede ad un voluto compiacimento.
Ma si deve riconoscere che la narrazione procede con molta misura.
UNITA’ 3
PARTE 10 TUCIDIDE
Tucidide viene definito da Cicerone "storico degno di fede" (Bruto, 47).
Non è uno storico siciliano, ma attira la nostra attenzione in quanto autore
di una storia della guerra del Peloponneso, nella quale - come Polibio egli affronta gli avvenimenti storici escludendo ogni riferimento a volontà
divine, coadiuvanti delle gesta umane. Per questa sua modernità, e per
l'aiuto che fornisce a coloro che si interessano anche alla storia della
Sicilia è ovvio per noi tracciarne un breve profilo.
Tucidide, nato nel 460 a.C. ad Atene e morto nel 395 a.C. circa, originato
da nobile famiglia - imparentata con Milziade, vedi Pindaro - dedicò
costantemente ogni sua energia intellettuale, per tutto il suo tempo
mortale, alla stesura della sua opera. In giovane età ebbe l'incarico
militare di difendere la città di Anfipoli e la Calcidica: sconfitto da
Brasida, venne accusato di tradimento, e costretto all'esilio in Tracia.
Iniziò così ad ordinare i dati per la sua opera: con la sua elaborazione
storiografica offre un esempio di storico dal temperamento risoluto, e
consapevole della importanza della sua funzione culturale.
Viene considerato superiore a Polibio per l'aver evitato ogni moraleggiare
intorno agli avvenimenti narrati ed analizzati con discreta concisione. La
sua opera consta di otto libri, ma quelli cui puntiamo il nostro interesse
sono il VI ed il VII tomo, dedicati alla spedizione ateniese in Sicilia, fino
al 413 a.C. In quell'anno, la guerra iniziata tra Atene e Sparta nel 431, si
trascina fino in Sicilia. Nell'estate del 413 la flotta ateniese, nel porto
Grande di Siracusa, viene distrutta. Anche sulla terraferma, nei pressi
del fiume Assinaro, gli ateniesi condotti da Nicia e Demostene vengono
sconfitti da truppe siceliote comandate dallo spartano Gilippo.
Altri eventi porteranno alla resa di Atene nel 404; ma ciò che per la
nostra storia della letteratura più conta è il prestigio che la già forte
Siracusa da tali avvenimenti ricava. Prestigio guadagnato anche in
seguito, con le vittorie ottenute a spese dei Cartaginesi nel 397 e nel 383,
quando era tiranno della città Gelone. Nuove colonie nacquero con gli
spostamenti delle navi e dei sicelioti siracusani: a Porto Vecchio
(Corsica), ad Ancona e ad Adria. I successivi progressi in campo
economico e sociale porteranno Siracusa ad avere una corte che attirerà
per ricchezza ed ospitalità molti degli ingegni di cui stiamo trattando.
Ciò che Eraclito, colla sua visione di un mondo in continuo
cambiamento, è per la filosofia, così Tucidide appare agli occhi degli
storici suoi successori. La storia si rinnova in eterno, per lui, ed il tutto
muta riguarda bene anche il costituirsi ed il dissolversi degli imperi:
concezione che pare piuttosto ovvia a chiunque non sia portato alla
ricerca di un potere. Oltre che da Polibio, Tucidide si differenzia anche da
un altro grande storico dell'antichità: Erodoto. Questi, tra gli avvenimenti
che ritiene degni di nota, cita anche quelli ai quali non può accedere per
una verifica: come i fatti riportati dalla tradizione. Tucidide è moderno
invece anche nel vagliare la attendibilità delle fonti, con razionale
attenzione.
Gran merito suo è, inoltre, quello di aver saputo dividere gli avvenimenti
della guerra del Peloponneso in guerra archidamica e guerra deceleica,
intervallate dalla pace conclusa dal generale Nicia nel 421 a.C. (valoroso
che morì nella sopra ricordata sconfitta ateniese in Sicilia). Tucidide si
arrischiò anche a prendere una posizione nei confronti di quegli
avvenimenti che a volte accadono contravvenendo alle umane aspettative
razionali, quando accade che un esercito debole riesca a vincere una
battaglia contro quello più dotato: per Tucidide se a volte il forte perde,
rimane solo danneggiato, mentre lo stesso non è per il debole, che viene
annientato. E ancora, Tucidide crede fermamente che è la legge del più
forte che domina i destini delle nazioni; e ciò a dispetto della giustizia:
"Non stabilimmo noi ( gli ateniesi n.d.A.) tale legge (del più
forte n.d.A.) e neppure ci distinguiamo nel volerla applicare:
c'era e ci sarà, in quanto è voluto dalla natura che gli
uomini più forti esercitino il potere".
Traspare costante un tono di ammirazione per la propria gente, che in
passato aveva saputo fronteggiare pericoli immani, in solitudine, contro i
Persiani:
"Ad Atene noi rettamente riflettiamo e apertamente
giudichiamo sugli affari privati e pubblici, convinti che i
discorsi non nuocciono all'operare, ma ad esso nuoce
piuttosto il passare ai fatti, prima di aver chiarite nei
discorsi le idee. Poiché noi abbiamo questo pregio
singolare, di essere insieme al sommo ardimentosi e
riflessivi in tutto quanto intraprendiamo; diversi perciò
dagli altri nei quali l'ignoranza genera audacia e la
ponderazione lentezza".
E non mancano i giudizi sulle condotte dei governi; viene elogiata la virtù
politica, guidata dalla magnanimità dei potenti di turno; con la
consapevolezza che ogni guerra, ogni insanguinato traguardo, prima o poi
svanirà col trascorrere dei secoli, se non dei decenni o dei lustri. Ecco
perchè è importante l'onore e la gloria che da esso ne consegue, in pace
come in guerra, a lasciare traccia veramente duratura dopo fatiche, e lutti,
e tragedie immani.
"Amiamo il bello, noi, ma sempre con semplicità; ed amiamo la
conoscenza, ma senza oziare. Le nostre ricchezze ci servono più per
essere maggiormente attivi che per mostrarci vanitosi; e la povertà da
noi confessata non ci rende vergognosi, ma più risoluti nel lavoro".
Infine riviviamo una delle più antiche pagine di storia che riguardano i
nostri padri; si tratta di un brano tratto dal VII libro di Tucidide, nella
traduzione di C. Coppola (Le più belle pagine della lett. greca classica,
Nuova Accademia Editrice, 1962); siamo negli anni 414, 413 a.C.:
"Durante la notte, Nicia e Demostene, tenuto conto delle
condizioni pietose in cui si trovavano le truppe per la
mancanza di vettovaglie e per il gran numero dei feriti a
seguito dei ripetuti attacchi nemici, decisero di accendere
fuochi quanti più fosse possibile e di battere in ritirata con
l'esercito, non per la via che avevano deciso
precedentemente, ma in senso contrario a quello dove c'era
il blocco dei Siracusani, cioè verso il mare. La direzione
generale di questa strada non portava le truppe a Catania,
ma dalla parte opposta della Sicilia, verso Camarina e Gela
e altre città, greche e barbare (i Greci per barbari
intendevano tutti coloro che non appartenevano ad uno dei
gruppi ellenici; n.d.A.). Accesi dunque molti fuochi,
marciavano di notte. Ed ecco che fra le truppe si diffuse un
grande panico, come suole accadere in genere agli eserciti,
specialmente se numerosi, quando marciano di notte in terra
ostile e col nemico alle costole. Le truppe di Nicia, in testa
alla colonna, restavano salde e perciò si avvantaggiarono di
molto, mentre quelle di Demostene, che costituivano il
grosso, più della metà dell'esercito, s'erano sparpagliate e
avanzavano in disordine. All'alba, tuttavia, giungono in
vicinanza del mare, e imboccano la strada detta di Eloro,
con l'intento di guadagnare il fiume Cacipari e quindi, lungo
il fiume, di inoltrarsi nell'interno. La speranza era che qui
venissero loro incontro i Siculi ai quali avevano fatto
appello. Ma, giunti che furono al fiume, trovarono anche qui
un presidio siracusano che stava chiudendo il guado con
muri e palizzate. E tuttavia riuscirono a forza a passare il
fiume e ripresero la marcia verso un altro fiume, l'Erineo.
Questa era la direzione consigliata dalle guide.
Intanto i Siracusani e gli alleati, appena sul far del giorno si
accorsero della scomparsa degli Ateniesi, accusarono in
gran parte Gilippo di averli volontariamente lasciati partire.
Datisi quindi ad un rapido inseguimento per la via che senza
difficoltà capirono esser quella presa dagli Ateniesi, li
raggiunsero all'ora del rancio e attaccarono subito le truppe
della retroguardia di Demostene, che avanzavano in gran
lentezza e disordine, per il panico della notte precedente.
Piombarono subito loro addosso e attaccarono, mentre la
cavalleria li circondava con facilità, isolati com'erano dal
grosso, riuscendoli a concentrare in un sol punto. Le truppe
di Nicia si trovavano avanti, a cinquanta stadi, perché egli
avanzava più rapidamente, convinto com'era che la salvezza
era riposta non nell'attendere deliberatamente il nemico e
attaccar battaglia, ma nel ritirarsi con la maggior celerità
possibile e combattere solo se costretti. (...). Mentre queste
truppe (prigioniere, di Demostene; n.d.A.) vengono subito
dirette verso la città, Nicia e i suoi, nello stesso giorno
giungono al fiume Erineo, lo varcano e pongono gli
accampamenti in una posizione elevata.
I Siracusani li raggiunsero il giorno dopo, gli fecero sapere
che Demostene si era arreso coi suoi e l'invitarono a fare lo
stesso. Non lo credette Nicia e ottenne una tregua per
mandare un cavaliere ad accertarsi di quanto gli era stato
riferito. Tornato che fu, il cavaliere confermò la resa, e
quindi Nicia mandò araldi a Gilippo (comandate degli
alleati spartani; n.d.A.) e ai Siracusani annunziando di esser
pronto a concludere un accordo a nome degli Ateniesi, nei
seguenti termini: risarcimento delle spese di guerra
sostenute dai Siracusani e liberazione del suo esercito: fin
quando non venisse consegnato il denaro, proponeva di dare
in ostaggio cittadini ateniesi, uno per talento. I Siracusani e
Gilippo non accettarono queste condizioni, ma, piombati
addosso agli Ateniesi e accerchiatili da ogni parte, li
tennero sotto il loro tiro fino a tarda ora. Anche queste
truppe di Nicia si trovavano a corto di vettovaglie e
mancavano del necessario. E tuttavia, spiato di notte un
momento di calma, si accingevano a muoversi, quando i
Siracusani, accortisi che riprendevano le armi, intonarono il
peana (canto di guerra; n.d.A.). Visto che non erano passati
inosservati, gli Ateniesi deposero di nuovo le armi, tranne
circa trecento uomini che riuscirono a forzare i posti di
guardia nemici e si avviarono dove poterono.
Sul far del giorno, Nicia riprese la marcia, mentre i
Siracusani e gli alleati li premevano allo stesso modo da
ogni parte, sempre con tiri di frecce e giavellotti. Gli
Ateniesi cercavano di raggiungere a marce forzate il fiume
Asinaro, sempre premuti dagli attacchi dei cavalieri, che
sbucavano da ogni parte, e dal resto dell'esercito nemico:
pensavano che, passato il fiume, avrebbero migliorato la
loro situazione, stanchi com' erano e assetati. Giunti che
furono al fiume, vi si buttarono dentro disordinatamente:
ognuno cercava per conto suo di passare per primo, mentre
i nemici, sempre presenti, rendevano ormai difficile la
traversata. Costretti ad avanzare in massa cadevano gli uni
sugli altri e si calpestavano a vicenda. Alcuni infilzandosi
nei propri giavellotti o nelle altre armi, o perivano subito o,
impacciati com'erano, venivano trascinati giù dalla
corrente. I Siracusani, appostati sulla riva opposta che era
scoscesa, colpivano dall'alto gli Ateniesi, mentre in gran
parte erano intenti a bere avidamente e si ostacolavano a
vicenda, chiusi com'erano nel letto incassato del fiume" (...).
Tanto sangue, infine, per lavarci gli occhi dalle illusioni di
ere felici vissute tra amori e bevute, canti e spettacoli
teatrali. Dei tanti uomini spazzati via, umile è rimasto invece
il lavoro, la roccia scolpita dalle loro dissolte mani,
forgiando teatri e templi; che nei loro incavi ancora
mostrano l'ombra delle dita umanissime.
UNITA’ 3
PARTE 11 DEMOSTENE
Demostene nacque ad Atene nel 384 a.C. da una famiglia ricca per la
proprietà di alcune fabbriche di armi, oltre che per beni immobiliari.
Rimasto tuttavia orfano all’età di sette anni, lui e l’unica sorella più
piccola furono affidati ai nipoti del padre Afobo e Demofonte ed
all'amico Terippide, poichè a questi ultimi il padre aveva affidato il
compito di amministrare il proprio patrimonio, uno dei più cospicui di
Atene, e di esercitare la tutela sui figli. Raggiunta la maggiore età,
Demostene ricevette in eredità la casa, gli schiavi e la somma di trenta
mine, come unico residuo dei beni paterni. Egli, allora, decise di citare in
giudizio i suoi tutori, dedicandosi con intensità davvero notevole al
processo. Di tale dibattimento, estremamente lungo, ci sono giunte cinque
orazioni, non tutte tuttavia attribuibili con certezza a Demostene. La
prima è l’accusa Contro Afobo, del 363 a.C., che, insieme alla breve
replica ( Contro Afobo II ), rappresenta la più antica testimonianza
dell’attività oratoria di Demostene. La complessa vertenza legale
continuò con altre tre orazioni, Contro Afobo per Fano, e i due discorsi
Contro Onetore. Alla conclusione del processo Demostene decise di
intraprendere la professione di logografo: si può dunque supporre che il
nostro oratore non fosse riuscito a recuperare il suo patrimonio. Della sua
attività logografica ci restano, oltre a quelle già citate, un corpo di 28
orazioni, parecchie delle quali, ancora una volta, presentano però
attribuzione incerta. La fama conquistata con la logografia fece sì che
Demostene potesse passare ben presto all’attività di oratore politico, che
esercitò dal 355 al 330 a.C., come capo indiscusso del partito
antimacedone e convinto assertore del primato politico ateniese
nell’Ellade. Proprio a causa della sua ostilità contro Filippo si originò la
violenta polemica fra lui ed Eschine, che si concluse con la sconfitta e
l’esilio di quest’ultimo. Tuttavia anche Demostene dovette abbandonare
Atene poco tempo dopo, in conseguenza dello scandalo di Arpalo; ma vi
rientrò da trionfatore nel 323, dopo la prematura scomparsa di
Alessandro, riprendendo il suo ruolo nell’opposizione armata contro la
Macedonia. Ma l’intervento di Antipatro e di Cratero ebbe ben presto
ragione della rivolta: le rappresaglie costarono la vita anche ad Iperide.
Demostene tentò la fuga nell’isola di Calauria, presso Trezene, e per non
farsi catturare vivo si suicidò col veleno nel tempio di Posidone,
nell’autunno del 322 a.C.
UNITA’ 3
PARTE 12 SOCRATE
Socrate nacque nel 470 / 469 a.c. da Sofronisco , scultore , e Fenarete ,
levatrice . Dapprima esercitò forse il mestiere del padre , ma
successivamente l'abbandonò per dedicarsi esclusivamente all'indagine
filosofica . Non di rado dovette quindi ricorrere all'aiuto economico di
amici . Sposò Santippe , che una certa tradizione tende a presentare come
donna bisbetica e insopportabile : si è arrivati a pensare che Socrate
stesse sempre in piazza non tanto per filosofare quanto piuttosto per stare
lontano da Santippe e dalle sue ramanzine continue : pare che Socrate sia
riuscito a far ragionare tutti tranne Santippe . Da lei ebbe tre figli .
Socrate non lasciò mai Atene se non per brevi spedizioni militari :
partecipò infatti nel 432 alla spedizione contro Potidea , traendo in salvo
Alcibiade ferito , e nel 424 combattè a Delio a fianco di Lachete durante
la ritirata degli Ateniesi di fronte ai Beoti . Successivamente nel 421
combattè ad Anfipoli . Nel 406 in conformità al principio della rotazione
delle cariche , fece parte dei pritani , ossia del gruppo del Consiglio al
quale spettava decidere quali problemi sottoporre all'Assemblea e si
oppose alla proposta illegale di processare tutti insieme i generali
vincitori nello scontro navale avvenuto al largo Arginuse , perchè non
avevano raccolto i naufraghi . Con questa presa di posizione egli si
poneva in contrasto con i democratici , ma nel 404 , passato il potere in
mano all'oligarchia capeggiata dai Trenta , rifiutò di obbedire all'ordine di
arrestare un loro avversario , Leone di Salamina . Nel 403 la democrazia
restaurata , pur concedendo un'amnistia , continuò a ravvisare in Socrate
una figura ostile al nuovo ordine , anche per i rapporti da lui intrattenuti
in passato con figure come Alcibiade e Crizia . Nel 399 fu presentato da
Meleto un atto di accusa contro Socrate , ma tra i suoi accusatori erano
anche Licone e soprattutto Anito , uno dei personaggi più influenti della
democrazia restaurata . L'atto di accusa è il seguente : " Socrate è
colpevole di essersi rifiutato di riconoscere gli dei riconosciuti dalla città
e di avere introdotto altre nuove divinità . Inoltre è colpevole di avere
corrotto i giovani . Si richiede la pena di morte " . Gli accusatori
contavano probabilmente in un esilio volontario da parte di Socrate ,
com'era avvenuto in passato per Protagora o Anassagora , ma egli non
abbandonò la città e si sottopose al processo . A maggioranza i giudici
votarono per la condanna a morte la quale fu eseguita in carcere mediante
la somministrazione di cicuta . Possiamo inserire Socrate nell'era sofistica
(sebbene lui si schierò contro i sofisti) perchè come i sofisti si interessò di
problemi etici ed antropologici , mettendo da parte la ricerca del principio
e della cosmogonia . Socrate non scrisse mai nulla e così per ricostruire il
suo pensiero dobbiamo ricorrere ad altri autori . Le fonti principali sulla
vita di Socrate sono quattro 1) Platone 2)Senofonte 3)Aristotele
4)Aristofane . 1) Platone è senz'altro la fonte più attendibile : egli fu
discepolo diretto di Socrate e con lui condivise sempre l'idea della
filosofia come ricerca continua . Senofonte è la fonte più banale e meno
interessante : il Socrate degli scritti di Senofonte è un cittadino ligio alla
tradizione , il vero interprete dei valori correnti , il saggio che mira al
bene dei suoi concittadini ed è ossequioso verso la città e le sue divinità .
Va subito precisato che Senofonte era un grande generale , coraggioso e
valoroso , ma non era certo un'aquila : i suoi scritti stessi non sono certo
esempi eclatanti della letteratura greca : sono ridondanti e ripetitivi .
Senofonte fece anche campagne militari con Socrate e nei suoi scritti ne
esalta il valore dicendo che non stava mai fermo , era sempre in azione ,
non soffriva niente (camminava addirittura a piedi nud sul ghiaccio) . A
Senofonte della filosofia non gliene importava nulla e con Socrate , di cui
era grande amico , non trattava mai argomenti filosofici , ma solo militari
: questo ci consente di capire che Socrate modulava il discorso a seconda
del personaggio che aveva di fronte : con un filosofo parlava di filosofia ,
con un generale di guerra . 3) La testimonianza di Aristotele è stata a
lungo ritenuta la più attendibile perchè Socrate non viene caricato di
significati simbolici : Aristotele ce ne parla in modo oggettivo . Tuttavia
la testimonianza aristotelica ha dei limiti : in primis , è la meno " artistica
" delle 4 ed è l'unica di un non-contemporaneo . Va poi detto che in
Aristotele Socrate ci viene presentato quasi come un " robot " : la
filosofia socratica viene presentata come un susseguirsi di ragionamenti e
non viene dato spazio al filosofare in pubblico , al dialogo aperto . 4)
Aristofane è il personaggio più vicino a Socrate come età : ci presenta un
Socrate relativamente giovane (circa 40 anni) . Va ricordato che
Aristofane era un commediografo e ne risulta che l'immagine che lui ci dà
di Socrate è fortemente impregnata di tratti sarcastici . Ne " Le nuvole "
ce lo presenta come un sofista studioso della natura (il contrario di ciò
che era in realtà) , con la testa fra le nuvole . Insomma Aristofane è
l'unico a darci di Socrate un'immagine fortemente negativa (non a caso
Aristofane era stato uno dei primi accusatori di Socrate) . In realtà non
dobbiamo pensare che Aristofane volesse gettar discredito su Socrate o lo
prendesse in giro per cattiveria : in fondo lui faceva solo il suo lavoro di
commediografo , che consisteva nel far ridere . In realtà con la figura di
Socrate vuole prendere in giro non Socrate , ma l'intera categoria dei
filosofi . La testimonianza di Platone resta la migliore e le altre tre vanno
sfruttate come appoggio . Platone lo conosceva davvero bene ed era lui
stesso un gran filosofo : il grosso limite è che trattandosi di un filosofo ,
Platone avrebbe potuto rimaneggiare i discorsi di Socrate , ed è proprio
quel che fa man mano che invecchia . " L'apologia " , per fortuna , resta
un dialogo giovanile nel quale Platone descrive il processo che decretò la
condanna a morte di Socrate . E' proprio in questo dialogo che emerge
fortemente la differenza tra Socrate ed i sofisti : i sofisti pronunciavano
discorsi raffinati ed eleganti , ma totalmente privi di verità : per loro
l'importante era parlar bene , avere un buon effetto sulle orecchie degli
ascoltatori . Per Socrate invece quel che più conta è la verità : lui si
proclama incapace di controbattere a discorsi così eleganti e ben
formulati (ma falsi) . Socrate , pur non tenendo un'orazione raffinata ,
dice il vero : la critica ai sofisti verrà poi ripresa da Platone stesso . I
sofisti puntavano a stupire l'ascoltatore , dal momento che erano convinti
che la verità non esistesse (soprattutto Gorgia . Socrate per difendersi in
tribunale non pronuncia un discorso (come i sofisti) , ma imposta un
dialogo botta e risposta : è proprio dal discorso che viene a galla la verità
(Platone dirà che il discorso tra due o più individui è come lo scontro tra
due pietre dal quale nasce la fiamma della conoscenza) . Lo stile oratorio
di Socrate è scarno , secco e quasi familiare , modulato a seconda
dell'interlocutore . Il punto di partenza del discorso socratico è la
cosiddetta " ironia socratica " , ossia la totale autodiminuzione , " io non
so , tu sai " . Così inizia anche " L'apologia" : si pone la domanda "che
cosa è x ?" e l'interlocutore cade nel tranello e risponde , sentendosi
superiore a Socrate . Socrate , come abbiamo detto parlando di Senofonte
, parla di argomenti noti all'interlocutore : se ad esempio parla con un
generale gli chiederà " che cosa è il coraggio ? " . Quello risponderà , per
esempio , dicendo che il coraggio è il non indietreggiare mai . Allora
Socrate interverrà dicendo che quello non è coraggio , bensì pazzia . La
critica diventa stimolo per l'interlocutore a fornire una seconda risposta
meglio articolata : il gioco può andare avanti a lungo e spesso rimane
aperto . Questo metodo viene detto " maieutico " : Socrate diceva di fare
lo stesso lavoro della madre , la quale era ostetrica : lei faceva partorire le
donne , lui le anime . Come le ostetriche valutano se il neonato è " buono
" , così Socrate valuta se le idee , le definizioni sono buone . Non tutti gli
interlocutori erano intelligenti e riconoscevano i propri errori : spesso
preferivano evitare Socrate . Da un interlocutore Socrate fu anche
denominato " torpedine " in quanto l'incontro con Socrate risulta
scioccante perchè ribalta le concezioni di chi era convinto di sapere e
dimostrava che in realtà non sapeva . Socrate stesso si paragonava ad un
moscone che stimola il cavallo : lui stimolava gli uomini a ragionare .
Socrate con il processo dell'autodiminuzione afferma di non sapere nulla ,
mentre sostiene che i sofisti sappiano tutto : dice che forse l'educazione
che impartisce lui è inutile rispetto a quella sofistica , ma senz'altro è più
importante . Le calunnie nei confronti di Socrate hanno avuto inizio
quando lui si definiva sapiente in quanto l'oracolo di Delfi gli aveva detto
che era il più sapiente tra gli uomini . Lui era rimasto sconvolto da tale
affermazione e non riusciva a crederci : allora cominciò a girare per
Atene per vedere se trovava persone effettivamente più sapienti di lui .
Dunque si recò da coloro che si ritenevano sapienti : politici , poeti ,
artigiani . Socrate si accorse che tutte e tre le categorie erano convinte di
sapere , ma in realtà non sapevano niente : i politici erano i peggiori di
tutti non in quanto politici (Socrate stesso , se vogliamo , era un politico
perchè svolgeva la sua attività in pubblico) ma in quanto non capaci di
insegnare il loro sapere : un vero sapiente deve spiegare ciò che sa :
anche i politici migliori (Pericle) non sanno trasmettere il loro sapere . Lo
stesso era per i poeti , che a partire da Omero erano considerati sapienti
ed educatori : Socrate li biasima sia perchè dicono assurdità , sia perchè il
loro non è un sapere , ma una forma di " follia ispirata " : era la divinità
che parlava per bocca loro . I meno peggio risultarono essere gli artigiani
, che almeno sapevano fare diverse cose di utilità pubblica : la loro è una
" tecnè " , ossia una sapienza pratica . Però anche gli artigiani avevano i
loro difetti : erano sì competenti nel loro settore , ma peccavano di
presunzione perchè erano convinti che la loro conoscenza fosse
universale ed illimitata , anzichè limitata . Inoltre essi agivano senza
pensare e ponderare . Socrate arrivò alla conclusione che l'oracolo di
Delfi aveva ragione : lui stesso è il più sapiente , pur sapendo di non
sapere . Il suo non va interpretato come atteggiamento di rinuncia alla
ricerca della verità , ma come segno di modestia intellettuale : è proprio il
fatto di essere consapevoli della propria conoscenza che spinge l'uomo a
sforzarsi di raggiungere la conoscenza ; se si è convinti di sapere già tutto
non ci si sforzerà di migliorare . Tra le varie accuse che vengono mosse a
Socrate c'è anche quella di corrompere i giovani nella piazza rendendoli
peggiori : lui ribatte a questa accusa dicendo che non avrebbe motivo di
fare ciò . Infatti se corrompesse i giovani finirebbe per vivere in una città
di giovani corrotti , il che si ritorcerebbe contro lui stesso . Va senz'altro
ricordato il cosiddetto " intellettualismo etico " di Socrate : secondo lui
nessuno può compiere il male sapendo effettivamente di compierlo :
nessuno potrebbe mai fare del male volontariamente . Un rapinatore
rapina non pensando di fare del male , ma di fare del bene : è un errore
intellettuale ritenere bene ciò che è male . E' un atteggiamento
tipicamente cristiano-cattolico che si possa scegliere tra bene e male
indistintamente . Dunque Socrate introducendo l'intellettualismo etico
dimostra di aver agito per il bene della sua città . E' Socrate che ha
scoperto il concetto moderno di anima ( yuch ) : in precedenza
significava " soffio vitale " , ciò che fa vivere le cose ; il termine yuch
assunse poi il significato di " immagine nell'Ade " , un'esistenza
depotenziata . Per gli Orfici significava " demone " . A partire da Socrate
fino al giorno d'oggi l'anima è diventata il nostro io : ci identifichiamo
con l'anima . Secondo Socrate possiamo dividere i beni ed i mali in tre
categorie a) dell'anima b) del corpo c) dell'esterno . Il corpo è lo
strumento nonchè la prigione dell'anima . Il denaro , per esempio , è un
bene esterno . In alcuni frangenti sembra che Socrate (e anche Platone )
rifiuti i beni materiali e del corpo , scegliendo quelli dell'anima ; in altre
occasioni pare che possano essere accettati entrambe . Socrate , per
esempio , pare che non disprezzasse il vino . Quest'ambiguità tra beni del
corpo e beni dell'anima può essere spiegata affermando che i beni son
tutti beni finchè non entrano in conflitto con altri : la ricerca del piacere
fisico diventa un male quando la si antepone alla ricerca di quello
intellettuale . Questo non vale solo per i beni , ma anche per il rapporto
tra anima e corpo : il corpo per Socrate e Platone non va disprezzato ,
anzi va apprezzato perchè serve all'anima . Per il Cristianesimo la
ricchezza è un male , per Socrate e Platone è un bene finchè non entra in
conflitto con gli altri beni . Interessante è il concetto socratico di
ingiustizia : essa non danneggia chi la subisce , ma chi la commette . La
giustizia infatti dà un senso di piacere interiore e chi è ingiusto perde
questo piacere , mentre chi subisce l'ingiustizia continua a provarlo .
Questo vale anche per Platone . Tra le cose che Socrate dice di non sapere
vi è la conoscenza dell'aldilà , di cosa c'è dopo la morte ( Platone dirà di
essere in grado di dimostrare l'esistenza di un aldilà) . Per lui non è che se
si vive una vita giusta si sarà premiati : si è già appagati dal vivere
giustamente , la felicità che si prova perchè si è giusti è già una sorta di
premio : Socrate dice che magari potrebbe esserci una vita ultraterrena ,
ma lui non lo sa . Tra le varie accuse rivolte c'era anche quella di ateismo
e di empietà : Socrate infatti credeva nei demoni , che lui proclamava "
figli delle divinità " . Lui dimostra che è un'accusa sbagliata dicendo che
se crede nei demoni che sono figli delle divinità , è ovvio che creda anche
nelle divinità : perchè ci sia il figlio (demone) , ci devono anche essere il
padre e la madre (le altre divinità) . Ma che cosa era questo demone ?
Abbiamo due testimonianze divergenti : per Platone era una sorta di
angelo custode - coscienza personale che interveniva ogni qual volta
Socrate stesse per sbagliare : si tratterebbe di una sorta di " aiuto
privilegiato " che non tutti hanno : solo le persone per bene . E' un dono
divino per i buoni . E' come se la divinità partecipasse alla vita umana .
Per Senofonte invece il demone è un'entità che lo spinge ad agire in
determinati modi : Senofonte intende ancorare fortemente Socrate alla
credenza in un ordine divino e in un intervento divino nella vita umana .
Per Socrate l'importante non è vivere , ma vivere bene : quando la nostra
anima è sana , giusta , allora anche noi stiamo bene . Sempre Senofonte
nei " Detti memorabili " riassume la prova dell'esistenza di Dio formulata
da Socrate in questi termini : ciò che non è opera del caso postula una
causa intelligente , con particolare riguardo al corpo umano che ha una
struttura organizzata non casuale . Per questa sua origine l'uomo è
ritenuto superiore a tutti gli altri animali ed è oggetto dell'interesse di Dio
, come si deduce anche dalla possibilità di conoscere i suoi progetti
sull'uomo ricorrendo all'arte della divinazione . Va notato che il Dio
socratico ( inteso come intelligenza finalizzatrice ) è una sorta di
elevazione a entità assoluta della psychè umana . Molti hanno notato che
gli accusatori non volevano in realtà condannarlo a morte , ma
semplicemente zittirlo . Ma Socrate non può accettare di essere zittito : il
suo destino è andare in giro a colloquiare con la gente . Vivere bene per
Socrate significa svolgere quest'attività e non rifiutare di essere colpevole
significava non far perdere significato alla sua vita . Dal momento che era
già vecchio e gli restavano pochi anni di vita , tanto valeva farla finita lì ,
ma non rinunciare ai suoi ideali . Mentre la ricerca di Platone si spingerà
in un'altra dimensione , quella di Socrate rimane saldamente ancorata al
mondo terreno : la sua mIssione è far capire ai cittadini ciò che fanno . In
Socrate vi è poi un rifiuto della politica (che peraltro troveremo anche in
Platone ) : fa infatti notare che lui stesso aveva avuto parecchi problemi
con la politica : prima contro di lui si erano scagliati gli oligarchici , ed
ora i democratici (nell'accusa ai danni di Socrate si possono scorgere
istanze politiche : lui era un aristocratico e i democratici volevano punirlo
) . Pur avendo problemi con la politica , Socrate non dice che vada abolita
. Prima dell'esecuzione della pena capitale , a Socrate era stata presentata
la possibilità di evadere dal carcere , ma lui si era rifiutato : in lui infatti
vi era il massimo rispetto per la legge , che non si deve infrangere in
nessun caso . La legge può essee criticata , ma non infranta : di fronte ad
una legge ingiusta non bisogna infrangerla , ma bisogna battersi per farla
cambiare . Socrate afferma che sarebbe stato suo dovere far cambiare la
legge e che non essendoci riuscito è giusto che lui muoia . Gli Ateniesi
son convinti di essersi liberati di Socrate avendolo eliminato fisicamente ,
ma in realtà per liberarsene completamente avrebbero dovuto " ucciderlo
filosoficamente " , batterlo a parole . In realtà volevano farlo tacere , ma
han sortito l'effetto opposto : Platone infatti , che era intenzionato a
dedicarsi alla vita politica , resterà sconvolto per condanna del maestro e
si dedicherà alla filosofia . In Socrate vi è una vaga idea di provvidenza
divina , ma non collettiva , bensì individuale : la divinità aiuta solo i
migliori . Celeberrima è la conclusione dell' Apologia , in cui Socrate si
rivolge ai suoi discepoli prima di essere giustiziato : " Ma ormai è ora di
partire : io verso la morte , voi verso la vita . Chi di noi cammini a una
meta superiore è oscuro a chiunque : non al mio dio ." Nel " Simposio "
di PlatonePlatone Alcibiade afferma che Socrate non assomiglia a
nessuno degli uomini del passato e del presente : è una figura nuova .
Non si interessa di politica , ma non la disprezza , non rifiuta i festini , ma
non vi si identifica ( nel " Simposio " tutti i convitati si addormentano ,
Socrate no ) . Soffermiamoci ora maggiormente sulla tecnica discorsiva
di Socrate : la confutazione è la tecnica che dimostra l'inconsistenza del
sapere dei propri interlocutori . Ma per arrivare a questo risultato bisogna
partire dal metodo delle domande e delle risposte . " Che cosa è la
giustizia ? " può essere il punto di partenza per il dibattito : porre questa o
qualsiasi altra domanda del genere significa richiedere la definizione
delle cose in questione , che però deve essere valida per tutti i casi
particolari . In questo senso la ricerca di Socrate è stata interpretata da
Aristotele come ricerca dell'universale , nell'ambito dei concetti e dei
problemi morali . Gli interlocutori di Socrate si dimostrano incapaci di
rispondere correttamente alla domanda sia perchè sottovalutano Socrate
(che dice di essere inferiore) sia perchè rispondono citando casi
particolari , anzichè la definizione universale . Abbiamo già citato il caso
della domanda " Che cosa è il coraggio ? " : rispondere " non
inditreggiare mai " è sbagliato , così come dire " assalire il nemico " : si
può essere coraggiosi anche nell'affrontare una malattia o
un'interrogazione : una definizione corretta deve coprire tutti i casi
possibili . Nella sua funzione negativa il metodo delle domande e risposte
si caratterizza come confutazione , ossia dimostrazione della falsità o
contradditorietà delle risposte date dall'interlocutore . Gli effetti prodotti
dall'esercizio di questo metodo sono paragonati a quelli della torpedine
marina , che intorpidisce coloro che tocca . Di fronte alla confutazione si
può reagire rifiutandola , come fanno vari interlocutori di Socrate . Ma ,
se la si accetta , essa può liberare dalle false opinioni che si hanno sui vari
argomenti e agire dunque come una forma di purificazione . La situazione
, che risulta dalla confutazione , è detta aporia , ossia letteralmente
situazione senza vie di uscita . Essa consiste nel rendersi conto che i
tentativi sin qui percorsi di rispondere a un determinato problema , hanno
condotto a un vicolo cieco . Ma in questa nuova situazione , liberi dal
falso sapere e soprattutto dalla presunzione di sapere , ci si può accingere
alla ricerca del vero sapere , tentando nuove stade che possano condurre
ad esso . In questo nuovo orientamento il metodo delle domande e
risposte può assolvere una funzione positiva . Essa è paragonata alla
funzione svolta dalla maieutica , capace di far partorire ad ognuno ,
mediante domande opportunamente indirizzate , la verità , di cui ciascuno
è gravido . Socrate si ostina incessantemente a far convergere i propri
interlocutori nell'ammissione di un punto fondamentale : per saper agire
bene , cioè virtuosamente , in un determinato ambito , occorre possedere
il sapere che renda capaci di ciò . A questo risultato egli perviene
mediante l'analogia con le tecniche : il buon artigiano che sa svolgere
bene la propria attività possiede un sapere capace di guidarlo a questo
risultato . La stessa cosa deve valere in ambito etico-politico : questo è il
nocciolo della famosa tesi secondo cui la virtù è scienza . Questa tesi
conduce ad alcune conseguenze . In primo luogo , chi conosce che cosa è
bene e quindi anche che cosa è buono per lui non può non farlo . Il bene è
dotato di un potere incontrastabile di attrazione . Ciò non significa che
Socrate disconosca l'importanza delle passioni e delle emozioni nella vita
umana , ma soltanto che in ogni ambito della vita umana l'unico
strumento capace di orientare verso il comportamento corretto è ravvisato
nel sapere . La posizione etica di Socrate non va confusa con forme di
rigorismo ascetico . Essa è invece definibile come una forma di
eudemonismo , perchè pone come obiettivo fondamentale il
perseguimento della felicità (in Greco eudaimonia ) . E' il sapere che è in
grado di effettuare un corretto calcolo degli stessi piaceri , misurando le
conseguenze piacevoli o dolorose che essi possono arrecare . Questo è il
sapere , di cui Socrate dichiara di non essere in possesso , ma proprio per
questo è il sapere che egli persegue . Non ha senso allora distinguere le
varie virtù nettamente le une dalle altre : la virtù è una , come uno solo è
il sapere in cui esse si compendiano : sapere che cosa è bene e che cosa è
male .
UNITA’ 3
PARTE 13 CALLIMACO
Vita e opere perdute
Il maggiore dei poeti alessandrini, Callimaco è considerato sia il
principale teorico sia il migliore esponente della poesia ellenistica. Nato
intorno al 300 a. C. a Cirene, in gioventù visse in ristrettezze economiche
e si guadagnò da vivere insegnando in una scuola di provincia; poi, non
sappiamo come, entrò a far parte della corte, ottenendo il favore di
Tolomeo II. Lavorò alla Biblioteca come poeta ed erudito, ma sappiamo
con certezza che non ne divenne mai il direttore. Le sue opere gli
procurarono fama e gloria, ma scatenarono aspri dibattiti con invidiosi
contemporanei. Morì intorno al 240.
La produzione di Callimaco come erudito e come poeta fu immensa: la
tradizione gli attribuiva ben 800 volumi, oggi quasi tutti perduti, tutti di
argomento
erudito:
lessici,
etnografia,
geografia,
curiosità,
toponomastica.
Delle sue opere di prosa la più importante furono i Pinakes, catalogo
ragionato di tutti gli autori e di tutte le opere raccolte nell'immensa
Biblioteca di Alessandria. Oltre a classificare le opere per genere e gli
autori per ordine alfabetico, Callimaco affrontava anche numerose
questioni biografiche e di autenticità. I Pinakes possono essere
considerati la prima opera di storiografia letteraria.
Inni
Gli Inni di Callimaco sono sei, ciascuno indirizzato ad una divinità.
Probabilmente furono composti in momenti differenti e riuniti insieme
solo in un secondo tempo. Sono tutti in esametri, tranne Per il bagno di
Pallade che è in distici elegiaci. Il contenuto degli Inni è di tipo arcaico e
ripreso dagli inni agli dei dello pseudo-Omero, ma affrontandolo con
sensibilità totalmente nuova. Gli dei sono messi sullo stesso piano degli
uomini e compiono le loro stesse azioni. La somiglianza arriva ad un
punto tale che sono descritte la nascita e la fanciullezza del dio.
Callimaco scrive non semplicemente per esporre il mito ma per fare
sfoggio d’erudizione; la sua opera è scritta innanzi tutto per il piacere di
scrivere, e solo in secondo piano c'è l'intenzione di erudire il lettore
(siamo in un'epoca in cui si diffonde il libro, e con lui si allarga la
diffusione della cultura).
Nell'inno Ad Artemide troviamo un’Artemide bambina che tira la barba di
Zeus per farsi ascoltare: una scena tipicamente umana, che potrebbe
avvenire tra qualsiasi figlia e padre e che testimonia la misura di
Callimaco nel ridurre il mondo olimpico all'umano.
In Per il bagno di Pallade è ripreso il mito della dea che si bagna nelle
acque del fiume e viene vista per caso da Tiresia, il quale per punizione
viene accecato, ma riceve la capacità di predire il futuro. La madre di
Tiresia, la ninfa Cariclo, supplica la dea di perdonare il figlio, ma senza
risultato; c’è dunque un distacco tra mondo divino e mondo umano. Il
contenuto è tipicamente aulico, ma non c'è la passionalità tipica di una
situazione del genere; troviamo delicatezza e malinconia, con la tendenza
a sfumare tutti i toni e a renderli il più delicati possibile.
L'inno A Demetra descrive una processione in onore della dea, durante la
quale viene portato un cesto di offerte sui cui lati è raffigurato il mito di
Erisittone, che aveva tagliato delle querce sacre alla dea ed era stato
punito con una fame insaziabile che lo aveva portato alla morte. La
narrazione procede basandosi sull'umorismo della situazione più che sulla
sua tragicità, senza offrire alcun messaggio etico.
Epigrammi
Gli epigrammi di Callimaco si caratterizzano per la loro brevità e per il
fatto che al centro di ogni componimento è posto il sentimento, anche se
trattato con la consueta ironia e raffinatezza. A noi ne sono pervenuti 63,
la maggior parte di argomento funerario, ma alcuni anche riguardanti
l'autore stesso.
Aitia
Gli Aitia erano l'opera più vasta di Callimaco: contenevano circa 4000
versi divisi in quattro libri, in cui (nei primi due) il poeta incontrava in
sogno le Muse e chiedeva loro le varie origini (aitia, appunto) di certe
usanze. Non si trattava di un'opera ordinata, bensì di una raccolta di
numerose elegie, in genere indipendenti tra loro. Ogni aition era dedicato
alla ricerca delle origini di una festa, di una città, di un mito, di
un'istituzione. Oggi ci rimangono, oltre a riassunti pairacei e frammenti i
varia estensione, che ci consentono di recuperare la struttura dell'opera e
alcuni brani, il proemio ed alcuni frammenti, tra cui la Chioma di
Berenice (un frammento dell'originale e la traduzione latina di Catullo).
Nonostante l'apparente contenuto scientifico, gli Aitia sono in realtà
un'opera di intrattenimento, uno sfoggio di erudizione in cui risalta
soprattutto la raffinatezza dell'arte di Callimaco.
Il proemio è un'invettiva di Callimaco contro i Telchini, soprannome dato
ai poeti invidiosi del suo successo. Il poeta imputa ai Telchini di non
misurare la poesia con i canoni della qualità, ma della quantità, e che vale
più un prodotto raffinato di un grande e noioso poema. Ci è pervenuto un
elenco papiraceo di questi Telchini, in cui stranamente non figura il nome
di Apollonio Rodio, ritenuto dagli antichi acerrimo rivale di Callimaco.
La Chioma di Berenice è l'aition che chiude il quarto e ultimo libro
dell'opera. La chioma stessa narra in prima persona la sua storia: fu
offerta in voto dalla regina Berenice in occasione della partenza del
marito, Tolomeo Evergete, per una spedizione militare in Siria. Ma
scomparve dal tempio e l'astronomo di corte la scoprì in cielo,
trasformata nella costellazione che da lei prese il nome. Quest’elegia
piacque a Catullo, che la tradusse in latino nel carme 66; ed è nella sua
traduzione che oggi è a noi nota. In quest’elegia l'esaltazione del sovrano
si unisce a quella della fedeltà coniugale: non si tratta solo di riscontrare
un evento umano nella sfera celeste, ma piuttosto di elogiare con
discrezione il sovrano e la sua consorte con la misura tipica del poeta di
Cirene.
Giambi
Erano tredici componimenti caratterizzati da una grandissima varietà di
metro e di contenuto, che sembrano essere antesignani della satira latina.
I meglio conservati sono il primo e il quarto; quest'ultimo, bellissimo,
narra un fortissimo contrasto tra l'alloro e l'ulivo.
L'alloro e l'ulivo si sfidano su chi sia la pianta migliore, vantando
ciascuno le proprie qualità e l'uso che fanno gli uomini dei loro rami (le
piante non solo sono assunte a soggetto dell’opera, ma sono addirittura
personalizzate). Tra i rami c’è una coppia di usignoli molto ciarliera
(rappresentante della voce del popolo) che fa da arbitro alla sfida. Chi li
creò? Atena l'ulivo e Apollo l'alloro; in questo sono pari perché gli dei
sono tutti sullo stesso piano. Chi li ha trovati? Pallade trovò l'ulivo,
mentre l'alloro, come tante altre piante, fu trovato dalla terra e dalla
pioggia; qui l'alloro perde un punto. A cosa servono? L'alloro a dare
gloria poetica, mentre l'ulivo costituisce il cibo dell'uomo (c’è qui
un’attenzione all'aspetto pratico delle cose, anticipatore dell'utile latino);
in definitiva vince l'ulivo. Interviene nella disputa un vecchio rovo a fare
del moralismo, ma è subito messo a tacere. E' ovvio che alla base di
questo giambo ci deve essere stata una disputa letteraria, ma ne
ignoriamo i dettagli.
Ecale
Era un poemetto di ca. 1000 versi su Teseo ospitato da una vecchia,
Ecale.
Si trattava del primo epillio, un genere dunque inventato da Callimaco,
che quindi aveva modo di fare poesia privata e intima, più reale, ma
anche raffinata, per la brevità, e per la scelta di un mito raro.
In questo epillio, conservato in frammenti molto brevi, Callimaco rompe
quindi con l'epica ed i suoi temi, inserendo la sua poetica della brevitas e
dell'ironia, umanizzando l'eroe e trascurando i grandi temi guerreschi.
Conclusioni
Callimaco crea una poesia vitale e anticlassicista: formula perciò una
poetica adatta al gusto alessandrino per il "bocconcino" prezioso. Infatti
trascura l'eros, che rappresenta una concezione poetica ormai superata, e
comprende ed impugna consapevolmente una poetica più adatta al gusto
dei tempi, volta a rivitalizzare la poesia.
Callimaco è dunque un poeta con la coscienza del nuovo, che gli deriva
dal sentire il netto distacco tra lui e la poetica antica: tale distacco è però
sentito in maniera dinamica, con la continua oscillazione, nelle sue opere,
tra tradizione e modernità.
UNITA’ 3
PARTE 14 APOLLONIO RODIO
In genere i poeti alessandrini attingevano alla tradizione epica per
ricavarne non un ampio poema volto all'esaltazione di gesta eroiche, ma
un componimento breve e raffinato; a questi fa eccezione Apollonio
Rodio. Apollonio Rodio nacque ad Alessandria d'Egitto intorno al 290
a.C. e soggiornò a lungo a Rodi (da qui l'appellativo di Rodio). L'unica
altra notizia certa della sua vita è che divenne direttore della Biblioteca.
Apollonio Rodio viene generalmente visto in contrapposizione con il suo
ex maestro, Callimaco; in realtà questa rivalità è per alcuni aspetti solo
apparente. Apollonio aveva in effetti uno stile molto diverso da quello dì
Callimaco, e riteneva di poter scrivere un’opera di carattere epico in età
ellenistica. Scrisse effettivamente un’opera gigantesca, le Argonautiche,
unico poema ellenistico a noi pervenuto. Non gli riuscì di raggiungere
l'acme della poesia in ogni punto dell’opera (era questo il suo intento),
ma il III libro è rispondente ai canoni ellenistici e anzi supera per bellezza
le opere di molti poeti a lui contemporanei. Paradossalmente Apollonio
Rodio, che non voleva assolutamente essere vox dell’ellenismo, ne
diventa una sorta di emblema.
Le Argonautiche
Sono un poema in esametri lungo circa seimila versi divisi in quattro
libri. Narra le vicende della spedizione degli Argonauti, dalla partenza da
Iolco fino al ritorno in Grecia. Il I, il II (che descrivono il viaggio di
andata nella terra della Colchide) e il IV (dedicato al ritorno in patria)
sono molto pesanti, ma il terzo, che racconta l'amore tra Giasone e
Medea, è considerato uno dei capolavori dell'ellenismo. Eccettuato il
terzo libro, si può affermare che Apollonio non si inserisce a viva forza
nel mito, mutandolo o spezzandolo, ma lo mantiene sostanzialmente
inalterato; ad esempio, il poema inizia con la descrizione dei partecipanti
alla spedizione, che ricalca l'elenco delle navi che presero parte alla
guerra di Troia contenuto del II libro dell'Iliade. Giasone viene messo in
evidenza (è l'ultimo ad essere nominato), ma di lui sono descritti i tratti
più umani; non è presentato come anhr, ma nemmeno come uomo
emblema dell'ellenismo; ha dei sentimenti, ma non c’è uno scavo
psicologico profondo. Egli vuole raggiungere il proprio fine (conquistare
il vello d'oro), ma non scavalca il suo mondo sentimentale (come invece
fece Enea). Giasone resta freddo (mentre il Giasone di Euripide ha un suo
mondo sentimentale in cui crede), a metà strada tra uomo e eroe.
Il III libro è incentrato su Medea e sul suo amore per Giasone. Eeta, re dei
Colchi e padre di Medea, impone a Giasone durissime prove da affrontare
prima di entrare in possesso del vello d'oro con la speranza che il greco
muoia nel corso delle prove. Ma Medea, colpita da una freccia di Eros,
s’innamora a prima vista di Giasone; la ragazza trascorre una notte agitata
da angoscianti sogni, nei quali la vergine fedele al padre si scontra con la
donna colpita dalla passione per l'amato. Nella mente di Medea balena
anche l'idea del suicidio, ma il bel ricordo della vita trascorsa la fa tornare
sui suoi passi e, momento dopo momento, matura l'idea di salvare
Giasone, procurandogli delle pozioni indispensabili per superare la prova.
Il mattino seguente Medea, con il cuore che le sobbalza in petto (cuore
reso con kardia, a rilevare la fisicità del sentimento di Medea), incontra
Giasone che si avvia per affrontare la prova e, offrendogli le pozioni, gli
confessa il suo amore. E Giasone la rassicura dai suoi timori assicurando
che la porterà con sé in Grecia, dove, onorata da tutti per l'aiuto reso agli
Argonauti, vivrà per sempre accanto a lui: questo è il suo pegno d'amore.
Poi Giasone, grazie all'aiuto di Medea, supera la prova.
Nel corso del terzo libro emergono dei concetti particolari. Innanzitutto
quello della maledizione, che colpisce non solo il diretto interessato ma
anche la sua famiglia e i suoi figli. Assume un valore particolare anche la
memoria del passato; il ricordo assume una connotazione personale ed è
privo di qualsiasi valore educativo (il contrario avviene nel mondo latino,
dove il ricordo è sempre oggettivo e si riferisce alle gesta di tutto il
popolo, sia belliche che sociali). Si riscontrano anche delle caratteristiche
peculiari dell'ellenismo, come lo scendere nel particolare (ad esempio
quando Apollonio, anziché parlare di generici alberi, specifica di quali
alberi si tratta, querce e pioppi) o l'azione ripetuta molte volte per
aumentare il paqoV e la tragicità dell'azione. E' invece tipico di Apollonio
il gusto per l'avventura e per l'esotico, e si sofferma a descrivere posti
nuovi, distanti e lontani (sullo sfondo c'è lo sviluppo commerciale
raggiunto dall'ellenismo). Questa voglia di conoscere è però diversa dalla
voglia di fare esperienza (swfrosunh) di Ulisse. Il gusto per l'elemento
naturalistico non si limita al livello descrittivo, ma si presenta anche
come interesse sentimentale nei confronti della natura. Non è questa una
novità per il mondo greco: la partecipazione sentimentale verso la natura
la riscontriamo in Omero e Saffo (1a quale, addirittura, diventava natura);
anche se in Apollonio non c'è un annullarsi dell'elemento umano
nell'elemento naturalistico, ci si arriva vicino sul piano del sentimento.
ooo
Dal 260 al 247 non solo diventa il secondo direttore della biblioteca di
Alessandria, succedendo a Zenòdoto, ma anche precettore di Tolemèo II.
Si reca a Rodi dopo una lite con Callimaco, evidenziata dall’"Ibis", e
l’insuccesso delle "Argonautiche".
Pubblica una seconda edizione delle "Argonautiche", ma è un’ipotesi
poco credibile.
Ha un’intensa attività filologico-letteraria (con poemi su fondazioni di
città, epigrammi e saggi), ma è famoso soprattutto per le "Argonautiche".
"Argonautica" - Con i suoi quattro libri formati da 5.833 esametri
complessivamente è il quarto poema epico pervenutoci per intero dopo
"Iliade", "Odissea" ed "Eneide". Riporta la leggenda degli Argonauti ed il
tentativo di Giasone di riportare in Grecia dalla Còlchide il vello d’oro
posseduto da Eeta, padre di Medèa e dio del sole, tentativo che riesce con
la magia di Medea. Precedenti notevoli si possono rintracciare sia nei tre
tragici che in Pindaro. Di notevole importanza l’invocazione ad Apollo
nel l. I e quella di Eràto, musa della poesia amorosa, nel l. III.
Caratteristiche: motivo dominante è l’amore, non freddo, ma profondo,
mutevole, possessivo, quale quello di Medea. Giasone, problematico ed
incerto, è un po’ il simbolo di un’epoca. Nel poema si notano interessi per
luoghi lontani, ma anche per l’orrido, il macabro, il prodigioso; gli dei,
invece, hanno un qualcosa di benestante e di salottiero, con gli stessi
modi degli umani mortali. Apollonio in esso etichetta tutto, cioè ne cerca
le cause e ne dà la motivazione, mentre per la lingua attinge ad Omero,
Esiodo ed ai prosatori ionici e contemporanei.
CRITICA
GARZYA - Il poema ricalca materia, tecnica narrativa e strutture
dell’epos omerico ed il mito, sempre alla base dell’opera, non ha altro
contenuto se non quello favolistico e leggendario. Ha singoli momenti
felici ("Il sogno di Medea"), ma manca di forza unitaria e sembra così
confermare la teoria callimachea dell’impossibilità di un carme
continuo.
SBORDONE - L’opera manca di omogeneità: vi sono imitazioni
omeriche e pedanterie erudite ed in ciò Apollonio è profondamente
alessandrino. Riesce soprattutto nelle scene brevi, nelle descrizioni di
scorcio, negli episodi.
CANTARELLA - Il poema è il documento di un continuo compromesso
fra la tradizione omerica ed il desiderio di originalità. Esso in effetti è
tutto episodico, frammentario e per di più senza poesia, la sola che
avrebbe potuto galvanizzare un personaggio scialbo come Giasone che
supera tutte le prove con l’aiuto di Medea, non un eroe e nemmeno un
uomo, mentitore, profittatore, spergiuro, senza nemmeno il merito del
seduttore perchè Eros fa tutto per lui. Unica, autentica gemma del poema
la morte di Ila rapita dalla ninfa della fonte del l. I.
Riflessi su... -> VIRGILIO - l’opera di Apollonio è il presupposto
dell’"Eneide", mentre Giasone e Medea le brutte copie di Enea e Didone
-> VALERIO FLACCO - il cui unico merito è quello di aver
scritto un’"Argonautica" in ll. 8, incompiuta.
UNITA’ 3
PARTE 15 TEOCRITO
Del poeta del IV - III secolo a.C. è incerta la data di nascita (forse il 310,
l'anno della vittoriosa spedizione navale di Agatocle in Africa contro i
Cartaginesi). Si sa che in giovinezza si recò a Cos, paese d'origine della
madre: e tale viaggio comportò il suo ingresso nel gruppo dei poeti di
Fileta. Una sua composizione del 275 dedicata a Gerone II, Le Càriti, fa
supporre che egli desiderasse usufruire dei favori della corte per potersi
stabilire a Siracusa come poeta protetto dal tiranno. Riuscì pure a trovare
un sovrano mecenate in Tolomeo II Filadelfo, in Egitto; e ad Alessandria
conobbe Callimaco, grande estimatore dell'opera Ciclope (da confrontare
col frammento dell'omonimo componimento di Filosseno).
Ignoti sono il luogo e la data di morte del poeta.
Teocrito è con ogni probabilità il maggiore poeta dell'età ellenistica, vero
erede del genere bucolico creato da Stesicoro, ma anche poeta di versi
amorosi e leggeri nella descrizione della società del suo tempo. Si
espresse con inni, elegie, liriche, giambi, epigrammi, anche se fu famoso
fin dall'antichità per la freschezza del suo genere bucolico; i
componimenti che ci sono giunti sono appunto nella raccolta dei poeti
bucolici (Artemidoro di Efeso) - età di Silla - insieme a quelli di Mosco,
Bione, ed altri anonimi. In tale raccolta sono attribuiti a Teocrito col
nome di Idilli 30 carmi, 24 epigrammi ed un carme figurato. La critica ne
attribuisce solo 21 al poeta e distinguendoli per la raffinatezza e
l'armonicità dell'ispirazione. La maggior parte di questi (9) sono
propriamente bucolici, hanno cioè contenuto agreste; 4 sono poemetti
epico-mitologici (epilli), 6 sono mimi e componimenti lirici (in metro e
dialetto eolico), 2 sono carmi erotici, 2 encomi. Gli Idilli più famosi sono
senz'altro Dafni, il Ciclope, Le Talisie (che la tradizione vuole composta
nell'isola di Cos), Le siracusane, Ila, Epigrammi, Arsinoe, Tirsi,
Serenata, Pecoraio, Eracle bambino, Syrinx, Le Incantatrici, I Mietitori,
L'amore di Cinisca, Le Càriti (encomio di Gerone II, che ha dei
riferimenti alla guerra che stava per iniziare contro i cartaginesi e che è da
situare nel 276 aC), il Tolomeo (encomio di Filadelfo, che ci suggerisce il
suo viaggio in Egitto sia avvenuto verso il 271 circa), La fattura, La visita
d'amore, Dioscuri, Berenice. Alcuni di questi idilli ispireranno Virgilio.
Il metro di Teocrito è l'esametro epico che illustra aspetti tradizionali
dell'arte e della cultura siciliana, ma vuole essere comunque gradito alla
sua epoca, aggiornandosi alle tendenze elleniche della letteratura, pur
traendone nuovi effetti musicali e senza disdegnare il dialetto dorico della
città natia. Oltre al genere bucolico e descrittivo d'ambienti Teocrito si
dedicò naturalmente alla tematica mitologica. La sua nascita a Siracusa,
oltre che dalla tradizione, ci è confermata dalla Suda.
"La sensibilità naturalistica, aliena da risonanze mistiche, ma forte e
profonda, è forse la caratteristica più intima dell'arte di Teocrito"
UNITA’ 3
PARTE 16 MENANDRO
Solo pochi decenni separano l’ultima opera di Aristofane, il “Pluto”,
dall’esordio teatrale di Menandro con l’”Orgè”: eppure questo breve lasso
di tempo fu foriero, per tutta la Grecia e per Atene in particolare, di
conseguenze tanto traumatiche che le opere dei due commediografi
risultano profondamente diverse, soprattutto nei contenuti.
Fu proprio la città di Atene a subire i danni maggiori, anche dal punto di
vista psicologico, ed i suoi cittadini più sensibili – gli intellettuali – ne
rimasero sconvolti: in pochissimi anni si è rivelata loro la limitatezza e la
piccolezza dell’uomo; la tuch, che diverrà non a caso la protagonista
indiscussa delle commedie menandree, ha ridotto la capitale culturale
dell’Ellade intera, la padrona dei mari, la democrazia in cui vige la
libertà, ad un protettorato dei Macedoni, sottoposta al governo dello
straniero.
Il commediografo, che dovette assistere impotente al ridimensionamento
della sua polis e subire di persona i catastrofici effetti del rovesciamento
di Demetrio Falereo, suo amico e protettore, riflette dunque nelle sue
opere una nuova e triste visione della realtà: non c’è più spazio per
l’esuberanza, la vitalità, la forza, la sicurezza e persino per la spavalderia
che rasenta i limiti dell’ubris, come accadeva per Diceopoli, cui era
sufficiente la potenza della parola – così egregiamente padroneggiata da
Aristofane – per abbattere tutti i suoi nemici; non v’è più motivo di
pungere avversari personali e personaggi pubblici, né di descrivere
l’animata vita dell’agorà o della bulè: dalla dimensione politica,
riguardante cioè la comunità nella sua interezza, si passa a quella più
modesta e sommessa della casa e del nucleo familiare.
Non ha più alcun senso la parabasi, in cui il coro discute con gli spettatori
dei problemi di attualità, perché ormai l’”attualità” è imposta dallo
straniero e non è più il frutto dell’assemblea dei cittadini.
Ecco che, allora, l’uomo ricorre, per salvarsi dallo sfacelo della sua città,
all’unico strumento rimastogli, la ragione. Vengono pertanto eliminati
dalle commedie tutti gli elementi dell’inverosimile e del fantastico
aristofanesco, che stonerebbero con il sobrio realismo cui si cerca di dar
vita. Menandro salva, invece, l’uomo, dopo averlo però totalmente
spogliato della sua patina di “invincibilità”.
Il pensiero del commediografo ( “Ws carien est’anqrwpos” ) però è ben
lontano dalla forza di quello di Sofocle, che affermava convinto: “Molte
sono le cose deina, ma nulla è deinoteron anqrwpou”.
Deinos è il termine tecnico della retorica per indicare la meraviglia e lo
stupore che un discorso può suscitare negli spettatori: è il riflesso della
fiducia che tutta un’epoca aveva riposto nelle capacità dell’uomo e della
sua parola. Anche la postilla menandrea, infatti, sembra il compianto di
un tempo migliore: “Che bella cosa è l’uomo, quando è uomo davvero”,
pare infatti evocare i tempi in cui il poliths ateniese si sentiva padrone del
mondo.
Nella nuova Atene menandrea, dunque, che appare quasi vuota in
confronto a quella caotica e viva di Aristofane, una volta scomparsi i
grandi “nemici”, come Cleone o Lamaco, l’ambiente domestico ed
appartato, usato nelle ambientazioni, suggerisce quasi spontaneamente
l’analisi psicologica, che, tuttavia, rimane alquanto superficiale.
Non a caso, infatti, Menandro è stato accusato di essersi lasciato troppo
influenzare dagli stereotipi proposti dai “caratteri” di Teofrasto, forse per
ricondurre al razionale – grazie a questi topoi –anche ciò che sfugge ad
uno schema preciso: è probabilmente per questo motivo che l’Atene di
Menandro, che dovrebbe essere più realistica di quella apertamente
“fantastica” di Aristofane , appare ugualmente artificiale.
Addentrandosi, dunque, nell’introspezione psicologica e nella vita
cittadina, si incontra il “rispetto”: il termine stesso utilizzato per indicarlo
non può però fare a meno di suscitare il senso di oppressione della
“società dell’ aidws” omerica; si parla poi di autocontrollo dei personaggi
proprio per contrapporsi deliberatamente alla sfrenatezza esasperata di
Aristofane. Si parla infine di jilanqropia – nelle commedie di Menandro
persino le etere talvolta si ravvedono e sono pronte ad aiutare il
protagonista – per non cadere nello sconforto della solitudine, dopo la
scomparsa della dimensione sociale della polis.
Ecco, allora, l’immagine di una città inevitabilmente “sospesa” e
cristallizzata in questa dimensione ideale, in cui tutti cercano di trovare
un’armonia ed inseguono un accordo, perché – perso ogni potere sulla
realtà esterna – essi possano almeno mantenere un lucido dominio su di
sé (swjrosunh).
A Menandro, tuttavia, non poteva sfuggire l’amara verità, che continua a
riaffiorare in tutte le sue commedie, almeno per quanto siamo in grado di
ricostruirle. Le trame complesse, l’accavallarsi confuso e convulso di
ritrovamenti ed anagnwriseis e gli scambi di identità lasciano infatti
trasparire l’assoluta mancanza di ordine e sicurezza e denunciano
apertamente che l’uomo, per salvarsi dal crollo della sua polis, si è
rifugiato in una dimensione strettamente privata, ma non è riuscito a
sfuggire alla tuch beffarda.
Il commediografo stesso si accorge, con sgomento, che l’essere umano ha
perduto l’apparente controllo sul proprio destino. L’umorismo delle sue
opere, dunque, è molto più contenuto di quello aristofanesco, tanto che –
in alcuni passi – rasenta la malinconia.
Menandro non fu molto amato dai suoi spettatori, se è vero che,
nonostante una produzione di più di cento commedie, vinse solo otto
volte: gli Ateniesi dovettero forse accorgersi di quanto fosse amaro veder
rappresentata la propria disgrazia, di quanto fosse doloroso correre con il
ricordo ai tempi – non lontani – in cui ancora la loro polis esercitava una
vera e propria egemonia su tutta la Grecia e di quanto costasse infine
confrontare quell’ampio impero con la sconfortante ristrettezza
dell’ambiente domestico.
UNITA’ 3
PARTE 17 POLIBIO
Nato in Arcadia poco prima del 200 a.C. da una famiglia di stampo
aristocratico che partecipava attivamente alla Lega achea, Polibio fece la
sua carriera politica all'interno della Lega aderendo al partito avverso ai
romani, finchè, dopo la battaglia di Pidna, all'interno della Lega prevalse
il partito filo-romano e per sua istigazione furono deportati a Roma mille
cittadini del partito avverso, tra cui Polibio. L'esilio durò 17 anni e
costituì una svolta importantissima nella sua vita e nel suo pensiero;
ospitato nella casa del vincitore di Pidna, il console Emilio Paolo, entrò in
amicizia con il più giovane dei suoi figli, Scipione Emiliano, il quale lo
introdusse nel circolo degli Scipioni. A contatto con il pensiero politico,
culturale e filosofico (lo stoicismo stava allora diventando l'ideologia
della classe dirigente) della Roma del tempo, Polibio cominciò a
modificare la sua ostilità di cittadino acheo e a ricercare le cause della
prepotente ascesa della potenza romana. Lentamente si convertì alla
causa di Roma e si convinse che il suo impero era voluto dalla stessa
tuch. A questo periodo risale a composizione delle Storie. Finalmente nel
150 Polibio potè far ritorno in patria, ma non vi rimase a lungo; seguì
Scipione Emiliano nella terza guerra punica a fianco del quale assistι alla
caduta di Cartagine, e compì numerosi viaggi per visitare quei luoghi che
andava descrivendo nelle Storie. Morì in patria a 82 anni per una caduta
da cavallo.
Le Storie
Opera in 40 libri dello scrittore greco Polibio (c. 205-121 a.C.)
I primi due libri sono introduttivi e riassuntivi dell'arco di tempo dal 264
al 221, mentre i libri III-XL contengono gli avvenimenti dal 220 al 146.
Di questa grande opera rimangono i libri IV, ampi excerpta dei libri
VIXVIII, frammenti degli altri, che provengono da citazioni e dall'opera
enciclopedica di Costantino il Porfirogenito; dei passi perduti aiutano la
ricostruzione Cicerone Diodoro Livio, Plutarco. La disposizione della
materia la seguente: nel I libro la prima guerra punica e lotta di Cartagine
contro i mercenari ribelli; nel II libro la guerra illirica, l'ultima guerra
gallica, le imprese dei Cartaginesi in Spagna, la storia della lega achea
alla battaglia di Sellasia; nel III libro gli avvenimenti della seconda guerra
punica fino a Canne; nel IV e V libro le vicende contemporanee
dell'Oriente greco, la guerra sociale degli Achei, la quarta guerra di
Celesiria tra Antioco III e Tolomeo IV Filopatore; nel VI l'analisi della
costituzione romana; nel VII la polemica contro gli storici precedenti, in
particolare contro Timeo; nel XXXIV libro la descrizione geografica del
mondo mediterraneo; nel XL e ultimo libro il riassunto di tutta l'opera. Si
è discusso se Polibio abbia voluto dedicare la sua opera ai Greci o ai
Romani, molto di più si è discusso sulla data di composizione e di
pubblicazione: intenzione dell'autore è scrivere una storia "universale" e
"prammatica": è polemico contro la storiografia retorica d'origine
isocratea, escludendo tutti gli orpelli oratori, sdegnando le rielaborazioni
dei discorsi e rifiutando ogni carattere declamatorio: "Tanto gli scrittori
che i lettori della storia non devono badare soltanto ai fatti in sè, ma agli
avvenimenti che li hanno preceduti, accompagnati, seguiti. Se si toglie
infatti alla storia l'esame delle cause, dei mezzi, degli scopi di ogni
impresa compiuta e la ricerca del risultato che essa ha conseguito, quello
che ne rimane può essere un ottimo saggio retorico, ma non genera
apprendimento e al momento procura diletto, ma non produce per il
futuro utilità alcuna" (III, cap. 31). Il libro XII è una spietata critica a
Timeo: problema centrale è quello etiologico con la distinzione di aitìa, di
pròfasis, di archè (la causa vera, il pretesto, l'inizio d'un fatto). I mezzi di
ricostruzione sono individuati nell'accertamento filologico, nell'autopsia
topografica e nella competenza militare e politica: "E' compito dello
storiografo prima di tutto quello di informarsi di tutti i discorsi
effettivamente pronunciati, senza distinzione alcuna, poi quello di
ricercare la causa del successo o dell'insuccesso di quanto fu detto o
compiuto; infatti la nuda esposizione degli avvenimenti può interessare,
ma non giovare, mentre se si adduce la causa degli eventi esposti, la
storiografia riesce veramente utile". La storia prammatica comprende
anch'essa tre parti: studio diligente dei documenti e delle memorie, visita
alle città, alle regioni, ai fiumi e ai porti, conoscenza della politica:
"Conoscere gli scritti più antichi è utilissimo se si vogliono apprendere le
opinioni di chi ci ha preceduto e le notizie che gli antichi avevano di
determinate località, popoli, governi, azioni ecc." (XII, cap. 25). Dalla
storia di Polibio scompare dall'indagine ogni fattore extraumano ed
extrarazionale; vi si nota un sostanziale ateismo, un astio aggressivo
contro la superstitio; così la storia polibiana è esposizione non di
genealogie o mitiche fondazioni di città, ma esposizione delle azioni
politiche: infatti prammatica significa politica, e da qui nasce l'utilità
della storia, che deve servire a formare gli uomini politici che così
faranno esperienza, leggendo le cose del passato. La storia, in
conclusione, è insegnamento. Quanto poi al fatto di scrivere una storia
universale, cioè catholikè, Polibio si ispira a Eforo e mette cos in pratica
quel cosmopolitismo, tanto tipico dell'ellenismo: qui l'idea cosmopolita si
incarna nella realtà dell'egemonia di Roma, che è la grande scoperta
dell'esule greco; di fronte alle due Costituzioni romana e cartaginese,
Polibio avverte la genialità della Costituzione romana, anzi sulle
Costituzioni ci offre una curiosa teoria distinguendo tre forme di
Costituzione: monarchia, aristocrazia, democrazia, ognuna delle quali
tende a degenerare nella cattiva forma corrispondente: tirannide,
oligarchia, oclocrazia. Ogni popolo, secondo Polibio, deve percorrere
l'intero ciclo dalla monarchia alla oclocrazia; dalla quale alla fine nascono
l'anarchia, il disordine, il trionfo degli istinti brutali: dal caos
dell'oclocrazia sorge di nuovo la monarchia, così il ciclo ritorna e si ha
l'anachìclosis. Perciò il motore unico delle azioni umane è l'utilità, mentre
la religione non è altro che un instrumentum regni, che serve a tenere a
freno la folla, ma è inutile per i savi. Come scrittore Polibio è uno dei
peggiori; la sua lingua è quella delle cancellerie ellenistiche, la prosa è
"slombata e stentata" (Perrotta), la lettura difficile e sgradevole: ammirato
da Mommsen, fu particolarmente elogiato da Croce.
UNITA’ 3
PARTE 18 LUCIANO
Luciano di Samosata (in greco: Λουκιανὸς Σαµοσατεύς; in latino:
Lucianus Samosatensis; Samosata, 120 circa – Atene, tra il 180 e il 192) è
stato uno scrittore e retore greco antico di origine siriana, celebre per la
natura arguta e irriverente dei suoi scritti satirici.
Biografia
Di origine siriana, secondo un'usanza diffusa ricevette alla nascita un
nome latino, ma questa sua origine “barbara” non fu mai motivo di
vergogna per lui che, anzi, si dichiarava apertamente siriano e non greco
in alcuni suoi scritti, nonostante la sua personalità intellettuale presenti
caratteristiche prettamente ellenistiche.
Seguendo la tradizione della famiglia materna, ebbe una breve e
deludente esperienza nel laboratorio di scultura dello zio, dal quale il
futuro scrittore fu cacciato dopo aver distrutto una lastra di marmo che
doveva essere sgrossata. Scoperta la vocazione letteraria, egli studiò
presso i sofisti dell'epoca, in Asia Minore, la grammatica e la retorica,
assicurandosi una perfetta assimilazione della lingua greca e dei principi
culturali dell'ellenismo.
Successivamente Luciano fece moltissimi viaggi, in qualità di maestro di
retorica e conferenziere, o come ambasciatore della sua città natale, in
Asia Minore, Grecia, Italia e Gallia. Inoltre egli svolse la attività di
avvocato in Antiochia di Siria (155-158). Nel 159 fu inviato come
ambasciatore a Roma, dove ebbe l'occasione di entrare in contatto con il
filosofo neoplatonico Nigrino, da cui si fece influenzare. Tornato ad
Antiochia (160) vi rimase fino al 162, pur recandosi talvolta in Grecia. In
veste di segretario della cancelleria imperiale si trasferì in Egitto, dal 173
al 176. Dopo questo incarico, egli si stabilì definitivamente ad Atene,
dove morì dopo il 180.
Opere
La produzione letteraria di Luciano spazia su generi ed argomenti tra loro
molto differenti ma con una costante di fondo: la critica e la satira nei
confronti delle scuole ufficiali così come dei pregiudizi dell'opinione
volgare.
Nell'ambito delle esercitazioni retoriche e delle declamazioni sofistiche
sono da segnalare Falaride I e II, il Diseredato e il Tirannicida, oltre
all'Elogio della mosca, che rientra negli encomi paradossali, genere in
voga presso i retori dell'epoca.
Tra le sue opere più significative c'è il trattato Come si deve scrivere la
storia, esortazione ad una storiografia fondata sull'obiettività e lontana da
ogni forma di adulazione dei potenti. Quasi come antifrasi alle sue teorie
scrisse la Storia Vera, racconto fantascientifico di viaggi al di là delle
colonne d’Ercole, in cui i protagonisti, tra cui lo scrittore, incontrano
creature fantastiche, arrivando addirittura a viaggiare nello spazio e ad
incontrare i Seleniti, antichi extraterrestri: si tratta di una divertente
parodia nei confronti delle opere di poeti, storici e filosofi contemporanei.
Si richiama ai canoni del genere romanzesco greco un altro famoso
componimento (la cui attribuzione a Luciano peraltro è incerta) dal titolo
Lucio o l'asino.
La sua fama è però soprattutto legata ai dialoghi, alcuni dei quali sono
raggruppati in modo da formare delle serie organiche (i Dialoghi degli
dei, i Dialoghi marini, i Dialoghi dei morti, i Dialoghi delle cortigiane),
mentre il gruppo più importante è costituito dai dialoghi di contenuto
morale, filosofico e religioso, caratterizzati da una vis satirica e polemica,
acre soprattutto verso i cinici, e da una evidente simpatia verso Epicuro:
tra questi, si segnalano Menippo o la necromanzia, Icaromenippo,
Caronte, Zeus confutato, Zeus tragedo, Prometeo o il Caucaso, l'
Assemblea degli dei, Due volte accusato, la Vendite delle vite all'asta e
l'Alessandro o il falso profeta, La vita di Demonatte, La morte di
Peregrino.
Tra le sue tante attività, si dedicò anche alla raccolta di storie e leggende
della tradizione greca. E a quanto pare fu lui a "creare" la figura di
Filippide, il soldato greco che corse ad Atene dopo la battaglia di
Maratona senza fermarsi per poter annunciare "Niké! Niké!" ("Vittoria!
Vittoria!") e spirare subito dopo. Pare che in realtà Filippide fosse un
antico messaggero greco per nulla collegato alla battaglia di Maratona,
mentre il soldato morto dopo l'annuncio pare si chiamasse Tersippo o
Eucle. Tuttavia gli storici contemporanei della battaglia (Erodoto in
primis) non fanno alcun riferimento a tale avvenimento). Dal mito di
Filippide e della sua corsa Pierre de Coubertin trasse l'ispirazione per la
creazione dell'odierna maratona.
UNITA’ 3
PARTE 19 PLUTARCO
La vita
Quasi tutto ciò che sappiamo circa la vita di Plutarco si ricava da
riferimenti interni alle sue stesse opere: in esse, egli ricorda (Moralia
385 b) di essere stato discepolo del platonico Ammonio nell’età in cui
Nerone soggiornò in Grecia (66-67 d.C.); da questo riferimento, è
possibile collocare la nascita di Plutarco poco prima del 50 d.C. Sempre
nei suoi scritti, egli narra che la sua famiglia fu funestata dalla scomparsa
prematura dei cinque figli che Plutarco ebbe dalla moglie Timossena.
Plutarco trascorse la maggior parte della propria esistenza nella nativa
Cheronea, in Beozia, (diceva scherzosamente di non volerla rendere più
piccola andandosene), ma ciò non gli impedì di fare importanti viaggi sia
in Grecia sia nelle altre zone dell’Impero: e così si recò ad Atene (ove fu
insignito della cittadinanza onoraria), a Sparta, ad Alessandria e forse
anche in Asia; ebbe modo di visitare l’Italia e di soggiornare a Roma,
senza però riuscire ad impadronirsi alla perfezione della lingua latina per
via dei molteplici impegni politici e culturali che lo impegnarono ( Vita di
Demostene, 2, 2). Plutarco divenne cittadino romano col nomen di
Mestrio (tratto dall’amico Mestrio Floro) e gli fu conferita da Traiano la
dignità consolare, da Adriano quella di suo ambasciatore in Grecia. È
curioso che di queste cariche prestigiose, di cui ci dicono Eusebio e il
lessico Suda, Plutarco non faccia mai menzione nei suoi scritti: questa
apparente stranezza è probabilmente dovuta alla fierezza greca di
Plutarco, che per tutta la vita non volle vantarsi di cariche esercitate in
favore del potere romano. Quest’ipotesi trova una potente conferma nel
fatto che egli elenchi nei suoi scritti una dopo l’altra tutte le cariche da lui
rivestite in Beozia (arconte eponimo, sovrintendente all’edilizia pubblica,
telearco). L’incarico che più ebbe a cuore fu però quello di sacerdote
delfico, che detenne per circa un ventennio e che molta influenza ebbe
sulla sua spiritualità. Molte incertezze permangono sulla data della morte
di Plutarco, che dovette in ogni caso coglierlo in età piuttosto avanzata: se
prestiamo fede a Eusebio, Plutarco non sarebbe morto dopo il 119 d.C.,
anche se c’è chi sposta la data fino al 125.
Le opere
I titoli delle opere scritte da Plutarco ci sono stati tramandati dal
cosiddetto “catalogo di Lampria”, nome che il lessico Suda attribuisce
erroneamente ad un figlio di Plutarco stesso che avrebbe compliato il
catalogo degli scritti del padre. In alcuni manoscritti il catalogo è poi
preceduto da un’epistola nella quale un mittente anonimo scrive ad un
altrettanto anonimo destinatario chiedendo di inviargli una lista degli
scritti del proprio padre. Oggi si pensa che tanto l’epistola quanto il
catalogo siano certamente di epoca posteriore, e si è fissata alla notevole
cifra di 260 il numero delle opere di Plutarco (di cui però alcune sono
sicuramente spurie). Di questa impressionante produzione a noi è giunto
soltanto un terzo. Le opere di Plutarco possono essere suddivise in due
grandi gruppi: le Vite parallele (che ci sono giunte in numero di 50) e i
Moralia ( Ethicà), dei quali sono sopravvissuti circa 70 scritti (non
contando quelli sicuramente falsi). Le 50 Vite parallele non sono altro
che 50 biografie di uomini illustri del mondo greco e romano (con
l’eccezione di quella del persiano Artaserse); di queste, 44 risultano
ordinate secondo coppie di personaggi appartenenti ai due popoli
(Alessandro-Cesare, Demostene-Cicerone, e così via), aspetto che
giustifica la denominazione di “parallele”. Nella sua opera, infatti,
Plutarco instaura un vero e proprio parallelo tra le vite di illustri Romani
e quelle di illustri Greci, operando un vero e proprio confronto ( sùgrisis)
tra il personaggio greco e quello romano presi in esame e spiegando le
ragioni di tale parallelismo. Solo quattro vite (Arato, Artaserse, Galba,
Otone) sono singole, e una delle coppie risulta costituita da due
personaggi per parte (Agide e Cleomene-Tiberio e Gaio Gracco),
portando il numero delle biografie a 50. Nei manoscritti, le 22 coppie ci
sono state tramandate nel modo seguente:
1 Teseo-Romolo; 2 Solone-Publicola; 3 Temistocle-Camillo; 4 AristideCatone il Vecchio; 5 Cimone-Lucullo; 6 Pericle-Fabio Massimo; 7 NiciaCrasso; 8 Alcibiade-Coriolano; 9 Demostene-Cicerone; 10 FocioneCatone il Giovane; 11 Dione-Bruto; 12 Emilio Paolo-Timoleonte; 13
Sertorio-Eumene; 14 Filopemene-T. Flaminio; 15 Pelopida-Marcello; 16
Alessandro-Cesare; 17 Demetrio-Antonio; 18 Pirro-Mario; 19 Agide e
Cleomene-Tiberio e Gaio Gracco; 20 Licurgo-Numa; 21 Lisandro-Silla;
22 Agesilao-Pompeo.
Va notato che i paralleli sopra indicati col numero 3, 10, 16 e 18 sono gli
unici privi del confronto. Il procedimento del confronto tra personaggi
illustri non era certo una novità (basti pensare alla celebre comparatio tra
Catone e Cesare nel cap. 54 della Congiura di Catilina di Sallustio), ma è
sicuramente innovativo nella sua raffinatezza l’uso che ne fa Plutarco:
egli accosta un personaggio greco ad uno latino con l’intenzione (insieme
politica e culturale) di avvicinare i due popoli e le due civiltà, superando i
rispettivi pregiudizi e favorendo una collaborazione incentrata su un
rapporto di stima e rispetto reciproci. In un contesto in cui il dominio
romano è una realtà indiscutibile, ma in cui al tempo stesso la Grecia, col
suo glorioso passato, non vuole essere relegata ai margini come mera
colonia, Plutarco sa bene che la sua è una missione storica di unificazione
e conciliazione tra due realtà diverse e potenzialmente in conflitto. Il
mondo greco e quello romano sono da Plutarco intesi come due mondi
complementari, quasi come se quello romano non fosse altro che una
riproposizione in parallelo degli antichi eroi greci, migrati a Roma. Il
mondo romano non segna dunque la fine di quello greco, ma piuttosto la
sua continuazione. Ma non è questo l’unico scopo dell’opera plutarchea:
ve n’è un altro, altrettanto importante, che Plutarco enuncia nell’esordio
della Vita di Emilio Paolo, allorché spiega che, “guardando nella storia
come in uno specchio”, egli prova a modellare in qualche modo la sua
vita sulle virtù dei protagonisti della storia, aggiungendo che “non esiste
modo migliore e più piacevole di migliorare i propri costumi”. Le virtù
degli eroi storici sono dunque un paradigma da cui mai bisogna
allontanare lo sguardo e che dev’essere conosciuto per poter essere
imitato. Plutarco sa bene che, per questa via, si esce dai sentieri della
storia per imboccare quelli delle biografie personali, e lo dichiara
programmaticamente nella Vita di Alessandro (I, I, ss.):
“Noi non scriviamo storie, ma biografie. […] Come dunque i
pittori ricavano le somiglianze dal volto e dai tratti
esteriormente visibili, attraverso i quali si manifesta il
carattere, così a noi dev’essere concesso di penetrare
maggiormente nei segni rivelatori dell’animo e mediante
questi dare un’immagine della vita di ciascuno, lasciando ad
altri le grandezze e le contese”.
Nel tratteggiare la vita dei suoi personaggi, Plutarco parte solitamente
dalla gioventù, su cui si sofferma con particolare insistenza, giacché la
intende come il momento di formazione dell’uomo e del suo éthos; poi
passa alle imprese storiche compiute (che sono una diretta emanazione
dell’éthos) dal personaggio cresciuto, per poi concludere con la vecchiaia
e con la morte; numerosi sono gli aneddoti e le frasi celebri (“meglio
essere i primi in un villaggio che i secondi a Roma”, dice ad esempio
Cesare). Su un piano strettamente filosofico, è bene rilevare come ogni
personaggio tenda, da un lato, ad assumere la fissità dell’archetipo
platonico, eterno modello da imitare, e, dall’altro lato, sia attratto nella
sfera dell’incessante divenire storico, entro cui recita dinamicamente il
suo ruolo di protagonista. Sicché ciascun personaggio è un modello
platonico calato nella storia o, se preferiamo, sceso dal cielo sulla terra, a
segnalare la possibile attuazione di quei modelli che, a tutta prima, nella
loro perfezione potrebbero sembrare meramente ideali. Questo schema è
poi reso più intricato dall’intersecarsi di un terzo piano, quello
“speculare”, in forza del quale ogni eroe greco si riflette specularmene
nel suo parallelo romano, che ne rappresenta, per così dire, una
reincarnazione.
Il pensiero filosofico
Se dalle Vite parallele ci è restituita l’immagine di un “Plutarco storico”
o, meglio, biografo, quello che affiora dai Moralia è un “Plutarco
filosofo” a trecentosessanta gradi, che non conosce zone inaccessibili alla
sua indagine filosofica (dalla gnoseologia all’etica, dalla teologia alla
psicologia, dalla pedagogia alla politica, ecc.): il titolo di Moralia, che
rimanda necessariamente alla filosofia morale (e che fu attribuito
all’opera plutarchea probabilmente in forza del fatto che gli scritti morali
furono quelli più apprezzati), pare dunque riduttivo, perché trascura il
carattere enciclopedico dell’indagine plutarchea. Una prima serie di scritti
filosofici è quella di contenuto etico che sviluppa argomenti di filosofia
spicciola ad uso quotidiano:
1 De adulatore et amico; 2 De profectibus in virtute; 3 De capienda ex
inimicis utilitate; 4 De amicorum multitudine; 5 De virtute et vitio; 6
Consolatio ad Apollonium; 7 De tuenda sanitate praecepta; 8 Coniugalia
praecepta; 9 De virtute morali; 10 De cohibenda ira; 11 De tranquillitate
animi; 12 De fraterno amore; 13 De garrulitate; 14 De curiositate; 15 De
cupiditate divitiarum; 16 De vitioso pudore; 17 De invidia et odio; 18 De
laude ipsius; 19 Consolatio ad uxorem; 20 Amatorius; 21 Amatoriae
narrationes; 22 De vitando aere alieno; 23 De amore.
Cinque sono le opere pedagogiche:
1 De liberis educandis; 2 De audiendis poetis; 3 De audiendo; 4 De
musica; 5 Pro nobilitate.
Questi sono gli scritti politici:
1 Maxime cum principibus viris philosopho esse disserendum; 2 Ad
principem indoctum; 3 An seni res publica gerenda sit; 4 Praecepta
gerendae rei publicae; 5 De unius in re publica dominatione, populari
statue t paucorum imperio; 6 De esilio; 7 Institutio Traiani.
Presentano un contenuto marcatamente speculativo alcune opere che
passano in rassegna, non senza intenti polemici, le diverse posizioni
assunte dalle varie scuole filosofiche:
1 Platonicae quaestiones; 2 De animae procreatione in Timaeo; 3 De
Stoicorum repugnantiis; 4 Stoicos absurdiora poetis dicere; 5 De
communibus notitiis adversus Stoicos; 6 Non posse suaviter vivi
secundum Epicurum; 7 Adversus Coloten; 8 De latenter vivendo; 9 De
libidine et aegritudine; 10 Quod in animo humano affectibus subiectum
parsne sit eius an facultas; 11 De anima.
Fin dai titoli appare evidente come nel mirino della critica di Plutarco
siano soprattutto gli Stoici e gli Epicurei, ai quali il pensatore di Cheronea
contrappone come antidoto il platonismo, di cui si dichiara a gran voce
seguace. Di argomento spiccatamente scientifico sono una serie di opere
al cui cuore sta l’indagine del mondo fisico e animale; in esse Plutarco si
occupa anche di astronomia e prende posizione contro l’uso alimentare
della carne:
1 De facie in orbe lunae; 2 De primo frigido; 3 Quaestiones physicae; 4
De amore prolis; 5 De sollertia animalium; 6 Bruta animalia ratione uti; 7
De esu carnium.
Alla storia della religione e a problematiche teologiche sono poi dedicati
scritti che risultano interessanti soprattutto alla luce delle preziosissime
informazioni antropologiche e culturali sul contesto spirituale tardopagano che racchiudono:
1 De superstitione; 2 De Iside et Osiride; 3 De E apud Delphos; 4 De
Pythiae oraculis; 5 De defectu oraculorum; 6 De sera numinis vindicta; 7
De genio Socratis.
Presentano poi un taglio antiquario ed erudito scritti che trattano, in
forma rigorosamente eziologica, di riti e usanze greche e romane:
1 Mulierum virtutes; 2 Aetia Romana; 3 Aetia Greca; 4 Regum et
imperatorum apophthègmata; 5 Apophthègmata Laconica; 6 Parallela
minora; De fluviis.
Plutarco si occupa anche di critica letteraria, di poetica e di retorica,
anche se i suoi scritti circa questi argomenti sono andati perduti: di essi
conosciamo solo i nomi, riportati nel catalogo di Lampria. Due però ci
sono giunti e sono rispettivamente dedicati ad un raffronto tra Aristofane
e Menandro e alla malignità di Erodoto (malignità dimostrata soprattutto
ai danni dei Corinzi e dei Beoti):
1 De comparatione Aristophanis et Menandri epitome; 2 De Herodoti
malignitate; 3 De vita et poesi Homeri; 4 X oratorum vitae; 5 De placitis
philosophorum; 6 De proverbis Alexandrinorum; 7 Ecloga de
impossibilibus; 8 De metris.
Prove di declamazione e di talento retorico sono alcuni scritti
(probabilmente giovanili) in cui Plutarco esercita la propria bravura
stilistica:
1 De fortuna; 2 De fortuna Romanorum; 3 De Alexandri Magni fortuna; 4
De gloria Athenensium; 5 Aquane an ignis sit utilior; 6 An virus doveri
possit; 7 An vitiositas ad infelicitatem sufficiat; 8 Animine an corporis
affectiones sint peiores; 9 De fato.
Contenuto miscellaneo e difficilmente classificabile hanno infine le
seguenti due opere:
1 Septem sapientium convivium; 2 Quaestiones convivales.
Le due forme stilistiche che Plutarco sembra di gran lunga preferire nel
fare filosofia sono quella del dialogo alla maniera platonica e quella del
trattato: ma il dialogo platonico, nelle mani di Plutarco, muta
radicalmente essenza, perdendo il suo splendore stilistico e il suo
procedere scandito dalla dialettica della “botta e risposta” in cerca del
vero; gli stessi personaggi sono ben poco artisticamente caratterizzati, e
non di rado il dialogo finisce per essere solo una cornice entro cui inserire
l’esposizione dell’argomento sotto forma di trattato. Lo stesso trattato
assume una forma particolare, declinandosi ora come declamazione
oratoria, ora come invettiva (tali sono gli scritti contro Epicurei e Stoici),
e talvolta come diatriba di derivazione cinica, con frequenti aneddoti e
ammonimenti rivolti al lettore e con un uso piuttosto colloquiale del
linguaggio. Dal lungo elenco di titoli sopra riportati è facile evincere
come Plutarco fu un ingegno enciclopedico, che si occupò di tutto, mosso
da una curiositas che lo spingeva a interrogarsi su ogni cosa. È soprattutto
a Platone che Plutarco si richiama espressamente, anche se la sua etica ha
molti tratti comuni con quella aristotelica: dall’Accademia egli mutua
l’atteggiamento antidogmatico e scettico, che lo porta spesso a ricorrere
alla sospensione del giudizio (epoché), rendendolo consapevole
dell’impossibilità di raggiungere in via definitiva la verità. Ma ciò non
vuol dire che Plutarco sia un relativista o uno scettico tout court: il
dubbio e la sospensione del giudizio vengono esercitati da Plutarco
limitatamente al mondo fisico, cioè al mondo della dòxa, dell’opinione e
della congettura; per quel che invece riguarda l’ambito delle eterne verità
religiose e morali, egli è profondamente dogmatico, a tal punto da poter
attaccare senza remore gli Stoici e gli Epicurei in nome del vero. Così,
nel De primo frigido, Plutarco conclude la sua indagine sull’origine del
freddo con un’inaspettata professione di scetticismo al suo interlocutore
Favorino, esortandolo ad evitare oculatamente le secche del dogmatismo;
e poi, negli scritti religiosi, attacca duramente quanti mettono in forse
l’esistenza dell’aldilà o l’immortalità dell’anima. Sulle orme dell’amato
Platone, Plutarco non ritiene assurdo o impossibile conciliare la fede in
un Dio unico col politeismo della religione tradizionale, verso la quale
nutre un incredibile rispetto. Non a caso egli fu sacerdote di Apollo e
venne iniziato anche ai misteri dionisiaci, nutrendo una fede incrollabile
nell’immortalità dell’anima e nell’aldilà, di cui abbozza una descrizione
di impareggiabile suggestività nel De sera numinis vindicta.
Suggestionato dal pitagorismo, Plutarco credeva anche nella
trasmigrazione delle anime: questo spiega il suo vivacissimo interesse per
il mondo animale, per il vegetarismo e per la lotta contro l’uso alimentare
delle carni. Seguace fedele del dio delfico, Plutarco credeva alla funzione
dell’arte mantica e alla veridicità degli oracoli, il cui silenzio egli prova a
spiegare nel De defectu oraculorum, attraverso le tesi esposte dai vari
interlocutori: una di tali tesi ipotizza addirittura l’esistenza di demoni,
ossia di esseri anfibi tra l’umano e il divino, coi quali in altri scritti si
cerca di render conto anche del male nel mondo e della sua apparente
inconciliabilità con la provvidenza divina. In questa prospettiva, il
filosofo di Cheronea non può non condannare l’ateismo e la
superstizione, propugnando la rivitalizzazione dell’oracolo di Delfi.
Interessato alla religione egizia, egli interpreta il mito di Iside e Osiride
alla luce delle nozioni (desunte dal Timeo di Platone) di intelletto, anima
del mondo e materia come ricettacolo. All’interno dei suoi dialoghi,
Plutarco non esita ad introdurre, ancora una volta seguendo le orme di
Platone, miti escatologici sul destino dell’anima dopo la morte; e
l’ammissione dell’immortalità dell’anima facilita l’ammissione di una
provvidenza divina che, nell’aldilà, premia i buoni e punisce i malvagi. È
questa (formulata nel De sera numinum vindicta, scritto in cui si discute
appunto del perché la divinità tardi a vendicarsi) una vera e propria
teodicea che risente notevolmente del mito di Er platonico.
Richiamandosi alle Leggi di Platone, Plutarco tenta poi di render conto
del male nel mondo, ammettendo l’esistenza, accanto ad un principio
divino razionale e buono, di un principio che genera il male:
“La nascita e la sostanza di questo universo derivano dalla
mescolanza di forze contrarie ma non di ugual potenza, dato
che il principio vincente è sempre quello buono. Ma non è
del resto possibile che la forza del male sia del tutto
annientata: essa è innata sia nella struttura fisica sia
nell’anima vitale del tutto, in un’eterna lotta contro la forza
del bene” (De Iside et Osiride, 49, 371 a).
Come abbiamo detto, Plutarco nutre un atteggiamento profondamente
ostile allo stoicismo e all’epicureismo: degli stoici, egli mette in luce le
innumerevoli contraddizioni teoriche che inficiano il loro sistema,
sottolineando anche l’incompatibilità tra l’impegno politico a cui essi
esortano e il loro totale disimpegno e agnosticismo politico praticato nella
vita di tutti i giorni. La stessa pretesa stoica di eliminare le passioni è
un’assurdità degna di essere derisa: ad essa Plutarco contrappone l’antica
strategia platonica di misurazione ragionata delle passioni, in modo tale
da disciplinarle e renderle funzionali ad una buona costituzione politica.
E del resto Plutarco recupera in toto l’antica tripartizione platonica
dell’anima: una tripartizione che, com’è noto, lungi dal liquidare le
passioni, le ammette e le promuove, a patto che siano regolate dalla guida
lungimirante della ragione. Dell’epicureismo Plutarco attacca ogni parte,
schierandosi con particolare accanimento contro l’etica: non è un caso
che il giovane Marx, nella sua dissertazione dottorale (Differenza tra le
filosofie della natura di Democrito e di Epicuro, 1841), non esiterà ad
individuare in Plutarco (insieme con Cicerone) il massimo nemico
dell’epicureismo. In particolare, il filosofo di Cheronea cerca di mettere
in mostra come – parafrasando il titolo di un suo scritto – sia impossibile
vivere felicemente seguendo Epicuro: e dato che l’etica è il cuore della
filosofia epicurea, distrutta quella, crollerà l’intero sistema. Una sferzante
requisitoria contro l’epicureismo è, ad esempio, quella condotta da
Plutarco contro l’epicureo Colote e nello scritto De latenter vivendo (in
cui prende di mira l’agnosticismo politico di Epicuro). Il pensatore di
Cheronea, così critico verso le diverse scuole di pensiero, assume un
atteggiamento di acquiescenza verso la realtà politica presente, tessendo a
più riprese le lodi di Roma, alla quale riconosce il merito di assicurare la
pace, la sicurezza e la libertà a quanti si affidano alla sua protezione. Il
vero obiettivo politico da raggiungere è allora quello della concordia tra i
cittadini, rimuovendo ogni lotta tra loro: a questo scopo, Plutarco propone
un ritorno alla paideìa, sulla scia di Platone. In un’epoca in cui il disegno
politico platonico è ormai irrealizzabile, resta comunque viva la linea
pedagogica del filosofo delle idee, a patto che la si porti all’altezza della
nuova temperie culturale, così intrisa di religione e spiritualità. Anche se
non fu mai un professore di filosofia (come lo sarà di lì a non molti
decenni l’aristotelico Alessandro di Afrodisia), Plutarco si occupò per
tutta la vita di questioni filosofiche, con un interesse che forse lo
accomuna più che ad ogni altro a Cicerone: come Cicerone, egli non è
uno specialista di filosofia in senso stretto, talvolta commette errori e
fraintendimenti, non elabora un sistema proprio, ma si pone in costante
dialogo con le menti illustri del passato, di cui cerca di riproporre i temi.
Così, nell’Amatorius, egli elabora una sorta di rifacimento del Simposio
platonico, declinandolo secondo i canoni della nuova sensibilità del suo
tempo e, in questo modo, scostandosi talvolta dagli insegnamenti
platonici: così l’obiettivo stesso del dialogo (dimostrare la superiorità
dell’amore eterosessuale rispetto a quello omosessuale) è profondamente
antiplatonico; verso l’omosessualità, Plutarco mostra una vera e propria
repulsione, pur senza giungere a condannarla inappellabilmente (giacché
era pur sempre stata un costume di grandi ingegni antichi).Il dialogo si
finge narrato da Autobulo, un figlio di Plutarco, che racconta ad un certo
Flaviano un episodio risalente ad anni addietro: i genitori di Autobulo
(cioè Plutarco stesso e sua moglie, Timossena) si erano recati a Tespie, ai
piedi del monte Elicona, per fare un sacrificio in onore di Eros e delle
Grazie; la città era sconvolta dal gran parlare che si faceva intorno alla
decisione della ricca vedova Ismenodora di sposare il giovanissimo
Baccone. Alcuni parenti del giovane approvano la decisione, altri la
rigettano: la cosa che più colpisce è che a decidere il tutto è Ismenodora,
mentre Baccone accetta passivamente le decisioni altrui. A Plutarco,
appartato nel santuario di Eros, giungono informazioni sulla vicenda e ciò
costituisce lo spunto per il dialogo: intanto Ismenodora macchina, con
l’appoggio di Baccone, un finto rapimento del giovane, in maniera da
mettere la famiglia del ragazzo di fronte al fatto già compiuto; proprio
mentre Plutarco sta tessendo l’elogio del matrimonio (contrapposto
all’amore omosessuale) e della virtù delle donne, arriva la notizia
dell’imminente felice matrimonio tra Baccone e Ismenodora. Nel corso
del dialogo, Plutarco prova a dimostrare la natura divina di Eros, messa in
dubbio da un interlocutore epicureo che si rivela piuttosto critico verso la
religione. Se nel Simposio platonico Eros era un daimon, Plutarco lo
descrive invece come un vero e proprio dio, grazie ad un’appassionata
argomentazione dialettica:
“Tu vuoi rimuovere gli inamovibili fondamenti della nostra
fede negli dei, quando chiedi per ciascuno di loro una
dimostrazione razionale. La fede ancestrale dei nostri padri
si fonda su se stessa, non si può trovare ed escogitare prova
più chiara di essa […]. Questa convinzione è una base, un
fondamento comune posto all’origine della pietà religiosa; se
in un solo punto viene messa in discussione la sua solidità e
risulta scossa la convinzione generale, essa diventa tutta
quanta instabile e sospetta” (Amatorius, 13, 756 B)
UNITA’ 3
PARTE 20 IL NUOVO TESTAMENTO CON CENNI
SULLA LETTERATURA CRISTIANA
Il Nuovo Testamento è la raccolta dei 27 libri canonici che costituiscono
la seconda parte della Bibbia cristiana.
Citazioni
Vangelo secondo Matteo
•
•
•
•
•
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo.
Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò
Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares da Tamar, […], Obed
generò Iesse, Iesse generò Davide, Davide generò Salomone da
quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo,
[…] Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo
di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. (1, 1-16)
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria,
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo
sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla
in segreto. Mentre però pensava a queste cose, ecco che gli apparve
in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché
quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati». (1, 18-21)
Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato
Emmanuele, che significa Dio con noi. (1, 23)
In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto
della Giudea, dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino!» (3, 1 – 2)
Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo,
disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira
•
•
•
•
imminente? Fate dunque frutti degni di conversione, e non crediate
di potere dire tra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio
può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Già la scure è
posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti
buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. (3, 7 – 10)
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli
afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno
la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché
saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i
perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei
cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei
cieli. (da Il discorso della Montagna, 5, 3-12)
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo
a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti. (7, 12)
Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Osanna nel più alto dei cieli! (21, 9)
Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che
è di Dio. (22, 21)
Vangelo secondo Marco
•
•
Giovanni [Il Battista] era vestito di peli di cammello, con una
cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele
selvatico e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me
e al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere i lacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma Egli vi battezzerà
con lo Spirito Santo». (1, 6 – 8)
Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i grandi della
sua corte, gli ufficiali e i notabili della Galilea. Entrata la figlia
della stessa Erodiade, danzò e piacque a erode e ai commensali.
Allora il re disse alla ragazza: «Chiedimi quello che vuoi e te lo
darò». E le fece questo giuramento: «Qualsiasi cosa mi chiederai te
la darò, fosse anche la metà del mio regno». La ragazza uscì e disse
alla madre: «Che cosa devo chiedere?» Quella rispose: «La testa di
Giovanni il Battista». Ed entrata di corsa dal re fece la richiesta
dicendo: «Voglio che tu mi dia subito su un vassoio la testa di
Giovanni il Battista». Il re ne fu rattristato; tuttavia, a motivo del
giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E
subito mandò una guardia con l'ordine che gli fosse portata la testa.
•
La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la testa su un
vassoio, la diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. (6,
21 – 28)
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato! (15, 34)
Vangelo secondo Luca
•
•
•
•
Allora gli [a Zaccaria] apparve un angelo del Signore, ritto alla
destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide Zaccaria si turbò e fu
preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la
tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un
figlio, che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si
rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al
Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito
Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli d'Israele al
Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di
Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla
saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto».
(1, 11 – 17)
Nel sesto mese, l'arcangelo Gabriele fu mandato da Dio in una città
della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un
uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di
grazia, il Signore è con te.» (1, 26 – 28)
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e
raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di
Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe sentito il saluto
di Maria, il bambino [Giovanni il Battista] le sussultò nel grembo.
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena
la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha
esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell'adempimento delle parole del Signore» (1, 39 – 45)
All'ottavo giorno [dalla nascita] vennero per circoncidere il
bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria.
Ma sua madre [Elisabetta] intervenne: «No, si chiamerà
Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si
chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo
padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e
scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. (1, 59
– 65)
•
•
•
•
Le folle lo [Giovanni] interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?».
Rispondeva: «Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha; e chi
ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a
farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che dobbiamo fare?». Ed
egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato
fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi che
dobbiamo fare?». Rispose: «Non maltrattate e non estorcete niente
a nessuno, contentatevi delle vostre paghe». (3, 10 – 14)
Ma il tetrarca Erode, biasimato da lui [Giovanni il Battista] a
causa di Erodiade, moglie di suo fratello, e per tutte le scelleratezze
che aveva commesso, aggiunse alle altre anche questa: fece
rinchiudere Giovanni in prigione. (3, 19 – 20)
Medico, cura te stesso. (4, 23)
Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per
novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. (15, 7)
Vangelo secondo Giovanni
•
•
•
•
•
•
•
Filippo incontrò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del
quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di
Giuseppe di Nazaret» (1, 45)
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. (3,
16)
Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un
Giudeo riguardo alla purificazione. Andarono perciò da Giovanni e
gli dissero: «Rabbi, colui che era con te dall'altra parte del
Giordano, e al quale hai reso testimonianza, ecco, sta battezzando e
tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi
qualcosa che non gli è stato dato dal cielo. Voi stessi mi siete
testimoni che ho detto: Non sono io il Cristo, ma io sono stato
mandato innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l'amico
dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello
sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve crescere e io
diminuire. (3, 25 – 30)
Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. (8, 7)
Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli;
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. (8, 31-32)
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri
amici. (15, 13)
Allora Pilato gli disse: "Dunque tu sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo
dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto
nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla
verità, ascolta la mia voce". (18, 37)
Atti degli Apostoli
•
•
•
•
Allora Paolo, alzatosi in mezzo all'Aeropago, disse: «Cittadini
ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dei. Passando
infatti ed osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato
anche un'ara con l'iscrizione: Al Dio ignoto. Quello che voi adorate
senza conoscere, io ve l'annunzio» (17, 22 – 23)
Approdammo a Siracusa, dove rimanemmo tre giorni 13e di qui,
costeggiando, giungemmo a Reggio. (28, 12 – 13)
Vi è più gioia nel dare che nel ricevere. (20, 35)
Ma quando l'ebbero legato con le cinghie, Paolo disse: «Potete voi
flagellare un cittadino romano, non ancora giudicato?». Udito ciò il
centurione corse a riferire al tribuno: «Che cosa stai per fare?
Quell'uomo è un romano!» allora il tribuno si recò da paolo e gli
domandò: «Dimmi, tu sei cittadino romano?». Rispose: «Sì».
Replicò il tribuno: «Io questa cittadinanza l'ho pagata a caro
prezzo». Paolo disse: «Io, invece, lo sono di nascita». E subito si
allontanarono da lui quelli che dovevano interrogarlo. Anche il
tribuno ebbe paura rendendosi conto che Paolo era cittadino
romano e che lui lo aveva messo in catene. Il giorno seguente,
volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui veniva
accusato dai Giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si
riunissero i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio; vi fece condurre
Paolo e lo presentò davanti a loro. (22, 25 – 30)
Lettera ai Romani
•
Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di
Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche
avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo
fermi; e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio; non solo,
ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione
produce pazienza, la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza.
Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei
nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti,
mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è
morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto; ma
forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di
morire; Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi
in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto
per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo
sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti, mentre
eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte
del Figlio suo, tanto più ora, che siamo riconciliati, saremo salvati
mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per
mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo
ora ottenuto la riconciliazione. (5:1-11)
Prima lettera ai Corinzi
•
•
•
•
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non
avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo
che tintinna. (13, 1)
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità,
non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode
dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta. (13, 4 – 7)
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono
delle lingue cesserà e la scienza svanirà. (13, 8)
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la
carità; ma di tutte più grande è la carità! (13, 13)
Lettera agli Efesini
•
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui
ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e
immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere
suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito
della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci
ha dato nel suo Figlio diletto; nel quale abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la
ricchezza della sua grazia. (1, 3-7)
Lettera ai Filippesi
•
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il
quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la
condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in
forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce. (2, 5-8)
Apocalisse di Giovanni
•
•
Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno di tribolazione, nel
regno e nella costanza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata
Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a
Gesù. Rapito in estasi, nel giorno del Signore, udii dietro di me una
voce potente, come di tromba, che diceva: Quello che vedi scrivilo
in un libro e mandalo alle sette Chiese: a Efeso, a Smirne, a
Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. (1, 9-12)
Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli
combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i
suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in
cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il
diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra
e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. (12, 7)
Incipit di alcuni libri
Vangelo secondo Matteo
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo
generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi
fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esròm, Esròm
generò Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn,
Naassòn generò Salmòn, Salmòn generò Booz da Racab, Booz generò
Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide. Davide
generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone
generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asàf, Asàf generò
Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Ioatam,
Ioatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse,
Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Ieconia e i
suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la
deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò
Zorobabèle, Zorobabèle generò Abiùd, Abiùd generò Elìacim, Elìacim
generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò
Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, Mattan generò
Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è
nato Gesù chiamato Cristo.
Vangelo secondo Marco
Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come è scritto nel
profeta Isaia:
Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te,
egli ti preparerà la strada.
Voce di uno che grida nel deserto:
preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri,
si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati.
•
Quando si risuscita dai morti non si prende né moglie né marito,
ma si è come degli angeli del cielo. (12,25)
Vangelo secondo Luca
Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti
successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono
testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso
anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di
scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teòfilo, perché ti possa
rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
Vangelo secondo Giovanni
In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era in principio presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui,
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre,
ma le tenebre non l'hanno accolta.
Venne un uomo mandato da Dio
e il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per rendere testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Egli non era la luce,
ma doveva render testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo
la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Egli era nel mondo,
e il mondo fu fatto per mezzo di lui,
eppure il mondo non lo riconobbe.
Venne fra la sua gente,
ma i suoi non l'hanno accolto.
A quanti però l'hanno accolto,
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali non da sangue,
né da volere di carne,
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
Atti degli Apostoli
Nel mio primo libro ho già trattato, o Teòfilo, di tutto quello che Gesù
fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato
istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto
in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte
prove, apparendo loro per quaranta giorni e parlando del regno di Dio.
Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da
Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre
"quella, disse, che voi avete udito da me: Giovanni ha battezzato con
acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni".
Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: "Signore, è questo il
tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?". Ma egli rispose: "Non
spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla
sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino
agli estremi confini della terra". Detto questo, fu elevato in alto sotto i
loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo.
Lettera ai Romani
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per
annunziare il vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi
profeti nelle sacre Scritture, riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di
Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo
Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo,
nostro Signore. Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia
dell'apostolato per ottenere l'obbedienza alla fede da parte di tutte le
genti, a gloria del suo nome; e tra queste siete anche voi, chiamati da
Gesù Cristo. A quanti sono in Roma diletti da Dio e santi per vocazione,
grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.
Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a
tutti voi, perché la fama della vostra fede si espande in tutto il mondo.
Quel Dio, al quale rendo culto nel mio spirito annunziando il vangelo del
Figlio suo, mi è testimone che io mi ricordo sempre di voi, chiedendo
sempre nelle mie preghiere che per volontà di Dio mi si apra una strada
per venire fino a voi.
Prima lettera ai Corinzi
Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il
fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, a coloro che sono
stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi insieme a tutti
quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo,
Signore nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal
Signore Gesù Cristo. Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a
motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui
siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della scienza.
La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita tra voi così saldamente, che
nessun dono di grazia più vi manca, mentre aspettate la manifestazione
del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi confermerà sino alla fine,
irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo: fedele è Dio, dal
quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo,
Signore nostro!
Seconda lettera ai Corinzi
Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timòteo,
alla chiesa di Dio che è in Corinto e a tutti i santi dell'intera Acaia: grazia
a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Sia benedetto
Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di
ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché
possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di
afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.
Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di
Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati, è
per la vostra consolazione e salvezza; quando siamo confortati, è per la
vostra consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con forza le
medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei
vostri riguardi è ben salda, convinti che come siete partecipi delle
sofferenze così lo siete anche della consolazione.
Lettera ai Galati
Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per
mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti
i fratelli che sono con me, alle Chiese della Galazia. Grazia a voi e pace
da parte di Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se
stesso per i nostri peccati, per strapparci da questo mondo perverso,
secondo la volontà di Dio e Padre nostro, al quale sia gloria nei secoli dei
secoli. Amen. Mi meraviglio che così in fretta da colui che vi ha chiamati
con la grazia di Cristo passiate ad un altro vangelo. In realtà, però, non ce
n'è un altro; solo che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire
il vangelo di Cristo.
Lettera agli Efesini
Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, ai santi che sono in
Efeso, credenti in Cristo Gesù: grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e
dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli,
in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere
santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere
suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della
sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel
suo Figlio diletto; nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo
sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
Lettera ai Filippesi
Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che
sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi. Grazia a voi e pace da Dio, Padre
nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Ringrazio il mio Dio ogni volta ch'io
mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi in ogni mia
preghiera, a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del vangelo
dal primo giorno fino al presente, e sono persuaso che colui che ha
iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno
di Cristo Gesù. È giusto, del resto, che io pensi questo di tutti voi, perché
vi porto nel cuore, voi che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata
concessa sia nelle catene, sia nella difesa e nel consolidamento del
vangelo.
Lettera ai Colossesi
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timòteo, ai
santi e fedeli fratelli in Cristo dimoranti in Colossi grazia a voi e pace da
Dio, Padre nostro! Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del
Signore nostro Gesù Cristo, nelle nostre preghiere per voi, per le notizie
ricevute della vostra fede in Cristo Gesù, e della carità che avete verso
tutti i santi, in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa
speranza voi avete già udito l'annunzio dalla parola di verità del vangelo
che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo fruttifica e si sviluppa;
così anche fra voi dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia
di Dio nella verità, che avete appresa da Epafra, nostro caro compagno
nel ministero; egli ci supplisce come un fedele ministro di Cristo, e ci ha
pure manifestato il vostro amore nello Spirito.
Prima lettera ai Tessalonicesi
Paolo, Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre
e nel Signore Gesù Cristo: grazia a voi e pace! Ringraziamo sempre Dio
per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere, continuamente memori
davanti a Dio e Padre nostro del vostro impegno nella fede, della vostra
operosità nella carità e della vostra costante speranza nel Signore nostro
Gesù Cristo. Noi ben sappiamo, fratelli amati da Dio, che siete stati eletti
da lui. Il nostro vangelo, infatti, non si è diffuso fra voi soltanto per
mezzo della parola, ma anche con potenza e con Spirito Santo e con
profonda convinzione, come ben sapete che siamo stati in mezzo a voi
per il vostro bene. E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore,
avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito Santo anche in mezzo a
grande tribolazione, così da diventare modello a tutti i credenti che sono
nella Macedonia e nell'Acaia.
Seconda lettera ai Tessalonicesi
Paolo, Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre
nostro e nel Signore Gesù Cristo: grazia a voi e pace da Dio Padre e dal
Signore Gesù Cristo. Dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli,
ed è ben giusto. La vostra fede infatti cresce rigogliosamente e abbonda la
vostra carità vicendevole; così noi possiamo gloriarci di voi nelle Chiese
di Dio, per la vostra fermezza e per la vostra fede in tutte le persecuzioni
e tribolazioni che sopportate. Questo è un segno del giusto giudizio di
Dio, che vi proclamerà degni di quel regno di Dio, per il quale ora
soffrite. È proprio della giustizia di Dio rendere afflizione a quelli che vi
affliggono e a voi, che ora siete afflitti, sollievo insieme a noi, quando si
manifesterà il Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza in
fuoco ardente, a far vendetta di quanti non conoscono Dio e non
obbediscono al vangelo del Signore nostro Gesù.
Prima lettera a Timoteo
Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per comando di Dio nostro salvatore e di
Cristo Gesù nostra speranza, a Timòteo, mio vero figlio nella fede:
grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù Signore nostro.
Partendo per la Macedonia, ti raccomandai di rimanere in Efeso, perché
tu invitassi alcuni a non insegnare dottrine diverse e a non badare più a
favole e a genealogie interminabili, che servono più a vane discussioni
che al disegno divino manifestato nella fede. Il fine di questo richiamo è
però la carità, che sgorga da un cuore puro, da una buona coscienza e da
una fede sincera.
Seconda lettera a Timoteo
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, per annunziare la
promessa della vita in Cristo Gesù, al diletto figlio Timòteo: grazia,
misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù Signore nostro.
Ringrazio Dio, che io servo con coscienza pura come i miei antenati,
ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere, notte e giorno; mi tornano
alla mente le tue lacrime e sento la nostalgia di rivederti per essere pieno
di gioia. Mi ricordo infatti della tua fede schietta, fede che fu prima nella
tua nonna Lòide, poi in tua madre Eunìce e ora, ne sono certo, anche in
te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per
l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di
timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza.
Lettera a Tito
Paolo, servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo per chiamare alla fede gli
eletti di Dio e per far conoscere la verità che conduce alla pietà ed è
fondata sulla speranza della vita eterna, promessa fin dai secoli eterni da
quel Dio che non mentisce, e manifestata poi con la sua parola mediante
la predicazione che è stata a me affidata per ordine di Dio, nostro
salvatore, a Tito, mio vero figlio nella fede comune: grazia e pace da Dio
Padre e da Cristo Gesù, nostro salvatore. Per questo ti ho lasciato a Creta
perché regolassi ciò che rimane da fare e perché stabilissi presbiteri in
ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato.
Lettera a Filemone
Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timòteo al nostro caro
collaboratore Filèmone, alla sorella Appia, ad Archippo nostro compagno
d'armi e alla comunità che si raduna nella tua casa: grazia a voi e pace da
Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Rendo sempre grazie a Dio
ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare della tua
carità per gli altri e della fede che hai nel Signore Gesù e verso tutti i
santi. La tua partecipazione alla fede diventi efficace per la conoscenza di
tutto il bene che si fa tra voi per Cristo.
Lettera agli Ebrei
Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi
ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a
noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per
mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Questo Figlio, che è
irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto
con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purificazione dei
peccati si è assiso alla destra della maestà nell'alto dei cieli, ed è diventato
tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha
ereditato. Infatti a quale degli angeli Dio ha mai detto: Tu sei mio figlio;
oggi ti ho generato? E ancora: Io sarò per lui padre ed egli sarà per me
figlio?
Lettera di Giacomo
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù
disperse nel mondo, salute. Considerate perfetta letizia, miei fratelli,
quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede
produce la pazienza. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché
siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. Se qualcuno di voi manca
di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti generosamente e senza
rinfacciare, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare,
perché chi esita somiglia all'onda del mare mossa e agitata dal vento; e
non pensi di ricevere qualcosa dal Signore un uomo che ha l'animo
oscillante e instabile in tutte le sue azioni.
Prima lettera di Pietro
Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli dispersi nel Ponto, nella Galazia,
nella Cappadòcia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di
Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù
Cristo e per essere aspersi del suo sangue: grazia e pace a voi in
abbondanza. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo;
nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati, mediante la
risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una
eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è
conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi
mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi
tempi. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po'
afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più
preziosa dell'oro, che, pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco,
torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo: voi
lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui. Perciò
esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la mèta della
vostra fede, cioè la salvezza delle anime.
Seconda lettera di Pietro
Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno
ricevuto in sorte con noi la stessa preziosa fede per la giustizia del nostro
Dio e salvatore Gesù Cristo: grazia e pace sia concessa a voi in
abbondanza nella conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro. La sua
potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e
la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua
gloria e potenza. Con queste ci ha donato i beni grandissimi e preziosi
che erano stati promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della
natura divina, essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa
della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla
vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la
temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà
l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità.
Prima lettera di Giovanni
Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi
abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò
che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita
si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e
vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a
noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi,
perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col
Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la
nostra gioia sia perfetta. Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e
che ora vi annunziamo: Dio è luce e in lui non ci sono tenebre.
Seconda lettera di Giovanni
Io, il presbitero, alla Signora eletta e ai suoi figli che amo nella verità, e
non io soltanto, ma tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a causa
della verità che dimora in noi e dimorerà con noi in eterno: grazia,
misericordia e pace siano con noi da parte di Dio Padre e da parte di Gesù
Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Mi sono molto
rallegrato di aver trovato alcuni tuoi figli che camminano nella verità,
secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora prego
te, Signora, non per darti un comandamento nuovo, ma quello che
abbiamo avuto fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. E in
questo sta l'amore: nel camminare secondo i suoi comandamenti. Questo
è il comandamento che avete appreso fin dal principio; camminate in
esso.
Terza lettera di Giovanni
Io, il presbitero, al carissimo Gaio, che amo nella verità. Carissimo,
faccio voti che tutto vada bene e che tu sia in buona salute, come va bene
per la tua anima. Molto infatti mi sono rallegrato quando sono giunti
alcuni fratelli e hanno reso testimonianza che tu sei verace in quanto tu
cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei
figli camminano nella verità. Carissimo, tu ti comporti fedelmente in tutto
ciò che fai in favore dei fratelli, benché forestieri. Essi hanno reso
testimonianza della tua carità davanti alla Chiesa, e farai bene a
provvederli nel viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per
amore del nome di Cristo, senza accettare nulla dai pagani.
Lettera di Giuda
Giuda, servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, agli eletti che vivono
nell'amore di Dio Padre e sono stati preservati per Gesù Cristo:
misericordia a voi e pace e carità in abbondanza. Carissimi, avevo un
gran desiderio di scrivervi riguardo alla nostra salvezza, ma sono stato
costretto a farlo per esortarvi a combattere per la fede, che fu trasmessa ai
credenti una volta per tutte. Si sono infiltrati infatti tra voi alcuni
individui – i quali sono già stati segnati da tempo per questa condanna –
empi che trovano pretesto alla loro dissolutezza nella grazia del nostro
Dio, rinnegando il nostro unico padrone e signore Gesù Cristo. Ora io
voglio ricordare a voi, che già conoscete tutte queste cose, che il Signore
dopo aver salvato il popolo dalla terra d'Egitto, fece perire in seguito
quelli che non vollero credere, e che gli angeli che non conservarono la
loro dignità ma lasciarono la propria dimora, egli li tiene in catene eterne,
nelle tenebre, per il giudizio del gran giorno.
Apocalisse di Giovanni
Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi
le cose che devono presto accadere, e che egli manifestò inviando il suo
angelo al suo servo Giovanni. Questi attesta la parola di Dio e la
testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge
e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in
pratica le cose che vi sono scritte. Perché il tempo è vicino. Giovanni alle
sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, che era
e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù
Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re
della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo
sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a
lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.