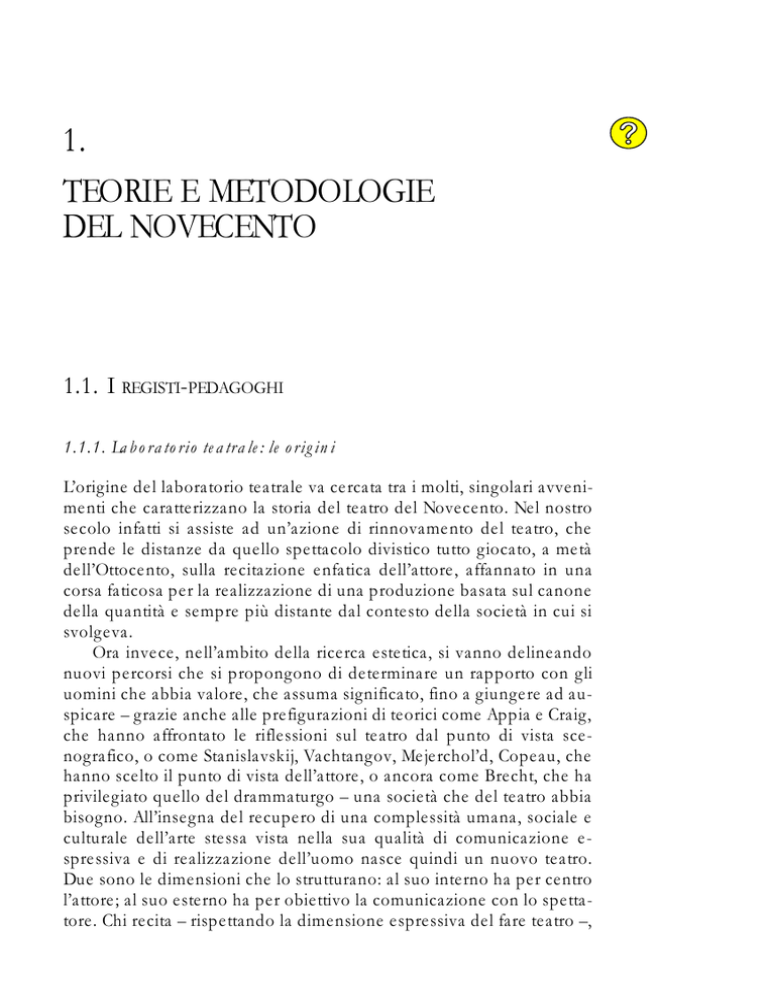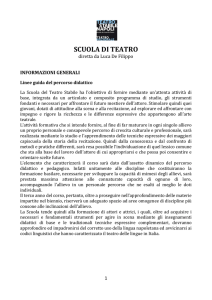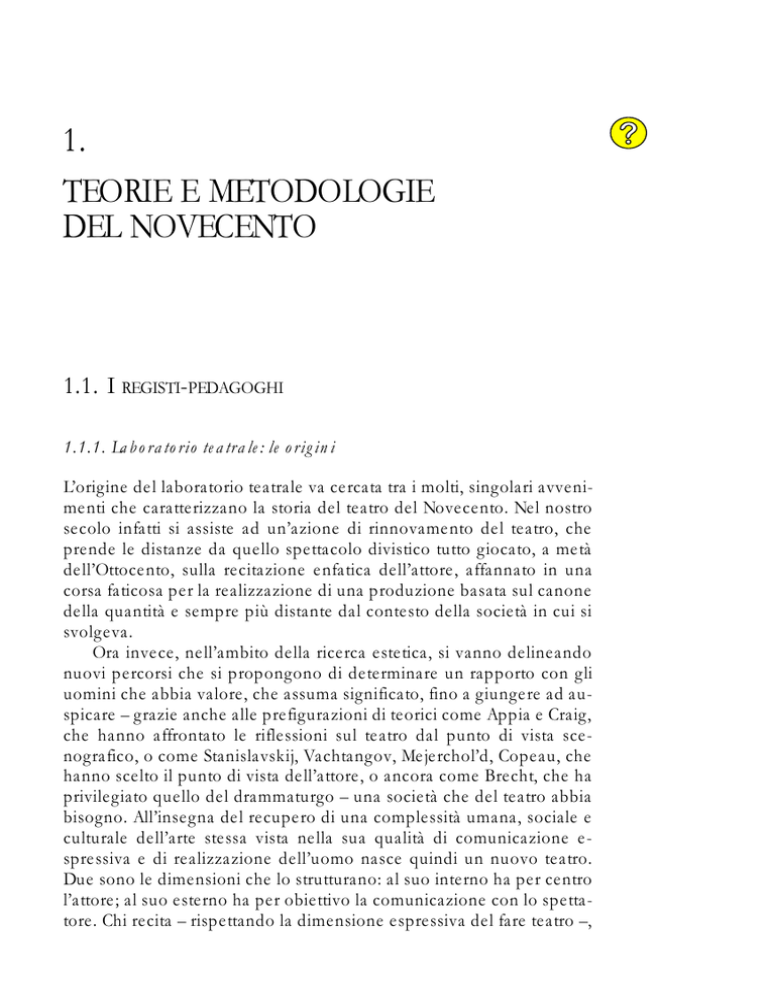
19
1.
TEORIE E METODOLOGIE
DEL NOVECENTO
1.1. I REGISTI-PEDAGOGHI
1.1.1. Laboratorio teatrale: le origini
L’origine del laboratorio teatrale va cercata tra i molti, singolari avvenimenti che caratterizzano la storia del teatro del Novecento. Nel nostro
secolo infatti si assiste ad un’azione di rinnovamento del teatro, che
prende le distanze da quello spettacolo divistico tutto giocato, a metà
dell’Ottocento, sulla recitazione enfatica dell’attore, affannato in una
corsa faticosa per la realizzazione di una produzione basata sul canone
della quantità e sempre più distante dal contesto della società in cui si
svolgeva.
Ora invece, nell’ambito della ricerca estetica, si vanno delineando
nuovi percorsi che si propongono di determinare un rapporto con gli
uomini che abbia valore, che assuma significato, fino a giungere ad auspicare – grazie anche alle prefigurazioni di teorici come Appia e Craig,
che hanno affrontato le riflessioni sul teatro dal punto di vista scenografico, o come Stanislavskij, Vachtangov, Mejerchol’d, Copeau, che
hanno scelto il punto di vista dell’attore, o ancora come Brecht, che ha
privilegiato quello del drammaturgo – una società che del teatro abbia
bisogno. All’insegna del recupero di una complessità umana, sociale e
culturale dell’arte stessa vista nella sua qualità di comunicazione espressiva e di realizzazione dell’uomo nasce quindi un nuovo teatro.
Due sono le dimensioni che lo strutturano: al suo interno ha per centro
l’attore; al suo esterno ha per obiettivo la comunicazione con lo spettatore. Chi recita – rispettando la dimensione espressiva del fare teatro –,
20
1. Teorie e metodologie del Novecento
la sua relazione con gli altri compagni di scena e quella con gli spettatori sono nucleo di partenza e fine delle tensioni progettuali e sperimentali del teatro del Novecento: nasce l’attore in quanto uomo che
usa consapevolmente se stesso per esprimere.
All’inizio del secolo, presso i grandi teatri cittadini – ad esempio
presso il Teatro d’Arte di Mosca, in Russia – esistevano scuole particolari, dedicate agli attori che sarebbero entrati a far parte delle compagnie
locali. Generalmente, però, queste strutture avevano un limite: restavano legate alla specifica personalità di un determinato insegnante, senza
mai prevedere un metodo consapevole, una solida base teorica, un organico disegno pedagogico; il loro scopo era unicamente quello di addestrare i futuri attori perché potessero lavorare in spettacoli allestiti in
tempi brevissimi.
Proprio nell’ambito di questo teatro, ad un tale modo di concepire
la formazione degli attori si oppose Konstantin Sergeevic Aleksèev Stanislavskij; egli rivoluzionò le «tecniche teatrali» introducendo una metodologia di ricerca sperimentale sull’attore e sviluppando le felici intuizioni di alcuni suoi predecessori, come Appia e Craig. Il «sistema» di
Stanislavskij è prassi pedagogica, trasmissione di un’esperienza attraverso l’azione, non teoria. La missione dell’attore consiste nel ricercare
e nell’apprendere per poi formare nuovi attori, indicando loro la via
della ricerca, pur senza dimenticare che la ricerca dovrà essere comunque e sempre personalizzata da chi vorrà intraprendere quel lungo lavoro su se stesso che prelude alla recitazione. Si racconta che gli attori
di Stanislavskij, abili istrioni che osservati da lontano sembravano conoscere segreti misteriosi e strumenti inaccessibili, fossero in realtà e
più semplicemente uomini che possedevano una certa morale, passati
attraverso una particolare formazione che li aveva cambiati.
E proprio da un avvenuto spostamento dell’attenzione, che dallo
spettacolo come fine ultimo dell’esperienza teatrale si è focalizzata sull’attore come protagonista del processo di rinnovamento del teatro, nasce l’incontro senza precedenti tra pedagogia e teatro, come coincidenza di intenti e di interessi: il teatro diventa luogo della scoperta e valorizzazione delle possibilità espressive dell’uomo, luogo in cui la sua
creatività e fantasia si manifestano liberamente.
Gli studi, i laboratori, le scuole dei maestri del Novecento sorgono
come spazi in cui scoprire e sviluppare la capacità creativa, come occasione di potersi sperimentare per gli attori, e per il regista-pedagogo
come atto complesso della sua matura creatività artistica. Qui, del re-
1.1. I registi-pedagoghi
21
sto, si esplicita e trova adeguata soluzione quell’esigenza di continuità
e di ordine che gli spettacoli non potrebbero soddisfare.
Lo «Studio» – così è stato definito il laboratorio teatrale da Stanislavskij – nasce per cercare soluzioni a contingenti problemi professionali
e diventa il centro di una nuova pedagogia teatrale che non si limita
più alla preparazione, in vista dell’esecuzione, di pezzi teatrali in sé
conclusi, ma inizia a ritenere gli esercizi esperienza attiva di teatro.
Esercizi che fanno parte dell’allenamento dell’attore, come diceva
Mejerchol’d, trenàz: sono necessari allo spettacolo, ma non ne fanno
parte. Durante il tempo trascorso allo Studio ogni attore cerca di trovare molteplici possibilità espressive sia attraverso il corpo sia attraverso
la voce, per poi tradurle in un voluminoso bagaglio fatto di opportunità – che gli apparterranno in quanto le avrà già sperimentate – da sfruttare, da utilizzare durante lo spettacolo.
Il lavoro pedagogico del laboratorio è racchiuso in un processo avviato da alcuni stimoli forniti dal regista-pedagogo impegnato a dirigerlo, una figura-guida che, associata al ruolo determinante giocato dagli
esercizi e dalla tecnica dell’improvvisazione, permette all’attore di porsi in una condizione di sperimentazione e di studio sempre nuova.
Questi principi sono il cardine di tutto il lavoro: rappresentano lo stadio del processo creativo in cui si ricerca ciò che non si conosce, un
mezzo per sostituire la ripetizione con la creatività, per crearsi una propria tradizione. A questo punto quel processo prevede un’ultima fase:
l’attore s’immerge in una riflessione profonda, che gli consentirà di
prendere coscienza di ciò che ha vissuto e conosciuto di se stesso.
Il laboratorio teatrale è dunque un momento definito ed uno spazio protetto in cui si manifesta un intento educativo in linea con le teorie dei maggiori pedagogisti che hanno operato negli ultimi due secoli,
come Froebel, Dewey, Montessori, i quali hanno rivalutato il valore
formativo dell’esperienza dell’allievo. Negli incontri di laboratorio,
supportati da una costante riflessione sul processo creativo, il maestroanimatore non insegna, ma mette a disposizione degli individui che
formano il gruppo le proprie capacità tecniche e professionali. Gli allievi, opportunamente guidati, affrontano un percorso individuale attraverso il quale si pongono in ascolto di loro stessi e, eseguendo esercizi mirati, giungono alla scoperta dei propri limiti e delle proprie capacità, apprendono possibilità nuove, utili ad esprimere in modo efficace il proprio pensiero e i propri sentimenti. Laboratorio quindi non
significa tanto un luogo quanto un lavoro, dal momento che costituisce
22
1. Teorie e metodologie del Novecento
un’occasione per crescere, per imparare facendo, nella convinzione
che l’aspetto più importante di questa esperienza sia da individuare nel
processo e non nel punto d’arrivo.
1.1.2. Registi-pedagoghi
Colui che inaugurò la tradizione dello Studio come momento formativo
del percorso personale-professionale dell’attore fu dunque Stanislavskij, che per primo si dedicò alla ricerca di un «sistema» che si ponesse
alla base del lavoro di costruzione della professionalità dell’attore e
che desse senso al teatro. La ricerca del grande regista scaturì da una
domanda fondamentale: se fosse possibile individuare i mezzi utili ad
indurre, in maniera volontaria e consapevole, lo stato creativo.
In seguito a numerosi studi basati sulla sperimentazione, questa
metodologia, seppur ancora in via di costituzione, si rivelò fondata
proprio sull’attore in quanto persona, il quale, nell’approfondimento
della sua arte, partiva proprio da se stesso, dalla sua creatività. Tutto il
lavoro realizzato con il «sistema» funzionava per gli attori come un ingente accumulo di esperienze interiori ed esteriori che nel lungo periodo di preparazione dello spettacolo sedimentava e fermentava fino a
lasciare un segno preciso in ciascuno di loro, qualcosa che si manifestava nella parte che interpretavano, ma che andava anche e soprattutto oltre.
Il metodo di lavoro consisteva, in termini generali, nell’avvicinarsi
dell’attore al personaggio attraverso lo studio dei sentimenti di quest’ultimo, cercando la verità mediante il recupero del proprio sentire:
l’attore trovava nella sua memoria emotiva i sentimenti in questione,
avvalendosi di azioni fisiche che in lui suscitavano tali stati emozionali.
In secondo luogo egli cercava di immedesimarsi nell’«altro» grazie al
«magico se», un esercizio particolare che lo calava nella situazione voluta. Ad insegnare il «sistema» presso il Teatro d’Arte di Mosca potevano
essere gli attori stessi o alcuni seguaci che non avevano alcun rapporto
diretto con l’arte teatrale (medici o psicologi). La conseguenza più grave: spesso gli insegnamenti non erano efficaci perché si basavano sulla
mera ripetizione delle esperienze e delle parole del maestro, non sul
lavoro e sull’elaborazione personale. Un tale modo di rapportarsi al
metodo stanislavskijano si rivelò quindi infruttuoso, dal momento che:
«[...] il sistema di Konstantin Stanislavskij deve essere studiato solo nella
1.1. I registi-pedagoghi
23
pratica», come ribadito dalle parole di Evgenij Vachtangov, ritenuto il
migliore fra i pedagoghi e i registi che si formarono con il maestro.
Egli si accostò molto giovane al teatro e fino alla sua morte, avvenuta quando non aveva neppure quarant’anni, non cessò mai di dedicargli tutto il suo tempo e tutta la sua passione. Lavorò strenuamente
alla propria formazione di attore e tenne come regista-pedagogo molti
Studi nei quali mise in pratica gli insegnamenti di Stanislavskij, tentando anche di superarli continuandone la ricerca. I suoi laboratori erano
pervasi da quell’atmosfera particolare, consona al principio di «studietà» e cioè: rispetto primario della persona e dell’ambiente; correttezza
non solo formale verso i compagni.
Il termine «studietà» definisce una situazione di lavoro in cui agiscono i membri di uno Studio artistico e contemporaneamente il «Principio
dello studio», quel nucleo fatto di teoria e prassi che vitalizzò la tecnica
teatrale russa durante i primi due decenni del secolo. Il laboratorio era
concepito da Vachtangov come un luogo di formazione etica prima ancora che di formazione teatrale, una scuola in cui educare l’uomo e
non solo l’attore, in cui sviluppare la socialità del gruppo a partire dalle
risorse interiori di ciascun ragazzo, prima ancora che dagli esercizi e
dagli studi di improvvisazione, impostazione della voce, dizione, canto, musica, ginnastica, scherma, storia del teatro e del costume, studi
che, peraltro, venivano effettuati quotidianamente nel laboratorio al
fine di raggiungere una preparazione completa in vista degli spettacoli.
Il seguace di Stanislavskij distingueva così la scuola dal teatro: la prima,
in cui ci si educava all’attività creativa, serviva a determinare le caratteristiche individuali dell’allievo, a svilupparne le doti naturali, a dargli
un metodo per affrontare il lavoro in teatro; in essa non si insegnava a
recitare, ma si preparava il campo per la «creazione» che sarebbe avvenuta poi, sulla scena. Quando Vachtangov si dedicava come regista alla
preparazione di una pièce teatrale, esortava gli attori che lavoravano
con lui a studiare il loro personaggio partendo ciascuno da se stesso:
chiedeva insistentemente sincerità, relazioni vere con il partner. In linea con il «sistema» del maestro, sosteneva che il modo più efficace di
accostarsi al pezzo da recitare consistesse nel suddividerlo in diversi
frammenti, definendo i compiti da eseguire, e nel concentrarsi su un
obiettivo, avendo sempre presente una motivazione che spingesse ad
agire.
Un altro ex-allievo del primo Studio di Stanislavskij, Vsevolod Mejerchol’d, riscoprì, come aveva fatto Vachtangov, la Commedia dell’Im-
24
1. Teorie e metodologie del Novecento
provviso, oltre al Kabuki giapponese, e ne sottolineò l’uso della gestualità, indispensabile per realizzare un teatro in cui gli attori si muovessero come saltimbanchi, artisti del circo, atleti, valorizzando il proprio
corpo e imparando a dominarlo sfruttandone rigorosamente tutte le capacità tecniche. Mejerchol’d prese le distanze dalle forme statiche del
teatro simbolista e si avvicinò ad un teatro più dinamico, allestito all’interno di uno spazio scenico spalancato all’azione. Il suo atteggiamento
nei confronti della creatività dell’attore si basava sulla fisiologia, piuttosto che sull’ispirazione. Egli stesso definì i suoi esperimenti sulle nuove
tecniche di recitazione «biomeccanica»: come disciplina essa cominciava là dove terminava l’esercizio, quando dall’esecuzione dei gesti si
passava a collegare il movimento con l’intenzione, da cui nasceva la relazione, in un ciclo che teneva conto di spazio, tempo e partner. Per
Mejerchol’d infatti era fondamentale lo studio dello spazio scenico, che
diventava promotore di senso, funzionale al movimento sulla scena;
proprio in relazione allo spazio egli indagava l’attore. La stessa biomeccanica è una ricerca condotta sull’attore, le cui reazioni ed emozioni sono subordinate ad una corretta disposizione fisica, che deve essere adeguata allo spazio e alla situazione. Il procedimento è strettamente legato al principio della riflessologia (sollecitazione - risposta fisica reazione psichica), che riproduce esattamente il lavoro dell’attore (intenzione - esecuzione fisica - reazione psichica), in cui la fase centrale
assume un’importanza determinante. Momenti-cardine dello Studio diventano allora la coordinazione ed il perfetto allenamento dello strumento di trasmissione, ossia del corpo: nei suoi laboratori Mejerchol’d
insegnava i principi della biomeccanica affinché gli attori apprendessero, attraverso esercizi e sperimentazioni personali, un metodo di lavoro
che li aiutasse, nella preparazione di una pièce, a trovare la sfera gestuale adeguata, convinti che tale sistema fosse comunque funzionale a
qualsiasi sistema rappresentativo.
Contemporaneo di Stanislavskij, in ambito occidentale, il francese
Jacques Copeau è da considerarsi un’importante figura di regista-pedagogo. Egli infatti pensò ad una pedagogia teatrale attraverso la quale
educare i suoi allievi-attori al senso che il teatro aveva assunto in origine e quindi lontano dal teatro privo di autentiche motivazioni del suo
tempo. Questa aspirazione lo spinse a lasciare Parigi e a costituire una
piccola comunità di lavoro con l’intento di dedicarsi alla ricerca della
purezza insita nell’espressione teatrale, veicolo di messaggi e desiderio
di ascolto, vicina a chi del teatro senta realmente il bisogno.
1.1. I registi-pedagoghi
25
Verso la metà di questo secolo si mise in luce un altro importante
studioso di teatro: il drammaturgo e regista Bertolt Brecht. Delineò una
nuova tecnica relativa alla costruzione del dramma, fondata sul principio di provocare lo «straniamento» in luogo dell’immedesimazione, reazione voluta allo stile di recitazione che si rifaceva a Stanislavskij. L’attore che recitava adottando questa nuova tecnica rappresentava i sentimenti ed i comportamenti del suo personaggio in modo singolare, arrivando all’immedesimazione in alcuni momenti e guardandolo come
dall’esterno in altri, tanto da sorprendere lo spettatore, il quale generalmente assumeva un atteggiamento critico nei confronti di ciò che gli
veniva presentato. Il pensiero di Brecht nacque da una riflessione che
egli fece sul teatro del suo tempo domandandosi se tale forma d’arte
avesse ancora in sé i suoi due elementi costitutivi, il divertimento associato all’istruzione, e notando come questi ultimi, invece di coesistere
in modo complementare, fossero ormai in contrasto tra loro.
Attraverso studi e sperimentazioni egli giunse ad affermare che,
perché acquistasse un significato socialmente utile, il teatro doveva essere posto nella condizione di tracciare, con mezzi artistici, un disegno
del mondo e modelli di convivenza umana tali da fornire allo spettatore la possibilità di capire e affrontare con coscienza l’ambiente sociale
in cui viveva. Proprio perché Brecht pensava alla rappresentazione teatrale come a uno strumento di conoscenza della realtà sociale, dei meccanismi che la muovevano e che avrebbero potuto cambiarla, fu considerato l’artefice di un teatro – che doveva convincere e non ammaliare
– definito «didattico» ed «epico». Ad alcuni incontri finalizzati all’allestimento dei suoi spettacoli egli invitò non solo attori di professione, ma
anche gente comune, come operai, studenti, bambini; ciò che accomunava tutti era la motivazione politico-sociale che li spingeva ad essere
lì e la volontà di farla conoscere agli altri, stimolandoli ad interrogarsi e
a prendere posizione. Tutto allora sulla scena doveva avere il significato voluto, non solo le singole parole, ma anche i gesti, sempre estremamente precisi e tratti dalla comune realtà dell’attore e dello spettatore
perché fossero facilmente compresi.
Continuando ad indagare questo secolo, non sarà difficile scorgere
importanti personaggi che attualmente si stanno dedicando a ricerche
sperimentali in ambito teatrale, frutto dell’evoluzione dell’arte dell’attore.
Assai rilevante è l’attività del regista Peter Brook, che ha avuto un
ruolo importante nella seconda riforma del teatro, avvenuta negli anni
26
1. Teorie e metodologie del Novecento
Sessanta, e che ha continuato ad esercitare il suo influsso sul teatro
mondiale (dagli anni Cinquanta) fino ad oggi. Dall’inizio della sua attività, Brook preferisce il «fare» e il suo Studio ad ogni altra formazione;
per lui, infatti, tutto proviene dall’esperienza, e l’esame analitico trova
ragione d’esistere solo a posteriori. Nella preparazione degli attori che
lavorano con lui all’allestimento degli spettacoli, l’allenamento non si
limita allo studio del testo, ma assume importanza determinante perché comprende l’approfondimento della conoscenza della sensibilità e
dell’affettività di ciascuno. Per Brook «essere attore è anche coltivare il
proprio essere, perché questo essere è visibile nella creazione», un
modo di intendere l’arte teatrale che si manifesta in quella che lui stesso definisce «l’estetica del ravvicinamento». In essa la recitazione viene
concepita come evento vissuto in presenza del pubblico, attento e partecipe di questa esperienza; l’attore deve recitare lasciando trasparire
la sua natura interiore, pur avendo coscienza di essere sempre un poco
più avanti dello spettatore nella riflessione sulla vicenda rappresentata.
Per realizzare questo, presso il Centro CIRT diretto dal regista, vengono eseguiti esercizi ed improvvisazioni che sono tanto più efficaci
quanto più l’individuo concepisce il teatro come esperienza formatrice
ed è consapevole del fatto che anche il suo modo di vivere abbia attinenza con la sua arte.
L’attività del Centro assomiglia al lavoro meticoloso e appassionato
dell’artigiano: Brook, insieme con il gruppo, la cui dimensione collettiva viene preferita a quella individuale, modella le materie del teatro,
parole e gesti, cercando con estrema attenzione di arricchirle, di migliorarne la fluidità in modo che non si fossilizzino su un’unica forma
senza tendere alla totale perfezione. Nel modo di procedere appena citato per il regista acquista un’importanza fondamentale la relazione, e
all’«arte come relazione» tende il suo teatro, in ogni momento, a qualsiasi livello: è un intreccio di relazioni in movimento.
Nell’attuale panorama teatrale merita un accenno particolare lo
studioso e regista Jerzy Grotowski, la cui fama è diffusa negli ambienti
teatrali non solo europei. Lavorando da alcuni anni in Italia, quasi rinchiuso nel suo Teatr Laboratorium di Pontedera, egli stesso riconosce
il laboratorio come unico luogo in cui sia possibile attuare una complessa ricerca, come luogo in cui:
[…] si vuole essere scoperto, svelato, nudo; sincero col corpo e col sangue, con l’intera natura dell’uomo, con tutto ciò che potete chiamare a
1.1. I registi-pedagoghi
27
piacere intelletto, anima, psiche, memoria e simili. Questo incontro, andare incontro, essere disarmato, non aver paura uno dell’altro, in nulla.
Le parole di Grotowski descrivono così il suo Workcenter, una specie di romitaggio artistico in cui pochi allievi accuratamente selezionati
si dedicano ad una ricerca personale, guidata da alcuni assistenti, secondo un progetto pedagogico che va oltre il prodotto teatrale. Lo studio avviene in una solitudine silenziosa, individuale, nonostante la vita
comunitaria. La condizione a cui ogni allievo perviene in seguito alla
sua ricerca lo trascende come persona, e l’arte diviene veicolo di qualcosa di assoluto, nella più pura delle trasparenze. È in questo momento
che si intravede la traccia di un maestro che sembra non ammettere restrizioni alla sua ricerca. Il teatro, pur essendo presente, diventa funzione del laboratorio: non più l’attore per costruire il teatro, ma il teatro
per cercare attori che diventano la materia stessa del laboratorio. Tutto
questo trova origine nella riflessione suggerita, nel nostro secolo, dalla
rifondazione etica dell’«arte attorica», nata dall’esigenza di conoscere
chi sia in realtà l’attore e chi sia la persona che viene prima dell’attore.
Due le tendenze: la ricerca sull’attore che conosce se stesso non solo
come artista, ma anche in quanto uomo, attraverso un lavoro finalizzato alla rappresentazione, come è stato per Stanislavskij; e la ricerca che,
attraverso l’arte teatrale, pur mantenendo la rappresentazione come
conclusione del processo, scopre l’uomo – prima e oltre l’attore –, ovvero l’origine del suo atto creativo, in un’occasione di conoscenza e di
elevazione spirituale, come è attualmente per Grotowski. Entrambe le
tendenze sono intrise di etica e tecnica.
Indagando la ricerca dello studioso polacco, si comprende che il
suo «teatro povero» non è orientato verso un come fare teatro, ma verso
un perché, verso un senso del fare teatro: il teatro considerato come
mezzo per superare la dimensione puramente terrena dal momento
che egli stesso, essendo profondamente religioso, ha cercato, in un
particolare frangente della sua vita, di trasformare la sua arte in un
mezzo che lo avvicinasse a Dio. Nel laboratorio di Pontedera gli esercizi non sono preparatori all’atto, all’azione umana: hanno senso quando
sviluppano il perfezionamento del gesto, del movimento, ma non gli
fanno perdere la spontaneità della ricerca creativa personale del performer, come viene chiamato l’allievo che fa, ripete e ripete ancora. La
ricerca deve assolutamente essere individuale: prima di arrivare ad una
creazione collettiva, è necessario essere consapevoli del fatto che cia-
28
1. Teorie e metodologie del Novecento
scuno possieda un proprio ambito soggettivo. Il fine del quotidiano allenamento, rigido ed estremamente impegnativo, è il raggiungimento
di quella condizione particolare definita dall’espressione: «corpo-invita».
Ripreso da Eugenio Barba, ex-allievo di Grotowski, il concetto di
corpo-in-vita costituisce il punto d’arrivo del lavoro dell’attore: l’esperienza dell’unità fra dimensione interiore e dimensione fisica o meccanica dell’uomo. L’attore, avviato un processo che parte dall’illusione
della dualità tra corpo e spirito nell’uomo, arriva a superarla mediante
un training molto impegnativo su se stesso: passa da una spontaneità
inculturata, cioè quotidiana, che è naturale, ad una spontaneità acculturata, cioè extra-quotidiana, che diventa rappresentativa. Raggiunta
questa seconda natura, l’intenzione e l’azione, la mente e il corpo non
sono più distinguibili, nemmeno per lo spettatore, il quale viene colpito non dall’inconsueta dinamica fisica che l’attore gli mostra, ma dall’organicità che ne emerge. Per arrivare a questa dimensione, il lavoro
non verterà soltanto sul corpo o soltanto sulla voce, ma soprattutto sulle energie sottostanti. L’allenamento fisico e l’allenamento mentale non
devono e non possono esistere separatamente; l’attore stesso dovrà allora costruire un ponte che unisca la sponda fisica alla sponda mentale
del processo creativo. Ogni atto creativo, dice Barba, è realizzato tramite una preliminare regressione ad un livello primitivo, un processo
di negazione o di disintegrazione che prepara il balzo verso il risultato:
tale momento è definito «precondizione» creativa. Nell’ambito dell’Antropologia Teatrale di cui Barba si occupa presso l’I.S.T.A. – un organismo permanente di ricerca sull’attore, che ha sede in Danimarca –,
questo livello è legato al concetto di «pre-espressività», momento che
precede logicamente lo stadio espressivo; è fondamentalmente una
realtà conoscitiva: serve all’uomo di teatro per orientare il suo lavoro,
che sfocerà comunque in espressione. È importante osservare come,
nella maggior parte degli individui, questo stato di pre-espressività sia
nascosto dietro ai molti condizionamenti che la vita di tutti i giorni ha
fortemente radicato. Per fare in modo che esso emerga ad un livello
che almeno si avvicini a quella purezza pressoché totale che conoscono solo i bambini più piccoli, è necessario lavorare proprio in un laboratorio teatrale, con esercizi che demoliscano le barriere, causa di falsi
comportamenti, magari di difesa, che l’individuo innalza perché non
ha coscienza di chi egli sia in realtà.
2.1. I principi fondamentali
89
2.
UNA TEORIA: L’APPORTO TEATRALE
NEL PROCESSO FORMATIVO
2.1. I PRINCIPI FONDAMENTALI
Il teatro è arte.
Fondamento dell’arte teatrale è il gioco.
Mostrare la vita significa «giocare» questa vita.
2.1.1. L’attore-persona
Uno dei principi fondamentali della teoria qui esposta è la costruzione
dell’attore-persona; l’obiettivo principale è lo sviluppo della creatività
e della fantasia attraverso un lavoro condotto, su basi scientifiche, dall’attore-soggetto su se stesso. Da tale premessa deriva necessariamente
il fatto che la finalità ultima e irrinunciabile perseguita dalla teoria non
è quella di trasformare l’uomo in attore-oggetto plasmandolo in vista
della produzione di spettacoli confezionabili e vendibili sul mercato,
ma quella di permettergli di valorizzare le sue qualità individuali rispettandone la personalità.
Il lavoro può essere rappresentato dalla seguente formula:
PRE-ESPRESSIVITÀ
+ METODOLOGIA = SVILUPPO DELLA CREATIVITÀ INDIVIDUALE
L’insieme degli individui creativi è in grado di generare anche uno
spettacolo, ma in questo modo il prodotto finito assume un valore relativo rispetto al processo di formazione dell’individualità nella performance. La diversità di questa prospettiva rispetto alle teorie teatrali anche più recenti, ad esempio quelle di Barba e di Grotowski, sta proprio
nella priorità da esse accordata alla rappresentazione come oggetto fi-
90
2. Una teoria: l’apporto teatrale nel processo formativo
nale del percorso; mentre in questa nuova teoria l’obiettivo finale è lo
sviluppo del soggetto.
I destinatari, bambino, adolescente, giovane e adulto, conservano
la loro espressività naturale come motivo di fondo; su di essa infatti
viene costruito l’attore-persona, senza manipolazioni o forzature psicologiche. Fondamentale per lo sviluppo della fantasia e della creatività è la conservazione della propria espressività, che costituisce il punto
di partenza, l’elemento cardine per il confronto con l’altro. Come è intuibile, questo percorso è essenzialmente educativo in quanto implica
un lavoro su se stessi e «con» gli altri, compiuto a livello di pre-espressività: riguarda le azioni dell’attore-persona, l’uso che egli è capace di
fare della sua presenza fisica. «Pre-espressivo» è un termine che viene
dell’Antropologia Teatrale; il contesto antropologico è dunque determinante per la definizione degli ambiti di azione. Come già detto, si
deve all’opera di Eugenio Barba la «creazione» del concetto di Antropologia Teatrale e dell’I.S.T.A. (International School of Theatre Antropology), nel 1979, la cui attività è centrata sulla ricerca dei principi fondamentali che sottostanno all’utilizzo del corpo nelle situazioni di rappresentazione. Si tratta di unire gli sforzi di attori e studiosi di varie discipline e di varie zone del pianeta per cercare di comprendere i processi
che avvengono nell’organismo dell’attore-persona e lo rendono «in
vita», trarne delle leggi e quindi riuscire a servirsene per la formazione
dell’attore-persona stesso. Più in generale l’Antropologia Teatrale si occupa dello studio del comportamento umano a livello biologico e socio-culturale in una situazione di rappresentazione. Sono stati indagati
i fenomeni della recitazione orientale – dal momento che in Oriente
esistono tecniche codificate per l’attore, mentre in Europa troneggiano
mode, convenzioni ed individualismi che rendono difficoltoso il procedere degli studi – e successivamente sono state teorizzate tre leggi fondamentali che ricorrono nel corpo-in-vita dell’attore-persona (definite
approfonditamente nel capitolo precedente).
Proprio in quest’ambito si impone fortemente la questione dell’educazione preliminare dell’attore-persona e dell’uomo. Se il senso
della recitazione viene dall’istinto e la sua qualità dall’intelligenza e dal
gusto, è logico attribuire a questa parte della formazione di un allievo
tutta l’importanza che merita, forzandolo, nella misura del possibile, ad
approfondire un po’ meglio quest’arte che spesso egli dichiara di aver
scelto per ragioni diverse e alla quale probabilmente, né per estrazione, né per educazione, è stato mai preparato.
2.1. I principi fondamentali
91
Uno degli strumenti più efficaci per insegnare la teoria e la pratica
della recitazione teatrale è costituito dall’improvvisazione, anche se talvolta utilizzata in maniera impropria e sviata dal suo scopo, che è essenzialmente educativo. Questo strumento deve essere usato non solo
come esercizio pratico per acquisire spigliatezza, senso dell’opportunità, naturalezza, ma anche come veicolo d’introspezione e fonte di meditazione sui problemi, per favorire lo sviluppo della personalità di
ogni allievo. L’improvvisazione infatti obbliga chi la pratica a scoprire i
propri mezzi espressivi.
Per costruire il nuovo attore-persona bisogna passare attraverso la
storia delle sue metodologie, bisogna cioè recuperare i segreti dell’arte
di recitare guardando al passato per costruire il futuro, per trovare inedite forme di espressione. Il nuovo è rappresentato dalla multimedialità dei linguaggi, intesi però nella loro essenza «primitiva», senza cioè
presupporre necessariamente l’uso di macchinari e strumenti artificiali.
Il centro di tutto rimane l’uomo nella sua naturalità. Il concetto trasmesso dalla multimedialità è l’idea che muove l’attore-persona, ma
l’unico strumento che a lui serve per creare è il suo corpo.
Pensare al teatro come multimedialità di linguaggi non vuol dire
pensare a qualcosa che ricorda il montaggio cinematografico, ma significa dare origine ad una serie di percorsi partendo da un unico ambito.
E se ricorrere al principio del montaggio vuol dire ottenere un prodotto
attraverso la somma di linguaggi, di «pezzi» diversi che alla fine non saranno più recuperabili senza distruggere il prodotto finito, seguire il
principio della multimedialità significa lavorare come in un programma
«windows» per computer: si parte da un ambiente di lavoro e da lì si
aprono diverse finestre che mettono in comunicazione con altri ambienti, per poi chiuderle, ritornare alla partenza e aprire un ciclo continuo. Si tratta di un’attività ininterrotta di esplorazione all’interno dei diversi mezzi espressivi. In questo senso multimedialità significa fare in
modo che i vari linguaggi (musica, scenografia, video, parola, danza
ecc.) si comportino come dei piani che si intersecano ma non si sovrappongono, e comunque non danno come risultato un montaggio finito.
Ogni strumento espressivo che partecipa alla scena deve seguire i
principi fondamentali della teoria esposta. In tal senso anche l’utilizzo
della scenografia, della musica, dell’immagine contribuisce allo sviluppo della creatività e della fantasia nel rispetto dell’uomo, inteso nella
sua naturalità. I significati e gli scopi assunti dai tanti mezzi capaci di
92
2. Una teoria: l’apporto teatrale nel processo formativo
«farci esprimere» saranno dunque altrettanto numerosi e diversificati.
La scenografia si sforzerà di attuare scelte non esclusivamente estetiche, ma funzionali alla presenza umana: si costituirà cioè non come qualcosa da guardare, ma come qualcosa da usare; la musica cercherà le proprie radici, il suono naturale, ed avrà una funzione di sostegno della figura umana sulla scena. L’immagine infine, ovvero la fotografia e il video, come uno strumento magico, dovrà cercare di catturare l’anima dell’uomo: non fermarsi quindi alla superficie delle cose,
non trasformare la persona in un oggetto da guardare e ammirare, ma
fissarne le emozioni, il calore, l’energia.