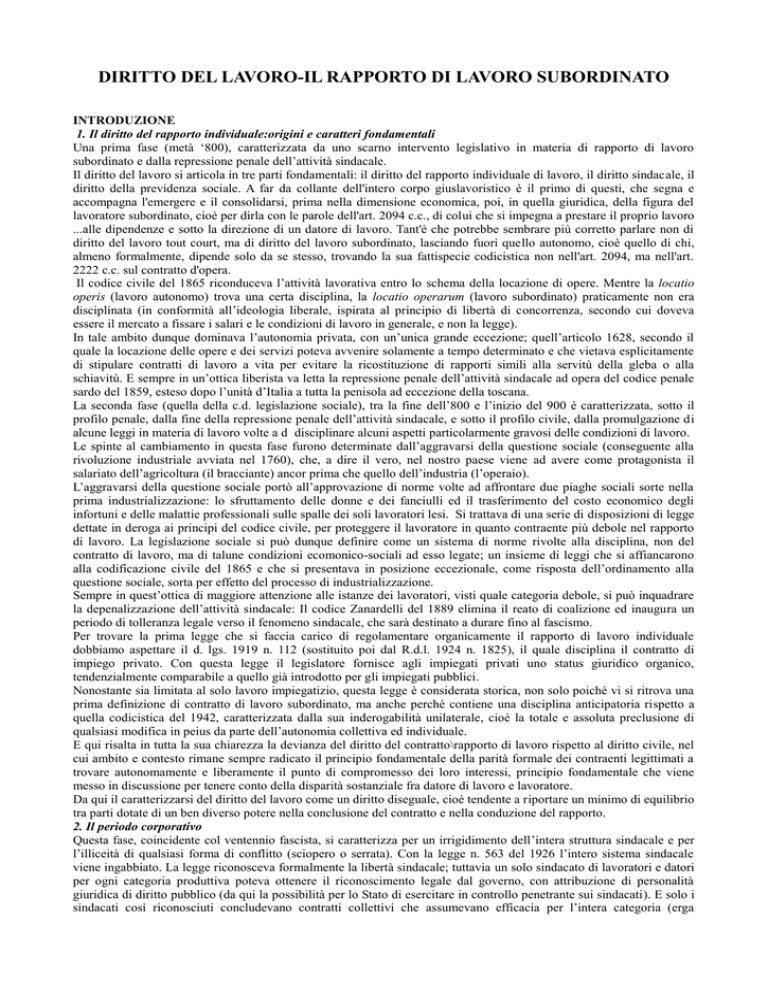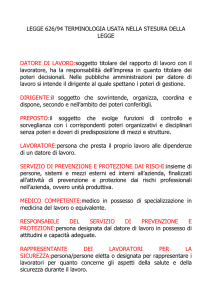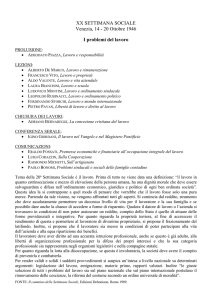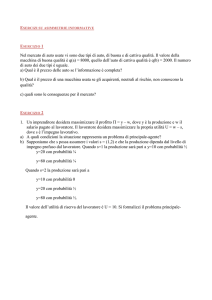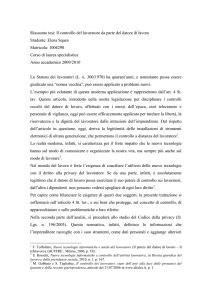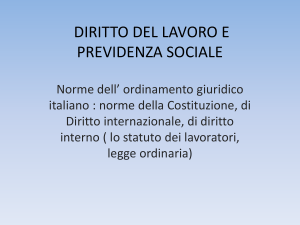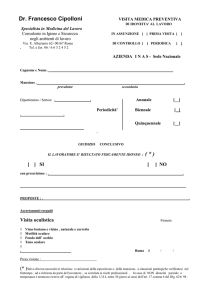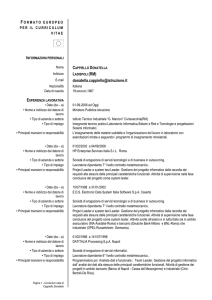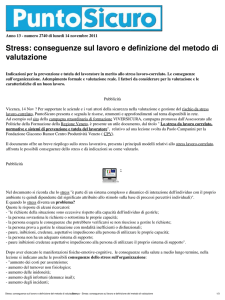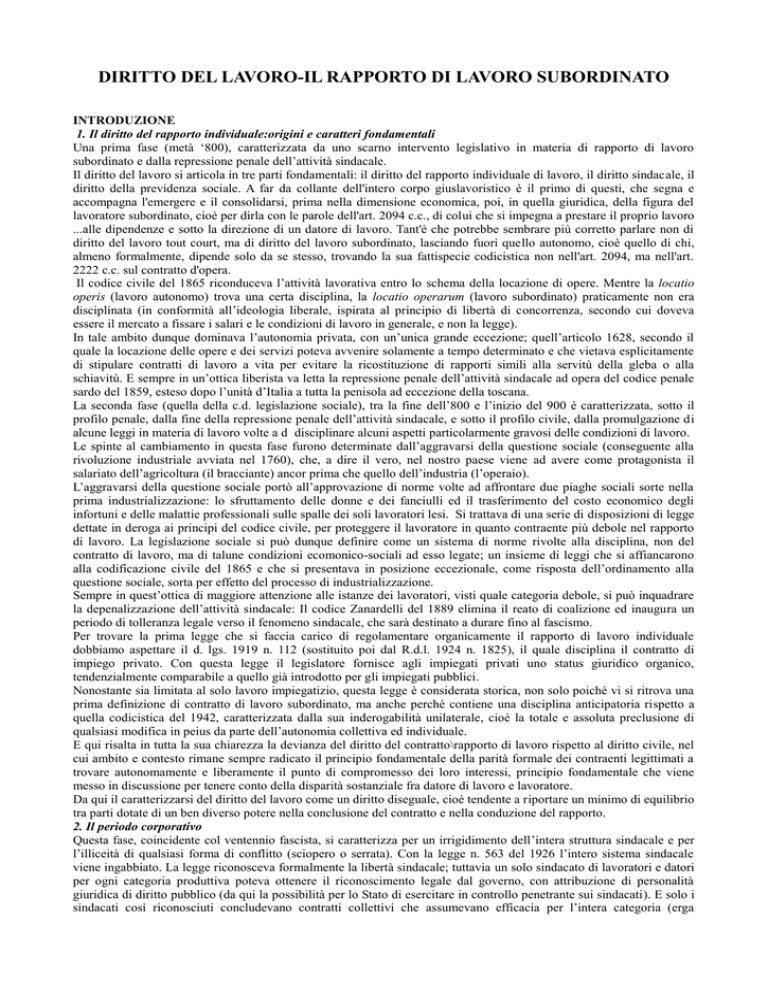
DIRITTO DEL LAVORO-IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
INTRODUZIONE
1. Il diritto del rapporto individuale:origini e caratteri fondamentali
Una prima fase (metà ‘800), caratterizzata da uno scarno intervento legislativo in materia di rapporto di lavoro
subordinato e dalla repressione penale dell’attività sindacale.
Il diritto del lavoro si articola in tre parti fondamentali: il diritto del rapporto individuale di lavoro, il diritto sindacale, il
diritto della previdenza sociale. A far da collante dell'intero corpo giuslavoristico è il primo di questi, che segna e
accompagna l'emergere e il consolidarsi, prima nella dimensione economica, poi, in quella giuridica, della figura del
lavoratore subordinato, cioè per dirla con le parole dell'art. 2094 c.c., di colui che si impegna a prestare il proprio lavoro
...alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro. Tant'è che potrebbe sembrare più corretto parlare non di
diritto del lavoro tout court, ma di diritto del lavoro subordinato, lasciando fuori quello autonomo, cioè quello di chi,
almeno formalmente, dipende solo da se stesso, trovando la sua fattispecie codicistica non nell'art. 2094, ma nell'art.
2222 c.c. sul contratto d'opera.
Il codice civile del 1865 riconduceva l’attività lavorativa entro lo schema della locazione di opere. Mentre la locatio
operis (lavoro autonomo) trova una certa disciplina, la locatio operarum (lavoro subordinato) praticamente non era
disciplinata (in conformità all’ideologia liberale, ispirata al principio di libertà di concorrenza, secondo cui doveva
essere il mercato a fissare i salari e le condizioni di lavoro in generale, e non la legge).
In tale ambito dunque dominava l’autonomia privata, con un’unica grande eccezione; quell’articolo 1628, secondo il
quale la locazione delle opere e dei servizi poteva avvenire solamente a tempo determinato e che vietava esplicitamente
di stipulare contratti di lavoro a vita per evitare la ricostituzione di rapporti simili alla servitù della gleba o alla
schiavitù. E sempre in un’ottica liberista va letta la repressione penale dell’attività sindacale ad opera del codice penale
sardo del 1859, esteso dopo l’unità d’Italia a tutta la penisola ad eccezione della toscana.
La seconda fase (quella della c.d. legislazione sociale), tra la fine dell’800 e l’inizio del 900 è caratterizzata, sotto il
profilo penale, dalla fine della repressione penale dell’attività sindacale, e sotto il profilo civile, dalla promulgazione di
alcune leggi in materia di lavoro volte a d disciplinare alcuni aspetti particolarmente gravosi delle condizioni di lavoro.
Le spinte al cambiamento in questa fase furono determinate dall’aggravarsi della questione sociale (conseguente alla
rivoluzione industriale avviata nel 1760), che, a dire il vero, nel nostro paese viene ad avere come protagonista il
salariato dell’agricoltura (il bracciante) ancor prima che quello dell’industria (l’operaio).
L’aggravarsi della questione sociale portò all’approvazione di norme volte ad affrontare due piaghe sociali sorte nella
prima industrializzazione: lo sfruttamento delle donne e dei fanciulli ed il trasferimento del costo economico degli
infortuni e delle malattie professionali sulle spalle dei soli lavoratori lesi. Si trattava di una serie di disposizioni di legge
dettate in deroga ai principi del codice civile, per proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole nel rapporto
di lavoro. La legislazione sociale si può dunque definire come un sistema di norme rivolte alla disciplina, non del
contratto di lavoro, ma di talune condizioni ecomonico-sociali ad esso legate; un insieme di leggi che si affiancarono
alla codificazione civile del 1865 e che si presentava in posizione eccezionale, come risposta dell’ordinamento alla
questione sociale, sorta per effetto del processo di industrializzazione.
Sempre in quest’ottica di maggiore attenzione alle istanze dei lavoratori, visti quale categoria debole, si può inquadrare
la depenalizzazione dell’attività sindacale: Il codice Zanardelli del 1889 elimina il reato di coalizione ed inaugura un
periodo di tolleranza legale verso il fenomeno sindacale, che sarà destinato a durare fino al fascismo.
Per trovare la prima legge che si faccia carico di regolamentare organicamente il rapporto di lavoro individuale
dobbiamo aspettare il d. lgs. 1919 n. 112 (sostituito poi dal R.d.l. 1924 n. 1825), il quale disciplina il contratto di
impiego privato. Con questa legge il legislatore fornisce agli impiegati privati uno status giuridico organico,
tendenzialmente comparabile a quello già introdotto per gli impiegati pubblici.
Nonostante sia limitata al solo lavoro impiegatizio, questa legge è considerata storica, non solo poiché vi si ritrova una
prima definizione di contratto di lavoro subordinato, ma anche perché contiene una disciplina anticipatoria rispetto a
quella codicistica del 1942, caratterizzata dalla sua inderogabilità unilaterale, cioè la totale e assoluta preclusione di
qualsiasi modifica in peius da parte dell’autonomia collettiva ed individuale.
E qui risalta in tutta la sua chiarezza la devianza del diritto del contratto\rapporto di lavoro rispetto al diritto civile, nel
cui ambito e contesto rimane sempre radicato il principio fondamentale della parità formale dei contraenti legittimati a
trovare autonomamente e liberamente il punto di compromesso dei loro interessi, principio fondamentale che viene
messo in discussione per tenere conto della disparità sostanziale fra datore di lavoro e lavoratore.
Da qui il caratterizzarsi del diritto del lavoro come un diritto diseguale, cioè tendente a riportare un minimo di equilibrio
tra parti dotate di un ben diverso potere nella conclusione del contratto e nella conduzione del rapporto.
2. Il periodo corporativo
Questa fase, coincidente col ventennio fascista, si caratterizza per un irrigidimento dell’intera struttura sindacale e per
l’illiceità di qualsiasi forma di conflitto (sciopero o serrata). Con la legge n. 563 del 1926 l’intero sistema sindacale
viene ingabbiato. La legge riconosceva formalmente la libertà sindacale; tuttavia un solo sindacato di lavoratori e datori
per ogni categoria produttiva poteva ottenere il riconoscimento legale dal governo, con attribuzione di personalità
giuridica di diritto pubblico (da qui la possibilità per lo Stato di esercitare in controllo penetrante sui sindacati). E solo i
sindacati così riconosciuti concludevano contratti collettivi che assumevano efficacia per l’intera categoria (erga
omnes), con effetti simili alle norme di legge.
Il legislatore penale intervenne in modo incisivo, qualificando come reati sia lo sciopero che la serrata (codice Rocco
del 1930).Con il corporativismo dunque i sindacati vengono trasformati in organi burocratici, privi di spinta conflittuale
e di effettiva rappresentatività.
3.La costituzione
Con la caduta del fascismo (1943), la conseguente fine del corporativismo e l’emanazione della costituzione (1948) si
apre una nuova fase storica dello sviluppo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali.
Si riafferma la libertà di organizzazione sindacale e tale libertà di attività sindacale viene ulteriormente valorizzata dal
riconoscimento del diritto di sciopero.
Prendendo in considerazione le fonti del diritto è possibile evidenziare come la rilevanza della materia del diritto del
lavoro sia cresciuta nelle varie fasi che ne hanno caratterizzato l’evoluzione. La prima fase si caratterizza per un forte
astensionismo legislativo; durante la fase della legislazione sociale, il diritto del lavoro diviene oggetto di una
produzione normativa che si caratterizza per la sua eccezionalità rispetto al diritto civile; con il codice civile del 1942 la
disciplina del rapporto di lavoro perde il suo carattere di eccezionalità e viene inclusa nella codificazione unificata del
diritto privato del 1942. infine con la costituzione, i principi fondamentali che presiedono alla disciplina del rapporto di
lavoro trovano una definitiva e più alta consacrazione nel testo costituzionale.
Sono molti i principi inerenti il diritto del lavoro che trovano formale consacrazione nella costituzione; l’art. 1 assume a
valore base dell’ordinamento repubblicano il lavoro, inteso in senso ampio, cioè rappresentativo di ogni attività
socialmente rilevante; l’art. 4,1 riconosce ad ogni cittadino il diritto al lavoro.
Oltre a questi principi, di portata più generale, nella Parte prima del titolo 3° ve ne sono altri, i quali si occupano in
maniera ancor più incisiva del rapporto di lavoro e del fenomeno sindacale. Tra questi spiccano per importanza e
rilievo:
L’art. 35 pone a carico della repubblica la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
L’art. 36 consacra il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente al sostentamento
suo e della famiglia, il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite ed infine rinvia alla legge
la fissazione della durata massima della giornata lavorativa.
L’art. 37 sanziona una disciplina di tutela per la donna lavoratrice e per i minori.
L’art. 39 sancisce 3 principi fondamentali:
La libertà (e quindi la pluralità) sindacale come fondamento delle relazioni industriali;
La registrazione del sindacato ed il riconoscimento della personalità giuridica come presupposto per acquisire la
capacità di stipulare contratti collettivi efficaci per tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce;
L’attribuzione di tale capacità contrattuale direttamente a rappresentanze unitarie dei sindacati registrati, costituite in
proporzione ai loro iscritti.
La valorizzazione dell’attività sindacale è poi rafforzata dal riconoscimento del diritto di sciopero operato dall’art. 40
Non è senza significato poi che l’art. 41 afferma che la libertà di iniziativa economica non possa esercitarsi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla dignità umana. Se ne è infatti dedotto che il testo costituzionale
abbia prefigurato un diverso equilibrio fra i due fattori della produzione, lavoro e capitale, più favorevole al lavoro di
quanto potesse esserlo precedentemente (per il suo essere mezzo di sostentamento insostituibile).
Da qui una rilettura degli artt. 2094 e ss. c.c., che li reinterpreterà alla luce del nuovo equilibrio stabilito dalla
Costituzione. Se prima quel complesso di articoli costituiva il diritto del rapporto individuale inscritto nel codice civile
ed era considerato più o meno alla pari con gli altri corpi di articoli ricondotti al codice civile, alla luce della
costituzione, quegli articoli acquistano un rilievo particolare, proprio in forza dell’essere quello del lavoro il rapporto
inter-privato di maggior peso costituzionale. Va detto tuttavia che spostare il punto di equilibrio fra lavoro e capitale non
equivale ad escludere l’inevitabile carattere compromissorio del diritto del lavoro.
Se dunque è vero che il diritto del lavoro è innanzitutto una tecnica protettiva di un soggetto soprattutto sul piano socioeconomico e, quindi, un diritto distributivo di garanzie e di risorse, non si può trascurare che esso è anche un diritto
della produzione, cioè una disciplina dei ruoli e delle modalità del produrre in una società sviluppata.
4.La legislazione post-costituzionale. Dalla normativa paternalista-individualista degli anni '50 e '60 a quella
garantista-promozionale dello Statuto dei lavoratori.
In un clima di inattuazione delle disposizioni costituzionali e di ripulitura del codice civile dalle incrostazioni
corporative, con una riutilizzazione a tutto campo delle categorie civilistiche, matura la prima stagione postcostituzionale del diritto del lavoro, quella paternalista-individualista, che così viene definita per l’interventismo sul
piano individuale fra la fine del decennio ’50 e l’inizio degli anni ’60.
La successiva stagione matura nelle intemperie della sequenza conflittuale 1968/1973, ormai entrata nella storia con
l’etichetta del suo climax, l’autunno caldo del ’69. Ed è in questo clima che vede la luce uno dei più importanti
interventi legislativi dell’intero periodo repubblicano; lo Statuto dei lavoratori del 1970; un testo caratterizzato
dall’intento di dare cittadinanza ai diritti sanciti dalla Costituzione, anche all’interno dei luoghi di lavoro, non solo
garantendo la presenza del sindacato, ma anche tutelando direttamente la posizione del singolo lavoratore.
Per quanto rilevante tuttavia lo Statuto presenta un limite genetico; quello di essere stato costruito a misura del
lavoratore “tipico”, occupato nella grande e media industria, con un contratto a tempo indeterminato e ad orario pieno,
tralasciando le differenti situazioni lavorative. Di lì a qualche anno, viene a fare da sostegno allo Statuto la L. n. 533 del
1973 sulle controversie individuali di lavoro, che assicura al nuovo diritto sostanziale un nuovo rito, più consapevole
dello squilibrio capitale-lavoro, più spedito, più effettivo.
5.Il passaggio dagli anni '70 agli anni '80: dall'emergenza alla flessibilità.
Il primo shock petrolifero danneggiò severamente l’economia italiana, dando vita ad un periodo di stagnazione del
prodotto interno lordo e di inflazione, con una pesante ricaduta in termini di disoccupazione.
Decolla così nella seconda metà degli anni ’70 una c.d. legislazione dell’emergenza, tesa ad accompagnare la
ristrutturazione industriale con una mobilità dei lavoratori dai settori in ridimensionamento a quelli in sviluppo, e a
favorire l’entrata sul mercato del lavoro dei giovani per via dei contratti flessibili, quali quelli di formazione e lavoro;
nonché a contenere la dinamica della scala mobile per decelerarne la ricaduta inflativa. La scala mobile era un
meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione dei lavoratori dipendenti, agganciato all’aumento del costo
della vita; l’aumento del costo della vita era a sua volta determinato sulla base della variazione del prezzo di alcuni beni
di consumo (il paniere).Lo scopo dell’introduzione della scala mobile doveva essere quello di mantenere inalterato il
potere d’acquisto salariale. A questo scopo dal 1946 fu prevista in Italia, sulla base della contrattazione collettiva, la
presenza di una quota integrativa del salario detta indennità di contingenza il cui importo, oltre a essere proporzionato a
fattori quali l'età o la qualifica del lavoratore, veniva periodicamente rivalutato in base alle variazioni intervenute nei
prezzi di alcuni beni e servizi ritenuti rappresentativi dei consumi della famiglia tipo (paniere). Tuttavia lo stesso
meccanismo della scala mobile innescava a sua volta dinamiche inflazionistiche, in relazione alla sue connessioni con il
PIL. Infatti un aumento dei salari al di sopra della produttività (per quanto in linea con l’inflazione corrente) è causa di
nuova inflazione. Se aumentano i salari e l’utile rimane invariato si genera un aumento della moneta circolante non
corrisposto da una crescita della ricchezza prodotta e dunque, una spirale inflazionistica.
Questa legislazione dell’emergenza mirava a favorire la difesa e la crescita dei livelli di occupazione, prevedendo
l’estensione, sia pure controllata e contrattata, delle forme di impiego flessibile della forza-lavoro (contratto a termine e
a tempo parziale; contratto di formazione e contratti di solidarietà).
Inoltre nel corso degli anni ’70 matura un profondo cambiamento nel ruolo dello Stato nelle relazioni industriali. Da
mediatore che cerca di garantire le regole del gioco, lo Stato diviene un “giocatore” nelle dinamiche delle relazioni
industriali e vi interviene quale gestore di risorse proprie, richiedendo ai sindacati comportamenti di moderazione,
specie salariale e di contenimento della conflittualità; e ai datori di lavoro richiede un tasso elevato, o almeno regolare,
d‘investimento. Tra i 3 attori delle relazioni industriali si realizza in tal modo quello che è stato definito “scambio
politico”. La concertazione e l’intervento pubblico dunque danno vita allo scambio politico, i cui primi frutti possono
essere intravisti nei protocolli triangolari del ’77, dell’83 (protocollo Scotti) e dell’84 (protocollo di S. Valentino, che
inferse il primo duro colpo al meccanismo della scala mobile).
I primi anni ’80 conoscono una relativa stabilizzazione, che fa da sfondo all’esperienza triangolare dell’83\’84. inoltre si
assiste ad un mutamento della struttura produttiva ed occupazionale (che influirà sulla legislazione); cioè il passaggio da
un modello di sviluppo industriale ad un terziario, nel contesto di un’accelerata informatizzazione e di una crescente
competizione mondiale. La legislazione caratterizzata da emergenzialità si converte alla flessibilità, come risposta
strutturale ad un cambiamento continuo dei mercati. A posteriori è possibile individuare almeno 3 elementi di novità
destinati a segnare a tutt’oggi il diritto del lavoro.
La concertazione triangolare – la diretta partecipazione del governo nella negoziazione triangolare (i protocolli)
testimonia la crescente rilevanza della spendita di risorse pubbliche nella trattativa fra le parti sociali. Questo intervento
pubblico è determinato in gran parte dalla necessità di porre un freno alle dinamiche inflazionistiche innescate dalla
scala mobile ed in quest’ottica si collocano alcune misure, (es. “tetti massimi” per i trattamenti dei lavoratori),
inderogabili, non solo in peius, ma anche in melius.
La moltiplicazione dei “tipi” di rapporto – la terziarizzazione e informatizzazione della struttura produttiva e
occupazionale ha determinato (oltre ad una frammentazione dell’impresa) una moltiplicazione della domanda di lavoro,
secondo coordinate flessibili di tempo, intensità e autonomia.
La deregolazione del diritto del lavoro – Sotto l’impatto della frammentazione dell’impresa e del mercato la
legislazione risponde non solo con la moltiplicazione dei “tipi”, ma anche con una riduzione della dote di garanzie
inderogabili ex lege. Tale tendenza deregolativa ha una duplice variante: quella c.d. “secca (in prospettiva neo-liberista),
con una smobilitazione della copertura legislativa imperativa a favore di una maggiore autonomia individuale; quella
c.d. “controllata”, anche questa con una riduzione della dote legale inderogabile, ma a pro di una qualche istanza
amministrativa partecipata o dell'autonomia collettiva.
6. Gli anni '90: la stagione di mezzo.
Nel corso del decennio ’90 non si è mancato di enfatizzare la divaricazione fra un diritto del lavoro “maggiore” (per gli
occupati a tempo indeterminato e pieno nelle grandi e medie imprese sindacalizzate) e un diritto del lavoro “minore”
(per tutti gli altri), divaricazione accentuata dalla presenza e rispettivamente assenza della contrattazione aziendale.
Divaricazione questa che avrebbe finito per aggravare la tendenziale dicotomia del mercato del lavoro tra lavoratori
“forti” e “deboli”.
Gli anni ’90 sono dominati dai problemi del risanamento e della stabilizzazione economica, aggravati dal peso del
debito pubblico, dall’inflazione e dalla fragile competitività del nostro sistema. Dopo una lunga pausa, ritorna dunque la
stagione dei protocolli, con una istituzionalizzazione e formalizzazione della concertazione triangolare, sempre
all'insegna della politica dei redditi, resa drammaticamente necessaria dall'accentuarsi della crisi finanziaria proprio alla
vigila della nascita dell'euro.
In una sequenza senza soluzione di continuità, all'accordo interconfederale del 23 luglio 1993, che rende stabile la
concertazione e riscrive il modello di contrattazione collettiva a tutt'oggi in vigore segue il protocollo del ’96 (Patto per
il lavoro), nel tentativo di rispondere all’esigenza di risanare i conti pubblici, in vista degli impegni assunti a Maastricht,
si concentra sulle tematiche occupazionali (introduzione del lavoro interinale, riforma del part-time; riforma della
disciplina dei LSU). Con l’accordo sociale per lo sviluppo e l’occupazione del ’98 (Patto di natale) la concertazione
assurge istituzionalmente al ruolo di strumento di coordinamento tra ordinamento statale e autonomia collettiva, ma
anche tra ordinamento nazionale e Unione Europea.
Sempre all’incombente crisi finanziaria si ricollegano due importanti riforme. La riforma previdenziale e la
privatizzazione del pubblico impiego.
La privatizzazione del pubblico impiego, realizzata con il d. lgs. 29\’93 (ora confluito nel T.U. n. 165 del 2001),
attraverso il quale il rapporto di pubblico impiego viene traghettato dal diritto pubblico al diritto privato, cioè dal diritto
amministrativo al diritto del lavoro, unificando così sotto il dominio unitario del diritto comune quasi l’intero universo
del lavoro subordinato; e ciò sul presupposto di rendere così l’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
meno costoso e burocratico. Non meno rilevante è la rivisitazione della normativa pensionistica (con un spesa
previdenziale ormai senza controllo) che porta al D.lgs. n. 124 del 1993, che vara la previdenza integrativa.
La legislazione sul rapporto e sul mercato del lavoro risulta caratterizzata da una duplice spinta di segno diverso.
Da una parte c’è tutta una tendenza ri-regolativa, dettata sia dall’intenzione di allargare l’area della tutela, sia dalla
necessità di razionalizzare una qualche normativa resa anacronistica dall’evoluzione economico-sociale. Questa
tendenza trova espressione in una sequenza ricca e articolata di leggi alcune delle quali molto importanti (la 108 del ’90
sui licenziamenti individuali, la 223 del ’91 sui licenziamenti collettivi, la 125 del ’91 sulle pari opportunità).
Dall’altra parte vi è una continuazione della tendenza de-regolativa del decennio precedente. Ne costituiscono
esemplificazioni la legge 223/1991, che delega al sindacato il delicato compito della gestione dei processi di crisi e
ristrutturazione delle imprese (l’individuazione di alternative al licenziamento e la determinazione dei criteri di scelta
dei lavoratori da licenziare collettivamente o da collocare in mobilità); oppure la L 196/1997 (c.d. pacchetto Treu), che
introduce il lavoro interinale e flessibilizza una serie di istituti, tra cui l’orario di lavoro.
7. Il diritto del lavoro, la globalizzazione e l'Europa.
Globalizzazione è una parola fin troppo abusata, per la sua capacità evocativa, ma ridotta all'essenza richiama una
dinamica di interazione sistematica tra le diverse economie nazionali, all'insegna di un'informazione in tempo reale e di
una competizione senza confine, tale da acquisire una sua dimensione autonoma e autosufficiente rispetto alla realtà dei
singoli stati, costretti ad adattarvisi. Il che comporta una ricaduta incisiva proprio su quei settori degli ordinamenti
interni, cresciuti e consolidatisi in termini strettamente nazionali, a misura di storie e di realtà socio-economiche
peculiari come, i sistemi di relazione collettive e i regimi disciplinanti i rapporti di lavoro. Tutto questo riduce i margini
di competizione sui mercati mondiali, incoraggiando la delocalizzazione industriale e disincentivando
l'entrata/permanenza di capitali esteri.
Si avvia un percorso verso un'Europa comunitaria, non solo economica ma anche politica. Un cammino che ha a lungo
risentito dell'imprinting originario del Trattato di Roma del 1957. Il momento di svolta coincide con la stipulazione del
Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) e più in particolare dell'accordo sulla politica sociale ad esso allegato (APS): il
Trattato trasforma la Cee in UE con una estensione delle sue competenze sociali, per la realizzazione e attuazione della
politica sociale comunitaria. Solo che l'accordo firmato da 11 stati membri su 12, è rimasto un semplice allegato del
Trattato del 1957, senza essere in grado di esprimere appieno tutto il suo impatto potenziale. Il che risulterà ovviato dal
trattato di Amsterdam (in vigore dal 1 maggio 1999) il quale promuove la cooperazione tra gli stati membri con una
Strategia europea per l'occupazione (SEO), articolata su quattro pilastri portanti: occupabilità, imprenditorialità,
adattabilità, pari opportunità.
Nel dopo Amsterdam continua il processo di unificazione. In proposito è sufficiente ricordare il Trattato di Nizza
(dicembre 2000), ed ora il varo della nuova costituzione europea, finalizzata ad imprimere alla realtà sovranazionale
non solo regole, ma valori e principi comuni, che dall'alto dovranno informare tutti i meccanismi di produzione ed
applicazione normativa. Tuttavia non poche rilevanti materie giuslavoristiche risultano ancora sottratte alla competenza
comunitaria, mentre altre restano soggette alla regola dell'umanità.
8. Le prospettive del nuovo secolo (c.d. Legge Biagi e riforma della Costituzione)
Si manifesta forte all’inizio del decennio 2000 una sollecitazione alla ripresa della concertazione, leit motiv degli anni
’90, ma che aveva esaurito la propria parabola con il Patto di Natale del ’98. tale sollecitazione trova risposta nel c.d.
Patto per l’Italia del 2002, accordo concluso tra governo e parti sociali, con l’intento di concretizzare le disposizioni
programmatiche contenute nel Libro Bianco in un’attività di riforma del mercato del lavoro, capace di assecondare le
istanze di flessibilità poste dal contesto economico europeo e mondiale.
Il Libro Bianco sul mercato del lavoro del 2001 è un documento programmatico contenente gli indirizzi generali della
azione di governo in materia di mercato del lavoro. Tale documento propone una rivisitazione a tutto campo del diritto
del lavoro: il tema di fondo è la flessibilizzazione del mercato del lavoro, da realizzarsi attraverso una distribuzione
graduata delle tutele dei lavoratori, lungo un continuum tra i due poli dell’autonomia e della subordinazione, con la
previsione di uno zoccolo minimo di garanzie anche per il gradino occupato dai rapporti di lavoro parasubordinato,
come le collaborazioni coordinate e continuative (tale previsione era contenuta nella proposta di Statuto dei lavori –
proposta che poi non troverà applicazione). A ciò si aggiunga la flessibilizzazione e l'accentuazione della deregolazione,
la sospensione; temporanea e sperimentale, degli effetti di cui all’art. 18 St. lav., finalizzata a promuovere l’occupazione
e l’emersione del sommerso. L’obiettivo perseguito è quello della flessibilizzazione del mercato del lavoro da realizzarsi
attraverso l’ampliamento degli spazi e dei margini di manovra della contrattazione individuale (riducendo gli spazi
destinati alla legge e alla contrattazione collettiva); favorire la diversificazione, incidendo sulla disciplina unitaria di
tutela del lavoratore.
Una peculiarità del Patto per l’Italia sta in ciò che, al termine “concertazione” si sostituì quello di “dialogo sociale”,
mutuato dal diritto comunitario. Il dialogo sociale si contraddistingue per la decisione unilaterale dell’esecutivo di
intervenire su determinate materie e per la possibilità di assumere l’iniziativa legislativa sulle questioni così individuate,
anche in mancanza di accordo o di unanime consenso del fronte sindacale, ferma restando, ovviamente, la consultazione
e la negoziazione con le parti sociali entro tempi certi e definiti.
Pur monca della parte riguardante la tutela contro il licenziamento la legge delega prosegue, esaltando il profilo della
flessibilizzazione delle tipologie di lavoro. Il proposito di armonizzare il nostro ordinamento con il panorama europeo
suggerisce l'approvazione del D.lgs. 532/1999 sul lavoro notturno nonché dei due decreti legislativi n. 61/2000 e
n.100/2001, sul lavoro part-time e il varo del D.lgs. 368/2001 sul contratto a termine, nonché del D.lgs. 66/2003
sull'orario di lavoro. La sottoscrizione del Patto per l’Italia portò all’emanazione di una legge delega al governo, la L.
30/2003 (legge Biagi) che, a sua volta, porterà al D. lgs. 276/2003, il quale eserciterà la delega in materia di mercato del
lavoro attribuita al governo dalla legge Biagi. Tuttavia l’attuazione delle indicazioni programmatiche del Libro Bianco,
non sarà integrale. Dal disegno originario prefigurato dal Libro Bianco, infatti, verrà stralciata la parte relativa alla
sospensione degli effetti dell’art. 18. Tuttavia, a differenza delle precedenti esperienze deregolative, stavolta alla
deregolazione segue una ri-regolazione accentrata, in cui il ruolo del sindacato e della contrattazione collettiva risulta
del tutto marginalizzato.
Nel tradurre i criteri direttivi della legge delega, il D. lgs. 276\2003 conferma il ruolo centrale della legge statale nella
gerarchia delle fonti. Sotto il profilo regolativo, poi, la marginalizzazione del sindacato e dell’autonomia collettiva,
permette l’esaltazione dell’autonomia privata individuale, cui il decreto consente di spaziare all’interno di un
ricchissimo panorama di rapporti, istituti, soggetto. Sempre a proposito del rilievo centrale della legislazione statale
nell’ambito del diritto del lavoro, tale posizione appare confermata anche dalla riforma del titolo V della Costituzione,
coeva al D. lgs. 276\2003 (L. Cost. 2001 n. 3). La riforma capovolge il rapporto tra legislazione statale e legislazione
regionale, rendendo la legislazione regionale residuale (diviene di competenza esclusiva regionale tutto quanto non
venga espressamente qualificato di competenza statale).
Tuttavia il legislatore della riforma include tra le materie oggetto di competenza legislativa concorrente la tutela e
sicurezza del lavoro. L’endiadi ha subito monopolizzato l’attenzione della dottrina, che ha espresso diverse opzioni
interpretative. Da un lato si è tentato di assegnare all’espressione tutela e sicurezza del lavoro un significato pieno,
coincidente con quello di “ordinamento giuslavoristico”. Dall’altro, a favore di una lettura più moderata, è stata
avanzata un’interpretazione (non solo letterale ma anche) sistemica, alla cui stregua l’espressione tutela e sicurezza va
raccordata con la competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile”. Secondo quest’ultimo
orientamento, che finora ha raccolto maggior consenso tra gli autori, il diritto del lavoro, in quanto parte
dell’ordinamento civile, resta di esclusiva competenza statale, con l’eccezione della materia della tutela e sicurezza del
lavoro, affidata alla competenza concorrente. In tal modo la competenza regionale viene circoscritta all’attività
amministrativa di tutela del lavoro (formazione, assistenza, collocamento, incentivazione all’occupazione), e si
scongiura il rischio di una federalizzazione dei diritti e delle tutele, tutt’ora di competenza della legislazione statale
esclusiva.
CAPITOLO UNO: IL TIPO “LAVORO SUBORDINATO”
1 La questione della subordinazione.
Nell’impianto codicistico il diritto del lavoro si caratterizza essenzialmente come diritto del lavoro subordinato: alla
subordinazione è dunque affidata la funzione di contraddistinguere il rapporto tipico oggetto della disciplina speciale di
quel diritto. E la subordinazione viene ricostruita come un particolare modo di essere della prestazione lavorativa. È
subordinata la prestazione che si svolge nell’organizzazione del datore di lavoro (“nell’impresa”), “alle dipendenze e
sotto la direzione” dello stesso (art. 2094 c.c.).
Ma la pregnanza qualificatoria della nozione di subordinazione come modo d’essere – eterodeterminato – della
prestazione lavorativa è fragile. Infatti l’eterodeterminazione (cioè la soggezione alle altrui decisioni e direttive) può
manifestarsi anche nell’ambito di altri rapporti aventi ad oggetto un’attività lato sensu lavorativa (es. contratto d'opera).
Per altro verso poi, l’eterodeterminazione può risultare assai attenuata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato
per lo più in dipendenza del genere di prestazione dedotta (ad esempio dirigenziale o altamente specialistica).
La storia del diritto del lavoro dunque si identifica con la storia della subordinazione. L’idoneità qualificatoria della
nozione di subordinazione è tuttavia messa alla prova in casi marginali e zone grigie. Ed è proprio in questi casi che la
nozione rivela inesorabilmente tutti i suoi limiti.
Il codice del 1865 ricollegava la distinzione tra lavoro subordinato ed autonomo a quella tra locatio operarum e locatio
operis, e dunque, alla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi.
Si ritenne dunque che la locatio operarum (lavoro subordinato) avesse come oggetto un’attività lavorativa in quanto
tale, avulsa dal risultato perseguito dal creditore e quindi con estraneità del debitore rispetto al rischio di quel risultato.
Mentre la locatio operis (lavoro autonomo) avesse ad oggetto uno specifico risultato di lavoro, consistente nel
compimento di un’opera o di un servizio, con conseguente rischio a carico del debitore.
Tuttavia la distinzione tra attività e risultato del lavoro è inadeguata a costituire il criterio discriminante tra i due tipi di
locazione delle opere. Nessun tipo di obbligazione infatti può prescindere da un risultato idoneo a soddisfare l’interesse
del creditore.
Per altro verso poi, la distinzione in dipendenza dell’oggetto dell’obbligazione non può trovare supporto nella diversa
ripartizione del rischio. È vero infatti che la distinzione tra locatio operis e locatio operarum ha storicamente avuto
rilievo pratico al fine di stabilire la diversa ripartizione, fra le parti contraenti, del rischio del lavoro, inteso come rischio
dell’utilità finale dell’attività dedotta in contratto (rischio che cade sul lavoratore nella locatio operis, sul datore di
lavoro nella locatio operarum). Ma ciò conferma che tale diversa ripartizione è una conseguenza della qualificazione del
rapporto come locatio operis oppure operarum e non può quindi fungere da criterio per la qualificazione stessa.
Cionondimeno la distinzione tra obbligazione di mera attività e obbligazione di risultato ha avuto lunga fortuna e solo in
tempi recenti è stata sottoposta ad una radicale e definitiva critica.
Si è anche tentato di agganciare la subordinazione a profili vari della condizione socio-economica del prestatore di
lavoro, valorizzando aspetti esterni alla fattispecie: estraneità ai mezzi di produzione, debolezza economica, ecc. Ma tali
tentativi sono falliti, in quanto estranei alla fattispecie legislativamente tipizzata e sprovvisti di sufficiente idoneità
qualificatoria. Si possono infatti trovare casi di “debolezza economica” al di fuori del vero e proprio lavoro subordinato,
così come può aversi il caso dell’appartenenza al lavoratore degli strumenti di lavoro o delle materie prime, senza che
per questo si fuoriesca necessariamente dall’ambito della subordinazione.
2. Le operazioni giurisprudenziali di qualificazione: il metodo tipologico
L’impossibilità di costruire una nozione generale ed omnicomprensiva di subordinazione sulla base dell’esile normativa
dell’art. 2094, ha spinto la dottrina a prestare maggiore attenzione alle operazioni di qualificazione effettuate dalla
giurisprudenza.
La giurisprudenza ha di fatto enucleato una serie di indici desunti dalla figura socialmente prevalente di lavoratore
subordinato e dalla normale disciplina del relativo rapporto; l’inserzione del lavoratore nell’organizzazione predisposta
dal datore di lavoro; la sottoposizione alle direttive, al controllo e al potere disciplinare dell’imprenditore; l’esclusività
della dipendenza da un solo datore; le modalità della retribuzione, generalmente a tempo e indipendente da risultato; il
vincolo dell’orario di lavoro; l’assenza del rischio, ecc.
La giurisprudenza, resasi conto dell’impossibilità di garantire la completa coincidenza tra fattispecie concreta e
fattispecie astratta attraverso un giudizio di identità (metodo sussuntivo), è giunta alla conclusione che l’operazione di
qualificazione può avvenire solo sulla base di un giudizio di approssimazione della fattispecie concreta rispetto al tipo
prefigurato dalla fattispecie astratta (metodo tipologico). Il procedimento di qualificazione si risolve dunque nella
riconduzione al tipo legale (e alla sua disciplina) delle fattispecie concrete che presentano una prevalenza degli indici
che caratterizzano il modello socialmente prevalente di lavoratore subordinato.
In proposito merita di essere riportata questa massima della Corte Costituzionale “l’elemento che contraddistingue il
rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere
direttivo e disciplinare del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione
aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la
forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva”.
Il giudizio di approssimazione comporta dunque stabilire se, malgrado l’assenza di alcuni indici della subordinazione,
l’assetto di interesse configurato dal rapporto da qualificare sia da ritenersi più vicino a quello espresso dal tipo lavoro
subordinato piuttosto che a altri tipi (contratto d’opera, agenzia, ecc.).
E per converso, trattandosi di un apprezzamento globale della fattispecie, nell’ambito di una valutazione di
approssimazione, si può anche avere un rapporto di lavoro subordinato che presenti elementi che, in connessione con
altri ed in situazioni diverse, potrebbero rivelare l’assenza di uno stato di subordinazione.
È evidente come tale giudizio comporti da parte del giudice una valutazione di merito largamente discrezionale. È la
Corte Costituzionale ha affermato che è censurabile, in sede di legittimità, soltanto l’individuazione degli indici di
subordinazione, mentre è insindacabile, se adeguatamente motivata, la valutazione delle circostanze di fatto che hanno
indotto il giudice a ritenere o escludere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
L’utilizzazione del metodo tipologico ha consentito alla giurisprudenza di operare (in ossequio alla forti pressioni
provenienti dal contesto sociale) negli anni un allargamento dell’area coperta dalla disciplina del rapporto di lavoro
subordinato (ed una conseguente estensione della relativa tutela). Si è parlato in relazione a questo fenomeno, di
espansione del diritto del lavoro subordinato.
3. La rilevanza della qualificazione operata dalle parti e le presunzioni giurisprudenziali. La procedura di
certificazione
L’innovazione tecnologica e la progressiva terziariarizzazione del mondo del lavoro hanno determinato un aumento dei
casi in limine tra l’area della subordinazione e quella dell’autonomia, andando così a rendere ancor più sfumata la zona
di demarcazione tra le due aree. Peraltro, proprio le crescenti difficoltà di qualificazione del rapporto hanno favorito
l’assunzione, tra gli indici giurisprudenziali, quale criterio sussidiario, del nomen iuris eventualmente attribuito dalle
parti al rapporto stesso. Precedentemente la giurisprudenza aveva sempre tendenzialmente ignorato il nomen iuris,sulla
base del presupposto che, data la tassatività del tipo “lavoro subordinato”, la qualificazione del rapporto spettasse al
giudice e che andasse dunque considerata irrilevante l’eventuale volontà delle parti.
Tuttavia a partire dagli anni ’80 la Suprema Corte si è dimostrata maggiormente aperta sulla questione, giungendo ad
affermare che “ai fini della qualificazione non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti.
La corte dunque richiama l’interprete ad una valutazione più attenta dell’elemento intenzionale, di cui esclude
l’incompatibilità con il principio che vuole la qualificazione saldamente agganciata alle oggettive modalità di
svolgimento del rapporto. Peraltro l’assunzione del nomen iuris nel novero degli indici utilizzabili, non si traduce in una
negazione della tassatività del tipo. Infatti a tale indice può farsi ricorso solo in via sussidiaria, ossia quando la volontà
delle parti non risulti contraddetta dalle modalità di effettivo svolgimento del rapporto (che sono sempre destinate a
prevalere in sede di qualificazione).
Al fine di alleggerire il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto, il D. lgs. 276/2003 ha introdotto nel nostro
ordinamento l’istituto della certificazione (come auspicato dal Libro Bianco).
Si tratta di una procedura volontaria, mediante la quale una Commissione appositamente istituita (presso gli Enti
Bilaterali, le Direzioni provinciali del lavoro, le province e le università) convalida (certifica) la qualificazione che le
parti danno al contratto di lavoro tra di esse stipulato.
La procedura può avere ad oggetto tutte le diverse tipologie flessibili di contratto di lavoro previste dallo stesso
D.lgs.276, nonché le rinunzie e le transazioni ex art. 2113 cod. civ. Restano invece esclusi i rapporti di lavoro instaurati
con le p.a., data l’esclusione generale del pubblico impiego dalla riforma.
Qualora le parti intendano avviare un procedimento di certificazione devono redigere un istanza comune (o comunque
sottoscriverla entrambe) e presentarla all’apposita Commissione territorialmente competente. Il D. lgs. 276 non prevede
un modello astratto di procedura, ma anzi, lascia ampia autonomia a ciascuna sede di certificazione (ente bilaterale,
direzione provinciale del lavoro, università), che dovrà determinare le fasi della procedura all’atto della propria
costituzione.
Ad ogni modo, il procedimento di certificazione deve concludersi entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza. L’atto che
certifica il contratto deve essere motivato e deve indicare il termine e l’autorità presso la quale eventualmente presentare
ricorso.
La certificazione esclude la possibilità di ricorso in giudizio in ordine alla qualificazione del rapporto, salvo il caso di
erronea qualificazione dello stesso da parte della Commissione o il caso di difformità tra il programma negoziale
certificato e quello effettivamente posto in essere. Tale efficacia, che in sostanza si traduce in una relativa
incontrovertibilità di quanto certificato, si esplica sia nei confronti delle parti stesse, sia nei confronti dei terzi. Gli
effetti della certificazione permangono dunque fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei
ricorsi esperibili dalle parti e dai terzi. Il ricorso può essere giurisdizionale o amministrativo.
-Il ricorso presso l’autorità giudiziaria è ammesso per erronea qualificazione del contratto, per difformità tra quanto
certificato e la successiva esecuzione del rapporto e per vizi del consenso (errore, dolo, violenza). Se il giudice accerta
l’erroneità della qualificazione, gli effetti scaturenti dalla sentenza retroagiscono fino alla data di stipulazione del
contratto. Se accerta la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, gli effetti
decorrono a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
-In quanto atto di natura amministrativa, poi, contro la certificazione è ammesso anche il ricorso davanti al TAR nella
cui giurisdizione ha sede la Commissione che ha certificato l’atto impugnato, ma solo per violazione del procedimento
o eccesso di potere. Ci sarebbe però da chiedersi in cosa possa consistere l’eccesso di potere con riferimento all’attività
di certificazione, nella quale il margine di discrezionalità amministrativa è pressoché inesistente, risolvendosi la
certificazione in una mera registrazione del voluto negoziale (del contenuto del rapporto voluto dalle parti).
4. Subordinazione, fattispecie tipica ed effetti.
È opinione consolidata che ogni rapporto che presenti le caratteristiche della subordinazione va necessariamente
ricondotto alla fattispecie tipica lavoro subordinato (tassatività del tipo). E una volta qualificato un rapporto come
rapporto di lavoro subordinato (ossia una volta ricondottolo alla fattispecie tipica), si producono tutti gli effetti
legislativamente correlati a tale fattispecie (tassatività della disciplina tipica). In parole povere, troverà inderogabile ed
integrale applicazione tutta quanta la disciplina tipica. Questi due orientamenti sono retaggio dell’antica concezione del
procedimento di qualificazione del rapporto sulla base di un giudizio di identità tra la fattispecie tipica e lo specifico
rapporto da qualificare.
Tuttavia, constatato che il procedimento di qualificazione si basa oggi su un giudizio di approssimazione (e non di
identità), occorrerebbe riconoscere che allo specifico rapporto, che pur viene qualificato come rapporto di lavoro
subordinato, possano ben difettare alcuni elementi propri della fattispecie tipica; magari elementi che vadano ritenuti
presupposti per l’applicazione di determinati profili della disciplina del rapporto. La disciplina tipica andrebbe quindi
considerata tendenzialmente (ma non necessariamente integralmente) applicabile al rapporto che viene qualificato come
di lavoro subordinato.
Ad esempio nel caso del lavoro dirigenziale ci si muove in direzione non già di un improbabile restringimento del tipo
legale, bensì dell’applicazione selettiva della disciplina tipica.
Questa è d’altronde la direzione segnata dalla proliferazione di norme eccezionali e derogatorie della regolamentazione
tipica, fino all’emersione di nuovi rapporti speciali. Al punto che si parla di frammentazione dell’unicità del rapporto di
lavoro e di destrutturazione del modello tipico, come risultato dell’operazione di moltiplicazione delle tipologie posta in
essere dalla c.d. riforma Biagi.
5. Para-subordinazione, lavoro autonomo, lavoro a progetto occasionale.
Speculare all’art. 2094 è l’art. 2222 c.d. civ, in base al quale si è in presenza di un contratto d’opera (lavoro autonomo)
quando “una persona si obbliga a compiere dietro corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente con perfetta parità dei soggetti del rapporto”.
L’elemento della durata della prestazione può dare luogo a figure ibride, ovvero di prestatori di lavoro formalmente
autonomi, ma di fatto ed in diversa misura dipendenti dal committente.
Tra la subordinazione e l’autonomia la dottrina ha così collocato la para-subordinazione, categoria sorta dalla
valorizzazione dal dato della debolezza o soggezione economica del prestatore di lavoro nei cfr. del committente.
Solo negli anni ’70 la para-subordinazione ha potuto vantare l’appoggio di alcuni fondamenti normativi. La legge di
riforma del processo del lavoro del ’73 (l. n. 533/1973) ha ricompreso tra le proprie destinatarie anche le controversie
relative a “rapporti d’agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una
prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. Da
questa definizione è poi sorta la fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa, dotata di autonoma
fisionomia e caratteri: il requisito della continuità rinvia ad una collaborazione durevole nel tempo, anche attraverso un
unico incarico di durata apprezzabile. La prevalente personalità va intesa come prevalenza dell’attività del lavoratore
sugli altri fattori impiegati (anche sul capitale). Il requisito della coordinazione implica un collegamento funzionale del
collaboratore con l’attività economica del committente. Tale tipo di collaborazione è diverso da quello richiesto dall’art.
2094 (lavoro subordinato), poiché deve esserci una certa libertà nelle modalità di esecuzione della prestazione.
Dal punto di vista della disciplina di tutela, il lavoro parasubordinato non si differenzia da quello autonomo. La
configurabilità di un rapporto di lavoro parasubordinato non implica infatti l’accesso alla disciplina tipica del lavoro
subordinato. Da qui i frequenti rilievi sull’inutilità della nozione di lavoro parasubordinato, specie se riguardata dal
punto di vista delle esigenze di drammatizzazione dell’alternativa secca tra tutela (subordinazione) e non tutela
(autonomia). Non a caso numerose sono le proposte di riforma, tra cui spicca la proposta di uno Statuto dei Lavori, poi
confluita nel programma di riforma del diritto di lavoro contenuto nel Libro Bianco dell'ottobre 2001.
Un momento di svolta nell’evoluzione della disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si ha poi
con il D. lgs. 276/03, che tenta di fare chiarezza sui confusi rapporti tra le aree della subordinazione e dell’autonomia,
introducendo per la prima volta un discrimine tipizzato lungo la linea di confine tra le due aree; il lavoro a progetto, che
va a sostituire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La ratio dell’introduzione di questa figura è quella di porre una linea di demarcazione quanto più netta possibile tra
autonomia e subordinazione, in modo tale da evitare l’abuso delle collaborazioni coordinate e continuative al fine di
eludere la legislazione posta a tutela del lavoro subordinato.
Il D.lgs. 276 dunque introduce la fattispecie lavoro a progetto attraverso una modifica\specificazione inerente alla figura
delle collaborazioni coordinate e continuative. Stabilisce infatti che tali “collaborazioni coordinate e continuative,
prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione” devono essere riconducibili ad uno o più progetti
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Tratto caratterizzante la fattispecie è dunque l’esistenza di uno
specifico progetto o programma di lavoro o fase di esso, che assurge a contrassegno della genuinità dell’autonomia del
rapporto. In assenza di tale progetto o programma manchi, ai sensi dell’art. 69 del D.lgs 276, il rapporto si considera
subordinato a tempo indeterminato.
Il progetto di riforma assolve alla funzione (essenziale in un rapporto di lavoro autonomo) di predeterminare il
perimetro dell’obbligazione del collaboratore, in modo tale da inibire al datore l’esercizio di quel potere direttivo che
caratterizza il lavoro subordinato. Il committente ha invece sul collaboratore un più limitato potere di coordinamento.
Dalle disposizioni sul lavoro a progetto restano esclusi, oltre la pubblica amministrazione (in virtù dell’esclusione
generale del decreto) ed alcuni specifici rapporti (come agenzia e rappresentanza commerciale), i rapporti occasionali.
Per prestazione occasionale si intende il rapporto di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno
solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito sia superiore a 5000 euro, nel
quale caso trovano applicazione le disposizioni sul lavoro a progetto. Una particolare fattispecie di prestazione
occasionale è poi quella del c.d. lavoro accessorio i cui soggetti possono essere adibiti a determinate mansioni per
riceverne in cambio un pagamento in buoni che potranno essere convertiti in denaro presso centri autorizzati
(concessionari). Il decreto delegato, come corretto dal D.lgs. 251/2004 delega ad un decreto ministeriale la fissazione
del valore nominale dei buoni. La differenza tra tale valore e il compenso netta è detratta concessionaria e versata, per
conto del lavoratore, in parte alla gestione separata INPS, in parte all' INAIL.
Il contratto a progetto deve essere stipulato per iscritto ai fini della prova e deve contenere l’indicazione del progetto,
della durata, del corrispettivo, delle forme di coordinamento. La stesura per iscritto del contratto (e l’indicazione del
progetto) sono estremamente importanti soprattutto per il committente, onde evitare che scatti la presunzione di
subordinazione di cui all’art. 69 del decreto.
Tuttavia a favore del collaboratore a progetto sono comunque previste alcune garanzie, talune già precedentemente
deducibili dalla disciplina codicistica (art. 2222 ss.)relativa al lavoro autonomo, altre nuove: tra le prime rientra ad
esempio il criterio della proporzionalità nella determinazione del corrispettivo, che dovrà tenere conto dei compensi
normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione. Tra le seconde, la
previsione che la gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore non comportano l’estinzione del rapporto, ma
solo la sua sospensione, senza erogazione del corrispettivo.
In coerenza con il rilievo dato al risultato, il legislatore stabilisce che il contratto si risolve al momento della
realizzazione del progetto, o comunque al raggiungimento del risultato. Tuttavia è stabilito che le parti possano recedere
prima della scadenza per giusta causa ed altresì secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite
dalle parti nel contratto di lavoro individuale. Ciò significa che le parti possono delineare un regime di libera
recedibilità o fissare penali per l'esercizio unilaterale del potere di recesso.
6. Lavoro associato e subordinazione (associazione in partecipazione e lavoro in cooperativa.
Il rapporto di lavoro subordinato delineato dall’art. 2094 è un rapporto di scambio articolato attorno a 2 obbligazioni
principali; l’attività lavorativa e la retribuzione. Si tratta di una fattispecie tipica in cui l’onerosità è elemento essenziale,
al pari della subordinazione.
A tal proposito vengono in rilievo alcuni rapporti, che, pur non essendo riconducibili alla figura del rapporto di lavoro
subordinato (in quanto privi dell’elemento di scambio lavoro-retribuzione), presentano una forte analogia con esso. È
questo il caso dei rapporti di carattere associativo (associazione in partecipazione, cooperative di lavoro).
L’associazione in partecipazione (artt. 2549.2554 c.c.) è un contratto col quale l’associante attribuisce all’associato la
partecipazione agli utili dell’impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto che può
anche consistere in una prestazione di lavoro. In teoria la fattispecie è facilmente distinguibile dal rapporto di lavoro
subordinato. Tuttavia in concreto, avviene frequentemente che la linea di demarcazione tra le 2 fattispecie sia tutt’altro
che netta. Anzi, l’estrema flessibilità di utilizzo dell’associazione in partecipazione ha spesso fatto sì che il relativo
contratto (come quello di co.co.co.) sia stato impiegato per dissimulare un rapporto di lavoro subordinato.
Basti pensare che lo specifico contratto di associazione può precludere qualsiasi attività di controllo dell’associato
sull’attività gestoria, escludere ogni forma di partecipazione dell’associato alle perdite e perfino garantirgli un guadagno
minimo. In queste ipotesi, nelle quali appare fortemente sfumato l’elemento paritario ed emerge una sostanziale
disparità economica e sociale fra le parti, i giudici sono soliti presumere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
e conseguentemente stabiliscono l’applicabilità della relativa disciplina tipica.
L'art 86, 2°comma, D.lgs. 276/2003 prevede che, in caso di assenza di un’effettiva partecipazione dell’associato
all’impresa associante e di adeguate erogazioni a suo favore, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi,
economici e normativi previsti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato corrispondente al medesimo
settore di attività. Ed in mancanza di contratto collettivo, ad una posizione corrispondente secondo il contratto di settore
analogo.
La fattispecie del lavoro in cooperativa è stata oggetto di attenzione da parte della legislazione dell’ultimo decennio, che
ha esteso al socio alcuni istituti tipici del lavoro subordinato (fondo di garanzia, cassa integrazione guadagni, ecc.).
Questi interventi hanno costituito l’istanza di tutela nella realtà delle cooperative, per lungo tempo relegata a margini
del diritto del lavoro.
Per la prestazione del socio in cooperativa la giurisprudenza non ha mai fatto ricorso alla presunzione di lavoro
subordinato, ma anzi ha utilizzato la presunzione opposta, cioè il ricorso alla presunzione di non subordinazione è stato
argomentato sulla base dell’assenza dell’elemento (essenziale in un rapporto di scambio) dell’alterità degli interessi (il
socio, nel prestare la propria opera, mira al raggiungimento dello scopo sociale).
Di recente, la L. 142/2001 (come modificata dall'art. 9 della L.d. 14 febbraio 2003, n.30) ha ricostruito in capo al
lavoratore-socio la titolarità di un rapporto in cui risultano una componente associativa ed una componente lavoristica.
Per quanto riguarda la qualificazione del rapporto di lavoro (che può essere subordinato o autonomo) la legge n. 142 ha
previsto l’obbligo per le cooperative di definire il regolamento sulla tipologia dei rapporti di lavoro. Sebbene quindi la
qualificazione del rapporto continui a dipendere dal suo effettivo contenuto il giudice non potrà non adottare (in luogo
della presunzione di non subordinazione) la presunzione di conformità di quel contenuto alla qualificazione attribuitagli
nel regolamento.
Ai soci lavoratori subordinati si applicano lo Statuto dei Lavoratori. Il socio ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e in ogni caso non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe
dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine. Le controversie relative alla posizione del
socio lavoratore, comprese le procedure di conciliazione ed arbitrato, sono assoggettate alla disciplina del processo del
lavoro; mentre quelle relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.
7. Il cumulo delle posizioni di socio o amministratore e di lavoratore subordinato.
L’attenuazione della subordinazione può dipendere inoltre dal cumulo in capo al medesimo soggetto della posizione si
lavoratore subordinato con quella di socio o amministratore della società datrice di lavoro. In tal caso la giurisprudenza
ammette che il lavoratore possa essere socio della società sua datrice di lavoro, anche che si tratti di una società di
persone, salvo che la prestazione costituisca oggetto di conferimento e sia quindi resa dal socio in adempimento del
contratto sociale. Si richiede semplicemente, nel caso di società di persone, che l’attività lavorativa sia prestata sotto il
controllo gerarchico di un altro socio; e nel caso di società di capitali, che il socio non sia azionista unico o socio
sovrano.
In parole povere il cumulo è escluso solo nel caso in cui il lavoratore sia amministratore unico o amministratore
delegato con poteri illimitati; in tali casi si verrebbe ad avere un fenomeno di auto-assunzione, che farebbe sfumare ogni
ipotesi di subordinazione.
Naturalmente è assai difficile se non impossibile distinguere in concreto interessi e funzioni pertinenti ad un soggetto
nella qualità di amministratore delegato da interessi e funzioni pertinenti allo stesso soggetto nella qualità di lavoratore
subordinato. Ciò spiega perché capita frequentemente di veder negata, in giurisprudenza, la compatibilità delle due
posizioni specie in ragione dell'assenza di un'attività di lavoro subordinato distinguibile dall'attività di amministratore.
8. Lavoro gratuito, lavoro familiare e volontariato.
L’onerosità è elemento costitutivo sia della fattispecie lavoro subordinato che della fattispecie lavoro autonomo. Il nesso
sinallagmatico che caratterizza entrambi i tipi di rapporti, impone che la prestazione lavorativa venga resa in cambio di
una controprestazione (la retribuzione o il compenso).
Il problema della configurazione ed ammissibilità del lavoro gratuito ha dato luogo ad un dibattito dottrinale con due
opinioni contrastanti.
Da un lato, si afferma che il rapporto di lavoro gratuito, nonostante innominato, è lecito in quanto idoneo a realizzare,
mediante l'impegno di lavorare senza salario, interessi di tipo benefico o ideologico, meritevoli di tutela da parte
dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 1322 c.c (c.d. tesi del contratto atipico di lavoro).
Dall'altro lato si osserva la necessaria ed ineliminabile inerenza dell'onerosità ad ogni rapporto di lavoro subordinato
giuridicamente rilevante.
In pratica i giudici distinguono tra la prestazione di lavoro gratuita svolta a titolo di cortesia (cioè al di fuori di ogni
vincolo giuridico) e il vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con illegittima esclusione della retribuzione, cui il
lavoratore può aver acconsentito per motivi diversi, quali l’aspettativa di vantaggi materiali differiti nel tempo.
In tal caso, il titolo gratuito è riconosciuto solo qualora, dall’analisi delle circostanze del caso, sia possibile giustificare
la causa gratuita ed escludere con certezza la sussistenza di un accordo elusivo della irrinunciabilità della retribuzione.
La questione dell'ammissibilità del lavoro gratuito non muta i suoi termini neppure se riguardata dall'angolazione delle
peculiarità che contraddistinguono il c.d. terzo settore, il non-profit. Qualora il rapporto abbia natura subordinata
sussiste necessariamente anche l'onerosità, elemento strutturale indispensabile alla fattispecie. Diversamente, è possibile
solo ricorrere alle ipotesi di lavoro gratuito tipizzate dal legislatore (volontariato; stage aziendali; lavoro senza rapporto
come i lavoratori socialmente utili ecc.).
Vi è tuttavia un’ipotesi in cui la giurisprudenza non ha mai utilizzato la presunzione di ricorrenza del lavoro subordinato
tipico (oneroso), ma anzi ha sempre fatto ricorso alla presunzione contraria di gratuità. È questo il caso del lavoro
prestato nell’ambito di un’impresa gestita da familiari. In tal caso si pone la presunzione che il lavoro sia reso per
ragioni di mutua solidarietà e al di fuori di un rapporto subordinato tipico (che tuttavia resta consentito alle parti di
costituire). Detto questo, va anche ricordato che il lavoro prestato nell’impresa familiare è stato dotato di una particolare
tutela (al prestatore di lavoro nell'ambito della famiglia vengono assicurati, oltre al mantenimento, la partecipazione agli
utili e ai beni nonché il diritto a concorrere alle fondamentali decisioni del nucleo familiare) con la riforma del diritto di
famiglia del 1975, che ha introdotto la figura dell’impresa familiare, condensata nell'art. 230 bis del codice civile.
Al lavoro svolto nella comunità familiare viene comunemente accomunato, ai fini della presunzione di gratuità, il
lavoro religioso nell’ambito della propria comunità, anche se è ammesso che in capo al religioso possa configurarsi un
rapporto di lavoro subordinato quando la sua attività sia svolta in favore di un soggetto privato o ente pubblico dietro
corrispettivo e non officii causa o religionis causa.
La presunzione di gratuità non operava infine con riguardo ai casi di praticantato presso studi professionali ed ai casi di
volontariato nell’ambito di organizzazioni laiche o religiose attive nell’assistenza sociale. In tali casi tuttavia si tendeva
a giustificare il titolo gratuito e ad escludere la frode facendo riferimento agli obiettivi non di lucro perseguiti dal
prestatore di lavoro (apprendimento, impegno sociale, ecc.).
Con la legge quadro sul volontariato (L266/1991) poi, si è stabilito che le organizzazioni di volontariato, per potere
essere qualificate come tali, debbano avvalersi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
propri associati o aderenti. L’attività di costoro è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o
autonomo, e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l’organizzazione di cui fanno parte. Va detto tuttavia che
la legge riconosce al volontario il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, ma solo entro limiti
predeterminati. Sull’organizzazione ricade comunque l’obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le
malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
9.La questione dei rapporti di lavoro speciali o di disciplina speciale.
Nel panorama produttivo si riscontrano rapporti di lavoro che, pur essendo sicuramente di natura subordinata,
presentano deviazioni più o meno accentuate rispetto alla fattispecie tipizzata dall’art. 2094. Si parla allora di rapporti di
lavoro speciali o a disciplina speciale.
Numerose e varie sono le ragioni della specialità; ed in proposito sono avanzate diverse teorie. Taluni ritengono che la
specialità possa derivare solo da alterazioni qualitative o causali del tipo (ad esempio nell’apprendistato l’elemento
formativo gioca un ruolo importante, per quanto riguarda la causa del rapporto). Altri ritengono che la specialità possa
derivare dall'incidenza di un interesse pubblico o della collettività o o dalla peculiarità dell'oggetto della prestazione.
Altri invece ritengono che la specialità possa derivare anche da variazioni meramente quantitative (ad esempio quelle
che si realizzano nel part-time o nel contratto di lavoro a tempo determinato).
Per quanto riguarda la disciplina applicabile a tali rapporti, l’opinione prevalente ritiene la disciplina generale
comunque applicabile per gli istituti che non sono oggetto di attenzione da parte della legge speciale.
La dottrina italiana preferisce tendenzialmente al termine “specialità” il termine più debole “atipicità”.
La tendenza alla deregolazione ha innescato a partire dagli anni ’80 un processo di diversificazione delle tipologie di
rapporto (c.d. articolazione del tipo).
Per distinguere le singole figure nei confronti della fattispecie madre sottesa all’art. 2094 (lavoro a tempo pieno e
determinato), la dottrina ha cominciato ad utilizzare il concetto di atipicità, riconducendo ad esso tutti quei rapporti di
lavoro subordinato che si discostano dalla fattispecie madre (il lavoro a termine, il part-time, il lavoro temporaneo,
ecc.). Posta in questi termini la questione appare di ordine meramente classificatorio o nominalistico. Ben più pregante
è la diversa alternativa concernente l'esaustività o meno della disciplina dettata per il lavoro speciale, cioè vale a dire il
quesito circa l'applicabilità o meno della disciplina generale del lavoro subordinato. Prevale l'opinione che la disciplina
generale risulti comunque applicabile per gli istituti non oggetto di specifica attenzione della legge speciale e che quindi
non opera alcun meccanismo di implicita incompatibilità. E ciò anche per effetto di un'applicazione analogica dell'art.
2239 c.c
9.1. Il lavoro a domicilio e il telelavoro.
Il fondamentale profilo di specialità del lavoro a domicilio è correlato al luogo di esecuzione della prestazione
lavorativa; non l’azienda del datore ma il domicilio dello stesso prestatore.
La ragione dell’elaborazione di un nucleo di disciplina specifica va ricercata nelle frequenti pratiche di evasione delle
garanzie assicurate dalla disciplina tipica al lavoratore subordinato, attraverso il lavoro a domicilio, rendendo incerta la
linea di confine con il lavoro autonomo.
La L. 877/1973 persegue l’obiettivo di scongiurare le pratiche evasive,anche attraverso una definizione fluida di
subordinazione nel lavoro a domicilio
In tal senso la il legislatore stabilisce all'art. 1 della suddetta legge che “è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo
di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di
membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro
retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello
stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi”.
In parole povere, nel lavoro a domicilio la subordinazione può presentarsi anche in forma alterata, bastando ad esempio,
che le direttive dell’imprenditore committente circa le modalità di esecuzione del lavoro siano impartite, non già di
volta in volta, ma all’inizio ed una volta per tutte, e che successivamente vi sia un controllo ella rispondenza del lavoro
finito a tali direttive. Si configura invece un’ipotesi di lavoro a domicilio autonomo quando il lavoratore presenta una
distinta organizzazione dei mezzi produttivi (a proprio rischio) e una struttura di tipo imprenditoriale
Altre disposizioni della legge 877/1973 intendono frenare possibili abusi di un uso spregiudicato del lavoro a domicilio.
Così non possono ricorrere al lavoro a domicilio sia le imprese in fase di ristrutturazione, riorganizzazione o
riconversione sia le imprese che abbiano ceduto a qualsiasi titolo macchinari e attrezzature per proseguire all'esterno la
stessa attività produttiva già svolta all'interno dei reparti. I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori a
domicilio e tale tipologia di lavoratori devono essere iscritti in un apposito registro. È esclusa l'ammissibilità
dell'esecuzione del lavoro a domicilio per attività che comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi.
La retribuzione del lavoratore a domicilio deve essere determinata in base alle tariffe di cottimo pieno risultanti dai
contratti collettivi di categoria, o, in mancanza, fissate da una Commissione regionale i cui membri sono designati dai
sindacati di categoria maggiormente rappresentativi.
Allorché non si verifichino evasioni della disciplina protettiva, il ricorso al lavoro a domicilio è ascrivibile al fenomeno
del c.d. decentramento produttivo, cioè della frammentazione del processo produttivo e della esportazione di talune
delle sue fasi all’esterno dell’organizzazione aziendale riconducibile all’imprenditore.
Una peculiare ipotesi di lavoro a domicilio è il telelavoro, vale a dire il lavoro svolto nel proprio domicilio mediante un
computer collegato ad una memoria centrale. Con questo sistema i lavori di archiviazione dati, di dattilografia e altre
mansioni d’ufficio possono essere decentrate, permanendo intatto un forte potere di controllo a distanza del datore di
lavoro. Mentre nel settore pubblico il telelavoro è regolato legislativamente, nel privato manca una sua disciplina
legislativa ad hoc, giacché la regolamentazione è demandata ad accordi quadro con cui si definiscono le garanzie
minime dei telelavoratori. Attualmente il telelavoro non riesce neppure a configurarsi come una tipologia contrattuale
specifica, costituendo piuttosto solo una modalità flessibile e delocalizzata di esecuzione della prestazione lavorativa. A
seconda delle condizioni concrete di svolgimento del rapporto infatti, il telelavoratore può essere titolare di un rapporto
autonomo, parasubordinato o subordinato.
9.2. Il lavoro domestico.
Il lavoro domestico rinviene la sua regolamentazione nel codice civile (artt. 2240-2246) e poi nella l. 2 aprile 1958, n.
339; quest'ultima però, è applicabile ai soli prestatori impegnati in modo continuativo e prevalente per almeno 4 ore
giornaliere presso lo stesso datore di lavoro (art. 1).
Si considera lavoratore domestico colui che presta attività a favore di una comunità familiare o di comunità similari.
La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2068, 2° comma, c.c., che espressamente sottraeva alla disciplina
sindacale i rapporti di lavoro in esame, ha permesso la stipula di contratti collettivi, sulla cui effettività e generalizzata
applicazione possono però nutrirsi fondate perplessità.
I lavoratori domestici possono ancora oggi essere licenziati ad nutum, ma va ricordato che la l. n. 108/1990 ha previsto
la nullità con diritto di reintegra, del licenziamento determinato da ragioni discriminatorie.
9.3. Il lavoro giornalistico.
L'attività giornalistica, solitamente prestata a favore di aziende editrici, oltre che oggetto di un rapporto di lavoro
subordinato, può assumere la veste di collaborazione autonoma, ma presuppone in ogni caso il requisito
dell'appartenenza all'Ordine professionale dei giornalisti.
Ai sensi dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36 Cost. Il lavoratore per la natura subordinata della prestazione resa, ha diritto al
trattamento economico previsto dal contratto collettivo. In altre parole, la mancata iscrizione all'albo professionale, pur
essendo penalmente sanzionata a norma degli artt. 348 e 498 cod. pen., non rende illecito né l'oggetto né la causa del
contratto e dà origine ad una prestazione di fatto rilevante agli effetti della pretesa retributiva, mentre si deve escludere
l'applicabilità del contratto collettivo per tutte quelle clausole che non riguardano i trattamenti economici. Nel lavoro
giornalistico, per la particolare natura intellettuale, può presentarsi più attenuato il vincolo di subordinazione rispetto ad
altre attività lavorative, in ragione dei margini di autonomia e discrezionalità.
Per ottenere l'iscrizione all'ordine è richiesto l'esercizio continuativo della pratica giornalistica, realizzata attraverso un
praticantato durante il quale l'aspirante giornalista viene impiegato nei servizi redazionali per apprendervi l'attività
giornalistica ed acquisire l'indispensabile preparazione. Una volta iscritti all'Albo i giornalisti sono divisi in due
categorie: quella dei professionisti (esercitanti in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica) e quella dei
pubblicisti (svolgenti un'attività non occasionale e retribuita, eventualmente in concorso con altre professioni e
impieghi).
Il contenuto del rapporto di lavoro giornalistico è regolato da un contratto collettivo nazionale. Il contratto collettivo
riconosce al giornalista una particolare tutela della sua dignità professionale e morale, nell'ipotesi di mutamento
dell'indirizzo politico del giornale, attraverso la previsione di un motivo legittimo di dimissioni in tronco senza perdere i
benefici economici e la particolare indennità (c.d. Indennità fissa), altrimenti riconosciuta solo nei casi di licenziamento
per colpa dell'editore (c.d. Clausola di coscienza).
L'art. 4 l. n. 108/1990 riconferma per l'azienda giornalistica che non riveste i caratteri dell'impresa l'esclusione
dell'applicabilità dell'art. 18 St. lav.; pertanto i rapporti di lavoro restano soggetti alla sola tutela obbligatoria,
indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Viceversa, ai datori imprenditori di tendenza si dovrà applicare l'art.
18 St. lav. (come modificato dall'art. 1, l. n. 108/1990).
9.4. Il lavoro sportivo.
Il rapporto di lavoro intercorrente tra atleti professionisti e società sportive è stato regolamentato ex professo con la l. 23
marzo 1981, n. 91. La recente normativa inquadra espressamente tale fattispecie nell'ambito del lavoro subordinato.
Tuttavia la legge ammette che la prestazione a titolo oneroso dell'atleta debba qualificarsi come lavoro autonomo
quando ricorra uno dei seguenti presupposti. a)l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o
più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b)l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò
che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o di allenamento; c)la prestazione che è oggetto del contratto, pur
avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali o cinque giorni ogni mese o trenta giorni ogni anno.
Tra gli aspetti salienti dell'intervento legislativo vanno segnalati: l'assunzione diretta dell'atleta senza il tramite
dell'ufficio di collocamento; l'obbligo di stipulare per iscritto, a pena di nullità, il contratto individuale che dovrà
uniformarsi ad un contratto tipo predisposto in conformità all'accordo triennale stipulato dalla Federazione sportiva
nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate, stabilendosi altresì che eventuali clausole peggiorative del
contratto individuale sono sostituite di diritto da quelle contenute nel contratto tipo: la mancata applicazione di alcune
norme dello Statuto dei lavoratori (artt. 4, 5, 13, 33, 34) nonché della disciplina vincolistica concernente i licenziamenti
individuali. In materia disciplinare l'art. 7 St. lav. consente alle parti di deferire ad un collegio arbitrale la definizione
delle controversie riguardanti l'attuazione del contratto stesso.
9.5. Il lavoro nautico.
La necessità di contemperare esigenze protettive del lavoratore con altri interessi legislativamente considerati e di
particolare rilevanza giustifica la specialità del rapporto di lavoro nautico (marittimo ed aereo).
L'interesse pubblico alla sicurezza della navigazione pervade tutta la materia ed impone una regolamentazione rigorosa
e specifica. L'art. 1 cod. nav. detta un criterio generale in virtù del quale ogni rapporto ricadente nell'area nautica resta
assoggettato alle norme del codice di navigazione e soltanto l'abrogazione o lacune consentono il subentro del diritto
civile comune. La peculiarità del settore hanno spinto il legislatore dello Statuto (art. 35, 3°comma) a non estendere tout
court l'intera legge n. 300/1970 al personale navigante, bensì a distinguere tra disposizioni immediatamente applicabili e
le restanti norme suscettibili di applicazione solo se espressamente richiamate dai contratti collettivi di categoria.
In particolare dalla mancanza di immediata operatività dell'art. 18 St. lav. si è tratto spunto per sollevare l'eccezione di
incostituzionalità dell'art. 35, 3°comma, St. lav. accolta dalla corte costituzionale con rif. sia al personale marittimo
navigante delle imprese di navigazione (sull'assunto che la contrattazione collettiva non è intervenuta a rendere operante
l'art. 18 dello Statuto, emergendo un'ingiustificata disparità di trattamento tra il personale marittimo navigante ed i
lavoratori comuni), sia al personale aeronavigante, estendendo con carattere di immediatezza a quest'ultimo il regime
della stabilità reale ex. Art. 18 St. lav.
CAPITOLO DUE: LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
1. La contrattualità del rapporto di lavoro.
La matrice contrattuale del rapporto di lavoro era pacifica allorché esso era considerato una sottospecie della locazione.
Tale matrice restò radicata anche quando la dottrina diede avvio al suo processo di distacco dallo schema locatizio.
Tuttavia, nel corso del primo ‘900, per influenza di una corrente di pensiero tedesca, si affermarono presso di noi talune
suggestioni di carattere istituzionalistico-comunitario. L’impresa si sostanzierebbe in una comunione di scopo tra datore
e lavoratore, destinata ad esprimersi in un rapporto di lavoro organizzato su base gerarchica. Fonte del rapporto sarebbe
non il contratto, bensì l’inserzione del lavoratore nell’impresa ossia nell’organizzazione creata e diretta dal datore
medesimo. Tali suggestioni, congeniali all’ideologia corporativa, parvero trovare consacrazione nel codice civile del
’42. il codice infatti non definisce il contratto di lavoro subordinato, ma il prestatore di lavoro subordinato ed intitola la
disciplina al rapporto e non al contratto, collocandola nel libro 5° (sull’impresa) e non nel libro 4°, dove sono
disciplinati i più importanti contratti di scambio. Cionondimeno la nostra dottrina è rimasta contrattualistica, facendo
emergere con sufficiente linearità un rapporto di scambio.
Va tuttavia dato conto di un filone dottrinale che, pur accogliendo la concezione conflittuale-scambistica della relazione
tra datore e lavoratore, si è focalizzata sull’organizzazione di lavoro come fonte di situazioni giuridiche sostanzialmente
autonome dal contratto, fino al punto di negare la matrice contrattuale del rapporto. Il rapporto di lavoro trarrebbe
origine dal fatto in sé della materiale prestazione di attività lavorativa e dalla correlata inserzione nell’organizzazione di
lavoro. Tale dottrina ha ritenuto di trovare un aggancio normativo nell’art. 2126 c.c. (prestazione di fatto con violazione
di legge); tale articolo stabilisce che la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo
in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità della causa o dell’oggetto.
Se, malgrado la nullità o l’annullamento del contratto, si producono i normali effetti del rapporto di lavoro subordinato
in virtù della sua materiale esecuzione, bisognerebbe riconoscere, secondo questa dottrina, che fonte di quel rapporto
non è il contratto, bensì la prestazione di fatto dell’attività lavorativa.
La dottrina contrattualistica però ha potuto ribattere che l’art. 2126 non prefigura un superamento della matrice
contrattuale del rapporto, giacché esso presuppone un contratto, sia pure invalido (portata retrospettiva).
La difesa della prospettiva contrattuale ha trovato pieno conforto nell'evoluzione legislativa, specie nello Statuto dei
Lavoratori. Il contratto di lavoro si differenzia dagli altri schemi negoziali di scambio per la rilevanza giuridica che è
attribuita al profilo organizzativo, cioè alla destinazione del rapporto a svolgersi nell'organizzazione del lavoro. La
matrice contrattuale è altresì pacifica nell'ambito della pubblica amministrazione, giusta la riconduzione legislativa del
rapporto di lavoro sotto l'egida del diritto comune (art. 2, 2°comma, D.lgs. n. 165/2001). E' la cosiddetta privatizzazione
dell'impiego pubblico, che ha riformato lo status giuridico dei dipendenti della pubblica amministrazione,
inquadrandolo nella medesima cornice scambistico negoziale del privato.
2. Art. 2126 cod. civ. e prestazione di fatto.
L'art. 2126 c.c. ha una portata solo retrospettiva e non proiettiva. Rapporto tipico e rapporto di fatto non sono
pienamente identificabili, giacché con l'esecuzione non si riproducono tutti quanti gli effetti del contratto tipico.
I limiti effetti (retrospettivi) dell’art. 2126 si producono solo allorché esista un contratto, sia pure invalido. Non si
producono tali effetti quando manchi il consenso o contro la dichiarata volontà del datore di lavoro. In questo caso, il
prestatore di lavoro potrà invocare esclusivamente la disciplina sull'ingiustificato arricchimento (art. 2041 ss. c.c), come
del resto nell'ipotesi di prestazione resa in esecuzione di un contratto con causa o oggetto illeciti.
Va detto tuttavia che la giurisprudenza, di fronte allo svolgimento di un’attività lavorativa, tende a presumere il
consenso del datore, con la conseguenza che la prestazione si considera generalmente resa in esecuzione di un contratto
di lavoro (stipulato per fatti concludenti), salva la prova contraria, gravante sull’imprenditore.
E la stessa nascita di un rapporto di lavoro subordinato (e l’applicazione della relativa disciplina tipica) esige un
contratto. È necessario ossia che le parti si accordino per operare uno scambio tra lavoro e remunerazione; altrimenti
non si ha rapporto di lavoro. Casi emblematici in tal senso sono il lavoro gratuito (ove difetta lo scambio) ed il lavoro
invito domino (ove difetta lo stesso accordo). Per lavoro prestato invito domino, s’intende il lavoro prestato senza il
consenso o addirittura contro la volontà del datore. In tal caso il prestatore di lavoro potrà invocare soltanto la disciplina
sull’ingiustificato arricchimento (come del resto nell’ipotesi di prestazione resa in esecuzione di un contratto con causa
o oggetto illeciti).
Si è anticipato che l'eccezionale regime disposto da tale norma non opera nel caso di illiceità dell'oggetto o della causa;
in tal caso il prestatore di lavoro potrà invocare la disciplina sull'ingiustificato arricchimento. Solo qualora l'illiceità
dipenda dalla violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126, 2°comma), questi avrà comunque
diritto alla retribuzione pattuita.
La presunzione relativa alla stipulazione del contratto per fatti concludenti è consentita ai giudici dalla regola generale
di libertà della forma nella stipulazione del contratto di lavoro.
È infine il caso di menzionare che è generalmente esclusa l’applicabilità in via analogica dell’art. 2126 al di fuori del
lavoro subordinato (ossia al lavoro autonomo e parasubordinato).
3. Il lavoratore: capacità giuridica e capacità di agire
L’implicazione della persona del lavoratore nel rapporto fa sì che ad essa si attribuisca rilevanza sia nella fase di
costituzione che in quella di esecuzione del rapporto. Ne deriva innanzitutto una regola di infungibilità soggettiva della
prestazione lavorativa (caratterizzata dall’intuitus personae), che è a sua volta conseguenza del principio generale di
intrasmissibilità della relativa obbligazione (sia inter vivos che mortis causa).
Per quanto riguarda la stipulazione del contratto, si suole parlare di capacità giuridica speciale, riferendosi alla
disciplina particolare (penalmente sanzionata), che fissa i requisiti d’età per l’accesso al lavoro. La capacità (giuridica)
di essere parte di un rapporto di lavoro coincide infatti con la c.d. capacità al lavoro, che si acquista con l’età minima di
ammissione al lavoro, indicata dalla l. 17 ottobre 1967, n. 977 ed integrata dal D.lgs. 4 agosto 1999 n. 345, traspositivo
della Direttiva n. 94/33/CE per la protezione dei giovani sul lavoro. Ai sensi dell'art. 2 l. n. 977/1967 “l’età minima per
l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e
comunque non può essere inferiore ai 15 anni (18 anni per il pubblico impiego).
Coerentemente con ciò il legislatore stabilisce un generale divieto di lavoro per il bambino, intendendo tale il minore
che non abbia ancora compiuto 15 anni o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico. Va detto tuttavia, che con
l’assenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale e l’autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è
legittimo l’impiego del bambino in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, purché ciò
non comporti un pregiudizio per la sicurezza, la salute, lo sviluppo o l’istruzione del bambino.
Piena capacità al lavoro hanno invece gli adolescenti, ossia i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni non più soggetti
all’obbligo scolastico. Sussiste tuttavia un divieto ad adibire gli adolescenti a specifiche attività lavorative,
tassativamente indicate dal legislatore, a tutela della loro sicurezza e salute.
Il difetto della capacità giuridica speciale (ossia dell’età minima per l’ammissione al lavoro) integra la mancanza di un
presupposto essenziale per la validità del contratto di lavoro e determina pertanto la nullità del contratto stesso per
illiceità dell’oggetto. Tuttavia nonostante, la nullità sia dovuta all’illiceità dell’oggetto del contratto, resta comunque
applicabile l’art. 2126, poiché il limite di ammissione al lavoro è previsto a tutela dello stesso lavoratore minore.
Diverso dal profilo della capacita giuridica speciale è quello della capacità di agire, cioè di stipulare il contratto di
lavoro da parte del soggetto provvisto dell’età minima di ammissione al lavoro. Nel 1975 il legislatore, nell’abbassare a
18 anni il raggiungimento della maggiore età, ha esplicitamente stabilito che sono fatte salve le leggi speciali che
stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità di prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato
all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. La nuova disciplina è stato oggetto di letture
contrapposte tra le quali spicca quella che ritiene che ormai si deve ritenere legislativamente sancita la coincidenza tra
capacità giuridica speciale e capacità di agire. Il difetto di capacità d’agire determina l’annullabilità del contratto. E dal
momento che il difetto di capacità di agire non incide sulla liceità dell’oggetto del contratto, è senz’altro applicabile
l’art. 2126.
4. Segue: Minori e lavoro.
Fermi restando i limiti di ammissione al lavoro, la l. n. 977/1967 appresta speciali garanzie a favore dei lavoratori con
età inferiore ai 18 anni per esigenze di tutela della salute e dello sviluppo dei minori. Il lavoro minorile solo da qualche
tempo costituisce oggetto di autonoma considerazione: infatti la tutela del lavoro minorile è stata per lunghi anni
accomunata alla tutela del lavoro femminile, nell’ambito di quella normativa di tutela delle “mezze forze di lavoro”,
volta a scoraggiarne lo sfruttamento.
L’esigenza di una disciplina differenziata è emersa con l’art. 37 Cost., che ha sancito tre principi fondamentali. Il primo
costituzionalizza la competenza legislativa in tema di età minore per l'ammissione al lavoro. Il secondo istituzionalizza
la tutela speciale per il lavoro minorile, distinguendolo dal lavoro femminile(per il quale non è prevista una tutela
speciale, ma solo la necessità di contemperare il lavoro della donna con la sua essenziale funzione familiare). Il terzo
principio dell’art. 37 poi, stabilisce che il minore ha diritto, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore
adulto
La tutela speciale del lavoro minorile indicata dall’art. 37 Cost. si è tradotta nelle disposizioni della l. n. 977 del 1967 e
risulta una normativa (allineata con gli standards internazionali ed in particolare con la Carta dei diritto fondamentali
dell’Unione). Il D.lgs. n. 345/1999 ha provveduto ad attuare la Direttiva 94/33/CE, novellando la l. n. 977 del 1967 con
l'obbiettivo di privilegiare l’istruzione, assicurare l’inserimento professionale mediante la formazione, garantire la salute
e la sicurezza dei minori, in quanto gruppo a rischio particolarmente sensibile. Ne risulta dunque una disciplina unitaria,
rivolta a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, in cui vengano coinvolti minori, incluso l’apprendistato, i contratti
di formazione e lavoro ed il lavoro a domicilio.
Così, fermi i già visti divieti in materia di ammissione al lavoro, la legge contempla due generali requisiti di
ammissibilità del lavoro minorile: a)che il datore di lavoro effettui la valutazione dei rischi ambientali (art. 4 D.lgs.
n.624 del 1994); b) che il minore si riconosciuto idoneo a svolgere la specifica prestazione oggetto del contratto con una
visita medica pagata dall’imprenditore ed eseguita da un medico del servizio sanitario nazionale, sia prima
dell’assunzione, sia dopo, con cadenza almeno annuale.
Il lavoro notturno è poi proibito per tutti i minori, salvo il caso delle prestazioni culturali, artistiche, sportive e
pubblicitarie.
5. Il datore di lavoro.
Se la capacità di lavoro del prestatore è subordinata al possesso di requisiti soggettivi speciali, nulla di analogo è
previsto invece per il datore di lavoro, applicandosi ad esso le regole civilistiche sulla capacità giuridica e di agire
destinate alla generalità dei soggetti.
Piuttosto, sul versante datoriale rileva la distinzione tra imprenditori e non imprenditori, questi ultimi titolari di
un’attività organizzata a fini non lucrativi (non profit), frequentemente esclusi dall’ambito di applicazione di importanti
normative di tutela del lavoro subordinato (disciplina delle integrazioni salariali e sostegno dell’attività sindacale nei
luoghi di lavoro). La diversificazione dei lavori è divenuta inarrestabile e la tendenziale disoccupazione strutturale delle
società industriali ha indotta ad ipotizzare nuove forme di lavoro non solo dentro, ma anche fuori il mercato, nell'ambito
di organizzazioni c.d. non-profit, che, anche in ragione della crisi del sistema pubblico di welfare, la normativa
disciplina e incentiva sia sul piano lavoristico (LL. nn. 266/1991, 381/1991) sia su quello tributario, dove è emersa la
nuova categoria della organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) (D.lgs. n. 460/1997).
Significative evoluzioni si registrano poi nelle amministrazioni pubbliche. Infatti, nonostante la sottrazione al regime
pubblicistico dei rapporti di pubblico impiego, il legislatore non ha tuttavia disconosciuto la netta distinzione
concettuale tra impresa privata e pubblica amministrazione. Pertanto alcuni tratti di specialità della disciplina
rimangono, in ossequio a norma costituzionali (art. 97 Cost) o alla necessità di perseguire al meglio l’interesse pubblico
o all’esigenza di confermare il tradizionale favore per il dipendente pubblico (applicazione dell’art. 18 St lav., a
prescindere dai limiti dimensionali).
Infine, nel diritto del lavoro riveste particolare rilievo la dimensione dell’impresa. Infatti sono numerose le ipotesi in cui
il legislatore condiziona l’applicabilità di determinate normative di tutela al superamento di una determinata soglia
occupazionale (si pensi ad esempio alla normativa sul licenziamento individuale, all’attività sindacale nei luoghi di
lavoro, alle procedure sindacali in tema di trasferimento d’azienda e licenziamenti collettivi, alle assunzioni
obbligatorie, ecc,).
La crescente attenzione del legislatore per iniziative di job creation, destinate ad incidere sulla domanda di lavoro in una
logica di incentivo all'occupazione e di servizio all'impresa, è uno degli elementi sintomatici delle trasformazioni che
attraversano attualmente il diritto del lavoro e testimoniano un nuovo interesse della materia per la figura datoriale,
attualmente al centro di complesse operazioni di decentramento o esternalizzazione, da un lato, di integrazione e
concentrazione a livello societario, dall'altro. Tuttavia, i processi di composizione o scomposizione dell'impresa non
hanno finora avuto ricadute sul piano del contratto individuale: la giurisprudenza è compatta nel negare al gruppo di
imprese un'autonoma soggettività giuridica, dovendo i contratti di lavoro essere imputati a ciascuna delle distinte
società del gruppo.
6. La forma del contratto di lavoro.
La legge non prescrive per il contratto di lavoro alcuna forma e quindi vige il principio generale della libertà della
forma. Ma il D.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, attuativo della Direttiva 91/533/CE, prevede l'obbligo del datore di
informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
Molti contratti collettivi del settore privato prescrivono la forma scritta del contratto di lavoro, ma è assai dubbio che
questa sia richiesta ai fini della validità del negozio, come disposto dall’art. 1352 c.c. (“se le parti hanno convenuto per
iscritto di adottare une determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata
voluta per la validità di questo”). Tale articolo infatti presuppone che la forma convenzionale sia stata voluta
nell’interesse delle parti, mentre nelle clausole collettive in questione la forma scritta è disposta ad esclusiva garanzia
del lavoratore.
La situazione è invece diversa nel caso del mancato rispetto dell’obbligo di forma scritta del contratto individuale di
lavoro prescritto da tutti i contratti collettivi di comparto del settore pubblico. In tal caso infatti si ritiene che la forma
scritta soddisfi anche l’interesse della p.a. alla certezza dei rapporti giuridici in essere.
Eccezioni al principio della libertà della forma sono previste con riguardo ad una serie nutrita di ipotesi.
In tali casi il vincolo di forma è inteso il più delle volte ad substantiam , con conseguente nullità dello stesso ed
operatività del meccanismo di conversione automatica, qualora la legge lo preveda esplicitamente. Ad esempio, la
carenza di forma scritta della clausola oppositiva di termine determina la conversione del contratto a termine in
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Altre volte la forma è richiesta ad probationem, con il corollario che il contratto sarà comunque valido, ma in presenza
di contestazioni sulla sua esistenza, l’interessato non potrà fornire prova testimoniale, salvo che il documento sia andato
perduto senza propria colpa (art. 2725 c.c.). Ad esempio, il D.lgs 276/2003 prevede la forma scritta ad probationem per
tutte le tipologie flessibili di contratto di lavoro di nuova introduzione (il lavoro ripartito, il lavoro intermittente,
finanche il lavoro a progetto, per il quale, data l’essenzialità della predisposizione del progetto o programma, ci si
aspettava piuttosto il requisito della forma scritta ad substantiam). Devono essere altresì stipulati per iscritto i contratti
di apprendistato nonché il contratto di inserimento ai sensi dell'art. 56, il quale prevede, esplicitamente, in caso di
mancanza di forma scritta, la conversione in contratto a tempo indeterminato. Un regime di forma vincolata è infine
previsto per talune clausole speciali, quali il patto di prova, il patto di non concorrenza, le clausole flessibili e le
clausole elastiche nel part-time.
7. Consenso, vizi del consenso e simulazione.
La matrice contrattuale del rapporto mette in luce la centralità dell’elemento volitivo nella fase costitutiva del rapporto
stesso. In generale tuttavia, la definizione dei contenuti dell’accordo è solo parzialmente oggetto di un reciproco
scambio del consenso tra la parti. Normalmente infatti la proposta di lavoro proviene dal datore e risulta altresì
formulata sulla scorta delle disposizioni di legge e del contratto collettivo, derogabili solo in melius.
Nel settore pubblico poi, la compressione dell’autonomia del datore di lavoro è ancor più accentuata, essendo vincolata
finanche la scelta dell’altro contraente. Se infatti è vero che la fase costitutiva del rapporto è ormai sotto l’egida del
diritto privato, va pur detto che la fase preassuntiva sembra rimanere nel dominio del diritto pubblico, applicandosi
ancora la regola del pubblico concorso. (D.lgs. n. 165/2001).
La volontà dei contraenti è assoggettata alla generale alla generale disciplina codicistica (domina quindi l'aspetto
privatistico) in tema di consenso e vizi del medesimo. Sul piano del contratto di lavoro, può rilevare l’errore, allorché
verta sulle qualità personali del lavoratore. Tuttavia, per essere essenziale, e quindi possibile causa di annullamento del
contratto, l’errore deve riguardare qualità che abbiano diretta attinenza con la prestazione lavorativa (ad. es. qualità
tecnico-professionali).
La rilevanza dell’errore è in ogni caso subordinata alla sua riconoscibilità da parte del datore. Essenzialità e
riconoscibilità non sono però necessari in caso di dolo del lavoratore, qualora cioè questi abbia dato causa all’errore con
affermazioni false (dolo commissivo) o reticenti (dolo omissivo). Non ha mancato di venire alla ribalta anche l'ipotesi
dell'errore di diritto di cui al n. 4 dell'art. 1429 c.c., con riguardo ad es. al caso del datore di lavoro che abbia proceduto
all'assunzione senza il rispetto della graduatoria concorsuale fidando sulla clausola preferenziale della residenza
contenuta nel bando di concorso e poi dichiarata nulla.
Per quanto riguarda invece la simulazione (discrasia volontaria tra volontà effettiva delle parti e dichiarazioni negoziali)
trova anche qui applicazione la disciplina codicistica.
Dunque in caso di simulazione assoluta (le parti stipulano un contratto di lavoro subordinato quando in realtà non
vogliono dare vita a nessun rapporto), il contratto simulato non produrrà alcun effetto tra le parti, ai sensi dell'art. 1414
c.c. In caso di simulazione relativa invece (allorché le parti intendono instaurare tra di esse un rapporto diverso da
quello simulato), sarà il contratto dissimulato a produrre effetti. Quindi se le parti stipulano un contratto simulato di
lavoro autonomo, che nasconde un contratto dissimulato di lavoro subordinato, al rapporto si applicherà la disciplina
tipica del rapporto subordinato (la questione viene risolta sulla base della corretta qualificazione del rapporto).
È evidente insomma come nel caso della simulazione relativa, si possa pervenire alle stesse soluzioni generali previste
dal codice in tema di simulazione, ma utilizzando come chiave di lettura la disciplina del diritto del lavoro
(qualificazione del rapporto e tassatività del tipo lavoro subordinato).
8. La clausola di prova.
Ai sensi dell’art. 2096, il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova, finalizzato alla verifica della capacità
professionale del lavoratore in relazione alle mansioni affidate.
Il patto di prova deve risultare da una clausola apposita per la quale è previsto l’obbligo di forma scritta ad substantiam.
Oltre alla forma scritta, l’ordinamento impone la predeterminazione della durata massima del periodo di prova,
normalmente stabilita dai contratti collettivi in misura non superiore a 6 mesi. In ogni caso, la l. n. 604/1966 pone
indirettamente un limite legale alla prova, con la conseguenza che, anche a volerla prolungare, il rapporto acquisterà
comunque una stabilità, una volta trascorso il semestre. La l. n. 604/1966 prevede che il recesso datoriale per il lavoro
in prova non richieda preavviso e sussistenza di presupposti giustificativi (motivi), con conseguente discrezionalità della
valutazione del datore di lavoro. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza
obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilità per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso
non può esercitarsi prima della scadenza del termine.
A fronte ci ciò, resta però, sempre sindacabile l'uso distorto del potere imprenditoriale, a tutela del diritto del prestatore
non subire licenziamenti arbitrari; sicché il giudice potrà ben dichiarare l'invalidità del recesso ogni qualvolta il
lavoratore dimostri che allo scioglimento unilaterale del vincolo negoziale abbia concorso un motivo non attinente
all'esperimento della prova, quindi illecito. Conseguenze dell'invalidità del recesso sono o la prosecuzione
dell'esperimento fino alla scadenza del termine prefissato o il risarcimento del danno.
L'assenza di qualsivoglia requisito formale per il recesso è stata confermata altresì in rif. all'invalido assunto
obbligatoriamente, con cui i giudici ritengono validamente stipulabile un patto di prova. Oggi la questione è affrontata
dalla l. n. 68/1999, laddove consente di stipulare ai fini occupazionali convenzioni per lo svolgimento di periodi di
prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, fermo il generale divieto di prestazioni non compatibili con le
minorazioni del prestatore.
Salvo il profilo del recesso senza preavviso, la disciplina legislativa del rapporto in prova non differisce da quella del
rapporto definitivo: la giurisprudenza riconosce al lavoratore in prova il normale trattamento economico e normativo.
Per quanto riguarda la natura del patto di prova, la dottrina maggioritaria tende a qualificarlo come una condizione
sospensiva potestativa. Alla luce della disciplina finora ricostruita peraltro, sembra comunque lecito ritenere che si tratti
di un patto di libera recedibilità senza preavviso da un altrimenti normale rapporto di lavoro subordinato.
CAPITOLO TRE:PUBBLICO E PRIVATO NEI MERCARI DEL LAVORO
1. L'evoluzione della normativa: dal vincolismo alla liberalizzazione.
Quello dell’intervento (dapprima solo pubblico) sul mercato del lavoro, è un ambito in continuo cambiamento, come del
resto è in mutamento il generale contesto economico-sociale, che produce e accresce un grave squilibrio quantitativo e
qualitativo fra domanda ed offerta di lavoro. Fino agli anni ’90 il perno centrale dell’intervento pubblico sul mercato del
lavoro è stato il collocamento, inteso come sistema istituzionale-normativo predisposto per lo svolgimento dell’attività
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, in vista della collocazione o assunzione di manodopera.
Nella fase precorporativa l’attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro era svolta contemporaneamente da
agenzie private con finalità lucrativa, associazioni sindacali e strutture pubbliche. Con l’avvento del corporativismo,
viene istituito in Italia il monopolio pubblico del collocamento, con il conseguente divieto di mediazione privata, anche
se gratuita.
La fase repubblicana eleva l’intervento pubblico nel mercato del lavoro (definito attività di collocamento) al rango di
“pubblica funzione”e la L. 264/1949 (legge Fanfani) poneva i principi fondamentali in materia, basandosi su 3 pilastri
principali: a)monopolio pubblico [era ammesso solo l’intervento pubblico nel mercato del lavoro con esclusione dei
privati]; b)gestione statale e accentrata [la gestione dell’attività era svolta dagli uffici periferici del Ministero del
Lavoro, senza la partecipazione di enti territoriali minori]; c)natura vincolistica [per l’assunzione di manodopera
inoccupata o disoccupata era obbligatoria (salvo eccezioni) l’iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento, nonché
la richiesta del datore di lavoro all’ufficio competente dell’avvio di un certo numero di lavoratori iscritti nelle liste ed in
possesso di determinati requisiti professionali (c.d. chiamata numerica, senza possibilità di scelta].
La rigidità della L. 264/1949 , la moltiplicazione dei collocamenti speciali hanno condotto il legislatore a ripensare le
regole e gli strumenti di regolazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con numerose riforme, che hanno
dato vita ad una stratificazione normativa.
Il primo elemento destabilizzante del sistema tradizionale è stato la generalizzazione della regola della chiamata
nominativa (che consente al datore di lavoro la scelta, ma richiede il nulla osta preventivo degli uffici), seguita
dall’introduzione della regola della assunzione diretta (art 9bis, L. n. 608/1996), con l’eliminazione del vincolismo nelle
modalità di assunzione, determinato dal collocamento. Inoltre, la L. n. 196/1997 (c.d. Pacchetto Treu), con la
regolamentazione del lavoro temporaneo, mette in discussione un altro principio dell'ordinamento tradizionale: il
divieto di intermediazione di manodopera.
Gli altri due pilastri (monopolio pubblico e gestione statale ed accentrata) restano in piedi fino al ’97, anno di
emanazione del decreto Montecchi (D.lgs. 469/1997) con il quale due nuovi principi si sostituiscono ai pilastri
tradizionali. Quello del decentramento amministrativo di funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli altri enti locali
(applicazione del principio di sussidiarietà verticale: la sussidiarietà verticale comporta una distribuzione delle funzioni
amministrative e/o legislative dal basso, sfoltendo quelle ritenute superflue e conferendo alle amministrazioni territoriali
quelle localizzabili nel rispettivo ambito di competenza, risalendo di volta in volta al livello immediatamente superiore
per le funzioni non localizzabili); e quello della liberalizzazione controllata dell’attività di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro (in un’ottica di sussidiarietà orizzontale che riguarda i rapporti tra pubblico e privato, tra istituzioni e
società civile ed economica, con una inevitabile ridefinizione tra potere sociale e politica).
Infine la definitiva consacrazione del decentramento e del principio di sussidiarietà verticale è avvenuta con la L. Cost.
3\2001, che riforma il titolo V della Costituzione (con particolare riferimento all’art. 117 che stravolge i rapporti
Stato\regioni in tema di potestà legislativa). Se nell'originario testo costituzionale l'unica concessione fatta alle regioni,
in materia di lavoro, riguardava la formazione professionale, mentre ora le regioni sono competenti per la parte
amministrativa del diritto del lavoro (detta anche diritto del marcato di lavoro). Gli strumenti di intervento pubblico nei
mercati del lavoro (collocamento, sostegno del reddito, politiche attive e formative) verranno sempre più governati a
livello regionale. A fronte di questa inevitabile frammentazione, la garanzia di uniformità di prestazioni a livello
nazionale è prevista dalla disposizione che attribuisce allo stato la determinazione dei principi fondamentali, dei livello
essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che dovranno essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
dal potere sostitutivo del governo nei cfr. delle regioni e degli enti locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di
leale collaborazione.
Il D.lgs. n. 297/2002 e il D.lgs. n. 276/2003 ambiscono ad una riorganizzazione dei mercati del lavoro incentrata sul
ruolo dei soggetti privati ribaltando il sistema nato con la L. n. 264/1949. Ora l'intervento pubblico nella mediazione tra
domanda e offerta di lavoro (collocamento) diventa un servizio e non un'autorità senza un regime di monopolio, né
vincolistico.
2. L'intervento pubblico nei mercati del lavoro. Struttura organizzativa e funzioni.
A seguito della nuova disciplina di liberalizzazione del collocamento, la complessa struttura dell'organizzazione
amministrativa ha dovuto rinnovarsi.
Il D. lgs. 469\97 (decreto Montecchi) ha previsto il conferimento alle Regioni e alle Province delle funzioni e dei
compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, mentre un ruolo generale di indirizzo e coordinamento
è attribuito allo Stato. Una delle finalità è quella di superare la dissociazione tra le funzioni relative al collocamento,
quelle relative alla formazione professionale e quelle in tema di politiche attive del lavoro, così da accrescere
l'efficienza del mercato del lavoro. Cade così uno dei pilastri della legge Fanfani; quello della natura statale della
gestione del collocamento.
Fino ad oggi, l’intervento pubblico nei mercati si è tradotto in una duplice presenza, caratterizzata, da un lato, da un
forte ruolo di regia e coordinamento della Regione in materia di politica attiva del lavoro, volta ad incrementare
l’occupazione e ad incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; dall’altro dalla gestione ed erogazione di
servizi per l’impiego affidate alle Province, attraverso articolazioni periferiche sparse sul territorio, i così detti centri per
l'impiego. Seguendo il modello delineato dal D.lgs. 469/1997 i servizi per l'impiego regionali e provinciali si articolano
in organi tecnico-politici e organi collegiali a composizione mista (con la presenza delle parti sociali).
Ai sensi del D.lgs. n. 469/1997 allo stato restano le competenze nelle materie specificamente elencate nonché un ruolo
generale di indirizzo, promozione e coordinamento
Le competenze statali sono esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, istituito con il D.P.R. 23 marzo
2001, n. 176. Il nuovo ministero è poi articolato in strutture periferiche, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro
che svolgono compiti in precedenza realizzati dagli uffici del lavoro e dagli ispettorati del lavoro.
Una riforma organica dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale è stata realizzata con il D.lgs. n.
124/2004: ora la funzione ispettiva si articola su tre distinti livelli di direzione e coordinamento: centrale, regionale e
provinciale, con un rafforzamento delle funzioni di prevenzione e formazione.
3.L’intervento dei privati nei mercati del lavoro. Le agenzie per il lavoro.
Il decreto 469/1997 si è occupato di demolire il monopolio pubblico, regolando l'ingresso di soggetti privati
nell'esercizio delle attività di mediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro.
La gestione in monopolio del collocamento da parte dello Stato appariva uno strumento funzionale al contratto sociale
del mercato del lavoro e all'obbiettivo di giungere ad una distribuzione equa dei posti di lavoro vacanti. La ratio del
monopolio pubblico del collocamento affondava le sue radici nel principio “il lavoro non è una merce” sancito dalla
Convenzione OIL (organizzazione internazionale del lavoro) n. 2 del 1919 e nella cattiva immagine lasciata dai raggiri e
dagli abusi di intermediari e reclutatori. La convenzione OIL è frutto della consapevolezza del mutato contesto socioeconomico e del riconoscimento dell'importante ruolo che può essere svolto dalle agenzie di impiego private ai fini di
un buon funzionamento del mercato del lavoro. Un primo colpo incisivo al monopolio del collocamento fu inferto dalla
Corte di giustizia CE: secondo la corte, l’ufficio pubblico di collocamento è un’impresa che gode di una posizione
dominante, che diventa abusiva quando, non essendo in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda
esistente sul mercato del lavoro, provoca una limitazione alla prestazione del servizio. Pertanto i divieti posti dalla
legislazione italiana all’attività privata, contrastano con la normativa europea.
Accogliendo le indicazioni provenienti dalla corte di giustizia europea, il D. lgs. 469/1997 ammette anche i privati
all’esercizio della mediazione della manodopera. L’idea di fondo è quella della sussidiarietà orizzontale, intesa quale
redistribuzione delle funzioni amministrative.
Il D.lgs. 276/03 ridisegna tutta l’organizzazione e la disciplina del mercato del lavoro, in un intreccio di norme che
coinvolgono, oltre il collocamento, la somministrazione e l’appalto.
Dal 2 giugno 2004 viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito albo, articolato in 5
sezioni, in cui vengono iscritti i soggetti (pubblici e privati) autorizzati dallo stesso Ministero (oppure, laddove previsto,
dalla regione) a svolgere attività di:
-Intermediazione, ossia attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro (ossia l’attività vera e propria di
collocamento, da non confondersi con l’intermediazione di cui alla L. 1369/1960).
-Somministrazione (fornitura professionale di manodopera).
-Ricerca e selezione del personale (attività di consulenza finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza del
committente attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative).
-Supporto alla ricollocazione professionale (attività effettuata su incarico del committente, volta alla ricollocazione nel
mercato del lavoro di lavoratori).
Alle 5 sezioni dell’albo corrispondono 5 tipi di agenzie per il lavoro: a-b)agenzie di somministrazione (che poi possono
essere generalistiche o specialistiche, a seconda che possano svolgere somministrazione in relazione a tutte le attività
indicate dal D. lgs. 276 oppure solo ad alcune specifiche attività); c)agenzie di intermediazione d)agenzie di ricerca e
selezione del personale e)agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
Vengono creati anche particolari regimi di autorizzazione per lo svolgimento (solo) dell'attività di intermediazione, cioè
mediazione tra domanda e offerta a favore di università, fondazioni universitarie, comuni, camere di commercio,
associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro ecc. L'esercizio non autorizzato delle suddette attività è punito
con sanzioni penali di natura contravvenzionale (D.lgs. n. 276/2003, art. 18, 1°comma).
Al requisito dell'esclusività dell'oggetto sociale la riforma del 2003 sostituisce solo in due casi (per le agenzie di
somministrazione c.d. generaliste e per quelle di intermediazione) il requisito della prevalenza, disponendo così solo
che una attività sia l'attività predominante per l'agenzia.
Il D.lgs. n. 276/2003 riafferma il principio di gratuità per i lavoratori delle prestazioni rese dai soggetti autorizzati e lo
sorregge con sanzione penale in caso di violazione ma contemporaneamente lo rende parzialmente derogabile dalle parti
sociali: i contratti collettivi possono infatti stabilire che tale principio non trovi applicazione per specifiche categorie di
lavoratori.
4. Le modalità di assunzione e gli adempimenti successivi.
La caduta del principio vincolistico del collocamento comincia nel 1984 per poi trovare nel 2003 definitiva
sistemazione.
Il collocamento, a partire dal periodo corporativo fino agli anni ’90, era considerato come un procedimento
amministrativo di avviamento al lavoro, in cui un insieme di atti, successivi e autonomi, ma collegati tra loro,
precedevano la fase di stipulazione del contratto di lavoro, limitando la libertà contrattuale. Lo scopo della natura
vincolistica del sistema di collocamento era quello di distribuire equamente i posti di lavoro tra i disoccupati.
Protagonisti del procedimento erano: gli uffici di collocamento statali, per i quali dovevano passare le richieste di
assunzione; i datori di lavoro, che dovevano rivolgersi a tali uffici per assumere; ed i lavoratori, che avevano l’onere di
premunirsi del libretto di lavoro e richiedere agli uffici l’iscrizione nelle liste di collocamento (ordinaria o speciali) per
poter essere assunti.
La regola generale per le assunzioni (seppur con numerose eccezioni) era quella della richiesta numerica (oggi
sopravvissuta per il collocamento dei disabili), che non contemplava la scelta del lavoratore da parte del datore di
lavoro, il quale richiedeva all’ufficio solo un certo numero di lavoratori in possesso di determinati requisiti
professionali, la cui individuazione avveniva ad opera degli uffici in base alle graduatorie delle liste di collocamento.
Nel ’91 cade la regola della richiesta numerica e viene generalizzata la chiamata nominativa che consente al datore di
lavoro di richiedere agli uffici di collocamento solo il nulla osta preventivo per l’assunzione di un determinato
lavoratore, già individuato dallo stesso datore.
Con la generalizzazione dell’assunzione diretta, nel 2003, la scelta è lasciata alla più totale discrezionalità del datore di
lavoro, che può stipulare un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore senza passare per il tramite degli uffici e a
prescindere dalle graduatorie. Nel 2003 è infatti prevista l’abrogazione della gran parte delle liste di collocamento e del
libretto di lavoro. La preferenza può cadere su qualunque lavoratore, purché ciò avvenga nel rispetto delle precedenze
previste dalla legge, dalle norme antidiscriminatorie e da quelle a garanzia della riservatezza individuale.
Restano le preferenze assolute nel caso di assunzione di personale da parte di determinati datori di lavoro: a)a favore dei
lavoratori licenziati per riduzione di personale o messi in mobilità, rispetto alle loro ex-ditte che avanzino richieste entro
sei mesi dal licenziamento; b)a favore dei lavoratori che rimangano disoccupati a seguito di trasferimento d'azienda
rispetto all'acquirente, affittuario o subentrante che effettuino assunzioni entro un anno dal trasferimento o un periodo
maggiore stabilito dagli accordi collettivi (art. 47, 6° comma, L. n. 428/1990).
Con riferimento ai contratti a tempo determinato la legge affida ai contratti collettivi nazionali di lavoro l'individuazione
di un diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda da esercitarsi entro un anno dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro. Per ciò che riguarda i lavoratori a tempo parziale il D.lgs n. 276/2003 demanda la previsione di
un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno alla pattuizione individuale.
L'art. 8, D.lgs. n. 61/2000, prevede specificamente la sanzione in caso di violazione da parte del datore del diritto di
precedenza: si riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza tra
l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio a tempo pieno nei
sei mesi successivi a detto passaggio (risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, quantificato attraverso la
valutazione equitativa del giudice ai sensi dell'ex art. 1226 c.c.).
Sopravvivono poi regole particolari che limitano la discrezionalità datoriale per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni e per alcuni sopravvissuti collocamenti speciali (disabili).
Oggi restano in vigore solo la lista speciale di collocamento prevista per la gente di mare, per i lavoratori dello
spettacolo, la lista di mobilità e la lista dei disabili ai fini del collocamento obbligatorio.
Restano in vigore la chiamata nominativa, il nulla-osta preventivo per l'assunzione e l'obbligo di iscrizione nella lista
speciale di collocamento per i lavoratori italiani che si rendono disponibili a svolgere attività di lavoro all'estero in paesi
extracomunitari. E ciò per garantire un controllo generale ed omogeneo relativo alle condizioni di sicurezza del lavoro e
al trattamento economico-previdenziale applicato al lavoratore, mentre non esistono norme speciali per il collocamento
dei lavoratori per attività da svolgersi in stati membri dell'UE.
In seguito all’assunzione, sorgono in capo al datore di lavoro degli obblighi di comunicazione agli uffici e degli
obblighi di informazione al lavoratore. Tali obblighi adempiono ad una funzione generale di trasparenza nella
costituzione del rapporto di lavoro. L’attività di comunicazione agli uffici risponde anche all’esigenza degli uffici
pubblici di monitorare il mercato del lavoro ed i flussi occupazionali.
L'obbligo di comunicazione deve essere assolto entro cinque giorni dall'assunzione, ma quando il D.lgs. 297/2002 sarà a
pieno regime, la comunicazione dovrà essere contestuale all'assunzione.
I datori di lavoro (siano essi soggetti privati o pubblici) sono tenuti a dare comunicazione al centro per l’impiego
competente dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione del rapporto (se a tempo
determinato), della tipologia contrattuale e del trattamento economico. Essi devono inoltre, all’atto di assunzione,
consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola
nonché i dati essenziali del contratto di lavoro, quali l’identità delle parti, la tipologia contrattuale, la qualifica, il
trattamento economico e normativo.
In tal modo viene implicitamente imposta la forma scritta al contratto di lavoro, ma non a pena dell’invalidità del
contratto, né per la sua prova, bensì soltanto a pena di una sanzione amministrativa.
5. Il collocamento mirato dei disabili.
Il collocamento c.d. obbligatorio dei disabili, per quanto oggetto anch’esso di un’attività di riforma, resta tuttavia
fortemente caratterizzato da una disciplina fortemente vincolistica, consistente nell’obbligo imposto a certi datori di
lavoro di assumere lavoratori considerati deboli sul mercato del lavoro. Dunque la L. n. 68/1999 appare in
controtendenza rispetto alla generalizzata liberalizzazione delle assunzioni. Nonostante presenti ancora elementi di
rigidità la L. n. 68/1999 è ispirata ad una logica diversa rispetto alla l. n. 482/1968, muovendosi verso un maggiore
coordinamento tra politiche attive del lavoro, inserimento lavorativo e politiche formative. La sua ratio non è più
meramente assistenziale e consiste nella promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro, così da poter realizzare la propria personalità.
Il collocamento obbligatorio è rivolto: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al
45%; b)alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertata dall'INAIL; c)alle persone
non vedenti o sordomute; d)alle persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalide per servizio. Inoltre il
legislatore prevede l'applicazione marginale del collocamento obbligatorio anche verso soggetti che disabili non sono
ma appartengono a categorie ritenute nel passato meritevoli di tutela (es. orfani e coniugi superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio).
I datori di lavoro sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette quando raggiungono
determinate soglie dimensionali. Essi sono obbligati ad assumere: a)il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50
dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Tuttavia vi sono delle eccezioni agli obblighi sancite dalla L. n. 68/1999 e D.P.R. n. 333/2000 che per conciliare le
esigenze dei datori con la ratio della legge di protezione dei disabili ammette la compensazione territoriale, per cui i
datori di lavoro possono essere autorizzati ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori superiore
portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive
I soggetti appartenenti alle categorie protette che risultino disoccupati e aspirano ad una occupazione conforme alle loro
capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco con una graduatoria. Per ogni persona viene stilata una scheda che
indica le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura ed il grado della minorazione.
I datori di lavoro devono presentare richiesta d’assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo (ossia da
quando il rapporto tra lavoratori normodotati e disabili sia sceso sotto il limite suddetto). Le assunzioni obbligatorie
possono avvenire sia mediante richiesta inviata dai datori di lavoro obbligati all'ufficio competente sia mediante
convenzioni stipulate dagli stessi datori con l'ufficio competente.
Con una scelta anacronistica, la richiesta numerica rappresenta ancora la regola nell’ambito del collocamento
obbligatorio dei disabili, anche se la richiesta nominativa è esplicitamente ammessa in diversi casi.
Le convenzioni rappresentano uno strumento di grande flessibilità e ammorbidimento dell'obbligo poiché consentono di
concordare i tempi e le modalità delle assunzioni obbligatorie che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra i
benefici spiccano l'ampliamento della facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di tirocinio con finalità formative o
di orientamento, nonché l'assunzione con contratto di lavoro a termine. Nella vigenza della L. n. 482/1968 si era posta
la questione della compatibilità del collocamento obbligatorio con contratti di lavoro c.d. flessibili. La L. n. 68/1999
rimette in discussione le soluzioni suddette in quanto, pur contemplando la possibilità di assumere i disabili con
tipologie contrattuali diverse da quella a tempo indeterminato e pieno, lo fa all'interno delle convenzioni e quindi
ingabbiando la flessibilità in una rete di precise tutele.
La violazione della disciplina in tema di collocamento obbligatorio dei disabili è sanzionata non penalmente ma
amministrativamente. Sono inoltre previste diverse misure ulteriori volte a spingere i soggetti obbligati ad ottemperare
all’obbligo spontaneamente, pena l’esclusione da benefici (ad esempio la partecipazione ad appalti pubblici).
6. L'avviamento al lavoro degli extracomunitari.
La normativa che regola l’ingresso ed il soggiorno per motivi di lavoro degli stranieri extracomunitari è stata riordinata
e razionalizzata dalla L. 40/1998 (legge Turco-Napolitano), successivamente confluita in un Testo Unico (TU)
approvato nel 1998 e modificato successivamente dalla L. 189/2002 (legge Bossi-Fini). Anche dopo la riforma del
Titolo V, parte II della Costituzione le materie dell'immigrazione, dell'asilo politico e e della condizione giuridica dei
cittadini extracomunitari, rimangono di competenza esclusiva dello stato.
L'art. 1 del T.U. si applica agli stranieri intesi quali cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi.
Per i lavoratori comunitari infatti vige il principio della libera circolazione all’interno dei Paesi membri. Peculiare resta
la condizione giuridica dei cittadini appartenenti a otto dei dieci stati entrati formalmente nell'UE il 1 maggio 2004 a
conclusione del processo di allargamento. Mentre per i cittadini della repubblica di Cipro e della repubblica di Malta si
applica immediatamente il principio della libera circolazione, per gli altri cittadini c.d. neo-comunitari che vogliono
prestare attività di lavoro subordinato in Italia si applicano ancora per due anni (c.d. moratoria) le norme per l'ingresso
degli extracomunitari, seppur con vistose aperture.
La disciplina è incentrata sulla netta differenza di trattamento tra:
-Stranieri che intendono entrare nel nostro Paese, per i quali vengono considerate legittime le misure limitative al loro
ingresso, per motivi superiori di ordine pubblico, che si concretizzano nel controllo dei flussi d’ingresso e nella
predisposizione di quote massime in entrata;
-Stranieri che ormai regolarmente soggiornano nel nostro Paese, ai quali, una volta ottenuto il permesso di soggiorno
per motivi di lavoro si riconosce parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
Per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia e in possesso di un regolare permesso di soggiorno non si
incontrano particolari difficoltà.
Una procedura burocratica lunga e complessa si ha invece quando un datore di lavoro italiano o straniero, regolarmente
soggiornante in Italia, intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o
stagionale con uno straniero residente all'estero. La procedura amministrativa è imperniata su due discipline distinte ma
con pesanti indifferenze: l'una, di ordine pubblico relativa all'ingresso e soggiorno in Italia (rilascio del visto d'ingresso
e del permesso di soggiorno) di competenza dell'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese di origine e delle
questure una volta in Italia; l'altra, di natura lavoristica, connessa all'accesso al mercato del lavoro in cui i datori
interessati devono effettuare agli uffici competenti le richieste numeriche di lavoratori iscritti in apposite liste o
nominative di nulla osta al lavoro (art. 18, L. n. 189/2002).
Condizioni per il rilascio del nulla osta al lavoro sono: l'impegno del datore di lavoro nei cfr. dello stato italiano al
pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di appartenenza; l'esibizione agli uffici della proposta di
contratto di soggiorno; l'impegno all'applicazione al lavoratore extracomunitario di trattamenti non inferiori a quelli
previsti dai contratti collettivi applicabili; l'indicazione delle modalità di alloggio; l'impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro (art. 5bis T.U.; art. 18 L. n. 189/2002). Lo straniero che richiede il permesso
di soggiorno a rilievi fotodattiloscopici. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato solo a seguito della
stipula del contratto di soggiorno e per la durata di questo, ma non può comunque superare i tetti massimi previsti dalla
legge (art. 5 T.U.). Il contratto di soggiorno è una figura tipica di contratto di lavoro nel quale sono obbligatoriamente
presenti, a pena di nullità, la garanzia abitativa e l'obbligazione di apprestare i mezzi necessari al rimpatrio dello
straniero.
7. Le politiche attive del lavoro e le misure per combattere la disoccupazione.
L'intervento pubblico sul mercato del lavoro deve promuovere e sostenere l'occupazione mediante una politica attiva
che stimoli e incrementi la domanda di lavoro al fine di agevolare le assunzioni. Vi sono quattro grandi aree in cui si
fanno ricadere le politiche attive del lavoro: informazione e orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro,
promozione dell'occupazione e sostegno ai soggetti deboli. Il D.lgs n. 469/1997 aveva messo al centro dell'azione
pubblica decentrata l'auspicata integrazione tra servizi all'impiego, politiche attive del lavoro e politiche formative.
In concorrenza, coesistenza e collaborazione con i servizi pubblici all'impiego, anche le agenzie private per il lavoro,
possono svolgere attività di politica attiva in senso lato, con attività si supporto alla ricollocazione professionale, attività
volte all'inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, nonché mediante la stipulazione di convenzioni
con le pubbliche istituzioni.
Alcune forme di agevolazione alle assunzioni sono quelle per i lavoratori iscritti nella lista di mobilità; quelle per
l'assunzione dei giovani con contratti a contenuto formativo e altre misure di primo inserimento al lavoro. Nella
prospettiva della promozione di nuova occupazione si inseriscono anche gli incentivi alla diffusione del contratto a
termine, a orario modulato, ridotto o flessibile, nonché dei contratti di solidarietà, cioè di quei contratti collettivi
aziendali stipulati dai sindacati che realizzano forme di solidarietà fra lavoratori, tramite riduzioni d'orario, parzialmente
o totalmente a loro carico. Tali contratti sono stati introdotti dalla L. n. 863/1984 e successivamente novellati dalle LL.
n. 236/1993 e n. 608/1996. Nel contratto di solidarietà di tipo difensivo (comportante una riduzione d'orario giornaliera,
settimanale o mensile, per evitare una riduzione della manodopera occupata) lo stato interviene con la cassa
integrazione straordinaria (CIGS). Viceversa, nel contratto di solidarietà di tipo espansivo (comportante una riduzione
d'orario definita con perdita della retribuzione) lo stato interviene con agevolazioni economiche alle imprese che
assumo nuovo personale.
Tra gli strumenti di agevolazione alle assunzioni ricordiamo anche il contratto di reinserimento (art. 20, L. n. 223/1991)
con il quale il datore di lavoro può ottenere agevolazioni contributive e normative assumendo solo lavoratori che
beneficiano del trattamento speciale di disoccupazione da almeno 12 mesi, in pratica quelli del settore edile ed affini.
L'appetibilità di questo strumento è determinata dalla previsione di una consistente riduzione sulla contribuzione
previdenziale ed assistenziale.
I lavori socialmente utili (LSU) risultano disciplinati da diversi interventi normativi (da ultimo D.lgs. n. 468/1997).
Nella pratica il LSU sono serviti a tamponare emergenze occupazionali, ma senza innescare un circolo virtuoso di
espansione dell'occupazione, piuttosto determinando effetti perversi e nutrendo le aspettative di lavoratori socialmente
utili di entrare nel pubblico impiego. Sono previsti benefici economici per datori di lavoro che assumono a tempo
indeterminato lavoratori socialmente utili. Ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili viene erogato da parte
dell'Inps un assegno mensile. Il legislatore, tra gli strumenti per combattere la disoccupazione e promuovere il lavoro
regolare, prevede incentivi, anche sotto forma di sostegno diretto per promuovere le assunzioni e l'emersione del
sommerso.
A cavallo tra le politiche assistenziali (c.d. di welfare) e le politiche attive del lavoro ( c.d. di workfare) si pongono
anche i c.d. fondi strutturali per promuovere e sostenere l'occupazione. Più interessanti e ricchi si stanno rivelando i
fondi strutturali dell'UE, in particolare il Fondo Sociale Europeo. Esistono poi i fondi c.d. bilaterali, di natura sindacale,
che, con la vigilanza del Ministero del Lavoro, promuovono interventi e misure di carattere previdenziale, o formativo,
nel quadro delle politiche stabilite nel contratto collettivo.
8. L'informazione sul mercato del lavoro, l'orientamento e la formazione professionale.
Nei primi anno '80 si è giunti alla consapevolezza che una politica attiva del lavoro debba dedicare grande cura sia ad
una informazione tempestiva e significativa sulla struttura e dinamica della domanda e dell'offerta, sia all'orientamento
e alla formazione professionale dell'offerta medesima. Per quanto riguarda l'informazione vi sono una serie di strutture
pubbliche che controllano e monitorano i flussi di lavoratori in entrata e in uscita dai mercati del lavoro e cercano di
studiarne caratteristiche e tendenze (es. Istat, Cnel, Ministero del lavoro ecc.).
Nell'ottica della realizzazione di un sistema di strumenti diretti a garantire la trasparenza nel mercato e una migliore
circolazione delle informazioni, dapprima il D.lgs. n. 469/1997 e successivamente il D.lgs. n. 276/2003 si occupano di
istituire una rete informatica (network). Ideato nel 1997 e battezzato come “Sistema Informativo Lavoro” (SIL), si
rinnova nel 2003, cambiando nome e struttura. Nasce così la “Borsa continua nazionale del lavoro”, sistema basato su
una rete di nodi regionali facilmente consultabile sia dai lavoratori che dalle imprese. Severi limiti all'acquisizione, al
trattamento e alla divulgazione dei dati personali sono predisposti per la tutela della riservatezza dei lavoratori e per
evitare il perpetrarsi di trattamenti discriminatori. La conduzione della Borsa del Lavoro resta ben salda nelle mani dello
stato, mentre la sua gestione viene in gran parte demandata alle regioni.
Al fine di agevolare l'inserimento al lavoro e l'incontro tra domanda ed offerta, il SIL e la Borsa del Lavoro, hanno dato
vita ad una banca dati informatizzata dei lavoratori in cerca di impiego, chiamata “elenco anagrafico” e una “scheda
professionale”, che vanno a sostituire rispettivamente le liste di collocamento e il libretto di lavoro ormai abrogati. Lo
scopo è sia quello di favorire l'assunzione e l'accesso, sia quello di controllare e monitorare le professionalità con una
costante vigilanza dello stato sull'andamento dei mercati regionali del lavoro.
L'orientamento professionale è un'attività volta ad informare ed indirizzare il soggetto verso una collocazione
professionale che tenga conto delle sue aspirazioni, delle sue competenze e delle richieste del mercato, con la conferma
del rafforzamento della competenza regionale. Quanto alla formazione professionale essa costituisce il momento di
raccordo tra l'istruzione e il lavoro, tra il diritto allo studio e il diritto al lavoro, tra il significato culturale e l'aspetto
produttivistico dell'istruzione.
Se la formulazione originaria dell'art. 117 della Costituzione affidava alle regioni la materia della formazione
professionale nell'ambito delle norme quadro poste dalla legislazione statale (competenza legislativa di tipo attuativo), il
novellato art. 117 Cost. (L. cost. n. 3/2001) affida ora alle regioni potestà legislativa primaria in materia di formazione
professionale. I servizi pubblici all'impiego, relativamente all'orientamento e alla formazione, dovranno convivere e
concorrere con le agenzie private per il lavoro, le quali dovranno operare nel quadro delle disposizioni regionali previste
in materia ed ottenere l'apposito accreditamento.
La somministrazione di lavoro
1. Dal divieto di interposizione di manodopera all'ammissibilità della somministrazione di lavoro.
Per più di quarant'anni il diritto del mercato del lavoro dell'Italia repubblicana è stato regolato da due leggi, la L. n.
264/1949 e la L. n. 1369/1960.
Inquadriamo innanzitutto il fenomeno di interposizione di manodopera. Si tratta di un’antica prassi, volta a liberare i
datori di lavoro dalla propria responsabilità giuridica ed economica nei confronti dei lavoratori, scaricandola su altri
soggetti (intermediari o interposti) così da potersi assicurare manodopera in maniera meno costosa e più flessibile.
Questo fenomeno (merchandage du travail) è definita nel linguaggio del legislatore del 1960 come interposizione. Si
possono individuare dunque due rapporti giuridici; quello tra l’interposto ed i lavoratori da questo assunti; e quello tra il
committente e l’interposto, il quale da in affitto la propria manodopera al committente. La cattiva immagine lasciata
nella storia dai raggiri e dagli abusi di intermediari e reclutatori hanno spinto il legislatore italiano per via della
compressione della tutela dei lavoratori e per la mercificazione della loro essenza a porre un divieto di interposizione.
La legge n. 1369/1960 vietava la realizzazione di una fattispecie complessa, a schema triangolare (triangolazione), in
cui un committente si rivolge ad un altro soggetto (detto interposto), per richiedere la fornitura di un certo numero di
lavoratori (assunti e retribuiti dallo stesso interposto). L'interposto detto anche caporale si rivela un fantoccio che, privo
di garanzie di solidità econimico-finanziaria, lucra sull'attività interpositoria anche facendo pagare un prezzo ai
lavoratori. La fattispecie vietata era quindi quella della fornitura di manodopera. La sanzione civile stabiliva che,
eliminato lo schema dell'interposto, i lavoratori fossero considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dirette di chi ne
avesse effettivamente utilizzato le prestazioni, tutelando gli interessi individuali, personali e patrimoniali del lavoratore
coinvolto nella fattispecie intepositoria. Con la sanzione penale (contravvenzione) si garantiva l'interesse pubblico
all'inderogabilità delle norme protettive poste a tutela del lavoratore subordinato.
La L. n. 1369/1960 è volta a contenere e regolarizzare il fenomeno del decentramento e del precariato. Decentrare vuol
dire scorporare o commissionare a terzi, pezzi del processo produttivo necessario per produrre il bene o servizio proprio
dell'attività di una certa impresa: sia che questo avvenga verso l'esterno (con ricorso ad altra azienda o a lavoro a
domicilio), sia che questo abbia luogo all'interno (con l'utilizzo di di un'altra azienda la quale porta dentro la prima il
proprio personale). L'intervento attuato dalla suddetta legge da un lato mira a impedire il decentramento fittizio
(sgravando la titolarità del rapporto lavorativo per ridurre costi e responsabilità), dall'altro, disincentivare lo stesso
decentramento genuino, rendendo più onerosa la scelta di procedere ad appalti d'opera e di servizi pienamente legittimi.
Tuttavia le istanze di flessibilizzazione e decentramento, fattesi sempre più pressanti a partire dagli anni '80 (per via
dello cambiamento del quadro socio-economico e del modello fisiologico di decentramento dato dall'emergere di una
piccola e media impresa che valorizza la combinazione fra elevate professionalità e tecnologie leggere) hanno portato
ad una rivisitazione dei fenomeni di interposizione di manodopera.
Tale ripensamento ha portato con la L. 196/1997 (Pacchetto Treu) che prevede un'importante deroga al generale divieto
di interposizione previsto dalla L. 1369/1960. La L. 196/1997 introduce così nel nostro ordinamento la fattispecie del
lavoro temporaneo tramite agenzia, o lavoro interinale. Si tratta di un istituto intermedio fra servizi all'impiego,
avviamento e selezione del personale, tipologia flessibile del rapporto di lavoro, alternativa al contratto a termine. Lo
schema della fattispecie è ricalcato su quello dell’interposizione di manodopera vietata dalla L. 1369/1960; solo che nei
limiti e alle condizioni previste dalla L. n. 196/1996 l'interposizione è autorizzata: si tratta dunque di una fornitura lecita
di manodopera. I soggetti sono sempre 3: agenzia fornitrice, utilizzatore e lavoratore e i contratti disciplinati sono 2;
uno di fornitura, stipulato tra utilizzatore e agenzia ed uno di lavoro subordinato, stipulato dall’agenzia con il lavoratore.
Il D. lgs. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi)poi si è spinto ancora oltre, rivisitando completamente la materia ed
introducendo la fattispecie della somministrazione di lavoro. Il decreto stabilisce l’abrogazione della L.n. 1369/1960 e
della parte della L. n. 196/1997 nella quale viene introdotto il lavoro interinale. Nonostante l’abrogazione della
disciplina sul divieto generale di interposizione di manodopera e sul lavoro interinale, tuttavia, molte di quelle
disposizioni sono rifluite nel decreto 276, creando quindi non poche affinità tra il previgente sistema e quello attuale.
La rimozione di tutele, tuttavia, è attuata con una tecnica di c.d. flessibilità normata, visto che sia la L. n. 196/1997 sia il
D.lgs. n. 276/2003 richiedono la sussistenza di una serie di requisiti per la valida stipulazione dei contratti di lavoro e di
fornitura/somministrazione e sanzionano le eventuali inottemperanze. L'apertura dell'Italia verso una forma trasparente
di “lavoro in affitto” (prima lavoro temporaneo e poi somministrazione di lavoro) deriva dalla presa di coscienza di un
mutamento socio-economico nonché dai buoni risultati ottenuti dall'applicazione di questo nei paesi che l'avevano da
tempo adottato. Tuttavia questa “concessione” è ammessa solo quando vi sia una tutela per i lavoratori e un sistema
sanzionatorio per i trasgressori. Se è innegabile la continuità tra la disciplina del lavoro temporaneo e quella della
somministrazione di lavoro perché entrambe ricorrono allo schema triangola e poiché entrambe costituiscono una
deroga legislativa, le differenze tra i due modelli non mancano: la deroga della somministrazione di lavoro è infatti più
ampia rispetto a quella del lavoro temporaneo.
2. Fenomeni interpositori e fattispecie a confine
Lo schema della somministrazione coinvolge, come tutti i fenomeni interpositori, 3 parti (triangolazione):
-l’utilizzatore, che richiede all’agenzia di somministrazione la fornitura di mere prestazioni di lavoro e usufruisce
effettivamente dell’opera dei lavoratori;
-l’agenzia di somministrazione, che assume i lavoratori e li mette a disposizione dell’utilizzatore, che potrà usufruirne
secondo le proprie esigenze;
-il lavoratore, assunto e retribuito dall’agenzia di somministrazione per prestare il proprio lavoro a favore
dell’utilizzatore.
Sin dall’entrata in vigore della L. 1369/1960, si era posto il problema dell’inquadramento giuridico del fenomeno
interpositorio, così da poterlo distinguere dal contratto di appalto, ed in particolare dall’appalto di servizi,
esplicitamente disciplinato dal Codice civile (art. 1655) e quindi sicuramente lecito.
Se la somministrazione è un'obbligazione di dare, cioè fornire lavoro subordinato altrui, l’appalto è il contratto col quale
una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o
di un servizio verso un corrispettivo in denaro (obbligazione di fare).
Di fronte agli appalti di servizi non implicanti l'impiego di un'organizzazione complessa (c.d. a bassa intensità
organizzativa) e con la prevalenza di apporto del fattore lavoro piuttosto che di capitale (ad alta intensità di lavoro) la
giurisprudenza operava il distinguo accertando chi organizzasse il fattore lavoro, quindi chi esercitasse i poteri tipici del
datore di lavoro, verso i dipendenti.
Il processo di smaterializzazione dell'impresa ha portato al progressivo ridimensionamento di quegli elementi
(attrezzature, impianti, macchine) che erano ritenuti caratterizzanti l'impresa.
Sulla base della lettura dell’art. 1655 c.c. è dunque possibile identificare facilmente le peculiarità del contratto di
appalto e le differenze rispetto alla somministrazione.
Mentre la somministrazione può essere semplicisticamente definita come un “affitto di lavoro”, che si concreta in
un’obbligazione di “dare” (prestare il lavoro subordinato dei propri dipendenti all’utilizzatore), l’appalto configura
un’obbligazione di “fare”, cioè di realizzare un’opera o un servizio e quindi di fornire un autonomo risultato produttivo.
Ed in relazione a questo risultato (all’opus) l’appaltatore assume su di se il rischio d’impresa, cosa che non si verifica
nella somministrazione. Il rischio d’impresa rappresenta dunque il primo profilo differenziale tra appalto e
somministrazione. Un altro elemento peculiare dell’appalto, che lo differisce dalla somministrazione sta nel fatto che
l’appalto presuppone una certa autonomia organizzativa e gestionale dell’appaltatore (il quale si qualifica a tutti gli
effetti come un imprenditore). L’appaltatore infatti opera “con organizzazione dei mezzi necessari”. Tale autonomia
organizzativa e gestionale è invece esclusa nel caso della somministrazione, nell’ambito della quale la proprietà delle
macchine, delle attrezzature e dei capitali è dell’utilizzatore. L’organizzazione dei mezzi è dunque un secondo profilo
differenziale tra appalto e somministrazione.
Il contratto di appalto si realizza dunque quando l’appaltante chiede all’appaltatore il compimento di un’opera o di un
servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, e non l’utilizzo di mere prestazioni
lavorative.
Di fronte agli appalti di servizi che non implicano l’impiego di un’organizzazione complessa e con prevalenza del
fattore “lavoro” su quello “capitale” (c.d. ad alta intensità di lavoro), è possibile individuare un altro indice che consente
di qualificare tale ipotesi come appalto e non come somministrazione: accertare a chi spetti l’organizzazione del “fattore
lavoro”, ossia accertare a chi spetti l’esercizio dei poteri datoriali (direttivi, di controllo e disciplinari). Infatti mentre
nell’appalto l’esercizio di tali poteri spetta al appaltatore, nella somministrazione essi spettano all’utilizzatore.
L’esercizio dei poteri direttivi è quindi il terzo profilo di differenziazione dell’appalto dalla somministrazione.
Questi 3 elementi discriminanti (assunzione del rischio, organizzazione dei mezzi e esercizio dei poteri direttivi sulla
forza lavoro) tra le fattispecie di appalto e somministrazione sono state confermati dal D. lgs. 276/2003. L’appalto
ritenuto non genuino, ossia privo di tali 3 requisiti è punito con la stessa sanzione penale (contravvenzione) prevista per
la somministrazione non autorizzata (e dunque illecita). Inoltre, analogamente a quanto accade in caso di
somministrazione illecita, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze
del committente che ne ha utilizzato effettivamente la prestazione.
Un altro strumento di uso flessibile della forza lavoro che rientra nello schema della triangolazione, ma che è stato
considerato generalmente lecito, è quello del distacco. Il distacco prevede un cambio nell’esercizio dei poteri datoriali,
comportando che il dipendente di un datore venga dislocato presso un altro datore, con contestuale assoggettamento al
comando e al controllo di quest’ultimo. Il distacco (anch’esso disciplinato dal D. lgs. 276\2003) non è altro che
un’ipotesi di fornitura lecita di manodopera esercitata non professionalmente ( il requisito della professionalità invece
caratterizza la somministrazione). Il distacco è quindi quella somministrazione posta in essere da un datore di lavoro
qualunque (non un’agenzia a tal uopo autorizzata). Anche il distacco, allorché illecito, è corredato dalla stessa sanzione
civile che accompagna la somministrazione illecita e l’appalto non genuino; l’imputazione del rapporto in capo
all’effettivo utilizzatore.
3. La somministrazione di lavoro del D.lgs. n. 276/2003
La riforma del 2003 (D.lgs. n. 276/2003 abrogante la L.n. 1369/1960) stabilisce che il fenomeno interpositorio continua
ad essere vietato, salvo la deroga ammessa dal legislatore.
È pertanto lecita la somministrazione se la triangolazione avviene nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina
della somministrazione di lavoro di cui gli artt. 20 e 21 del D.lgs. 276/2003, pena l’imputazione del rapporto di lavoro
in capo all’utilizzatore.
Lo schema è il solito: un soggetto, imprenditore o non imprenditore, denominato utilizzatore, si rivolge ad un’agenzia di
somministrazione per ottenere una fornitura di manodopera. I lavoratori oggetto della fornitura sono assunti e retribuiti
dall’agenzia ma svolgono la loro attività lavorativa per l’utilizzatore.
Quella rappresentata dalla somministrazione di lavoro è una deroga più ampia rispetto a quella della fornitura di lavoro
temporaneo (L. n. 196/1997). infatti a differenza della L. n. 196/1997, la fornitura di manodopera (D.lgs. n. 276/2003)
può avvenire sia per mezzo di un contratto di somministrazione a tempo determinato, sia a tempo indeterminato. La
tecnica usata dal legislatore è quella della casistica tassativa per la somministrazione a tempo indeterminato e quella
delle ragioni giustificative (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo) per la somministrazione
a termine, così da limitare sia il controllo giudiziale, sia di ribadire la caduta del requisito della temporaneità previsto
invece per il lavoro temporaneo (L. n. 196/1997).
Allo scopo di garantire la trasparenza del mercato del lavoro, per il contratto di somministrazione sono previsti precisi
requisiti di forma (l'atto scritto ad substantiam) e di contenuto. Tutte le informazioni inerenti il contratto di
somministrazione devono essere fornite dall'agenzia al lavoratore all'atto della stipulazione del contratto e l'utilizzatore
ha l'obbligo di comunicare ai sindacati il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione in occasione di ciascuna
fornitura e a consuntivo ogni dodici mesi. La somministrazione di lavoro è espressamente vietata: 1)per la sostituzione
di lavoratori in sciopero; 2)per le unità produttive e le mansioni interessate, nei 6 mesi precedenti, da licenziamenti
collettivi o da integrazioni salariali; 3)da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Secondo il classico schema della triangolazione, accanto al contratto di somministrazione tra agenzia autorizzata e
utilizzatore troviamo il contratto di lavoro subordinato tra agenzia e lavoratore, privo di un necessario collegamento
negoziale col contratto di somministrazione. Il contratto di lavoro subordinato tra agenzia e lavoratore può essere
stipulato a tempo pieno, parziale, determinato o indeterminato, con diritto del lavoratore, per i periodi di non lavoro in
cui resta in attesa di assegnazione, ad una “indennità di disponibilità”.
Il rapporto tra lavoratore e utilizzatore non assume autonoma e diretta veste contrattuale, pur risultando regolato dalla
legge. I lavoratori infatti risultano alle dirette dipendenze dell’agenzia, titolare del contratto di lavoro, anche se al
contempo essi svolgono la propria attività lavorativa nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.
Sull’agenzia, in quanto datore di lavoro, gravano gli obblighi retributivi e contributivi, previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, con la previsione di una obbligazione solidale sussidiaria dell'utilizzatore, il quale comunque è
contrattualmente tenuto a rimborsare all'agenzia i costi da questa sostenuti per i lavoratori.
Per quanto riguarda l’esercizio dei poteri datoriali, si assiste ad una scissione tra il potere direttivo e di controllo, che
spetta all’utilizzatore ed il potere disciplinare, che resta in capo all’agenzia.
L'art. 23, 1° comma, ribadisce la regola della parità di trattamento riconoscendo che il lavoratore somministrato ha
diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. L'agenzia di somministrazione deve provvedere ad addestrare i lavoratori e
informarli sui rischi generali per la loro sicurezza e salute, mentre un tale obbligo è posto in capo all'utilizzatore per i
rischi specifici, cioè quelli relativi alle mansioni a cui verranno adibiti. Gravano sull'utilizzatore nei cfr. dei lavoratori
somministrati tutti gli obblighi di sicurezza e protezione individuati dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
La disciplina della somministrazione di lavoro (D.lgs. n. 276/2003) costituisce una deroga più ampia rispetto
all'interposizione vietata di quanto non lo fosse il lavoro temporaneo (L. n. 196/1997). In definitiva si riscontra una
maggiore libertà dell'utilizzatore di scegliere se avvalersi dei lavoratori somministrati da un'agenzia autorizzata o se
procedere direttamente ad assunzioni.
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) è ritenuto una della novità più importanti
della c.d. Riforma Biagi poiché detta fattispecie nel pacchetto Treu non era esplicitamente prevista e dai più era ritenuta
vietata. La necessità del requisito della temporaneità prevista dalla L. n. 196/1997 veniva ravvisata nella ratio che
questo contratto di lavoro flessibile fungesse da traghetto verso un lavoro stabile alle dipendenze dell'utilizzatore. Un
altra differenza tra il modello di fornitura di manodopera ammessa nel 1997 e quello del 2003 è data dal fatto che le
sanzioni che presidiano i confini della somministrazione illecita riguardano solo il contratto di somministrazione
stipulato tra l'agenzia e l'utilizzatore, mentre non vengono riproposte le sanzioni previste nella L. n. 196/1997 per il caso
di violazioni concernenti il contratto di lavoro stipulato tra l'agenzia e il lavoratore.
Inoltre, nel passaggio tra il lavoro temporaneo e la somministrazione vi è un indebolimento delle tutele per i lavoratori
somministrati rispetto a quelle assicurate ai lavoratori temporanei. In primis, il D.lgs. n. 276 non ripropone il limite
posto dalla L. n. 196/1997 al gradimento dell'utilizzatore e consistente nel diritto del lavoratore a prestare la propria
opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione anche se sgradito all'utilizzatore. In secundis, il D.lgs. n. 276 pur
riproponendo l'obbligo di applicare ai lavoratori somministrati un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello dei dipendenti dell'utilizzatore di pari livello e a parità di mansioni aggiunge l'avverbio “complessivamente”, non
previsto nella L. n. 196/1997. La nuova disposizione ha l'effetto di poter considerare adempiuto l'obbligo di parità di
trattamento anche se singoli aspetti del rapporto non vengono disciplinati in modo uniforme tra lavoratori somministrati
e dipendenti dell'utilizzatore e rimette il giudizio di ottemperanza all'obbligo di legge alla difficile valutazione (del
giudice) se il trattamento riservato nel suo globale (complessivamente) al lavoratore somministrato sia non inferiore a
quello riservato nel suo globale al dipendente dell'utilizzatore. In più, viene prevista una espressa deroga alla parità di
trattamento per i lavoratori c.d. svantaggiati. Altra diminuzione di tutela per i lavoratori somministrati si deduce
dall'esclusione della disciplina dei licenziamenti collettivi: il recesso dell'agenzia non viene qualificato quindi dal
legislatore come licenziamento collettivo ma come licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo,
con l'esonero per il somministratore dal contratto effettuato sul licenziamento sia in sede sindacale sia in sede
amministrativa in occasione dell'esame congiunto previsto dall'art. 4 della L. n. 223/1991 e dai costi della suddetta
procedura.
Il D.lgs. n. 276/2003 rende economicamente più conveniente il contratto di appalto rispetto alla somministrazione di
lavoro. Il D.lgs. n. 276/2003 prevede la solidarietà tra agenzia di somministrazione e utilizzatore e la parità di
trattamento tra i dipendenti dell'agenzia e quelli dell'utilizzatore solo per la somministrazione, mentre per tutte le ipotesi
di appalto si limita a disporre la solidarietà tra committente e appaltatore di far valere entro un anno dalla cessazione
dell'appalto medesimo.
Sotto altro profilo sono invece evidenti le convenienze della somministrazione. Per l'agenzia riguardano l'esenzione
dalle procedure di licenziamento collettivo. Per l'utilizzatore tali convenienze consistono nella concreta possibilità nei
gruppi di impresa di creare una società-figlia dedicata specificamente alla somministrazione di personale per l'intero
gruppo e nella possibilità di usare la somministrazione come una lunga prova nei confronti del lavoratore finalizzata ad
una eventuale successiva assunzione.
Gli ammortizzatori sociali e la tutela nel ricollocamento.
1. Gli ammortizzatori sociali.
Un altro profilo dell’intervento pubblico sul mercato è costituito dal come orientare, formare, collocare, rendere mobile
l'offerta, nonché dal come sostenere il reddito della manodopera inoccupata, disoccupata e occupata, ma sospesa dal
lavoro e dalla retribuzione. Il legislatore parla in tal senso di ammortizzatori sociali, riferendosi a tutta una serie di
strumenti di sostegno del reddito profondamente diversi tra loro, ma caratterizzati da uno scopo unico: attutire
(ammortizzare) gli effetti negativi che determinate vicende hanno sul reddito dei soggetti.
Si tratta di un universo variegato di istituti in cui, oltre al trattamento di disoccupazione, di cassa integrazione (ordinaria
e straordinaria) e di mobilità (che sono forme di sostegno del reddito che intervengono in caso di vicende interruttive e
sospensive del rapporto di lavoro), vengono fatti rientrare anche i lavori socialmente utili, i contratti di solidarietà e più
in generale tutte le prestazioni spettanti ai cittadini in quanto tali nelle situazioni di bisogno .
Si tratta di una materia che ricopre un ruolo di snodo fra politiche dell'occupazione e politiche assistenziali (di welfare).
In estrema sintesi, l’evoluzione normativa di questa materia si è caratterizzata per aver prestato: A) quasi nessuna
attenzione ad una qualsiasi garanzia di reddito per la manodopera inoccupata, cioè priva di una precedente esperienza
lavorativa (giovani); B) scarsa attenzione ad una sufficiente garanzia di reddito per la manodopera disoccupata, cioè con
alle spalle un’esperienza lavorativa; C) grande attenzione ad una congrua garanzia di reddito e di lavoro per la
manodopera occupata (in aziende di certi settori e con certe dimensioni) che, come tale, vanta una maggiore aspettativa
rispetto alla continuità della retribuzione goduta (e anche una ben maggiore forza all’interno dell’organizzazione
sindacale).
Proprio l’iniqua distribuzione delle tutele è oggi al centro del dibattito che ha portato ad una prospettiva innovativa non
più solo assistenziale (di welfare), ma di workfare, capace di proteggere dalle vecchie e nuove forme di insicurezza dei
lavoratori sul mercato, senza produrre effetti disincentivanti sull'offerta di lavoro. La riforma del sistema ancora ferma
in Parlamento (D.d.l. S/848 bis), vorrebbe realizzare un circolo virtuoso tra sostegno al reddito, orientamento e
formazione professionale, reinserimento al lavoro, al fine di eliminare le discriminazioni, con l'auspicio che accanto agli
ammortizzatori sociali operi anche un sistema di assicurazioni private.
2. Il sistema della mobilità.
Nella L. n. 223/1991 la mobilità è concepita da posto a mercato e il lavoratore in mobilità non un lavoratore con
un'occupazione fittizia, bensì un lavoratore disoccupato che gode di una particolare tutela economica e preferenziale nel
ricollocamento.
La strumentazione predisposta per reinserire questi lavoratori disoccupati nell'attività produttiva ruota attorno alla lista
di mobilità (art. 6, L. n. 223/1991). L’iscrizione in tale lista conferisce una peculiare posizione giuridica di vantaggio sul
mercato del lavoro, e in certi casi anche il diritto all’indennità di mobilità.
Secondo la disciplina originaria (risultante dalla L. 223/1991) nella lista di mobilità possono essere iscritti con diritto
all’indennità: a)i lavoratori (operai, impiegati e quadri) licenziati collettivamente da imprese che rientrano nel campo di
applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (ossia con + di 15 dipendenti); b)i lavoratori licenziati
nell'edilizia in casi particolari; c)in via transitoria, a peculiari categorie di lavoratori.
L'iscrizione nella lista è disposta d'ufficio dall'organo competente senza necessità di apposita domanda del lavoratore.
L’emergenza occupazionale successiva alla legge del ’91 ha spinto per un ampliamento dell’ambito di applicazione
delle liste di mobilità. Sono dunque stati ammessi alla procedura di mobilità anche i lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività da parte di datori di lavoro esclusi dal
campo d’applicazione della Cigs (cioè imprenditori con meno di 16 dipendenti). Tali soggetti cui è stata estesa
l’applicazione del sistema della mobilità tuttavia non maturano il diritto alla relativa indennità. Essi godono solo dei
benefici di natura occupazionale, ai fini di una più agevole ricollocazione lavorativa.
Al fine di promuovere la ricollocazione in attività di lavoro subordinato, sono concessi incentivi sia al lavoratore che al
datore di lavoro.
Per il lavoratore è prevista: a)un’indennità di nuova sistemazione se accetta un’occupazione che comporti il
cambiamento di residenza; b)la possibilità di ottenere un assegno integrativo mensile nel caso accetti un impiego
comportante una retribuzione inferiore alla precedente; c)la possibilità di accettare occasioni di lavoro a tempo
determinato o parziale senza perdere l’iscrizione nelle liste di mobilità e con facoltà di cumulare l’indennità di mobilità
con la retribuzione, nei limiti del reddito (rivalutato) cui aveva diritto al momento del licenziamento; d)la precedenza,
entro 6 mesi dal licenziamento, nella riassunzione da parte della stessa impresa che lo ha licenziato.
Per il datore opera un duplice meccanismo vincolistico e promozionale. Il profilo vincolistico è attuato tramite le
precedenze, mentre per quanto riguarda il profilo promozionale, sono previsti degli incentivi economici (sotto forma di
sgravi contributivi) per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità.
La cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità, con conseguente decadenza dai trattamenti economici, (art 9, L.
n. 223/1991) può avvenire per cause fisiologiche (legate all’esaurimento della funzione protettiva) o per cause
patologiche, configurandosi come sanzione per certi comportamenti scorretti del lavoratore :il lavoratore infatti è tenuto
a collaborare attivamente in funzione del suo ricollocamento. La legge prevede in alcuni casi la possibilità di riscrizione
del lavoratore cancellato per motivi fisiologici.
3. (Segue): L'indennità di mobilità.
L’indennità di mobilità (oltre al vantaggio nel ricollocamento, include anche il sostegno economico), istituita dalla L.
223/1991, è fondamentalmente un trattamento di disoccupazione particolare, riservato ai lavoratori licenziati
collettivamente in determinati settori produttivi e da imprese di determinate dimensioni.
La domanda va presentata da parte del lavoratore entro 68 gg. dalla cessazione del rapporto (a pena di decadenza).
L’indennità è erogata dall’INPS, ma concorrono anche le imprese rientranti nel campo di applicazione della Cigs (cassa
integrazione guadagni straordinaria).
Tale indennità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione, nonché l'indennità di malattia.
L’indennità di mobilità spetta a operai, impiegati e quadri (non ai dirigenti) in caso di disoccupazione derivante da: a)
licenziamento durante o alla fine della Cigs; b)procedure concorsuali; c)licenziamento per riduzione del personale senza
essere passati dalla Cigs.
Il godimento dell’indennità di mobilità dunque non è sempre preceduto dal godimento di un periodo di Cigs.
Per evitare la simulazione di rapporti di lavoro subordinato al solo fine di godere dell’indennità di mobilità, si richiede
che gli operai, impiegati o quadri collocati in mobilità debbano possedere un’anzianità aziendale minima di 12 mesi
(requisito soggettivo), di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato in un rapporto di lavoro a carattere continuativo
e comunque non a termine.
Il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità può andare da 12 a 48 mesi ed è differenziato in relazione all’età del
lavoratore e alla collocazione geografica (48 mesi nel mezzogiorno). L’indennità comunque non può essere corrisposta
per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa. L’importo dell’indennità nei
primi 12 mesi è pari al trattamento Cigs; poi si riduce all’80% del trattamento Cigs. Il lavoratore può richiedere la
liquidazione anticipata dell'indennità per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa.
4. Lo stato di disoccupazione.
Per capire quando la disoccupazione è effettivamente involontaria e definire chi sono i disoccupati nei cui confronti lo
stato deve promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata, viene
emanato il D.lgs. n. 181/2000, successivamente modificato dal D.lgs. n. 297/2002.
Lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo
svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa. I disoccupati di lunga durata sono coloro che, con o senza precedenti
lavorativi, siano alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.
5.L’indennità ordinaria di disoccupazione
Nei confronti dei disoccupati involontari la riforma promette un sostegni generalizzato ed omogeneo con un'indennità di
disoccupazione ordinaria. L’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita e finanziata
esclusivamente con i contributi posti a carico dei datori di lavoro, rappresenta lo strumento di tutela delle necessità
economiche del lavoratore causate dalla mancanza di lavoro nel mercato.
L’evento protetto è la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro. Dunque ha titolo per ricevere tale
trattamento chi risulti essere privo di lavoro per ragioni a lui non imputabili, ma derivanti da oggettive condizioni di
mercato; pertanto non godono dell’indennità i non occupati, ossia coloro che devono appena cominciare a lavorare.
Sono altresì esclusi i soggetti che godono di un regime di stabilità tale da far ritenere il licenziamento come un evento
eccezionale ed alcune categorie di soggetti specificamente nominate (apprendisti, personale artistico, sacerdoti ecc.)
In pratica il sorgere di un rapporto di lavoro subordinato fa sorgere anche il rapporto previdenziale avente ad oggetto
l’erogazione del trattamento economico sostitutivo del reddito perduto a seguito della involontaria inattività (quindi non
per dimissioni).
L’indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi, al lavoratore subordinato
disoccupato, sempre che sia stato impiegato in passato fino a maturare un certo periodo contributivo (per i lavoratori
ultracinquantenni la durata è di 9 mesi).
La domanda va presentata all’INPS entro 68 gg. dalla cessazione del rapporto con allegata una certificazione da cui
risulti la disoccupazione e la propria immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa.
Oggi l'indennità di disoccupazione con requisiti normali è pari al 40% dell'ultima retribuzione percepita prima della
cessazione del lavoro. Il governo, anche a seguito dell'intesa del 5 luglio 2002 raggiunta con CISL e UIL (c.d. Patto per
l'Italia) ha modificato in parte il D.d.l. n. 848bis/2003, ma senza sciogliere il nodo cruciale: quello delle risorse. Si
continua infatti a parlare di riforma “senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato”, riproponendo così
un'impostazione diversa dall'accordo raggiunto con le parti sociali
Il nuovo sostegno al reddito secondo il D.l. suddetto, dovrebbe durare per un periodo continuativo massimo di 12 mesi,
con un meccanismo a scalare che assicuri al lavoratore, per i primi 6 mesi, ben il 60% della retribuzione, per poi
scendere gradualmente, nei due trimestri successivi al 40% e al 30%. In cambio, i lavoratori hanno l'obbligo, fra l'altro,
di partecipare a programmi formativi, pena la perdita del sussidio.
CAPITOLO QUATTRO: IL DECENTRAMENTO PRODUTTIVO.
1. Il distacco.
Decentrare vuol dire scorporare o comunque commissionare a terzi pezzi del processo produttivo necessario per
produrre il bene o servizio proprio dell'attività di una certa impresa.
Dopo aver analizzato la triangolazione, passiamo a considerare un altro fenomeno interpositorio lecito, il distacco
consistente nell’invio di un dipendente di un datore di lavoro (distaccante) presso un diverso datore (distaccatario), con
il permanere della titolarità del rapporto e dell’obbligo retributivo e contributivo in capo al primo, anche se il lavoratore
distaccato viene assoggettato al potere direttivo, di controllo ed eventualmente disciplinare del secondo. Si tratta dunque
di un’ipotesi di somministrazione di lavoro, che, seppur posta in essere non da un’agenzia autorizzata, costituisce
comunque uno strumento lecito di decentramento produttivo
Regolamentato dal legislatore proprio nell'ambito del pubblico impiego fin dal 1957 (D.P.R. n. 3 artt. 56 e 57) e
ammesso dalla prassi giurisprudenziale nell'impiego privato fin dagli anni '70, oggi trova disciplina generale nell'art. 30
del D.lgs. n. 276/2003. Quest'ultimo considera il distacco come ipotesi legittima di somministrazione di lavoro posta in
essere da un soggetto che non esercita professionalmente attività di fornitura di lavoro altrui.
Lo schema è sempre quello della triangolazione, in quanto anche col distacco si realizza quella temporanea
dissociazione tra datore formale e utilizzatore della prestazione di lavoro. Un datore di lavoro distaccante, per
soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente un proprio lavoratore (o più di uno) a disposizione di altro
soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa pur rimanendo direttamente responsabile
del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
Il D.lgs n. 276/2003 ha introdotto nuovi elementi, consentendo, da un lato di ammettere il distacco anche da parte di
datori non imprenditori purché dotati di un'autonoma struttura organizzativa; dall'altro, all'oggetto della prestazione del
lavoratore distaccato che deve essere determinata.
Elemento di continuità con il passato è l'interesse proprio del datore distaccante che la norma richiede per configurare
legittimo il distacco. A metà tra continuità e innovazione si pone il requisito della temporaneità del distacco, cioè non
definitività, che pare acquistare maggiore autonomia rispetto all'elaborazione giurisprudenziale precedente la quale ne
aveva svalutato la portata o considerandolo compreso nello stesso interesse del distaccante o dandone un'interpretazione
decisamente estensiva.
Alcuni elementi della definizione di distacco data dal legislatore, consentono di distinguere il distacco da una semplice
ipotesi di somministrazione non autorizzata (e quindi illecita): a)l’interesse proprio dal datore distaccante – se il
distacco perseguisse l’interesse dell’impresa del distaccatario, troveremmo dinanzi ad una somministrazione non
autorizzata; b)determinatezza dell’attività oggetto della prestazione del lavoratore distaccato – il lavoratore deve essere
distaccato per una specifica attività, non riducibile alla generica messa a disposizione di manodopera; c)temporaneità
del distacco – la durata del distacco può essere anche lunga, ma non può coincidere con tutta la durata del rapporto di
lavoro. In assenza di questi requisiti, il distacco configura un’ipotesi illecita di decentramento produttivo ed è punito
con la stessa sanzione civile che accompagna la somministrazione illecita (ossia la possibilità per il lavoratore di
ottenere, tramite apposita domanda, l’imputazione del rapporto in capo all’effettivo utilizzatore).
A tutela del lavoratore distaccato sono poi previste 2 regole corrispondenti a due limiti imposti al potere del distaccante:
-Il distacco che comporti un mutamento di mansioni del lavoratore distaccato, richiede il consenso dello stesso;
-Il distacco che comporti un trasferimento del lavoratore ad un’unità produttiva distante più di 50 km da quella in cui il
lavoratore è adibito, deve essere giustificato da ragioni tecniche, organizzative o produttive.
La L. n. 236/1993 attribuisce agli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, la facoltà di regolare il
comando o distacco di uno o più lavoratori da un'impresa all'altra e tutto ciò per evitare il licenziamento.
Infine un cenno ad un fenomeno in crescente diffusione, soprattutto nell'ambito di gruppi di imprese multinazionali: il
distacco del lavoratore all'estero. Al fine di regolamentare il fenomeno del distacco di lavoratori da uno stato estero è
stato emanato il D.lgs. n. 72/2000.
2. Il rapporto di lavoro nei gruppi di impresa e in imprese collegate.
Un fenomeno strettamente connesso al comando o distacco è rappresentato dal collegamento fra più imprese, società di
persone o di capitali. Si parla in questo caso di “gruppo di imprese” o di “imprese di gruppo”. Nel nostro ordinamento
non esiste una nozione giuridica unitaria di gruppo.
In linea di massima si ritiene che il mero collegamento economico-societario tra più società non integri ai fini lavoristici
un unico datore di lavoro, salvo che non emerga con molta chiarezza la presenza di un unico centro decisionale per la
gestione del personale e dei rapporti sindacali. La Corte di Cassazione ritiene che le varie società collegate debbano
essere considerate unitariamente quando vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del
frazionamento di una attività tra le varie entità societarie. Ciò che viene accertato allorquando si riscontri: a)unicità
della struttura organizzativa e produttiva; b)integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il
correlativo interesse comune; c)coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico
soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune, d)utilizzazione
contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese.
In tale scenario si innestano alcune disposizioni legislative che danno rilievo al rapporto di collegamento esistente tra
imprese o al fine di ampliare l'ambito dei destinatari di determinate tutele e prevenire le frodi o con l'obbiettivo di
consentire l'accentramento in capo alla società capogruppo degli adempimenti burocratici “in materia di lavoro,
previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti”.
3. Il trasferimento d'azienda (o di ramo d'azienda).
La disciplina del trasferimento d’azienda (o di un suo ramo) ad un terzo mira a garantire, di massima, la prosecuzione
del rapporto di lavoro presso l’acquirente con una forma di garanzia dei diritti dei lavoratori rafforzata, coinvolgendo sia
il cedente che il cessionario dell'azienda nelle posizioni debitorie nei confronti dei lavoratori.
I ripetuti interventi del legislatore comunitario e nazionale, sono ispirati dalla volontà di rafforzare le tutele dei
lavoratori e ampliarne la portata applicativa perché il trasferimento d’azienda rappresenta uno strumento sempre più
utilizzato per realizzare il decentramento produttivo (outsourcing), o per esternalizzare attività non appartenenti al
nucleo essenziale (core business) del ciclo produttivo ed affidarle a terzi, fenomeni che possono sfociare in
licenziamenti collettivi o possono determinare riflessi sulle condizioni di vita e lavoro dei lavoratori.
La normativa base del trasferimento d'azienda è ancora oggi racchiusa nell'art. 2112 c.c. e nell'art. 47 L. 428/1990
(attuazione della direttiva n. 77/187/CE) sui quali ha inciso in maniera sensibile il D.lgs. n. 18/2001 (di attuazione alla
Direttiva n. 98/50/CE) e l'art. 32 del D.lgs. n. 276/2003.
Il principio base delle suddette direttive è quello del mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
d’azienda e di conservazione del posto, che si realizza garantendo il passaggio dei lavoratori al nuovo titolare
dell’azienda o del suo ramo. La ratio è quella di garantire una sostanziale indifferenza dei rapporti di lavoro rispetto alle
vicende circolatorie dell’azienda, cioè rispetto a vicende attinenti alla proprietà o alla titolarità dell'azienda.
Si tratta di trovare un punto d’equilibrio tra la libertà di iniziativa economica privata e la tutela dei lavoratori coinvolti
nei processi di trasferimento dell’azienda.
Si è parlato di crisi di identità dell'art. 2112 c.c., poiché detto articolo, nato per garantire il mantenimento dei diritti dei
lavoratori e la continuità dell'occupazione, oggi viene sovente utilizzato per ridimensionare o dismettere da parte
dell'imprenditore settori di attività e quindi i dipendenti a questi addetti senza sottostare alla procedura e agli oneri
previsti per i licenziamenti collettivi e a prescindere dal consenso dei lavoratori ceduti.
Il fenomeno dell'esternalizzazione (outsourching) si accompagna spesso a quello della internalizzazione (insourcing).
Ciò accade quando l'acquirente del segmento aziendale esternalizzato si impegna con il cedente- mediante un contratto
di appalto- a fornirgli beni o servizi realizzati mediante il segmento ceduto.
Nel tentativo di accompagnare e disciplinare il decentramento produttivo nel suo duplice aspetto il legislatore del 2003
aggiunge un 6° comma all'art 2112, con il quale dispone, per il caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, che appaltante e
appaltatore siano obbligati in solido verso i lavoratori dipendenti dell'appaltatore entro il limite di un anno dalla
cessazione dell'appalto.
Il ripetuto intervento innovatore del 2001 e del 2003, nell'incidere sull'art 2112 c.c., ha dato vita all'ampliamento del
concetto di trasferimento d'azienda, sotto l'influenza della Corte di Giustizia CE. Per trasferimento d’azienda si intende
“qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità dell’azienda (o di un ramo della stessa), a prescindere
dallo schema negoziale utilizzato”. Quindi, qualunque sia lo strumento negoziale utilizzato per realizzare il
trasferimento (cessione, usufrutto, affitto, leasing), è consentito all’imprenditore cedente di trasferire automaticamente i
dipendenti addetti all’entità trasferita.
Per quanto riguarda l’oggetto del trasferimento, il concetto d’azienda viene ampliato e oggi per azienda si intende
“un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva la propria
identità”. Tale definizione consente di allentare ogni aggancio con la nozione di azienda dell’art. 2555 c.c., nel quale la
nozione di azienda appare imperniata sul complesso di beni organizzati dall’imprenditore (con tutto il carico di
materialità da questi evocato) e sposta l’accento sull’attività e sull’organizzazione.
Il nuovo dato normativo induce a ritenere sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'art 2112 c.c., anche la traslazione di
un'attività realizzata solo mediante l'impiego di un insieme di lavoratori all'uopo organizzati, senza il supporto di un
apparato strumentale, a condizione che non si tratti di una mera sommatoria di prestazioni lavorative e che l'attività
traslata si caratterizzi per un'amalgama organizzativo. Una simile lettura smaterializzata dell'azienda consente di
estendere l'art. 2112 c.c., anche al trasferimento di attività caratterizzate da elevato “contenuto umano”.
Resta aperta la dibattuta questione concernente l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e dell'art 47 L. n. 428/1990, ai datori di
lavoro non imprenditori. Di fronte all'attuale formulazione del 5° comma dell'art. 2112 c.c., come novellato dal D.lgs. n.
276/2003, che definisce l'azienda “come un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro” dopo aver
eliminato la specificazione prevista dal D.lgs. n. 18/2001 “al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”, ha
portato certa dottrina ad includere nel campo di applicazione della norma anche il caso in cui il cessionario sia un
soggetto non imprenditore.
Una nozione legale di ramo d'azienda, ribattezzato “parte dell'azienda”, è stata introdotta dal D.lgs. n. 18/2001 e
modificata dal D.lgs. n. 276/2003 (art 32). Essa consiste in “un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento”.
Il D,lgs. n. 18/2001 richiedeva come requisiti per l'identificazione della “parte dell'azienda” la sua preesistenza rispetto
al trasferimento e la conservazione della propria identità nel trasferimento.
Con le modifiche apportate con il D.lgs 276/2003 il legislatore ha inteso rispondere alle accuse di inutile rigidità rivolte
alla definizione di parte dell'azienda sorte nella vigenza del D.lgs. n. 18/2001 ed ha stabilito che per l'applicazione
dell'art. 2112 c.c. è sufficiente che la porzione di attività ceduta sia dotata di autonomia funzionale, cioè di coesione
funzionale e organizzativa, che può sorgere anche solo al momento del trasferimento. La definizione di ramo o parte
d'azienda viene quindi resa meno rigida, con l'eliminazione dei requisiti previgenti (preesistenza rispetto al
trasferimento e la conservazione della propria identità nel trasferimento).
Se in concreto ricorrono gli elementi identificativi dell’azienda o del ramo, il passaggio del lavoratori addetti (ma non
necessariamente tutti) sarà governato dall’automatismo e dalle garanzie previste dall’art. 2112 c.c., senza il consenso
dei lavoratori. In caso contrario (ad es, trasferimento di una porzione di attività non idonea alla produzione di beni o
servizi o di un segmento aziendale privo di autonomia funzionale) si rientrerà nell’ipotesi di cessione di singoli beni e di
singoli contratti di lavoro (art. 1406 c.c.), che richiede il consenso del contraente ceduto, sicché il passaggio dei
lavoratori al nuovo titolare resterà subordinato al loro consenso, ma non opereranno in loro favore le garanzie previste
dall’art. 2112 c.c.
Il novellato art. 2112 c.c. revede la conservazione di tutti i diritti già maturati presso il cedente (conservazione
dell’anzianità di servizio maturata, scatti, tfr, ecc.). Il rapporto in sostanza prosegue immutato in tutti i suoi aspetti e si
considera unitariamente, senza alcuna interruzione dovuta alla modificazione dei soggetti (cedente e cessionario).
È inoltre prevista una responsabilità solidale tra cedente e cessionario in ordine ai crediti maturati dal lavoratore nel
corso del rapporto col primo. È comunque consentito che il lavoratore possa liberare dalla responsabilità solidale uno
dei due coobbligati ma, trattandosi di ipotesi di cosiddetta volontà individuale assistita, ciò dovrà avvenire secondo
modalità precise: nei confronti del cedente alla commissione di conciliazione prevista dai contratti collettivi o istituita
presso ciascuna Direzione Provinciale del lavoro o in sede sindacale, nei confronti del cessionario (solitamente il più
interessato ad ottenere la liberazione) ai sensi dell'art. 2113 c.c.
L’art. 2112 c.c, novellato dal D.lgs. n. 18/2001, garantisce ai lavoratori ceduti l’applicazione dei contratti collettivi che
disciplinavano il rapporto di lavoro prima del trasferimento, conferendo a tali contratti collettivi una sorta di ultrattività
(in deroga alle disposizioni civilistiche sull’efficacia del contratto), visto che la pattuizione collettiva continuerà a
produrre effetti (fino alla scadenza) nei confronti di un soggetto, il cessionario, che non è parte dell’accordo.
Tuttavia se il cessionario applica uno specifico contratto collettivo, tale disciplina prevale e sostituisce quella del
contratto collettivo in precedenza applicato dal cedente. Ma ciò solo nel caso in cui i 2 contratti siano dello stesso
livello. Ciò per evitare i potenziali effetti pregiudizievoli che una indiscriminata sostituzione di contratti collettivi con
contratti aziendali potrebbe cagionare ai lavoratori.
Per agevolare il rilevamento ed il salvataggio di aziende in crisi (crisi aziendale o dichiarazione di fallimento con
accertamento del Ministero del Lavoro) oggetto di procedure concorsuali, il legislatore ha stabilito una deroga alle
garanzie in favore dei lavoratori, fin qui descritte. In tali casi, se viene raggiunto un accordo sindacale circa il
mantenimento, anche parziale, dell’occupazione da parte del cessionario, le garanzie di conservazione di tutti i diritti, di
mantenimento dei trattamenti collettivi pregressi, nonché l’obbligazione solidale tra cedente e cessionario, possono
essere azzerate o graduate dal medesimo accordo sindacale.
Sempre l’art. 2112 stabilisce altresì che in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con il
concessionario e che il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento (ciò all’evidente scopo
di evitare che il trasferimento d’azienda vanga usato come espediente per procedere a licenziamenti senza osservare la
disciplina prevista dal legislatore). Ciò significa che l'imprenditore cedente può licenziare i propri dipendenti solo se
ricorre un'autonoma giusta causa o un giustificato motivo. Il lavoratore non ha diritto a rimanere alle dipendenze del
cedente, quindi, se non accetta il trasferimento, non gli resta che rassegnare le dimissioni, naturalmente con preavviso.
Tuttavia, nel caso in cui le condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica per effetto del trasferimento, il
lavoratore ha la facoltà di dimettersi entro 3 mesi dal trasferimento con gli effetti propri del “recesso per giusta causa”
(art. 2119 c.c.), ossia senza dover dare preavviso e ricevendo l’indennità sostitutiva del preavviso.
L'art. 47 della L. n. 428/1990 prevede nel caso il trasferimento coinvolga un’azienda (o un suo ramo) con meno di 15
dipendenti una speciale procedura di consultazione sindacale.
Almeno 25 gg. prima che sia perfezionato l’atto di trasferimento, cedente e cessionario hanno l’obbligo di comunicare il
trasferimento ai sindacati (RSU o RSA, e sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato
nell’impresa interessata). I sindacati, ricevuta la comunicazione, possono richiedere che si apra un confronto con
cedente e cessionario, ed in tal caso, questi ultimi saranno obbligati ad aprire un esame congiunto a tal uopo. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 10 gg. dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
Il mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario degli obblighi di informazione e di esame congiunto
costituisce condotta antisindacale, ai sensi dell’art. 28 St. lav. La violazione tuttavia non inciderà sulla validità del
negozio traslativo.
Per i lavoratori che non passano alle dipendenze del cessionario è comunque previsto un diritto di precedenza nelle
assunzioni che quest'ultimo effettuati entro un anno dalla data del trasferimento o entro il maggior periodo stabilito
negli accordi collettivi (art. 47, 6°comma, L. n. 428/1990).
CAPITOLO CINQUE: LA PRESTAZIONE DI LAVORO: MANSIONI, QUALIFICHE E CATEGORIE.
1. L'obbligazione di lavoro.
Il rapporto di lavoro è un rapporto complesso, risultante da 2 contrapposte obbligazioni fondamentali (di lavoro e di
retribuzione) e da una serie di altri obblighi e doveri reciproci fra loro connessi e correlati alle obbligazioni principali.
La prestazione di lavoro è oggetto dell'obbligazione principale del lavoratore. L’obbligazione di lavorare è
un’obbligazione di comportamento (o di attività) che impone al lavoratore soltanto di tenere un certo comportamento, e
non di raggiungere un risultato specifico.
Gli elementi che concorrono a determinare la prestazione di lavoro sono diversi; il tipo di attività, la durata (intesa come
orario di lavoro e più in generale tempo di lavoro) e il luogo di esecuzione della prestazione.
Per indicare il tipo di attività che costituisce oggetto dell’obbligazione di lavoro si fa riferimento alle mansioni del
lavoratore (art. 2103 c.c.). In relazione alle mansioni si stabiliscono qualifica e categoria.
L'oggetto della prestazione di lavoro è dunque determinato solo in modo generico, con riferimento cioè alla serie di
compiti e quindi alle mansioni per le quali è stato assunto. La specificazione dei compiti di volta in volta richiesti al
lavoratore rientra nel potere direttivo del datore di lavoro, che lo esercita tramite i suoi collaboratori appartenenti alla
c.d. linea gerarchica (capi di vario livello). Le mansioni sono dunque l’insieme dei compiti e delle concrete e specifiche
attività che il lavoratore è chiamato ad eseguire e che sono esigibili dal datore di lavoro. Esse individuano l’oggetto
specifico dell’obbligazione lavorativa.
Una simile determinazione relativamente gerarchica corrisponde alle esigenze mutevoli dell'organizzazione del lavoro.
L'individuazione di compiti troppo stretti quali contenuto dell'obbligazione ostacolerebbe un impiego flessibile del
lavoratore. L'assunzione con compiti troppo indefiniti, a parte l'ipotesi (di scuola) di nullità del contratto per
indeterminatezza dell'oggetto (art. 1346 c.c.), contraddirebbe il principio della divisione del lavoro, essenziale alla
moderna organizzazione produttiva. Con l'avvento del modello post-fordista si è assistito ad un allargamento delle
mansioni, che tendono a divenire polivalenti.
I gruppi di mansioni risultanti dalle classificazioni delle posizioni di lavoro individuano le qualifiche. La qualifica
dunque individua un raggruppamento di mansioni che in genere individua una figura professionale.
La qualifica designa lo status professionale del lavoratore (identificato in base alle mansioni assegnate) e concorre con
le mansioni a determinare la sua posizione nella struttura organizzativa dell’impresa, e quindi il suo trattamento
economico e normativo.
Benché sia la qualifica che la mansione concorrano entrambe a determinare l’oggetto della prestazione dovuta dal
lavoratore e la sua posizione giuridica, esse si distinguono, in quanto la qualifica indica l’oggetto generico
dell’obbligazione lavorativa inerente allo status professionale del lavoratore, mentre le mansioni individuano l’oggetto
specifico dell’obbligo, i concreti compiti che il lavoratore esegue in base alle direttive del datore.
Le qualifiche sono a loro volta raggruppate in entità classificatorie più ampie: le categorie. Il codice civile (art. 2095)
individua 4 categorie; operaio, impiegato, quadro e dirigente (il quadro è stato aggiunto nel 1985).
Il codice (art. 2095) rinvia all’autonomia collettiva l’esatta determinazione dei requisiti di appartenenza a ciascuna
categoria. I contratti collettivi di categoria, infatti, contengono le c.d. declaratorie, vale a dire formulano per ciascuna
categoria i criteri di appartenenza sulla base delle mansioni svolte che variano peraltro in funzione del livello di
appartenenza (per quanto riguarda i “livelli di appartenenza”, si tratta di diversi livelli di professionalità che la
contrattazione collettiva identifica all’interno delle varie categorie o, qualifiche legali, come vengono altresì definite le
categorie in ambito contrattuale).
È il caso poi di precisare che la terminologia contrattuale tradizionale inverte quella legislativa. La contrattazione
collettiva parla di “qualifica” per indicare le categorie legali (operaio, impiegato, quadro e dirigente) e di “categorie”,
“livelli” o “profili professionali” per indicare le classificazioni interne (operaio di 1° o 2° categoria o livello).
2. Le categorie dei lavoratori: impiegati e operai.
La distinzione fra operai e impiegati ha fondamento legislativo nella storica legge sull’impiego privato (R.D.L. n. 1825
del 1924). Questa legge è la prima disciplina organica del rapporto di lavoro di origine statuale, influenzata dalla
precedente normativa degli usi e dai principi della giurisprudenza dei probiviri.
I criteri distintivi delle 2 categorie sono indicati nell'art. 1 della L. del 1924 ove si definisce l'impiegato come colui che
svolge attività professionale, con funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di ordine, eccettuata ogni prestazione
che sia solamente di manodopera. I criteri della “professionalità” e della “non manualità” della prestazione
dell’impiegato sono apparsi subito scarsamente rigorosi. Si è dato così rilievo al criterio della “collaborazione
impiegatizia”, cioè alla particolare funzione degli impiegati di collaborare ad attività organizzative proprie
dell’imprenditore, e quindi di agire in sua sostituzione. Formula, questa, che è consolidata anche nella codificazione del
1942.
Il superamento della distinzione fra operai e impiegati si è avviato (ad opera della contrattazione collettiva) prima nei
settori ad alta percentuale impiegatizia, dove l'operazione era più facile, poi nell'industria a partire dalla tornata
contrattuale del 1973. L'unificazione dei metodi di classificazione e di valutazione retributiva del lavoro si è realizzata
con il c.d. “inquadramento unico”, anche se non sono eliminate le differenze residue (ad es. le diverse discipline
contrattuali del periodo di prova, di preavviso, nonché alcune diversità della disciplina legale in tema di previdenza e
sicurezza sociale). La giurisprudenza ha evitato di forzare il superamento di tali residue differenze, respingendo le
posizioni critiche che ne sostenevano la sopravvenuta illegittimità. Comunque, la diminuzione delle differenze, a partire
dagli anni '90, ha attenuato l'interesse sia della giurisprudenza che della dottrina per la tradizionale questione della
distinzione fra operai e impiegati.
2.1. Dirigenti.
Per quanto riguarda la disciplina legale, la specialità della disciplina è di tipo “negativo”. Infatti molte disposizioni che
prevedono tutele e garanzie a favore dei lavoratori non si applicano ai dirigenti (in relazione al licenziamento, alla
durata della giornata lavorativa, alla durata massima settimanale, ecc.).
Sotto il profilo contrattuale invece, la disciplina si caratterizza in senso prettamente “positivo”. La maggiore forza
negoziale dei dirigenti (sia a livello individuale che collettivo) fa si che essi riescano ad ottenere un trattamento
economico notevolmente vantaggioso rispetto alle altre categorie di lavoratori.
Se la specialità della disciplina è netta, non può dirsi altrettanto dei criteri distintivi della categoria tra dirigenti e quadri.
In mancanza di definizioni legali (l'art 2095 c.c. rinvia alla contrattazione) l'identificazione di tali criteri è stata operata
dalla giurisprudenza, ricorrendo alle indicazioni contrattuali. La definizione tradizionale della giurisprudenza è che il
dirigente costituisce l'alter ego dell'imprenditore, preposto alla direzione dell'intera impresa o a un ramo importante ed
autonomo di questa e provvisto per questa ragione di piena autonomia.
A partire dagli anni '80 la giurisprudenza ha dovuto prendere atto dell'evoluzione che ha progressivamente allargato la
figura fino a comprendervi lavoratori del tutto privi di poteri direzionali e di autonomia.
Il riconoscimento della qualifica dirigenziale attraverso la contrattazione rende applicabile la disciplina contrattuale, ma
non basta di per sé a rendere applicabile a tali figure la disciplina legale speciale. I giudici hanno cercato di tenere
separata la qualificazione di dirigente ai fini legali da quella a fini contrattuali con il riconoscimento della c.d. “qualifica
convenzionale di dirigente”. Ma il tentativo non ha fermato la tendenza espansiva della categoria. In realtà
l'identificazione del dirigente, non può basarsi su criteri astratti e generali (come quello di alter ego), ma deve risultare
da un'analisi delle funzioni.
La tendenza verso l'espansione della categoria ha indotto parte della dottrina a porre in discussione la sua stessa
unitarietà. Nonostante l'unitarietà della figura continui ad essere riaffermata dall'opinione prevalente, la giurisprudenza
più recente sembra porsi su tale scia: avvalla una nozione restrittiva di dirigente apicale (top manager) coincidente con
quella di alter ego del datore di lavoro vuoi per escluderlo dalla soggezione del potere disciplinare, vuoi per sottrarlo
alla disciplina limitativa del licenziamento. Detto orientamento alimenta una tendenza ad allontanare il dirigente apicale
dalle tutele delle altre categorie e, nel contempo, a ricondurre il dirigente minore nell'alveo del c.d. “pseudo-dirigente” o
dirigente meramente convenzionale, con conseguente applicazione delle tutele lavoristiche.
2.2. I quadri.
La L. n. 190/1985 nel modificare l'art. 2095 c.c., definisce i quadri come quei lavoratori che, pur non appartenendo alla
categoria dirigenziale, svolgono continuativamente funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa. Ancora una volta il legislatore affida alla contrattazione collettiva il compito
di stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria.
La portata di questa norma è incerta: dubbie sono soprattutto le conseguenze della sua inosservanza in ordine
all'identificazione della categoria. Gli aspetti di disciplina speciale individuati dalla L. n. 190 sono alquanto limitati e
non sono neppure necessariamente collegati alla posizione di quadro, ma estendibili a tutti i prestatori che siano
meritevoli di pari considerazione per le mansioni svolte. Per gli altri aspetti non espressamente regolamentati, ai quadri
si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati, salvo diversa espressa disposizione della contrattazione
collettiva (art. 2, 3°comma, L. n. 190/1985).
La difficoltà di delimitare la figura dei quadri, verso l’alto rispetto ai dirigenti e verso il basso rispetto agli impiegati con
funzioni direttive, è confermata dall'esperienza contrattuale successiva alla L. n. 190/1985; in generale avvalora la
scarsa aderenza all'attuale realtà organizzativa del lavoro di classificazioni come quelle dell'art 2095 c.c., imperniate su
categorie rigide.
L’orientamento dei sindacati confederali, in sede di contrattazione collettiva nazionale, mostra una tendenza al
contenimento della categoria. Tendenza che pare confermata dalla Corte Costituzionale, la quale ha rilevato che la
categoria rientra pur sempre nell’ambito impiegatizio, sia pure inteso latu sensu, cosicché al riconoscimento sul piano
legislativo della nuova categoria professionale non è seguito un vero e proprio “riconoscimento” sul piano sindacale.
3. Le mansioni e la qualifica.
L'individuazione delle mansioni del lavoratore (e quindi la sua qualifica e categoria) si determina secondo le regole
generali in materia di rapporti contrattuali. È questo il principio di contrattualità delle mansioni, desumibile dall’art.
2103 c.c. , il quale esplica che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto”.
L’individuazione delle mansioni e della qualifica del lavoratore avviene di norma secondo la tipologia definita dalla
contrattazione collettiva. Ed è influenzata in modo decisivo dalla situazione sottostante al rapporto: posizione
professionale del lavoratore, condizioni organizzative dell'azienda e del mercato del lavoro. In in mancanza di una
precisa indicazione contrattuale delle mansioni, il punto di riferimento per stabilire la qualifica saranno le mansioni
effettivamente svolte in modo stabile dal lavoratore.
L’identificazione in concreto della qualifica diventa così oggetto di frequenti controversie. Dato che i criteri di
classificazione e di gerarchia delle qualifiche sono fissati nella contrattazione collettiva senza indicazioni legislative, i
parametri cui riferirsi dovranno desumersi dalla stessa contrattazione. È questa la pratica giurisprudenziale prevalente,
secondo le direttive seguite in materia di retribuzione sufficiente in applicazione dell'art. 36 Cost.
L'unica definizione legislativa specifica è quella della categoria di impiegato (R.D.L. n. 1825/1924), che peraltro è
sempre stata alquanto indeterminata ed è sempre più labile ed incerta. Non maggiore pregnanza ha la definizione dei
quadri contenuta nella L. n. 190/1985.
Ad ogni modo, base della valutazione sono le mansioni oggettive dedotte nel rapporto e non le caratteristiche
professionali del lavoratore. La c.d. “qualifica soggettiva” del lavoratore, intesa come somma di capacità personali
professionali, è di per sé é priva di rilevanza giuridica nel nostro ordinamento.
Niente vieta allora che un lavoratore provvisto di una certa qualificazione professionale sia assunto in mansioni e
qualifiche diverse, anche inferiori. Ma anche il titolo di studio costituisce elemento decisivo per l'attribuzione di una
certa qualifica o condizione essenziale per acquisirla. Nulla vieta altresì che le mansioni di assunzione siano polivalenti
o promiscue, con una maggiore flessibilità del lavoro e minore ripetitività dei compiti. Nel caso di mansioni promiscue
(a cavallo fra qualifiche diverse), l'inquadramento può presentare problemi. La giurisprudenza ritiene in tal caso di far
riferimento alle mansioni di fatto prevalenti. Al fine di individuarle, il criterio quantitativo va combinato con quello
qualitativo in un'ottica di flessibilità e di maggiore attenzione alle caratteristiche concrete dell'organizzazione aziendale
del lavoro.
La rilevanza qualificatoria delle qualifiche è diversa da quella delle categorie. Mansioni e qualifica individuano
l'oggetto della prestazione dovuta dal lavoratore mentre la qualifica costituisce la posizione giuridica fondamentale del
lavoratore da cui deriva una serie di doveri/diritti inerenti al rapporto di lavoro. Le categorie (operai, impiegati, quadri,
dirigenti) si determinano sulla base delle mansioni e qualifiche ad individuazione di alcuni aspetti del trattamento c.d.
“normativo del lavoratore” sia esso stabilito su base legislativa o su base contrattuale.
4. La disciplina contrattuale delle qualifiche: l'inquadramento unico.
Le qualifiche insieme alle categorie costituiscono un oggetto centrale della contrattazione collettiva dalle sue origini e
rappresentano i termini di un “patto storico” fra imprese e lavoratori sui criteri di valutazione del lavoro.
Fino agli anni '60 si è assistito ad una sostanziale staticità dell'organizzazione del lavoro e della stessa contrattazione.
Nel corso degli anni '60, la contrattazione aziendale sperimentò nuovi sistemi di classificazione basati su tecniche di
valutazione delle posizioni del lavoro; la c.d. “job evaluation”. Ma tali esperimenti non si generalizzarono per la
debolezza della contrattazione e per la diffidenza dei sindacati.
Un cambiamento del sistema si realizzò alla fine degli anni '60 con l'adozione del c.d. inquadramento unico. Le novità
introdotte dal nuovo sistema sono, in primo luogo il superamento parziale della distinzione tra operai e impiegati
(divenuta obsoleta e non più rispondente agli assetti produttivi) attraverso l’adozione di una scala di classificazione
unica, ordinata per livelli professionali e in secondo luogo la riduzione del numero di livelli per gruppi omogenei di
mansioni in cui si raggruppano le mansioni ai fini retributivi, in modo tale da ridurre la differenziazione salariale.
In definitiva il sistema di inquadramento unico ha mantenuto il significato prevalente di raggiungimento classificatorio,
di riduzione di differenziali salariali e di perequazione normativa fra operai e impiegati. Tuttavia l'influsso della scala
mobile ha provocato un crescente appiattimento salariale che nei primi anni '80 ha contribuito in modo decisivo a
mettere in crisi l'intero sistema classificatorio.
Una innovazione netta è stata introdotta dai primi anni '90 in quei contratti di categoria che hanno riformato il sistema
classificatorio. In particolare il contratto dei chimici ha sostituito i tradizionali livelli di inquadramento con nuove aree
(o categorie) professionali.
La gran parte dei contratti di categoria si limita a prevedere apposite Commissioni paritetiche nazionali per la revisione
delle classificazioni provviste di compiti non solo applicativi ma anche innovativi, di modifica e aggiustamento dei
profili professionali a seconda delle indicazioni provenienti dalla realtà aziendale. Tali innovazioni riflettono la
consapevolezza che negli attuali contesti produttivi, caratterizzati da grande mutevolezza tecnologica/organizzativa, una
valutazione corretta del lavoro può difficilmente raggiungersi con declatorie statiche, ma solo adottando procedure
flessibili di adattamento continuo delle classificazioni alla realtà produttiva realizzabili a livello decentrato.
Questa evoluzione contrattuale incide anche sul sindacato giudiziale e sui diritti del singolo lavoratore
all'inquadramento. Il contratto giudiziale è ammesso per verificare la congruenza fra le mansioni concrete del singolo e
la relativa classificazione, non invece sulle regole classificatorie come tali che rientrano nella insindacabile competenza
dell'autonomia collettiva. Nel sistema di amministrazione flessibile delle qualifiche, il controllo del giudice può essere
impraticabile nel modo tradizionale per la mancanza di riferimento a regole classificatorie generali.
5. Lo jus variandi: dal codice civile all'art. 13 St.lav.
L’oggetto dell’obbligazione di lavoro è solo relativamente determinato in riferimento alle mansioni di assunzione. Le
specificazioni del comportamento concretamente dovuto dal lavoratore spettano al datore di lavoro,attraverso l'esercizio
del proprio potere direttivo.
Inoltre al datore è riconosciuto il potere di modificare le mansioni del lavoratore oltre l’ambito convenuto. Un simile
potere unilaterale, denominato jus variandi, non trova riscontro in altri rapporti obbligatori di durata, dove le modifiche
del contenuto obbligatorio sono ammissibili solo per mutuo consenso. Tale potere si giustifica in relazione alle esigenze
flessibili dell’organizzazione del lavoro, che spesso richiedono modifiche non prevedibili o non fronteggiabili (per la
loro eccezionalità) e che il datore deve poter fronteggiare con tempestività.
La prima disciplina organica dello jus variandi fu stabilita nell'art. 2103 c.c. Nella versione originaria della norma lo ujs
variandi era riconosciuto all'imprenditore per esigenze dell'impresa e purché non importasse una diminuzione della
retribuzione e un mutamento sostanziale della posizione del lavoratore. L'unico limite rimaneva l'invariabilità in pejus
della retribuzione.
I limiti stabiliti dalla norma riguardavano solo gli spostamenti unilaterali di mansioni, mentre non incidevano sulle
modifiche consensuali, ritenute ammissibili senza condizioni sul presupposto della piena disponibilità della materia da
parte dell'autonomia privata.
Alle debolezze garantistiche della disciplina originaria, rimediò l’art. 13 St. Lav. che ha sollevato molteplici
controversie relative sia alla sua incidenza sullo jus variandi, sia al significato dei singoli limiti in essa stabiliti alle
variazioni delle mansioni.
Non sembra accettabile la tesi secondo cui la norma avrebbe del tutto cancellato lo jus variandi dell'imprenditore e
implicherebbe la necessità del consenso del lavoratore. Una simile rivoluzione nei poteri dell'imprenditore, che
irrigidirebbe in modo drastico la gestione della forza lavoro, non si desume dalla Statuto. Questo mira infatti a limitare i
poteri direttivi dell'imprenditore, non ad eliminarli, conformemente del resto alla contrattazione collettiva che il
legislatore ha tenuto presente. Meno problematico è invece il richiamo della norma alle mansioni ultime effettivamente
svolte come termine di raffronto per giudicare le legittimità degli spostamenti.
5.1. Il limite dell'equivalenza delle mansioni.
Le modifiche in “orizzontale” sono ammesse dal nuovo art. 2103 c.c. solo per mansioni “equivalenti” a quelle di
assunzione, senza alcuna diminuzione della retribuzione (1°comma). La prassi giurisprudenziale ha inteso l'equivalenza
in modo rigido e statico, tale cioè da escludere qualsiasi mobilità- unilaterale o consensuale- verso il basso. Non
sorprende quindi che l'art. 13 sia divenuto una delle norme più criticate dello Statuto per l'eccessiva rigidità che essa
avrebbe indotto nell'impiego della forza lavoro, mirando alla tutela della professionalità del lavoratore.
Se in un periodo di crescita economica tale impostazione ha potuto essere difesa , la crisi produttiva degli anni recenti
ha aumentato i motivi di critica e le difficoltà applicative. Di qui l'esigenza, segnalata dalla dottrina, di un'applicazione
flessibile e contrattata della norma, perseguendo una tutela dinamica e non statica della professionalità.
Il giudizio sull'equivalenza delle mansioni risulta da più elementi. L'eguaglianza di retribuzione prevista dagli
inquadramenti contrattuali ha un valore indicativo, ma non sufficiente. L'equivalenza è dunque essenzialmente
equivalenza professionale. L'equivalenza professionale va accertata considerando il “complesso della attitudini e delle
capacità acquisite dal lavoratore” cioè quel bagaglio di perizia ed esperienza che costituisce il suo patrimonio
professionale. Tuttavia, secondo un orientamento tuttora minoritario, tale lettura statica dovrebbe essere corretta sulla
base della valutazione, più dinamica. In altri termini, bisognerebbe dar rilievo non tanto al saper fare, quanto al saper
come fare.
Un'interpretazione corretta del precetto in esame comprende inoltre un controllo circa la modifica dei compiti inerenti al
posto di lavoro e quindi può ostacolare la sottrazione o riduzione delle mansioni svolte senza conferimento di altre. A
fortiori deve ritenersi illecito il comportamento del datore di lavoro che rifiuti sistematicamente la prestazione di lavoro,
così intaccando la posizione professionale del lavoratore nell'ambito aziendale. Infatti la valorizzazione della
professionalità realizzata dall'art. 13 St.lav. è stata vista come un indice normativo che comprova l'esistenza di un diritto
e non solo di un dovere del lavoratore all'esecuzione della prestazione di lavoro.
La giurisprudenza prevalente stenta ad imboccare la via di un'interpretazione più elastica della nozione di equivalenza,
restando ancorata ad una nozione statica e alimentando una serie composita di azioni giudiziali contro la
dequalificazione. Se così è, non sorprende che poi la stessa Corte sia costretta a percorrere, la strada meno piana della
creazione di “eccezioni” al divieto di patti contrari.
In ipotesi di violazione del precetto normativo il lavoratore può richiedere, oltre alla dichiarazione di nullità dell'atto e la
condanna alla reintegra, anche il risarcimento del danno da dequalificazione (c.d. danno alla professionalità), pur se
quest'ultimo profilo resta esposto ad incertezze relativamente sia al contenuto dell'onere della prova (con frequente
ricorso a presunzioni), sia alla quantificazione del danno (per lo più operata con valutazione equitativa sulla base della
retribuzione), sia alla proliferazione delle figure di danno.
5.2 La nullità dei patti contrari
L'ultimo comma del nuovo art. 2103 c.c., nel sancire la nullità di ogni patto contrario, tende a correggere la lacuna più
vistosa della vecchia disciplina. Gli accordi nulli cui si riferisce la norma sono quelli individuali e collettivi che
realizzano un risultato vietato dalla norma, ad es., l'adibizione a mansioni inferiori (c.d. mobilità verso il basso).
La natura inderogabile della norma tuttavia, pone un problema a fronte di quei patti che dispongono lo spostamento a
mansioni inferiori per soddisfare un interesse qualificato del lavoratore (quello di evitare un licenziamento). A favore
della validità di tali patti, depone un'interpretazione della norma sensibile agli interessi sostanziali in gioco
(salvaguardia della professionalità del lavoratore con l’interesse alla conservazione del posto di lavoro) e al risultato che
essa vuole realizzare. La norma mira a proteggere la posizione professionale del lavoratore. Quindi non esclude la
variazione consensuale rispetto a mansioni e posizioni professionali diventate inagibili o per invalidità incolpevole (ad
es., sopravvenuta inidoneità psico-fisica), o per modifiche oggettive della struttura aziendale (ad es., quale unica
alternativa al licenziamento).
Il legislatore impone al datore di lavoro di spostare le lavoratrici madri temporaneamente a mansioni non
pregiudizievoli alla loro salute, anche se inferiori, con conservazione della retribuzione precedente. Analogamente i
lavoratori divenuti invalidi durante il rapporto di lavoro non possono essere licenziati nel caso in cui possano essere
adibiti a mansioni diverse, anche inferiori.
Sempre nella logica di una graduatoria dei valori in gioco, il legislatore prevede l'assegnazione a mansioni “diverse da
quelle svolte” (cioè inferiori) per i lavoratori eccedenti in alternativa al licenziamento collettivo, per messa in mobilità o
per riduzione di personale.
Un filone giurisprudenziale, ricalcando la citata normativa, giunge a legittimare il mutamento in pejus delle mansioni su
mera richiesta del lavoratore per soddisfare un proprio interesse non ulteriormente qualificato. A volte il consenso è
desunto dal comportamento del lavoratore. Quest'ultima soluzione però accende il sospetto di un'operazione elusiva
della prescrizione posta dal nuovo art. 2103 c.c. Per un controllo sull'effettiva libertà negoziale del lavoratore appare
condivisibile la prassi di trasfondere gli accordi di dequalificazione in verbali di conciliazione avanti la Direzione
provinciale del lavoro.
5.3. (Segue): Mobilità verso l'alto e carriera.
L’ultimo comma del nuovo art. 2103 c.c., disciplina la cosiddetta mobilità verso l'alto o verticale, cioè l'assegnazione a
mansioni superiori. Il legislatore ha stabilito che lo svolgimento di mansioni superiori protratto per più di 3 mesi (o per
il minor periodo previsto dai contratti collettivi) rende irreversibile lo spostamento. La norma è diretta ad evitare
pratiche fraudolente di spostamenti ricorrenti di breve durata senza riconoscimento della professionalità acquisita.
La promozione si realizza automaticamente al compiersi del periodo temporale; ma si ritiene che l'automaticità funzioni
soprattutto a carico del datore.
Mentre l'art. 13 St.lav. conferma che la progressione in carriera è affidata al potere discrezionale del datore, la
contrattazione collettiva, specie in certi settori dei servizi, ha previsto diverse procedure rivolte a vincolare le scelte
datoriali: concorsi privatistici interni di vario genere, simili a quelli tradizionali del pubblico impiego, spesso con la
partecipazione sindacale.
Si è discusso se i 3 mesi di svolgimento delle mansioni superiori debbano essere continuativi o se si possano anche
cumulare distinti periodi. La giurisprudenza prevalente propende per la prima ipotesi (e intende i 3 mesi come mesi di
lavoro effettivo e non di calendario). Peraltro precisa che eventuali interruzioni di tale periodo non connesse a reali
esigenze produttive, ma effettuate dal datore al fine di eludere l’applicazione della norma, non impediscono il cumulo e
quindi la promozione, in quanto devono ritenersi in frode alla legge o contrarie ad un'esecuzione secondo buona fede
del contratto. Così pure si precisa che la continuità non va intesa in senso rigido e quindi non è interrotta ad esempio
dalle ferie (che tuttavia non si computano).
La norma prevede poi un’eccezione alla promozione automatica quando l’adibizione alle mansioni superiori venga
disposta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio,
maternità\paternità, permessi, aspettative sindacali, previsti dalla legge o dal contratto). In definitiva, l'eccezione non
vale (e quindi matura la promozione) per le ipotesi di sostituzione derivanti da scelte organizzative del datore.
L’eccezione è motivata dall’esigenza di non vanificare il diritto del lavoratore assente di ritornare al proprio posto di
lavoro dopo il periodo di sospensione.
Si è ritenuto che entrino nel disposto della norma anche le cosiddette sostituzioni a cascata: la promozione automatica
cioè sarebbe preclusa nei confronti non solo del sostituto dell'assente, ma di eventuali ulteriori sostituti che coprano il
posto di chi sostituisce l'assente. Il lavoratore spostato a mansioni superiori ha diritto da subito al trattamento superiore
corrispondente (art 2103 c.c.).
CAPITOLO SEI: DILIGENZA, OBBEDIENZA, FEDELTA', LUOGO E DURATA DEL LAVORO.
1. La diligenza come misura della prestazione
Diligenza ed obbedienza sono specificazioni della stessa obbligazione lavorativa e concorrano ad individuare il
contenuto della prestazione di lavoro, cioè i doveri del lavoratore subordinato.
La diligenza richiesta al prestatore di lavoro dall’art. 2104 rappresenta il criterio di misura della prestazione dovuta;
oggetto dell’obbligazione lavorativa è la prestazione diligente. Per indicare la diligenza richiesta al lavoratore, l’art.
2104 la rapporta a diversi parametri.
Il primo parametro utilizzato dall’art. 2104 è la natura della prestazione dovuta. Il rinvio alla natura della prestazione
(che costituisce una sorta di specificazione del principio generale fissato dall’art. 1176 relativo alle obbligazioni in
generale) impone il riferimento alla qualità del lavoro prestato, risultante dalle mansioni, dalle qualifiche o dai profili
professionali che la definiscono. Si abbandona il riferimento al criterio della diligenza del buon padre di famiglia (la
diligenza media di cui all’art. 1176) per adottare il modello ben più pregnante del soggetto in possesso delle esperienze
e competenze richieste per fornire una prestazione di normale qualità.
La diligenza richiesta al lavoratore viene poi rapportata all’interesse dell’impresa. Sotto questo profilo la prestazione del
lavoratore si deve inserire nell’organizzazione aziendale. La prestazione del singolo lavoratore deve essere quindi
integrabile e coordinabile con quella degli altri lavoratori, in una concreta organizzazione e con riguardo al concreto
interesse del creditore (ovvero del datore di lavoro).
Infine è presente un terzo riferimento, all’interesse superiore della produzione nazionale, che deve tuttavia ritenersi
abrogato con la caduta del regime corporativo e non può ritenersi sostituito dal criterio dell'utilità sociale di cui all'art.
41 Cost.
2. Il dovere di obbedienza.
L’art. 2104 poi fa riferimento al dovere di obbedienza del lavoratore. Non si tratta di un vero e proprio obbligo a sé, ma
piuttosto della posizione (di soggezione giuridica) del lavoratore corrispondente al potere direttivo del datore di lavoro.
In pratica, l’obbedienza implica l’osservanza delle disposizioni impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo
dai quali il lavoratore dipende, per l’esecuzione della prestazione di lavoro. L’effetto che si produce in capo al
lavoratore è l’obbligo di eseguire tali disposizioni, ossia di eseguire la prestazione lavorativa, così come specificata dal
datore e dai suoi collaboratori nell’esercizio del potere direttivo. Tale obbligo comprende tutti i comportamenti
necessari a rendere la prestazione lavorativa ragionevolmente integrabile nell’organizzazione dell’impresa.
Il dovere di obbedienza, data la sua stretta correlazione al potere direttivo datoriale, risente direttamente dei limiti legali
e contrattuali posti all’esercizio di quest’ultimo. Ed in tale ottica un rilevo particolare assume la disciplina introdotta
dallo St. lav., che ha avviato un processo di spersonalizzazione del rapporto di lavoro tale da ridimensionare
notevolmente gli aspetti di soggezione giuridica del prestatore (l’inserimento del lavoratore nell’impresa, pur
mantenendo rilievo, non può implicare un allargamento della sua posizione debitoria a comportamenti che non siano
ragionevolmente richiesti da esigenze organizzative).
Anche la giurisprudenza ha più volte sottolineato la necessità di ridimensionare il dovere di obbedienza, tenendo conto
dei limiti legali e contrattuali; così che il prestatore di lavoro potrà legittimamente rifiutare (cd. Autotutela) l'esecuzione
di disposizioni datoriali, se illegittime e contrastanti con i suddetti limiti.
Oltre ai limiti specifici si assiste ad una “razionalizzazione” dell'esercizio discrezionale dei poteri, di un allentamento
della concezione esclusivamente gerarchica dell'organizzazione aziendale. Tutti questi elementi circoscrivono l'area di
mera soggezione del lavoratore e introducono elementi di iniziativa e/o di autoregolazione del lavoratore.
3. L'obbligo di fedeltà: concorrenza e riservatezza.
Nonostante l’ambiziosa rubrica “obbligo di fedeltà”, è opinione comune che l’art. 2105 non imponga al lavoratore un
obbligo di fedeltà in senso proprio, bensì configuri, a carico del medesimo, semplici comportamenti omissivi, integrativi
della prestazione principale di lavorare.
Un dovere di fedeltà in senso ampio neppure è ravvisabile nel settore pubblico, ove gli obblighi del dipendente non si
differenziano da quelli del dipendente privato.
Da ciò deriva che il lavoratore deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105, ma anche
da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi
all’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con gli interessi della stessa
impresa.
Il dovere di fedeltà si sostanzia nell’obbligo di tenere un comportamento leale verso il datore e di tutelarne gli interessi
(principi di correttezza e buona fede). Esso si configura come un obbligo accessorio a quello principale di prestare la
propria attività lavorativa (e proprio in virtù dell’autonomia di tale dovere, esso sussiste anche in assenza di prestazione
lavorativa, come ad esempio in periodi di malattia o di sciopero).
L’art. 2105 articola l’obbligo di fedeltà in 2 distinti doveri, ambedue di contenuto negativo (obbligo di non fare): il
divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza.
Il divieto di concorrenza comporta l’obbligo di astenersi dal trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza
con l’imprenditore. Esso va tenuto distinto dal divieto di concorrenza sleale ex art. 2598 e dal patto di non concorrenza.
Il divieto di concorrenza sleale ex art. 2598 individua una serie di comportamenti posti in essere da chiunque e
prescinde da un rapporto contrattuale tra danneggiante e danneggiato. Da ciò consegue che la responsabilità derivante
da violazione dell’art. 2598 ha natura extracontrattuale, mentre la responsabilità derivante da violazione del divieto di
concorrenza ex art. 2105 ha natura contrattuale, con tute le conseguenze giuridiche che ne conseguono.
Il patto di non concorrenza invece, consiste in un accordo tra datore e lavoratore, avente ad oggetto il divieto di svolgere
attività concorrenziali con quelle dell’imprenditore, anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
(mentre il divieto di concorrenza ex art. 2105 ha vigore solo per la durata del rapporto di lavoro, dato il suo fondamento
contrattuale). Affinché il patto di non concorrenza sia legittimo, si devono rispettare determinate condizioni (il patto
deve essere redatto per iscritto e deve essere limitato sotto il profilo del tipo di attività vietate e sotto il profilo
temporale).
L’altro obbligo sancito dall’art. 2105 è quello di riservatezza. La norma pone sotto la tutela del c.d. segreto aziendale
tutte le notizie di carattere organizzativo e produttivo conosciute dal dipendente in ragione del suo inserimento
nell’impresa, vietandone, così: a) la divulgazione, in via assoluta (cioè indipendentemente dal verificarsi di un danno);
b) e l’utilizzazione, ma solo in caso di potenziale pregiudizio per l’impresa stessa.
Escluse dal divieto sono invece quelle competenze e conoscenze professionali acquisite dal lavoratore nello
svolgimento della propria prestazione lavorativa e dunque, facenti parte del patrimonio professionale dello stesso.
Data la natura dell’interesse protetto, l’opinione prevalente ritiene che l’obbligo di riservatezza perduri in capo al
lavoratore finché persista l’esistenza cui è finalizzato, e quindi anche dopo la cessazione del rapporto.
4. Le invenzioni del lavoratore.
L'art. 2590 c.c. attribuisce al lavoratore il diritto ad essere riconosciuto “autore” dell'invenzione industriale realizzata
nello svolgimento del rapporto di lavoro.
In tema di brevetti industriali la disciplina è contenuta nel R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 e regola i doveri e diritti delle
parti sulla base di una triplice tipologia: a seconda a) che l'attività inventiva sia quella specificatamente dedotta nel
contratto (invenzioni cd. di servizio); b) che sia comunque svolta “nell'esecuzione e nell'adempimento” del contratto,
attuata, cioè, in orario di lavoro, utilizzando le occasioni e le possibilità offerte dalla propria posizione nell'impresa
(invenzioni cd. aziendali); c)che rientri nell'ambito dell'attività dell'impresa, ma sia realizzata indipendentemente dal
rapporto, fuori dall'orario di lavoro e con mezzi propri del lavoratore (invenzioni cd. occasionali).
Nel primo caso tutti i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro; nel secondo caso il
datore mantiene tali diritti, ma il lavoratore ha diritto ad un equo premio; nella terza ipotesi i diritti patrimoniali spettano
al lavoratore, ma il datore ha diritto di prelazione da esercitarsi entro 3 mesi per l'uso della stessa o per l'acquisto del
brevetto.
Luogo della prestazione di lavoro
1. La disciplina del trasferimento del lavoratore.
Dai principi generali in tema di obbligazioni apprendiamo che il luogo di adempimento della prestazione, se non è
determinato contrattualmente, deve desumersi dagli usi o da altre circostanze, prima tra tutte la natura della prestazione
(art. 1182 c.c.). Da ciò si deduce che la determinazione del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, così come
l’eventuale successiva modifica dello stesso, sono entrambe affidate al potere direttivo del datore.
L’art. 13 St. lav., nel novellare l’art. 2103, conferma tale potere unilaterale di modifica del luogo di lavoro del datore,
assoggettandone l’esercizio a limiti interni e prevedendo la nullità dei patti contrari. Inoltre il D.lgs. n. 152/1997 ha
posto in capo al datore degli obblighi di informazione scritta circa il luogo della prestazione lavorativa.
L’art. 13 non prende in considerazione qualsiasi spostamento spaziale del lavoratore ma solo quello da un’unità
produttiva ad un’altra (trasferimento esterno); mentre non considera i c.d. trasferimenti interni, cioè i passaggi del
lavoratore all’interno della medesima articolazione produttiva (per i trasferimenti interni dunque non operano i limiti
dell’art. 13).
L’art. 13 subordina l’esercizio del potere di trasferimento all’esistenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive”. Tale limite tuttavia è alquanto debole; il datore avrebbe si l’onere di comunicare (anche solo oralmente) tali
ragioni al proprio dipendente, ma solo su sua esplicita richiesta.
Quanto alle ragioni tecniche, organizzative e produttive, poi, la tesi prevalente è nel senso di escludere un controllo di
merito sulle scelte datoriali. Il giudice dovrà quindi limitarsi ad accertare l’effettiva presenza di tali ragioni, e l’esistenza
di un nesso di causalità tra queste ed il provvedimento di trasferimento preso (senza richiedere la prova dell’inevitabilità
del trasferimento).
Anche i comportamenti del lavoratore, qualora determinino situazioni di “incompatibilità ambientale” (es. rapporti
difficili con i colleghi o con la clientela), in quanto causa di disorganizzazione e disfunzione aziendale, integrano una
ragione oggettiva che legittima il trasferimento del lavoratore. Per questa via passa talvolta il tentativo di legittimare il
trasferimento per motivi disciplinari.
Sono poi previsti dei limiti più intensi al potere di trasferimenti di determinate figure di lavoratori; ad esempio per il
dirigente sindacale aziendale è richiesto il previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza; per il
lavoratore che fruisce di congedi di maternità o paternità è previsto il diritto al rientro nella stessa unità produttiva o in
altra nel medesimo comune e per il lavoratore handicappato grave e per i suoi congiunti che lo assistono con continuità,
anche non conviventi, è previsto il consenso e il diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio
domicilio.
2. Trasferta e trasfertismo.
Secondo l’orientamento prevalente, l’art. 13 sarebbe chiamato a disciplinare, non ogni vicenda modificativa del luogo
della prestazione, bensì solo il trasferimento definitivo del lavoratore. Resterebbero così escluse dalla disciplina di tutela
altre fattispecie, quali il distacco, la trasferta ed il trasfertismo, figure trattate prevalentemente dalla contrattazione
collettiva, che vi ricollega solo uno speciale trattamento economico (indennità di trasferta o di trasfertismo).
La trasferta (o missione) si distingue dal trasfertismo per il suo carattere di provvisorietà. Si tratta di una modifica del
luogo di lavoro, che, essendo solo temporanea, non incide irrimediabilmente sull’interesse del lavoratore alla stabile
dimora e alla vita di relazione connessa.
Con il termine trasfertismo, invece, si fa riferimento allo spostamento di quei lavoratori obbligati per contratto a rendere
sistematicamente la propria prestazione in luoghi sempre diversi e provvisori e le cui mansioni sono caratterizzate
dall’essere di per se stesse itineranti (viaggiatori, piazzisti). Sicché in queste ipotesi la trasferta appare una modalità
normale anziché eccezionale della prestazione lavorativa concordata.
Durata della prestazione di lavoro.
1. La durata della prestazione: orario e pause.
La durata del rapporto di lavoro costituisce la misura della prestazione dovuta dal lavoratore e si riferisce
all’obbligazione di lavoro stessa, nonché agli obblighi integrativi ed accessori. Esso implica che la durata costituisce la
misura della prestazione dovuta dal lavoratore.
La quantità effettiva di prestazione normalmente dovuta è indicata dalla disciplina dell’orario di lavoro, inteso in senso
ampio, cioè non solo come orario giornaliero, ma come tempo complessivo di lavoro nella settimana e nell’anno; quindi
con esclusione delle c.d. pause periodiche (riposi giornalieri, settimanali, ferie), durante le quali il rapporto continua
nonostante la sospensione dell’obbligo di lavoro e permangono gli obblighi accessori o strumentali (come quello di
fedeltà). L’orario di lavoro è altresì criterio essenziale di commisurazione dell’obbligo retributivo del datore.
La disciplina legislativa e contrattuale del tempo di lavoro è storicamente rivolta a limitarne la durata massima, a tutela
dell’integrità psico-fisica del lavoratore. In Italia la legge base in materia di orario massimo giornaliero è stata a lungo
rappresentata dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692. i successivi art. 2107 e 2108 e il 2° comma dell'art. 36 Costituzione
non hanno alterato l'originaria impostazione vincolistica della disciplina.
Peraltro, le crisi economiche e le innovazioni tecnologiche hanno fatto emergere l’esigenza di riduzioni di orario e di
nuovi regimi di orario, non più a fini protettivi della salute del lavoratore, ma come misura per fronteggiare la crescente
disoccupazione.
Sul finire del XX sec. Il legislatore dando impulso ad un impegno delle parti sociali (accordi del 23 luglio 1993 e del 24
settembre 1996), ha proceduto ad una prima modernizzazione della normativa sui regimi di orario (art. 13 L. n.
196/1997).
Nel frattempo, l'emanazione della Direttiva Ce n. 104 del 1993 sui tempi di lavoro e di riposo ha sollecitato un
intervento legislativo su taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Intervento a cui si è giunti soltanto dopo
una condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia Europea, con il D.lgs. 8 aprile 2003, n.66 (subito corretto dal
D.lgs. 19 luglio 2004, n. 213).
Nonostante la direttiva fosse ufficialmente finalizzata a garantire un più elevato livello di protezione dei lavoratori,
l’intervento del legislatore italiano ha invece per obiettivo la flessibilità nella gestione degli orari di lavoro in relazione
alle mutevoli esigenze produttive e organizzative.
2. L'orario di lavoro: disciplina legale e contrattuale.
La disciplina originaria sulla durata massima del lavoro (R.D.L. 692/1923) prevedeva (per le aziende industriali e
commerciali) che l’orario massimo non potesse superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali. Tale disciplina
venne sostituita in toto dalla normativa contrattuale, che aveva generalizzato, a partire dal 1973, la settimana di 40 ore
distribuite su 5 giorni.
In seguito, la L. 196/1997 (legge Treu) ha dato conferma legislativa alla generalizzazione per via contrattuale della
settimana lavorativa di 40 ore, limite che andava ad aggiungersi a quello giornaliero di 8 ore (secondo la più recente
giurisprudenza i due limiti erano concorrenti e non alternativi e dunque parimenti vincolanti).
Infine il D.lgs. 66/2003, nel recepire le indicazioni comunitarie, ha disposto l’integrale abrogazione delle pregresse
disposizioni non esplicitamente richiamate dallo stesso decreto. In tale sede il legislatore ha confermato l’orario
massimo normale (oltre il quale la prestazione lavorativa è da considerarsi straordinaria) ed ha anche attribuito ai
sindacati comparativamente più rappresentativi:
-di potere stabilire contrattualmente una durata inferiore a quella legale;
-di potere riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative, per periodi ultrasettimanali non
superiori all’anno.
Il decreto dunque, da un lato ha configurato i limiti normali massimi settimanali, e dall’altro, ha consentito il regime di
orario multiperiodale, consistente nella possibilità di superamento convenzionale dei limiti normali massimi, salvo
compensazione nell’anno. La riforma ha dunque valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva nella gestione
contrattata della flessibilizzazione dell’orario di lavoro. Un’innovazione sostanziale rispetto al regime precedente
riguarda invece la regolamentazione della durata massima complessiva (ossia comprendente anche gli straordinari) della
settimana lavorativa. La determinazione della durata massima complessiva settimanale è demandata ai contratti
collettivi, i quali tuttavia devono rispettare un limite legale di 48 ore, limite che però va calcolato in modo flessibile. Il
limite di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni, va infatti calcolato non settimana per settimana, ma come media in un arco
temporale non superiore ai 4 mesi (tale limite può però essere elevato dalla contrattazione collettiva a 6 o a 12 mesi).
Accanto ai limiti settimanali, normale e massimo, la legge non fa più riferimento ad una durata della giornata lavorativa.
Tuttavia, fermo restando che nulla impedisce alla contrattazione collettiva di fissare tetti di orario giornaliero, una
limitazione della durata della giornata lavorativa può comunque essere ricavata dalla norma sul risposo giornaliero, che
garantisce al lavoratore il diritto ad 11 ore consecutive di riposo giornaliero e ad una pausa di 10 minuti; da ciò si
desume che la giornata lavorativa non possa superare le 12,50 ore.
La presenza di un limite, seppure indiretto, di orario massimo giornaliero, permette di fugare i dubbi di costituzionalità
che possono porsi in relazione all’art. 36 Cost., che impone al legislatore di fissare la durata massima della giornata
lavorativa.
I limiti stabiliti dal legislatore si riferiscono al lavoro effettivamente svolto. Sul punto, il D.lgs. 66/2003 fornisce una
nuova nozione di orario di lavoro, ricalcata su quella comunitaria, da intendersi come qualsiasi periodo in cui il
lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio della sua attività. Questi 3 elementi sono da
considerarsi concorrenti e non alternativi, dunque se il lavoratore si trova a disposizione del datore, ma non è al lavoro
(se ad esempio è in reperibilità) tale periodo non va considerato come periodo di lavoro effettivo.
In realtà la nozione di orario di lavoro della normativa comunitaria pare escludere che nella stessa rientri soltanto il
lavoro caratterizzato da un’effettiva applicazione delle energie lavorative. Vanno infatti considerati anche quei periodi
nei quali in lavoratore non sia impegnato in attività di lavoro in senso stretto, ma stia comunque mettendo a
disposizione le proprie energie lavorative al datore di lavoro, essendo comunque obbligato a restare sul luogo di lavoro,
per poter fornire a richiesta del datore, immediatamente la propria prestazione (ipotesi diversa dalla reperibilità, durante
la quale il lavoratore non è obbligato a restare sul luogo di lavoro).
Ci si è chiesti se il datore possa modificare unilateralmente l’orario di lavoro, nel rispetto dei limiti massimi individuati
dalla legge e eventualmente dalla contrattazione collettiva.
Per la modifica dell’estensione dell’orario di lavoro (e della retribuzione) l’opinione dominante nega l’esistenza di un
potere unilaterale del datore, richiedendo l’assenso del lavoratore. Per la modifica della collocazione temporale
dell’orario, un criticabile orientamento giurisprudenziale risponde in modo positivo, ritenendo che lo jus variandi in tale
materia costituisca tipica manifestazione del potere direttivo ed organizzativo del datore. Ovviamente sono fatti salvi gli
eventuali limiti negoziali concordati a livello individuale o collettivo.
Altro aspetto da considerare è quello della distribuzione sul multiperiodo dell’orario settimanale normale di lavoro. È
pacifico che essendo tutti i poteri in materia rimessi dal legislatore alla contrattazione collettiva, gli interventi del datore
siano vincolati alla presenza di una disciplina collettiva autorizzatoria. In assenza o al di fuori dei limiti previsti da
questa disciplina, il datore non potrà che essere vincolato al limite rigido delle 40 ore settimanali, oltre il quale scatterà
il regime del lavoro straordinario.
La regolamentazione dell’orario di lavoro dettata dal D.lgs. 66/2003 si applica a tutti i settori di attività pubblici e
privati. Fanno invece eccezione all’applicazione generalizzata delle regole contenute nel D.lgs. 66/2003 tutta una serie
di attività tassativamente elencate nello stesso decreto (personale scolastico, forze di polizia, forze armate, gente di
mare, personale di volo nell’aviazione civile).
3. (Segue): lavoro straordinario (e supplementare).
Una disciplina particolare è prevista per il lavoro straordinario, ossia per il lavoro prestato oltre l’orario normale
settimanale di lavoro fissato dalla legge. Nel sistema originario, il lavoro eccedente le 48 ore settimanali o le 8
giornaliere; con l’entrata in vigore del decreto 66/2003 invece il limite settimanale è stato ridotto a 40 ore (calcolate, in
regime di orario multiperiodale, come media), mentre il limite giornaliero è scomparso.
La facoltà attribuita al datore di ampliare occasionalmente la durata dal lavoro ordinario è stata sempre vista dal
legislatore con sfavore, ed è ad oggi ostacolata da limiti legali nonché da disincentivi di ordine economico. La ragione
di tale atteggiamento di sfavore verso il lavoro straordinario consiste nel fatto che un eccesso del ricorso al lavoro
straordinario potrebbe vanificare la ratio stessa della regolamentazione dell’orario di lavoro, forzando sistematicamente
i lavoratori ad orari di lavoro ben superiori ai limiti normali di orario, e quindi, potenzialmente pericolosi per la loro
salute. Inoltre una simile eventualità frustrerebbe le finalità occupazionali perseguite attraverso la riduzione di orario.
Per questo motivo, il lavoro straordinario, sommato al lavoro normale, deve essere contenuto entro il limite massimo
settimanale di orario stabilito dai contratti collettivi, senza eccedere in ogni caso, le 48 ore settimanali (calcolate come
media). Entro tale limite, i contratti collettivi sono liberi di regolare le modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro
straordinario, anche prevedendo l’obbligo del lavoratore di effettuare le prestazioni eccedenti, fatto salvo un giustificato
motivo di rifiuto.
In caso di assenza di disciplina collettiva, invece, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo se la richiesta del
datore è corredata dal consenso del lavoratore e comunque entro il limite massimo annuale di 250 ore.
Inoltre, salvo diversa disposizione della disciplina collettiva, il lavoro straordinario può essere richiesto -anche
prescindendo dal consenso del lavoratore - per esigenze tassativamente determinate (eccezionali esigenze tecnicoproduttive, impossibili da fronteggiare attraverso l’assunzione di nuovi lavoratori; casi in cui la mancata esecuzione di
prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato oppure un danno alle persone o
alla produzione; eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva).
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con maggiorazioni retributive, la cui determinazione
è integralmente rimessa alla contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva può altresì consentire ai lavoratori di
usufruire, in aggiunta o in alternativa alle maggiorazioni retributive, di riposi compensativi (questa è la traduzione in
legge di un istituto introdotto dalla contrattazione collettiva, noto come “banca delle ore”).
A conti fatti, forse la remora più efficace frapposta all’utilizzo del lavoro straordinario è posta dal legislatore non già
sotto forma di limite diretto, bensì di penalizzazione indiretta di tipo economico, rappresentata dall’obbligo per il datore
di pagare un contributo addizionale in una percentuale (variabile) della retribuzione erogata per le ore di straordinario.
-Il lavoro supplementare
Il lavoro eccedente il limite di orario fissato dai contratti collettivi, ma entro il limite di orario normale settimanale
fissato dalla legge, non è di per sé straordinario agli effetti di legge, ma è definito come lavoro supplementare (o anche
straordinario contrattuale). Laddove dunque la contrattazione collettiva abbia previsto un limite settimanale di orario
normale di lavoro (ovviamente inferiore al limite legale di 40 ore) e tale limite venga superato, pur rimanendo entro il
limite legale dell’orario normale di lavoro delle 40 ore, non troverà applicazione la disciplina sul lavoro straordinario,
ma soltanto quella contrattuale (eventualmente) prevista per il lavoro supplementare.
Abbiamo già detto che il decreto 66\2003 ha eliminato il limite (legale) giornaliero. Tuttavia, nel caso in cui la
contrattazione collettiva abbia previsto oltre all’orario settimanale ridotto, un orario normale giornaliero, anche il
superamento di tale limite determina l’applicazione della (eventuale) disciplina sul lavoro supplementare.
4. (Segue): lavoro notturno e regimi d'orario.
Dato il maggiore affaticamento psicofisico ed i sacrifici alla vita di relazione che questo comporta, il legislatore ha
dettato una disciplina specifica per il lavoro notturno. Inizialmente si è limitato a considerare i soli aspetti economici,
stabilendo, all’art. 2108 c.c. che il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere retribuito con
una maggiorazione rispetto al lavoro diurno. Data la genericità della norma, la contrattazione collettiva ha svolto in
materia un ruolo decisivo.
La disciplina organica del lavoro notturno è contenuta nel decreto 66\2003, il quale stabilisce i criteri per individuare
quando e in favore di chi debba essere applicata (non tutti i lavoratori che prestano la propria attività nelle ore notturne,
infatti, devono essere considerati lavoratori notturni). Pertanto:
-si ha lavoro notturno quando l’attività è svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti
l’intervallo tra la mezzanotte e le ore 5 del mattino.
-è lavoratore notturno quel lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno 3 ore del
tempo giornaliero o comunque una parte del suo orario normale di lavoro secondo il contratto collettivo. In assenza di
disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno chi svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per almeno 80 giorni
lavorativi annui.
La disciplina del lavoro notturno è rimessa alla contrattazione collettiva, nel rispetto però delle disposizioni del decreto
66\2003, con particolare riferimento alla durata massima della prestazione. L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non
può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salva l’individuazione, da parte della contrattazione collettiva, di un periodo
di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. Il limite non riguarda solo la prestazione
lavorativa resa in periodo notturno, ma l’orario generale che devono osservare i lavoratori notturni (anche di giorno). È
altresì previsto che i lavoratori notturni debbano godere di una riduzione dell’orario di lavoro normale e\o di una
maggiorazione della retribuzione. La determinazione della riduzione di orario o della maggiorazione retributiva e
demandata alla contrattazione collettiva.
Lo svolgimento di prestazioni di lavoro notturno non può avvenire in danno della salute e dell’integrità psicofisica del
lavoratore. Pertanto è obbligo del datore accertare lo stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno attraverso
controlli preventivi e periodici ai quali è subordinata la idoneità del lavoratore a svolgere lavoro notturno.
Vi è poi il divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino
al compimento di un anno di età del bambino. Vi sono poi altre tre ipotesi, non riservate alle sole madri, nelle quali il
lavoro notturno non deve obbligatoriamente essere prestato, cioè vi è un diritto di esenzione dal lavoro notturno: a)una
prima ipotesi riguarda la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente il padre convivente
con la stessa. La norma attribuisce al padre un diritto non originario, ma subordinato ad una eventuale rinuncia da parte
della madre; b)sono esonerati dalla prestazione di lavoro notturno anche le lavoratrici o i lavoratori che siano l'unico
genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c) l'ultima ipotesi di esonero riguarda le
lavoratrici e i lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile.
Regimi particolari di orario risultano dall'uso di turni avvicendati, stabiliti con modalità alquanto varie, secondo le
esigenze dell'organizzazione del lavoro. A riguardo si riferisce il D.lgs. 66/2003 il quale definisce il lavoro a turni come
qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente
occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso quello rotativo e il quale comporti la
necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Il
medesimo decreto legislativo definisce il lavoratore a turni come qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito
nel quadro del lavoro a turni.
Le preoccupazioni economiche e di competitività hanno indotto le aziende a ricercare regimi d'orario e di
organizzazione del lavoro flessibili, cioè, da migliorare il grado di utilizzo degli impianti e i livelli di produttività.
5. Riposi giornalieri, settimanali, annuali e festività.
Il decreto 66\2003 disciplina non solo il tempo di lavoro ma anche il tempo di non lavoro (riposi periodici giornalieri,
settimanali, annuali e pause giornaliere).
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale (40 ore, calcolabili anche come media nel multiperiodo), il
lavoratore ha diritto a 11 ore di risposo consecutivo ogni 24 ore. Tale regime di riposo giornaliero, come visto, è
divenuto essenziale per la determinazione dell’orario giornaliero. La regola vuole che il riposo vada fruito in modo
consecutivo; tuttavia ad essa si può derogare per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata.
Oltre alla consecutività del riposo, deroghe sono ammesse anche alla durata minima dello stesso, potendo scendere al di
sotto delle 11 ore per quei lavoratori (dirigenti) la cui durata dell’orario di lavoro non è predeterminata attraverso
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Il decreto 66/2003 riconosce inoltre al lavoratore il cui orario giornaliero ecceda le 6 ore, un intervallo per pausa, le cui
modalità e la cui durata vengono stabilite dai contratti collettivi. Qualora manchi una disciplina collettiva, è la stessa
legge ad imporre una pausa di 10 minuti.
Il diritto a riposi settimanali trova riconoscimento (oltre che a livello comunitario) nella stessa Costituzione, che, all’art.
36, ne sancisce l’irrinunciabilità.
Il decreto 66\2003 ha confermato in materia, i principi base di periodicità e consecutività del risposo settimanale. Il
lavoratore ha diritto ogni 7 giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la
domenica. È stato inoltre previsto il cumulo del riposo settimanale con le 11 ore di riposo giornaliero, garantendo così
di fatto al lavoratore 35 ore di riposo consecutive ogni 7 giorni.
Il riposo settimanale di regola coincide con la domenica, con numerose eccezioni. È ammessa la collocabilità del riposo
di 24 ore consecutive in un giorno diverso dalla domenica (sempre nel rispetto della cadenza settimanale) per un novero
nutrito di ipotesi (attività a ciclo continuo; industrie stagionali laddove vi sia un rischio di deterioramento della materia
prima; servizi e attività il cui funzionamento domenicale soddisfi interessi rilevanti della comunità ovvero sia di
pubblica utilità).
Il lavoro nella giornata domenicale, da diritto, in considerazione della sua maggior penosità, ad una maggiorazione
retributiva prevista dai contratti collettivi
Va ricordato che al di fuori delle ipotesi autorizzate dalla legge, la prestazione di lavoro in giornata festiva è illecita per
contrarietà a norma imperativa di legge (tuttavia la nullità non pregiudica il diritto del lavoratore alla retribuzione).
Le festività infrasettimanali a tutt’oggi riconosciute sono 12 (5 civili e 7 religiose). Durante tali festività, i lavoratori
(pagati a ore) ricevono la normale retribuzione giornaliera. Se le festività cadono di domenica, i lavoratori ricevono una
retribuzione doppia.
6. (Segue): le ferie
Il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite è riconosciuto dall’art. 36 Cost., che ne sancisce
l’irrinunciabilità, nonché dall'art. 10 D.lgs. 66/2003, che mantiene in vigore l'art. 2109 c.c.. Le ferie rispondono allo
scopo tipico di soddisfare primarie necessità fisiche e morali del dipendente. La loro durata minima è fissata in 4
settimane, elevabile dai contratti collettivi.
Il periodo di ferie è annuale; esso spetta cioè, entro l’anno. Tuttavia, perché lo stesso maturi, non occorre aver prestato
servizio per un intero anno, essendo garantito, anche a coloro che abbiano lavorato per un periodo inferiore, 1\12 delle
ferie per ogni mese di servizio prestato (è questo il c.d. principio della introannualità delle ferie). In base allo stesso
principio, quando il rapporto cessi prima della maturazione o del godimento della pausa feriale, il lavoratore avrà diritto
alla corresponsione di un indennità sostitutiva proporzionale alle ferie non godute.
Per espressa previsione del decreto 66\2003, il periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dall’indennità
per ferie non godute, salvo che in caso di risoluzione del rapporto.
La scelta del periodo feriale rientra nel potere dispositivo del datore, da esercitarsi in buona fede, contemperando le
esigenze aziendali con quelle dei lavoratori. Il datore resta tuttavia libero di assoggettare il proprio potere al vincolo
della contrattazione collettiva (ciò che del resto solitamente avviene; le condizioni di godimento delle ferie sono spesso
oggetto di contrattazione). Il potere di determinazione del periodo feriale, riconosciuto al datore non è assoluto. Il datore
dovrà anzitutto rispettare il principio secondo cui, salvo diverse previsioni contrattuali collettive, le ferie vanno godute
per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione, mentre il restante periodo entro 18 mesi dal termine dell’anno di
maturazione. In secondo luogo, il datore dovrà tener conto del fatto che le ferie vanno possibilmente godute in modo
continuativo.
Una questione a lungo controversa è stata quella relativa agli effetti della malattia sopravvenuta nel corso delle ferie. La
giurisprudenza prevalente ha per lungo periodo escluso l'effetto interruttivo della malattia rispetto alle ferie. Questo
orientamento ha subito un netto capovolgimento con la dichiarazione di illegittimità da parte della Corte Costituzionale
dell'art. 2109 c.c., nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.
La Corte ha ritenuto che il sopraggiungere della malattia ostacoli la fruizione effettiva delle ferie e mal si concili,
perciò, con la loro irrinunciabilità sancita dall'art 36 Cost. L'orientamento dominante attribuisce effetti sospensivi non
ad ogni malattia , bensì solo a quella che impedisca, in concreto, il normale decorso delle ferie e ne precluda il
raggiungimento delle finalità tipiche.
Vi sono poi altri tipi di pause, le quali si differenziano dalle pause, per essere legati a motivi personali di vario genere
(le 150 ore per i lavoratori studenti; i permessi retribuiti; i congedi per la formazione; lo svolgimento di attività di
volontariato ecc.)
CAPITOLO SETTE: POTERI E DOVERI DEL DATORE DI LAVORO
1. I poteri del datore in generale e i loro limiti.
Il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza per la posizione di preminenza riconosciuta al datore di lavoro, cui
corrisponde una posizione di soggezione del lavoratore. Tale situazione si evince già dalle norme codicistiche sul
lavoratore subordinato, il quale collabora nell’impresa, prestando la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore (art. 2094), ed al quale è addossato l’obbligo di obbedienza di cui all’art. 2104.
Tali posizioni di supremazia del datore sono state storicamente considerate come poteri giuridici esercitabili
discrezionalmente dal datore, a tutela di un interesse proprio, ed ogni tentativo di assoggettare tali poteri al rispetto dei
principi costituzionali (come quello di eguaglianza) sono rimasti senza seguito, almeno fino all’emanazione dello
Statuto del lavoratori. Fino all'emanazione della L. n. 604/1966 sui licenziamenti, il potere di recesso ad nutum
dell'imprenditore suggellava l'effettività della supremazia datoriale., e ciò risulta non coerente con la logica del
contratto, che è egualitaria.
La natura contrattuale del rapporto risulta rivalutata attraverso la riduzione dei contenuti di comando e il rafforzamento
dell'autonomia collettiva: il contratto non è più esclusivo strumento di soddisfacimento delle esigenze aziendali, ma
riflette situazioni di interesse e poteri del lavoratore funzionali alla promozione dei valori costituzionali di dignità e
libertà. Se non può negarsi che con il contratto di lavoro subordinato il lavoratore legittima l'esercizio di alcuni poteri
unilaterali del datore, è altrettanto vero che questi poteri incontrano una serie di vincoli tali da ridurne il carattere
“autoritativo”.
2. Il potere direttivo: contenuti.
Le innovazioni normative suddette incidono sul potere direttivo del datore di lavoro, il quale comprende una serie di
poteri (o facoltà) del datore (potere organizzativo, di vigilanza, gerarchico, di conformazione, ecc.) finalizzati nel loro
insieme a garantire l'esecuzione e la disciplina del lavoro in vista degli interessi sottesi al rapporto (art. 2104 c.c.). La
disciplina riguarda i poteri imprenditoriali correlati allo svolgimento e alla disciplina del lavoro non, invece, le funzioni
manageriali di gestione dell'impresa, queste sottratte alla disciplina legislativa dello Statuto.
3. I limiti del poter direttivo: principio di non discriminazione.
Ai poteri dell'imprenditore si riferiscono diverse norme del Titolo I dello Statuto dei Lavoratori, tra cui l'art. 7 sul potere
disciplinare e l'art. 9 sul dovere di sicurezza del datore di lavoro. Un limite generale all'esercizio dei poteri
imprenditoriali è il divieto di discriminazione.
Quello della tutela antidiscriminatoria è terreno classico di incidenza del diritto comunitario, rispetto al quale il diritto
interno nutre oggi ineludibili obblighi di adeguamento (direttiva n. 76/201/CE, oggi modificata dalla direttiva n.
2002/73/CE, emanata in tema di parità di trattamento e di opportunità per uomini e donne sul versante occupazionale e
delle condizioni di lavoro; oltre direttiva n. 2000/43/CE relativa a discriminazioni per religione, convinzioni personali,
handicap, età, tendenze sessuali, oggetto della direttiva n. 2000/78/CE).
La costituzione all'art. 37 pone una direttiva di parità fra lavoratori e lavoratrici, con la precisazione che “le condizioni
di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale e adeguata protezione.
Un’ulteriore fondamento può essere ritrovato all’art. 3, che esprime il principio di eguaglianza, formale e sostanziale.
Col principio di eguaglianza formale, il costituente impone che situazioni eguali vengano trattate in modo eguale.
Mentre il principio di eguaglianza sostanziale impone all’ordinamento di rimuovere tutti quegli ostacoli che limitano o
impediscono di fatto la realizzazione di quella eguaglianza formale enunciata nel primo comma.
Non tanto una direttiva di eguaglianza, quanto piuttosto l'imposizione di un esercizio non arbitrario dei poteri datoriali,
viene sancita dall'art. 15 St. lav., che dichiara nullo ogni atto o patto che rechi in qualche modo pregiudizio alla
lavoratrice o al lavoratore a causa del suo sesso (più recenti interventi legislativi hanno esteso il divieto ad atti o patti
discriminatori per motivi sindacali, politici, religiosi, razziali e di lingua).
4. La tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso. Parità di trattamento e parità retributiva nella L. n.
903/1977.
La L. n. 903/1977, in quanto pone specifici divieti di discriminazione, viene considerata attuazione del principio di
eguaglianza formale.
A partire dall'Ottocento, forti limiti al lavoro delle donne sono stati posti tramite una normativa diretta a scoraggiarne ed
emarginarne l'impiego, sia pur con intenti formalmente protettivi. Solo nel 1977 la L. n. 903 ha stabilito parità tra donne
e uomini, tenendo conto di tutti i profili del rapporto di lavoro, sia privato che pubblico, dalla sua costituzione alla sua
estinzione.
La L.903/1977 vieta ogni discriminazione per sesso nell’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di
assunzione e del settore di attività, nonché nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale. La legge
vieta esplicitamente anche ogni discriminazione fra uomini e donne nell'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e
nella progressione di carriera. Quest'ultima, è del resto, l'area di più frequente discriminazione a carico delle donne.
La L. n. 903/1977, modificando l'art. 15 St. lav. , dichiara nullo ogni patto o atto che rechi in qualche modo pregiudizio
alle lavoratrici o al lavoratore a causa del sesso ed estende il divieto ai patti o atti discriminatori per motivi politici,
religiosi, razziali e di lingua.
A presidio del divieto di discriminazione, la L. 903\1977 introduce un procedimento speciale, strutturato sulla falsariga
di quello dell’art. 28 St. lav. Sicché, qualora vengano posti in essere comportamenti discriminatori, il lavoratore, o, per
sua delega, le OO.SS., nonché, come vedremo, i consiglieri di parità, potranno ricorrere al giudice al fine di ottenere in
via d’urgenza un decreto immediatamente esecutivo, contenente l’ordine di cessazione del comportamento e di
rimozione degli effetti.
La L. n. 903/1977 si preoccupa di ribadire la parità di retribuzione per prestazioni uguali p di eguale valore tra
lavoratori e lavoratrici. Inoltre i sistemi di classificazione del lavoro devono basarsi su criteri comuni per uomini e
donne. Se ne desume l'illegittimità di quelle distinzioni fra lavori tipicamente maschili e lavori tipicamente femminili,
frutto della “segregazione occupazionale”.
L'applicazione dei principi e degli strumenti di tutela giudiziaria della L. n. 903/1977 è risultata insoddisfacente nella
prassi, per la scarsa efficacia preventiva e punitiva di questi ultimi: proprio questa mancanza di risultato è stato uno dei
motivi dell'approvazione, dopo un lungo dibattito, della L. n. 125/1991.
5. Pari opportunità e azioni positive nella L. n. 125/1991.
La L.125/1991 , poi modificata dal D.lgs. 196/2000, ha un duplice obbiettivo: a) rimediare alle debolezze della L. n.
903/1977; b) porsi in un’ottica di uguaglianza sostanziale, cioè di promozione delle pari opportunità.
La L. n. 125/1991 provvede ad una definizione esplicita delle discriminazioni per ragioni di sesso, distinguendole tra
dirette ed indirette. Dirette sono tutte le discriminazioni operanti sul piani individuale, cioè quei trattamenti differenziati
, basati su condizioni soggettive, non ragionevoli ex. Art. 3 Costituzione. La L. n. 125/1991 definisce la discriminazione
sessuale diretta come “qualsiasi atto, patto o comportamento che produce un effetto pregiudizievole discriminando
anche in via indiretta le lavoratrici e i lavoratori in ragione del loro sesso.
La discriminazione indiretta è invece più sottile e complessa poiché passa dal piano individuale a quello collettivo. La
L. n. 125/1991 definisce discriminazione sessuale indiretta qualsiasi comportamento pregiudizievole, a prescindere
dall'intento discriminatorio, conseguente all'adozione di criteri formalmente neutri ed eguali fra soggetti, ma che
svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori di un sesso senza giustificazione alcuna, in quanto non
essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Per effetto della trasposizione nel nostro ordinamento della direttiva n. 2002/73/Ce, che ha modificato la precedente
direttiva n. 76/2007/CE, la discriminazione indiretta per ragioni di sesso, è in procinto di essere novellata e allineata alle
nuove nozioni di discriminazione indiretta per ragioni di razza od origine etnica, nonché di religione, convinzioni
personali, handicap, età e orientamento sessuale, con una progressiva omogeneità per ciascuno dei tre ambiti
considerati: discriminazioni di sesso, di razza od origine etnica e altre discriminazioni.
La ratio promozionale delle pari opportunità, propria della L. 125\1991, trova la sua massima espressione nel
riconoscimento delle azioni positive. Le direttive di parità formale fin qui esaminate, infatti, si sono rivelate insufficienti
a risolvere il problema della eguaglianza nel lavoro. Le situazioni di svantaggio infatti, non sono necessariamente il
risultato di atti discriminatori intenzionali e specifici, bensì spesso risentono di condizionamenti strutturali radicati.
Simili condizionamenti sono superabili solo attraverso azioni positive (azioni promozionali ed incentivi), dirette ad
attuare l’eguaglianza sostanziale.
Tali azioni positive sono dunque quelle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione delle pari opportunità fra lavoratori e lavoratrici. Esse sono uno strumento di diritto diseguale, che tuttavia
non contrasta con l’art. 3 Cost., essendo di natura transitoria. Si tratta infatti di deviazioni dall’eguaglianza formale
legittimate dal perseguimento dell’eguaglianza sostanziale.
L'attuazione di azioni positive a favore delle donne è affidata a diversi organi promotori. La L. n. 125/1991 li elenca in
modo tassativo, comprendendovi sia soggetti istituzionali (il comitato ed i consiglieri di parità), sia soggetti privati
(sindacati e datori di lavoro). La legge contiene, inoltre, una cospicua strumentazione sanzionatoria, giudiziale ed
istituzionale, orientata a riparare alla scarsa effettività della tradizionale normativa antidiscriminatoria.
Il D.lgs. n. 196/2000 disciplina le cosiddette istituzioni della parità:
-il comitato nazionale della parità (CNP) è istituito presso il Ministero del lavoro con il fine di promuovere la rimozione
dei comportamenti discriminatori che limitano di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro, nella
progressione professionale e di carriera. Il CNP si caratterizza per funzioni propositive e consultive, la cui effettività,
però, è più che mai affidata alla qualità ed autorevolezza dei suoi componenti, nonché all'efficienza delle strutture di
supporto. Per superare questi limiti il legislatore ha recentemente stabilito che il CNP formuli annualmente un
programma-obbiettivo con l'indicazione delle tipologie di progetti di azioni positive da promuovere, i soggetti ammessi
e i relativi criteri di valutazione.
-la scelta del legislatore è stata nel senso di potenziare le consigliere e i consiglieri di parità, nominati a tutti i livelli di
governo con funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non
discriminazione. Sono pubblici ufficiali con l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui vengono a
conoscenza.
La storia della “burocrazia di parità” si intreccia con la tutela giurisdizionale delle lavoratrici o dei lavoratori
discriminati. La L. n. 125/1991 affianca all'azione individuale in giudizio, un'azione istituzionale in giudizio,
promuovibile dal consigliere di parità competente per territorio autonomamente, quando le pratiche discriminatorie
abbiano rilevanza collettiva o su delega del soggetto discriminato. Nell'ipotesi di azione su delega del soggetto
discriminato, l'azione può condurre solo ad effetti limitati alla situazione individuale, mentre il giudizio instaurato sulla
base dell'azione istituzionale autonoma conduce, coerentemente al carattere collettivo della discriminazione impugnata,
ad un ordine di definizione di un piano collettivo di rimozione degli effetti discriminatori.
Un ulteriore innovazione rilevante della suddetta legge, riguarda la cosiddetta inversione parziale dell'onere della prova
nel giudizio in tema di discriminazione. Quando il soggetto ricorrente (lavoratore o lavoratrice) fornisce elementi di
fatto idonei a fondare, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso
spetta al convenuto (datore di lavoro) l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.
6. La tutela contro le discriminazioni per ragioni di razza o di origine etnica e le altre discriminazioni.
Con i D.lgs. 215 e 216 del 9 luglio 2003 si è data attuazione nel nostro Paese alle direttive n 2003/43/CE (parità di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e n. 200/78/CE( parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro). Quest'ultima è conosciuta anche come direttiva “altre
discriminazioni” poiché si fa carico di assicurare un'adeguata tutela contro le discriminazioni per motivi connessi alla
religione, convinzioni personali, agli handicap, all'età e all'orientamento sessuale: si tratta di un ambito residuale
rispetto a quello delle discriminazioni per ragioni di sesso, di razza od origine etnica, già oggetto di disciplina
comunitaria.
Un importante precedente dei D.lgs. 215 e 216 del 9 luglio 2003 è rappresentato nel nostro ordinamento dal Testo
Unico sull'immigrazione (D.lgs. n. 286/1998)
entrambi i decreti legge in questione contengono una propria peculiare definizione di discriminazione diretta ed
indiretta per razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, agli handicap, all'età e all'orientamento sessuale:
-si ha discriminazione diretta quando in ragione di tali motivi una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia
, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra in una situazione analoga.
-la discriminazione indiretta ricorre quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto un patto o un
comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica, di una
determinata religione o ideologia di altra natura o i soggetti portatori di handicap, o di una particolare età, o di un
orientamento sessuale, in una situazione di particolare svantaggio rispetto alle altre persone.
A seguito dei decreti in esame anche l'ordine di discriminare rientra nell'area delle discriminazioni vietate. Lo stesso
deve dirsi per le molestie, ovvero qualsiasi comportamento indesiderato, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità
delle persone e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. La nozione, nel suo
riferimento a comportamenti lesivi della dignità personale, ricomprende le condotte di mobbing.
Sul piano processuale il soggetto discriminato ha innanzitutto la possibilità di ricorrere al giudice per vedere dichiarata
la nullità dell'atto discriminatorio ai sensi dell'art. 15 St. lav. , come modificato dal D.lgs. n. 216.
per il resto, la tutela giurisdizionale prevista dai decreti in esame, ricalca il procedimento speciale già contemplato dal
testo unico sull'immigrazione, che sul punto viene esplicitamente richiamato. Al fine di dimostrare la sussistenza del
comportamento discriminatorio, la vittima può dedurre in giudizio elementi elementi di fatto anche sulla base di dati
statistici. Non è, invece riconosciuta l'inversione parziale dell'onere della prova. Il giudice, con l'accoglimento del
ricorso, ha il potere di ordinare la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti, nonché di provvedere, su
richiesta, al risarcimento del danno anche non patrimoniale.
Il potere di controllo.
I limiti al potere di vigilanza: controlli nell'attività e visite personali.
La disciplina statuaria impone limiti specifici al potere di vigilanza del datore di lavoro sull'attività lavorativa.
Gli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori si rivolgono al personale di vigilanza in senso lato (guardie giurate). Tali
norme mirano, non ad abolire la funzione di vigilanza, ma piuttosto a privarla degli aspetti polizieschi e di controllo
occulto, talora storicamente assunti con la costituzione di vere e proprie polizie interne, utilizzate per finalità di
controllo disciplinare o anche antisindacale.
L’art. 4 si occupa dei controlli esercitabili dal datore di lavoro, stabilendo che essi non possono realizzarsi mediante
impianti audiovisivi (telecamere a circuito chiuso) o altre apparecchiature atte a sorvegliare a distanza l’attività dei
lavoratori. Controlli a distanza possono giustificarsi soltanto se richiesti per esigenze organizzative, produttive o
attinenti alla sicurezza del lavoro, cosicché il controllo sul lavoro ne sia al più una conseguenza accidentale. Per
rafforzare l'effettività dell'art. 4 è prevista una garanzia procedurale a vari livelli: sindacale, amministrativo e, in ultima
istanza, giudiziale. Le apparecchiature di controllo suddette sono installabili solo previo accordo con tutte le RSA o, in
mancanza, con la commissione interna.
In difetto d'accordo con le rappresentanze sindacali, il datore di lavoro può ricorrere alla Direzione del Lavoro-Servizi
Ispettivi, che decide le modalità d'uso degli impianti o ne esclude l'installazione. Contro tale provvedimento è dato
ricorso al Ministro del Lavoro
Principi simili a quelli dell'art 4 sono stabiliti dall'art. 6 Statuto dei lavoratori, che regola le visite personali di controllo
sul lavoratore. L’art. 6 pone il divieto delle visite personali di controllo (perquisizioni) sulla persona del lavoratore e
sulle sue pertinenze (borse, etc.), salvo quelle che risultino indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale. Ed
anche in tal caso, le visite personali di controllo devono svolgersi secondo precise modalità volte salvaguardare la
dignità e la riservatezza del perquisito (esse sono effettuabili solo all’uscita dei luoghi di lavoro e con sistemi di
selezione automatica o a sorte dei soggetti con un metodo cosiddetto imparziale).
L’art. 5 limita il potere di controllo dell’imprenditore nei confronti del lavoratore assente dal lavoro per infermità o
infortunio. Più precisamente vieta la prassi dei controlli diretti tramite i c.d. medici di fabbrica (nominati e pagati dal
datore) e affida l’accertamento ai servizi ispettivi degli istituti competenti (l’inail per gli infortuni, l’asl per le malattie).
Questi sono tenuti a compierlo quando il datore lo richieda, nel rispetto delle cosiddette fasce orarie di reperibilità. La
ratio della norma è quella di garantire l’imparzialità del controllo sullo stato di salute.
Il 3° comma dell'art. 5 St. lav. riserva ad enti pubblici anche il controllo sull'idoneità fisica del lavoratore, vale a dire
sulla capacità di proseguire il rapporto di lavoro.
2. Il divieto di indagine sulle opinioni e la tutela della privacy.
L’art. 8 infine vieta al datore di effettuare indagini (anche tramite terzi), ai fini dell'assunzione e nel corso del rapporto,
sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su tutti i fatti non rilevanti ai fini della valutazione
della attitudine professionale di questo.
Nel complesso l’art. 8 indica una tendenza alla spersonalizzazione del rapporto di lavoro -cioè l’irrilevanza di fatti e
comportamenti personali-estranei allo svolgimento corretto delle prestazioni dedotte nel rapporto.
Tuttavia la norma appare, come l'art. 4 St. lav., inadeguata a proteggere il lavoratore dalle informazioni che sul suo
conto possano essere legittimamente raccolte ed elaborate. Anche su questo punto, un'adeguata tutela della riservatezza
del lavoratore è realizzabile non tanto con divieti rigidi ed isolati, quanto un controllo procedimentale sulle
informazioni, al fine di impedirne usi impropri. Nel nostro ordinamento è assente, a riguardo, una normativa settoriale
completa, ma la materia è ricompresa nell’ambito della disciplina generale di tutela della privacy: il riferimento è stato
la L. n. 675/1996, poi sostituita dal D.lgs. 196/2003 denominato Codice in materia di protezione dei dati personali.
Quest'ultimo a differenza della L. n. 675/1996 perviene ad un'unificazione delle regole riguardanti il trattamento e la
comunicazione dei dati, così mirando ad una semplificazione delle regole sul punto. Permane, invece, la
differenziazione tra settore privato e settore pubblico (per cui è stabilita una disciplina speciale).
Le regole appaiono diverse per:
-i dati ordinari o comuni cioè tutti quei dati che non sono sensibili o giudiziari. Il loro trattamento è ammesso solo con il
consenso espresso dell'interessato, salvo tassative eccezioni tra cui i trattamenti svolti per la gestione del rapporto di
lavoro.
-i dati sensibili sono quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni
politiche, l'adesione ai partiti, ai sindacati, lo stato di salute o la vita sessuale dell'individuo.
-i dati giudiziari sono invece quelli idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di indagato o
imputato.
Queste ultime due tipologie di dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
La duplice regola generale (consenso e autorizzazione) conosce tuttavia eccezioni e temperamenti. Esistono infatti
numerose ipotesi in cui il trattamento è ammesso anche senza consenso, sulla base della sola autorizzazione del
Garante. In forza di ciò, il datore di lavoro potrà trattare la gran parte dei dati sensibili attinenti ai propri lavoratori senza
ottenere il preventivo consenso. L'autorizzazione del Garante può essere, poi, rilasciata anche con riferimento a
determinate categorie di titolari o di trattamenti (c.d. autorizzazioni generali).
Il garante ha adottato alcuni provvedimenti con cui ha esonerato dall'obbligo della richiesta di autorizzazione in una
serie di occasioni tra cui l'adempimento di obblighi o compiti previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi o dalla
normativa comunitaria, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, dell'applicazione della normativa in tema di
assistenza e di previdenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il lavoratore ha diritto di accedere ai dati personali, nonché di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione,
la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco, se trattati in violazione della legge.
Codice di deontologia e di buona condotta, la cui sottoscrizione è promossa dal Garante, con la possibilità di prevedere,
tra l'altro, specifiche modalità di informativa all'interessato e di eventuale prestazione del consenso relativamente alla
pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione, nonché alla ricezione di curricula contenenti dati personali,
incluso quelli sensibili. Il codice mantiene fermo quanto disposto dagli artt. 4 e 8 St. lav: dunque la disciplina sulla
privacy si conferma quale regolamentazione aggiuntiva rispetto a quella settoriale di limitazione del potere di controllo
del datore e impone una lettura integrata dei due sistemi normativi (legge sulla privacy e Statuto dei lavoratori).
Alla luce della normativa sulla privacy e di quella statuaria (St. lav.) va risolto anche il problema della legittimità di
controlli tecnologici sulle comunicazioni telefoniche del lavoratore, nonché sull'utilizzo da parte di questi del computer
aziendale, della posta elettronica e di internet.
Nel caso in cui un dipendente abbia effettuato conversazioni private con il telefono aziendale, è stato considerato
legittimo il licenziamento, nonché la registrazione ad opera del datore di lavoro dei numeri telefonici chiamati, anche in
assenza della procedura determinata dall'art 4 St. lav. Ciò sul presupposto che tale norma si occuperebbe della sola
vigilanza sull'attività lavorativa, non invece dei controlli sulle condotte illecite del prestatore di lavoro (c.d. Controlli
difensivi).
Un'attenzione ancora maggiore suscitano le questioni legate alla vigilanza sull'uso di apparecchiature elettroniche da
parte del personale, ad esempio il computer aziendale. Secondo il Garante, la posta elettronica andrebbe protetta alla
stregua della corrispondenza epistolare o telefonica, con conseguente piena applicabilità della normativa penale, che
protegge le comunicazioni personali di tal fatta (art. 616 ss. c.p.). La giurisprudenza ha però escluso gli estremi del
suddetto reato nella condotta del datore che, all'insaputa del lavoratore, ne aveva controllato la posta elettronica e ciò
proprio in ragione della natura non privata, bensì aziendale dell'indirizzo e-mail.
Problemi analoghi ha sollevato il controllo sulla navigazione in internet del lavoratore. L'estrema delicatezza della
materia, suscettibile di implicazioni anche con riguardo all'art. 8 St. lav., suggerisce l'intervento di una disciplina ad hoc,
allo stato assente nell'ordinamento. Il Garante ha rammentato che la miglior tutela della riservatezza delle
comunicazioni personali si realizza con la previsione delle condotte illecite del personale, mentre il controllo ex post
assume carattere di extrema ratio.
Il potere disciplinare.
1. Il fondamento del potere disciplinare.
Il potere disciplinare indica la facoltà del datore di irrogare sanzioni al lavoratore che venga meno ai suoi doveri
contrattuali. Il riconoscimento unilaterale al datore di lavoro di un potere punitivo, costituisce sicuramente un’anomalia
sul piano dei rapporti contrattuali, ispirati tendenzialmente ad una logica paritaria ed egualitaria. Si è dunque tentato di
trovare un fondamento a tale potere disciplinare, così da giustificarlo anche in un’ottica quale quella contrattuale.
Taluni hanno ricondotto tale potere alla subordinazione del prestatore di lavoro. Altri hanno ricondotto tale potere
all’area delle c.d. pene private convenzionali (le clausole penali). Altri ancora hanno negato il fondamento contrattuale
di tale potere e ne hanno individuato la matrice direttamente nell’organizzazione del lavoro (ossia nel potere direttivo
del datore) oppure nella contrattazione collettiva.
Con l’emanazione dell’art. 7 St. lav., il potere disciplinare viene ricondotto alla funzione organizzatoria del contratto di
lavoro. Sempre l’art. 7 poi, unitamente all’art. 2106 c.c., provvede a sottoporre il potere disciplinare del datore a precise
forme di esercizio e di controllo, al fine di renderlo compatibile con la logica egualitaria del contratto.
A tal fine sono stati individuati requisiti sostanziali e procedimentali per l’esercizio di tale potere. Si tratta di
presupposti che condizionano l’esercizio del potere disciplinare e la cui mancanza determina la nullità della sanzione.
2. I requisiti sostanziali.
Presupposto sostanziale del potere disciplinare è anzitutto la sussistenza del fatto addebitato che spetta al datore di
lavoro provare. Sul lavoratore grava invece l’onere di provare l’eventuale riconducibilità del fatto addebitato a causa
non imputabile a lui.
È necessario che vi sia proporzionalità fra infrazione e sanzione. La tipologia legale delle sanzioni contempla il
richiamo verbale, l’ammonizione scritta, la multa per un massimo di 4 ore e la sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione per un massimo di 10 giorni, nonché il licenziamento disciplinare. Tale tipologia esaurisce in pratica l’area
delle sanzioni irrogabili. Infatti provvedimenti attinenti alla normale gestione del rapporto di lavoro (trasferimento,
mutamento di mansioni, ecc.) non sono utilizzabili quali sanzioni, con una distorsione della loro funzione naturale.
Tale limite peraltro è rafforzato dall’art. 7, il quale stabilisce che non possono essere disposte sanzioni disciplinari che
comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro (salvo il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo).
Sulla relazione di proporzionalità influisce (in termini di un aggravamento della sanzione) l’eventuale recidiva.
Tuttavia lo statuto pone a ciò un limite, stabilendo che non può tenersi conto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni
dalla loro applicazione (circoscrivendo così il possibile utilizzo dell’aggravante entro limiti temporali).
3. I requisiti procedimentali.
Anche i requisiti procedimentali, come quelli sostanziali, sono presupposti del potere disciplinare, sicché la loro assenza
si traduce nell’inesistenza del potere, e, conseguentemente, nella nullità della sanzione.
Preesistenza del codice disciplinare
È necessaria la preesistenza di un testo che, oltre alle procedure di contestazione, individui le infrazioni e le relative
sanzioni, in modo che non si abbia la creazione ex post delle une e delle altre.
Va precisato tuttavia che il codice non deve contenere una precisa e sistematica previsione di tutte le singole infrazioni e
delle relative sanzioni, alla stregua dei precetti penalistici del nullum crimen sine lege, essendo sufficiente una
proporzionata correlazione tra le singole ipotesi di infrazioni, sia pure di carattere schematico, e le corrispondenti
previsioni sanzionatorie, anche se suscettibili di discrezionale adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze
del lavoratore.
Certo la funzione garantista della norma può essere svuotata attraverso clausole la cui indeterminatezza consenta nella
sostanza la creazione ex post del precetto da parte del datore di lavoro. Ma d’altronde un’analitica elencazione di tutti i
possibili comportamenti vietati è impensabile ed altrettanto impensabile è una correlazione tra infrazione e sanzione che
non presenti ragionevoli margini di elasticità.
Pubblicità del codice
L’art. 7 impone che il codice disciplinare venga portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo
accessibile a tutti. In caso di licenziamento disciplinare, tuttavia, l’affissione costituisce formalità necessaria solo
quando al lavoratore vengano contestate violazioni di doveri che discendono da disposizioni del datore di lavoro o del
contratto collettivo, non quando si tratti di violazioni di doveri che derivano dalla legge.
La contestazione dell’addebito
A garanzia del contraddittorio, il datore non può irrogare la sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il datore di lavoro, dopo la contestazione dell’addebito, è tenuto
a sentire oralmente il lavoratore che ne faccia richiesta e a ricevere le sue eventuali difese scritte (il lavoratore ha anche
facoltà di farsi assistere da un rappresentante sindacale).
L’addebito deve essere contestato con immediatezza (tra la conoscenza del fatto e la sua contestazione non può
trascorrere più del tempo ragionevolmente necessario al datore per fare un minimo di accertamenti ed assumere la
decisione di dare inizio al procedimento disciplinare) e specificità (deve individuare i fatti con sufficiente precisione, sì
da consentire al lavoratore di rendere le giustificazioni del caso).
I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5
giorni dalla contestazione per iscritto dell’addebito. Tale periodo, secondo la cassazione, non va considerato come una
pausa di riflessione per il datore (in modo che non prenda decisione avventate), ma piuttosto come un lasso di tempo
necessario al lavoratore per approntare le proprie difese, sicché l’attesa non si giustifica più allorché tali difese siano
state già presentate.
L’art. 7 non prevede alcun obbligo di motivazione del provvedimento per il datore. Tuttavia, qualora il codice
disciplinare o il contratto collettivo prevedano l’obbligo del datore di motivare la sanzione, l’inosservanza di tale
obbligo comporterà la nullità del provvedimento disciplinare.
Contro il provvedimento disciplinare, il lavoratore può, oltre alla normale ricorso giudiziario, avviare una procedura
arbitrale presso la Direzione provinciale del lavoro. Si tratta di un rimedio speciale, previsto dall’art. 7, che da facoltà al
lavoratore di chiedere entro 20 giorni la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato. Tale collegio, ove non
riesca a comporre la controversia, è tenuto a pronunciarsi sulla sua legittimità ed anche a determinare l’entità della
sanzione. La scelta della via arbitrale è incentivata, giacché la sua attivazione comporta la sospensione della sanzione
fino alla pronuncia sulla controversia.
I doveri del datore di lavoro.
1. L'obbligo di sicurezza e l'art. 2087 cod. civ.
L'ambiente di lavoro comprende non solo il contesto materiale di svolgimento della prestazione, ma anche l'insieme
delle condizioni dell'organizzazione del lavoro.
L'art 2087 c.c. vincola il datore ad un obbligo di sicurezza nei confronti dei lavoratori, imponendogli di adottare tutte le
misure atte a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Il suddetto articolo specifica una
serie di norme regolamentari sulla prevenzione degli infortuni e e per l'igiene del lavoro (D.P.R. n. 547 del 1955; D.P.R.
nn. 302 e 303 del 1956), nonché norme speciali che limitano l'orario di lavoro dei minori e delle donne in gravidanza.
Inoltre tale articolo impone al datore di predisporre tutte le misure idonee, secondo l'esperienza, la tecnica e la
particolarità del lavoro, a prevenire situazioni di danno della salute fisica e la personalità del lavoratore alla luce della
mutevole realtà produttiva (c.d. principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile).
La debolezza dell'effettività dell'art. 2087 è dovuta ad una disparità di poteri delle parti. Esso è invocato per lo più per
ottenere il risarcimento dei danni dovuti a infortuni o lesioni già verificatisi, mentre non ha avuto rilievo nella sua
funzione preventiva. La tutela delle condizioni di lavoro è stata inoltre pregiudicata dalla endemica debolezza della
presenza sindacale in azienda e da una contrattazione più incline a monetizzare i rischi dell'ambiente che a intervenire
per migliorarlo.
2. (Segue): dall'art. 9 dello Statuto dei lavoratori al D.lgs. n. 626 del 1994 e successive modifiche.
L'art. 9 St. lav. attribuisce ai lavoratori il diritto di controllare “mediante loro rappresentanze” l'applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Il D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, nell'attuare la disciplina comunitaria, regolamenta ex novo la materia con ambizioni
sistematiche e di completezza in ordine alla salvaguardia della sicurezza del lavoro. Il sistema risulta ora imperniato sul
principio della prevenzione, da realizzarsi tramite una propedeutica valutazione di tutti i rischi presenti in azienda.
L'obbiettivo è di eliminarli alla fonte, ove possibile o comunque di ridurli al minimo, mediante un'attività di
programmazione degli interventi. È il cd. Modello partecipato della sicurezza: accanto al datore di lavoro, ai dirigenti e
ai preposti, nonché agli organismi pubblici di controllo (ASL e Direzione del Lavoro- Servizi Ispettivi), già presenti, il
legislatore introduce nuovi soggetti: il servizio di prevenzione e protezione e il suo responsabile; il medico competente;
i lavoratori; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Ciascuno, in relazione alle proprie responsabilità, è
chiamato a dare attuazione al principio generale di prevenzione. Tuttavia, il datore di lavoro resta il principale
responsabile in materia di sicurezza.
L'obbligo di sicurezza a carico del datore viene scomposto in una serie di specifici adempimenti svolti in collaborazione
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza:
-il primo consiste nelle c.d. valutazione dei rischi.
-il secondo è rappresentato dalla redazione del c.d. documento per la sicurezza contenente: 1)una relazione sulla
valutazione dei rischi; 2)l'individuazione delle misure di prevenzione; 3)le modalità ed i tempi per la realizzazione del
programma di sicurezza.
L'introduzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il segno dell'accoglimento di istanze partecipative nel
nostro sistema di relazioni collettive. Il rappresentante viene consultato oltre che nei casi appena detti, in merito alla
designazione degli addetti al servizio di prevenzione ed all'organizzazione della formazione dei lavoratori. Egli riceve
tutte le informazioni in materia, elabora proposte ecc. Deve essere eletto o designato dai lavoratori in tutte le aziende o
unità produttive. Le sue funzioni sono prevalentemente tecniche a differenza di quelle attribuite alle RSA o RSU.
I dipendenti devono contribuire con il datore all'adempimento degli obblighi in tema di tutela della salute (c.d. principio
del coinvolgimento del lavoratore), ubbidendo alle direttive generali loro impartite in materia, utilizzando correttamente
i macchinari; sottoponendosi alla formazione; segnalando le carenze. Essi hanno, in ogni caso, diritto ad allontanarsi dal
posto di lavoro in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile. La violazione degli obblighi da parte del lavoratore
viene sanzionata (anche penalmente). Si è assistito inoltre all'estensione dell'obbligo di sicurezza anche ai contratti di
lavoro flessibili e di somministrazione, nonché ai contratti in cui ci si avvale di lavoratori autonomi.
3. L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
A tutela dei lavoratori contro i rischi inerenti all'ambiente di lavoro, è finalizzato il sistema delle assicurazioni sociali
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, attualmente gestito dall'INAIL.
Il D.lgs. n. 38 del 2000 ha esteso l'obbligo assicurativo ai lavoratori parasubordinati, oltre che ai lavoratori dell'area
dirigenziale, agli sportivi professionisti, ai lavoratori italiani operanti in paesi extracomunitari. Inoltre la novella ha
ricompreso le ipotesi di infortunio c.d. “in itinere” (cioè subito dal lavoratore nel recarsi sul luogo di lavoro o fra due
diversi luoghi di lavoro o nel normale tragitto di andata e ritorno rispetto al luogo ove il lavoratore consuma il pasto, in
assenza di un servizio di mensa aziendale).
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il danno risarcibile ha coinciso per lungo tempo con il solo
danno patrimoniale, legato alla perdita della capacità lavorativa (oltre all'eventuale danno morale ex art. 2059 c.c.).
Più recentemente la giurisprudenza è giunta a riconoscere l'esistenza e la risarcibilità del c.d. danno biologico, inteso
come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata. Quello biologico è un danno
(propriamente non patrimoniale e non morale) alla persona del lavoratore, che scaturisce dalla violazione del diritto alla
salute da lui subita (risarcibilità ai sensi dell'art. 2087 c.c.).
Il D.lgs. n. 38/2000 ha disposto la copertura del danno biologico, definito dal legislatore come lesione all'integrità
psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. La sua liquidazione avviene sulla base di un
apposita tabella approvata con Decreto del Ministro del lavoro (D.M. 12 luglio 2000).
4. Il danno alla persona del lavoratore.
Al di là del danno biologico vi sono ulteriori pregiudizi alla persona del lavoratore, di cui i giudici ormai sostengono la
risarcibilità, imputandoli al datore di lavoro a titolo di responsabilità contrattuale, sulla scorta dell'art. 2087 c.c, che
protegge anche la personalità morale, oltre all'integrità fisica, del lavoratore. Si tratta di menomazioni alla dignità
personale, connesse ad eventi diversi (demansionamento, soppressione del riposo settimanale, molestie sessuali,
mobbing).
Il danno per demansionamento, il danno da usura psicofisica per frazionamento o soppressione del riposo settimanale, il
danno da molestie sessuali e il danno da mobbing sono figure ricomprese nella figura del danno esistenziale, volto a
ristorare qualsiasi pregiudizio alle attività realizzatrici della persona. La dottrina è preoccupata dalla tendenza
all'eccessiva e confusa moltiplicazione delle fattispecie di danno alla persona risarcibili (danno morale, biologico,
esistenziale).
5.Gli obblighi di informazione del datore.
Un'importanza crescente l'hanno avuta gli obblighi di informazione a carico dell'imprenditore. L'art. 27 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, ora art. II-87 della Costituzione europea ha riconosciuto un diritto di
informazione e di consultazione nell'impresa a favore dei lavoratori i dei loro rappresentanti nei casi previsti dal diritto
comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Obblighi di informazione a favore del lavoratore sono soprattutto previsti dal D.lgs. n. 152/1997. Il decreto, di
attuazione della direttiva n. 91/533/CE, pone a carico del datore un obbligo di informare il lavoratore delle condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro: luogo, orario, mansioni, durata del preavviso ecc.
Obblighi ulteriori di informazione in capo al datore sono disposti dalla disciplina contrattuale nei cfr. talora del
lavoratore singolo e più spesso delle rappresentanze aziendali. Questi obblighi riguardano non solo informazioni
attinenti allo svolgimento dei rapporti di lavoro, ma anche notizie sulla gestione complessiva dell'impresa.
6.La cooperazione del datore all'adempimento.
La cooperazione del datore di lavoro è necessaria per l'adempimento della prestazione da parte del lavoratore. Questa
posizione del datore è configurata come onere. Il rifiuto di ricevere una prestazione possibile, in capo al datore soltanto
delle conseguenze tipiche della mora credendi: risarcimento danni o risarcimento della retribuzione.
Un obbligo del datore di permettere lo svolgimento della prestazione è configurato solo in rapporti di lavoro
caratterizzati da un interesse specifico del lavoratore ad eseguire il proprio lavoro. Caso emblematico è l'apprendistato
nonché il lavoro in prova, in quanto l'effettiva prestazione rappresenta un'occasione di formazione e risulta necessaria
per valorizzare e mantenere la professionalità.
Di recente si è affermata l'esistenza in generale di un diritto del lavoratore a svolgere la prestazione e, quindi, di un
correlativo obbligo del datore di porre in essere le condizioni necessarie a permettere tale svolgimento. Il fondamento di
tale diritto è stato desunto dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori che riconosce e protegge la posizione professionale del
lavoratore. Un'analoga indicazione è stata desunta dall'art. 18 St. lav., il quale protegge l'interesse specifico del
lavoratore ingiustamente licenziato alla reintegrazione effettiva nel posto di lavoro e non solo alla retribuzione e alla
continuazione giuridica del rapporto.
Le possibilità del lavoratore di far valere tale diritto al lavoro, sono oltremodo precarie, perché incontrano le tradizionali
obiezioni circa la non eseguibilità in forma specifica di un obbligo infungibile del datore come quello di predisporre le
condizioni per lo svolgimento del lavoro (non solamente di far entrare il lavoratore in azienda). D'altra parte è difficile
per il lavoratore fornire la prova dei danni conseguenti al mancato impiego.
CAPITOLO OTTO: LA RETRIBUZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO: FONTI, NOZIONE, STRUTTURA.
1.Fonti individuali e collettive
Sul piano del rapporto individuale la retribuzione costituisce (artt. 2094 e 2099 c.c.) la prestazione fondamentale del
datore di lavoro nei confronti del lavoratore. L'obbligo retributivo connota così il contratto di lavoro come contratto
oneroso, di scambio o a prestazioni corrispettive.
Sul piano collettivo le retribuzioni costituiscono una quota cospicua del reddito nazionale e rappresentano uno
strumento decisivo per la sua distribuzione fra diversi gruppi e categorie sociali.
La disciplina della retribuzione, per quanto riguarda gli aspetti quantitativi nonché i modi ed i criteri di calcolo, è
fondamentalmente determinata dalla contrattazione collettiva, la quale si conferma per tali aspetti la fonte prioritaria di
disciplina de rapporto. All'autonomia individuale spetta un ruolo di miglioramento degli standard retributivi stabiliti in
sede collettiva.
La legislazione ordinaria ha svolto un ruolo contenuto, di disciplina di aspetti secondari dell'istituto (forme, modalità di
adempimento), fino ai provvedimenti sul costo del lavoro dal 1977 in poi, con i quali si è realizzato per la prima volta
un controllo eteronomo delle dinamiche retributive.
Una funzione storicamente di grande rilievo è stata esercitata dalle direttive costituzionali, in materia di retribuzione
proporzionata e sufficiente, per il tramite di una intensa opera di interpretazione giurisprudenziale. L'influenza della
giurisprudenza è stata considerevole anche nell'interpretazione della complessa disciplina contrattuale dei maggiori
profili dell'istituto. La materia retributiva esula dalle competenze comunitarie, salvo per quanto riguarda la parità fra
uomini e donne.
2.Corrispettività e principi costituzionali: a)sufficienza e proporzionalità. Il concetto giurisprudenziale di
retribuzione minima.
L’obbligo retributivo caratterizza il rapporto di lavoro come rapporto di scambio o a prestazioni corrispettive. La
retribuzione rappresenta la controprestazione del datore di lavoro.
Tuttavia, nel rapporto di lavoro, tale controprestazione è soggetta ad una disciplina particolare, non riscontrabile in altri
rapporti a prestazioni corrispettive. Infatti il nesso di corrispettività fra le prestazioni, così come disciplinato dai
contratti sinallagmatici, subisce delle alterazioni (tassativamente previste) in una serie di casi di sospensione del
rapporto di lavoro (malattia, infortunio, gravidanza, permessi sindacali, per motivi di studio, etc..); in tali ipotesi è fatto
obbligo al datore di adempiere (in tutto o in parte) all’obbligo retributivo nonostante l’assenza di controprestazione.
La determinazione quantitativa della retribuzione risulta soprattutto dalla contrattazione collettiva (la legge
generalmente si limita a disciplinare aspetti secondari dell’istituto della retribuzione, come le modalità d’adempimento;
mentre alla contrattazione individuale è solitamente affidato un ruolo di miglioramento degli standard retributivi stabiliti
in sede collettiva).
Ma la Costituzione contiene al riguardo precetti fondamentali. La norma di riferimento è l’art. 36, ove si sancisce che il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.
Il principio di sufficienza richiede un livello retributivo non solo correlato al minimo vitale, ma tale da permettere al
lavoratore e alla famiglia un tenore di vita dignitoso, secondo il contesto storico, sociale e ambientale.
Il principio di proporzionalità invece esplicita una correlazione della retribuzione con le mansioni svolte dal lavoratore e
con il tempo di lavoro.
È evidente come non vi sia omogeneità tra i due principi. La sufficienza impone di considerare elementi esterni al
contratto, cioè l’inadeguatezza della retribuzione rispetto alle condizioni soggettive del lavoratore. La proporzionalità
invece pone l’attenzione sull’equivalenza oggettiva dello scambio tra lavoro e retribuzione.
Tuttavia la giurisprudenza, che ha giocato un ruolo essenziale nell’interpretazione della norma, ha sostanzialmente
risolto l’antinomia a tutto vantaggio del secondo dei due principi, ritenendo in sostanza sempre e comunque rispettato il
canone della sufficienza sol che lo fosse quello di proporzionalità.
Infatti il giudice si limita a verificare se la retribuzione è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato,
ritenendo che il livello retributivo così individuato sia di per sé idoneo a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore
medio e della sua famiglia.
La giurisprudenza ha così estrapolato dall’art. 36 un principio unitario di retribuzione minima. Ma vediamo più nel
dettaglio il percorso giurisprudenziale.
Innanzitutto va detto che l’art. 36 è norma immediatamente precettiva; dunque il giudice può sindacare se la
retribuzione spettante al lavoratore sia conforme al dettato costituzionale. Ma quale livello retributivo può ritenersi
conforme ai canoni dell’art. 36? I giudici hanno fatto costante riferimento alla retribuzione base (i c.d. minimi tabellari)
prevista dai contratti collettivi di categoria o di settore, considerati quale parametro affidabile a prescindere dalla diretta
applicabilità del contratto (c.d. estensione indiretta del contratto collettivo).
Dunque le retribuzioni così individuate costituiscono il livello minimo vincolante per tutti i rapporti di lavoro di quella
categoria o di quel settore.
Da ciò discendono due conseguenze. La prima è che i canoni di sufficienza e proporzionalità non rivestono un valore
assoluto ed uniforme per tutte le categorie di lavoratori, ma variano in funzione del settore.
La seconda è la prevalenza assoluta del canone della proporzionalità su quello di sufficienza. Infatti i contratti collettivi
ricercano un equilibrio tra la prestazione di lavoro e la controprestazione retributiva in una data situazione di mercato,
senza occuparsi delle condizioni di vita del singolo lavoratore.
Se il contratto individuale non rispetta i canoni di sufficienza e proporzionalità, la relativa pattuizione deve ritenersi
nulla per violazione di norma imperativa. Anzi, secondo i principi sulla nullità parziale, trattandosi di nullità di clausola
essenziale, la conseguenza dovrebbe essere la nullità dell’intero contratto di lavoro.
Tuttavia secondo la giurisprudenza, in questo caso soccorre l’art. 2099 c.c., il quale stabilisce che, in mancanza di
norme contrattuali (collettive o individuali) la retribuzione è determinata dal giudice. Tale percorso però non sembra
condivisibile. L’art. 2099 infatti contempla l’ipotesi in cui una retribuzione non sia affatto concordata (attribuendo al
giudice il potere di colmare tale lacuna), mentre in tal caso una determinazione della retribuzione vi è stata, per quanto
travolta da nullità.
In realtà il procedimento seguito dalla giurisprudenza può giustificarsi in base all’art. 1339, in tema di prezzi o clausole
imposte, in base al quale, a fronte di un regolamento contrattuale difforme, la conseguenza non è la nullità totale del
contratto, ma la correzione del regolamento contrattuale alla stregua della regola normativa (nel caso in questione la
retribuzione individualmente concordata è sostituita dalla retribuzione minima legale risultante dall’art. 36 Cost.)
Quel che è eccezionale non è tanto il meccanismo di correzione del contratto, quanto il fatto di aver riconosciuto
efficacia erga omnes ai minimi retributivi individuati dalla contrattazione collettiva per ciascun settore o categoria.
Sicché anche i lavoratori dipendenti da imprese non aderenti alle associazioni imprenditoriali stipulanti (e quindi non
tenuti ex contractu a rispettare i minimi retributivi) possono richiedere l’applicazione delle tabelle collettive – che venga
loro negata dal datore di lavoro.
La funzione di supplenza giudiziaria così realizzata nella tutela minima delle retribuzioni è stata estremamente
importante, soprattutto in quei settori (lavoro a domicilio, piccole imprese, settori poco sindacalizzati) nei quali la
giurisprudenza sulla retribuzione costituisce l’unico elemento di protezione.
Infine i principi di sufficienza e proporzionalità retributiva escludono che nel rapporto di lavoro possano adottarsi forme
di retribuzione tali da non garantire un compenso al lavoratore, in quanto totalmente agganciate ad elementi incerti quali
gli utili o le provvigioni (tali forme retributive quindi potranno essere solo parziali).
3.b) Non discriminazione e parità retributiva.
Il dettato costituzionale, e in particolare i principi di eguaglianza e di non discriminazione, hanno spinto a sostenere
l’esistenza di un principio di parità retributiva, in base al quale, ai lavoratori, a parità di mansioni e anzianità,
spetterebbe un medesimo trattamento retributivo, senza possibilità per il datore di trattamenti differenziati.
Il principio di non discriminazione però, per la verità, si caratterizza in negativo, giacché inibisce trattamenti
differenziati (fra gruppi di lavoratori) per specifici motivi (sesso, età, religione, ecc.).
Il principio di eguaglianza invece, il quale dovrebbe importare in positivo una parificazione del trattamento retributivo
di lavoratori che ricoprano la stessa posizione professionale, non può in realtà configurare un principio generale di
parità retributiva nei rapporti inter-privati di lavoro; l’art. 3 Cost. infatti opera solamente nei rapporti con il potere
pubblico.
Né è possibile supportare il principio di parità retributiva con l’art. 36 Cost., il quale attiene all’equilibrio tra le
prestazioni del singolo rapporto di lavoro e non implica dunque un rapporto “orizzontale” di parità retributiva fra diversi
lavoratori che si trovino in situazioni analoghe (sicché un lavoratore non potrebbe rivendicare una retribuzione
maggiore sol perché altri lavoratori con analoghe qualifiche o mansioni godono di un trattamento più favorevole).
Anche la Corte Costituzionale si è espressa sull’argomento, richiamandosi alla normativa legale (art. 16 St. lav) ed
internazionale, la cui applicazione garantirebbe il diritto ad un’uguale retribuzione a parità di mansioni.
Tuttavia le conclusioni della Corte in merito all’effettiva sussistenza di un principio assoluto di parità retributiva non
sono chiare, giacché essa contestualmente ammette che sono tollerabili e possibili disparità di trattamento per lavoratori
in posizioni analoghe, qualora simili differenziazioni siano giustificate e comunque ragionevoli.
In definitiva si può ad oggi affermare l’inesistenza di un principio di parità retributiva del lavoratori a parità di
mansioni; gli unici limiti esistenti alla definizione del trattamento retributivo sono la garanzia del minimo retributivo e il
principio di non discriminazione. Un simile principio in effetti andrebbe a comprimere eccessivamente l’autonomia
individuale privata nella determinazione dei trattamenti retributivi e delle condizioni di lavoro.
Nozione di retribuzione
1. Il concetto di retribuzione. a)le definizioni legislative. b) la nozione giurisprudenziale onnicomprensiva. Critica.
Si è discusso se esista un concetto unitario di retribuzione o se piuttosto ne esistano molteplici, ognuno rilevante ad un
fine diverso. La discussione non è accademica e comporta importanti conseguenze, poiché l’individuazione di una
nozione onnicomprensiva di retribuzione consentirebbe di stabilire quali attribuzioni patrimoniali possano considerarsi
effettuate dal datore a titolo retributivo (a tutti gli effetti). E stabilire che un determinato apporto è dovuto dal datore a
titolo retributivo comporta due conseguenze:
-rende tale apporto non modificabile dal datore, né nell’ “an ne nel quantum”;
-fa si che tale apporto venga incluso nel calcolo di quegli istituti che fanno riferimento alla retribuzione come base di
computo (indennità di fine rapporto, contributi previdenziali, tredicesima, ecc.).
Ebbene, va in effetti detto che vi sono una pluralità di definizioni legislative di retribuzione.
Una delle più importanti è quella fornita dall’art. 2121 c.c., che individua gli elementi retributivi da computare nel
calcolo delle indennità di mancato preavviso; secondo tale definizione (alquanto ampia) devono essere inclusi nel
calcolo “tutti i compensi corrisposti al lavoratore aventi carattere continuativo, con esclusione delle sole prestazioni
erogate a titolo di rimborso spese”.
L’art. 2120 c.c., che disciplina il tfr da una diversa definizione di retribuzione da prendere a base di calcolo a tali fini;
“tutti gli emolumenti corrisposti dal datore in dipendenza del rapporto di lavoro e a titolo non occasionale”. La formula
“a titolo non occasionale” sembra ancora più ampia di quella di “compensi continuativi” data dall’art. 2121.
Ancora una diversa nozione di retribuzione viene poi data ai fini contributivi e fiscali; a tali fini vengono in
considerazione “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Tale varietà di forme retributive ha creato notevoli difficoltà alla giurisprudenza,la quale di conseguenza negli anni ’70
ha elaborato il c.d. concetto onnicomprensivo o unitario di retribuzione. Si sono dunque individuati alcuni caratteri
strutturali che sarebbero propri della retribuzione in modo constante:
-la determinatezza richiesta per definirne la quantità, in misura sia variabile che fissa.
-l’obbligatorietà, che escluderebbe le prestazioni eventuali rientranti nella discrezionalità o liberalità del datore;
-la corrispettività, nel senso non di corrispondenza con specifiche prestazioni di lavoro, ma di una generica
riconducibilità causale al rapporto di lavoro;
-la continuità, come corresponsione ricorrente nel tempo con carattere di regolarità, anche per compensi non configurati
ex ante come stabili, ma erogati di fatto in modo continuativo (es. il lavoro straordinario).
Tali caratteri sono stati utilizzati per ricomprendere nella retribuzione grosso modo tutti i compensi erogati dal datore in
dipendenza del rapporto di lavoro, con carattere necessario e ricorrente nel tempo, con la sola esclusione dei rimborsi
spese (onnicomprensività del concetto).
Gli obiettivi perseguiti dalla giurisprudenza con l’elaborazione del concetto onnicomprensivo di retribuzione sono due:
-stabilire se certe prestazioni del datore (qualificate a vario titolo come prestazioni assistenziali o gratifiche liberali)
dovessero ritenersi effettuate a titolo retributivo e dunque non modificabili nell’ an né nel quantum;
-identificare, attraverso i caratteri indicati nella nozione onnicomprensiva, quegli apporti che dovessero essere
considerati per il calcolo di quegli istituti che hanno la retribuzione come base di computo.
È questo il caso delle indennità di fine rapporto, dei contributi previdenziali, dei c.d. elementi differiti della retribuzione
(la tredicesima mensilità, la quattordicesima), delle maggiorazioni dovute per il lavoro straordinario.
L’elaborazione del concetto di onnicomprensività però ha portato ad ampliare enormemente la nozione di retribuzione.
Altro è infatti, ritenere che una determinata indennità è retributiva, nel senso che non è discrezionale ma dovuta dal
datore, altro è sostenere che per questo motivo essa vada computata in una serie di istituti che prendono la retribuzione
come parametro di riferimento.
Proprio in virtù di tali implicazioni, tale orientamento giurisprudenziale è stato oggetto di critiche, sia giuridiche, sia di
politica retributiva.
Sul versante giuridico si è osservato che il concetto onnicomprensivo non ha fondamento giuridico, in quanto è
costruito su caratteri eterogenei (stabiliti per finalità diverse) che non possono avere valore assoluto al di fuori delle
fattispecie per le quali sono stati elaborati. Ciascuna definizione di retribuzione non risponde ad una presunta
omogeneità strutturale, ma ad esigenze particolari legate a particolari situazioni. Sicché la determinazione di cosa sia
retribuzione va ricercata di volta in volta sulla base degli elementi strutturale e della ratio risultanti dalle fonti legali o
contrattuali che vengono in rilievo per il singolo istituto.
Un’altra critica è poi quella che concerne il pericoloso effetto moltiplicatorio che la nozione onnicomprensiva può avere
sulle dinamiche salariali. Ogni aumento di una singola voce retributiva si riflette (moltiplicando il suo peso) su tutti gli
istituti il cui computo è rapportato alla retribuzione (gratifiche, scatti, ecc).
Tali critiche hanno determinato la fine di tale orientamento giurisprudenziale ed hanno portato a disconoscere la
configurabilità di un concetto unitario di retribuzione.
Forme della retribuzione.
1.Tipologia legale.
Con l’espressione generica retribuzione si fa riferimento ad una complessa tipologia di attribuzioni patrimoniali cui è
obbligato il datore di lavoro nei confronti del lavoratore, regolate da fonti diverse (per lo più contrattuali) e che
presentano altresì forme e denominazioni diverse.
L’art. 2099 effettua un’elencazione di tali tipologie, individuando dunque varie forme retributive: retribuzione a tempo,
retribuzione a cottimo, partecipazione agli utili o ai prodotti, provvigione e retribuzione in natura.
La forma retributiva di gran lunga più usata è quella a tempo, cioè determinata in ragione del tempo della prestazione di
lavoro. Essa è l’unica forma adottata in maniera esclusiva. Le altre forme infatti possono costituire compensi parziali o
elementi della retribuzione, la quale mantiene sempre una parte fissa determinata a tempo, al fine di garantire al
lavoratore un minimo retribuito dovuto per il semplice fatto di aver prestato la propria attività lavorativa per un
determinato periodo di tempo.
La retribuzione a cottimo costituisce l’altra fondamentale forma di retribuzione. In essa si tiene conto non soltanto del
tempo impiegato ma anche del risultato, della produttività del lavoro e quindi del rendimento fornito dal lavoratore. Il
riferimento al risultato, concetto tipico del lavoro autonomo, può trarre in inganno. Esso infatti deriva da una
concezione dell’istituto radicata nella sua storia, ma non più attuale. Storicamente infatti, il cottimo è stato una forma
tipica di corrispettivo del lavoro autonomo. Tuttavia, lo sviluppo delle forme di lavoro a cottimo nella grande impresa
industriale hanno portato ad una rimeditazione dottrinale dell’istituto, che lo ha distinto dal contratto d’opera e acquisito
nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. A ben vedere infatti, nella determinazione della retribuzione a cottimo
rileva la quantità della prestazione, e quindi il rendimento, e non propriamente il risultato (il quale può dipendere anche
da fattori esterni all’attività del prestatore). Il risultato può essere preso in considerazione solo in quanto e allorché
identifichi in concreto l’attività svolta dal prestatore (altre volte invece il risultato non coincide con la quantità di attività
prestata). Ciò comporta che ogni qualvolta il risultato venga meno per fattori non attinenti alla prestazione del
lavoratore (difettosità della materia prima, guasto alle macchine) resta fermo il diritto alla retribuzione di cottimo
corrispondente al lavoro svolto o che si sarebbe potuto svolgere. Si possono distinguere varie forme di cottimo, in
dipendenza dell’unità presa a base di misurazione del rendimento e quindi del compenso: cottimo a forfait (in cui il
compenso è commisurato all’opera finita), cottimo a misura (in cui è commisurato alla quantità prodotta), cottimo a
tempo (si considera il tempo risparmiato rispetto al tempo standard). Si distinguono inoltre il cottimo individuale dal
cottimo collettivo, nel quale si considera il rendimento di un gruppo di lavoratori. La disciplina legislativa del cottimo è
contenuta in 2 sole norme (ormai di rilievo residuale, dato il ruolo preminente assunto dalla contrattazione collettiva).
L’art. 2100 prevede il c.d. cottimo obbligatorio, stabilendo che il lavoratore deve essere retribuito a cottimo nelle ipotesi
in cui, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato ad un certo ritmo produttivo (es. catena di
montaggio), oppure quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di
lavorazione (per cui si prestabiliscono i tempi standards e su tale base si fissa la retribuzione). Il cottimo obbligatorio è
inoltre previsto per il lavoro a domicilio. Qui la ragione va ricercata nelle particolari condizioni di espletamento del
lavoro, che si svolge fuori dall’impresa e non è quindi controllabile nel tempo impiegato ma solo quanto al risultato.
L’art. 2101 stabilisce alcuni principi generali in ordine alle procedure di fissazione della retribuzione a cottimo che
spettano all’imprenditore, ma con due ordini di limiti. Anzitutto la legge gli impone di comunicare preventivamente ai
lavoratori gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguire. Inoltre il datore può modificare tali
elementi solo nel caso in cui siano cambiate le condizioni di lavoro che li giustificano (ed il nuovo sistema di cottimo
diventa definitivo dopo un periodo di adattamento previsto dai contratti collettivi).
Un’altra forma di retribuzione prevista dall’art. 2099 è la retribuzione in natura, che è generalmente vista con sfavore e
addirittura bandita in certi Paesi per le forme di sfruttamento cui dava adito, addossando ai lavoratori il rischio della
trasformazione in denaro.
La provvigione è una forma di retribuzione agganciata agli affari trattati dal lavoratore nei casi in cui l’oggetto della
prestazione consista appunto nella trattazione di affari in nome e per conto del datore.
La partecipazione ai prodotti, usata per lo più nelle attività di lavoro agricolo e nella pesca come retribuzione parziale, è
una specie particolare di provvigione; qui però il prodotto non è l’affare ma il bene fisico oggetto dell’attività
d’impresa.
Un’altra forma di retribuzione è poi la partecipazione agli utili. A tal fine , salvo patto contrario vanno considerati gli
utili netti, e, per le imprese soggette a pubblicazione del bilancio, a quelli risultanti dal bilancio regolarmente approvato
e pubblicato. Questa forma di retribuzione comunque non fa venire meno il carattere di rapporto di lavoro subordinato;
mancando infatti, da parte del lavoratore una partecipazione alle perdite ed un’ingerenza nella gestione dell’impresa,
non si crea alcun rapporto associativo fra prestatore e datore.
2.La disciplina contrattuale della retribuzione. La proliferazione delle forme retributive.
La disciplina contrattuale poi conosce tutta una serie di istituti diversi da quelli finora accennati, oltremodo variabili.
Spesso le distinzioni sono solo nominalistiche, giustificate dalla volontà, spesso coincidente del sindacato e degli
imprenditori, di mascherare aumenti retributivi normali sotto altri nomi quali indennità o elementi accessori, magari per
eludere gli obblighi contributivi o inizialmente per conservare al datore margini di discrezionalità nella conservazione o
meno dei singoli compensi.
Una distinzione ricorrente è quella fra retribuzione diretta, cioè corrisposta immediatamente al lavoratore nei singoli
periodi di durata del rapporto, e retribuzione differita, cioè corrisposta in modo posticipato rispetto al periodo di
maturazione; annualmente (gratifica natalizia o tredicesima mensilità e la quattordicesima) o alla fine del rapporto (tfr).
Un altro termine ricorrente è quello di automatismi retributivi, usato per designare diversi istituti che comportano
incrementi automatici del trattamento economico al verificarsi di determinati fatti o cadenze temporali, senza bisogno di
specifici interventi contrattuali o legislativi (scatti di anzianità e tfr sono automatismi connessi all’anzianità di servizio).
Il nucleo centrale della retribuzione è la retribuzione tabellare, risultante dalla contrattazione collettiva nazionale di
categoria. La contrattazione fissa vari standards che vengono periodicamente aggiornati in rapporto alle diverse
categorie e qualifiche di lavoratori (ora chiamati livelli di inquadramento).
Le tabelle fissate nei contratti collettivi nazionali rappresentano il livello standard della retribuzione (la retribuzione
base). Esse vengono integrate dalla contrattazione a livello aziendale, ove questa sia presente, finendo così per
rappresentare un trattamento minimo.
Gli incrementi aziendali di solito non confluiscono nella retribuzione base. Spesso sono fissati in forme e con nomi
diversi (premi annuali di produzione o di bilancio) e contribuiscono a formare la retribuzione normale o globale (che è
composta dalla retribuzione tabellare, dalle integrazioni aziendali e dalle maggiorazioni previste per il lavoro
straordinario, notturno e festivo, ossia dalla retribuzione base più tutti gli ulteriori eventuali elementi accessori, legati
alle caratteristiche della prestazione individuale). La presenza di ulteriori trattamenti retributivi individuali
(superminimi) è particolarmente diffusa per i lavoratori di medio-alto livello.
3. Le voci retributive contrattuali.
La retribuzione base (o tabellare) è connessa con la qualifica ricoperta dal lavoratore e quindi con le mansioni svolte.
Tale voce retributiva era, fino al 1992, comprensiva dell’indennità di contingenza o scala mobile, un istituto di origine
patrizia che ha costituito per quasi 40 anni il meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni all’aumento del
costo della vita.
L’indennità di contingenza era un automatismo retributivo indicizzato al costo della vita, in misura fissa, avente la
funzione di garantire il costante adeguamento del valore nominale della retribuzione a quello reale, al fine di
salvaguardare i salari dalla perdita del potere d’acquisto per effetto dell’inflazione
Il Protocollo del 1992 sancisce la scomparsa del meccanismo della scala mobile. Il Protocollo del ’93 poi ha introdotto
un nuovo sistema di difesa del potere d’acquisto dei salari, attribuendo alla contrattazione collettiva (in particolare al
contratto collettivo nazionale di categoria) la possibilità di recuperare lo scarto tra livello reale dei salari e livello
d’inflazione. In pratica, i soggetti sindacali, in sede di rinnovo della parte economica del contratto (che ha durata
biennale), procedono alla comparazione tra inflazione programmata e inflazione effettiva e sulla base dello scarto
registrato viene negoziato l’incremento dei livelli retributivi per il secondo biennio.
Ci si è anche preoccupati dell’eventualità che le trattative per i rinnovi contrattuali subiscano ritardi e le retribuzioni dei
lavoratori risultino scoperte di fronte all’inflazione. per questo è stata introdotta una forma di adeguamento automatico
delle retribuzioni al costo della vita, l' indennità di vacanza contrattuale.
L’istituto non si pone solo come garanzia per la difesa del potere d’acquisto dei salari, ma svolge anche una funzione di
incentivo al regolare svolgersi dell’attività contrattuale. L’indennità spetta infatti ai lavoratori dopo il terzo mese dalla
scadenza del contratto collettivo di categoria, se questo non è stato ancora rinnovato. L’indennità ha poi anche una
funzione sanzionatoria; nel caso sia violata la clausola di tregua prevista dal Protocollo (ossia nel caso in cui le parti
assumano iniziative unilaterali o procedano ad azioni dirette durante il “periodo di raffreddamento”, che comprende
l’ultimo trimestre di applicazione del vecchio contratto ed il mese successivo alla sua scadenza), il termine di
decorrenza dell’indennità può essere anticipato o fatto slittare in avanti (di 3 mesi).
Fra gli elementi retributivi compresi nella retribuzione normale o globale, i contratti collettivi prevedono gli scatti di
anzianità. Si tratta di aumenti di retribuzione periodici (di solito biennali) stabiliti in varia misura, in rapporto
all’anzianità di servizio del lavoratore, misurata dalla permanenza nell’azienda. Insieme al tfr costituiscono il principale
automatismo retributivo legato all’anzianità.
I superminimi costituiscono incrementi aziendali rispetto alle retribuzioni contrattuali standard assegnati collettivamente
(di solito in seguito ad accordi aziendali) oppure individualmente.
Istituti generalmente contrattati a livello collettivo, ma che possono pure assumere forma individuale, sono i premi, fra i
quali troviamo, tra i più diffusi, i premi di produzione. Configurati all’inizio degli anni ’60 come strumenti per far
partecipare i lavoratori ai benefici della produttività aziendale, cui dovevano essere correlati, sono stati quasi subito
trasformati dalla contrattazione aziendale in compensi fissi (annuali) slegati dalla produttività, diventando così un
integrazione aziendale della retribuzione base stabilita nel contratto nazionale.
Il Protocollo del ’93 portò ad una forte spinta all’utilizzazione dei premi in funzione radicalmente diversa da quella
storicamente consolidata. In un contesto di ripartizione di competenze tra contratto nazionale di categoria e contratto di
secondo livello (aziendale o territoriale), è previsto che a quest’ultimo spetti di prevedere erogazioni strettamente
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi
di produttività. Dunque ai sensi del Protocollo i nuovi premi di risultato dovrebbero costituire voci retributive variabili,
collegate al raggiungimento di obiettivi predefiniti, deputate a premiare la professionalità dei dipendenti ed il loro
impegno per il buon successo dell’impresa.
In verità i premi in questione si distinguono a seconda dei parametri di misurazione:
-premi di produttività, agganciati ad indicatori (la qualità o quantità del prodotto, il risparmio sui costi, ecc) che
ricadono nella sfera di controllo dei lavoratori. Questi premi costituiscono effettivamente una forma di retribuzione
incentivante dell’impegno lavorativo.
-premi di redditività, legati ad indici che denotano il successo dell’impresa sul mercato (quali il fatturato o l’utile
d’esercizio) ed il cui raggiungimento dipende in larga parte da scelte strategiche che esulano dall’impegno dei
lavoratori. Questi premi costituiscono un metodo di flessibilizzazione della retribuzione e quindi di alleggerimento del
costo del lavoro in periodi di difficoltà (poiché se l’impresa non ha successo tali premi non vengono corrisposti).
Le gratifiche mantengono anch’esse, come i premi, solo il nome dell’originale corresponsione liberale. Costituiscono
elementi integrativi della retribuzione, differiti in quanto corrisposti una volta l’anno., per far fronte a particolari spese o
bisogni del lavoratore. La più diffusa e quella natalizia (detta anche tredicesima mensilità).
Una categoria particolarmente eterogenea è quella delle indennità, previste soprattutto dalla contrattazione collettiva. La
denominazione suggerisce che si tratti di attribuzioni di carattere risarcitorio; ma la grande maggioranza di tali
indennità, ancora una volta, è stata presto attratta nell’area della retribuzione, in qualità di elementi accessori. Infatti
esse servono ad adattare il compenso complessivo del lavoratore a diverse particolarità del lavoro (condizioni temporali,
di disagio, di gravosità), senza però che si possa configurare tipicamente la reintegrazione di una specifica perdita
patrimoniale, danno o spesa subita dal lavoratore a causa del lavoro (solo il tale ultimo caso saremmo di fronte a
prestazioni indennitarie o a rimborsi spese in senso tecnico).
L'adempimento dell'obbligo retributivo.
L'adempimento dell'obbligo retributivo, quale obbligazione di dare è regolato dagli artt. 1176 e 1218 c.c. nonché
dall'art. 2099 c.c., il quale stabilisce più specificamente che i tempi e le circostanze del pagamento devono essere quelli
in uso nel luogo dove il lavoro è eseguito.
Il diritto al pagamento della retribuzione sorge a lavoro compiuto; è questo il principio della post-numerazione, in base
al quale il pagamento della retribuzione è posticipato rispetto all’erogazione della prestazione lavorativa.
Il termine per la corresponsione della retribuzione è stabilito dai contratti collettivi o in mancanza, dagli usi del luogo
dove il lavoro è compiuto. I pagamenti seguono cadenze periodiche stabilite dai contratti (solitamente mensili).
Periodicità diverse sono stabilite per gli elementi differiti della retribuzione (come la tredicesima ed i premi di
produzione).
Per gli impiegati l’unità di tempo considerata a base di calcolo per la retribuzione è il mese, e quindi la retribuzione è
corrisposta su base mensile ed è denominata stipendio. Per gli operai l’unità di tempo base è l’ora lavorata, e quindi per
loro vale la retribuzione oraria, denominata salario o paga. Tale distinzione non ha rilievo per il termine d’adempimento,
che può essere in ogni caso mensile, quindicinale o settimanale, ma per la diversa incidenza del rischio della mancata
prestazione. L’impiegato non subisce alcuna decurtazione dello stipendio per le ipotesi di mancata prestazione
dell’attività che non derivino da suo inadempimento, mentre l’operaio, la cui retribuzione è calcolata sulla base delle ore
lavorate nel mese, risente delle interruzioni, anche non colpevoli, del lavoro.
Il datore ha l’obbligo (L. n. 4/1953)di consegnare al lavoratore, contestualmente alla corresponsione della retribuzione,
il c.d. prospetto di paga (busta paga), nel quale sono indicati nome e qualifica professionale del lavoratore, periodo di
riferimento e soprattutto l’elenco di tutti gli elementi che compongono la retribuzione corrisposta.
CAPITOLO NOVE: LE SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO.
1.Fattispecie e tipologie
La sospensione è annoverata tra le vicende del rapporto di lavoro. Vi sono ricomprese una serie di ipotesi eterogenee
(sciopero, malattia e infortunio, gravidanza, permessi e aspettative, sospensioni determinate da crisi aziendali, ecc.), che
presentano un elemento comune: la sospensione totale o parziale dell’obbligazione di lavoro e degli obblighi
indispensabili per il suo adempimento, non necessariamente di altre posizioni giuridiche accessorie (es. l’obbligo di
fedeltà o la retribuzione). La sospensione quindi non è riferibile al rapporto nel suo complesso, ma all’obbligazione e
prestazione di lavoro.
Una ricorrente classificazione distingue tra sospensioni per fatto del lavoratore e sospensioni dipendenti dall’impresa.
La diversità della causa sospensiva si riflette in differenze di trattamento, soprattutto riguardo alla garanzia del reddito.
In caso di sospensione dipendente dall’impresa, è di regola riconosciuta al lavoratore l’intera retribuzione, mentre in
caso di sospensione per fatto del lavoratore, la garanzia riconosciuta è solitamente quella di un’indennità previdenziale,
e solo in mancanza, la retribuzione o parte di essa secondo la legge o i contratti collettivi.
Il diritto del lavoro contiene in questi casi principi speciali rispetto alle regole generali dei contratti di scambio, ispirati a
intenti protettivi del lavoratore, rispetto a due interessi fondamentali: la conservazione del lavoro e del reddito.
Nei casi di possibilità della prestazione (non imputabile) la regola generale del diritto civile è che il rapporto si estingue
automaticamente se l’impossibilità è definitiva oppure se dura tanto da far venir meno l’interesse del creditore alla
prestazione. Viceversa, nei casi previsti dagli artt. 2110-2111, l’impossibilità temporanea non estingue ma sospende il
rapporto di lavoro ed al lavoratore è garantita la conservazione del posto.
Mentre nei normali contratti a prestazioni corrispettive la sospensione dell’obbligazione di una parte comporta la
sospensione della controprestazione, il diritto del lavoro prevede il mantenimento dell’obbligo retributivo in capo al
datore in svariate ipotesi.
Si tratta in sostanza di deroghe alla disciplina prevista dal diritto civile, volte a tutelare il lavoratore. Per quanto riguarda
la portata e l’estensione di tali regole, si ritiene che siano ammissibili solo allorché specificamente previste dalla
disciplina legislativa o contrattuale, e che dunque siano tassative.
Sospensioni per cause inerenti al prestatore di lavoro.
1.Gli artt. 2110-2111 c.c.
I casi più rilevanti di sospensioni per fatto del lavoratore sono quelli trattati dagli artt. 2110 e 2111 (malattia, infortunio,
gravidanza, puerperio, servizio militare).
Tra le previsioni comuni vi è il diritto del lavoratore alla conservazione del posto, per il periodo stabilito dalla legge, dai
contratti collettivi, dagli usi o secondo equità (c.d. periodo di comporto). Ciò implica che il potere di recesso sia sospeso
per tutto il periodo del comporto (salva la sussistenza di un fatto che integri gli estremi della giusta causa). L’eventuale
recesso deliberato dal datore si ritiene non nullo, bensì inefficace o ad efficacia differita alla fine della malattia o del
periodo di comporto (eccettuato però il caso della lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio).
I periodi di assenza vanno computati a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
Oltre alla conservazione del posto, l’art. 2110 prevede la conservazione del reddito, stabilendo che, in mancanza di
forme previdenziali equivalenti, il lavoratore ha diritto alla retribuzione, per il periodo e nella misura stabiliti dalla
legge, dal contratto collettivo, dagli usi o secondo equità (la regola deve ritenersi estesa al richiamo alle armi, ma non al
servizio di leva).
2. Malattia e infortunio.
Nei casi di malattia e di infortunio, la protezione del lavoratore- già costituzionalmente garantita dagli art. 32 e 38- è
stata progressivamente rafforzata dalla contrattazione collettiva.
La nozione lavoristica di malattia ricomprende le sole affezioni morbose che comportano un’incapacità al lavoro.
La conservazione del posto è garantita per periodi variabili, di solito a seconda dell’anzianità di servizi del lavoratore e
con esclusione dei dipendenti in prova. In caso di infortunio la conservazione del posto perdura fino alla guarigione
certificata dall’Inail.
Quanto alla conservazione del reddito, la disciplina legale (R.D.L. n. 1825 del 1924) prevede che gli impiegati abbiano
diritto al mantenimento della retribuzione a carico del datore di lavoro (integrale per un certo periodo di tempo e
parziale per il periodo successivo), mentre gli operai ricevono un’indennità previdenziale posta a carico dell’Istituto
pubblico competente (l’Inps per la malattia e l’Inail per l’infortunio), ma anticipata dal datore di lavoro.
L'indennità è nella misura del 60% della retribuzione normale; decorre a partire dal 3° o 4° giorni dopo l'inizio della
sospensione (cosiddetta carenza) e persiste per un periodo variabile a seconda dell'anzianità, facendo carico al datore di
lavoro di integrare, in tutto o in parte, quanto corrisposto dagli enti previdenziali agli operai.
Più controverso è il trattamento dei primi giorni di malattia (per gli operai). La regola del non pagamento dei primi 3
giorni (c.d. carenza), giustificata dall’esigenza di limitare l’onere economico per gli Istituti previdenziali e di
scoraggiare fenomeni di assenteismo, è stata progressivamente corretta dalla contrattazione collettiva, che ha imposto al
datore di integrare in parte o in tutto la retribuzione agli operai fin dal primo giorno di malattia.
In proposito la L. n. 638/1983 ha imposto ai lavoratori l’obbligo di reperibilità in determinate fasce orarie(10-12; 1719), salvo giustificato motivo, ai fini della sottoposizione a visita medica, pena la decadenza dei lavoratori da ogni
trattamento economico fino a 10 giorni e la riduzione dello stesso alla metà per l'ulteriore periodo. Mentre la prima
parte della disposizione è stata confermata dalla Corte Costituzionale, la perdita del 50% dell'indennità per l'ulteriore
periodo è stata ritenuta incostituzionale in quanto contraria all'art. 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede
una seconda visita medica di controllo prima della decadenza di tale diritto.
Al fine di permettere i controlli in esami il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro le cause
dell'assenza: immediatamente nel caso di infortunio, entro 2 giorni nel caso di malattia, trasmettendo al datore di lavoro
l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia e all'INPS il certificato di diagnosi, entrambi redatti dal
medico curante (art. 2 L. n. 33/1980 e art. 5 L. n. 155/1981). L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita
dell'indennità INPS per i giorni di ritardo, salvo che il ritardo sia giustificato da ragioni serie ed apprezzabili.
Per quanto riguarda le malattie brevi e reiterate, invece, la fattispecie trova sovente disciplina nella contrattazione
collettiva, con la determinazione, accanto al comporto c.d. secco (relativo ad un unico episodio morboso), di un
comporto per sommatoria o improprio, riferito alle malattie reiterate: il licenziamento viene ritenuto legittimo, se i vari
episodi di malattia verificatisi entro un determinato periodo (di solito pari alla durata del contratto collettivo), sommati
insieme, superino il periodo di comporto per sommatoria.
La contrattazione collettiva non ha fissato il comporto per sommatoria ed è quindi compito del giudice determinarlo
secondo equità. Notevole interesse poi, desta la questione dello svolgimento di attività lavorativa per conto proprio o di
terzi, in periodo di dichiarata e certificata malattia. La Suprema Corte a riguardo nega “ la generalizzazione teorizzante
il divieto di espletamento di attività lavorative durante il periodo di malattia”, dovendosi valutare l'incidenza dell'attività
espletata sul pronto recupero delle energie psico-fisiche ed eventuali aspetti simulatori del denunziato stato morboso.
3.Gravidanza, puerperio e congedi parentali.
Le donne lavoratrici sono beneficiarie di una speciale tutela legislativa nel corso della gravidanza e del puerperio, volta
ad assicurare alla madre e al bambino quella speciale protezione costituzionalmente sancita (art. 37).
L’attuale disciplina è contenuta nel testo unico (TU) in materia di tutela della maternità e paternità (d. lgs. 151/2001). Il
decreto segna un’importante tappa nell’evoluzione legislativa della materia. L’obiettivo è sempre quello di proteggere la
salute e la vita della madre e del bambino, ma con una rinnovata attenzione per le esigenze fisiologiche ed altresì
relazionali ed affettive di cura del figlio ad opera di ambedue i genitori lavoratori. Da ciò l’estensione della disciplina ad
adozioni ed affidamenti, con conseguente abbandono del tradizionale concetto puramente fisico di maternità e la quasi
totale equiparazione del lavoratore padre alla lavoratrice madre.
Solo alla lavoratrice madre naturale (in ragione dell’esigenza di tutelarne la gestazione) è imposta la fruizione del c.d.
congedo di maternità pre-parto, con conseguente divieto del lavoro:
-nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto.
-se il parto avviene oltre tale data, nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto (art 16 T.U.);
-l’interdizione dal lavoro deve essere anticipata in caso di complicanze della gravidanza o quando le condizioni di
lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli per la salute della gestante e del nascituro (art. 17 T.U.).
È previsto poi un congedo di maternità post-parto, che impone alla lavoratrice madre di astenersi dal lavoro:
-nei 3 mesi successivi al parto;
-negli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga prima della data presunta.
Nel complesso dunque, la donna gode di un congedo di maternità pari a 5 mesi. L’inosservanza di tali disposizioni è
punita penalmente con l'arresto fino a sei mesi (art. 18 T.U.).
Ferma restando la durata complessiva del congedo, le lavoratrici hanno comunque la possibilità di goderne secondo una
modulazione diversa, astenendosi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi
successivi al parto ove il medico specialista del S.S.N e il medico competente per la sicurezza su lavoro lo autorizzino
(art. 20 T.U.). Durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della
retribuzione normale. L’indennità è a carico dell’INPS, anche se di regola grava sul datore l’obbligo di anticiparla.
I periodi di congedo obbligatorio vanno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Gli stessi periodi sono
considerati come attività lavorativa ai fini della progressione di carriera.
Gli interventi legislativi succedutisi in materia attestano come il fondamento della protezione sia ormai sempre più
nitidamente ricondotto alla maternità in quanto tale e non più, come in passato, al solo svolgimento di un’attività
lavorativa subordinata. Infatti il trattamento di maternità è stato esteso anche alle lavoratrici autonome e alle libere
professioniste. Inoltre leggi nazionali prevedono spesso un assegno di maternità ed un assegno unico per il nucleo
familiare, per la madre che non svolga alcuna attività lavorativa ed appartenga ad una famiglia con limitate risorse
economiche.
È nullo il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al compimento di 1
anno di età del figlio, salvo casi eccezionali (colpa grave, cessazione dell’attività aziendale).
In questo periodo anche le dimissioni sono guardate con sospetto, siccome possibile strumento per mascherare un
licenziamento. Per questo è stato contemplato un meccanismo di convalida delle dimissioni presso il servizio ispettivo
della direzione provinciale del lavoro, nonché una tutela economica (con tutte le indennità previste per il
licenziamento). Tali disposizioni si estendono anche al lavoratore padre che abbia usufruito del congedo di paternità.
Al termine del congedo, la lavoratrice madre (o il lavoratore padre) gode del diritto al rientro. Il diritto al rientro
comporta la conservazione del posto, il diritto al mantenimento delle precedenti mansioni o di altre equivalenti e, salvo
espressa rinuncia, il diritto a rientrare nella stessa unità produttiva (o in altra nello stesso comune) ed a permanervi fino
al compimento di 1 anno del bambino.
Il congedo post-parto per i primi 3 mesi di vita del bambino (con le stesse tutele, pure contro il licenziamento, e lo
stesso trattamento economico) si estende pure al padre, ma limitatamente ad alcuni casi tassativi (morte o grave
infermità della madre, affidamento esclusivo al padre), nei quali il venir meno dell’assistenza della madre rende
necessaria una presenza sostitutiva dell’altro genitore.
Il congedo di paternità si differenzia però da quello di maternità:
-è facoltativo.
-può essere esercitato solo in alternativa alla madre.
-è rigido, poiché non prevede flessibilità di sorta, essendo consentito al padre di assentarsi solo nei primi 3 mesi di vita
del figlio.
Al fine di agevolare l’ingresso del bambino nella famiglia, un congedo di 3 mesi può essere chiesto dalla madre (o in
alternativa dal padre) che abbia adottato o abbia ottenuto in affidamento un bambino. Il congedo va fruito nei 3 mesi
successivi all’ingresso del bambino nella famiglia (art. 26 e 31 T.U.).
Nell'intento di consentire ad entrambi i genitori di conciliare il lavoro con la cura dei figli, sono poi previsti dei congedi
parentali, spettanti a ciascun genitore e per ciascun bambino, nei suoi primi 8 anni di vita. I genitori possono usufruire
del congedo sia separatamente che contemporaneamente. I congedi parentali non possono eccedere il limite
complessivo di 10 mesi, ma il diritto è esercitabile da ciascun genitore per un periodo (continuativo o frazionato) non
superiore a 6 mesi (qualora vi sia un solo genitore, egli può godere di un periodo non superiore a 10 mesi).
Il limite complessivo di 10 mesi, è tuttavia elevato ad 11, qualora il padre eserciti il proprio diritto di astensione dal
lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi (ciò allo scopo di incidere sulla tradizionale distribuzione dei ruoli in
famiglia, nel tentativo di modificarne la direzione).
Il limite di questa disciplina risiede tuttavia nell’esiguità del trattamento economico spettante ai genitori durante il
congedo. Essi hanno infatti diritto ad un’indennità (corrisposta dall’INPS) pari al 30% della retribuzione fino al terzo
ano di vita del bambino e per un periodo complessivo massimo di 6 mesi; mentre dal terzo anno di vita fino all’ottavo, e
comunque per il periodo residuo di astensione facoltativa, l’indennità è dovuta solo se il reddito individuale del genitore
sia inferiore ad una certa sogli minima (art. 33 T.U).
Anche i periodi di congedo parentale devono essere computati nell’anzianità di servizio e devono essere considerati
come attività lavorativa ai fini della progressione di carriera.
La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre di minore con handicap grave hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato presso istituti specializzati. I riposi
giornalieri sono fruibili, soltanto nel primo anno di vita del figlio o, quando si tratti di adozione o affidamento. Questi
riposi non spettano alla lavoratrice madre autonoma o libera professionista. In caso di parto plurimo, i riposi giornalieri
sono raddoppiati, indipendentemente dal numero dei gemelli. Entrambi i genitori, ma alternativamente, hanno diritto di
assentarsi dal lavoro per le malattie del figlio, previo certificato medico (per i primi 3 anni di vita del figlio per tutta la
durata della malattia, mentre dal terzo all’ottavo anno del figlio per un massimo di 5 giorni l’anno).
Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti suddetti sono puniti con sanzioni amministrative. È altresì
nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da
parte della lavoratrice o del lavoratore.
4.Servizio militare.
La garanzia del posto di lavoro e il decorso dell’anzianità ai vari effetti (salvo il tfr) sono riconosciuti in caso di servizio
di leva, di servizio civile e di richiamo alle armi. La garanzia del reddito, invece, è prevista solo per il caso di richiamo
alle armi. Va tuttavia ricordato che il reclutamento obbligatorio delle Forze Armate è stato sospeso a partire dal 1
gennaio 2005, sancendosi così la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con
personale civile del Ministero della difesa (L. n. 226/2004).
5.Altri casi di sospensione.
Oltre ai casi già riportati, esistono altre ipotesi, di origine legale o contrattuale, caratterizzate dalla temporanea
interruzione dell’obbligazione lavorativa, con diritto alla conservazione del posto, e talvolta anche del reddito.
Di alcune di esse ci siamo già occupati o ce ne occuperemo successivamente: pause di lavoro e riposi; permessi ed
aspettative per l’adempimento di cariche sindacali, o per l’espletamento del mandato sindacale da parte di dirigenti di
rsa; congedi familiari (non retribuiti) per morte o malattia di parenti prossimi o per il matrimonio; congedi formativi;
permessi per motivi di studio.
La sospensione del rapporto può anche risultare da un accordo individuale tra le parti, nel qual caso sarà lo stesso
accordo a stabilire i diritti e doveri derivanti dal rapporto sospeso (si ritiene infatti che la materia rientri nella
disponibilità dei contraenti).
Sospensioni dipendenti dall'impresa.
1. La Cassa Integrazione Guadagni: l'evoluzione normativa.
La cassa integrazione guadagni rappresenta un’integrazione previdenziale versata a favore del lavoratore sospeso o ad
orario ridotto fino all’integrale ripresa della produzione nella grande impresa privata. Si tratta di una forma di intervento
pubblico sul mercato del lavoro, atta a garantire la sopravvivenza dell’impresa, nonché la salvaguardia dell’occupazione
e del reddito dei lavoratori durante episodi di contrazione dell’attività aziendale. Essa rappresenta inoltre un’ipotesi di
sospensione del rapporto di lavoro per fatti inerenti all’impresa.
Se si applicasse il diritto comune dei contratti, l’imprenditore sarebbe esonerato dall’obbligo retributivo solo laddove la
sospensione della prestazione fosse dovuta ad un’impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile (art. 1218 e 1256
c.c.). Ma, a parte la difficoltà di accertare la non imputabilità all’imprenditore di una certa situazione aziendale, il
ricorso a tale soluzione non garantirebbe una adeguata soddisfazione degli interessi in gioco. Da un lato esporrebbe il
datore alle pretese creditorie dei lavoratori; dall’altro penalizzerebbe gli stessi lavoratori per i riflessi negativi che una
contrazione dell’attività aziendale avrebbe sui rapporti di lavoro.
Da qui l’introduzione della Cig, con funzioni sia di sostegno all’impresa, sia di garanzia del reddito e dell’occupazione.
In tali casi dunque l’INPS assicura ai dipendenti di imprese industriali, con qualifica di operaio, impiegato e quadro,
un’indennità pari all’80% della retribuzione globale di fatto che ad essi sarebbe spettata per le ore di lavoro non
prestate.
La Cig, introdotta nell’industria dalla contrattazione collettiva corporativa nel secondo dopoguerra, è stata poi recepita
dalla legge (D.lgs. n. 788/1945 e n. 869/1947) che l'ha quantificata in una percentuale della retribuzione, versata
dall’ente pubblico (INPS) all’operaio sospeso o messo ad orario ridotto a seguito di un’involontaria e breve interruzione
dell’attività aziendale. Ciò con l’obiettivo di rispondere al coincidente interesse del dipendente e dell’azienda alla
conservazione del rapporto fino alla prevista piena ripresa produttiva ed occupazionale. Infatti in entrambi i casi di
integrazione salariale vi deve essere la prospettiva della cessazione dell’evento sospensivo e quindi della ripresa
produttiva (sebbene nell’intervento straordinario tali prospettive sono più incerte).
L’evoluzione normativa dei successivi decenni tuttavia ha traviato la natura originaria della Cig, attraverso una graduale
evoluzione dell’istituto che ha attraversato quattro fasi principali:
1) C'è una prima fase, che culmina all'epoca della cosiddetta legislazione garantista-promozionale, caratterizzata
da una graduale crescita della Cassa Integrazione, secondo esigenze diverse. L’istituto diviene operativo non
più solo in caso di un’interruzione o contrazione dell’attività aziendale involontaria e breve, in vista di una
prossima e sicura ripresa, ma anche programmata, lunga e senza una prospettiva certa di rioccupazione della
forza lavoro. (LL. n. 1115/1968 e n. 464/1972). Inoltre la cassa integrazione è stata estesa ad altri settori
produttivi quali quello edile e quello agricolo (LL. n. 77/1963 e n. 457/1972). Questa fase è chiusa dalle leggi
n. 164 per l'industria e 427 per l'edilizia, entrambe del 1975, destinate a risistemare ed omogeneizzare l'intera
Cig, nonché ad istituzionalizzare la previa consultazione e trattativa sindacale.
2) La seconda fase copre gli anni del cosiddetto diritto dell'emergenza e in parte del cosiddetto diritto della crisi
ed è segnata dall'espansione a-selettiva e priva di limiti temporali della Cigs. Nel corso degli anni dunque
l’istituto è andato acquisendo un carattere sempre più “assistenziale”, avendo a carico un numero crescente di
lavoratori qualificabili come veri e propri “disoccupati occulti”.
3) C'è poi una terza fase, caratterizzata da una ridefinizione del ruolo dell’integrazione salariale, volta a
ricondurre la Cig alle sue finalità originarie di sostegno all’impresa e alle sue esigenze di trasformazione
anziché di funzione sostitutiva del trattamento di disoccupazione. Per un verso si è proceduto, in via indiretta,
introducendo misure volte a diminuire il ricorso alla Cig, quali i contratti di solidarietà difensivi o i prepensionamenti; per altro verso si è proceduto a restringere direttamente l’ambito di applicazione della Cig.
A mezzo del 1991 viene emanata la L. n. 223 con la quale la Cassa Integrazione Guadagni va incontro ad un riforma. Le
modifiche riguardano l'intervento ordinario (Cigo), nel senso di renderlo più omogeneo rispetto a quello straordinario,
ma soprattutto toccano l'intervento straordinario (Cigs) al fine di ricondurlo alle sue finalità originarie, di sostegno
temporaneo all'impresa e alle sue esigenze di trasformazione anziché di funzione sostitutiva del trattamento di
disoccupazione dei lavoratori. In tale ottica la Cassa Integrazione non dovrebbe essere più l'anticamera dei
licenziamenti collettivi, né dovrebbe giustificare la corresponsione dell'integrazione salariale ai lavoratori con un
rapporto di lavoro fittizio.
4) Tuttavia la linearità della riforma operata con la L. n. 223\1991 è stata subito interrotta dalla successiva
sequenza legislativa, che ha introdotto una fitta serie di caotiche modifiche, che dilatano l’ambito (oggettivo e
soggettivo) di applicazione della Cig, dapprima prevedendo deroghe provvisorie e poi introducendo proroghe
ai termini di scadenza delle stesse.
A fronte di una perpetuazione della logica delle proroghe e degli interventi “a pioggia” di tipo assistenziale, si registrano
recenti impulsi di riorganizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali, in coincidenza con una nuova visione del
mercato del lavoro quale opportunità e crocevia di passaggio per la maggior parte dei lavoratori, mobili e in crescita
professionale. In tale prospettiva assume rilevanza la rete di protezione sociale apprestata dallo Stato per sostenere il
lavoratore in cerca di occupazione. Tale rete si concentra sulla formazione professionale, sui servizi all'impiego,
sull'indennità di disoccupazione e su quella di mobilità, assottigliando sempre di più le sue trame con riguardo
all'integrazione salariale che dovrebbe rappresentare un sussidio solo eccezionale ed assolutamente temporaneo per
superare le crisi transitorie d'azienda e di mercato.
La proposta di riforma degli ammortizzatori sociali mira a razionalizzare gli attuali istituti, superando sprechi ed
inefficienze, e a collegare strettamente integrazioni al reddito, servizi di orientamento, formazione come altre misure di
inserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso gli organismi bilaterali. La prospettiva è quella di un nuovo
sistema di tutele attive, volto ad incoraggiare e ad assistere il lavoratore nel processo di reinserimento nel mercato del
lavoro.
2.L'intervento ordinario e straordinario: “cause integrabili”, ambito applicativo, durata e misura dell'integrazione.
L’intervento ordinario si presenta alla stregua di strumento “micro”, di supporto ad un calo produttivo riconducibile ad
un evento temporaneo, congiunturale, senza un impatto durevole. Mentre l’intervento straordinario si presenta come
mezzo “macro”, di ammortizzo di un ridimensionamento produttivo, ricollegabile ad un processo lungo, strutturale, con
effetto duraturo. Tale differenza si riflette in vari aspetti della disciplina.
Le cause eleggibili sono le cause che provocano delle interruzioni o contrazioni dell’attività aziendale, con conseguente
sospensione dal lavoro o riduzione di orario ammessi all’integrazione.
Per l’intervento ordinario sono date da: a)situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili
all’imprenditore o agli operai; b)situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato (L. n. 164/1975).
Per l’intervento straordinario sono invece costituite da: a)ristrutturazione (mutamento di tecnologie), riorganizzazione
(mutamento dell’organizzazione aziendale) o riconversione aziendale (mutamento dell’attività stessa); b)crisi aziendale
individuata sulla base di criteri ministeriali, in relazione alle situazioni territoriali e dei settori (L. n. 675/1977, come
modificata dalla L. n. 223/1991).
L’intervento straordinario può inoltre essere richiesto dal responsabile della procedura (curatore, liquidatore,
commissario) nei casi di fallimento, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o concordato
preventivo, in mancanza di continuazione dell’attività d’impresa.
L’intervento della cassa integrazione straordinaria è infine previsto nelle ipotesi di stipulazione di un contratto di
solidarietà difensivo, al fine di evitare una riduzione del personale.
Campi d’applicazione
L’intervento ordinario è limitato alle imprese industriali (art. 1 L. n. 164/1975), sebbene successive leggi abbiano
provveduto a coprire i settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
L’intervento straordinario invece è concedibile solo all’impresa con più di 15 dipendenti. Originariamente riservato alla
sola industria, inclusa l’edilizia, è stato successivamente esteso ad altri settori (imprese commerciali, di spedizione e
trasporto, nonché delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, delle imprese appaltatrici di servizi di
mesa o ristorazione e di servizi di pulizia di imprese industriali in Cig ed altresì delle imprese di vigilanza), nonché alle
cooperative di produzione e lavoro (art. 8 L. n. 236/1993).
per le categorie o i settori d impresa esclusi dal campo di applicazione della Cig, nonché per gli enti e le aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, si è stabilito che “in attesa di un'organica riforma del sistema
degli ammortizzatori sociali” si attiva il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale o per fronteggiare situazioni di crisi. Il legislatore ha così inteso
promuovere nuovi tipologie di ammortizzatori sociali, da regolare e gestire per via contrattuale (tramite fondi presso
l'INPS, finanziati con il contributo di datori e lavoratori). Si aprono in tal modo spazi per forme di vera e propria
previdenza negoziata, così definita per l'intervento della contrattazione e non dello Stato.
Lavoratori aventi diritto
L’intervento ordinario è rimasto a lungo riservato ai soli operai. Tuttavia la L. n. 223\1991 ne ha allargato l’ambito a
impiegati e quadri, sì da farlo coincidere con quello dell’intervento straordinario. Quest'ultimo, però, ricomprende anche
i soci delle cooperative di produzione e lavoro (ed è di regola subordinato al possesso di un'anzianità lavorativa di
almeno 90 giorni: art 8 L. n. 160/1988).
Misura dell’indennità
Sia l’intervento ordinario che quello straordinario corrispondono all’80% della retribuzione altrimenti spettante al
lavoratore per le ore non lavorate comprese tra le 0 e il limite orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore
settimanali. Nel caso di contratti di solidarietà difensivi, l’integrazione salariale straordinaria è pari al 60% della
retribuzione perduta in seguito alla riduzione di orario.
Durata dell’integrazione salariale
L’intervento ordinario è previsto per 3 mesi continuativi, con eventuali proroghe trimestrali in casi eccezionali, fino a 12
mesi. I limiti di durata non si applicano in caso di eventi oggettivamente non evitabili. L’intervento straordinario è
invece disposto per un tempo diverso, a seconda delle cause integrabili:
-in caso di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendali: per 2 anni, con eventuali altre 2 proroghe,
ciascuna non superiore a 12 mesi per programmi di particolare complessità o in ragione della rilevanza delle
conseguenze occupazionali;
-in caso di crisi aziendale: per 12 mesi, con eventuale nuova erogazione per la medesima causale solo dopo un periodo
pari ai 2/3 di quello relativo alla precedente concessione;
-in caso di procedure concorsuali: per un periodo non superiore ai 12 mesi, prorogabili di altri 6 mesi quando sussistano
fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione.
Nei contratti di solidarietà difensivi il trattamento può essere corrisposto per 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (che
diventano 36 nel sud Italia).
Per limitare la durata degli interventi Cig la L. n. 223 prevede un tetto cumulativo e un disincentivo economico. Il tetto
è di 36 mesi nel quinquennio, mentre per ciò che riguarda il disincentivo economico è stabilito che il contributo
addizionale dovuto per ogni cassaintegrato è raddoppiato in caso di proroga del trattamento per ristrutturazioni.
Con l'introduzione di rigidi limiti temporali, la L. n. 223 del 1991 ha voluto porre fine alla deprecabile prassi di utilizzo
improprio della Cig, tipica degli anni '70 e '80. Tuttavia, questo meritorio intento ha dovuto fare i conti con decine di
deroghe e proroghe (c.d. stillicidio). Ma nonostante ciò la recente previsione di nuovi criteri per la concessione delle
proroghe ha dato prioritaria rilevanza alla programmazione di attività formative a favore dei lavoratori in CIGS.
3. (Segue): Procedure, erogazione e finanziamento della Cig.
Per la messa in Cig straordinaria e ordinaria, la legge prevede precisi termini di presentazione della domanda e l'obbligo
per l'impresa di esperire le procedure sindacali.
Salvo che per le imprese soggette ad amministrazione straordinaria o a procedure concorsuali la domanda (di
concessione o di proroga) va presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana
in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario. La fissazione di questo termine (di decadenza) preclude
la possibilità di ottenere il trattamento per periodi eccessivamente lontani dal verificarsi della causa integrabile.
L’informazione e la consultazione sindacale è una vera e propria condizione di ammissibilità della domanda di cassa
integrazione. La sequenza procedurale è duplice con riguardo all'intervento ordinario:
-nei casi di eventi oggettivamente non evitabili, che rendano non differibile la contrattazione o la sospensione
dell'attività produttiva, è prevista una comunicazione successiva alle RSA (o RSU) o, in mancanza, alle organizzazioni
sindacali provinciali di categoria più rappresentative, nonché, a richiesta, un esame congiunto (da esaurirsi entro 5
giorni) per sospensioni e riduzioni d'orario superiori alle 16 ore settimanali.
-negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva è, invece, prevista una comunicazione preventiva
alle RSA (o RSU) e alle OO.SS. Provinciali di categoria più rappresentative, nonché, sempre a richiesta, un esame
congiunto (da esaurirsi entro 25 o 10 giorni, a seconda che il numero dei dipendenti sia superiore o inferiore ai 50).
Solo nella procedura relativa all’intervento ordinario, è ammessa, in caso di eventi oggettivamente non evitabili che
rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell’attività produttiva, una comunicazione successiva.
Quanto all'intervento straordinario è previsto in ogni caso un obbligo di comunicazione preventiva da parte
dell'imprenditore nei confronti delle RSU o, in assenza, delle OO.SS.; poi a richiesta dell'imprenditore o dei suddetti
organismi rappresentativi dei lavoratori, entro 3 giorni dalla comunicazione, può essere richiesto un esame congiunto
della situazione aziendale dinanzi all'ufficio regionale competente e allo stesso Ministero del lavoro nel caso in cui
l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni.
Conclusa la fase di consultazione sindacale, nell'intervento ordinario la domanda di messa in Cassa o di eventuali
proroghe si sviluppa presso la sede provinciale INPS.
Nel caso di intervento straordinario, la domanda è inoltrata al Ministero del lavoro (Direzione degli ammortizzatori
sociali e incentivi all'occupazione) previo parere della Regione (D.P.R. n. 218/2000). La richiesta deve contenere il
programma (mirato al rilancio dell’attività e alla salvaguardia dei livelli occupazionali) che l'impresa intende attuare.
Al Ministero è attribuita la competenza di approvare il programma con decreto e di concedere il trattamento di
integrazione salariale (nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda o di 60 per i periodi successivi ai primi
dodici mesi, escluso il caso di crisi aziendale) (art. 8 D.P.R. n. 218/2000).
Una volta concessa, l’integrazione salariale è anticipata dalla stessa azienda, che la recupera con il sistema del
conguaglio, trattenendo una somma corrispondente sui contributi sociali da versare all’INPS.
Nell’intervento straordinario però, è possibile, per le imprese beneficiare, in caso di comprovate difficoltà finanziarie,
richiedere l’esenzione, con conseguente pagamento diretto da parte dell’INPS.
Il finanziamento dell’integrazione salariale avviene con un contributo ordinario per ogni dipendente (a carico dello stato
nell’intervento straordinario e delle imprese nell’intervento ordinario), nonché con un contributo addizionale per
ciascun cassintegrato a carico delle imprese. Il contributo addizionale non è dovuto quando la Cig è giustificata “da
eventi oggettivamente non evitabili”. Per sovvenzionare il trattamento straordinario, la L n. 407/1990 ha anche
introdotto un contributo a carico dei lavoratori, che iniziano così a partecipare finanziariamente al sistema di
disoccupazione.
4. (Segue): Criteri di scelta, rientro in azienda, ricollocamento dei lavoratori.
Ai sensi della L. n. 223/1991, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere- nonché le modalità della
rotazione- devono formare oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto con i sindacati. I criteri di scelta adottati
nella Cig sono diversi da quelli previsti per i licenziamenti collettivi, in quanto i cassaintegrati al termine del periodo
“rientrano in azienda”.
In pratica, seconda la Suprema Corte, in materia operano i seguenti principi: i criteri Cig, fissati dal datore di lavoro o
dall'accordo collettivo, devono essere obiettivi e razionali, rispettare i principi di correttezza, equità e buona fede e
comunque, deve evitare qualsiasi discriminazione.
La vera novità introdotta dalla L. n. 223\1991 consiste nella rotazione fra i lavoratori sospesi o ad orario ridotto. Va
detto che il datore non è assolutamente tenuto alla rotazione, ma eventuali motivi di impedimento al meccanismo di
rotazione dovranno essere comunicati alle OO.SS. ed indicati partitamente nel programma di Cig: il Ministro del lavoro,
se li riterrà ingiustificati, promuoverà l'accordo fra le parti o, in mancanza, imporrà con decreto il meccanismo della
rotazione. Tuttavia, anche l'obbligo imposto con decreto ministeriale è privo di efficacia reale: potrà restare
inottemperato, salvo il pagamento a carico del datore del doppio dei contributi addizionali per quei lavoratori che non
rientrano nel meccanismo della rotazione.
La L. n. 223\1991 prevede che i lavoratori, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale,
“rientrano in azienda”. Nonostante la laconicità della norma, il rientro, da un lato, deve essere effettivo e la sua efficacia
non può essere degradata al mero equivalente economico; dall’altro non fa sorgere un diritto alla stabilità del rapporto,
cioè lo stesso lavoratore può, se ne ricorrono i presupposti, essere licenziato (individualmente o collettivamente).
Il legislatore è inoltre esplicitamente intervenuto per fornire ai lavoratori cassaintegrati una peculiare “dote”. Si tratta
soprattutto di sgravi contributivi, destinati alle imprese che li assumono, in particolare quelle del Mezzogiorno.
Infine, i fruitori del trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione, hanno diritto
alla corresponsione anticipata dell'indennità per l'avvio di nuove attività produttive (art. 1 bis L. n. 483/1994).
Il lavoratore cassintegrato può svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato. Deve tuttavia darne preventiva
comunicazione alla sede provinciale INPS, con conseguente perdita dell’integrazione per le sole giornate di lavoro
effettuate. In mancanza di tale comunicazione il lavoratore decade dal diritto all’integrazione. Il lavoratore decade
altresì in caso di mancata frequenza dei corsi di formazione professionale (L. n. 164/1975 ed anche D.L. n. 294/2004).
Intervento Ordinario
Cause integrabili
Intervento Straordinario
Situazioni aziendali dovute ad eventi Ristrutturazione,
riorganizzazione
transitori e non imputabili;
conversione aziendale;
Situazioni temporanee di mercato;
o
Crisi aziendale;
Procedure concorsuali;
Stipula di un contratto di solidarietà
difensivo;
Campi di applicazione
Imprese industriale (inclusa l’edilizia)
Imprese industriali (inclusa l’edilizia) e
cooperative di produzione e lavoro con più
di 15 dipendenti (più estensione ad altre
imprese)
Lavoratori aventi diritto
Operai, impiegati e quadri (esclusi Operai, impiegati, quadri e soci
dirigenti e apprendisti)
cooperative di produzione e lavoro
di
Misura dell’integrazione
80% della retribuzione globale di fatto, 80% della
massimale
ma con un massimale
un
retribuzione,
ma
con
60% della retribuzione perduta nei contratti
di solidarietà difensivi
Durata dell’integrazione
3 mesi continuativi con eventuali 24 mesi (+12 +12)
eccezionali proroghe trimestrali fino a
12 mesi, salvo casi oggettivamente non 12 mesi (+12)
evitabili
12 mesi (+6)
24 mesi (+24 o 36 nel meridione)
Procedura amministrativa
La domanda va inoltrata all’INPS (sede La domanda (corredata di programma),
provinciale) ed è accolta con delibera previo motivato parere della regione, è
inoltrata al Ministero del lavoro, che la
della commissione provinciale CIG
approva con decreto ministeriale
Finanziamento
Contributo
ordinario
a
carico Contributo ordinario a carico dello Stato +
dell’imprenditore
+
contributo contributo
addizionale
a
carico
addizionale a carico dell’imprenditore
dell’imprenditore
Modalità di pagamento
Anticipo da parte dell’imprenditore e Anticipo da parte dell’imprenditore
successivo conguaglio con l’INPS.
successivo conguaglio con l’INPS
e
Possibilità di richiesta di pagamento diretto
da parte dell’INPS in caso di comprovate
difficoltà finanziarie
Informazione e consultazione Comunicazione successiva a RSA (o Comunicazione successiva a RSA (o RSU) o
RSU) o in mancanza alle OO.SS in mancanza alle OO.SS provinciali +
sindacale
provinciali
+
rappresentative.
È rappresentative
ammessa
eccezionalmente
la
comunicazione preventiva.
CAPITOLO DIECI: LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il licenziamento individuale.
1.Le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.
L’estinzione del rapporto di lavoro può avvenire:
-per recesso del datore (licenziamento) o del lavoratore (dimissioni). Il recesso unilaterale è espressione del potere di
ciascuna delle parti di sciogliere il rapporto con la semplice comunicazione all’altra parte. Si tratta di un diritto
potestativo riconosciuto dall’ordinamento in deroga al principio generale secondo cui il contratto può essere risolto solo
per mutuo consenso. Il potere di licenziare trova nell’ordinamento penetranti limitazioni.
-per risoluzione consensuale. In tal caso non operano le limitazioni previste per il licenziamento, dovendosi però
ritenere operante la nullità prevista dalla L. n. 7/1963 nell'ipotesi in cui la risoluzione consensuale nasconda un
licenziamento coperto da un consenso estorto al dipendente. (es. sono nulle le dimissioni rese dalla lavoratrice in
occasione del matrimonio).
-per scadenza del termine nei contratti di lavoro a tempo determinato.
-per altre particolari circostanze specificamente previste dalla legge (ad esempio il mancato ritorno in azienda del
lavoratore dopo il servizio militare o dopo la reintegrazione ex art. 18 St. lav).
-per morte del lavoratore (salvi determinati oneri economici in favore dei superstiti). La morte del datore invece non
provoca la cessazione del rapporto, che prosegue con i successivi titolari dell'impresa; il rapporto si estingue solo se
strettamente e infungibilmente legato alla persona del datore.
-per impossibilità sopravvenuta e forza maggiore. Si discute se possano formare autonoma causa estintiva. Si
distinguono a tal uopo ipotesi riguardanti l’impresa o il datore. Tra le prime di enumerano il cosiddetto factum principis
(requisizione amministrativa, ordine dell’autorità di evacuare i locali, fenomeni naturali che abbiano distrutto i locali
aziendali, stato di guerra). Tra le ipotesi concernenti il lavoratore sono incluse la carcerazione, accertamento sanitario di
assoluta inidoneità al lavoro).
L’opinione prevalente è che l’impossibilità sopravvenuta e la forza maggiore rilevino come cause estintive non già alla
stregua della disciplina del diritto comune (art. 1464 e 1256 c.c.), ma nei limiti in cui configurano un giustificato motivo
oggettivo di licenziamento.
Per il caso in cui un lavoratore sia divenuto inabile nel corso del rapporto; in questo caso il legislatore ha espressamente
escluso la possibilità di intimare il licenziamento qualora il dipendente possa essere adibito a mansioni equivalenti o, in
mancanza, a mansioni inferiori.
2.Il recesso nella disciplina del codice civile.
La disciplina del recesso nel rapporto di lavoro era originariamente improntata ad una filosofia tipicamente liberista. In
base al codice civile del 1865, le parti, così come avevano piena libertà di costituire e disciplinare il rapporto,
disponevano in piena autonomia anche della sua cessazione (come sappiamo l’unico limite all’autonomia privata era
costituito dal divieto di lavoro a tempo indeterminato).
Tale ottica liberistica ha trovato riscontro anche nel codice del 1942, nel quale l’artt. 2118 attribuiva a ciascuno dei
contraenti la facoltà di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza fornire alcuna motivazione (recesso
ad nutum) (oggi la libertà di recesso dell’art. 2118 incontra le limitazioni poste dal legislatore).
Conseguenza di tale disposizione era dunque la preclusione del controllo del giudice sui motivi del licenziamento e l'
idoneità della semplice dichiarazione da parte del datore ad estinguere il rapporto.
La previsione del recesso ad nutum si collegava a vari principi di ordine generale: a)pareva garantire la libertà
individuale dei contraenti nei confronti di vincoli contrattuali a tempo indeterminato, potendo ciascuno liberarsi dal
rapporto istantaneamente; b) pareva garantire una presunta eguaglianza tra le parti, ponendole in posizione simmetrica
di fronte alla cessazione del rapporto; c)allineava la risoluzione del rapporto di lavoro a quella di ogni altro contratto
sinallagmatico a tempo indeterminato, considerandola alla stregua di un qualsiasi istituto contrattuale riconducibile al
diritto civile; d)creava una logica simmetrica tra la costituzione e la cessazione del rapporto di lavoro nel comune segno
della libera determinazione ad opera della volontà delle parti.
L’unico vincolo per il recedente ai sensi della disciplina codicistica è rappresentato dall’obbligo di preavviso (da cui
deriva il differimento della cassazione del rapporto). L’obbligo di preavviso trova fondamento nella necessità di tutelare
la parte receduta, consentendole il tempo necessario per trovare una nuova occupazione (nel caso di licenziamento) o un
sostituto (in caso di dimissioni).
L’obbligo di preavviso viene meno in caso di licenziamento per giusta causa, poiché ai sensi dell’art. 2119, la giusta
causa di licenziamento preclude la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto.
Nel caso di dimissioni sorrette da giusta causa poi, non solo il lavoratore è esonerato dall’obbligo di preavviso, ma ha
anche diritto ad un’indennità sostitutiva del preavviso.
La durata del preavviso non è predeterminata dal codice, che sul punto rinvia alla contrattazione collettiva e, in
mancanza, agli usi o all’equità.
Ai sensi dell'art. 2110 c.c., il lavoratore in malattia non può essere licenziato fino alla cessazione dello stato morboso o
alla scadenza del periodo di comporto. L'art. 2109 c.c., impedisce la computabilità nelle ferie del periodo di preavviso.
Il codice all'art. 2118 autorizza la parte che recede a sostituire il periodo di preavviso con un’indennità pari alla
retribuzione che sarebbe spettata in caso di preavviso lavorato (c.d. indennità sostitutiva del preavviso).L'indennità di
preavviso (art. 2121 c.c.) viene calcolata in un numero di mensilità o di giorni stabilito dai contratti collettivi. La
sostituzione del periodo di preavviso con la relativa indennità è una facoltà della parte recedente.
La sostituzione del preavviso con l’indennità però non produce l’anticipata risoluzione del rapporto, il quale, pur in
assenza di prestazione, resta giuridicamente attivo fino al termine del periodo di preavviso, sicché eventuali incrementi
retributivi producono effetto in favore del lavoratore.
Tuttavia è lecito un accordo mediante il quale il datore e il lavoratore prevedano la risoluzione immediata del rapporto,
precludendo istantaneamente la maturazione di ulteriori vantaggi economici e normativi. Per la validità di siffatto
accordo occorre una manifestazione di volontà esplicita o implicita (mediante comportamenti concludenti). La mera
accettazione dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché del TFR non concretizza alcun comportamento concludente
in tal senso.
Il codice all'art. 2119 esclude espressamente che il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa integrino una
giusta causa di licenziamento. Pertanto l’apertura di tali procedure concorsuali non comporta l’automatica cessazione
dell’attività di impresa; è anzi previsto che all'esercizio provvisorio dell'impresa possa essere autorizzato il curatore del
fallimento o il liquidatore. In tal caso i rapporti di lavoro continuano regolarmente ed il licenziamento potrà essere
intimato soltanto se si verifica un inadempimento dei lavoratori o se l'attività aziendale venga realmente a cessare con
l'obbiettiva impossibilità di utilizzare la forza lavoro.
Anche il trasferimento d’azienda non integra di per sé causa di giustificazione del licenziamento; anzi il legislatore si è
preoccupato di garantire le continuità occupazionale dei dipendenti “ceduti”.
3.L'introduzione della regola della necessaria giustificazione del licenziamento.
La logica che giustificava il recesso ad nutum era assolutamente mistificatoria. Il rispetto dell’eguaglianza formale si
poneva infatti in totale contrasto con l’eguaglianza sostanziale, data la diversa posizione delle parti del rapporto di
lavoro.
Infatti, mentre le dimissioni del lavoratore creano al datore solo un fastidio dovuto alla sostituzione del lavoratore
(peraltro agevolata dalla tendenziale ricchezza dell’offerta di lavoro), il licenziamento produce un danno ben maggiore
per il lavoratore, in virtù della difficoltà di reperire una nuova occupazione in un mercato decisamente ostile (nonché
per il fatto di privarlo dell’unica o principale fonte di sostentamento).
Ciò pose l’attenzione sulla necessità di una rivisitazione della materia. Con l'avvento della Carta Costituzionale si
generò l'auspicio- anche attraverso una valorizzazione degli art 4 e 41 della Costituzione e dell'art 1345 c.c., sul motivo
illecito- che si affermasse un generale divieto dei licenziamenti immotivati.
Una disciplina legislativa della materia trovò inizialmente l'opposizione, oltre che da parte datoriale, ad opera della
CISL, ostile da sempre agli interventi legislativi in materie ritenute di competenza dell'autonomia collettiva.
Tuttavia in tale contesto si affermò la L. 604/1966 sui licenziamenti individuali. Tale legge manteneva intatta la libertà
di dimissioni, cui continua ad applicarsi la disciplina codicistica, e introdusse il principio della giustificazione obiettiva
del potere di recesso, dichiarando illegittimo il licenziamento non sorretto da giusta causa o da giustificato motivo. La
stessa legge introduceva le nuove definizioni di giustificato motivo (nella duplice configurazione soggettiva e oggettiva)
mentre rinviava per l’identificazione della giusta causa al codice civile e più precisamente all'art 2119.
Quindi mentre nel regime del codice, l’esistenza o meno della giusta causa rilevava solo ai fini della concessione del
preavviso (o della indennità sostitutiva), in presenza della disciplina legislativa vincolistica sui licenziamenti
individuali, l’assenza di giusta causa comporta la illegittimità del licenziamento.
La legge 604 all'art. 5 inoltre pose l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo a carico del datore,
chiamato così a supportare anche sul piano probatorio la legittimità del recesso.
L'art. 8 della stessa legge infine, prevedeva, in caso di licenziamento ingiustificato, un regime sanzionatorio ritenuto
alquanto moderato o compromissorio; riassunzione del lavoratore o (a scelta del datore) pagamento di una penale
risarcitoria ragguagliata ad un numero di mensilità di retribuzione che variava, a seconda delle dimensioni dell’impresa,
dell’anzianità di servizio e del comportamento delle parti. Nei fatti, i datori optavano quasi sempre per il pagamento
dell’indennità risarcitorio, quindi salvaguardando il potere del datore di lavoro di estinguere anche immotivatamente il
rapporto, salva l'efficacia dissuasiva dell'onere economico.
Soltanto per i licenziamenti per rappresaglia (ossia determinati da ragioni ideologiche, religiose, politiche o sindacali)
veniva apprestato un regime di più radicale nullità (indipendentemente dalle dimensioni aziendali), con conseguente
prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità.
Un deciso passo in avanti si ebbe con l’art. 18 St. lav., che segna il passaggio da un regime di stabilità meramente
obbligatoria ad un regime di stabilità reale.
In base all’art. 18, laddove il giudice ritenga il licenziamento non assistito da giusta causa o da giustificato motivo, deve
ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro senza alcuna possibilità alternativa di tipo risarcitorio. Oltre
alla reintegrazione, il giudice condanna il datore al risarcimento del danno subito dal lavoratore, risarcimento
commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione (e
comunque non inferiore a 5 mensilità).
In sostanza il datore può anche non reintegrare effettivamente il lavoratore, ma dovrà comunque continuare a pagargli
ininterrottamente un’indennità pari alle retribuzioni correnti (il che rappresenta un fortissimo incentivo alla effettiva
reintegrazione ed utilizzazione del lavoratore). Soltanto il lavoratore potrà liberare il datore dalla reintegra e
dall’obbligo risarcitorio, chiedendo in sostituzione della reintegrazione un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione,
oppure non riprendendo servizio entro 30 giorni dall’invito rivoltogli dal datore.
L’art. 18 prevede poi lo stesso regime sanzionatorio per i licenziamenti per rappresaglia e per i licenziamenti inefficaci
per vizio di forma. La disciplina dell’art. 18 tuttavia si applica soltanto ai datori di lavoro e alle unità produttive che
superano determinate soglie occupazionali.
La L. 108/1990 poi, ha ridotto al minimo i casi di recesso ad nutum; solo per alcune categorie di lavoratori
(collaboratori domestici, lavoratori in prova e con certi limiti anche i dirigenti) permane un regime di libera recedibilità.
4.La giusta causa.
L’art. 2119 autorizza ciascuna delle parti a recedere per giusta causa dal contratto qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In tale ipotesi, come detto, la parte recedente non è tenuta a
dare preavviso.
Parte della dottrina ravvisa la giusta causa non soltanto in un gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali, ma
anche in qualsiasi altra circostanza o situazione esterna al rapporto di lavoro, verificatasi nella sfera del lavoratore, che
sia idonea a ledere il vincolo di fiducia tra le parti e perciò ad impedire la prosecuzione del rapporto.
Per altri invece la giusta causa viene identificata esclusivamente solo con un vistoso inadempimento degli obblighi
contrattuali, imputabile a colpa o dolo del lavoratore, a nulla rilevando fatti “esterni” al rapporto (ed in particolare
comportamenti che rientrano nella vita privata del dipendente).
La prima tesi viene tra l'altro supportata dall'art. 9 della legge sull'impiego privato (R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825)antesignano dell'art. 2119 c.c.- il quale alludeva ad una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto, mentre il codice civile del 1942, ha sostituito il termine “mancanza” con quello più ampio e
neutro di “causa”, il che accrediterebbe appunto l'attuale maggiore ampiezza delle ragioni legittimanti il licenziamento
in tronco.
In effetti, almeno in determinate ipotesi, fatti o comportamenti apparentemente estranei alla sfera contrattuale e magari
attinenti alla vita privata del lavoratore possono compromettere l’elemento fiduciario e quindi esser invocati ai fini della
ricorrenza della giusta causa. Basti pensare alla guardia giurata che viene sorpresa a rubare al di fuori del rapporto di
lavoro, o alla commessa di un supermercato condannata per il furto commesso in un altro supermercato, o al cassiere di
banca che commette un reato contro il patrimonio.
A ben vedere però, in questi casi il fatto o il comportamento “esterno” in tanto ha rilievo in quanto finisce per incidere
sulla aspettativa della controparte di un esatto adempimento per il futuro, della obbligazione lavorativa. Non basta
dunque che sia pregiudicato un generico rapporto fiduciario o che sia messa in discussione la compatibilità personale tra
datore e prestatore di lavoro, ma occorre che venga meno la fiducia nella puntualità dei successivi adempimenti,
elemento generalmente rilevante in tutti i contratti di durata.
La giurisprudenza, evitando di delineare rigidi confini in ordine alla rilevanza di comportamenti estranei alla sfera
contrattuale, insiste sulla necessità di una valutazione complessiva ed in concreto delle singole fattispecie. Ai fini della
sussistenza della giusta causa non è sufficiente una valutazione in astratto, ma occorre verificare se, tenuto conto della
natura del singolo rapporto, della posizione delle parti, delle mansioni espletate e del particolare grado di fiducia
connesso alla qualifica rivestita, la mancanza commessa si riveli talmente grave da non consentire la prosecuzione del
rapporto.
In giudizio valutativo trova applicazione un criterio (principio) di sussidiarietà, per effetto del quale il recesso per
giusta causa viene legittimato soltanto nelle ipotesi in cui il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o le minori
sanzioni disciplinari risultino inadeguati.
Con riguardo alle cosiddette organizzazioni di tendenza tipicamente orientate al perseguimento di finalità ideologiche
(partiti, sindacati, giornali politicamente orientati, scuole d'ispirazione religiosa) il concetto di giusta causa viene reso
più elastico sino a ricomprendere anche situazioni di incompatibilità personale agli scopi o all'ideologia
dell'organizzazione, giacché in tal caso il profilo fiduciario attiene strettamente al contratto di lavoro ed alle
obbligazioni assunte.
Quale che sia la concezione preferibile, la giusta causa consiste comunque in un fatto di tale gravità da imporre
l’immediata estromissione del lavoratore, mentre resta ininfluente l’effettivo pregiudizio subito dal datore (ad esempio
nel caso di un guardiano che si allontani più volte dal luogo da sorvegliare, la configurabilità della giusta causa
prescinde dall’effettivo verificarsi in concreto di episodi di furto o danneggiamento).
Spesso i contratti collettivi provvedono ad elencare i fatti definibili in concreto come giusta causa e giustificato motivo
soggettivo. Si tende tuttavia a negare alcuna vincolatività a tali elencazioni, che, per quanto rilevanti in ragione della
loro provenienza dalle parti sociali, non esimono tuttavia il giudice dall’onere di indagare sulla reale entità e gravità
della mancanza nel caso specifico.
La pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore non rappresenta di per se giusta causa; ciò che rileva è
invece il fatto oggetto dell’imputazione, che può integrare giusta causa a seconda dell’incidenza o meno sul piano delle
obbligazioni contrattuali e della aspettativa di adempimento.
Nel caso in cui un fatto contestato come giusta causa non venga riconosciuto come tale, ma tuttavia venga accertato dal
giudice come giustificato motivo soggettivo, è ammessa la conversione del licenziamento per giusta causa in
licenziamento per giustificato motivo soggettivo (conversione alla quale consegue il solo diritto del lavoratore
all’indennità per mancato preavviso).
5.Il giustificato motivo soggettivo.
La definizione del giustificato motivo- che può essere soggettivo o oggettivo- è contenuta nell'art. 3 della L. n.
604/1966.
Il giustificato motivo soggettivo si realizza quando il lavoratore incorre in un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali, che legittima il licenziamento con preavviso (a differenza di quello per giusta causa che è senza preavviso).
Per coloro che ritengono che il concetto di giusta causa identifichi solo un inadempimento contrattuale, la differenza col
giustificato motivo soggettivo è solo quantitativa (il giustificato motivo soggettivo si caratterizzerebbe solo per la
minore gravità dell’inadempimento, capace di consentire la prosecuzione del rapporto).
Per coloro che invece sostengono che la giusta causa abbracci anche quei fatti e comportamenti extracontrattuali idonei
a ledere la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti, la differenza è anche qualitativa.
L’inadempimento può riguardare solo e tutti gli obblighi contrattali discendenti dal contratto di lavoro, ossia quelli
relativi alla prestazione lavorativa, con i suoi corollari (diligenza, correttezza, non concorrenza, non divulgazione di
notizie aziendali).
Peraltro solo un inadempimento notevole integra gli estremi del giustificato motivo soggettivo (ad un inadempimento
minore fa seguito la sola applicazione di sanzioni disciplinari). Il criterio di identificazione del carattere “notevole”
dell'inadempimento va individuato nel grado di colpa del lavoratore e non nell’utilità del datore compromessa
dall’inadempimento.
Per quanto sia apprezzabile a livello metodologico il raffronto tra il criterio della notevolezza stabilito dall'art. 3 della L.
n. 604/1966 e quello della “non scarsa importanza” dell'inadempimento fissato in generale dall'art. 1455 c.c., resta
preclusa qualsiasi coincidenza tra i due criteri.
In ogni caso ampia è la discrezionalità del giudice nel classificare un determinato inadempimento come giusta causa di
licenziamento o come giustificato motivo soggettivo, non potendo ritenersi vincolanti, ma solo orientative le
tipizzazioni del giustificato motivo soggettivo operate dalla contrattazione collettiva.
Il legislatore ha espressamente escluso la configurabilità di un giustificato motivo di licenziamento nel caso di rifiuto
del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Sempre con riguardo alla
tipologia del lavoro part-time è altresì stabilito che l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il
consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo e che l'eventuale rifiuto
dello stesso non integri gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
6.Il giustificato motivo oggettivo.
Ai sensi dell'art. 3 L. n. 604/1966 il giustificato motivo oggettivo consiste in ragioni inerenti all’attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e legittima il recesso del datore di lavoro nel rispetto
del periodo di preavviso.
Nel contrasto tra l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto e quello del datore ad espellere unità lavorativa
realmente non più funzionali alle esigenze dell’impresa, è il secondo a prevalere.
Sono però richieste 2 condizioni:
-l’effettività delle esigenze aziendali richiamate nella motivazione del licenziamento;
-un preciso nesso di causalità tra tali esigenze ed il licenziamento.
Il giudice deve dunque accertare l’effettiva soppressione di una posizione lavorativa all’interno dell’azienda
(riconducibile a scelte organizzative del datore). In forza del principio di libertà di iniziativa economica privata (art. 41
Cost.) le scelte di gestione dell’imprenditore non sono sindacabili da parte del giudice, che deve limitarsi ad accertarne
la sola effettiva realizzazione. Egli deve poi verificare l’esistenza di un nesso di causalità tra le modifiche organizzative
operate dal datore ed il licenziamento, ossa la coerenza del licenziamento rispetto a tali modifiche organizzative (ad
esempio non è legittimo il licenziamento di un lavoratore non interessato da un processo di riorganizzazione).
Di massima si ritiene che il licenziamento sia assistito da un giustificato motivo oggettivo solo quando il lavoratore non
possa essere utilizzato su posizioni di lavoro alternative (ciò conformemente alla concezione del licenziamento come
estrema ratio). L’onere di provare l’impossibilità di proficuo utilizzo del lavoratore in posti di lavoro diversi è a carico
del datore, ma data la difficoltà di fornire una simile prova la giurisprudenza si accontenta di elementi probatori
presuntivi, come la dimostrazione di non aver proceduto ad assunzioni. Sir richiede dunque una priva di tipo “statico”,
riferito allo stato dell'organizzazione del lavoro e non alle ipotetiche modifiche organizzative che il datore potrebbe
attuare per reperire nuove possibilità occupazionali.
Il giustificato motivo oggettivo non attiene esclusivamente all’attività aziendale e all’organizzazione del lavoro. Anche
vicende soggettive possono rientrarvi qualora comportino un oggettivo impedimento al regolare funzionamento
dell’attività aziendale. Si tratta di situazioni del lavoratore che si ripercuotono negativamente sull’attività e
sull’organizzazione aziendale (si pensi alla carcerazione preventiva del lavoratore, per fatti estranei agli obblighi verso
il datore o al ritiro della patente per un autista o alla sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore a svolgere
le mansioni).
Secondo la giurisprudenza prevalente le assenze del lavoratore per carcerazione preventiva non integrano di per sé una
giusta causa o un giustificato motivo soggettivo del licenziamento, ma possono determinare una sopravvenuta
impossibilità parziale della prestazione a norma dell'art. 1464 c.c., la cui idoneità estintiva del rapporto va valutata in
relazione alle dimensioni dell'impresa, al tipo di organizzazione tecnico produttiva, alla durata ragionevolmente
prevedibile dell'assenza, alla natura e fungibilità delle mansioni del lavoratore detenuto.
Altra questione di rilievo concerne il fenomeno delle brevi malattie reiterate in relazione alle quali si è posto il problema
della ricondicibilità alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, qualora le assenze determinino un pregiudizio per
il regolare funzionamento dell'attività aziendale. La Suprema Corte a Sezioni Unite ha definitivamente escluso che le
assenze per malattia possano essere qualificate come giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Ciò significa che
non è possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo prima del decorso del termine di comporto di cui all'art.
2110 c.c.
7.Il licenziamento discriminatorio ed i periodi di irrecedibilità.
7.1.Il licenziamento discriminatorio.
Il licenziamento discriminatorio (in origine art. 4 L. n. 604/1966) è determinato da “ragioni di credo politico o fede
religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacale è nullo indipendentemente dalla
motivazione addotta e nell'art 15 St. lav.- come modificato dalla L. n. 903/1977 e dal D.lgs. n. 216/2003- stabilisce la
nullità di qualsiasi patto o atto diretto “a licenziare un lavoratore a causa della sua affiliazione o attivitià sindacale o
della sua partecipazione ad uno sciopero” nonché dei licenziamenti attuati “a fini di discriminazione politica, religiosa,
razziale, di lingua e di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali”.
La L. 108\’90 ha introdotto un regime sanzionatorio ancora più efficace, confermando la nullità dei licenziamenti
discriminatori e considerando altresì applicabile la sanzione reintegratoria in qualsiasi caso o il pagamento della
cosiddetta indennità supplementare. Interessante è a tal proposito l’estensione della tutela reale ai dirigenti
“discriminati”.
A prescindere dalla motivazione addotta dal datore, incombe sul prestatore l’onere di provare l’intento discriminatorio
sotteso al licenziamento, onere che risulta in qualche modo alleviato sia dall'obbligo di motivazione del licenziamento,
che impone al datore di comprovare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sia dalla possibilità di fare
ricorso a presunzioni, al fine di dimostrare le finalità discriminatorie dell'atto.
7.2.I periodi di irrecedibilità.
Il potere di recesso del datore non è vincolato solo a presupposti causali, ma incontra anche limiti temporali. La ragione
di fondo che presiede a tali limiti è legata alla tutela di diritti fondamentali e della stabilità del rapporto del lavoratore
quale individuo e cittadino, diritti costituzionalmente rilevanti e preminenti sull’obbligazione lavorativa (come il diritto
alla salute o all'assolvimento del servizio militare, di cariche politiche o sindacali).
Le ipotesi principali di limitazione temporanea del potere di licenziare sono elencate agli artt. 2110 e 2111 (malattia,
infortunio, gravidanza, puerperio e servizio militare). In queste ipotesi il datore può recedere dal rapporto di lavoro solo
quando sia trascorso il periodo protetto, stabilito dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. Abbiamo già detto
che il licenziamento intimato durante il periodo di comporto è inefficace. Esso acquisterà efficacia al termine di detto
periodo (anche se taluni ritengono che in tal caso il licenziamento non sia inefficace ma affetto da nullità insanabile al
termine del comporto).
È previsto un periodo di irrecedibilità anche nei periodi che precedono e seguono immediatamente il matrimonio della
lavoratrice (dal momento delle pubblicazioni fino ad 1 anno dalla celebrazione del matrimonio). L'art. 1 della L. 9
gennaio 1963, n. 7 dispone che al fine evitare che il licenziamento per causa di matrimonio venga mascherato sotto
formali dimissioni della lavoratrice, sono ritenute nulle le dimissioni rassegnate dalla stessa nel medesimo periodo. In
tal caso il rapporto non si trova in fase di sospensione (la lavoratrice è tenuta a svolgere la propria prestazione
lavorativa). Tuttavia il divieto di recesso è stato imposto per evitare qualsiasi valutazione del datore circa la
convenienza dell’ulteriore occupazione della lavoratrice, nel timore di una futura maternità.
È ancora previsto dall'art. 54 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 un divieto generale di licenziamento, pena la nullità, per
la lavoratrice madre (dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità, nonché fino al compimento
di 1 anno di vita del bambino) e per il lavoratore padre (fino al termine del congedo di paternità nonché fino al
compimento di 1 anno di vita del bambino). Il lavoratore licenziato in tale periodo deve presentare documentazione
dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
Il divieto di licenziamento tuttavia non si applica in caso:
-di colpa grave costituente giusta causa di licenziamento;
-di cessazione dell’attività aziendale;
-di ultimazione della prestazione per la quale si è stai assunti o di risoluzione del rapporto per scadenza del termine;
-di esito negativo della prova.
È inoltre sancita la nullità del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la
malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore. Nell'ipotesi di adozione e di affidamento il divieto di
licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo
di maternità o di paternità. La corte costituzionale con la sentenza n. 495 del 2001 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 24, D.lgs n. 151/2001 nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità
nell'ipotesi di licenziamento per giusta causa intimato durante il periodo di irrecedibilità.
È opportuno specificare che la previsione di irrecedibilità durante detti periodi non esclude la possibilità di
licenziamento per giusta causa, ma solo del recesso ad nutum e di quello per giustificato motivo. Ovviamente nei
periodi di irrecedibilità coincidenti con la sospensione del lavoro la giusta causa può riguardare solo la violazione degli
obblighi accessori e non l’obbligazione lavorativa principale (che è sospesa), a meno che l’inadempimento si sia
verificato prima della sospensione e sia venuto a conoscenza del datore di lavoro solo in seguito.
L’unico fatto oggettivo (non riguardate comportamenti del lavoratore ma vicende aziendali) capace di estinzione del
rapporto di lavoro durante il periodo di comporto è la cessazione dell’attività aziendale che determina l'impossibilità
materiale della prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
8.La forma e la procedura di irrogazione del licenziamento.
La presenza dei requisiti sostanziali- giusta causa o giustificato motivo soggettivo od oggettivo- è condizione
necessaria, ma non sufficiente per poter configurare il licenziamento come legittimo. Occorre, infatti, che il
licenziamento venga irrogato secondo ben precise modalità a garanzia della posizione del lavoratore.
8.1.Il licenziamento non disciplinare.
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore, mentre non è necessaria l’indicazione dei motivi, i
quali possono essere richiesti dal lavoratore entro 15 giorni dalla comunicazione (in tal caso il datore è tenuto ad
esplicitarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta). Diversa è la procedura di irrogazione del licenziamento
disciplinare.
Solo per i lavoratori domestici, per i lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici e per i lavoratori
in prova permane un principio di libertà di forma, nel senso che il licenziamento può essere intimato oralmente e senza
motivazione.
Il licenziamento dei dirigenti richiede la forma scritta ma non anche un obbligo di motivazione (art 2 L. n. 108/1990).
Il licenziamento, in quanto atto unilaterale recettizio, produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza del
lavoratore (art. 1334 c.c.).
L'onere della forma scritta è rispettato anche nel caso in cui il datore di lavoro offra in consegna la lettera di
licenziamento al dipendente che rifiuti di riceverla e nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salva la
prova dell'impossibilità incolpevole di effettiva conoscenza.
Il licenziamento carente di forma o di motivazione (se richiesta) posto in essere da datori di lavoro cui si applica l’art.
18 St. lav., è assoggettato alla stessa disciplina del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo
(reintegrazione + risarcimento pari ad almeno 5 mensilità di retribuzione). Il licenziamento viziato nella forma attratto
nell’area della stabilità obbligatoria invece, viene qualificato dalla L. 604\’66 come inefficace; da esso non deriveranno
effetti giuridici ed il lavoratore avrà diritto a risarcimento del danno, che tuttavia in tal caso sarà determinato secondo le
regole generali sull’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e non secondo l’art. 18 St. lav (non dunque con il
minimi di 5 mensilità).
Il licenziamento viziato per ragioni di forma può essere rinnovato osservano le modalità prescritte e la cessazione del
rapporto si produrrà solo al momento della rinnovazione.
Se l'enunciazione scritta dei motivi può non essere contestualmente all'intimazione del licenziamento, tuttavia una volta
effettuata deve essere tale da consentire al lavoratore di precostituire una linea difensiva. Di qui i corollari di
completezza, analiticità e immutabilità della motivazione. In forza del principio di immutabilità restano precluse la
modifica dei fatti e l'allegazione, in epoca successiva alla contestazione, di addebiti già noti al datore e non contestati al
lavoratore.
8.2. Il licenziamento disciplinare.
Il licenziamento disciplinare è volto a sanzionare un comportamento colposo o comunque manchevole del lavoratore.
Esso è espressione del potere disciplinare del datore e come tale, è sottoposto ad oneri formali più incisivi. Non basta la
mera comunicazione del licenziamento e l’eventuale successiva specificazione dei motivi, ma occorre rispettare gli
oneri procedurali che l’art. 7 St. lav. prevede per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. I momenti essenziali di tale
procedura sono:
-preventiva affissione del codice disciplinare in luogo accessibile ai lavoratori;
-contestazione per iscritto degli specifici addebiti mossi al lavoratore;
-concessione di un termine per dare modo al lavoratore di presentare le proprie giustificazioni;
-la previsione di una pausa di riflessione (5 giorni) tra la contestazione dell'addebito e l'applicazione del provvedimento
disciplinare.
Tuttavia l’art. 7 St. lav. specifica che “non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro”. Il che ha fatto sorgere la dottrina il dubbio se il licenziamento possa o meno essere
qualificato quale sanzione disciplinare, e se, di conseguenza, possa trovarvi applicazione l’art. 7 St. lav.
Si sono manifestate 2 tesi opposte al riguardo (una che considera il licenziamento disciplinare la più grave delle
sanzioni disciplinari ed una che ritiene il licenziamento disciplinare irriducibile ad una sanzione, proprio per la sua
natura “espulsiva”, mentre la sanzione postulerebbe la prosecuzione del rapporto). Alle due tesi radicalmente opposte ne
è stata avanzata anche una terza , secondo la quale l’art. 7 St. lav diviene applicabile al licenziamento disciplinare solo
allorché esso sia esplicitamente annoverato tra le sanzioni disciplinari dalla contrattazione collettiva.
La questione è stata risolta dalla sentenza n.204 della Corte Costituzionale del 1982, che ha stabilito che i primi 3
commi dell’art. 7 (affissione del codice disciplinare, contestazione degli addebiti, e assistenza sindacale) devono
applicarsi a tutti i licenziamenti disciplinari.
La cassazione ha poi specificato che il licenziamento deve ritenersi disciplinare quando sia correlato ad un
comportamento imputabile a titolo di colpa al lavoratore e che è irrilevante la sua eventuale esplicita qualificazione in
termini disciplinari nella contrattazione collettiva.
Secondo tale impostazione (cosiddetto ontologico) dunque il licenziamento disciplinare copre per intero l’area del
licenziamento per giustificato motivo soggettivo e quasi totalmente quella del licenziamento per giusta causa.
Sicché, a seguito dell’intervento della corte costituzionale risultano estesi al licenziamento disciplinare il principio di
pubblicità e l’obbligo di contestazione preventiva dell’addebito, per dar modo al lavoratore di preparare la propria
difesa (eventualmente con l’assistenza del sindacato). Inoltre è stato dibattuto il tema dell'applicazione o meno ai
licenziamenti disciplinari della cosiddetta pausa di riflessione di 5 giorni prevista dall'art. 7 St. lav.
La cassazione ha a riguardo però precisato che nel caso in cui i fatti addebitati al lavoratore configurino illeciti penali o
gravi violazioni dei doveri fondamentali del lavoratore, la mancata affissione del codice disciplinare non inficia la
legittimità del licenziamento (giacché il lavoratore non rischia di incorrere in sanzioni per fatti da lui non
preventivamente conosciuti come mancanze).
Mentre dunque nel licenziamento non disciplinare la comunicazione del recesso può essere contemporanea o precedente
alla comunicazione dei motivi, nel licenziamento disciplinare la contestazione degli addebiti deve necessariamente
precedere l’adozione del provvedimento espulsivo.
Inoltre la contestazione degli addebiti deve rispettare i principi di specificità (i fatti vanno riferiti in modo preciso, per
consentire una difesa puntuale), immutabilità (il fatto risultante dalla contestazione non può essere successivamente
modificato) e immediatezza (il licenziamento deve essere intimato in stretta correlazione temporale con il verificarsi dei
fatti che giustificano la cessazione del rapporto).
L’immediatezza è presupposto di legittimità del provvedimento, ma va comunque riferita, non all’epoca in cui si è
verificata la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo, ma al momento in cui il datore, tenuto conto delle
circostanze, abbia avuto piena conoscenza del fatto posto a fondamento del recesso.
Anche con riguardo ai licenziamenti disciplinari occorre interrogarsi sulle conseguenze giuridiche del mancato rispetto
della forma e\o della procedura, distinguendo i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 18 St.
lav., da quelli (di dimensioni minori) che rientrano nello spazio operativo della L. 604/1966 e infine dalle situazioni in
cui vige un regime di libera recedibilità (recesso ad nutum).
In ogni caso il licenziamento disciplinare adottato senza il rispetto delle garanzie previste dall’art. 7 St. lav. va
considerato ingiustificato; per quanto riguarda le conseguenze giuridiche bisogna distinguere:
Per quanto riguarda i datori che rientrano nell’area di applicazione della stabilità reale (le aziende di dimensioni
maggiori) vedranno applicarsi il regime sanzionatorio previsto dall’art. 18 St. lav. (reintegrazione del lavoratore +
risarcimento del danno non inferiore a 5 mensilità) (tutela reale).
Per quanto riguarda i datori che si collocano nell’area di applicazione della stabilità obbligatoria, il licenziamento
disciplinare che presenti vizi di procedura non è affetto da nullità, ma produce gli effetti tipici dell’area di tutela
obbligatoria, indicati dalla L. 604/1966 (che prevede la possibilità di scelta del datore tra riassunzione e pagamento di
un’indennità).
Per quanto concerne poi l’area della libera recedibilità (anche in tale ambito trovano applicazione le garanzie previste
dall’art. 7 St. lav.), invece, è controverso se la conseguenza della violazione della forma o della procedura comporti
l’inefficacia del licenziamento (con conseguente prosecuzione del rapporto) o la mera corresponsione dell’indennità di
preavviso (va tuttavia detto che, a seguito della L. 108/1990 l’area di applicazione del recesso ad nutum è estremamente
ridotta).
Quanto ai dirigenti, il licenziamento disciplinare intimato senza il rispetto della procedura dà luogo all'obbligo per il
datore di versare l'indennità aggiuntiva prevista dai contratti collettivi per l'ipotesi di licenziamento giustificato, ma non
produce l'invalidità del recesso.
9.L'impugnativa del licenziamento.
L'art. 6 della L. n. 604/1966 stabilisce che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni
dalla ricezione della comunicazione (o dalla comunicazione dei motivi, laddove questa non sia contestuale). Sicché in
caso di licenziamento con preavviso, la decorrenza avviene già durante il periodo di preavviso, anche se il rapporto non
si è ancora estinto.
Decorso tale termine, il lavoratore decade dal diritto di impugnazione e il giudice non potrà rilevare d’ufficio
l’insussistenza di un giustificato motivo di licenziamento (la cassazione ha stabilito che la decadenza dal diritto di
impugnativa preclude ogni possibilità di accertamento da parte del giudice relativo all’eventuale illegittimità del
licenziamento).
La previsione di un termine di decadenza si spiega con la necessità di garantire un minimo di certezza al potere
organizzativo del datore, evitando che questi resti esposto per lungo tempo al rischio di una reintegrazione del
lavoratore con relativo risarcimento.
La decadenza è applicabile non solo al licenziamento ingiustificato, ma anche a quello nullo in quanto discriminatorio,
nonché al licenziamento disciplinare viziato dal mancato rispetto del procedimento previsto dall’art. 7 St. lav.
Il termine di decadenza è insuscettibile di sospensione o interruzione (anche in caso di incapacità del lavoratore). Solo
la comunicazione al datore della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione può sospendere il decorso del
termine (per la durata di tale tentativo) e solo la comunicazione della volontà di impugnare il provvedimento ha
efficacia interruttiva.
L’impugnativa può essere giudiziale o extragiudiziale. È considerato impugnativa extragiudiziale qualunque atto scritto
mediante il quale il lavoratore, a prescindere da formule sacramentali, manifesta inequivocabilmente al datore la volontà
di contestare la legittimità del recesso. Evitata così la decadenza, il lavoratore ha la possibilità di agire in giudizio, entro
il termine di prescrizione, al fine di ottenere, a seconda dei casi, l’applicazione dell’art. 18 St. lav. o della disciplina
contenuta nella L. 604\1966.
Tuttavia può accadere che il lavoratore impedisca la decadenza direttamente attraverso l’impugnativa giudiziale, nel
qual caso, per evitare la decadenza dal diritto all’impugnativa, è necessario che il deposito del ricorso e la sua notifica al
datore avvengano entro i 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento.
Si è posto poi il problema se anche il licenziamento orale debba essere impugnato nel termine di 60 giorni. La
giurisprudenza prevalente, in ossequio alla qualificazione di inefficacia operata dal legislatore, sostiene che il
licenziamento formalmente viziato è insuscettibile di produrre qualsiasi effetto e va formalmente considerato tamquam
non esset, con la conseguenza che il lavoratore può in qualunque tempo proporre l’ordinaria azione di accertamento
dell’inefficacia del licenziamento.
Tentativo obbligatorio di conciliazione
L'art. 5 della L. n. 108/1990 ha previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale che deve essere
preventivamente promosso dal lavoratore che intenda impugnare l’atto di licenziamento.
Originariamente il tentativo di conciliazione era obbligatorio solo per i lavoratori appartenenti ad imprese che
rientrassero nell’ambito di applicazione del regime di stabilità obbligatoria (ossia imprese di dimensioni minori). Il
D.lgs. 80/1998 ha poi esteso l’obbligo di esperimento del tentativo di conciliazione a tutti i lavoratori cui sia intimato il
licenziamento, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa.
Se il ricorso viene proposto in difetto del tentativo di conciliazione, il giudice deve sospendere il processo e fissare un
termine, non superiore a 60 giorni, entro cui le parti devono proporre la richiesta del tentativo di conciliazione.
Il procedimento di conciliazione si conclude con un verbale che sancisce il successo o il fallimento del tentativo.
Se il tentativo di conciliazione fallisce, datore e lavoratore hanno facoltà di promuovere un arbitrato per la soluzione
della vertenza. In ogni caso non si tratta di un tentativo da esperire obbligatoriamente ma solo di una facoltà delle parti,
che possono liberamente decidere di rivolgersi direttamente al giudice.
Il tentativo di rilanciare forme di composizione stragiudiziale delle controversie in tema di licenziamento intimato da
parte dei datori di lavoro “minori” trova giustificazione nell'intento legislativo di favorire, negli ambiti produttivi più
ristretti, decisioni in qualche misura equitative ed attente anche alla specificità ambientale della vicenda nonché nella
preoccupazione di non gravare delle spese del giudizio ordinario i datori di lavoro con minori potenzialità economiche.
10.L'onere della prova.
La distribuzione dell’onere della prova in materia di licenziamenti individuali è regolata dall'art 5 L. n. 604/1966,
secondo il quale “ l'onera della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento
spetta al datore di lavoro”(data la sua posizione di forza nel rapporti con il lavoratore anche dal punto di vista
processuale). In applicazione di tale principio, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'inutilizzabilità del lavoratore
licenziato per giustificato motivo oggettivo. Nessuna giustificazione invece deve esser fornita laddove sia ancora
legittimo il recesso ad nutum.
Quanto detto riguarda la prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo; tuttavia i problemi di
ripartizione dell’onere della prova non si esauriscono qui.
In primo luogo può darsi ad esempio il caso che venga in contestazione l’esistenza di quei presupposti (numero dei
dipendenti) da cui discende l’applicabilità dell’uno o dell’altro regime sanzionatorio del licenziamento invalido (oppure
l’operatività del recesso ad nutum); la cassazione ha stabilito che spetta al lavoratore l’onere di provare l’esistenza di
tali presupposti, in quanto fatti costitutivi del diritto (alla stabilità reale o obbligatoria) rivendicato in giudizio, salvi i
poteri istruttori integrativi del giudice.
Altra ipotesi riguarda la ripartizione dell’onere della prova in caso di licenziamento discriminatorio (licenziamento
nullo determinato da ragioni di credo politico, fede religiosa o dall’appartenenza ad un sindacato). In tal caso il datore
deve porre a fondamento del licenziamento una semplice ragione giustificativa (giusta causa o giustificato motivo
oppure la ricorrenza di un’ipotesi di licenziamento collettivo), mentre il lavoratore deve eccepire (e provare) al
ricorrenza, dietro le apparenze formali, di reali ragioni di discriminazione politica, sindacale o religiosa.
Si tratta chiaramente di una prova difficile, giacché il lavoratore dovrebbe essere in grado di dimostrare la destinazione
a fini discriminatori di licenziamenti che si presentano apparentemente giustificati (perciò si è ritenuto che in tali casi
ancor più rigorosa e penetrante debba essere l’indagine istruttoria del giudice tramite il pieno utilizzo dei poteri
conferitigli dall'art. 421 cod. proc.pen. , con rilievo della prova per presunzioni di cui gli art. 2727 e 2729 c.c).
Infine occorre considerare il casi del lavoratore che agisce in giudizio per ottenere la declaratoria di inefficacia del
licenziamento per carenza di forma scritta o per mancata o intempestiva comunicazione dei motivi richiesti. Il datore di
lavoro spesso può essere indotto ad opporre che il rapporto si è in realtà interrotto in forza di dimissioni presentate
oralmente dal lavoratore. In tale ipotesi, al lavoratore che si fa attore in giudizio contestando l'illegittimità del
licenziamento orale, spetta provare che esso si è verificato effettivamente nella realtà e che non si è dunque trattato,
come asserisce l'imprenditore, di dimissioni. Qui infatti non è in gioco la prova della giusta causa o del giustificato
motivo, bensì la dimostrazione del tipo di recesso intervenuto (licenziamento o dimissioni).
11.Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido.
Per il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo è previsto (fatta salva l’area di residua
applicabilità del recesso ad nutum) un doppio alternativo regime sanzionatorio: quello delineato dall'art 8 della L. n.
604/1966 (c.d. tutela obbligatoria), che si applica ai datori che non superino determinate soglie occupazionali, e quello
delineato dall’art. 18 St. lav., (tutela reale) che si applica al di sopra di tali soglie occupazionali.
11.1.La tutela obbligatoria.
Secondo l'art 8 della L. 604/1966 (applicabile come detto alle unità produttive di minori dimensioni) dall’annullamento
del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo discende un’obbligazione alternativa (e non facoltativa)
a carico del datore in un'ottica di stabilità obbligatoria: il datore è tenuto a riassumere il lavoratore entro 3 giorni o, in
mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo variabile tra un minimi di 2,5 e un massimo di 6
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero di dipendenti occupati, alle dimensioni
dell’impresa, all’anzianità di servizio del lavoratore e al comportamento delle parti.
La misura massima di tale indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore
ai 10 anni e fino a 14 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendente da datore di lavoro che
occupa più di 15 dipendenti (dislocati in diverse unità produttive minori).
In sostanza il licenziamento, per quanto illegittimo, risolve il rapporto di lavoro ma fa sorgere un’obbligazione di
ricostituzione ex novo del rapporto stesso o, a scelta del datore, di versamento di un’indennità risarcitoria (soluzione
quest’ultima, largamente prevalente nella pratica).
11.2.La tutela reale.
Diverso è invece il regime sanzionatorio del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo delineato dall’art.
18 St. lav. ed operante per i datori di lavoro che presentino maggiori livelli occupazionali. Superando l’alternativa tra
riassunzione e pagamento della penale, e introducendo un sistema di stabilità reale, l’art. 18 considera il rapporto di
lavoro come non interrotto dal licenziamento ingiustificato (che ne impedisce giuridicamente la sola funzionalità di
fatto). Più in particolare la norma prevede:
-la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
-il risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento ingiustificato commisurato alla retribuzione globale
di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione (tale risarcimento comunque non può
essere inferiore a 5 mensilità).
Questo più drastico regime sanzionatorio è esteso altresì alle ipotesi di nullità del licenziamento discriminatorio nonché
alle ipotesi di inefficacia del licenziamento per vizi formali o procedurali (omessa comunicazione per iscritto, omessa
indicazione dei motivi richiesti dal lavoratore, mancato rispetto dell’art. 7 St. lav per i licenziamenti disciplinari) nelle
imprese di maggiori dimensioni.
a)L’ordine di reintegrazione
Una prima lettura dell’art. 18 potrebbe suggerire che l’ordine di reintegrazione sia quasi superfluo o avrebbe un valore
meramente “etico”; il rapporto di lavoro, interrotto solo di fatto dall’illegittimo licenziamento, non richiederebbe infatti
alcun modo di essere ripristinato, poiché esso prosegue automaticamente a seguito dell’accertamento dell’invalidità del
recesso datoriale.
Un’analisi più attenta tuttavia consente di mettere in luce il contenuto autonomo ed aggiuntivo (dunque non superfluo)
dell’ordine di reintegra rispetto agli obblighi scaturenti normalmente dal rapporto di lavoro. Un conto infatti è
l’accertamento della vigenza di tali obblighi e della ininterrotta prosecuzione giuridica del rapporto, e altra cosa è
l’ordine al datore di ripristino, anche sul piano fattuale, della collaborazione lavorativa.
Le posizioni restano divaricate circa i modi di attuazione coattiva dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, ove il
datore di lavoro non ottemperi spontaneamente.
Sempre a proposito dell’ordine di reintegrazione del giudice, è il caso di notare come esso non sia in realtà
accompagnato da alcuno strumento di coazione diretta (in caso di inosservanza da parte del datore dell’obbligo di
reintegrazione). ciò si spiega con il principio di non coercibilità diretta degli obblighi infungibili di fare (nemo ad
factum precise cogi potest); non è possibile in sostanza imporre al datore la reintegrazione effettiva del datore.
E proprio in ragione di ciò assume particolare rilevanza il diritto al risarcimento del lavoratore illegittimamente
licenziato derivante dall’art. 18, giacché l’obbligo di continuare a corrispondere la retribuzione globale di fatto al
lavoratore dal momento dell’illegittimo licenziamento al momento della reintegrazione del lavoratore, finisce per
assumere una funzione di coazione indiretta all’adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di reintegra.
Se poi, una volta emesso l’ordine di reintegra, il lavoratore non riprende servizio entro 30 giorni dall’invito a tal uopo
rivoltogli dal datore, il rapporto di lavoro si intende risolto (salvo un giustificato motivo di assenza).
A tal fine non basta che sia stata emessa una sentenza di reintegrazione, occorrendo uno specifico invito del datore di
lavoro. La reintegrazione deve avvenire nello stesso posto occupato al momento del licenziamento, anche qualora esso
sia stato nel frattempo assegnato ad altri. Nulla impedisce che successivamente alla reintegrazione il datore di lavoro
adibisca al lavoratore a diverse mansioni sempre nel rispetto della previsione dell'art. 2103 c.c.
b)Il risarcimento del danno.
Il giudice che emette una sentenza di reintegra nel posto di lavoro, condanna il datore al risarcimento del danno subito
dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità, stabilendo un’indennità
commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (e
comunque non inferiore a 5 mensilità di retribuzione), nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali
maturati nel medesimo lasso temporale. La nuova formulazione presenta contenuti innovativi rispetto alla vecchia
dizione dell'art 18 St. lav., che contemplava, da un lato, il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il
licenziamento e la sentenza di reintegra e, dall'altro, il versamento della retribuzione per il periodo successivo alla
pronuncia giudiziale e sino all'effettiva reintegrazione.
La lettera della norma non sembra alludere al danno effettivo arrecato al lavoratore, ma sembra piuttosto stabilire in
modo rigido e quasi presuntivo il criterio di determinazione dell’indennità. Ciò potrebbe far pensare che la misura del
risarcimento sia inderogabilmente vincolata alla retribuzione non percepita dal lavoratore licenziato e debba
quantificarsi non sulla base delle effettive diminuzioni patrimoniali che le sfera patrimoniale del lavoratore ha subito,
ma applicando in modo rigoroso il criterio legale presuntivo della retribuzione globale di fatto.
Tuttavia, preoccupazioni di ordine equitativo suggeriscono una lettura più flessibile della norma, che porti a considerare
le variabili di ciascun caso concreto, in modo da attenuare la rigidità della quantificazione del risarcimento, rendendo
l’indennità suscettibile di variazioni corrispondenti a vicende patrimoniali che, sebbene si verifichino nell’abito della
sfera patrimoniali soggettiva del lavoratore, assumono diversa rilevanza; a favore del datore, allorché questi possa
provare che il lavoratore nel frattempo ha percepito compensi o retribuzioni da altri datori di lavoro (in tal caso
l’aliunde perceptum assume valenza compensatrice e quindi moderatrice del risarcimento): oppure a favore del
lavoratore, allorché questi dimostri di aver subito pregiudizi ulteriori (ad es; per sfratto morosità o per l’assunzione di
mutui) oltre alla perdita della retribuzione.
Del resto, in favore di tale interpretazione si può considerare l’utilizzo del termine “commisurato”, che esprime che la
retribuzione è solo il parametro di quantificazione dell’indennità, nel contesto di un regime risarcitorio di un danno
effettivo e non presunto. La norma fissa poi una misura minima del risarcimento in 5 mensilità di retribuzione, che sono
dovute, a titolo sanzionatorio, anche quando la reintegrazione si avvenuta entro un lasso di tempo inferiore.
Il riferimento alla retribuzione globale di fatto (mutuato dalla contrattazione collettiva) deve intendersi comprensivo di
tutto quanto il lavoratore avrebbe effettivamente e continuativamente percepito nel periodo considerato.
È esplicitamente previsto poi che il datore debba altresì versare i contributi assistenziali e previdenziali relativi al
periodo che intercorre tra il licenziamento e l’effettiva reintegra. Della facoltà del lavoratore di sostituire la reintegra nel
posto di lavoro con un’indennità pari a 15 mensilità (restando fermo il risarcimento del danno) si è già detto.
12.Tutela processuale del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro
Il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro può essere fatto valere, oltre che attraverso l’ordinario processo del
lavoro, tramite strumenti più rapidi. Innanzitutto il lavoratore ha la possibilità di invocare l’art. 700 c.p.c., in base al
quale, quando vi è fondato motivo di temere che nelle more del giudizio ordinario il diritto azionato possa subire un
pregiudizio imminente e irreparabile, si può chiedere un provvedimento d’urgenza a carattere cautelativo; nella specie
una sospensione del licenziamento (con reintegra provvisoria) sino all’esito del giudizio ordinario di merito. Nel caso in
cui invece il licenziamento sia connesso ad un fine antisindacale, la sua illegittimità può essere fatta valere anche dal
sindacato mediante la procedura ex art. 28 St. lav., per la repressione della condotta antisindacale del datore. In tal caso
l’azione del sindacato e l’azione ordinaria del lavoratore per l’impugnazione del licenziamento possono coesistere.
È infine in caso di ricordare che il lavoratore che ha ottenuto una sentenza di reintegrazione ha facoltà di chiedere al
datore, in sostituzione di tale reintegrazione, una indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto (anche in
tal caso però resta fermo il diritto al risarcimento del danno commisurato al periodo che va dal licenziamento alla
richiesta della indennità sostitutiva della reintegrazione).
Una tutela del tutto particolare viene poi concessa dai commi 4 e 7 dell'art. 18 St. lav., ai dirigenti delle RSA e ai
membri delle Commissioni interne, particolarmente esposti ad azioni di rappresaglia.
Il provvedimento di reintegra può essere provvisoriamente emesso con ordinanza nel corso di giudizio quando prima
facie le prove fornite dal datore di lavoro non sembrano sufficienti a giustificare il licenziamento. Il provvedimento
deve essere però richiesto congiuntamente dal sindacalista licenziato e dal sindacato di appartenenza. In caso di mancata
reintegrazione del sindacalista, dopo l'ordine giudiziale, il datore dovrà pagare, oltre alla retribuzione, una somma di
pari entità ad un fondo previdenziale, realizzandosi così una forma di coazione indiretta al rispetto dell'ordine del
giudice.
13.Il campo di applicazione della disciplina vincolistica dei licenziamenti individuali.
Il regime di tutela del posto di lavoro è differenziato in ragione delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro.
L'ampio dibattito sviluppatosi a riguardo, con l'intervento della Corte Costituzionale e proposte di referendum, si è
assestato lungo le linee tracciate dalla L. n. 108/1990, che ha mantenuto in vita, accanto al regime reintegratorio dell'art.
18, il regime di tutela meramente indennitaria introdotto dalla L. n. 604/1966. E poi permane un ristrettissimo numero
di rapporti, dove permane la possibilità del recesso ad nutum.
13.1.2. L'area della tutela reale e della tutela obbligatoria
Il regime di tutela del posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo è differenziato in ragione delle dimensioni
occupazionali del datore di lavoro.
Area della tutela reale
Ad oggi l’art. 18 St. lav. (e la sanzione di reintegrazione) si applica a ogni datore di lavoro che:
-occupa nell’unità produttiva (sede, stabilimento, reparto, ufficio) + di 15 dipendenti (5 in caso di imprese agricole);
-occupa nello stesso comune (anche in più unità produttive) + di 15 dipendenti (5 in caso di imprese agricole);
-occupa complessivamente + di 60 dipendenti.
Ai fini dei criteri individuati dai primi due punti il numero dei dipendenti si abbassa a 5 per le imprese agricole.
Tale diverso limite occupazionale è stato giustificato dalla stessa Corte Costituzionale con le profonde diversità
strutturali del settore agricolo, nel quale il rapporto forza-lavoro-capitale investito è in linea di massima ben diverso
rispetto a quello che caratterizza l'impresa commerciale ed industriale.
Ai fini del computo delle soglie occupazionali l'art 1 della L. n. 108 del 1990 precisa che si tiene conto sia dei lavoratori
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale (part time) per la quota di orario effettivamente svolto,
sia dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Si deve però rilevare come la recente riforma del mercato del lavoro, attuata con il D.lgs. n. 276/2003, abbia sostituito
tale ultima tipologia con quella del “contratto di inserimento”
Non si computano invece il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il 2° grado (in linea diretta e collaterale). La L.
n. 108/1990 non ammette al computo gli apprendisti nonostante il monito della Corte Costituzionale. Sono altresì
esclusi dal computo dell'organico dell'impresa utilizzatrice i lavoratori somministrati nonché i lavoratori a domicilio
subordinati.
In definitiva occorre avere riguardo alla reale struttura dell'organigramma aziendale, cioè a quel disegno organizzativo
che dà ragione delle posizioni d lavoro normalmente necessarie all'andamento produttivo, così da ammettere al computo
anche quei posti che, previsti nella normale pianta organica, sono momentaneamente vuoti per cessazione del rapporto
con il relativo titolare. In presenza di società collegate non ha rilievo il numero complessivo dei dipendenti occupati
nelle varie società, salvo l'accertamento di una fraudolenta utilizzazione dell'entità societaria al fine di eludere la
normativa della L. n. 108 del 1990.
Un dibattito a sé concernente l'identificazione dell'unità produttiva autonoma suscettibile di computo separato degli
occupati e rilevante nelle imprese che non occupano complessivamente più di 60 dipendenti. Se il riferimento all'unità
produttiva come criterio di delimitazione della operatività dell'art. 18 St. lav, è ispirato alla opportunità di evitare
situazioni di tensione tra lavoratore e alter ego del datore, coerenza vuole che non può parlarsi di unità produttiva
quando manchi un preposto dell'imprenditore, fornito dei poteri gerarchici e di gestione del personale. È configurabile
come unità produttiva autonoma lì ove sussistano un nucleo produttivo decentrato e la presenza di un alter ego del
datore.
Area della tutela obbligatoria
Ove non sia applicabile l’art. 18 St. lav., in quanto non vengono superate le su menzionate soglie occupazionali, si
applicherà il regime di stabilità obbligatoria delineato dalla L. 604/1966 (riassunzione o risarcimento da 2,5 a 6
mensilità).
Il regime di stabilità obbligatoria si applica poi, a prescindere dalla consistenza occupazionale, nei confronti dei datori
di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione
o religiosa (c.d. imprese di tendenza).
Il legislatore ha voluto sottrarre tali datori al rischio della reintegra ex art. 18, ritenendo che il carattere ideologico o,
come si dice, di tendenza, dell’attività svolta e delle finalità perseguite, mal si concilierebbe con la prosecuzione coatta
della collaborazione con un lavoratore sgradito o comunque non allineato all’ispirazione politica o ideologica che guida
l’attività del soggetto datore. In altri termini si è ritenuto di far prevalere le peculiari esigenze del datore di lavoro
rispetto alla istanza di stabilità reale del lavoratore. Il legislatore non ha ritenuto di distinguere tra lavori addetti a
mansioni “di tendenza” e addetti a mansioni “neutre”poiché anche a questi ultimi è richiesta una lealtà ideologica.
L'organizzazione di tendenza conserva il beneficio di non reintegrare ex art. 18 il lavoratore licenziato per fatti estranei
alle caratteristiche ideologiche o di tendenza (ad es. furto) che poi si sono rivelati insussistenti in sede giudiziaria,
derivandone un'eccessiva estensione dell'area di privilegio disegnata dalla norma. Va comunque precisato che nelle
attività di tendenza svolte con fini lucrativi la tendenza acquista rilievo, potendo integrare come giusta causa fatti che in
contesti diversi non possono legittimare il recesso datoriale: un giornale di partito può legittimamente licenziare il
giornalista che pretenda di scrivere articoli in sintonia con indirizzi politici diversi.
13.3.Area residuale del licenziamento libero
Dall'art. 10, L. n. 604/1966, si desume che non godono di tutela contro i licenziamenti arbitrari (e sono quindi
licenziabili ad nutum) i dirigenti amministrativi e tecnici. L’esclusione è determinata dal vincolo fiduciario che
contraddistingue il rapporto di lavoro dei dirigenti e che rende improponibile una prosecuzione di tale rapporto con
soggetti che non godono più della completa fiducia del datore.
I dirigenti tuttavia godono della tutela contro i licenziamenti discriminatori (e il datore è tenuto a comunicare il
licenziamento in forma scritta).
Occorre inoltre precisare che la mancata applicazione della disciplina legislativa su licenziamenti individuali è
compensata da una diffusa tutela prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, che, in caso di recesso privo di
“giustificatezza” (da intendersi come mera presenza di valide ragioni di recesso), riconosce al dirigente il diritto ad
un’indennità supplementare.
Nonché vi è l'obbligo del datore di lavoro di comunicare per iscritto la motivazione del licenziamento. In merito ai
contenuti della nozione di “giustificatezza”, la giurisprudenza esclude una sovrapposizione con le nozioni legali di
“giusta causa” e di “giustificato motivo”, ritenendo che la giustificatezza sia da individuare nella mera presenza di
valide ragioni di recesso, da valutare secondo buona fede e correttezza.
La contrattazione collettiva ha riconosciuto ai dirigenti la possibilità di ricorrere ad un Collegio di conciliazione ed
arbitrato per l'accertamento della giustificatezza o meno del licenziamento- ferma restando la validità del licenziamentoil collegio ha facoltà di condannare il datore al pagamento dell'indennità supplementare, di natura risarcitoria.
In dottrina è stata prospettata l’opportunità di distinguere, nell’affollato quadro delle posizioni dirigenziali, tra dirigenza
autentica e dirigenti di livello inferiore (le cui mansioni non hanno le caratteristiche proprie del rapporto dirigenziali),
che sarebbero in sostanza equiparabili agli impiegati di grado elevato e che perciò andrebbero tutelati dalla disciplina
limitativa dei licenziamenti. La giurisprudenza ha raccolto questa proposta, ritenendo che soltanto nei confronti dei
dirigenti apicali non possano trovare applicazione le garanzie procedimentali sul licenziamento disciplinare (art. 7 St.
lav.), applicandosi invece nei confronti del dirigente di livello medio-basso.
Controversa è l'applicabilità delle garanzie previste dall'art. 7 della L. n. 300/1970 al rapporto di lavoro dirigenziale
nell'ipotesi di licenziamento disciplinare. Sulla falsariga della sentenza della Cassazione n. 6041 del 29 maggio 1995 è
stata teorizzata la distinzione tra dirigente (vero alter ego dell'imprenditore) e dirigente di livello inferiore. La procedura
disciplinare non sarebbe necessaria per il dirigente di vertice, mentre sarebbe indispensabile in caso di recesso
disciplinare dal rapporto con il dirigente di livello medio-basso. Il licenziamento disciplinare del dirigente (mediobasso) senza il rispetto delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 St. lav obbliga il datore a versare, oltre l'indennità di
mancato preavviso, l'indennità aggiuntiva prevista dal contratto collettivo per le ipotesi di licenziamento ingiustificato,
ma non comporta la prosecuzione del rapporto.
Sempre ai sensi dell'art. 10, L. n. 604/1966 la disciplina vincolistica dei licenziamenti non si applica ai lavoratori assunti
in prova (la tutela però riprende vigore trascorsi 6 mesi dall’inizio del rapporto), ai lavoratori assunti con contratto a
termine, agli atleti professionisti, ai lavoratori domestici (collaboratori domestici per quali si esclude l'art. 18 St.lav e
della L. n. 604/1966, mentre vige l'art 2118 c.c., il quale si applica a tutta una categoria di prestatori che, per essere
inseriti all'interno di una comunità familiare o similare, devono necessariamente mantenere una piena sintonia anche
personale con il datore di lavoro e la predetta comunità), né ai lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti
pensionistici.
La dottrina e la giurisprudenza tende a comprimere ulteriormente la residua operatività dell'art. 2118 c.c., affermando
che dai principi generali discende la necessità che il licenziamento, pur dove vige un regime di recesso ad nutum, non
sia assistito da un motivo illecito, pena l'invalidità del medesimo licenziamento in forza dell'art. 1345 c.c., norma la cui
operatività non è in alcun modo delimitata e che risulta applicabile in virtù dell'art. 1324 c.c., anche agli atti unilaterali.
In tal caso spetterà al lavoratore provare il motivo illecito del licenziamento e, in ipotesi di prova positiva, il
licenziamento sarà dichiarato nullo.
La L. 26 febbraio 1982, n. 54 (art 6) ha attribuito ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici, ma che non
abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti previdenziali, il diritto di
optare per la prosecuzione del rapporto fino al conseguimento del predetto massimo e comunque non oltre il 65° anno
d'età. I lavoratori che esercitano la facoltà d'opzione beneficiano delle garanzie previste dagli art 1 e 2 della L. n.
108/1990 sino al raggiungimento della massima anzianità contributiva. Identiche garanzie sono state successivamente
estese dalla L. 29 dicembre 1990, n. 407 (art 6) a favore dei dipendenti che non richiedono la liquidazione di una
pensione di vecchiaia.
14. Il dibattito de iure condendo: le proposte di riforma.
Con la riforma dl mercato del lavoro, attuata del D.lgs n. 276/2003, si è sviluppato un rinnovato interesse in merito
all'opportunità di intervenire sull'art. 18 dello Statuto, in considerazione del fatto che una rigorosa tutela degli occupati
può tradursi in una penalizzazione di coloro che sono fuori dal mondo del lavoro.
L'infruttuoso esito del referendum, per il mancato raggiungimento del quorum, fece proseguire il dibattito in ambito
politico e sindacale. Così, nel novembre 2001, il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge (S 848) contenente
la “Delega al Governo in materia del mercato del lavoro”, si prevedeva di intervenire anche sulla materia relativa ai
rimedi nei confronti del licenziamento illegittimo, ipotizzando una temporanea riduzione del campo di applicazione
dell'art. 18 (e della relativa reintegrazione).
Successivamente ad un acceso dibattito parlamentare e a manifestazioni di piazza della CGIL, il Governo decideva di
stralciare dal citato disegno di legge delega la parte relativa alla riforma dell'art. 18 St. lav che tuttora giace in
Parlamento. L'ipotesi di modifica dell'art. 18 permetterebbe di sperimentare per tre anni la sospensione dell'operatività
dell'art 18 e la previsione di una sanzione meramente indennitaria per i licenziamenti illegittimi, così da determinare un
incentivo all'accrescimento dimensionale delle piccole imprese e all'incremento occupazionale.
Licenziamento ingiustificato
Licenziamento
discriminatorio
Vizi
formali
licenziamenti
disciplinari
Tipo
invalidità
Tipo
di Disciplina
invalidità
applicabile
Tipo
di Disciplina
invalidità
applicabile
Tipo
invalidità
Nullità
di Disciplina
applicabile
in Vizi
procedurali
non licenziamenti disciplinari
Unità produttive (o Annullabilità
unità nel territorio
comunale) con +di 15
dipendenti o datori con
+ di 60 dipendenti
Tutela reale
Nullità
Tutela reale
Inefficacia
Tutela reale
Unità produttive (o Annullabilità
unità nel territorio
comunale) fino a 15
dipendenti o datori
fino a 60 dipendenti
Tutela
obbligatoria
Nullità
Tutela reale
Inefficacia
Tutela reale Illegittimità
di
diritto
comune
Lavoratori esposti al Validità
recesso ad nutum
Art. 2118
Nullità
Tutela reale
Validità
Illegittimità
in
di Disciplina
applicabile
Tutela reale
Tutela
obbligatoria
Nullità
di
diritto comune
I licenziamenti collettivi
1.Evoluzione delle fonti di disciplina: contrattazione collettiva, giurisprudenza, normativa comunitaria, legge.
Un’ulteriore modo di estinzione del rapporto di lavoro (contrassegnato da una disciplina distinta da quella del recesso
individuale) è il licenziamento collettivo, disciplinato dalla L. 223\1991.
La materia dei licenziamenti collettivi è stata per molti anni caratterizzata da un voluto astensionismo legislativo,
determinato dalla consapevolezza della difficoltà di apprestare una idonea tutela a tutti gli interessi coinvolti (i
licenziamenti collettivi erano dunque regolati da 2 accordi interconfederali nonché da alcune scarne disposizioni
legislative: la L. n. 604/1966 e la L. n. 108/1990, che si limita a confermare l'esclusione dei licenziamenti collettivi
dall'applicazione della disciplina del licenziamento individuale).
Tale astensionismo era compensato dall’adozione di una politica di prevenzione delle riduzioni di personale, realizzata
con la creazione di sistemi alternativi: la Cassa integrazione guadagni e l’istituto della mobilità.
L’utilizzo di questi sistemi (di Cig e circuiti di mobilità) ha portato ad effetti perversi, finendo per traviare la natura
degli istituti e col creare situazioni di sopravvivenza meramente fittizia dei rapporti di lavoro i cui costi venivano
interamente supportati dalla collettività.
Il legislatore è cosi stato indotto (anche sotto la spinta dell’unione europea, la cui corte di giustizia ha condannato
l’Italia per la mancata recezione delle proprie direttive in materia, con particolar riferimento all’estensione della
disciplina ai datori di lavoro non imprenditori) ad un intervento normativo di portata generale; la L. 223/1991, con la
quale si è inteso valorizzare la mobilità esterna o extra-aziendale, concepita come momento successivo al licenziamento
collettivo volto a favorire la ricollocazione dei lavoratori licenziati.
Un ruolo propulsivo nell'evoluzione della disciplina sui licenziamenti collettivi è stato l'ordinamento comunitario con la
Dir. 17 febbraio 1975, n. 75/129, modificata dalla Dir. 24 giungo 1992, n. 92/56, entrambe poi confluite, nella Dir. 20
luglio 1998, n. 98/59.
2.I licenziamenti collettivi nella L. n. 223/1991: la riduzione di personale e la messa in mobilità nelle imprese.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della L. n. 223/1991, la rilevanza della distinzione tra datori di lavoro
imprenditori e datori di lavoro non imprenditori è venuta meno con il D.lgs. 8 aprile 2004,. n. 110, emanato in ossequio
alla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 32/02.
Per quanto riguarda gli imprenditori (i lavoratori licenziati da datori che non sono imprenditori non possono godere
degli ammortizzatori sociali di cui alla L. 223/1991), l’istituto del licenziamento collettivo è connesso con la Cassa
integrazione guadagni. Essa assume una funzione di sostegno di crisi aziendali reversibili, mentre in caso di problemi di
eccedenza definitiva di personale non rimane che il licenziamento collettivo seguito da mobilità.
Può anche accadere che si utilizzino entrambi gli strumenti, allorché il licenziamento collettivo con collocazione in
mobilità segua un periodo di sospensione in CIGS (nel caso in cui un’eccedenza di manodopera da reversibile si
trasformi in irreversibile durante il periodo di CIGS).
La L. 223/1991 contempla due fattispecie di licenziamento collettivo: quello per riduzione di personale e quello per
messa in mobilità
Licenziamento per riduzione di personale
Per dar corso al licenziamento per riduzione di personale è necessario che l’imprenditore abbia un organico complessivo
di più di 15 dipendenti e che intenda licenziare almeno 5 lavoratori nella stessa provincia in un arco temporale di 120
giorni. È questo il presupposto numerico.
La causa della dismissione deve essere unitaria e riconducibile ad una riduzione o trasformazione di attività d’impresa
(vi si possono ricondurre anche le ipotesi nelle quali l’imprenditore riduca solo la forza lavoro occupata a causa di
innovazioni o ammodernamenti tecnologici, senza realizzare una contrazione di strutture o di attività) o alla cessazione
totale dell’attività (chiusura dell’impresa). È questo il presupposto causale. Con riguardo al presupposto causale, il
giudice eventualmente investito della legittimità del licenziamento collettivo non può (in ossequio al principio di libertà
nell’iniziativa economica ex art. 41 Cost.) sindacare il merito delle scelte datoriali, ma deve limitarsi ad accertare:
-la sussistenza del presupposto causale invocato a sostegno dei licenziamenti collettivi (ossia verificare se una riduzione
o trasformazione dell’attività vi sia effettivamente);
-il nesso causale tra il progettato ridimensionamento ed i singoli provvedimenti di recesso;
-la correttezza procedurale dell’operazione (ossia il rispetto della procedura di mobilità e dei criteri di scelta dei
licenziandi).
D’altronde, se omogenei sono i presupposti causali sottesi al licenziamento collettivo ed al licenziamento individuale
per giustificato motivo oggettivo, analogo deve essere in entrambe le fattispecie anche il sindacato giudiziale (anche se
nel licenziamento collettivo l’indagine è un pò più ampia giacché ha ad oggetto anche il rispetto della procedura di
mobilità).
Il giudice deve dunque indagare sulle circostanze di fatto che accompagnano il licenziamento collettivo, per verificare
se contrastano con le motivazioni poste dal datore di lavoro a sostegno della sua volontà di dar corso ai licenziamenti
stessi. Potrebbe ad esempio escludere la sussistenza del legittimo presupposto causale il fatto che il datore abbia
provveduto a nuove assunzioni, laddove queste rappresentino un ampliamento dell’attività economica contrastante con
la pretesa riduzione della stessa, oppure laddove le assunzioni siano motivate dalla necessità di colmare i vuoti
verificatisi nel personale rimasto in servizio (licenziamenti seguiti da immediate nuove assunzioni possono presumersi
dovuti non all’esigenza di ridurre il personale, ma solo al desiderio di disfarsi di lavoratori sgraditi).
Licenziamento per messa in mobilità
L’imprenditore con più di 15 dipendenti può avviare le procedure di mobilità qualora, durante il godimento o alla fine di
un periodo di CIGS, ritenga di non essere in grado di reimpiegare tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a
misure alternative. La dizione sembra lasciare la libertà al datore in merito alla decisione sul ricorso allo strumento della
Cassa Integrazione rispetto al licenziamento collettivo.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa sui licenziamenti collettivi i dirigenti ed i casi di scadenza dei
rapporti di lavoro a termine.
Per questa tipologia di licenziamento non è previsto un limite numerico (a differenza dell’altra), mentre è presupposta la
CIGS; mentre è discussa l'esistenza di un obbligo di ricorrere a misure alternative anche dopo l'emanazione del D.lgs. n.
151/1997, il quale si limita a sollecitare (senza imporre) la ricerca e l'adozione di tali misure alternative.
3.La procedura di mobilità.
Tra il momento in cui matura la decisione imprenditoriale di procedere al licenziamento collettivo ed il momento
dell'effettiva espulsione del singolo lavoratore dal processo produttivo la legge pone la c.d. procedura di mobilità (che è
identica per entrambi i tipi di licenziamento collettivo), la cui funzione è quella di attutire, ove possibile, gli effetti del
licenziamento collettivo sul mercato del lavoro.
La procedura è regolata dagli art. 4 e 5 della L. 223/1991; ai fini della sua attivazione è fatto obbligo all’imprenditore di
comunicare preventivamente per iscritto alle RSA (ora RSU) e alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative, i motivi tecnici e organizzativi che determinano la necessità di ridurre il personale; il
numero, e i profili professionali del personale eccedente, i tempi di attuazione del programma di mobilità; le eventuali
misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma.
L'informativa deve essere seria e completa, “dettagliata ed analitica” ed idonea ad aprire il confronto sindacale; essa
dovrà dunque evidenziare tutte le ragioni che sono alla base della scelta imprenditoriale di ridurre il personale.
L'obbligo di informazione deve essere adempiuto “indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura
delle procedure...siano assunte dal datore di lavoro o da una impresa che lo controlli”.
La comunicazione comporta inoltre un costo per l’impresa, in quanto ad essa va allegata una copia della ricevuta del
versamento all’Inps di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale, moltiplicato per il
numero dei lavoratori considerati in esubero (somma da versare in 30 rate mensili).
La procedura avviata con la comunicazione, può poi articolarsi in due fasi; una eventuale e l’altra subordinata all’esito
negativo della prima.
La prima fase, che potrebbe essere definita fase sindacale, può aver luogo, ad iniziativa del sindacato, entro 7 giorni
dalla ricezione della comunicazione e deve comunque durare non più di 45 giorni. La fase sindacale si sostanzia in un
libero confronto tra l’imprenditore ed il sindacato, finalizzato a ricercare un accordo che risolva in tutto o in parte il
problema delle eccedenze.
Questa consultazione si configura per il datore di lavoro come un onere a trattare in buona fede, il cui mancato rispetto,
ove risulti immotivato, può integrare un comportamento antisindacale sanzionabile ex art. 28 St.lav, oltre ad avere un
obiettiva ed autonoma rilevanza civilistica, potendo essere causa dell'inefficacia dei recessi intimati.
Tuttavia, per quanto il legislatore si sia sforzato di incentivare il dialogo con finalità conciliative, l’imprenditore resta
comunque libero di non accettare le proposte sindacali ed il sindacato, a sua volta, può anche decidere di non attivare
affatto la procedura.
D'altra parte, la legge, nell'intento di favorire soluzioni compromissorie, predispone una serie di incentivi alla
conclusione dell'accordo. L'imprenditore viene incentivato a concludere l'accordo dal momento che in questo caso
beneficia di una consistente decurtazione dei costi di licenziamento. È prevista, altresì, un'ipotesi di deroga all'art. 2103
c.c., qualora sia possibile evitare un recesso spostando il lavoratore ad altre mansione anche se non equivalenti a quelle
di provenienza; un'anticipazione parziale del trattamento di pensione combinato con la riduzione a part-time dell'orario
di lavoro ed, infine, la possibilità di utilizzare una versione rivisitata del contratto di solidarietà. Inoltre, e sempre la fine
di evitare le riduzioni di personale, l'accordo sindacale può regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori
dall'impresa ad altra per una durata temporanea.
Esaurita la fase sindacale, si configurano due possibili situazioni; o è stata raggiunta un’intesa formalizzata in un
accordo oppure la procedura è stata infruttuosa. In questo secondo caso la legge prevede l’apertura di un ulteriore fase
conciliativa in sede amministrativa, su impulso del direttore della Direzione provinciale del lavoro.
4.Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e intimazione del licenziamento.
Una volta conclusa l’intera procedura (che non può durare + di 75 giorni), qualora rimanga la necessità di intimare tutti
o soltanto alcuni dei licenziamenti inizialmente previsti nella comunicazione preventiva, il datore ha facoltà di
individuare in concreto i lavoratori colpiti dal provvedimento espulsivo.
L’individuazione deve essere fatta secondo criteri che- a norma dell'art. 5, L. n. 223/1991- possono essere elencati in un
accordo collettivo, oppure, in mancanza, si dovrà fare ricorso a quelli stabiliti in via sussidiaria dalla L. 223/1991
(esigenze tecnico-produttive ed organizzative, carichi di famiglia, anzianità).
I criteri (diversi da quelli legali) eventualmente previsti dall'autonomia collettiva devono essere predeterminati ed
obbiettivi, generali ed astratti, con conseguente inammissibilità di criteri vaghi ed elastici. I contratti collettivi, in
particolare, non possono concordare indirettamente col datore la lista dei licenziandi.
Nei confronti del lavoratore identificato come destinatario del provvedimento espulsivo, il datore potrà intimare il
licenziamento, in forma scritta, col rispetto del prescritto preavviso, ma senza alcuna necessità di motivazione.
L’atto di recesso ai sensi della L. n. 223/1991 assolve anche un’altra funzione oltre a quella dismissoria; la funzione di
immissione del lavoratore licenziato nelle liste di mobilità.
A valle dell'intimazione del licenziamento, sorge per il datore il dovere di informare sia la parte pubblica che le
associazioni sindacali di categoria destinatarie della comunicazione introduttiva della procedure. L’informativa deve
contenere i nominativi dei lavoratori licenziati, il luogo di residenza, la qualifica, il livello d’inquadramento, l’età, i
carichi familiari e i criteri adottati nella scelta. Tale informativa assolve ad una duplice finalità. Nei confronti della parte
pubblica funge da segnalazione per l’iscrizione dei lavoratori licenziati nelle liste di mobilità; nei confronti dei
sindacati, riveste un ruolo di garanzia della trasparenza e di controllo eventuale sulle scelte datoriali, mettendo in
condizione di potersi attivare in caso di violazioni di legge o di arbitri da parte dell'imprenditore, sul piano
dell'autotutela collettiva, o attraverso azioni individuali.
5.Il sistema sanzionatorio.
La legge dispone che il licenziamento collettivo è viziato quando sia intimato senza l’osservanza delle forme previste,
quando non siano state rispettate le procedure ed infine, quando vi sia stata la violazione o la non corretta applicazione
dei criteri di scelta.
Il lavoratore colpito dal provvedimento di recesso che, ravvisando uno di tali vizi, voglia far valere le proprie ragioni,
ha l’onere di impugnare il licenziamento nelle forme e con i termini di decadenza previsti dalla L. n. 604/1966 per il
licenziamento individuale. Qualora il giudice accerti l’illegittimità del licenziamento, ne dichiara l’inefficacia (in caso
di vizio di forma o di procedura) o l’annullabilità (in caso di violazione dei criteri di scelta), ed ordina, ai sensi dell’art.
18 St. lav., la reintegra del lavoratore.
Tuttavia nel (solo) caso in cui la violazione concerna i criteri di scelta, il datore ha facoltà di intimare il licenziamento
ad un altro lavoratore (applicando stavolta correttamente i criteri di scelta) senza doversi sottoporre ad una nuova
procedura; unico onere aggiuntivo sarà una comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali.
In sostanza la tutela reale, prevista per la violazione delle garanzie sostanziali e procedurali, finisce per operare con
riguardo ad ogni impresa con più di 15 dipendenti. Nella configurazione legislativa la facoltà di sostituzione non
incontra alcun limite temporale e quantitativo, per cui, almeno in teoria si potranno verificare casi di sostituzione a
catena.
6. L'estensione della L. n. 223/1991 ai datori di lavoro non imprenditori. Il D.lgs. 8 aprile 2004, n. 110.
Quanto detto finora vale solo per i licenziamenti collettivi intimati da datori di lavoro imprenditori. Il D.lgs. 8 aprile
2004, n. 110 ha però esteso l'applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi dettata dalla L. n. 223/1991 anche
ai datori di lavoro non imprenditori, anche se si tratta di un'estensione solo parziale. Il legislatore tuttavia, in seguito ad
una condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea (per la mancata ricezione della Dir 20 luglio 1998, n. 98/59
nella parte in cui prevedeva l'inclusione tra i destinatari della L. n. 223/1991 di tutti i datori di lavoro e non solo degli
imprenditori), è stato obbligato ad estendere la disciplina dei licenziamenti collettivi a tutti i datori di lavoro, includendo
così anche i non imprenditori, originariamente non inclusi.
L’estensione tuttavia non è assoluta, giacché vi sono alcune differenze nella disciplina. I dipendenti di datori di lavoro
non imprenditori infatti, pur potendo iscriversi nelle liste di mobilità, si trovano in una condizione deteriore rispetto ai
dipendenti di imprese, giacché non possono godere degli ammortizzatori sociali (in particolare dell’indennità di
mobilità) né delle agevolazioni contributive a favore del nuovo datore di lavoro (in caso nuova assunzione).
Il trattamento di fine di fine rapporto.
Il TFR è un’indennità che spetta al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. Si calcola dividendo per
13,5 tutto quello che il lavoratore ha percepito nel corso dell’anno a titolo non occasionale e con esclusione dei rimborsi
spese. La cifra va rivalutata con l’applicazione di una maggiorazione annua composta da un tasso fisso dell’1,5% e
inoltre del 75% dell’aumento dell’indice ISTAT.
1.L'evoluzione legislativa.
L’anzianità di servizio presso il medesimo datore di lavoro assume particolare rilevanza quando, in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro, è dovuta al lavoratore un’indennità commisurata, tra l’altro, alla durata del rapporto.
L’evoluzione della disciplina è determinata da una progressiva modificazione della sua natura e funzione. Alle origini e
per molto tempo la c.d. “indennità di anzianità” ha rappresentato una sorta di premio fedeltà per il lavoratore.
Riconosciuta inizialmente solo agli impiegati e negata a chi si dimetteva o veniva licenziato per giusta causa, essa
contribuiva a valorizzare una concezione fiduciaria e paternalistica del rapporto di lavoro. Successivamente essa fu
estesa anche agli operai e a tutte le cause di cessazione del rapporto, finendo così per assumere una finalità latu sensu
previdenziale (per far fronte alle esigenze del lavoratore nel momento del venire meno di una stabile fonte di
guadagno). La disciplina attuale dell’istituto, oggi denominato TFR (trattamento di fine rapporto), è contenuta nella L.
297/1982, n. 297.
2.I nuovi criteri di calcolo
Il meccanismo di calcolo della vecchia indennità di anzianità consisteva nella moltiplicazione dell’ultima retribuzione
per un coefficiente proporzionale alla durata del rapporto.
Secondo l’attuale disciplina invece, per ciascun anno di servizio occorre considerare la retribuzione annuale
complessiva e dividerla per 13,5 (quindi una quota poco superiore alla retribuzione mensile). Nella retribuzione annuale
vanno computate tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale con
esclusione dei soli rimborsi spese.
Per evitare fenomeni di super-liquidazioni e quindi ingiustificate sperequazioni, la legge vieta alla contrattazione
(collettiva o individuale) di abbassare il divisore 13,5. L’autonomia collettiva è invece libera di espungere alcune voci
retributive dalla retribuzione annuale e dunque di comprimere l’entità del TFR (magari nell’ambito di una strategia tesa
a valorizzare la retribuzione corrente rispetto a quella differita). L'ART. 5, 5° comma, L. n. 297/1982 ha consentito
inoltre, a partire dal 31 dicembre 1989, una piena equiparazione del trattamento previsto per impiegati ed operai.
Le quote della retribuzione annuale vanno poi rivalutate annualmente con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5%
in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. Il meccanismo di indicizzazione è
stato costruito in modo che la sua efficienza risulti inversamente proporzionale al tasso di inflazione. I nuovi criteri di
computo presentano il vantaggio di riflettere fedelmente la storia retributiva di ciascun lavoratore, impedendo manovre
o effetti sperequativi a vantaggio di chi presenta dei picchi di carriera nella fase terminale del rapporto.
Il nuovo sistema di computo del TFR concerne solo le indennità maturate dopo il 31 maggio 1982. i rapporti di lavoro
in corso all’entrata in vigore del nuovo sistema vengono assoggettati ad un meccanismo di computo differenziato (il
vecchio sistema per il periodo anteriore al 1982, il nuovo computo per il periodo successivo).
3. Le anticipazioni e il Fondo di garanzia. L'indennità in caso di morte.
Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso le stesso datore può ottenere, in pendenza del rapporto,
un’anticipazione del TFR non superiore al 70% del trattamento già maturato.
La legge però pone vincoli finalistici alla domanda di anticipazione (spese sanitarie per terapie o interventi straordinari;
acquisto della prima casa per se o per i figli, ecc) e limita il numero dei beneficiari, onde non esporre le aziende ad
ingenti ed improvvisi esborsi di liquidità (non più del 10% degli aventi diritto e in ogni caso non più del 4% del numero
totale dei dipendenti).
La legge (art. 2, L. n. 297/1982) prevede un fondo di garanzia, alimentato da contributi datoriali e destinato a sostituire
il datore nell’erogazione del TFR in alcuni casi di insolvenza o di inadempienza e segnatamente in caso l’azienda
incorra in procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione amministrativa coatta o
amministrazione straordinaria). L'istituzione del Fondo risponde ad un'esigenza di “socializzazione del rischio
dell'insolvenza”.
Una volta accertati (secondo le regole generali delle procedure concorsuali) esistenza e ammontare del credito, il fondo
erogherà l’ammontare immediatamente e, surrogandosi a lavoratore, sopporterà le lungaggini e i rischi della procedura
concorsuale.
L’intervento del fondo è esteso anche ai lavoratori che dipendono da datori di lavoro non soggetti a procedure
concorsuali nonché ai soci delle cooperative di lavoro, e in tal caso il lavoratore potrà inoltrare la domanda al fondo solo
dopo l’inutile esperimento della procedura di esecuzione forzata.
In caso di morte del lavoratore il TFR e l’indennità di mancato preavviso (ai sensi dell'art. 2122 c.c) spettano al coniuge
e ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°.
Tali indennità non possono essere oggetto di patti anteriori alla morte del lavoratore, il quale può disporne per
testamento solo in mancanza dei superstiti suindicati.
4. Prospettive di riforma.
Le prospettive di riforma del TFR appaiono strettamente intrecciate con l'evoluzione del sistema pensionistico e, in
particolare, col finanziamento della previdenza complementare d cui al D.lgs. n. 124/1993 (cosiddetti fondi pensione).
Il D.lgs 17 agosto 1999, n. 299 prevedeva, in via sperimentale, la c.d “cartolarizzazione” del TFR : in alternativa al
versamento in contanti del TFR ai fondi pensione, il debito debito dell'impresa costituito dalle quote annuali di TFR
poteva essere trasformato in strumenti emessi della impresa stessa o attribuiti al fondo pensione. Tali strumenti
finanziari potevano consistere in azioni, obbligazioni convertibili in azioni, o altri titolo cum warrant. L'operazione,
consentita dal 1999 e solo per i 3 anni successivi, richiedeva in ogni caso il consenso scritto del lavoratore.
La L. d. 23 agosto 2004, n.243 (Riforma Maroni) mira, tra l'altro, a facilitare l'afflusso del TFR ai fondi pensionistici
complementari, di cui al D.lgs n. 12471993. A riguardo non viene previsto un vero e propri obbligo di conferimento, ma
una forma di silenzio-assenso. In altri termini resta fermo il principio di volontarietà dell'adesione al fondo pensione,
solo che adesso la volontà del lavoratore di non aderirvi deve essere espressa entro 6 mesi dall'assunzione, altrimenti il
silenzio del lavoratore è considerato come volontà di aderire ad un fondo pensione (e di conferirvi il TFR). Tuttavia, se
il silenzio del lavoratore non si accompagna anche alla scelta del fondo pensione, sono previste modalità tacite di
conferimento del TFR stesso a favore di fondi istituito o promossi dalle regione, tramite loro strutture pubbliche o a
partecipazione pubblica all'uopo istituite o in base a contratti o accordi collettivi; in loro mancanza il TFR andrà
destinato alle forme pensionistiche costituite presso enti di previdenza obbligatoria.
Per le imprese, a fronte della perdita di disponibilità del TFR quale importante fonte di autofinanziamento, la legge
delega citata prevede misure compensative “in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e
medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento
del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto.
CAPITOLO UNDICI:I CONTRATTI A TERMINE, FLESSIBILI E FORMATIVI.
Contratti a termine.
1.Il lavoro a termine.
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine, anche se risulta fisiologico il contratto di lavoro a
tempo indeterminato. Tuttavia, crescenti istanze di flessibilità e di nuova occupazione hanno condotto ad una
progressiva attenuazione dell'originario rigore, fino all'emanazione del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Lo sfavore era già rinvenibile nel vecchio art. 2097 c.c., secondo cui il contratto di lavoro si reputava a tempo
indeterminato qualora il termine non risultasse dalla specialità del rapporto o da atto scritto. La L. n. 230/1962 ha poi
abrogato la norma. Irrigidendo ulteriormente la disciplina. Forma scritta e specialità sono divenuti così requisiti
cumulativi e non alternativi, pena la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Ad
attenuazione della rigidità della L. n. 230 è poi ripetutamente intervenuta la legislazione successiva, fino a delegare alla
contrattazione collettiva la facoltà della loro individuazione (cosiddetta liberalizzazione controllata e/o contrattata
dell'istituto).
Nel recepire la Dir 99/70/UE, il D.lgs n. 368/2001 abroga la legge 239/1962 con una regolamentazione tesa a
liberalizzare l'apposizione del termine e a conservare alcune specifiche garanzie della precedente disciplina. Non si
tratta pertanto di un provvedimento di mera deregolamentazione: i requisiti per la valida instaurazione di un rapporto a
termine restano quelli di forma e sostanza, già richiesti cumulativamente dalla legge del 1962, integrati dai requisti di
tipo quantitativo tradizionalmente previsti dalla contrattazione collettiva (clausole di contingentamento) e da quelli di
tipo negativo (divieti).
Il D.lgs n. 368/2001 conserva anzitutto il principio della forma scritta ad substantiam, sancendo che l'apposizione del
termine deve risultare, direttamente o indirettamente, da atto scritto, con la precisazione che devono essere indicate per
iscritto anche le relative ragioni giustificatrici.
La più visibile innovazione concerne il requisito di sostanza. Il precedente numerus clausus di ipotesi viene meno,
essendo ora l'apposizione del termine consentita a fronte della sussistenza di più generiche “ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo. La formula determina il superamento della precedente tecnica legislativa per
“casi di specialità”, predeterminati tassativamente dalla legge e dal contratto collettivo, col risultato di una più ampia
apertura all'autonomia individuale e di un diverso ruolo dell'organo giudiziale, chiamato ad una verifica circa la
sussistenza delle suindicate ragioni.
Oltre che alla sussistenza delle suindicate ragioni, l'apposizione del termine è subordinata al rispetto di limiti
quantitativi (clausole di contingentamento) la cui individuazione, anche in maniera non uniforme, è rimessa alla libera
scelta dei CCNL di categoria stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Come già per la somministrazione di manodopera l'art. 3 del D.lgs n. 368/2001 introduce tassativi divieti di assunzione
a termine, opportuni nel sistema “aperto” del D.lgs n. 368/2001: sostituzioni di scioperanti; trattamento di integrazione
salariale in corso per personale con le stesse mansioni; imprese inadempienti all'obbligo di valutazione dei rischi ; unità
produttive interessate nel semestre precedente da licenziamenti collettivi di lavoratori impegnati nelle stesse mansioni.
Qualora manchi il requisito di forma o di sostanza o vengano violati i descritti divieti, il rapporto di lavoro si considera
a tempo indeterminato fin dall'origine.
Il termine può essere prorogato, previo consenso del lavoratore, una sola volta e per la stessa attività lavorativa cui si
riferisce il contratto, purché sussistano ragioni oggettive, anche se diverse da quelle originarie, e la durata complessiva
del rapporto non superi i 3 anni. Si discute se il termine di 3 anni abbia carattere generale o se si risolva più
semplicemente in un divieto di proroga per tutti i contratti il cui termine iniziale già oltrepassi il triennio.
Dubbie sono le conseguenze della illegittimità della proroga per assenza dei requisiti sopra indicati: la dottrina è divisa
tra chi ritiene applicabile la sanzione della conversione e chi, ravvisa una prosecuzione di fatto del rapporto, con tutti gli
effetti sanzionatori del caso. Se il rapporto continua di fatto oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato, esso si considera a tempo indeterminato, ma solo a partire dal ventesimo o dal trentesimo
giorno di continuazione, a seconda che il contratto sia di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi. Nel
periodo intermedio, il datore è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno
di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo ed al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Il D.lgs 368/2001 prevede che se il lavoratore è riassunto a termine entro 10 o 20 giorni dalla scadenza di un contratto di
durata “fino a sei mesi” o “superiore a sei mesi”, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Qualora si
tratti di due assunzioni successive a termine, “intendendosi per tali quelle effettuate senza soluzione di continuità”, il
rapporto si riterrà, invece, a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
L'art 6 del D.lgs 368/2001 enuncia un generale principio di parità di trattamento dei lavoratori a tempo determinato con
quelli a tempo indeterminato, salvo specifici profili di obbiettiva incompatibilità. La violazione espone il datore di
lavoro alle sanzioni amministrative.
Un vero e proprio diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, da
esercitarsi entro un trimestre dalla cessazione del rapporto, è riconosciuto ai lavoratori a termine stagionale o impiegati
in punte stagionali, per l'anno successivo allo scioglimento del rapporto, secondo quanto disposto dall'art 23, 2° comma,
L. n. 56/1987. Componendo i precedenti contrasti giurisprudenziali, l'art. 8 stabilisce ai fini dell'applicazione dell'art 35
St. lav (in materia di diritti sindacali), la non computabilità nell'organico dell'impresa di tutti i lavoratori titolari di un
contratto a termine non superiore a 9 mesi,, con ciò intendendo incentivare l'utilizzo di tale tipologia contrattuale da
parte aziendale. Non essendo disciplinato dalla L. n. 604/1966, né dall'art 18 St. lav o dalla L. n. 108/1990, il recesso
datoriale ante tempus privo di giusta causa è fonte di un obbligo risarcitorio commisurato alle retribuzioni che sarebbero
maturate fino alla scadenza, detratto quanto il lavoratore abbia conseguito o avrebbe potuto conseguire da un'altra
occupazione usando l'ordinaria diligenza.
Anche per i dirigenti è confermata la possibilità di impiego a termine per il periodo massimo di un quinquennio, ferma
la facoltà di dimissioni dopo un triennio. I dirigenti sono, inoltre, esclusi dal campo di applicazione del decreto, salve le
disposizioni sul principio di non discriminazione e i criteri di computo.
Nessuna esclusione o disciplina speciale è, invece, prevista per il settore pubblico dall'art 36 D.lgs n. 165/2001, secondo
il quale le pubbliche amministrazioni si avvalgano delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego secondo
le modalità previste dai contratti collettivi di comparto. Resta tuttavia inapplicabile il meccanismo della conversione. In
tale ipotesi viene riconosciuto al lavoratore il diritto al risarcimento del danno.
Contratti flessibili.
1.Il lavoro a tempo parziale.
Negli ultimi anni, le crescenti preoccupazioni occupazionali e di competitività hanno spinto il legislatore a disciplinare
contratti di lavoro con regimi di orario flessibili, volti a migliorare i livelli di produttività e ad aumentare il tasso di
occupazione (o anche solo di partecipazione) in particolare delle fasce deboli sul mercato del lavoro (donne, giovani e
anziani).
Il D.lgs n. 276/2003, nel titolo V, disciplina tre tipologie contrattuali:
-il lavoro a tempo parziale è caratterizzato da una diminuzione dell’orario di lavoro rispetto a quello normale;
-il lavoro ripartito è uno speciale contratto col quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e
identica obbligazione lavorativa.
-il lavoro intermittente è quello mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne può
utilizzare la prestazione
Tutti e tre questi contratti consentono un uso flessibile della forza lavoro sotto il profilo temporale.
Il lavoro a tempo parziale (o part-time) da un ventennio costituisce una delle manifestazioni più significative della
tendenza alla diversificazione del rapporto di lavoro rispetto al modello tradizionale.
La disciplina dell’istituto del lavoro a tempo parziale risulta da:
D. lgs. 61/2000, che ha abrogato la precedente disciplina e ha introdotto una nuova disciplina conforme agli indirizzi
comunitari e rispondente all’esigenza di promuovere una maggiore diffusione di tale tipologia contrattuale.
D. lgs. 276/2003 – con questo intervento di riforma sono stati rimossi alcuni vincoli che costituivano un freno alla
diffusione di questo tipo di contratto e che ha reso più flessibile la gestione dei tempi parziali di lavoro.
L. 247/2007 – con quest’ultimo intervento di riforma si è rafforzata la competenza della contrattazione collettiva in
materia (specie per quanto concerne le clausole elastiche e flessibili).
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro inferiore
rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno. Per orario di lavoro a tempo pieno deve intendersi l’orario normale di lavoro,
corrispondente alle 40 ore settimanali fissate dalla legge o all’eventuale orario minore fissato dai contratti collettivi.
Si distinguono 3 differenti tipologie di part time.
-rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, in cui la riduzione rispetto al tempo pieno è prevista rispetto
all’orario normale giornaliero (si lavora tutti i giorni della settimana lavorativa ma in ciascun giorno per un minor
numero di ore).
-rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, in cui l’attività lavorativa è svolta a orario giornaliero pieno, ma
limitatamente a periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (si lavora a tempo pieno, ma solo
in alcuni giorni della settimana o in alcune settimane del mese o in alcuni messi dell’anno).
-rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto, in cui l’attività lavorativa si svolge secondo una combinazione delle
due tipologie precedenti (ad esempio, si lavora in tutti i giorni della settimana lavorativa, ma in alcuni giorni a tempo
pieno mentre in altri giorni a tempo parziale).
I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni di lavoratori e datori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o dalle rappresentanza sindacali aziendali (RSA o RSU) hanno la potestà di
determinare le condizioni e le modalità della prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il D.lgs n. 61 prevede che il contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta, ma tale forma è richiesta non ai
fini della validità del contratto, ma solo ad probationem, con l'indicazione puntuale della durata della prestazione
lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Sicché
l’inosservanza della forma scritta non determina la nullità del contratto ma solo una limitazione dei mezzi probatori
(infatti in tal caso la prova per testimoni sarà ammessa solo in caso di incolpevole perdita del documento art. 2725 c.c.).
In difetto di prova della stipulazione del part-time, sul richiesta del lavoratore, potrà essere dichiarata la conversione
giudiziale del contratto di lavoro dal tempo parziale al tempo pieno; ma soltanto ex nunc, cioè a partire dalla data in cui
la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata.
Per quanto riguarda in contenuto del contratto, esso deve indicare la durata della prestazione lavorativa e la collocazione
temporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. È richiesta dunque una
formale e precisa predeterminazione dell’orario ridotto, bilanciata però da significative aperture alle flessibilità nella
durata e nella collocazione temporale (di cui parlerò a proposito di lavoro supplementare, straordinario, clausole
elastiche e flessibili).
Anche in questo caso però, l’eventuale mancanza o indeterminatezza di tali indicazioni non comporta la nullità del
contratto, ma:
-se l’omissione riguarda la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la
conversione giudiziale del contratto di lavoro a tempo parziale in tempo pieno (ma sempre solo a partire dalla data
dell’accertamento giudiziale);
-se invece l’omissione riguarda la sola collocazione temporale dell’orario (ossia la collocazione delle ore di lavoro
nell’arco della giornata – di mattina o di pomeriggio, ad esempio), allora sarà il giudice a provvedere a determinare la
modalità temporali di svolgimento della prestazione, facendo riferimento alle previsioni dei contratti collettivi, o, in
mancanza, con valutazione equitativo.
Nonostante la necessità di predeterminare nel contratto la durata della prestazione lavorativa, è ammessa la possibilità di
variare in aumento tale durata. Il lavoro eccedente assume diverse nozioni a seconda della tipologia di contratto: lavoro
supplementare nel part time orizzontale; clausole elastiche e lavoro straordinario nel parti time verticale e misto.
Nel part time orizzontale il datore ha facoltà di richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare, cioè di lavoro svolto
oltre l’orario a tempo parziale concordato ma entro il limite del tempo pieno.
La regolamentazione del lavoro supplementare è rimessa alla contrattazione collettiva, che può determinare il numero
massimo di ore supplementari effettuabili, l’individuazione delle causali in base alle quali il datore di lavoro può
richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare e le eventuali conseguenze in caso di superamento del tetto di ore di
lavoro supplementare contrattualmente previste. Inoltre possono (ma non debbono) prevedere una maggiorazione della
retribuzione oraria globale di fatto dovuta in relazione al lavoro supplementare.
Non è necessario il consenso espresso del lavoratore alla richiesta del datore di effettuare lavoro supplementare se il
contratto collettivo prevede e disciplina la facoltà del datore di richiedere tali prestazioni (ma l’eventuale rifiuto del
lavoratore non può giustificare il licenziamento, bensì solo altre sanzioni disciplinari). Altrimenti è necessario il
consenso del lavoratore.
Il lavoro straordinario invece si verifica quanto viene superato l’orario legale settimanale (40 ore). Per questo motivo
nel part time esso è possibile solo quando sia raggiunto il tempo pieno e quindi solo nel part time verticale o misto. In
tal caso si applicherà la disciplina generale del part time prevista per il lavoro a tempo pieno. Le clausole di elasticità (o
clausole elastiche) infine consentono al datore di aumentare la durata della prestazione, nel part time verticale o misto,
senza che le ore in più valgano come straordinario
Oltre alla durata della prestazione lavorativa, è ammessa anche la possibilità di modificare la collocazione temporale
della stessa (per quanto anch’essa debba risultare dal contratto). Ciò accade attraverso l’apposizione al contratto di
clausole di flessibilità (o clausole flessibili).
Dunque mentre le clausole elastiche consentono al datore di lavoro di richiedere una prestazione lavorativa di durata
superiore a quella prevista nel contratto, le clausole flessibili consentono allo stesso di modificare la collocazione
temporale della stessa prestazione (es.: invece che lavorare 6 ore dalle 8 alle 14, lavorare sempre 6 ore ma dalle 14 alle
20). A differenza delle clausole elastiche (che possono essere apposte solo ai contratti part time di tipo verticale o misto)
le clausole flessibili possono essere apposte anche ai contratti di part time di tipo orizzontale.
Prima della L. 247/2007 la regolamentazione della clausole elastiche e flessibili, se non prevista dalla contrattazione
collettiva, era rimessa direttamente alle parti del rapporto di lavoro. Oggi invece, l’introduzione di tali clausole è
rimessa esclusivamente ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, contratti i quali ne stabiliscono anche condizioni e modalità. Per la concreta
introduzione di tali tipi di clausole nel rapporto concreto è poi necessario il consenso espresso del lavoratore,
formalizzato attraverso uno specifico patto scritto (la forma scritta del patto di elasticità\flessibilità è richiesta ad
substantiam), anche se contestuale al contratto di lavoro. In sostanza tali clausole accessorie attribuiscono al datore un
vero e proprio jus variandi temporale, accentuando i tratti della subordinazione del lavoratore.
Il trattamento economico e normativo del lavoratore part time è regolato dai seguenti principi ordinatori:
-principio di non discriminazione, in base al quale il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti di
un lavoratore a tempo pieno comparabile (per livello d’inquadramento), in particolare per quanto riguarda l’importo
della retribuzione oraria, la durata delle ferie annuali, la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per
maternità.
-principio di proporzionalità in base al quale il trattamento del lavoratore deve essere ridotto proporzionalmente alla
ridotta entità della prestazione lavorativa per quegli istituti commisurati alla stessa (importo della retribuzione globale e
feriale).
Il lavoratore part time gode di un diritto di precedenza con riferimento alla trasformazione del rapporto da tempo
parziale a tempo pieno. Ossia ha il diritto di essere preferito ad altri lavoratori, in caso di nuove assunzioni a tempo
pieno da parte del datore.
Occorre però distinguere 2 ipotesi:
-per i lavoratori originariamente assunti con contratto part time, il diritto di precedenza è azionabile solo se previsto dal
contratto individuale.
-per i lavoratori originariamente assunti a tempo pieno ma che poi hanno trasformato il rapporto in part time, il diritto di
precedenza è senz’altro azionabile in quanto deriva dalla legge.
È ammessa anche la trasformazione opposta (da tempo pieno in part time) purché vi sia l’accordo delle parti (in forma
scritta) e questo accordo venga convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro. In tal caso non esiste un vero e
proprio diritto soggettivo del lavoratore a tale trasformazione, giacché il legislatore impone al datore di lavoro che
intenda procede a nuove assunzioni a tempo parziale soltanto che questi informi il personale già occupato con rapporto
a tempo pieno e che prenda in considerazione le loro eventuali domande di trasformazione a tempo parziale.
Il legislatore dispone che i lavoratori part time vadano computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti
sempre in proporzione all’orario effettuato, rapportato al tempo pieno; e ciò in tutte le ipotesi in cui si renda necessario
l’accertamento della consistenza dell’organico aziendale.
Nell'attesa della riforma degli incentivi all'occupazione, l'art 46 D.lgs n. 276/2003 , cancella il previgente sistema di
benefici contributivi, mostrando di privilegiare i soli incentivi normativi al fine di promuovere il ricorso al lavoro a
tempo parziale.
2.Il lavoro ripartito
Dopo un lungo silenzio il D.lgs. n. 276/2003 definisce il lavoro ripartito o job sharing come quello speciale contratto di
lavoro subordinato col quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione
lavorativa.
Il vincolo di solidarietà importa che ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento
dell’intera obbligazione lavorativa.
Il vincolo di solidarietà inoltre presuppone la piena fungibilità della prestazione di lavoro.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato per iscritto (forma richiesta ad probationem) e deve necessariamente
contenere alcune indicazioni: la ripartizione percentuale e temporale del lavoro fra i coobbligati, il luogo di lavoro, il
trattamento economico e normativo.
La disciplina applicabile, al di là di quella speciale, è rinviata alla contrattazione collettiva. In assenza di contratti
collettivi si applica la normativa generale del lavoro subordinato, ma soltanto in quanto compatibile con le peculiarità
del rapporto ripartito.
Al momento della stipula le parti devono concordare la quantità e la collocazione temporale della attività lavorativa.
Inoltre i lavoratori hanno la facoltà di modificare successivamente la ripartizione dell’orario e di sostituirsi a vicenda (in
tal caso, il rischio della impossibilità della prestazione per fatti attinenti ad uno dei coobbligati è posto in capo all’altro).
Insomma i lavoratori sono liberi di organizzare tra loro la prestazione di lavoro, ripartendosi l’orario di lavoro, con
l’obbligo di sostituirsi a vicenda in caso di inadempimento di uno dei due.
L’eventuale impedimento di entrambi i lavoratori, invece, può determinare l’estinzione dell’obbligazione (e quindi
giustificare la risoluzione del rapporto) allorché perduri tanto tempo da far cessare l’interesse del creditore alla
prestazione (secondo la disciplina di diritto comune).
Un altro aspetto peculiare del lavoro gemellato attiene alla cessazione del rapporto di lavoro. Le dimissioni o il
licenziamento (per colpa o per ragioni oggettive inerenti alla persona) di uno dei due comporta l’estinzione dell’intero
vincolo contrattuale, a meno che il datore e l’altro lavoratore non convertano il contratto di lavoro ripartito in un
normale contratto di lavoro subordinato.
Viceversa, il licenziamento per ragioni aziendali non può che riguardare entrambi i lavoratori.
3.Il lavoro intermittente.
Sulla scia di esperienze straniere il D.lgs n. 276/2003 disciplina il contratto di lavoro intermittente (o job on call) cioè il
contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore che ne può utilizzare la prestazione
lavorativa (art. 33).
La peculiarità sta nel fatto che il datore può utilizzare la prestazione lavorativa in modo intermittente, se e quando
decida di farlo, e a sua volta il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata (lavoro intermittente senza obbligo
di disponibilità).
Le cose cambiano se, con l’apposizione di una clausola accessoria, il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata
del datore (lavoro intermittente con obbligo di disponibilità). In tal caso peraltro, sorge un correlativo obbligo del datore
di corrispondere al lavoratore un’indennità di disponibilità.
Si può ricorrere al lavoro intermittente soltanto in presenza di determinate causali:
-per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti
collettivi;
-oppure per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (fine settimana, ferie estive, vacanze
pasquali o natalizie).
È inoltre consentito in via sperimentale l’utilizzo del lavoro intermittente per giovani fino a 25 anni o per lavoratori con
più di 45 anni esclusi dal ciclo produttivo o iscritti nelle liste di mobilità o di collocamento.
È invece vietato il ricorso al lavoro intermittente negli stessi casi di divieto per il lavoro a termine e per il lavoro
somministrato:
-per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
-in unità produttive nelle quali si sia proceduto nel 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi, a sospensioni oppure a
riduzioni di orario di lavoro che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente.
Anche il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ad probationem. Esso deve indicare la
causale giustificativa, la durata, il luogo e la modalità della disponibilità del lavoratore, il trattamento economico e
normativo.
Caratteristica del lavoro intermittente è che la prestazione non è effettuata con continuità, come di norma, ma solo su
richiesta del datore. E a sua volta il contratto non genera automaticamente un obbligo del lavoratore di rispondere
positivamente alla chiamata del datore. Perché tale obbligo sussista è necessario che sia inserita una apposita clausola
nel contratto individuale, a fronte della quale deve essere corrisposta al lavoratore una indennità di disponibilità.
Per quanto riguarda il trattamento economico bisogna distinguere a seconda che si tratti di lavoro intermittente con o
senza obbligo di disponibilità.
-in caso di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, per i periodi non lavorati, il lavoratore non è titolare di
alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati (e dunque non percepisce nulla).
-se invece si tratta di lavoro intermittente con obbligo di disponibilità, per i periodi di disponibilità garantita, il
lavoratore ha diritto a percepire la relativa indennità.
Per i periodi lavorati invece ha diritto al regolare trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di
categoria, proporzionato, naturalmente in ragione della prestazione effettivamente eseguita. Da ciò si desume che
trovano applicazione anche nel lavoro intermittente i principi di non discriminazione e di proporzionalità nel
trattamento economico e normativo.
Contratti a contenuto formativo e altre esperienze di alternanza formazione/lavoro.
1.Dall'apprendistato agli apprendistati.
Sulla strada dell'alternanza e dell'intreccio tra formazione e lavoro, la legislazione è venuta proponendo in primis
l'apprendistato-denominato tirocinio dal codice civile-strumento d'ingresso del giovane nel mondo del lavoro, scosso
nelle sue fondamenta e rinnovato dal D.lgs. 276/2003, il quale prevede 3 tipologie di contratto di apprendistato
differenziate, che perseguono l’obiettivo di formare il giovane per il suo inserimento nel mercato del lavoro.
Quello derivante dal contratto di apprendistato è un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, la cui specialità
discende dalla causa mista del contratto: non solo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, ma anche e
soprattutto scambio tra attività lavorativa e formazione professionale, interna ed esterna all’azienda.
Dunque a fronte della prestazione lavorativa, il datore si obbliga a corrispondere all’apprendista, non solo una
controprestazione retributiva, ma anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale,
di una qualificazione tecnico-professionale o di titoli di studio di livello secondario o universitario.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato classico i giovani di età non inferiore ai
16 anni e non superiore a 24. Il contratto di apprendistato è subordinata quindi ad un limite minimo e ad uno massimo di
età. Il limite massimo di età riguarda esclusivamente il momento in cui il rapporto ha inizio, ma se valicato
successivamente, non ne preclude la continuazione.
Al fine di tutelare la salute del lavoratore si fissa l'obbliga di visita sanitaria pre-assuntiva per accertare che le
condizioni fisiche di questo ne consentano l'assegnazione al lavoro per il quale deve essere assunto. È consentita
l'apposizione del patto di prova che tuttavia non può avere durata superiore a due mesi.
La fissazione della durata dell'apprendistato classico è rinviata ai contratti collettivi nazionali e non potrà essere
inferiore ai 18 mesi e superiore ai 4 anni ((L. n. 196/1997). I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso
più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non
separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Il numero massimo di apprendisti che un datore può assumere non può superare il numero del personale specializzato e
qualificato in servizio (ma se il personale qualificato è composto da soli 3 elementi è ammessa in deroga l’assunzione di
3 apprendisti).
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei lavoratori occupati ai fini
dell’applicazione di quegli istituti collegati al superamento di una certa soglia occupazionale.
Addestramento pratico e insegnamento complementare caratterizzano a partire dal 1998 il contratto di apprendistato
classico con l'intento di renderlo più congruo ad una formazione professionale effettiva, attenuandone la valenza di
mero strumento di riduzione del costo del lavoro.
Durante il rapporto di apprendistato trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, mentre al termine del
periodo il datore di lavoro ha facoltà di dare disdetta ai sensi dell'art. 2118 c.c.
L’assunzione di apprendisti comporta per il datore di lavoro il vantaggio economico di una ridottissima contribuzione
previdenziale e assicurativa. Tali incentivi sono naturalmente subordinati all’effettività della formazione da parte del
datore di lavoro, e dunque vengono meno in caso si accerti un grave inadempimento dell’obbligo formativo imputabile
al datore (il datore dovrà versare la differenza dei contributi maggiorata del 100%).
Il D.lgs n. 276/2003 prevede per un futuro prossimo la sostituzione del contratto di apprendistato con una trilogia di tipi
contrattuali. L'entrata in vigore delle nuove tipologie di apprendistato non è immediata e nelle more di una
regolamentazione ulteriore (demandata alle Regioni e alla contrattazione collettiva) si applica la vecchia e classica
disciplina:
-apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (apprendistato del 1° tipo)
Tale apprendistato costituisce un’alternativa alla frequenza di un istituto di scuola media superiore ed è volto al
conseguimento di una qualifica professionale per giovani che abbiano compiuto i 15 anni.
La stipulazione di questo contratto consente al minore di entrare nel mondo del lavoro e contemporaneamente di
adempiere ai propri obblighi formativi.
Possono essere assunti giovani di età compresa tra i 15 ed i 18 anni e la durata massima del contratto è di 3 anni (purché
sempre all’interno del limite massimo d’età).
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta (ad substantiam). Al contratto di apprendistato si applica la disciplina
del licenziamento vigente in materia di lavoro subordinato, per cui il licenziamento dell’apprendista è legittimo solo in
presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Al termine del periodo di apprendistato invece, il datore può
recedere dal rapporto ai sensi dell’art. 2118 c.c..
Quanto alla formazione da erogare il legislatore nazionale rinvia quasi completamente alle norme regionali.
-apprendistato professionalizzante (del 2° tipo)
Tale apprendistato mira al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso una formazione sul lavoro ed
un apprendimento tecnico-professionale.
Mentre dunque l’apprendistato del 1° tipo mira a far conseguire al giovane un titolo di studi e costituisce assolvimento
del diritto-dovere di istruzione, l’apprendistato professionalizzante mira a far conseguire al giovane una qualificazione,
accrescendone le competenze fino a farlo divenire un lavoratore qualificato.
Possono essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata del contratto deve essere tra un minimo di
2 ed un massimo di 6 anni.
Anche questo contratto deve essere stipulato in forma scritta e vale quanto detto prima a proposito del licenziamento.
Per quanto riguarda la formazione professionale, il legislatore nazionale, pur rinviando al legislatore regionale,
stabilisce che debbano comunque essere erogate al giovane almeno 120 ore per anno di formazione teorica (distinta
dall’addestramento pratico).
-apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (apprendistato del 3° tipo)
Tale apprendistato è diretto al conseguimento di un titolo di studio secondario, universitario e di alta formazione.
Possono essere parti di tale contratto soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. Non sono previsti limiti di durata del
contratto.
I profili che attengono alla formazione sono rimessi alle regioni, ma è chiaro che il fulcro della formazione consisterà
nella frequenza di una scuola superiore o università.
2.I contratti di formazione e lavoro.
Il contratto di formazione e lavoro è nato con la finalità di agevolare l’occupazione giovanile mediante un’esperienza di
lavoro formativa. Tuttavia nel tempo tale finalità è stata snaturata e tale tipo di contratto si è trasformato in uno
strumento di procacciamento di manodopera giovane con un regime agevolato.
Sicché, in seguito alle decisioni della commissione europea e della corte di giustizia europea (che hanno considerato il
regime di benefici economici previsto per tale tipo di contratto in contrasto con la normativa europea sulla
concorrenza), il legislatore italiano (contestualmente alla creazione di un nuovo contratto a finalità formative; il
contratto di inserimento), ridusse l’ambito di applicazione del CFL, ormai in estinzione.
A partire dall’ottobre 2003 la disciplina dei CFL viene circoscritta all’ambito del pubblico impiego e trova solo
residuale applicazione nell’impiego privato, limitatamente ai contratti in corso (per i quali peraltro, sono stati limitati i
benefici previsti originariamente).
Tramite CFL possono essere assunti giovani fra i 16 ed i 32 anni. Si distinguono due tipologie di CFL.
-il CFL forte che concede al datore ampie flessibilità (durata fino a 2 anni, benefici contributivi) in cambio di un’attività
formativa vera e propria, volta ad accrescere la professionalità del lavoratore.
-ed il CFL leggero, che riduce la porzione di flessibilità (durata dimezzata e benefici solo in caso di stabilizzazione)
accontentandosi di un’attività più informativa che formativa, volta ad agevolare l’inserimento lavorativo.
Per la stipulazione del contratto è richiesta la forma scritta, pena la conversione in contratto a tempo indeterminato.
Anche l’inosservanza da parte del datore degli obblighi di formazione comporta la trasformazione del CFL in contratto
a tempo indeterminato (sin dalla sua instaurazione) e la revoca dei benefici contributivi (anch’essa sin dall’inizio).
Il CFL è un contratto non facilmente classificabile; species del genus contratto a termine, è ormai considerato un
contratto a causa mista o complessa con una doppia obbligazione principale a carico del datore, retribuzione e
formazione. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di
lavoro subordinato.
3.Il contratti di inserimento.
L’estinzione (almeno nel settore privato) del CFL è coincisa con l’ascesa ad opera del D.lgs n. 276/2003 di un’altra
tipologia di contratto a contenuto formativo: il contratto di inserimento. Si tratta di un contratto dalla più marcata
finalità occupazionale che formativa. Esso infatti è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo,
l’inserimento (o il reinserimento) nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori. Si tratta dunque di uno
strumento diretto a realizzare l’inserimento mirato nel mercato del lavoro di categorie socialmente deboli.
Introducendo tale tipologia contrattuale, il legislatore ha inteso valorizzare l’acquisizione di professionalità concreta,
calibrata in rapporto al fabbisogno del datore di lavoro, nella prospettiva della futura, eventuale stabilizzazione del
rapporto.
Possono essere assunti con contratto di inserimento se seguenti categorie di persone:
-soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
-disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni.
-lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro.
-donne residenti in aree geografiche con un elevato tasso di disoccupazione femminile.
-persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
L'utilizzo del contratto di inserimento è escluso nel pubblico impiego con l'eccezione degli enti pubblici di ricerca e
degli enti pubblici economici.
Condizione necessaria per l’assunzione con contratto d’inserimento è la definizione (col consenso del lavoratore) di un
progetto individuale di inserimento, volto a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore
stesso al contesto lavorativo. Ciò dovrebbe significare che non sono assumibili con questa tipologia contrattuale
soggetti privi di una capacità professionale adattabile per i quali invece, dovrebbe essere utilizzato, ove possibile,
l'apprendistato.
L'Accordo interconfederale firmato l'11 febbraio 2004 dispone che il progetto individuale di inserimento debba
prevedere una formazione teorica non inferiore alle 16 ore, ripartita tra apprendimento di nozioni di prevenzione
antinfortunistica e disciplina del rapporto e organizzazione aziendale.
La causa del contratto di inserimento può essere considerata mista se è prevista una formazione professionale. Il
contratto d’inserimento deve essere stipulato in forma scritta e in esso deve essere necessariamente indicato il progetto
individuale di inserimento concordato col lavoratore. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si
intende assunto a tempo indeterminato sin dall’origine.
Il contratto d’inserimento può avere una durata variabile da 9 a 18 mesi (se il rapporto continua alla scadenza del
termine, il contratto si trasforma in un normale contratto a tempo indeterminato.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, ai contratti d’inserimento di applicano, per quanto compatibile, la
disciplina in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.
Così come il contratto di apprendistato ed i contratti di formazione e lavoro, il contratto d’inserimento comporta dei
vantaggi economici e normativi per il datore. È previsto infatti che al lavoratore possa essere attribuito un
inquadramento inferiore rispetto a quello corrispondente alla qualifica al cui conseguimento è preordinato il contratto
d’inserimento (ed il sotto-inquadramento comporta ovviamente un trattamento economico inferiore). L’inquadramento
del lavoratore può arrivare sino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante.
Inoltre anche i lavoratori assunti con contratto d’inserimento sono esclusi dal computo dei lavoratori occupati.
4.I tirocini formativi e di orientamento.
I tirocini formativi e di orientamento (stage) non configurano un rapporto di lavoro subordinato e consistono in un
inserimento temporaneo (di durata non superiore a 12 mesi, 24 nel caso di disabili) di un soggetto all’interno del mondo
produttivo, allo scopo di sperimentare un contatto diretto ed un addestramento pratico.
I tirocini formativi possono essere svolti sulla base di convenzioni stipulate tra datori privati e pubblici (ospitanti) e
soggetti promotori individuati dalla legge (agenzie regionali per l’impiego, università, scuole), in cui i tirocinanti sono
parte terza.
Non si prevede normalmente la corresponsione di alcuna somma di denaro al tirocinante, anche se spesso il soggetto
ospitante eroga una borsa o premo al termine dello stage.
Questa pratica è adottata sovente dalle scuole medie superiori e dalle università nel percorso didattico degli studenti
consentendo loro di accumulare “crediti formativi”.
Tutti gli stagisti devono essere assicurati contro gli infortuni, le malattie professionali e per la responsabilità civile verso
terzi nonché informati sulle misure di tutela e di sicurezza sul lavoro. La disciplina recente tende ad incentivare gli stage
rendendoli meno costosi per i datori, trasferendo sui soggetti promotori sia i costi connessi alla figura del tutore, sia
quelli per la responsabilità civile e gli infortuni sul lavoro.
Proprio nell'ottica di realizzare un'alternanza tra formazione e lavoro, con il D.lgs n. 276/2003 (art. 60) ha visto la luce
per brevissimo tempo un nuovo tipo di tirocinio di orientamento denominato “estivo”, riguardante un adolescente o
giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico che intenda svolgere
un'esperienza in azienda con fini orientativi e di addestramento pratico. Questa previsione però, è stata dichiarata
incostituzionale, poiché, attenendo alla formazione professionale riguarda una materia di competenza esclusiva delle
Regioni.
CAPITOLO DODICI: IL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
1. La c.d. Privatizzazione del pubblico impiego.
Il decennio 1992/2003 ha assistito alla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego. Il D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
opera un'autentica rivoluzione sul piano delle fonti, traghettando il rapporto di pubblico impiego dal diritto pubblico al
diritto privato (ovvero dal diritto amministrativo al diritto del lavoro). Da un lato, il decreto modifica l'atto posto alla
base del rapporto di impiego, che è ora un contratto e non più un provvedimento unilaterale e di nomina da parte della
pubblica amministrazione; dall'altro, restituisce al contratto collettivo il ruolo di fonte immediata di disciplina del
rapporto.
In origine il rapporto di pubblico impiego nasce come istituto giuridico in ragione delle esigenze organizzative della
pubblica amministrazione per il perseguimento dell'interesse istituzionale di essa, che è, per definizione interesse
pubblico generale. Il rapporto di pubblico impiego, dunque, per lungo tempo non è caratterizzato da una posizione
paritaria fra dipendente ed amministrazione e resta estraneo al modello della locatio operarum, presentando caratteri
alternativi rispetto al rapporto con un datore di lavoro privato.
I tratti caratteristici del tradizionale rapporto di impiego pubblico sono riassumibili nell'esercizio da parte della pubblica
amministrazione della supremazia speciale e nella configurabilità in capo al dipendente di una posizione di status: in
precedenza il rapporto traeva origine non da un contratto, ma da un atto amministrativo unilaterale (l'atto di nomina);
non si rinveniva il carattere della sinallagmaticità, per cui le prerogative di cui il dipendente godeva trovavano causa
non nello scambio, ma nell'esigenza di garantire le condizioni necessarie al miglior esercizio delle funzioni pubbliche
(imparzialità, buon funzionamento ecc.).
La riforma prende un timido avvio con la L. n. 93 del 1983 (legge quadro sul pubblico impiego) che per la prima volta
valorizza la logica dello scambio. Nel breve volgere di due anni, fra il 1992 e 1993, il Parlamento ed il Governo varano
la cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico. Le L. d. n. 59/1977 (c.d. “delega Bassanini”) e n.
127/1977 (c.d “Bassanini bis”) sfociano in una sequenza di decreti legislativi, tutti confluiti nel D.lgs. 30 marzo 2001, n.
165 (Testo unico per il pubblico impiego). Infine, a modifica di alcune rilevanti norme del D.lgs. n. 165/2001, è stato
emanato un nuovo provvedimento in materia di riordino della dirigenza statale finalizzato “a favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”, che ha di fatto inaugurato una terza fase della riforma.
Con questi interventi il legislatore ha ampliato l'area della privatizzazione:
a) circoscrivendo il più possibile il limite della specialità;
b) coinvolgendo nella riforma anche la dirigenza generale, precedentemente esclusa;
c) prevedendo che l'organizzazione delle pubbliche amministrazione resti sottoposta al diritto pubblico solo
limitatamente alle “linee fondamentali di organizzazione degli uffici, all'individuazione e ai modi di conferimento degli
uffici di maggiore rilevanza, alle dotazioni organiche complessive” (cosiddetti atti macro-organizzativi), mentre gli atti
di gestione organizzativa, in primis del personale, vengono attratti nell'orbita del diritto privato (cosiddetto microorganizzazione).
2.Tratti di specialità nella disciplina del rapporto alle dipendenze della P.A.: le linee portanti della privatizzazione.
Nonostante la privatizzazione, il rapporto di pubblico impiego conserva consistenti tratti di disciplina speciale per gli
interessi pubblici implicati e in relazione alla peculiare organizzazione del datore di lavoro.
La specialità della disciplina è volta ad adattare il modello privatistico dettato dal Codice civile e dallo Statuto dei
lavoratori alla particolare struttura organizzativa della pubblica amministrazione. Il nucleo della riforma del rapporto di
pubblico impiego è contenuto negli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 165/2001 che stabilisce la riconduzione del rapporto al
contratto individuale di lavoro così in fase di costituzione, come di gestione del rapporto medesimo, nonché
l'applicazione del Codice civile e delle leggi che regolano il lavoro nell'impresa privata. La Pubblica amministrazione si
pone ormai in un rapporto paritario di scambio con il proprio dipendente e agisce nella veste di privato datore di lavoro,
con poteri di autonomia privata anche se con limiti maggiori e diversi rispetto al datore privato. Questa nuova
configurazione non elide dunque la pregnanza dei pubblici interessi pur sempre perseguiti dalla pubblica
amministrazione, ma ne sancisce l'estraneità alla struttura del rapporto. La riforma incide dunque sul rapporto di lavoro;
ma non modifica la natura del datore di lavoro, che rimane pubblica.
La scelta di considerare la riserva di legge operante solo per l'organizzazione degli uffici e non per il rapporto di lavoro
incide sull'ambito di applicazione soggettivo della riforma: questa ricomprende anche i rapporti di lavoro dei dipendenti
che sul distinto piano dell'organizzazione amministrativa esercitano funzioni pubbliche, si pensi in primo luogo ai
dirigenti. Resta esclusa dalla privatizzazione, una serie di figure la cui attività per lo più si identifica con le funzioni
costitutive della civitas.
Altrettanto esteso è l'ambito oggettivo della riforma che si applica non solo direttamente alle amministrazioni dello
Stato, ma anche alle amministrazioni dotate di autonomia riconosciuta a livello costituzionale, quali le regioni, le
provincie, i comuni, le università. Inevitabile conseguenza della privatizzazione deve ritenersi il passaggio dalla
giurisdizione del giudice amministrativo a quella del giudice ordinario. Per i dipendenti pubblici e privati, un unico
giudice garantirebbe, al di là dell'uniformità delle regole, l'uniformità della loro interpretazione ed applicazione. La
scelta del legislatore è quella di devolvere al giudice ordinario le controversie relative alle materie attinenti al rapporto
di lavoro e di conservare alla giurisdizione del giudice amministrativo quelle relative alla organizzazione ed all'esercizio
della funzione.
Vi è la perfetta consequenzialità fra “privatizzazione” del rapporto e devoluzione delle controversie al giudice ordinario:
il pubblico dipendente, il cui rapporto di lavoro è ormai fondato sul contratto, vanta nei confronti della pubblica
amministrazione, veri e propri diritti soggettivi, rispetto ai quali il giudice naturale è appunto proprio il giudice
ordinario.
3.La dirigenza pubblica.
Con l'espressione dirigenza pubblica si individua il personale di più elevata posizione all'interno delle amministrazioni
con proprie attribuzioni in ordine all'organizzazione e all'esercizio delle attività amministrativo-gestorie.
Negli anni '90 si pose il problema della definizione di una nuova disciplina della dirigenza, considerata momento
centrale per l'adozione di un modello organizzativo c.d. “per obbiettivi” della pubblica amministrazione. La versione
originaria della riforma presentava ambiguità e certezza, per questo perfezionata e rivista nell'ambito della cosiddetta
“seconda privatizzazione”, poi confluita nel c.d. Testo unico del pubblico impiego (D.lgs. n. 165/2001).
La dirigenza pubblica è retta da una specifica disciplina, legislativa e contrattuale contenuta nel capo II del D.lgs. n.
165/2001, applicabile in via diretta alle amministrazioni dello Stato, mentre per le pubbliche amministrazioni non statali
sono previsti specifici criteri di adeguamento. L'elemento qualificante del riassetto della dirigenza consiste nella c.d.
“contrattualizzazione” del rapporto di lavoro di tutti i dirigenti, che permette di separare il contratto di lavoro ed il
conferimento dell'incarico. Fondamentale è la ridefinizione dei rapporti tra dirigenti ed organi politici al fine di far
acquisire alla dirigenza una reale autonomia operativa. Si tratta di una disciplina dettagliata che delinea un processo
circolare che si sviluppa in tre fasi. Una prima fase si ha quando gli organi di indirizzo forniscono le direttive; una
seconda fase in cui gli organi burocratici agiscono in piena autonomia e con ampia discrezionalità per il raggiungimento
degli obbiettivi prefissati dai primi; una terza in cui gli organi di indirizzo verificano l'attività svolta dai dirigenti anche
ai fin del conferimento del successivo incarico e dell'attribuzione del trattamento economico accessorio.
Tale modificazione della disciplina della dirigenza pubblica costituisce il necessario presupposto della privatizzazione
del pubblico impiego. Lo sviluppo del processo circolare ridefinisce i rapporti tra organi politici ed organi burocratici,
ridefinizione contenuta nei “Principi generali” del D.lgs. n. 165/2001 in base alla quale gli organi di governo esercitano
“le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obbiettivi ed i programmi da attuare”.
Ai dirigenti spetta invece “l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo”. I dirigenti sono, quindi, “responsabili della
gestione e dei relativi risultati” e gli organi di direzione politica verificano la rispondenza dei risultati della gestione e
delle direttive generali impartite, così da chiudere il suddetto processo circolare.
La categoria dei dirigenti pubblici si articola in 2 fasce: la prima, dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, che
intrattengono rapporti direttamente con gli organi di governo; la seconda, dei dirigenti tout court, che comprende tutti
gli altri. Alla qualifica di dirigenti di ruolo si accede tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni o
per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al concorso
per esami possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ed alcuni soggetti esterni muniti di
esperienze dirigenziali nelle P.A., mentre il corso-concorso ammette la partecipazione di soggetti esterni oltre a quella di
dipendenti pubblici con una congrua anzianità di servizio in qualificate posizioni funzionali. Esaurito il reclutamento, il
vincitore stipula con l'amministrazione un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, regolato
dal diritto comune e dai contratti collettivi.
Nel settore pubblico si assiste alla scissione tra stipulazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
conferimento dell'incarico a termine. L'inserimento nel ruolo dell'amministrazione conseguente alla stipulazione del
contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce, infatti, il presupposto per il successivo atto dell'amministrazione
che conferisce al dirigente la titolarità, a tempo determinato, di un ufficio dirigenziale. Il conferimento dell'incaricato,
che è atto unilaterale individua l'oggetto dell'incarico e gli obbiettivi da conseguire, nonché la durata dell'incarico. Al
provvedimento di conferimento accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento
economico.
Il D.lgs. n. 165/2001 introduce la cosiddetta regola dello spoil system che consiste nella cessazione degli incarichi di
funzione dirigenziale al variare della compagine politica. Oltre all'ipotesi citata, la revoca dell'incarico prima della
scadenza del termine è prevista in altre due ipotesi. In primo luogo, può essere conseguenza della risoluzione del
rapporto. In secondo luogo, la revoca dell'incarico rappresenta l'esito della dell'accertamento della responsabilità
dirigenziale. L'istituto della responsabilità dirigenziale rientra nella logica di valutazione e di controllo dell'attività della
dirigenza. L'accertamento di tale responsabilità è l'esito di un procedimento di valutazione annuale, svolto in
contraddittorio con il dirigente. L'accertamento della responsabilità comporta per il dirigente l'impossibilità di rinnovo
dello stesso incarico e la revoca dell'incarico. Tali provvedimenti sono adottati previo conforme parere di un Comitato
di Garanti. In caso di licenziamento il dirigente può ricorrere ad un collegio di conciliazione, che pone a carico
dell'amministrazione un'indennità supplementare, qualora il recesso risulti ingiustificato, ma non la garanzia della
reintegrazione prevista in generale per tutti gli altri pubblici dipendenti.
4.Il reclutamento del personale. Forme contrattuali flessibili.
Nonostante la privatizzazione o contrattualizzazione del pubblico impiego, persistono forti tratti di specialità del
rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni specie in tema di accesso all'impiego, tecnicamente detto
“reclutamento”. I procedimenti di assunzione restano infatti nell'area coperta da riserva do legge e sono sottoposti ad
una disciplina pubblicistica, in ossequio agli art. 51, 97 e 98 della Costituzione, ritenendo il concorso pubblico quale
meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci e metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad
esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione.
L'art. 35 D.lgs. n. 165/2001, prevede che il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni possa avvenire:
a)tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta (concorso); b)mediante richiesta
numerica con avviamento degli iscritti nelle liste appositamente redatte dagli uffici regionali o provinciali competenti e
nelle liste di mobilità per le qualifiche e profili medio-bassi; c)mediante richiesta numerica o nominativa dei disabili
iscritti nelle liste speciali di collocamento.
Per l'assunzione, che avviene “con contratto individuale di lavoro”, il datore di lavoro pubblico può anche avvalersi
delle tipologie contrattuali definite flessibili o atipiche previste dal codice civile , purché nel rispetto delle disposizioni
sul reclutamento del personale sopra indicate.
Discorso a parte merita il part-time, dato che non soltanto è inserito a pieno titolo tra le tipologie flessibili, ma è
addirittura prevista in molti casi la trasformazione automatica dal tempo pieno al tempo parziale a domanda del
lavoratore; con diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle
successive scadenze previste dai contratti collettivi. Fini peculiari del part-time nel settore pubblico sono, non tanto
l'aumento dell'occupazione, quanto il contenimento del costo del lavoro e la lotta al cosiddetto “doppio lavoro”.
Diversamente dal settore privato, la disciplina del pubblico impiego esclude sempre che la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori possa comportare come sanzione la costituzione di
rapporti a tempo indeterminato con la stessa pubblica amministrazione.
5.Mansioni, inquadramento e jus variandi.
Di fondamentale importanza è la trasposizione del principio di “contrattualità” delle mansioni, con una significativa
attenzione concentrata sul facere del lavoratore, piuttosto che sulla qualifica formale rivestita.
In tema di jus variandi permane tuttavia uno dei più importanti tratti di specialità. La deroga alla disciplina comune,
cioè all'art. 2103 c.c., trova una giustificazione nell'esigenza di permettere alle pubbliche amministrazioni di controllare
sempre l'accesso a qualifiche superiori da parte dei dipendenti. Questa deroga è ora confermata dall'art. 52 D.lgs. n.
165/2001, in un'ottica di tendenziale unificazione fra lavoro pubblico e lavoro privato.
In primo luogo il parametro dell'equivalenza (professionale) delle mansioni, come nel provato, è richiamato quale limite
al potere organizzativo del datore pubblico, ma l'art. 52 D.lgs. n. 165/2001 attribuisce il giudizio di equivalenza al
sistema di “classificazione professionale prevista dai contratti collettivi” anziché agli oscillanti percorsi
giurisprudenziali. La specialità più rilevante riguarda l'assegnazione a mansioni superiori. L'art. 52 D.lgs. n. 165/2001
prevede uno jus variandi in melius non discrezionale, come nel privato, ma soltanto in due ipotesi tassative: a)vacanza
di posto in organico, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili a dodici nel caso di contestuale attivazione
delle procedure per la copertura del posto; b)sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto
per tutto il periodo di assenza, escluse le ferie. La modifica temporanea deve essere giustificata da obbiettive esigenze
di servizio e l'adibizione può avvenire soltanto a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore.
L'adibizione legittima ed effettiva a mansioni superiori dà diritto al trattamento economico e normativo corrispondente
all'attività svolta, ma, in deroga all'art. 2103 c.c., non conferisce mai il diritto all'attribuzione definitiva della qualifica
corrispondente.
Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla norma l'assegnazione a mansioni superiori è quindi nulla, sicché il
lavoratore può rifiutarla. Tuttavia, in caso di esercizio di fatto di mansioni superiori, la disciplina vigente, pur negando il
passaggio automatico alla qualifica superiore, riconosce il diritto del lavoratore alle differenze retributive corrispondenti
all'attività svolta per tutto il periodo di espletamento.
6.La retribuzione e il trattamento di fine rapporto.
La materia retributiva risponde all'esigenza di parificazione nei trattamenti economici in relazione ai sistemi di
inquadramento e di un rafforzato controllo sul costo del lavoro pubblico.
L'assetto realizzato è in gran parte coerente con il settore privato, sia con riguardo all'applicazione dei principi
costituzionali di sufficienza e proporzionalità, sia riguardo al sistema delle fonti. Secondo l'art. 45 del D.lgs. n.
165/2001 “ il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”, ridimensionando
fortemente il ruolo del contratto individuale.
L'art. 45 D.lgs. n. 165/2001 impone alle amministrazioni pubbliche di garantire ai propri dipendenti “parità di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”,
introducendo un limite legislativo rispetto all'adozione di trattamenti economici differenziati tra lavoratori.
Ai dipendenti pubblici “contrattualizzati” l'art 2, 5° comma, L. n. 335/1995 ha esteso il meccanismo di calcolo della
“liquidazione” introdotto dalla L. n. 297/1982. Il nuovo impianto normativo utilizza il TFR come mezzo di
contribuzione ai fondi pensionistici complementari (cosiddetti fondi pensione), facendo precedere dai necessari
stanziamenti di spesa, l'intervento della contrattazione collettiva.
La parificazione con i dipendenti privati è destinata ad operare pienamente per i lavoratori pubblici che risultano neoassunti al 31 dicembre 2000: il loro TFR è in toto assoggettato all'art 2120 c.c. Per i lavoratori già occupati al 31
dicembre 2000, il passaggio al TFR è subordinato, invece, all'esercizio di una specifica opzione che comporta anche
l'automatica adesione al fondo pensione di comporto; per coloro, invece, che non eserciteranno l'opzione, rimarrà ferma
la precedente disciplina relativa al TFR.
Il TFR è accantonato figurativamente e, alla cessazione dal servizio, liquidato dall'INDAP, cui viene affidata la gestione
del fondo per il TFR dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali. Per i dipendenti degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca e di sperimentazione, l'accantonamento, la gestione e la liquidazione del TFR saranno invece
effettuati dai singoli enti datori di lavoro.
La L. n. 335/1995 è intervenuta a soddisfare l'esigenza di parificazione normativa tra settore pubblico e privato,
espressa sia dal D.lgs. n. 29/1993, sia dalla L. n. 87/1994, che aveva introdotto il computo di una quota di indennità
integrativa speciale, onde assicurare una sostanziale equivalenza al TFR nel risultato complessivo. Lavoro privato e
pubblico sono accomunati inoltre dalla riforma c.d. Maroni relativa al sistema previdenziale pubblico e complementare.
7.Il potere disciplinare e il licenziamento per motivi soggettivi.
L'adozione del contratto e l'attribuzione all'amministrazione dei poteri e delle capacità del privato datore di lavoro
permettono infatti di conferire diversa natura al potere disciplinare, privando la pubblica amministrazione delle
tradizionali posizioni di supremazia speciale.
La materia è ora regolata dall'art. 55 del D.lgs n. 165/2001 che contiene una disciplina parzialmente derogatoria rispetto
a quella vigente nel settore privato, applicabile a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con esclusione dei
soggetti sottratti alla privatizzazione. L'art. in esame rinvia all'art 2106 c.c., che individua le infrazioni nell'inosservanza
delle disposizioni in materia di diligenza, di obbedienza e di fedeltà.
Gli obblighi del pubblico dipendente il cui rapporto è privatizzato non si differenziano da quelli del dipendente privato:
si tratta di obblighi volti a garantire l'esatto adempimento della prestazione dovuta che non coinvolgono in alcun modo
la sfera privata del dipendente.
La tipologia e l'entità delle infrazioni nonché delle sanzioni sono definite dai contratti collettivi nell'ambito del codice
disciplinare, nel rispetto del limiti stabiliti dalla legge e, in particolare, dal criterio di proporzionalità.
Non pare dunque possibile interpretare il richiamo ai contratti collettivi, come individuazione di una fonte “esclusiva” e
“obbligatoria” di determinazione delle infrazioni e sanzioni in via negoziale, essendo invece la normativa contrattuale
fonte da considerarsi solo “privilegiata”. Non è peraltro esteso al settore pubblico l'art. 4, 4° comma St.lav., ove si
stabilisce che “non possono essere disposte sanzioni che comportino mutamenti definitivi del rapporto” e che “la multa
non può essere disposta per un importo superiore a 4 ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio per più di
10 giorni”, individuando così una tipologia “legale” delle sanzioni.
Nel novero delle sanzioni deve essere compreso, così come nel privato, anche il licenziamento disciplinare rispetto al
quale non si pongono, stante la generale applicabilità dello Statuto dei lavoratori e dunque del suo art. 18 a prescindere
dal numero dei lavoratori impiegati, i problemi conosciuti nel settore privato circa la tutela applicabile in caso di
licenziamento disciplinare illegittimo.
I commi da 1 a 6 dell'art. 55, D.lgs n. 165/2001 dettano una disciplina esaustiva del procedimento disciplinare che
ricalca quello dell'art 7 dello Statuto dei lavoratori; il risultato consiste nella definizione di una procedura assai più
snella ed efficiente rispetto ai numerosi oneri procedimentali contemplatati negli art da 100 a 123 del T.U. n. 3/1957. Si
prevede che, salvo il caso in cui le sanzioni da applicare si identifichino con il rimprovero verbale o scritto (censura), ad
irrogarle non sia il capo della struttura, ma, su segnalazione di questo, un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari
(U.P.D.). E' l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari che fa tutto: contesta l'addebito al dipendente, istruisce il
procedimento e applica la sanzione; al capo della struttura in cui il dipendente lavoro resta solo il compito di
segnalazione sulle ipotesi di infrazione. In analogia con il settore privato è necessaria la tempestiva contestazione per
iscritto degli addebiti e l'audizione a difesa del dipendente assistito da un rappresentante di associazione sindacale o da
un procuratore. L'audizione a difesa del dipendente deve avvenire nel termine di 15 giorni dalla convocazione; nei
successivi 15 giorni la pubblica amministrazione deve applicare la sanzione, inoltre “i provvedimenti disciplinari più
gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha dato causa”. Tali disposizioni potrebbero essere coordinate nel modo seguente: a)prima
ipotesi: la pubblica amministrazione contesta l'addebito, decorrono 15 giorni ed il dipendente non si presenta, nei
successivi 15 giorni la pubblica amministrazione può irrogare la sanzione; b)seconda ipotesi: la pubblica
amministrazione contesta l'addebito, il dipendente si presenta per difendersi fra il 1° e il 15° giorno; fra il 5° e il 15°
giorno successivo all'audizione la pubblica amministrazione può irrogare la sanzione.
Una novità assoluta è costituita dall'istituto del c.d. “patteggiamento” che consente una più pronta definizione dei
procedimenti e di una deflazione del contenzioso in materia disciplinare: se il dipendente vi consente è, infatti, possibile
l'applicazione di una sanzione ridotta, ma questa non è più suscettibile di impugnazione, né in via giudiziale né
arbitrale. Infine è prevista la procedura di carattere conciliativo-arbitrale, da esperirsi secondo le modalità fissate dai
contratti collettivi o in mancanza innanzi al Collegio arbitrale di disciplina istituito presso ciascuna pubblica
amministrazione. Nel corso della procedura conciliativo-arbitrale la sanzione resta sospesa, mentre solo la pubblica
amministrazione, diversamente dal dipendente, ha l'obbligo di conformarsi alla decisione del Collegio. Ciò non
significa che all'Amministrazione sia preclusa l'impugnativa giudiziale del provvedimento arbitrale, bensì che esiste per
la pubblica amministrazione un obbligo legale di immediata esecuzione del provvedimento, a prescindere dalla sua
successiva impugnazione. L'art 56 prevede che, se i contratti collettivi non abbiano istituito apposite procedure di
conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore innanzi al Collegio di
conciliazione per le controversie di impiego pubblico presso la Direzione provinciale del lavoro.
Un ulteriore profilo di specialità è costituito dalla regolazione legislativa dei rapporti tra processo penale e
procedimento disciplinare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La L. 27 marzo 2001, n. 97, ha infatti
ristabilito, con la modifica dell'art. 653 c.p.p., un rapporto di pregiudizialità degli esiti del processo penale sul
procedimento disciplinare, sia in caso di assoluzione che di condanna del dipendente, introducendo altresì nuove misure
cautelari obbligatorie, adottabili dalle pubbliche amministrazioni nelle ipotesi di rinvio a giudizio del dipendente per
gravi reati contro la pubblica amministrazione. In certi casi la condanna in sede penale può comportare l'applicazione,
da parte del giudice penale, della pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro.
8.Estinzione del rapporto e tutela contro i licenziamenti illegittimi.
Per ragioni storiche ed ambientali, l'adozione di provvedimenti espulsivi nel pubblico impiego avveniva di rado e per
via di oneri procedurali, ciò alimentava l'aspettativa di una sostanziale inamovibilità del pubblico dipendente.
Il D.lgs. n. 165/2001 estende l'applicabilità dello Statuto dei lavoratori al settore pubblico. Deve di conseguenza
ritenersi che anche in fase di estinzione il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici “privatizzati” è assimilato a quello
dei dipendenti privati (giusta casa e giustificato motivo oggettivo e soggettivo).
Un regime di maggior favore continua però a sussistere per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione
dei dirigenti), in ragione del fatto che, in ipotesi di licenziamento illegittimo, trova sempre applicazione la tutela reale a
prescindere dal numero dei lavoratori occupati.
9.Eccedenze di personale e mobilità collettiva. Il collocamento in disponibilità.
Il D.lgs n. 80/1998 e il D.lgs. n. 387/1998 hanno interamente rivisitato la disciplina delle eccedenze di personale e della
mobilità collettiva nelle pubbliche amministrazioni originariamente prevista dal D.lgs. n. 29/1993.
La disciplina delle eccedenze di personale nel pubblico impiego risulta articolata in più fasi:
-“fotografia” della consistenza del personale.
Presupposto dell'attivazione della procedura di mobilità è la rilevazione della consistenza del personale in rapporto al
fabbisogno di risorse umane secondo gli atti e le procedure previste dall'ordinamento di ogni amministrazione
interessata;
-rilevazione dell'eccedenza e confronto con le organizzazioni sindacali.
Ulteriore presupposto per l'applicazione della disciplina della mobilità collettiva è la “rilevazione dell'eccedenza” da
parte delle pubbliche amministrazioni interessate, le quali sono tenute ad informare preventivamente le rappresentanze
unitarie del personale e le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale, secondo le procedure previste dall'art.
33, D.lgs. n. 165/2001. L'informazione al sindacato deve avvenire attraverso una comunicazione scritta e contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza.
Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a richiesta delle OO.SS. si procede ad un esame diretto a
verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o
nell'ambito della stessa amministrazione, o presso altre amministrazioni nell'ambito della provincia o nel diverso ambito
determinato dai contratti collettivi nazionali.
In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua. La procedura si
conclude, in ogni caso, entro 60 giorni dalla comunicazione. Per i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in
disponibilità l'art. 33, 1° comma, D.lgs n. 165/2001 rinvia a quelli fissati in via suppletiva dall'art. 5, L. n. 223/1991.
-messa in disponibilità e ricollocazione del personale eccedente.
Rilevata l'eccedenza e conclusa la procedura, l'art 33, 7° comma, D.lgs n. 165/2001 prevede che venga comunicato il
“collocamento in disponibilità” al personale in esubero che non sia stato possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione o ricollocare presso altre amministrazioni. Il “collocamento in disponibilità”
costituisce dunque una misura di extrema ratio che comporta non la risoluzione ma la sospensione del rapporto di
lavoro, col pagamento di un'indennità a carico del datore (80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale) per
la durata massima di 24 mesi con uno schema simile a quello della Cassa integrazione.
-risoluzione del rapporto.
Se la ricollocazione non riesce, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla scadenza dei 24 mesi di
durata massima del trattamento. Si tratta di un'ipotesi di risoluzione automatica ex lege del rapporto di lavoro, la quale
non necessita di alcun atto di accertamento da parte della pubblica amministrazione circa l'esistenza dei presupposti di
legge che determina l'estinzione del rapporto di lavoro, risultando altresì l'amministrazione esonerata dal rendere il
preavviso previsto invece per il licenziamento. Peraltro il dipendente il cui rapporto di lavoro cessa al termine della
disponibilità avrà la possibilità di impugnare l'atto di collocamento in disponibilità risalente ai due anni che precedono
per eventuali vizi della gestione dell'eccedenza da parte della pubblica amministrazione, mentre l'atto di risoluzione al
termine del biennio potrà in ipotesi trovare impugnazione da parte del dipendente per illegittima pretermissione nella
ricollocazione su posti vacanti.
CAPITOLO TREDICI: LE GARANZIE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE
1.Tipologia e ratio. Inderogabilità e indisponibilità.
In considerazione della posizione di debolezza nella quale si trova il lavoratore subordinato, il legislatore ha approntato
una speciale disciplina protettiva. L’ordinamento interviene nei confronti dell’autonomia privata delle parti,
precludendo che la loro autonomia regolamentare o contrattuale possa contraddire la disciplina legislativa
inderogabilmente posta e impedendo che l’autonomia dispositiva del lavoratore si eserciti in modo auto-lesivo, cioè a
dire in una prospettiva di abdicazione o dismissione di diritti.
Per un verso infatti la legislazione impone un trattamento minimo inderogabile e conforma quindi l’assetto iniziale degli
interessi implicati nel rapporto di lavoro (operando così nella fase genetica del rapporto); per altro verso poi essa
impone limiti al potere del lavoratore di disporre successivamente alla costituzione del rapporto, di tali diritti.
In conformità alle cennate finalità protettive del lavoratore subordinato, la quasi totalità delle discipline legislative del
rapporto di lavoro è dunque inderogabile da parte dell’autonomia privata (individuale e collettiva) o almeno è
inderogabile in peius (sicché è derogabile solo in senso migliorativo per il lavoratore).
Ogni modifica convenzionale che alteri in peius il trattamento legislativo garantito al lavoratore è non soltanto
radicalmente nulla ex art. 1418, ma è per lo più sostituita di diritto dalla disciplina legale.
Neanche con l’espresso consenso del lavoratore potrebbe insomma essere convenuto un trattamento deteriore rispetto a
quello legale in tema, ad esempio, di orario di lavoro, ferie, esercizio del potere disciplinare, poiché in qualunque
momento lo stesso lavoratore potrebbe richiedere il ripristino del regolamento legale.
L’apposizione di tali vincoli rigorosi alla determinazione iniziale del regolamento del rapporto non può che riverberarsi
(pena la loro sostanziale inutilità) sull’intero svolgimento del rapporto, incidendo così anche su eventuali negozi di
dismissione posti in essere successivamente dal lavoratore.
Viene pertanto preclusa non soltanto qualsivoglia difforme regolamentazione iniziale del rapporto, ma anche ogni sua
successiva modificazione realizzata tramite negozi dispositivi.
Da qui l’indisponibilità dei diritti derivanti da norma inderogabile, confermata dall’esistenza di una disciplina specifica
che prevede la invalidità delle rinunce e transazioni del lavoratore aventi ad oggetto tali diritti.
La rinunzia è un atto unilaterale tendente alla dismissione di un diritto soggettivo da parte del titolare, mentre la
transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni (entrambe rinunciano ad un proprio
diritto), pongono fine ad una lite esistente o prevengono una lite eventuale.
2. La disciplina delle rinunzie e delle transazioni.
L’art. 2113 si occupa espressamente delle rinunce e transazioni del lavoratore che incidano su diritti derivanti da norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo, comminando per esse la sanzione dell’invalidità. Tale invalidità consiste
tuttavia in una annullabilità, dal momento che essa può essere fatta valere solo dal lavoratore e solo entro un termine di
decadenza (6 mesi dalla cessazione del rapporto o dal negozio se successivo).
L’art. 2113 dunque, disponendo l’annullabilità (e non la nullità) dei negozi dismissori ivi indicati, delinea una
alterazione del modello generale prefigurato dall’art. 1418. questa attenuazione si giustifica con il richiamo all’esigenza
di certezza dei rapporti giuridici e alla necessita di non lasciare il datore troppo a lungo esposto a ripensamenti e
rivendicazioni del lavoratore.
La disciplina dell’art. 2113 concerne comunque solo i diritti già maturati, cioè già entrati nel patrimonio del lavoratore
(es. retribuzioni pregresse), mentre una rinuncia preventiva del lavoratore a diritti futuri (compensi o ferie dei mesi a
venire) è da ritenersi radicalmente nulla, ai sensi dell’art. 1418.
Trattandosi di annullabilità, l’invalidità di rinunce e transazioni può essere fatta valere solo entro un breve termine di
decadenza (6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della rinunzia o della transazione se successive
all’estinzione del rapporto). Inoltre all’impugnazione del negozio è legittimato solo il lavoratore. Sicché se questi
omette di impugnare tempestivamente la rinunzia o la transazione, tale omissione provoca l’effetto di sanare il negozio.
L’impugnazione può essere effettuata con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, da cui emerga la volontà del
lavoratore di invalidare l’atto di disposizione. Se invece, nel termine prescritto, viene instaurato il giudizio, è sufficiente
che il lavoratore chieda il riconoscimento dei diritti rinunziati o transatti.
Successivi interventi legislativi hanno esteso l’ambito applicativo dell’art. 2113; sia sotto il profilo soggettivo
(estendendone l’applicazione anche ai lavoratori parasubordinati), sia sotto il profilo oggettivo, estendendone
l’applicazione anche ai negozi dismissori aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili di contratti
collettivi (confermando così, seppur indirettamente, l’efficacia normativa dei contratti collettivi).
Una questione a se stante è costituita dalle c.d. quietanze a saldo, ossia da quelle dichiarazioni, spesso sottoscritte dal
lavoratore alla cessazione del rapporto, nelle quali il dipendente afferma di avere ricevuto il pagamento di ogni
spettanza e, dunque, di non avere più nulla a pretendere. Ebbene tali dichiarazioni non hanno in linea di principio alcun
valore negoziale o dismissorio, bensì un contenuto meramente ricognitivo, al quale è estranea ogni volontà abdicativa.
Pertanto le quietanze a saldo esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 2113.
Con esse il lavoratore esprime la propria convinzione di non avere nulla altro a pretendere, ma non la volontà di
rinunziare a diritti spettanti. Pertanto, se successivamente tale convinzione dovesse rivelarsi erronea, egli ben potrà
rivendicare i propri diritti, anche oltre il termine di 6 mesi (poiché, essendo tale dichiarazione priva di ogni efficacia
negoziale, il lavoratore potrà promuovere, nell’ordinario termine di prescrizione, senza ossia il vincolo del termine di
decadenza previsto dall’art. 2113, l’azione per i crediti derivanti dal rapporto di lavoro).
La situazione naturalmente cambia laddove nella formulazione della quietanza si rinvengano dichiarazioni abdicative o
transattive (“rinunzio” o “transigo”); infatti nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un intento abdicativi o
transattivo, anche la quietanza rientrerà nell’ambito di applicazione dell’art. 2113.
Sono infine sottratte all’ambito di applicazione dell’art. 2113 le rinunzie e le transazioni occorse nell’ambito di
conciliazioni intervenute in sede giudiziaria, oppure avvenute davanti alle Commissioni costituite presso l’Ufficio
provinciale del lavoro, oppure stipulate in sede sindacale. Tali conciliazioni sono dunque valide e inoppugnabili. La
ragione di tale deroga va ricercata nella presunzione che, attraverso il filtro rappresentato dall’intervento del giudice,
delle commissioni di conciliazione o del sindacato, la rinunzia o la transazione vengano epurate dalle conseguenze
negative riconducibili allo stato di soggezione del lavoratore.
3.La prescrizione dei diritti del lavoratore.
Tutele particolari dei crediti del lavoratore si rinvengono anche in relazione a vicende di carattere non negoziale però
suscettibili di provocare l’estinzione dei diritti: la prescrizione e la decadenza. Con riguardo alla prescrizione occorre
ricordare che i crediti retributivi di carattere periodico (retribuzione mensile, quindicinale, settimanale, mensilità
aggiuntive, premi di rendimento) sono assoggettati alla prescrizione estintiva quinquennale prevista dall’art. 2948. Ed
anche la prescrizione per le indennità connesse alla cessazione del rapporto è di 5 anni.
La prescrizione estintiva ordinaria decennale assume nel diritto del lavoro una rilevanza del tutto residuale, trovando
applicazione solo nei confronti di alcuni diritti del prestatore (come il diritto alla qualifica).
I crediti retributivi del lavoratore sono inoltre sottoposti ad una concorrente prescrizione, denominata prescrizione
presuntiva in ragione del fatto che essi, salvo prova contraria, si presumono pagati ove sia trascorso un certo lasso di
tempo dall’epoca in cui sono sorti. Tale prescrizione è annuale per il diritto del lavoratore alle retribuzioni mensili,
mentre è triennale per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori ad un mese.
Nel caso decorra tale termine prescrizionale non si verifica l’estinzione del credito ma si riscontra solamente una
presunzione legale del suo soddisfacimento, presunzione che può essere vinta attraverso la confessione giudiziale del
datore o tramite il giuramento decisorio.
Il codice civile non contiene indicazioni specifiche riguardo alla decorrenza della prescrizione estintiva (quinquennale)
dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, sicché, prima dell’intervento della Corte Costituzionale, si
faceva riferimento alla regola generale secondo la quale la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere (il che equivaleva a sancire la decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto di lavoro). Ciò
finché la sentenza n. 63 del 10 giugno del 1966 della Corte Costituzionale non dichiarò l’illegittimità di tale regola
generale (risultante dall’art. 2948 in tema di prescrizione) limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione
del diritto alla retribuzione inizi a decorrere durante la pendenza del rapporto, stabilendo così che tale decorrenza
dovesse avere inizio a partire dalla cessazione del rapporto (allorquando il lavoratore è libero da quello stato di
soggezione psicologica presente durante il rapporto di lavoro, che può indurlo ad evitare di rivendicare diritti non
soddisfatti).
Successivamente poi la Corte è più volte ritornata sul tema temperando la declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 2948
e limitando l’operatività della regola della decorrenza differita della prescrizione, sotto un duplice profilo:
-da un lato ha limitato il differimento del decorso della prescrizione alla cessazione del rapporto solo ai diritti del
lavoratore aventi natura retributiva.
-dall’altro lato ha circoscritto l’applicazione della regola del decorso della prescrizione a partire dalla cessazione del
rapporto a quei rapporto che siano privi del requisito della stabilità del posto di lavoro (sicché per i rapporti di lavoro
“stabili” i crediti di lavoro si estinguono anche durante il rapporto di lavoro).
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto un'importante sentenza della Cassazione ha affermato che l'applicazione della
L. 20 maggio 1970, n. 300 (art. 18) esclude quel timore del licenziamento capace di indurre il lavoratore a non
esercitare i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro, cosicché in questo caso, non potendosi ipotizzare una
coazione psicologica a rinunziare implicitamente al diritto retributivo, non si delinea alcuna violazione del principio
costituzionale di irrinunziabilità e riprende vigore la regola generale in base alla quale la prescrizione inizia a decorrere
dal momento in cui il diritto è sorto e quindi anche durante il rapporto di lavoro.
Per i rapporti di lavoro stabili, dunque, i crediti di lavoro, si prescrivono anche durante il rapporto di lavoro e gli art.
2948 e 2955 e 2956 tornano ad operare nella loro formulazione originaria antecedente la sent. n. 63/1966 della Corte
Costituzionale. Occorre infine ricordare che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art 2, 1° comma del
R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, che prevedeva la prescrizione biennale del diritto agli stipendi ed assegni agli impiegati
dello Stato, crediti questi che- a seguito della declaratoria d'incostituzionalità sopra citata- si prescrivono nel termine
quinquennale di cui all'art 2948, n.4 c.c.
4.La decadenza.
Oltre che per prescrizione, i diritti del lavoratore possono estinguersi per decadenza. Ma mentre la prescrizione
costituisce una regola generale alla quale è assoggettato ogni diritto (ad eccezione di quelli imprescrittibili o
indisponibili), la decadenza trova applicazione soltanto per tassativa previsione della legge o dell’autonomia negoziale.
La decadenza legale (ossia la predeterminazione legislativa di un termine entro il quale deve essere perentoriamente
esercitato un diritto) trova una limitata diffusione nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Le due ipotesi più
rilevanti sono quelle della impugnazione del licenziamento e dell’impugnazione delle rinunzie e transazioni (peraltro
entrambe queste ipotesi presentano la peculiarità che la decorrenza del termine di decadenza inizia quando il rapporto di
lavoro è ormai cessato).
Decisamente più ricorrenti sono le ipotesi di decadenza convenzionale contenute nei contratti collettivi nazionali ed
aziendali, la cui legittimità va valutata alla stregua del disposto dell’art. 2965, che sancisce la nullità del patto col quale
si stabiliscono termini di decadenza tali da rendere eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto. La
giurisprudenza tende ad ancorare la congruità del termine di decadenza all’art. 2113; onde per cui sono considerati
illegittimi i termini di decadenza inferiori a quello previsto dall’art. 2113 (6 mesi).
È appena il caso di ricordare la differenza tra prescrizione e decadenza. La prescrizione è una modalità di estinzione di
un diritto causata dal trascorrere del tempo e dall’inerzia del titolare. La decadenza invece nella perdita della possibilità
di esercitare un diritto causata dal mancato compimento di un certo atto o attività entro un termine. Nella decadenza (a
differenza di quanto accade nella prescrizione) non si ha riguardo alla condizione soggettiva del soggetto, ma solo al
fatto obiettivo del decorrere del tempo (e alla circostanza che il soggetto compia o meno una determinata attività entro il
termine previsto ), ed infatti nella decadenza non sono previsti gli istituti dell’interruzione e della sospensione.
5.Altre garanzie del credito retributivo:a) i privilegi; b) impignorabilità, insequestrabilità, incedibilità.
a)I privilegi.
Accanto al peculiare sistema protettivo qui descritto che delinea un'articolata serie di garanzie afferenti l'effettiva
soddisfazione dei crediti, soprattutto retributivi, del lavoratore dipendente. Una disciplina particolare è prevista per i
privilegi. Il privilegio è una causa legittima di prelazione accordata dalla legge in considerazione della natura del
credito: il titolare di questo potrà essere soddisfatto con precedenza rispetto ad altri crediti (c.d. Chirografi). Il diritto del
lavoro registra privilegi speciali (che si esercitano cioè su alcuni beni determinati in ragione della connessione esistente
tra il credito e tali beni). Più rilevanti e incisivi sono i privilegi generali, che si esercitano su tutti i beni mobili del
debitore, nel senso di una soddisfazione prioritaria sul ricavato della vendita di tali beni in sede di esecuzione forzata.
Secondo l'art. 2751 bis un privilegio generale assiste la retribuzione, le indennità dovute a causa della cessazione del
rapporto, il risarcimento del danno per omissione contributiva e per licenziamento illegittimo. La l. n. 297/1982 ha
modificato la graduatoria dei crediti relativi al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso rispetto a tutti gli altri crediti
privilegiati e posponendoli soltanto rispetto ai crediti ipotecari.
b)Impignorabilità, insequestrabilità, incedibilità.
La protezione del credito retributivo si estende anche nei confronti dei terzi (creditori del lavoratore) che potrebbero
aggredire il patrimonio del prestatore al fine di veder soddisfatto il proprio interesse. L'esigenza di evitare che il credito
retributivo possa concorrere a costituire la garanzia patrimoniale generale (art. 2740 c.c.) nasce dalla funzione che la
Costituzione stessa (art. 36) assegna alla retribuzione, quale mezzo di sostentamento del prestatore e della sua famiglia.
In questa prospettiva l'art. 545 c.c, prevede che le somme dovute a titolo di stipendio e le altre indennità possano essere
pignorate solo nella misura stabilita dal giudice se il pignoramento concerne crediti alimentari, mentre non potrà essere
superata la misura di 1/5 se si procede per crediti di natura diversa.
Per il sequestro e la compensazione sono ammessi gli stessi limite consentiti per il pignoramento.
Una più accentuata tutela del credito retributivo era contemplata nel D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 per i dipendenti
pubblici, a favore dei quali veniva sancita la piena incedibilità, insequestrabilità, impignorabilità degli stipendi, assegni,
pensioni ed indennità. Uniche eccezioni al principio erano il sequestro ed il pignoramento, fino alla concorrenza di 1/3,
per cause di alimenti e, fino alla concorrenza di 1/5, per debiti tributari del lavoratore nonché per debiti derivanti dal
rapporto di impiego, con una differenza di status tra impiegati pubblici e privati.
Dunque la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione che non prevede la pignorabilità e la
sequestrabilità, fino alla concorrenza di 1/5 per ogni credito vantato nei confronti del personale, degli stipendi e
retribuzioni corrisposti dallo Stato o da altri enti diversi dallo Stato nonché dalle aziende e dalla imprese indicate
dall'art. 1 del medesimo D.P.R.
6.La tutela giurisdizionale dei diritti del lavoratore privato e pubblico.
La garanzia sostanziale dei diritti del lavoratore viene integrata e sorretta dalla previsione di speciali forme processuali
che mirano ad ottenere una più immediata ed efficace tutela. La disciplina processuale risulta speciale rispetto a quella
del processo civile ordinario, perché occorre tener conto: a)della particolarità degli interessi anche collettivi in gioco e
dei relativi conflitti; b)della particolare deteriorabilità dei diritti del lavoratore subordinato, la cui tutela se condizionata
agli ordinari tempi del processo civile sarebbe per ciò stesso definitivamente pregiudicata; c)della necessità di
neutralizzare sul piano processuale la peculiare situazione di debolezza “relativa” del prestatore di lavoro, mediante una
tutela “differenziata” in grado di ripristinare anche sulla ribalta processuale l'uguaglianza sostanziale.
La svolta riformatrice fu realizzata con la vigente L. 11 agosto 1973, n. 533, la quale ha dilatato il tradizionale campo di
applicazione del processo del lavoro ai rapporti di impiego con enti pubblici economici e con enti pubblici se non
devoluti dalla legge ad altro giudice, ed ora, dopo la privatizzazione, ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, salvo
eccezioni (rapporti di mezzadria, agrari, di agenzia, di rappresentanza commerciale).
L'originaria competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro è stata trasferita al tribunale in composizione
monocratica ad opera del D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. L'appello avverso le sentenze del tribunale è proposto innanzi
alla Corte d'appello le cui sentenze possono essere impugnate in Cassazione nei limiti dei principi generali.
La domanda giudiziale del lavoratore va proposta con ricorso completo e analitico, così come la memoria di
costituzione in giudizio del datore di lavoro, onde favorire una rapida fissazione dei termini della controversia ed un suo
rapido svolgimento. Vanno indicati i mezzi di prova ed i documenti che si offrono in comunicazione e che vanno
depositati in cancelleria.
Il sistema di preclusioni e di decadenze istituite dagli artt. 414 e 416 c.p.c., nel perseguire il fondamentale obbiettivo
della celerità, esclude, a grandi linee, la possibilità di integrazione (oltre che di modifica) delle difese e tende ad imporre
un'effettiva lealtà processuale, evitando manovre dilatorie e riserve mentali o strategiche. Alla prima udienza si procede
all'interrogatorio libero delle parti. In conformità al principio dell'immediatezza nella stessa udienza, dovrebbero essere
ammessi ed assunti i mezzi di prova. Ma tale principio viene quasi sempre disatteso, provvedendo il giudice a fissare
altra o più udienze per l'istruttoria. Espletata quest'ultima, il giudice, su richiesta delle parti, può concedere un termine
non superiore ai 10 giorni per il deposito di note difensive, fissando udienza di discussione.
Sempre allo scopo di rafforzare la tutela giurisdizionale dei diritti del lavoratore, sono stati ampliati i poteri istruttori del
giudice. In particolare è prevista la possibilità di disporre d'ufficio ed in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo
di prova; il potere di interrogare liberamente sui fatti della causa quelle persone che siano incapaci di testimoniare a
norma dell'art 246 c.p.c, o alle quali sia vietato deporre a norma dell'art 247 c.p.c.; la possibilità di disporre l'accesso sui
luoghi di lavoro e di richiedere informazioni ed osservazioni alle associazioni sindacati indicate dalle parti.
Nell'udienza di discussione il giudice pronuncia la sentenza. La sentenza che condanna al pagamento di somme per
crediti di lavoro deve condannare altresì il datore a pagare gli interessi legali e a risarcire il maggiore danno subito dal
lavoratore per la diminuzione di valore dei suoi crediti, causata dal ritardo nel pagamento.
La sentenza del Tribunale che pronunzia condanna in favore del lavoratore per crediti di lavoro è esecutiva senza
necessità di apposita domanda. L'esecutorietà ha carattere automatico. Il giudice quindi non può rifiutarla neppure per i
particolari motivi che ne avrebbero giustificato il diniego nei giudizi civili ordinari. La L. n. 353/1990 ha garantito la
provvisoria esecutività della sentenza anche in favore del datore.
Il sistema di tutela giurisdizionale dei diritti dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici è rimasto per lungo tempo
permeato dai principi tradizionali del diritto amministrativo e solo negli ultimi anni si è avviato una sostanziale
equiparazione con il sistema di tutela processuale dei lavoratori privati. L'effettiva equiparazione si è realizzata con la
privatizzazione del rapporto di pubblico impiego operata dal D.lgs. n. 29/1993. Ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n.
165/2001, sono ora devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro
non privatizzati e di quelle in materie di procedure concorsuali. Il passaggio di giurisdizione è stato definitivamente
realizzato nel 1998 (con il D.lgs. n. 80), che ha sancito la soggezione alla giurisdizione ordinaria delle controversie
attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998; mentre quelle sorte nel periodo precedente restano alla giurisdizione
amministrativa.
7.La conciliazione e l'arbitrato.
L'esigenza di riduzione del contenzioso giudiziario ha condotto il legislatore a valorizzare gli strumenti della
conciliazione e dell'arbitrato.
La conciliazione può essere sia giudiziale che stragiudiziale: nel primo caso essa avviene nel corso del processo su
iniziativa del giudice, il quale è tenuto a tentarla fin dall'inizio del giudizio. Qualora venga raggiunta, il relativo verbale
ha efficacia di titolo esecutivo. Nel secondo caso, essa avviene o in sede amministrativa, di fronte ad apposite
commissioni costituite presso le Direzioni provinciali del lavoro, o in sede sindacali, secondo le procedure e davanti agli
organismi previsti dai contratti collettivi. Il D.lgs. n. 80 del 1998 ha reso obbligatorio il tentativo di conciliazione nei
confronti di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro, configurandolo quale condizione di procedibilità della
domanda.
L'arbitrato è un istituto che prevede il deferimento ad un terzo del potere di decidere come comporre una controversia. Il
terzo non è un giudice. L'arbitrato può essere rituale (art 808), cioè idoneo a conseguire effetti equivalenti alla
giurisdizione, o irrituale (D.lgs n. 80/1998), in quanto richiesto all'arbitro sotto forma di un semplice accertamento di
natura convenzionale, e quindi idoneo a conseguire effetti puramente negoziali.
L'arbitrato rituale si svolge secondo regole processuali prefissate, e conduce all'emanazione di un atto (lodo)che
acquista valore di sentenza mediante un decreto di omologazione del giudice. Per le controversie di lavoro, la legge
stabilisce che possono essere decise da arbitri a)solo se ciò sia consentito da contratti e accordi collettivi; b)purché
l'arbitrato sia facoltativo, ovvero sia sempre garantita la facoltà per le parti di adire il giudice; c)a condizione che il
giudizio avvenga secondo diritto (non secondo equità).
Se si aggiunge che il lodo può essere impugnato, oltre che per violazione di regole di diritto, anche per violazione o
falsa applicazione di contratti collettivi, diventa inevitabile la conclusione che l'atteggiamento legislativo nei confronti
dell'arbitrato, è a dir poco, di cautela.
L'arbitrato irrituale si presenta invece regolato su base legale solo di recente. La disciplina è innovativa sotto un duplice
profilo. Da un lato, si configura come il tramite per una sorta di ritualizzazione dell'arbitrato irrituale, nel senso che
predispone le modalità con cui i contratti collettivi dovranno regolamentare le procedure arbitrali. Dall'altro lato, tale
disciplina abroga il 2°e 3° comma dell'art 5, L. n. 533 del 1973 e li sostituisce con la previsione di cui all'art. 412Ter ,
secondo cui “sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in un unico grado il Tribunale, in
funzione di giudice del lavoro. Ciò ha il significato di limitare la possibilità di impugnazione del lodo irrituale alle sole
ragioni previste dalle parti. Con ciò il lodo potrebbe finalmente acquistare una certa stabilità. Per l'arbitrato irrituale
continuano inoltre a valere le limitazioni già viste per l'arbitrato rituale.