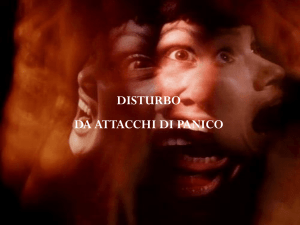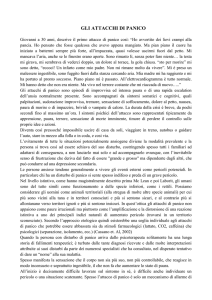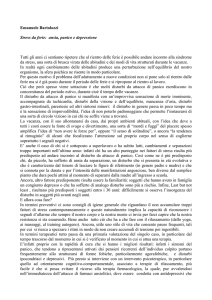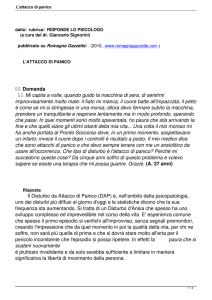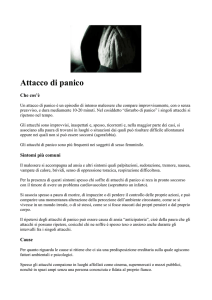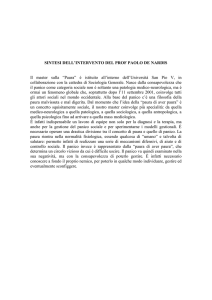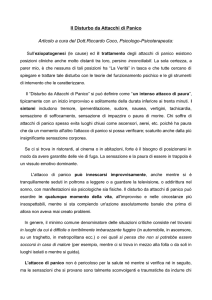MENTALIZZAZIONE E DISTURBO DA ATTACCO DI PANICO
RIASSUNTO
Attraverso la comparazione di due casi clinici, quello di una ragazza
affetta da un DAP nel contesto di un’agorafobia cronica con abituale
ricorso alla somatizzazione e quello di una donna di mezza età con un
attacco di panico conseguente a un evento terrorizzante nel contesto di
una personalità più matura malgrado tratti ansiosi e agorafobici, viene
discusso il ruolo del difetto di mentalizzazione nel DAP e
l’insediamento di un abbozzo di mentalizzazione come svolta di una
psicoterapia.
INTRODUZIONE
La mentalizzazione è prima di tutto un costrutto sociale in quanto è per suo tramite
che siamo consapevoli e quindi poi reagiamo agli stati mentali propri e altrui. Per
questo essa è centrale nella comprensione e nel trattamento di molti disturbi, come
i disturbi alimentari (Skarderud 2007) e i disturbi dell’umore (Allen et al. 2003), il
disturbo post traumatico da stress (Allen 2001), la patologia psicosomatica
(Fasullo 2009) anche se è da dieci anni il cavallo di battaglia del trattamento del
disturbo borderline (Bateman e Fonagy 2004 e 2010).
Il concetto nacque nel 1938 (Stern) e attraversò l’Infant Observation e poi l’Infant
Research, collegando il processo di mentalizzazione anche ai tipi di attaccamento
(Bowlby); in Francia ne parlarono l’Ecole Psychosomatique de Paris (Marty 1980)
e poi Sami-Ali (1987) e Mc Dougall (1989), ma è solo a partire da Fonagy (1989,
1991) che esso si sviluppò, sia dal punto di vista concettuale, che operativo,
profittando anche dello sviluppo di altri concetti come la funzione riflessiva
(Rudden et al. 2008) .
Non si pensi quindi che un deficit nella mentalizzazione inevitabilmente legato ad
un trauma specifico e grave, ma anche solo allo sviluppo di uno stile di
attaccamento non sicuro evidenziabile con le scale della Ainsworth (1982) e della
Main (1991) e quindi con una incerta capacità di riflessione, anch’essa misurabile
(Rudden et al., citati).
A questo punto io però mi allontano dai concetti generali di mentalizzazione e di
funzione riflessiva, ma li considero come uno strumento prezioso per le persone
che soffrono di attacchi di panico. Non è la mia una novità assoluta per l’Italia
perchè lo ha già brevemente richiamato Fasullo in un breve articolo recentemente
pubblicato in generale nei disturbi psicosomatici, come l’attacco di panico è (Berti
Ceroni 2010). Ho presente per la comprensione e il trattamento del panico una
serie di articoli che facevano il punto delle osservazioni di un gruppo di psichiatri
(Klerman, Shear) e psicoanalisti (Cooper e Shapiro) pilotati da Busch, che si sono
susseguiti a partire dall’inizio del decennio scorso (Busch 1991) fino al grande
volume collettaneo sulla mentalizzazione (Busch 2008) e ne ho personalmente
sentito e discusso con Mary Target un anno fa.
I pazienti che soffrono di un disturbo da attacchi di panico sono persone che, in
generale, hanno una grave carenza nella mentalizzazione: per un periodo mediolungo con questi pazienti non si può che parlare di sintomi, mancando essi appunto
della necessaria capacità introspettiva perché si possa far altro in terapia.
D’altronde non è un caso che il disturbo da attacchi di panico sia uno dei disturbi
psicosomatici per eccellenza: ricordiamoci che è nato all’Ecole Psychosomatique e
che ha le stimmate che Berti Ceroni (2010) enuncia per quando un disturbo
psichico può essere appropriatamente chiamato psicosomatico, e cioè l’instaurarsi
di fenomeni somatici in sequenza fino a uno stop attribuibile ai meccanismi di
arresto per feedback somatico. Anche al di fuori dell’attacco/degli attacchi di
panico chi ne soffre è decisamente carente nella mentalizzazione e sta al terapeuta
riuscire ad indurlo ad essere consapevole dei propri sentimenti e pensieri. Per
questo nella lingua anglosassone si preferisce usare il gerundio (mentalizing): la
mentalizzazione è un’azione. Nella seconda fase della terapia (Monari 2000, 2007)
il terapeuta aiuta il paziente a gestire i sentimenti e i pensieri che esso ha, derivanti
o da tempi lontani o dal hic et nunc.
Voglio spendere altre parole sul concetto di mentalizzazione e di funzione
riflessiva nei pazienti sofferenti di disturbo da attacco di panico e su come poi essi
si declinano nella strategia terapeutica.
ELEMENTI DI STORIA DEL DISTURBO DA ATTACCHI DI PANICO
Il panico è l’ultimo “uomo nero” della sofferenza psichica (psicofisica) dell’uomo,
che è venuto dopo l’anoressia, la depressione, le varie tossicomanie. Certo, chi per
qualche manciata o decina di minuti sente che sta per morire – o diventar matto –
mentre tutti i parametri biologici (frequenza cardiaca, pressione arteriosa, respiro)
impazziscono, ha ben chiaro che di cosa grave si tratta: l’attività in corso viene
interrotta, si corre all’ospedale. L’abbandono improvviso della scena da parte di un
famoso comico e la guizzante fuoriuscita dalla vasca di una nuotatrice quest’anno
sono esempi di questa impellenza.
Non si tratta di fenomeno che sia divenuto noto da poco tempo: il concetto, non il
nome, di panico nacque all’interno della psicoanalisi, un “preciso complesso di
sintomi” che Freud chiamò “nevrosi d’angoscia” per distinguerlo dalla neurastenia
(Freud 1894, p.147). Come già in alcune minute, la J e la K in primis, Freud
sostanzialmente ipotizza che la neurastenia sia un eccitamento psichico imputabile
a una scarica libidica inadeguata e impropria, e la nevrosi d’angoscia, invece, una
tensione fisica, che ora diremmo da stress. Freud, da fine clinico quale era, alla
descrizione della complessa sintomatologia psichica e fisica dell’attacco vero e
proprio – dispnea, palpitazione, angoscia relativa al corpo (ipocondria,
claustrofobia, agorafobia, vertigine delle altezze), rimuginio ossessivo – aggregò
“l’attesa angosciosa” che lo anticipa e l’agorafobia che lo segue, e identificò quindi
l’intero complesso sintomatologico ora chiamato Disturbo da Attacchi di Panico.
La teoria era che l’attacco di panico fosse attribuibile a un trauma pulsionale, cioè
all’“ingorgo” libidico.
Da allora varie sono stare le ipotesi riguardo all’eziologia del disturbo da attacco di
panico, quella che a me pare più coerente è quella di matrice relazionale: secondo
la teoria delle relazioni oggettuali il soggetto non sarebbe stato in grado di
introiettare in modo sufficiente il caregiver: ecco allora che il terapeuta deve fare
da contenitore metabolizzando emozioni e pensieri (da Winnicott, a Bion, a
Gaddini) finchè non è il paziente stesso che riesce a farlo. D’altronde se ben
riflettiamo su questa possibile eziologia essa è la stessa che Fonagy e coll. e
un’infinità di altri studiosi la invocano come causa non solo del disturbo da attacco
di panico, ma anche del disturbo border, di cui appunto Fonagy si è occupato
promuovendo la mentalizzazione.
D’altronde secondo la Scuola Francese il disturbo psicosomatico è dovuto ad un
precoce disturbo con il caregiver tale che il futuro paziente non riesce a introiettare
l’oggetto. McDougall (1989) usa la metafora del corps à deux per indicare la
matrice di base (un solo corpo per due persone, madre e figlio) da cui il neonato si
differenzia per individuazione, de somatizzando le funzioni mentali. Il fallimento
maturativo provoca la désaffection: emozioni precoci intense che minacciano
l’identità psicofisica costringono a erigere una barriera difensiva potentissima per
preservare la sopravvivenza psichica e rendere il campo affettivo inaccessibile alla
consapevolezza. Ciò determina l’inabilità nel paziente psicosomatico adulto a
riconoscersi nel proprio corpo e nei propri affetti. E’ l’astrazione che rende
concepibile il dolore mentale. Il sintomo psicosomatico risulta un parziale
fallimento di questo processo. In esso il corpo parla al posto della mente che non si
è formata: la tendenza alla somatizzazione è dunque un’operazione auto protettiva
dalla insopportabile tensione di ogni mutamento, avvertito come minaccioso per la
sopravvivenza del Sé.
Cosa diversa è il costrutto di alessitimia, che si basa fondamentalmente su un
deficit di elaborazione cognitiva delle emozioni, dovuto al fatto che il soggetto
psicosomatico si caratterizza per non aver appreso ad esprimere verbalmente le sue
emozioni a causa di un grave disturbo evolutivo nelle relazioni oggettuali; ciò ha
permesso di abbandonare il vecchio modello delle malattie psicosomatiche centrate
sul conflitto.
L’ipotesi stessa di Bowlby e dell’Infant Research, a ben vedere, non è che un
difetto nell’attaccamento dovuto a una carenza dell’introiezione degli oggetti
esterni.
L’agorafobia stessa, sempre così legata all’attacco di panico, o prima o dopo di
esso (Berti Ceroni e Grava in preparazione), ci parla di contenitori: se essa avviene
dopo l’attacco è spiegabile come una condotta di evitamento, se avviene prima
come la paura di “disperdersi” nel vuoto non avendo potuto creare una pelle (Bick)
che contenesse il soggetto. Stessa eziologia, a parer mio, per la claustrofobia: la
mancata introiezione fa si che in luoghi chiusi ci si senta “schiacciati” sempre per
la mancanza di un introietto. Tutto ciò fa sì che chi soffre di attacchi di panico
(oltre a chi soffre di disturbo borderline di personalità soprattutto) ha un continuo
bisogno di avere l’altro concretamente presente e ha bisogno di una continua
rassicurazione che questo non stia per lasciarlo (per esempio la paura e le
conseguenti rassicurazioni sul chiedere se l’altro è arrabbiato con noi).
ELEMENTI GENERALI DI TECNICA TERAPEUTICA
Anche al di fuori dell’attacco, dell’ictus emotivo (Klein 1964) e somatico, il
linguaggio sarà solo quello del corpo e sarà solo con un’attività continua e a volte
pedante che il terapeuta può cercare di portare il paziente nei sentimenti e nei
pensieri su di essi, non essendone egli da solo capace; fenomeni uguali a quelli
della fase dell’esplorazione che Fonagy e Bateman usano con i pazienti borderline.
Da un punto di vista tecnico mi sono riconosciuta nella suddivisione in due tempi
della terapia illustrata da Monari (2000 e 2007): il primo appunto quando il
paziente è decisamente carente nella mentalizzazione e sta al terapeuta riuscire ad
indurlo ad essere consapevole dei propri sentimenti e pensieri. Ricordo che è per
questo che nella lingua anglosassone si preferisce usare il gerundio (mentalizing):
la mentalizzazione è un’azione. Nel secondo tempo il terapeuta aiuta il paziente a
gestire i sentimenti e i pensieri che esso ha, derivanti o da tempi lontani, o nell’hic
et nunc.
E’ questa suddivisione in disaccordo rispetto al disegno di terapia di Fonagy con il
risultato che io, e verosimilmente non solo io, pur non essendo al corrente di altri,
non metto necessariamente l’accento sul flusso di sentimenti che viaggiano fra
terapeuta e paziente, dando così un ruolo preminente al transfert e al
controtransfert. Ricordiamoci però che Fonagy parla e tratta di pazienti con un
disturbo borderline.
DUE ESEMPI CLINICI
Racconto la storia e l’evoluzione della terapia nella giovane Miriam e di fare
invece notare caratteristiche di pensiero e di terapia di una paziente più avanti
negli anni che ha avuto un attacco di panico in occasione di uno stato di paura
che poteva indurre in chiunque uno stato fortemente ansioso. Tale stato
ansioso poteva a buon diritto indurre un attacco di panico, il che mi ha indotto
a riflettere sulla possibilità che esista non solo un disturbo da attacco di
Panico, ma anche un attacco di panico “reattivo”; in seconda istanza infatti
Daniela non presenta problemi di mentalizzazione.
Miriam ha iniziato ad avere attacchi di panico nel Maggio di tre anni fa. Viene
inviata al Servizio dal medico di base per importanti manifestazioni ansiose. Il
medico psichiatra del Centro, mio tutor, identifica un Disturbo da Attacchi di
Panico (DAP) e prescrive farmaci, nello specifico un antidepressivo e un
ansiolitico, e l’indirizza a me, come psicologa in tirocinio presso quel Centro,
per colloqui psicologici di approfondimento della sintomatologia e della rete
di relazioni.
Propongo a Miriam di vederla una volta alla settimana, per 50’, “contratto”
che accetterà e che rispetterà fedelmente.
Ammetto di aver incontrato nella stesura di questa caso più di una difficoltà a
dare unità e omogeneità al suo tessuto narrativo, depurandolo delle tante
iterazioni e ridondanze in cui l’esposizione ha rischiato a più riprese di
ingolfarsi. Due sono stati infatti gli ordini di cause che le hanno generate.
La prima difficoltà va ricercata nella insufficiente mentalizzazione da cui la
paziente era affetta: infatti essa non riusciva a distinguere sia i propri
sentimenti che quelli altrui e a pensare i propri pensieri. Poiché una
correlazione di senso tra difetto di mentalizzazione e Disturbo da Attacchi di
Panico non mi era allora ben nota, gran parte del tempo in seduta era dedicato
al recupero di quello che era emerso la volta precedente per poter poi passare
oltre. Ciò rendeva problematica l’organizzazione del materiale in qualche cosa
di omogeneo. Perciò la prima fase della stesura di questo caso ha assunto la
forma di una serie di colloqui clinici, così come li avevo trascritti di settimana
in settimana. A partire da questa frammentarietà di base ho dovuto poi
rielaborare, non senza difficoltà, suddetto materiale per riuscire a costruire
una “storia” della paziente e del processo terapeutico.
Un’altra difficoltà è nata dalla molteplicità dei nuclei problematici (controllo,
stile di attaccamento, somatizzazione) emersi via via nel tempo. E’ stato
necessario un lungo e lento lavoro terapeutico per cominciare a sciogliere
questi nodi, ottenere una prima remissione dei sintomi e avviare la paziente
alla costruzione di un sé meglio strutturato. Perciò lente e fragili, e spesso
soggette a regressioni e stalli, sono state le conquiste con cui giorno dopo
giorno è stata erosa l’area dei nuclei sopraddetti.
Alcuni episodi che Miriam riporta nei primi incontri mettono subito a fuoco
con sufficiente chiarezza la fragilità dei confini del sé e i nuclei problematici
sottostanti all’esplosione degli attacchi di panico. Appena ha “una piccola
crisi”, che può preannunciare un attacco, Miriam convoca telefonicamente,
nell’ordine che segue, prima la madre, poi il padre e infine il fidanzato per
essere rassicurata; quando deve andare dal medico si fa accompagnare dalla
madre, così come capita che si faccia accompagnare al Centro di Salute
Mentale da un familiare; al fratello con il quale ha un rapporto possessivo,
non concede, come vedremo, di avere una fidanzata. Tutto ciò dà una
indicazione di come una rigida tipologia relazionale sia prevalente nella sua
famiglia.
In un’altra seduta Miriam mi racconta di aver sentito “una forte vampata alla
nuca” e, siccome non aveva mai provato prima tale sensazione, si è spaventata
e ha chiamato i familiari secondo l’ordine consueto. Mette le mani avanti
rispetto a qualsiasi mio intervento, mi anticipa dicendo che quando ha un
attacco di panico non riesce a pensare a nulla se non agli aspetti fisici di
quanto le sta succedendo, cioè non riesce a pensare che non sia nulla e si
spaventa a morte. Non intervengo perché è ovvio che Miriam percepirebbe
qualsiasi commento come un giudizio e quindi mi “limito” ad ascoltare il suo
lungo sfogo sui sintomi fisici. Subito dopo essa parla del suo carattere, di
come sia testarda, forte. Mi dice che secondo lei le vengono gli attacchi di
panico perché “si è presa carico di troppe cose e adesso il fisico ne risente”.
Riaffiora anche qui il legame simbiotico con i suoi, per cui essa si è
autoattribuita il compito di proteggerli di fronte a ogni evenienza: da una parte
si sente colpevole nei confronti dei genitori perché con i suoi problemi li fa
soffrire, dall’altra, appunto, si carica di troppe responsabilità e da ciò
deriverebbe quella stanchezza fisica che innesca secondo lei l’attacco di
panico. Vi è stata infatti un’inversione dei ruoli: Miriam ha “dovuto” essere
lei il genitore, ha dovuto essere il “genitore” che conteneva i genitori reali
recepiti come troppo fragili e che difatti non avevano potuto garantire alla
figlia un attaccamento e un contenimento adeguati a fornire un sentimento di
sicurezza.
Come si vede l’aspetto meramente fisico resta al centro dei primi tempi della
terapia. In prima approssimazione ritengo di poter dire che, da un punto di
vista psicopatologico, vi sia un sottostante attaccamento insicuro con il
proprio caregiver e che pertanto il processo di separazione/individuazione non
sia completato.
Come già accennato in altre parti dell’articolo mi viene in aiuto il concetto di
terapia a “due tempi” di Monari (200,2007), in cui l’autore suggerisce nella
prima fase, oltre che essere di supporto, di confrontare il paziente ogni volta
che esprima il suo malessere come disturbo fisico a confrontarlo con il fatto
che non è in grado di elaborarlo cognitivamente (alessitimia) e tanto meno
emotivamente.
Nella seconda fase Monari propone di continuare il lavoro intrapreso nella
prima e cioè di continuare a confrontare la paziente sulla sua capacità, o
meglio incapacità, di mentalizzazione, finchè pian piano non si pongono le
basi per lo sviluppo di quest’ultima.
Un esempio – a mio avviso toccante – di tutto ciò lo possiamo ritrovare in una
seduta prossima alla fine della terapia, seduta nella quale Miriam mi
sorprende comunicandomi che ha ripensato al suo passato, a quando era
bambina e a come non potesse mai stare da sola. Le rimando che ciò mi
richiama alla mente la sua incapacità attuale di “stare da sola”, anche per
un’ora solamente. Miriam annuisce e mi dice che anche secondo lei c’è una
“sorta” di collegamento fra le due questioni. In seguito essa associa come, da
bambina appunto, giocasse sempre con altri, ma mai da sola. Andava in
cortile, o a turno a casa dei suoi amici, oppure erano loro ad andare da lei.
Miriam comunque non restava a giocare in solitudine; quando la madre glielo
proponeva, per farla stare in casa almeno un paio d’ore dopo i pasti, essa non
accettava e le chiedeva invece: “Mi annoio, che cosa posso fare da sola?”.
Questa incapacità di Miriam nel potere – da bambina – stare da sola, offre un
nuovo spunto sull’origine del suo nucleo problematico: possiamo ipotizzare
cioè che essa non abbia in sé quella capacità immaginativa che ci permette di
chiamare in causa gli altri senza che vi sia la loro presenza concreta.
Sappiamo che tutto questo riguarda la capacità di introiezione e quindi lo
sviluppo di adeguati processi di individuazione/separazione. Se tutti questi
passaggi fossero avvenuti a tempo debito, oggi, o per meglio dire ieri, Miriam
non sarebbe stata così deficitaria nell’utilizzo della propria funzione riflessiva;
essa sarebbe stata cioè non solo in grado di giocare da sola, ma, per dirla con
Winnicott (1971), sarebbe stata “semplicemente” in grado di “giocare”.
Mi riferisco qui in particolare alla capacità di plasmare la realtà con la propria
fantasia, o alla capacità di stare da soli perché si è dapprima in grado di
popolare il proprio mondo di oggetti transizionali, oggetti che in seguito
potranno divenire, nel gioco, simboli; simboli dunque e non più equazioni
simboliche (Segal, 1957).
Pertanto nel modo di giocare di Miriam e nella scarsa capacità immaginativa
che in quell’attività essa manifestava, si intravedono i probabili segnali di
un’insufficiente
capacità
di
simbolizzazione,
buon
indice
di
una
mentalizzazione scarsa o carente.
Nelle ultime sedute ripenso alla terapia, alle sue fasi, agli scogli, al suo
procedere. Ammetto che il mio sentimento, soprattutto riguardo alla seconda
fase della terapia, è di soddisfazione – quasi di “orgoglio” – per i risultati
ottenuti.
Miriam, nell’ultima seduta, mi comunica che ha festeggiato da pochi giorni
l’anniversario del primo attacco di panico: è il terzo anniversario, mi precisa,
per i primi due anni sentiva solo la rabbia di “essere ingabbiata” in un
malessere che non sentiva suo e che letteralmente non le lasciava alcun
respiro. Quest’anno è stato diverso.
P: “Mi sono resa conto di quanto questo star male in fin dei conti mi abbia
permesso una comunicazione, che ben presto si è trasformata in un confronto
con l’altro ; ho compreso che tutto ciò mi ha portato a essere la Miriam di
oggi, e cioè un essere umano che è per tanti aspetti uguale a quello di prima,
ma che si conosce molto di più e tante volte si accetta per come è”.
Daniela, una donna di una sessantina d’anni, completamente autosufficiente,
vive in una casa isolata in montagna dove le nevicate sono frequenti ed
abbondanti. Nell’anno in cui la seguo in terapia, inviatami da un collega
psichiatra con la diagnosi di un Disturbo da Attacchi di Panico e con una
terapia farmacologica che comprende benzodiazepine e antidepressivi
serotoninergici, le nevicate sono state così abbondanti che ripetutamente e per
interi giorni non ha potuto attraversare il cortile neanche per aprire il cancello
almeno per fare la spesa. E’ in occasione di una di queste nevicate, mi
racconta, che ha avuto il suo secondo attacco di panico (il primo le era
occorso una ventina di anni fa e per questo era entrata in terapia).
Quando la vedo è molto impaurita, non riesce a mangiare perché prova
disgusto del cibo (elemento che al momento sono indecisa se considerarlo un
disturbo psicosomatico o invece di conversione), non riesce a vivere così
isolata, presenta una flessione del tono dell’umore.
Con il procedere della terapia noto però che Daniela non ha problemi
nell’identificare i propri stati d’animo e a trasformarli in domande e
riflessioni: manca quindi di quello che è stato definito come una delle
caratteristiche fondamentali del Disturbo da attacchi di Panico e cioè la
mancanza, o insufficiente, mentalizzazione. In più, mi capita sempre più
spesso di riflettere, con il procedere della terapia, che questo suo attacco di
panico è stato “sollecitato” da una situazione reale che poteva trasformarsi in
un’emergenza qualora avesse avuto bisogno di un aiuto da parte di qualcuno.
Oltre a tutti questi elementi che testimoniano a sfavore di un attacco di panico
sì, ma non di un disturbo in tal senso, Daniela con il passar del tempo mi
mostra sempre di più le sue capacità di “sentire le proprie emozioni e pensare
i propri pensieri”: arriverà infatti alla conclusione che tutto sommato questo
“attacco” è stato utile perché l’ha costretta a riflettere sulla necessità ora da lei
sentita come impellente di non vivere più così isolata, perché la solitudine è
diventata un vero problema per lei. Solitudine che non necessariamente dovrà
cessare con la ricerca di un compagno, ma di avere più vicine le sue amiche,
dei cinema, dei circoli culturali.
Pertanto mentre “accompagnavo” Daniela in questa tranche di terapia si è
insinuata sempre di più nella mia mente la necessità di distinguere fra un caso
caratterizzato da singoli attacchi di panico, per di più reattivi, dai casi in cui è
presente un Disturbo da Attacchi di Panico. Che io sappia nessun autore si è
ancora posto questo interrogativo ed è per questo che ho voluto mettere a
confronto i succitati casi.
CONCLUSIONI
E’ stata finora lasciata fondamentalmente implicita la convinzione che dovremmo
promuovere il mentalizzare nella pratica clinica perché è adattativo. Un
mentalizzare capace di ascolto ci mette in condizione di apprendere e di crescere
per mezzo delle relazioni, comprese quelle psicoterapiche.
Dovremmo comunque anche tenere presente che, pur essendo potenzialmente
positivo, il mentalizzare, come molte altre abilità, può essere utilizzato tanto per il
male che per il bene. Gli psicopatici sono molto abili nel decifrare gli stati mentali
altrui, ma, non provando senso di colpa o di riguardo, lo usano in modo
manipolatorio e a fini di sfruttamento. I sadici traggono piacere dal tormentare gli
altri e anche questo richiede una certa capacità di sintonizzarsi con gli stati affettivi
altrui. Lo stesso i terroristi con le loro vittime. Psicopatia, sadismo e terrorismo
implicano cioè una profonda, ma parziale, abilità empatica e contemporaneamente
una mancanza di empatia: infatti le persone che presentano questi tratti, non sono
in realtà capaci di identificarsi con l’angoscia degli altri.
Inoltre, come molte altre competenze, il mentalizzare può essere utilizzato non solo
per fini sbagliati, ma anche in modo eccessivo. Ad esempio, un bambino cresciuto
in un ambiente domestico violento o abusante può diventare troppo attento agli
stati mentali degli altri, per poter anticipare o evitare il pericolo. Viceversa un
bambino può acquisire una particolare sensibilità, una sintonia profonda con stati
affettivi dei caregivers, per esempio con l’umore depresso di un genitore: in questo
caso probabilmente diventerà psicoterapeuta o comunque intraprenderà un’altra
professione di aiuto agli altri (Ferenczi, 1929, 1930; Miller, 1979). Allo stesso
modo, la sensibilità estrema per gli stati mentali propri può essere angosciante e
controproducente e condurre a una ruminazione ansiosa e depressiva in cui ci si
impantana: in questi casi va persa una capacità di mentalizzazione flessibile.
Per ragioni di completezza vorrei qui accennare brevemente ad alcune delle
critiche a cui la teoria e la pratica della mentalizzazione sono state e sono
sottoposte: c’è chi afferma che in esse non vi è niente di nuovo, dato che
rappresenta una condensazione di nozioni più tradizionali come la capacità mentale
psicologica, l’empatia e di altre più recenti, come la pienezza della consapevolezza
mentale (mindfulness) e l’intersoggettività; altri ritengono infine che può sembrare
che vi sia poca differenza tra il promuovere la capacità di mentalizzare e le
pratiche professionali fondate sul cognitivismo.
La bibliografia deve sempre riguardare solo testi specifici citati, non genericamente
autori ipernoti di riferimento
BIBLIOGRAFIA
AINSWORTH M. D. S. (1982). Attachment: retrospect and prospect. In: Parkes C. M. and
Stevenson-Hinde J. (eds). The place of attachment in human behaviour. Basic Books, New York.
ALLEN J. G. (2001). Traumatic relationship and serious mental disorders. Wiley, Chichester.
ALLEN J., BLEIBERG G., HASLAM-HOPWOOD T. Mentalizing as a compass for treatment.
Bull. Menninger Clinic, 67, 1-11. 2003.
BATEMAN A., FONAGY.P. (2004). Il trattamento basato sulla mentalizzazione. Cortina,
Milano, 2006.
BATEMAN A, FONAGY P. (2010). Mentalization based treatment for borderline personalità
disorder. World Psychiatry, 9, 11-15.
BERTI CERONI G.. (2010). Un tentativo di classificazione dei disturbi fra psiche e soma. In:
Berti Ceroni G., Muri, confini e bordi. In corso di pubblicazione.
BICK E. (1968). The experience of the skin in the early objects relations. Int.J. Psychoanal., 49,
484- 486.
BUSCH F., COOPER A., KLERMAN G., PENZER R., SHAPIRO T., SHEAR M.K. (1991).
Neurophysiological, cognitive – behavioural, and psychoanalytical approaches to
panic disorder: an Integration. Psychoanal. Inq. 11, 316 – 332.
BUSCH F.N. Mentalization. Theoretical Considerations, Research Findings and Clinical
Implications. The Analytic Press, New York and London, 2008.
FASULLO S. (2009). La patologia psicosomatica quale insufficiente mentalizzazione di tensioni
emozionali, L’altro, 12, 29-32.
NEL TESTO SON CITATI FERENCZI 1929 E 1930
FERENCZI S. (1928). L’elasticità della tecnica della psicoanalisi Tr.it in: Ferenczi S. Opere,
Volume Terzo. Cortina, Milano, 1992.
FERENCZI S. (1929). Il bambino mal accolto e la sua pulsione di morte. Tr. it. in: Ferenczi S., cit.,
Volume Quarto.
FERENCZI S. (1930). Principio di rilassamento e neocatarsi. Tr. it. in: Ferenczi, S., cit., Volume
Quarto
FONAGY P. (1989), On tolerating mental states: theory of mind in borderline patients. Bull.
Anna Freud Centre 12, 91-115.
FONAGY P. (1991), Thinking about thinking. Int. J. Psycoanal., 72, 1-18.
FREUD S. (1895), Minuta J. O. S. F., 2.
FREUD S.(1895), Minuta K. O. S. F., 2.
FREUD S. (1894). Legittimità di separare dalla nevrastenia un preciso complesso di sintomi
come nevrosi d’angoscia. O.S. F., 2.
FREUD S. (1895). A proposito di una critica della nevrosi d’angoscia. O. S. F., 2.
KLEIN D.F. (1964), Delineation of two drug responsive anxiety syndromes.
Psychofarmacol., 5, 397-408.
MARTY P., (1980). L’ordre psychosomatique. Payot, Paris.
MAIN M. (1991). CERCARE DOVE è LA SCALA
MC DOUGALL J., (1989). Teatri del corpo. Un approccio psicoanalitico ai disturbi
psicosomatici. Cortina, Milano, 1990.
MILLER A. (1979). Il dramma del bambino dotato. Boringhieri, Torino, 1989.
MONARI M. (2000), La terapia psicoanalitica dei pazienti gravi e difficili: le prime fasi. Riv.
Psicoanal., 46, 663-681.
MONARI M. (2007), Alleanza terapeutica, teoria dell'attaccamento e mentalizzazione negli
inizi con i pazienti difficili. Psichiatria di Comunità, 6, 99-106.
RUDDEN R.M., MILROD B., ARONSON A., TARGET M., (2008). Reflective Functioning in Panic
Disorder Patients, in Busch, cit.
SAMI-ALI P. (1987). Penser le somatique. Dunod, Paris.
SEGAL H. (1957). Note sulla formazione del simbolo. Tr. it. in: Casi clinici. Il Pensiero
Scientifico, Roma, 1980.
SKARDERUD F. (2007). Eating one’s words. Part III. Mentalization based psychotherapy for
anorexia nervosa. An outline for a treatment and training manual. Eur. Eat Disord.Rev. XV, 323339.
STERN A. (1938). Psychoanalitic investigation and therapy in borderline group of neurosis.
Psycoanalitic quaterly, 7, 467-489.
TARGET M. (2009). Seminario a Torino, Marzo 2009, sala del Rettorato, Università di Torin