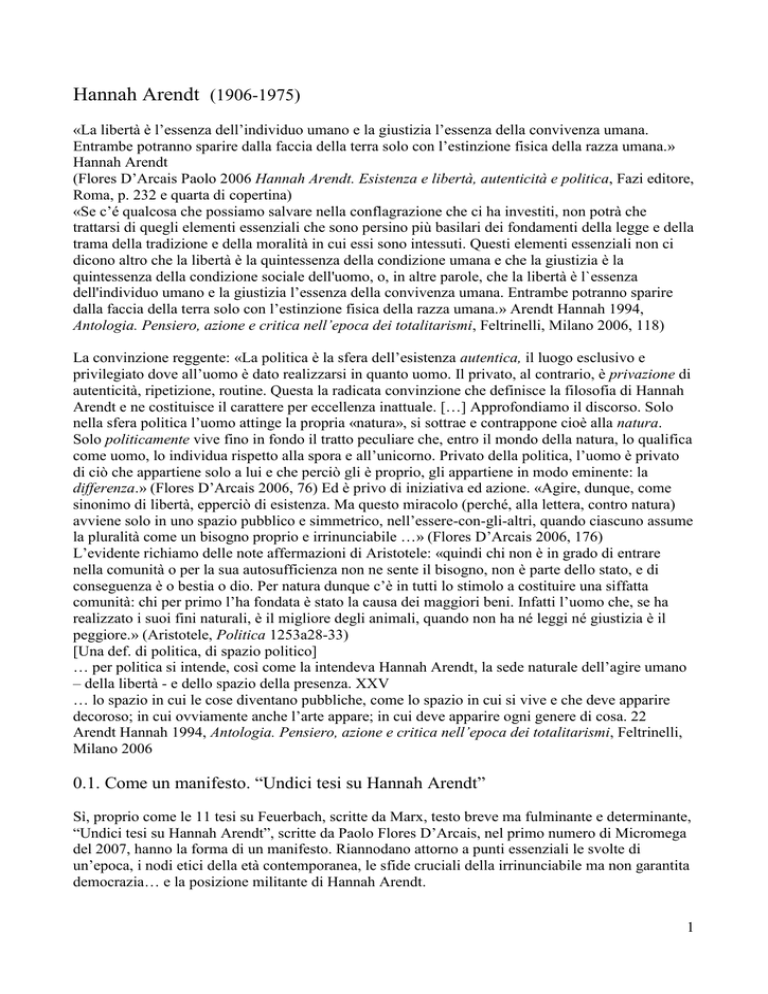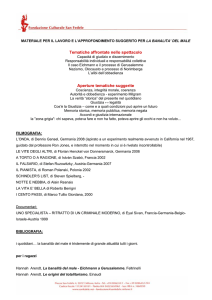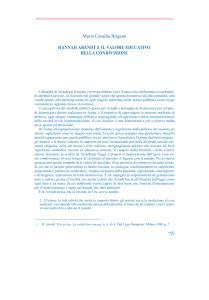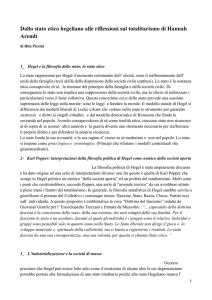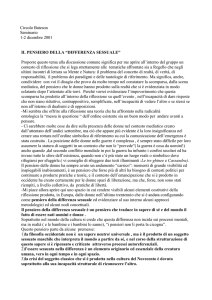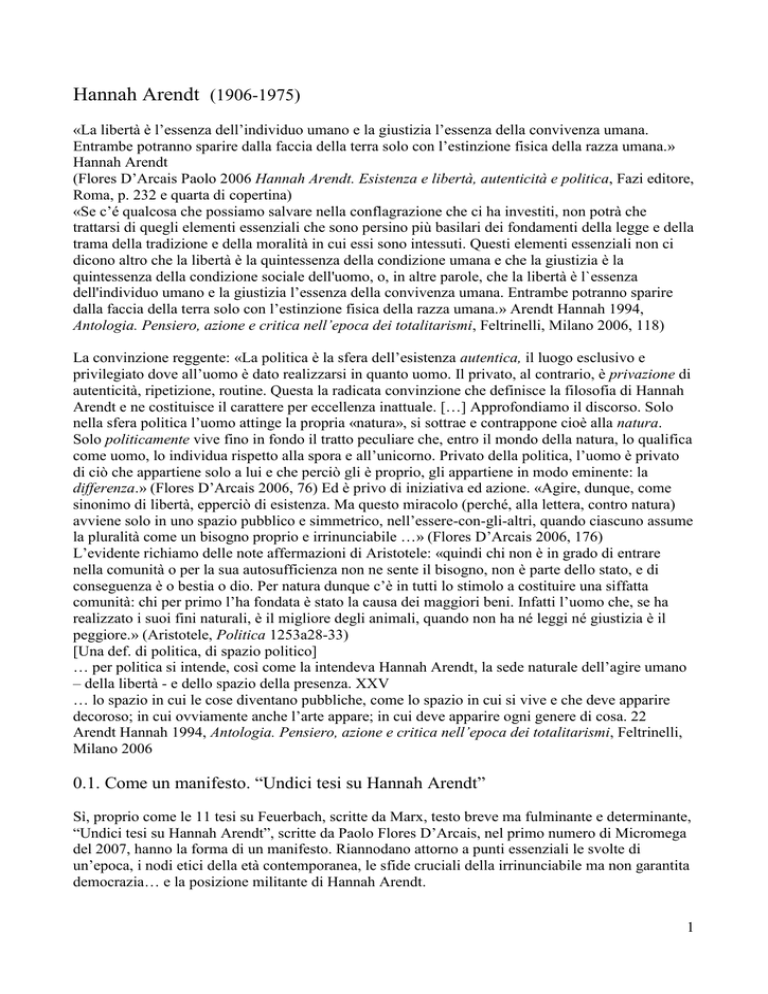
Hannah Arendt (1906-1975)
«La libertà è l’essenza dell’individuo umano e la giustizia l’essenza della convivenza umana.
Entrambe potranno sparire dalla faccia della terra solo con l’estinzione fisica della razza umana.»
Hannah Arendt
(Flores D’Arcais Paolo 2006 Hannah Arendt. Esistenza e libertà, autenticità e politica, Fazi editore,
Roma, p. 232 e quarta di copertina)
«Se c’é qualcosa che possiamo salvare nella conflagrazione che ci ha investiti, non potrà che
trattarsi di quegli elementi essenziali che sono persino più basilari dei fondamenti della legge e della
trama della tradizione e della moralità in cui essi sono intessuti. Questi elementi essenziali non ci
dicono altro che la libertà è la quintessenza della condizione umana e che la giustizia è la
quintessenza della condizione sociale dell'uomo, o, in altre parole, che la libertà è l`essenza
dell'individuo umano e la giustizia l’essenza della convivenza umana. Entrambe potranno sparire
dalla faccia della terra solo con l’estinzione fisica della razza umana.» Arendt Hannah 1994,
Antologia. Pensiero, azione e critica nell’epoca dei totalitarismi, Feltrinelli, Milano 2006, 118)
La convinzione reggente: «La politica è la sfera dell’esistenza autentica, il luogo esclusivo e
privilegiato dove all’uomo è dato realizzarsi in quanto uomo. Il privato, al contrario, è privazione di
autenticità, ripetizione, routine. Questa la radicata convinzione che definisce la filosofia di Hannah
Arendt e ne costituisce il carattere per eccellenza inattuale. […] Approfondiamo il discorso. Solo
nella sfera politica l’uomo attinge la propria «natura», si sottrae e contrappone cioè alla natura.
Solo politicamente vive fino in fondo il tratto peculiare che, entro il mondo della natura, lo qualifica
come uomo, lo individua rispetto alla spora e all’unicorno. Privato della politica, l’uomo è privato
di ciò che appartiene solo a lui e che perciò gli è proprio, gli appartiene in modo eminente: la
differenza.» (Flores D’Arcais 2006, 76) Ed è privo di iniziativa ed azione. «Agire, dunque, come
sinonimo di libertà, epperciò di esistenza. Ma questo miracolo (perché, alla lettera, contro natura)
avviene solo in uno spazio pubblico e simmetrico, nell’essere-con-gli-altri, quando ciascuno assume
la pluralità come un bisogno proprio e irrinunciabile …» (Flores D’Arcais 2006, 176)
L’evidente richiamo delle note affermazioni di Aristotele: «quindi chi non è in grado di entrare
nella comunità o per la sua autosufficienza non ne sente il bisogno, non è parte dello stato, e di
conseguenza è o bestia o dio. Per natura dunque c’è in tutti lo stimolo a costituire una siffatta
comunità: chi per primo l’ha fondata è stato la causa dei maggiori beni. Infatti l’uomo che, se ha
realizzato i suoi fini naturali, è il migliore degli animali, quando non ha né leggi né giustizia è il
peggiore.» (Aristotele, Politica 1253a28-33)
[Una def. di politica, di spazio politico]
… per politica si intende, così come la intendeva Hannah Arendt, la sede naturale dell’agire umano
– della libertà - e dello spazio della presenza. XXV
… lo spazio in cui le cose diventano pubbliche, come lo spazio in cui si vive e che deve apparire
decoroso; in cui ovviamente anche l’arte appare; in cui deve apparire ogni genere di cosa. 22
Arendt Hannah 1994, Antologia. Pensiero, azione e critica nell’epoca dei totalitarismi, Feltrinelli,
Milano 2006
0.1. Come un manifesto. “Undici tesi su Hannah Arendt”
Sì, proprio come le 11 tesi su Feuerbach, scritte da Marx, testo breve ma fulminante e determinante,
“Undici tesi su Hannah Arendt”, scritte da Paolo Flores D’Arcais, nel primo numero di Micromega
del 2007, hanno la forma di un manifesto. Riannodano attorno a punti essenziali le svolte di
un’epoca, i nodi etici della età contemporanea, le sfide cruciali della irrinunciabile ma non garantita
democrazia… e la posizione militante di Hannah Arendt.
1
Memorabile l’11a tesi di Marx su Feuerbach: “I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi
diversi; si tratta però di mutarlo”; qui, la tesi per Arendt è per una filosofia che non si attribuisca più
poteri (e pretese) demiurgici, ma che non può chiamarsi fuori dalla rigida finitezza dei fatti del
mondo e del soggetto; ha senso e ragion d’essere solo come pensiero-nel-mondo (alla stregua di un
pervicace realismo aristotelico), con coscienza critica (La vita della mente 1978) e vita attiva (Vita
activa 1958).
Eccole, le 11 tesi, nei loro incipit (con poche integrazioni di richiamo).
Tesi 1. Hannah Arendt ha capito il suo tempo come nessun altro filosofo, perché lo ha pensato
come problema politico. Anzi come il problema dell'assenza della politica, e soprattutto della
rimozione politica e filosofica di tale assenza.
«L’interesse per la politica è diventato una questione di vita e di morte per la filosofia stessa»
(1954).
Hannah Arendt ha capito il suo tempo come nessun altro, perché lo ha pensato come fuga dalla
libertà, paura della libertà, manipolazione della libertà anche e laddove più si parla di libertà. La
libertà, però, nel senso esigente e coerente di potere-di-ciascuno.
Tesi 2. Il prestigio di Hannah Arendt, oggi dilagante in modo sospetto, si basa su un equivoco. Tutti
riconoscono che ha pensato il proprio tempo perché ha pensato il totalitarismo. Ma il secolo XX è
stato anche, a due riprese e a saldo del suo bilancio, il secolo della sconfitta e del fallimento dei
totalitarismi. Se l'analisi del totalitarismo fosse il cuore e il vanto del suo lavoro, la filosofia di
Hannah Arendt ci parlerebbe di un problema trascorso.
Tesi 3. Hannah Arendt, da una posizione non marxista, e anzi radicalmente critica del marxismo,
dimostra che il libero mercato non costituisce un baluardo delle libertà. Che homo oeconomicus
verso le libertà è, al massimo, indifferente. Hannah Arendt scaglia l'anatema contro il buon padre di
famiglia, questo eroe eponimo di tutti i politici conservatori (e non solo), giudicandolo «il criminale
del XX secolo». Criminale, perché antepone la passione del benessere privato all'interesse per la
cosa pubblica [non è partecipe, attivo, non è spoudàios, non è civile è “familistico”: «Quando coloro
che detengono la sovranità nei corpi deliberativi si scelgono gli uni con gli altri, quando il figlio
succede al padre nel posto che questi ha lasciato libero, quando costoro pretendono di essere
padroni assoluti delle leggi, allora si ha ancora, necessariamente, un governo oligarchico estremo.»
Aristotele, Politica 1298b2s)
Tesi 4. La sfera pubblica per essere luogo d'azione, cioè di autonomia, deve essere spazio pubblico
simmetrico. Di eguaglianza nell'essere-ascoltati. Perché il nomos sia davvero autos deve nascere da
tutti e da ciascuno.
Tesi 5. Nel totalitarismo «ogni persona viene ridotta ad un'immutabile identità di reazioni, in modo
che ciascuno di questi fasci possa essere scambiato con qualsiasi altro. Si tratta di fabbricare
qualcosa che non esiste, cioè un tipo d’uomo simile agli animali, la cui unica libertà consisterebbe
nel preservare la specie». Questa la conclusione della sua opera più famosa.
Tesi 6. Per Hannah Arendt il male radicale coincide con la banalità del male. Il buon padre di
famiglia è il criminale del XX secolo. Il male è il conformismo. Una democrazia che non contrasti
quotidianamente questa radice del totalitarismo sta minacciando la libertà e minando se stessa.
Tesi 7. Hannah Arendt non ha mai imputato la responsabilità del totalitarismo a una filosofia. A
nessuna filosofia. Del resto è sempre stata consapevole di quale ridicolo delirio sia la pretesa di
troppi filosofi che la filosofia sia una potenza che determina il senso e il carattere delle epoche.
Anche per questo, forse, rifiutava l'etichetta di filosofo.
Tesi 8. L'esistenza, e dunque la storia, è per Hannah Arendt pluralità, contingenza, imprevedibilità.
Né il cosmo né la storia né la scimmia nuda che tutti noi siamo, sono dotati di cromosomi morali.
Non esiste una natura umana, ma una condizione umana, che obbliga l'uomo a crearsi la norma,
utensile più irrinunciabile dell'amigdala, del fuoco, della ruota, per surrogare la perduta cogenza
dell'istinto. Una norma qualsiasi, purché funzioni.
Tesi 9. L'identità è l'altra faccia del senso, appartengono alla stessa necessità esistenziale. Se la
democrazia non li assicura a tutti nella cittadinanza, verranno cercati altrove contro lo spirito
2
repubblicano. Cioè: o il cittadino può sperimentare quotidianamente la propria libertà come
autonomia, come potere condiviso ed eguale, oppure la cittadinanza si disgrega in caleidoscopio di
identità, ciascuna delle quali sarà luogo di asimmetria e di illibertà, perché di obbedienza a qualche
logica dell'Uno (anche nelle forme soft dell'identità nera, femminista, omosessuale: per non parlare
delle identità religiose). L'identità parziale non è ossatura e componente della democrazia, ma
minaccia. [distrugge la dimensione “aristotelica” della realtà come possibilità e quindi divenire,
perennemente in potenza alla propria piena e migliore forma]
Tesi 10. Il pensiero di Hannah Arendt costituisce una critica anticipata di tutte le derive
ermeneutiche e post-heideggeriane, oggi egemoni nella filosofia.
Per Hannah Arendt, la cura intransigente per «le modeste verità di fatto» è compito filosofico e
politico primario e irrinunciabile. Fa tutt'uno con la possibilità della libertà - contro il totalitarismo
che progetta di annientare tanto la libertà che le verità di fatto.
Dunque, la volontà di distruzione filosofica dei fatti, che si manifesta nell’affermazione
dell'ermeneutica «non ci sono fatti, solo interpretazione», benché non produca totalitarismo
(secondo Hannah, nessuna filosofia ha questo potere) denuncia il carattere metafisico, anzi
ipermetafisico, di tali filosofie.
Tesi 11. La filosofia non può limitarsi ad interpretare il mondo perché è nel-mondo. Si illude di
poterlo solo interpretare. La filosofia non produce e neppure definisce le epoche del mondo, ma non
è innocente di fronte ad esso, perché è sempre già nel-mondo.
Pensando nel-mondo - quel mondo che è più che mai il nostro - il totalitarismo come dismisura
onnipervasiva dell'eclissi della politica (intesa come autonomia nell'azione simmetricamente
condivisa), pensando lo scarto delle democrazie realmente esistenti dall'ideale della democrazia
come tasso di rischio di un totalitarismo possibile, Hannah Arendt non ha solo pensato il problema
politico del futuro in cui già siamo, ma ci propone, contro ogni metafisica comunque travestita, la
decisione critico-razionale per una filosofia del finito.
Che tenga fermo il disincanto, cioè l'addio ad ogni Autore della norma che non siano gli uomini
stessi. Che tenga ferma la contingenza, cioè il caso e la libertà, come trama e tessuto della storia.
Che tenga ferma la radicale differenza tra fatti e valori, tra le modeste verità di fatto (o i risultati
inequivocabili delle scienze empirico-matematiche) e ogni ermeneutica della «comprensione». Che
tenga ferma la politica come libertà nell'azione, che ci sottrae al conformismo del prevedibile e alla
servitù volontaria del replicante.
Il miglior antidoto oggi a disposizione contro il pensiero unico d'Occidente, la nuova santa alleanza
che oscilla tra vulgata liberale, derive identitarie, restaurazioni oscurantiste di papi e altri
fondamentalismi cristiani.
La filosofia di Hannah Arendt è un esistenzialismo libertario. Una filosofia del finito rigorosa e
intransigente lasciata in eredità al nostro futuro.
Un manifesto che pone i postulati della filosofia e dell’impegno politico di Hannah Arendt e segna
le linee di riflessione del pensiero e della prassi politica responsabile dell’età contemporanea.
0.2. Schema per introdurre
0.2.1. Il luogo storico della riflessione di Hannah Arendt: il nazismo e la triplice tragedia
personale di Hannah Arendt:
― il maestro / amante alleato o connivente culturale (la filosofia connivente) con il regime nazista
― la patria distrutta, annullata culturalmente e eticamente dalla sua costruzione politica
― la menzogna della razza strumento per annullare l’umanità nella costruzione di identità storiche
Come per Aristotele, anche Hannah Arendt si occupa di politica guidata dall’idea «che l’esistenza
autentica si raggiunge nella sfera pubblica – la politica! – anziché nel ripiegamento privato. Non
dunque in interiore homine, neppure inteso come luogo della meditazione filosofica, ma proprio
nella partecipazione a quel “nuovo inizio” che è l’azione quando consente all’inaudito di far
irruzione nel mondo. Paradosso incomprensibile per la tradizione liberale: che l’individuo si realizzi
3
nell’agire pubblico e comune e si perda invece nel trafficare privato dell’homo oeconomicus.» Sia la
concezione dello stato, polis e politéia, come luogo in cui l’individuo scopre e realizza la propria
natura complessa, sia la distinzione tra la sfera della polis (del pubblico e comune) e dell’oikos
(dell’economico e del privato) sono alla radice della riflessione politica di Aristotele e di Arendt;
riflessione che assume il richiamo al reale, e non a meri concetti ideali astratti, la direzione della
propria analisi politica.
La posizione per osservare e per riflettere, il luogo del domandare: non dimenticare il reale. “La
nostra odierna domanda sul senso della politica, scrive la Arendt, «nasce da esperienze politiche
molto reali: essa è suscitata dalle sciagure che la politica ha già provocato nel nostro secolo, e da
quelle ancora più grandi che rischiano di scaturirne» (p. 21; cfr. anche p. 97). In concreto, si tratta
delle «esperienze politiche fondamentali della nostra epoca»: il totalitarismo e la bomba atomica, o
più precisamente i «regimi totalitari» e «l’enorme sviluppo dei moderni strumenti di distruzione il
cui monopolio è detenuto dagli stati» (p. 22). Si tratta dunque di fenomeni di politica sia interna che
estera dell’era moderna: una situazione, per la Arendt, «in cui non siamo, o non siamo ancora, in
grado di muoverci politicamente» (p. 9).” (Ursula Ludz in Arendt Hannah 1993 Che cos’è la
politica?, Edizioni di Comunità, Milano 2001 p.122-123)
Dunque Hannah Arendt specifica il “nuovo” luogo del domandare. Un domandare realistico, storico
e non idealistico, non imbottito dalle trappole dell’inganno di un pensiero che per definirsi puro si
chiama “fuori da” e assume per sé la posizione ideale di una irresponsabile teoreticità. Oggi è
tramontata la domanda sul senso della politica impostata a partire dallo stato di natura, come
avveniva per i teorici dello Stato moderno, Hobbes, Locke, Rousseau…; la domanda prende avvio
da un ben altro contesto e richiede una fondazione storica concreta: visti i disastri totalitari e tecnici
(bomba atomica) del XX secolo realizzati e (auto)presentati come se fossero il compimento dello
Stato nella sua autentica, autonoma, sovrana e assoluta, limpida ragione, contro gli impacci della
società civile e le remore individualistiche della tradizione liberale, la domanda allora riemerge
nella sua massima semplicità e essenzialità: «che cos’è la politica?», e questo quesito cade, più
fondamentalmente, in un’altra domanda: “la politica ha ancora un senso?”
0.2.2. La direzione del progetto complessivo di Hannah Arendt in prima presentazione:
«Per duemila anni una filosofia maschile ha vincolato la ricerca della saggezza alla morte: alla
consolazione apportatavi dal pensiero o alla dimostrazione di una vita incorporea. Nel ventesimo
secolo, finalmente, una donna, il quarto cavaliere dell’apocalisse che invoco sulla tradizione, ha
pronunciato con forza gli assiomi di una filosofia fondata sulla nascita. Anche questi assiomi hanno
radici eclettiche: combinando intuizioni di Platone e Aristotele, Agostino e Tommaso, Rousseau e
(soprattutto) Kant, Hannah Arendt ha parlato di un’esistenza plurale e politica, di scambi che
generano risultati nuovi e inaccessibili a ogni individuo isolato, di una socialità in cui la bellezza e
la dignità dell’apparire in pubblico, il compiacimento del rispecchiarsi l’uno negli occhi dell’altro e
dell’immagine di sé stessi che così prende forma predominano sulla funzionalità utilitaristica —
proprio come nell’amore. Il mondo della Arendt non ha spessore: è fatto di superfici che si
avvicendano e s’intersecano; la sua profondità è anch’essa un effetto superficiale, una conseguenza
di queste vicissitudini e questi intarsi.»
Bencivenga Ermanno 2010 La filosofia come strumento di liberazione, Raffaello Cortina Editore,
Milano, p. 90
Catapultata nella politica dagli eventi epocali del ‘900, capace di leggerne i tratti a partire dalla
cultura filosofica nel suo sviluppo e in compagnia dei contemporanei (in particolare di Heidegger,
Bultmann, Jaspers), alla ricerca di una spiegazione dei totalitarismi del ‘900 e del loro esito in
progetti di sterminio etnico culturale dell’uomo, dell’umanità, Arendt passa al setaccio l’intera
storia del pensiero (filosofico, religioso…) occidentale allo scopo di scoprire tracce di
inconsapevole legittimazione delle politiche totalitarie del ‘900. Osserva e precisa: «Ebbene, ho il
sospetto che la filosofia non sia del tutto incolpevole di questo pasticcio. Naturalmente non nel
senso che Hitler abbia qualcosa a che fare con Platone. (Se mi sono data tanta pena di individuare le
4
componenti delle forme totalitarie di governo, è proprio anche per purificare la tradizione
occidentale, da Platone fino a Nietzsche incluso, da simili sospetti.) Ma piuttosto nel senso che
questa filosofia occidentale non ha mai avuto un concetto puro del politico, né poteva averne uno,
poiché per forza di cose parlava dell’Uomo, e solo incidentalmente trattava della pluralità». (Arendt
1993, 115)
In Arendt nessuna criminalizzazione del passato (né Platone, né Hegel, né Nietzsche), che
significherebbe assolvere o trovare scusanti per le scelte presenti, ma scoperta di come (e perché, e
anche per quale tratto interno, suo proprio, al di là dell’uso e della distorsione che con voluta
consapevolezza o no se ne fa) la tradizione culturale dell’Occidente possa essere così
disinvoltamente usata, manipolata, a legittimare il contrario di ciò che essa proclama e intende
promuovere. È la scoperta di un rischio e di una sfida: non è possibile trovare una netta barriera che
divida in modo certo il bene dal male, il vero dal falso, come dal suo inizio la filosofia sembra voler
e poter promettere. Occorre scoprire la contingenza delle culture e dei modelli, accettare la
singolarità e la pluralità delle persone, delle esperienze e delle situazioni (afferma infatti «La
politica si fonda sul dato della pluralità degli uomini» Arendt 1993 p.5, p.121; la negazione di
questa pluralità è la negazione della politica) e promuovere la responsabilità etica attiva degli
uomini per il mondo (cfr. Vita activa, e Arendt 1993, a p. 18 «al centro della politica vi è infatti
sempre la preoccupazione per il mondo, non per l’uomo»; commenta U. Ludz: “La preoccupazione
per il mondo implica una sorta di dovere, di coazione a preoccuparsi”; Arendt 1993 p. 148)
0.2.3. La domanda su che cos’è la politica così come si formula e diventa impellente nell’opera
postuma, a lungo pensata, più volte abbozzata, come un testamento dei quesiti fondamentali e
ricorrenti su cui Arendt ha lavorato e che attendono, per lei e per tutti, una risposta: Arendt Hannah
1993 Che cos’è la politica?, Edizioni di Comunità, Milano 2001
«Come la filosofia che riguarda l’uomo al singolare comincia sul serio soltanto dopo che l’uomo ha
compreso che può dire sì o no alla vita, così la politica che riguarda gli uomini al plurale forse
comincia sul serio soltanto ora che sappiamo di poter dire sì o no all’umanità». 126
Compaiono tre parole chiave: contingenza, pluralità, vita attiva (responsabilità, il dovere di
preoccuparsi, l’essere “spoudàios” direbbe Aristotele).
1. Che cos’è la politica? i pregiudizi, (lo status quo ante ricorrente e presente nei confronti del
politico). «Se vogliamo parlare di politica ai giorni nostri, dobbiamo partire dai pregiudizi che noi
tutti, se non siamo politici di professione, nutriamo nei confronti della politica.» (Arendt 1993, 9 e
12) Occorre dunque partire, con realismo, dai pregiudizi della cosiddetta antipolitica. 1. Perché sono
molto diffusi, pervicaci e ricorrenti; 2. per indagare la loro ragion d’essere; 3. Perché in essi
vengono espressi un pensiero e una volontà politica (quale?). Liquidare sbrigativamente come
qualunquismo il “pregiudizio” dell’antipolitica è non comprendere, in generale, la funzione del
pregiudizio, è perdere una strada possibile di accesso alla politica, al senso della politica.
1.1. non possiamo vivere senza pregiudizi, sia come persona sia come società.
«Se vogliamo parlare di politica ai giorni nostri, dobbiamo partire dai pregiudizi che noi tutti, se
non siamo politici di professione, nutriamo nei confronti della politica. I pregiudizi che
condividiamo con gli altri, che ci vengono spontanei, che possiamo scambiarci nella conversazione
senza prima doverli spiegare diffusamente, rappresentano infatti a loro volta, nel senso più ampio
del termine, un fattore politico: qualcosa che è parte integrante delle umane faccende nella cui sfera
ci muoviamo ogni giorno. Il fatto che i pregiudizi svolgano un ruolo così straordinariamente grande
nella vita quotidiana, e dunque nella politica, non è di per sé deplorevole; e per nessun motivo
dovremmo cercare di cambiare le cose. Nessuno infatti può vivere senza pregiudizi; e non solo
perché nessuno è abbastanza intelligente o assennato da riuscire a dare un giudizio originale su tutto
ciò che nel corso della sua vita gli viene richiesto di giudicare, ma perché una tale mancanza di
pregiudizi esigerebbe una vigilanza sovrumana.» (Arendt 1993, 12)[una vigilanza diretta e totale].
«In compenso, non essendo vincolati a una persona, possono contare molto facilmente sull’altrui
5
consenso, senza doversi sobbarcare a uno sforzo di persuasione. In ciò il pregiudizio si distingue dal
giudizio, al quale d’altro canto lo accomuna il fatto che per suo tramite gli uomini si riconoscono e
si sentono affini; cosicché l’uomo che è schiavo dei pregiudizi in fondo è sempre certo dell’effetto,
mentre l’idiosincrasia non riesce praticamente ad affermarsi nello spazio pubblico-politico e si fa
valere soltanto nell’intimità del privato. Di conseguenza il pregiudizio svolge un ruolo di rilievo
nell’ambito puramente sociale: di fatto non esiste società che non si costituisca più o meno in base
ai pregiudizi, i quali fanno sì che certe specie di uomini siano ammesse e altre escluse. Più un uomo
è libero da pregiudizi, meno sarà adatto alla vita sociale.» (Arendt 1993, 13)
(Sul tema dei pregiudizi è indispensabile il richiamo allo studio e alla definizione del ruolo della
precomprensione in Rudolf Bultmann 1884-1976)
1.2. le radici storiche dell’efficacia e della pericolosità dei pregiudizi.
«Uno dei motivi dell’efficacia e della pericolosità dei pregiudizi è che in essi si cela sempre un
pezzo di passato. A ben vedere, un vero pregiudizio si riconosce anche perché in esso si cela un
giudizio formulato tempo addietro, il quale in origine aveva un fondamento empirico legittimo e
pertinente e si è mutato in pregiudizio soltanto perché si è trascinato attraverso gli anni senza
controlli o revisioni. Sotto questo aspetto il pregiudizio si distingue dalla mera diceria, che non
sopravvive al giorno o all’ora della chiacchiera e mescola come in un caleidoscopio le opinioni e i
giudizi più eterogenei. Il rischio del pregiudizio sta proprio nel suo essere in realtà sempre ben
radicato nel passato, cosicché esso non solo previene e ostacola il giudizio ma, oltre al giudizio,
impedisce anche una effettiva esperienza del presente. Se si vogliono dissipare i pregiudizi, per
prima cosa si deve sempre ritrovare il giudizio passato che vi sta dietro, dunque di fatto rilevarne il
tenore di verità. Se non si tiene conto di ciò, nulla otterranno interi battaglioni di oratori illuminati
né intere biblioteche di pubblicazioni; come risulta chiaramente dagli sforzi quasi infiniti, e
infinitamente infruttuosi, nei riguardi dei problemi gravati da pregiudizi del genere più antico, come
la questione dei neri negli Stati Uniti oppure la questione ebraica.
Poiché il pregiudizio previene il giudizio richiamandosi al passato, la sua legittimità temporale è
limitata alle epoche storiche che a livello meramente quantitativo costituiscono la parte maggiore
della storia, quelle cioè in cui il nuovo è relativamente raro e il vecchio predomina nella compagine
politica e sociale.» (Arendt 1993, 14)
1.3. il pregiudizio politico dell’antipolitica: «Oggi la politica consiste in effetti nel pregiudizio
verso la politica.
Se vogliamo parlare di politica ai giorni nostri, dobbiamo partire dai pregiudizi che noi tutti, se non
siamo politici di professione, nutriamo nei confronti della politica. Tali pregiudizi, che sono comuni
a noi tutti, rappresentano a loro volta, nel senso più ampio del termine, un fattore politico: essi non
derivano dalla presunzione delle persone istruite, né sono dovuti al cinismo di chi ha troppo vissuto
e troppo poco compreso. Non possiamo ignorarli, dato che si agitano dentro di noi, e non possiamo
sopirli attraverso il ragionamento poiché sanno fare appello a realtà incontestabili e rispecchiano
fedelmente, proprio nei suoi aspetti politici, la reale situazione odierna. Eppure questi pregiudizi
non sono giudizi. Essi denunciano che siamo finiti in una situazione in cui non siamo, o non siamo
ancora, in grado di muoverci politicamente. Il rischio è che il politico scompaia del tutto dalla faccia
della terra. Ma i pregiudizi precorrono i tempi; gettano via il bambino con l’acqua sporca,
confondono con la politica ciò che alla politica porrebbe fine, e presentano quella che sarebbe una
catastrofe come se fosse insita nella natura delle cose, e dunque ineluttabile.
Se però per politico si intende una sfera del mondo dove gli uomini si presentano primariamente
come soggetti attivi, e dove conferiscono alle umane faccende una stabilità che altrimenti non le
riguarderebbe, la speranza appare tutt’altro che utopica. L’eliminazione degli uomini in quanto
soggetti attivi è riuscita spesso nella storia, sebbene non a livello mondiale: sia sotto forma di quella
tirannide che oggi ci sembra antiquata, dove la volontà di un uomo pretendeva totale libertà di
azione, sia sotto forma del moderno totalitarismo, dove si vorrebbe liberare la presunta superiorità
6
dei processi e delle «energie storiche» impersonali e sottomettervi gli uomini. Il carattere
intrinsecamente impolitico, nel senso più profondo del termine, di questa forma di dominio, si rivela
proprio nella dinamica che le è peculiare e ne è scatenata, in cui ogni cosa e persona che ieri era
ancora considerata «grande» oggi può e deve essere consegnata all’oblio, affinché il movimento
mantenga il suo slancio. E non può certo servire a tranquillizzarci constatare che nelle democrazie
di massa, senza alcun terrore e per così dire spontaneamente, prendono piede da un lato un’analoga
impotenza degli uomini e, dall’altro, un analogo processo di logoramento e oblio che sembra
ribaltarsi di continuo, per quanto tali fenomeni, nel mondo libero e non terrorizzato, rimangano
confinati all’ambito strettamente politico ed economico.» (Arendt 1993, 9-11)
1.4. motivi recenti per rinnovati pregiudizi politici contro la politica.
«I pregiudizi, che nella crisi odierna ostacolano la comprensione teorica della vera natura della
politica, riguardano praticamente tutte le categorie politiche in cui siamo abituati a pensare, ma
soprattutto la categoria del fine e del mezzo, che considera il politico nell’ottica di un fine supremo
a esso estraneo, poi l’idea che la sostanza del politico sia la violenza, e infine la convinzione che il
dominio sia il concetto centrale della teoria politica. Tutti questi giudizi e pregiudizi nascono da una
diffidenza, di per sé non ingiustificata, nei confronti della politica. Ma questa antichissima
diffidenza ha subito un ulteriore cambiamento nell’odierno pregiudizio verso la politica. Dopo
l’invenzione della bomba atomica si è aggiunta la paura, altamente legittima, che l’umanità possa
autoeliminarsi attraverso la politica e gli strumenti di violenza di cui dispone. Da questa paura nasce
la speranza che l’umanità si ravveda e anziché se stessa tolga di mezzo la politica. E tale speranza
non è meno legittima di quella paura. Infatti, l’idea che la politica esista sempre e dovunque vi siano
degli uomini è essa stessa un pregiudizio, e l’ideale socialista di una condizione umana finale
astatale, o per Marx apolitica, non è affatto utopico; è soltanto orribile.» (Arendt 1993, 62)
Dunque una conclusione e una convinzione… sul ruolo indispensabile della politica nella umana
convivenza, al di là di ogni legittimo sospetto e dissenso; e ancor più si fa necessaria la domanda su
quale ne sia il senso.
«Comprendere una situazione politica non significa altro che acquisire e avere ben presente un
quadro quanto più vasto dei possibili punti di vista e posizioni dai quali la situazione può essere
considerata e giudicata. Di quella phronesis, che per Aristotele è la vera virtù cardinale del
politico.» (Arendt 1993, 76-77)
2.Che cos’è la politica? i postulati e gli irrinunciabili (l’idea, gli ideali)
[percorso in schema: l’idealità, cioè i postulati, gli irrinunciabili, le prospettive (punto 2.); la realtà,
cioè le trasformazioni del XX secolo, i totalitarismi, l’imperialismo, il globalismo (punto 3.)]
2.1. gli irrinunciabili: la pluralità. «La politica si fonda sul dato di fatto della pluralità degli
uomini.» (Arendt 1993,5)
La pluralità su cui tanto insiste la filosofia greca con Aristotele, che trova concettualmente la sua
legittimazione fondamentale nella presentazione metafisica dell’essere in quanto essere
originariamente, non per derivazione o per omonimia, molteplice, si presenta e torna ad essere
postulato primo del pensiero e dell’agire politico nelle proposte di Hannah Arendt.
«Il «male radicale» consiste infatti nella volontà di costruire una nuova natura dell’uomo dalla
quale estirpare ogni tratto non sussumibile sotto una legge universale. Grazie soprattutto ai campi di
sterminio viene alla fine realizzato il progetto di un’Unica Umanità, indistinguibile nei suoi
molteplici appartenenti. Quella che era una pura astrazione del pensiero, un’ipostasi delle filosofie
della storia sette-ottocentesche, ad Auschwitz cessa di essere una finzione. Nei campi di sterminio,
gli esseri umani sono davvero diventati meri esemplari intercambiabili della specie. Ridotti a un
fascio di necessità biologiche, essi perdono completamente quell’imprevedibilità e quella differenza
che sono la conseguenza della libertà e del fatto che «non l’Uomo, ma gli uomini abitano la terra».»
(Arendt Hannah 1951 Le origini del totalitarismo Einaudi, Torino, 2004; con introduzione di
Simona Forti, Le figure del male, da introduzione S. Forti p. XL)
7
«È nella natura della filosofia occuparsi dell’uomo al singolare, mentre la politica non sarebbe
neppure concepibile se gli uomini non esistessero al plurale» (2, 216). (Flores D’Arcais 2006, 197)
La pluralità irriducibile del mondo umano deve essere dapprima elusa nel pensiero, per poter poi
essere spenta nell’assoggettamento al dominio unificante. (Flores D’Arcais 2006, 197)
L’universale esige una polizia planetaria (nessuno lo sa meglio di un lettore francese: «Pour adorer
longtemps un théorème, la foi ne suffit pas, il faut encore une police» (Albert Camus, 530). (Flores
D’Arcais 2006, 197)
2.2. gli irrinunciabili: la diversità. «La politica tratta della convivenza e comunanza dei diversi.
Politicamente gli uomini si organizzano in base a determinati tratti comuni essenziali all’interno di
un caos assoluto, oppure da un assoluto caos di differenze.» (Arendt 1993, 5)
«Il punto è che il nostro concetto di libertà, quantomeno nei suoi aspetti politici, è inconcepibile al
di fuori della pluralità, e che la pluralità include non solo differenti stili di vita e di pensiero, ma
differenti principi. Una società universale può significare solo una minaccia alla libertà» (2,208).
(Flores D’Arcais 2006, 224)
2.3. gli irrinunciabili: la libertà e come va intesa: è il senso della politica.
«E per la Arendt (con Aristotele) libero è ciò che è per sé e non per altro”» (Flores D’Arcais 2006,
21). «Lo spazio pubblico è in definitiva il trascendentale sia della libertà che dell’essere-insieme.»
(Flores D’Arcais 2006, 23)
2.3.1. la libertà è un fatto politico; non è una dimensione naturale, ma una dimensione politica; cioè
non garantita come naturale (contro i pregiudizi e le illusioni giusnaturalistiche), né può essere
definita in natura [vedi le tesi di Hobbes], ma diventa la sfida e il luogo del politico. «… si tratta
soltanto di guarire dal moderno pregiudizio che la politica sia una necessità inalienabile e che sia
sempre esistita sempre e dovunque.» (Arendt 1993, 32)
«Aristotele, per il quale il termine politikon era senz’altro un aggettivo dell’organizzazione della
polis e non una generica definizione della convivenza umana, non voleva affatto dire che gli uomini
sono tutti politici, o che la politica, ovvero la polis, esiste ovunque vivano degli esseri umani. Dalla
sua definizione erano esclusi non soltanto gli schiavi ma anche i barbari dei regni asiatici, governati
da despoti, della cui natura umana egli non dubitava in alcun modo. Voleva solo dire che è una
particolarità dell’uomo poter vivere in una polis, e che l’organizzazione della polis rappresenta la
forma più alta di convivenza umana e dunque, in senso specifico, è umana: ugualmente lontana sia
dal divino, il quale può esistere per sé solo in piena libertà e autonomia, che dall’animale, la cui vita
comunitaria, laddove esiste, è una forma di vita necessaria. […]
Se dunque vogliamo intendere il politico in termini di mezzo e fine, nel senso greco come in quello
di Aristotele esso era in primo luogo un fine, non un mezzo. E il fine non era la libertà per
antonomasia, che si realizzava nella polis, ma l’emancipazione prepolitica per la libertà nella polis.
Qui il senso del politico, ma non il suo fine, è che gli uomini comunichino in libertà, al di là di
violenza, coercizione e dominio, come eguali che soltanto in situazioni di emergenza, e cioè in
tempo di guerra, comandavano e obbedivano, ma che altrimenti regolavano ogni faccenda
attraverso il dialogo e la reciproca persuasione.
Il politico, nel senso greco, è dunque incentrato sulla libertà; una libertà intesa in negativo come
non-essere-dominati e non-dominare, e, in positivo, come uno spazio che può essere creato solo da
molti e nel quale ognuno si muove tra suoi pari. Senza questi altri, che sono miei pari, non esiste
libertà; per questo chi domina sugli altri, e dunque per principio è diverso dagli altri, è certo più
felice e invidiabile di quelli sui quali domina, ma non è affatto più libero. Anche lui si muove in uno
spazio in cui la libertà non esiste. Per noi questo è di difficile comprensione, poiché con la parità
colleghiamo il concetto di giustizia e non quello di libertà, e in tal modo interpretiamo il termine
greco per una libera costituzione, la isonomia, secondo la nostra idea di parità davanti alla legge.
Ma isonomia non significa né che tutti sono uguali davanti alla legge, né che la legge è uguale per
tutti; ma solo che tutti hanno pari diritto all’attività politica, che nella polis era prevalentemente
8
un’attività dialogica. Isonomia significa dunque prevalentemente libertà di parola, e in quanto tale
equivale a isegoria; più tardi, Polibio le definisce entrambe semplicemente isologia.» (Arendt 1993,
28-30 passim) [vedi parresia in Foucault]
2.4. gli irrinunciabili: il dialogo, il diritto di parola, e il suo ruolo
2.4.1. La centralità della libertà e la sua accezione in termini di parresia (che non è la parola usata
da Arendt, ma emerge come una sua tesi esplicita: vedi p. 36-37) diventano un fatto eminentemente
politico soprattutto anche quando si considera come essi si impongano dapprima affiancando poi
subordinando a sé, nei modelli politici del mondo greco, comportamenti che sembrano, almeno
biologicamente, rivendicare per sé una priorità di ampiezza e di carattere naturale. Non sono politici
di per sé o in primo piano, il coraggio, la forza, il rischio, la dedizione a una causa (assoluta) o quei
valori della morale omerica che sembrano miticamente costituire la nascita e la definizione del
politico (ma anche lì del resto e significativamente, come fa notare Arendt, non sono mai separate
dal logos, da un discorso dell’eroe, anzi sarebbero prive di significato e di efficacia, addirittura di
azione e di avvio, senza quelle parole). Questi sono tratti che appartengono più alla animalità
dell’uomo, alla sua espressione biologica, più che alla sua specifica natura di relazione etica sociale,
razionale ed emotiva. Lo specifico della polis è la parità nel rapporto dialogico (la parresia) (inteso,
tale rapporto, anche in senso aristocratico, riservato a coloro che si considerano pari tra di loro, ad
esclusione di donne, schiavi, stranieri … quindi parresia in regime aristocratico). Coraggio, forza,
valore non sono certo virtù escluse, sono virtù etiche, ma nell’obiettivo e nel fine della libertà
umana sociale, non libertà animale apolitica asociale, comunque isolata e solitaria propria o di dio o
di una bestia (come ricordava Aristotele).
«Certo è del tutto naturale che in questo spazio propriamente politico il concetto di libertà si vada
modificando; il significato dell’impresa e dell’avventura passa sempre più in secondo piano, e ciò
che in quelle avventure era per così dire solo un accessorio necessario, la costante presenza degli
altri, la comunicazione tra uguali nello spazio pubblico della agora, quella che Erodoto chiama
isegoria, diventa l’effettivo contenuto dell’essere-liberi. Al contempo, l’attività più importante per
l’essere-liberi si sposta dall’agire al parlare, dal libero atto al libero discorso.
Questo spostamento è di grande peso, e più ancora che nella stessa storia della Grecia si afferma
nella tradizione del nostro concetto di libertà, dove vige l’idea che agire e parlare siano per
principio distinti l’uno dall’altro e che vi corrispondano per così dire due facoltà umane del tutto
diverse. Infatti, una delle realtà più singolari e stimolanti del pensiero greco è proprio che fin
dall’inizio, e cioè già in Omero, non vi compare una siffatta distinzione di principio tra parlare e
agire; chi compie grandi gesta deve sempre proferire anche grandi parole, e non solo perché le
grandi parole devono accompagnare a mo’ di spiegazione le grandi gesta, che altrimenti, mute,
cadrebbero nell’oblio, ma perché lo stesso parlare era considerato a priori un modo di agire.
L’uomo non può difendersi dai colpi del fato, dai tiri degli dei, ma può affrontarli e contestarli con
la parola, e per quanto contestarli non serva a niente, né a scongiurare la sfortuna né ad attirare la
fortuna, pure le parole appartengono al processo in quanto tale; se le parole sono alla pari con il
processo, se le «parole grandi», come ci dice il finale di Antigone «rispondono, contraccambiando,
ai colpi di quelli dalle spalle potenti [gli dei]», allora ciò che avviene è grande e degno di un
glorioso ricordo. Che in questo senso il parlare sia una sorta di azione, che la rovina possa
trasformarsi in un atto se nella rovina le si scagliano contro parole, su questo assunto si fonda la
tragedia greca e il suo dramma, il suo «agito».
Proprio questo concetto del parlare, che sta alla base anche della scoperta della forza autonoma del
logos da parte della filosofia greca, passa in secondo piano già nell’esperienza della polis, per poi
sparire del tutto dalla tradizione del pensiero politico. La libertà di opinione, il diritto di ascoltare le
opinioni altrui e di essere ascoltati, che costituisce anche per noi una componente inalienabile della
libertà politica, ha ben presto soppiantato quell’altra libertà, che pur senza contrastarla è di natura
così diversa, propria dell’agire e del parlare inteso come azione. Questa libertà consiste in ciò che
chiamiamo spontaneità, e che per Kant si basa sulla facoltà di ogni uomo di iniziare una nuova serie
9
partendo da se stesso. All’interno della sfera politica greca, l’equivalenza tra la libertà di agire e il
sancire-un-inizio-e-cominciare-qualcosa è illustrata al meglio dalla parola archein, che significa sia
cominciare che dominare.» (Arendt 1993, 36-37)
2.4.2. le ragioni antropologiche, oltre che sociali, del dialogare.
«Determinante non è però, oggi come allora, che ognuno possa dire tutto ciò che gli pare, o che
ogni uomo abbia l’innato diritto di esprimere se stesso così come è. Qui si tratta piuttosto
dell’esperienza per cui nessuno, da solo e senza compagni, può comprendere adeguatamente e nella
sua piena realtà tutto ciò che è obiettivo, in quanto gli si mostra e gli si rivela sempre in un’unica
prospettiva, conforme e intrinseca alla sua posizione nel mondo. Se egli vuole vedere ed esperire il
mondo così come è «realmente», può farlo solo considerandolo una cosa che è comune a molti, che
sta tra loro, che li separa e unisce, che si mostra a ognuno in modo diverso, e dunque diviene
comprensibile solo se molti ne parlano insieme e si scambiano e confrontano le loro opinioni e
prospettive. Soltanto nella libertà di dialogare il mondo appare quello di cui si parla, nella sua
obiettività visibile da ogni lato. Vivere in un mondo reale e parlarne insieme agli altri sono in fondo
una cosa sola, e ai greci la vita privata appariva «idiota» [nel senso di Eraclito] perché le era negata
quella pluralità del discorrere di qualcosa, e con essa l’esperienza della realtà del mondo.
Questa libertà di movimento, che si tratti della libertà di andarsene e di iniziare qualcosa di nuovo e
di inaudito, oppure della libertà di comunicare con i molti e di esperire quella pluralità complessiva
che è il mondo, non era né è in alcun modo il fine della politica, ciò che si può ottenere con mezzi
politici, ma è piuttosto l’effettivo contenuto e il senso del politico in sé. In questo senso politica e
libertà sono identiche, e ovunque manchi questo tipo di libertà non esiste neppure uno spazio
propriamente politico. (Arendt 1993, 39-40)
2.4.3. in conclusione, alcune conferme: 1. quindi la situazione politica non è una necessità naturale,
ma una condizione antropologica etico-sociale; non è a caso, del resto, che Aristotele la inserisca,
come a sua fondazione nel campo dell’etica, dove è prevista l’azione in vista di un fine, dove è
necessaria la scelta (del mezzo per il fine), e quindi la libertà, e dove è, in definitiva, l’intero quadro
delle virtù a determinarne la possibilità: a. le virtù dianoetiche chiamate a raccolta nella saggezza
che è l’arte della loro gestione quando esse, virtù dianoetiche, si rapportano all’esterno, al sociale e
entrano in comunicazione o in relazione, b. le virtù etiche che definiscono i volti e i modi sociali
efficaci dell’agire; 2. quindi non è politica la situazione nella quale si chiede il sacrificio della
libertà, o totale o parziale, per ideali o scopi che nulla abbiano a che vedere con la libertà stessa
intesa nella densità della parresia e dell’azione come viene intesa nel testo di Arendt.
2.5. gli irrinunciabili: la contingenza, la possibilità e la realtà
«Perciò è chiaro che tre sono i termini di cui deve tener conto l’educazione: il giusto mezzo, il
possibile, il conveniente (méson, dunatòn, prépon).» (Aristotele, Politica 1342a33-34)
2.5.1. il primo dato. Come tutto ciò che è vivente e naturale, così l’uomo e la politica cadono nella
sfera del contingente, delle cose che possono essere altrimenti (non di ciò che è necessario), come
da dottrina di Aristotele; quindi è contesto in cui l’azione può esercitare modifiche. «Parlare in
termini di “essenza” significa infatti, per Hannah Arendt, avere già smesso di pensare. Significa
avere già rinunciato alla categoria ineludibile per pensare le vicende umane, la categoria della
contingenza.» (Flores D’Arcais 2006, 19) Il contingente è quindi contesto di politica, ed è strategia
politica anche il tentativo di negare l’esistente (ciò che domina, il criterio del conforme, la sua
presentazione come essenza) per far sì che esso possa venir modificato. In generale,
l’immaginazione è lo strumento attraverso cui chi agisce “nega l’esistente”, ossia è la facoltà
mentale che ci rende in grado di “far posto” nella mente a qualcosa che prima non c’era. Qui è in
gioco l’iniziativa dell’immaginazione e in generale della mente, il pensiero e le idee come inizio
proprio dell’uomo. Nelle situazioni complesse infatti si impone il gioco continuo di rimando tra
concretezza e idealità; come sottolinea la metodologia delle scienze storico-sociali (o delle scienze
in generale) sottolineata dalla Scuola di Francoforte. «Adorno lo dice chiaramente. C’è una
sproporzione per così dire nel senso forte del termine, tra ciò che ogni disciplina (storia, scienza
10
politica, economia, psicologia clinica...) ha di parziale e il peso dell’oggetto delle cui modalità di
apparizione bisogna rendere conto. Spiegare il sistema nazista con la sola sociologia, con la sola
economia o con la sola psicologia clinica sarebbe una mistificazione. Per Adorno doveva esserci
alla radice qualcosa di più fondamentale e, se così si può dire, di invariante. «Qualcosa» che, in
quanto tale, non dipende né dagli uomini nè dai tempi né dai luoghi. [quindi] Un perenne
andirivieni tra fatti e concetti. Si attiva così un andirivieni tra la considerazione di dati sociali
pesanti e la creazione concettuale. Un va’ e vieni che è probabilmente il nerbo di ogni ricerca sugli
atteggiamenti, i comportamenti e i sistemi dotati di forte carica ideologica. […] In ultima analisi è il
problema fondamentale con cui si scontra ogni tentativo di approccio scientifico (nel senso forte del
termine) a dati sociali complessi. […] Non sfugge loro [Adorno e collaboratori] che i diversi
approcci “specializzati” disponibili (approccio storico, economico, politico, clinico…) non possono
darne conto proprio per la loro natura parziale e frammentaria.» (Deconchy Jean-Pierre, Dru
Vincent 2007, 21,22,23) Ed è questa la contingenza tradotta in regola di metodo, in doppia regola di
metodo: 1. andirivieni tra fatti e concetti; 2. convergenza di diverse specializzazioni.
2.5.2. il secondo dato. Per contro, però, la politica ha anche a che fare con la fattualità, con
l’accadere concreto e materiale: il mondo, i dati di fatto.
2.5.2.1. la tesi, che deve essere considerata postulato della riflessione di Arendt è che l’elemento
“comune” delle relazioni umane, luogo dell’incontro, non è l’umanità (idea astratta, illuministica,
kantiana…) ma il mondo; è questo il luogo della condivisione, cura, responsabilità e quindi
dell’umanità (che altrimenti si chiuderebbe su se stessa o risulta comunque astratta se non
inesistente). «Una delle tesi fondamentali dell’antropologia filosofica arendtiana è infatti che gli
uomini sono costitutivamente mondani.» (Arendt 1994, Antologia, XVII introduz. Paolo Costa)
E Arendt: « L’umanità può essere raggiunta solo da chi ha esposto la propria vita e la propria
persona ‘al rischio della sfera pubblica’» (Arendt 1994, Antologia 24)
2.5.2.2. I dati di fatto, una volta accaduti, non possono essere facilmente eliminati, negati,
cancellati. «Se qualcuno è un essere pensante, radicato nei propri pensieri e ricordi e per cui sa che
deve vivere con se stesso, ci saranno limiti a ciò che permetterà a se stesso di fare. E questi limiti
non gli si imporranno dall’esterno ma saranno per così dire autoposti [selfset]; questi limiti possono
certo cambiare da persona a persona, da paese a paese, da secolo a secolo. Ma il male estremo e
senza limiti è possibile soltanto dove queste radici sono completamente assenti. Ed esse sono
assenti ovunque gli uomini scivolano sulla superficie degli eventi, dove consentono a loro stessi di
volgere lo sguardo senza penetrare nella profondità di cui potrebbero essere capaci». [Arendt, Some
questions of Moral Philosophy] (Arendt 1951, pref. S. Forti p. L-LI)
2.5.3. il legame tra i due dati. La politica si muove fra una fragile contingenza e una ostinata
fattualità. Ciò che sta in mezzo a questi due poli è la possibilità, la potenzialità, la facoltà di
cambiare le cose insita nell’umana facoltà di agire.
L’agire umano solo come interazione, nella collettiva facoltà di iniziare qualcosa di nuovo, è la vera
fonte del potere. La politica è quindi un “agire di concerto” che modifica l’esistente non attraverso
la forza, la coercizione, ma grazie ad un combinarsi plurale di singolarità umane.
L’imprevedibilità dell’azione ha a che fare con un inizio, con un cominciamento che è radicale,
inaspettato nella misura in cui nega l’esistente ed è mosso da un impeto trasformativo radicato nella
natalità. Ma diverse sono le modalità con cui un agire (politico) nega l’esistente; bisogna
distinguere tra:
2.5.3.1. un cominciamento rivoluzionario: la radicale negazione dell’esistente al fine di costruire un
novus ordo sæculorum [prospettiva ripresa in proposta politica],
2.5.3.2. la contraffazione totale della realtà fattuale operata per la prima volta nella storia umana dai
regimi totalitari del XX secolo [prospettiva ripresa in analisi del luogo storico del pensare].
Il rapporto tra menzogna e politica, quindi, può essere utile e "fisiologico" nella misura in cui la
menzogna è saltuaria, volta a coprire un aspetto, una porzione di quella realtà politica la cui
contingenza è, per sua natura, inoccultabile quanto incontrollabile. Tale rapporto diventa invece
11
patologico quando la menzogna mira a sostituire sistematicamente la realtà, e la contingenza viene
rimpiazzata da una implausibile coerenza.
2.6. un bilancio iniziale sull’onda dei postulati.
Lungi dal ritenere che la politica debba di necessità essere "onesta", "vera" e "buona", Arendt
afferma che essa è innanzitutto l'intreccio complesso - irriducibile ad un criterio ordinativo
comprensivo - di una pluralità di agenti, liberi ciascuno di cominciare qualcosa di nuovo. Ancora
una volta, Arendt ci appare più machiavelliana di quanto lei stessa avrebbe mai ammesso: se di
bontà o di verità si deve parlare, in ambito politico, queste qualità hanno a che fare non con criteri
di natura morale o logica (su questo più avanti), bensì con un tessuto plurale di volontà, di
intenzioni, di desideri che dipende, costitutivamente, da accordi temporanei, da quell'«agire di
concerto» che Arendt ritiene essere l'unica via efficace alla realizzazione di sé. «Non l'uomo, ma gli
uomini abitano la terra» afferma la Nostra, intendendo con ciò criticare la fictio filosofica dell’Uno,
e quella politica dell'individuo. La verità della politica è dunque la sua pluralità, e riguarda il fatto
che essa non può essere sottoposta a quella reductio ad unum di cui spesso la filosofia
(politicamente) si serve per semplificare le differenze. Ne consegue che la virtù propria della sfera
politica concerne l’essenziale rispetto per tale pluralità e contingenza.
Contro la necessità (storica) come negazione dell’uomo e della politica o il meccanismo della
necessità e la negazione della politica; a proposito di Il processo di Kafka.
«Cominciamo dal romanzo Il processo, su cui sono state scritte talmente tante interpretazioni da
riempire una piccola biblioteca. É la storia di un uomo processato sulla base di leggi che gli sono
sconosciute e che alla fine viene giustiziato senza che riesca i a capirne la ragione. […]
La forza del meccanismo di cui cade vittima K. nel Processo sta precisamente, da un lato, in questa
apparente necessità e, dall’altro, nell’ammirazione delle persone per la necessità. Mentire per amore
della necessità appare come qualcosa di sublime, e un uomo che non si sottomette al meccanismo,
anche se la sua sottomissione può significare la sua motte, viene visto come uno che pecca contro
una sorta di ordine divino. Nel caso di K. la sottomissione é ottenuta non con la forza, ma
semplicemente accrescendo il sentimento di colpa che l'accusa infondata suscita nell’imputato.
Ovviamente questo sentimento si basa, in ultima istanza, sul fatto che nessun uomo è totalmente
esente da colpe; e poiché K., un indaffarato impiegato di banca, non ha mai avuto il tempo per
riflettere su questioni cosi astratte, viene spinto a esplorare certe regioni sconosciute del suo io, e
ciò, a sua volta, accresce la sua confusione e lo induce a scambiare il male del mondo,
diabolicamente orchestrato, che lo circonda per un’espressione necessaria di quella generica colpa
che é inoffensiva e quasi innocente se paragonata alla perfidia che eleva la “menzogna a principio
universale" e usa e abusa anche della giustificata umiltà umana.
Perciò il sentimento di colpa che si impadronisce di K., e che dà inizio, di per sé, a uno sviluppo
interiore, trasforma e modella la sua vittima fino a renderla idonea al processo. É proprio questo
sentimento che gli consente di accedere al mondo della necessità, dell’ingiustizia e della menzogna,
di assolvere un ruolo conforme alle regole, di adattarsi alle condizioni esistenti. […]
Una caratteristica peculiare del nostro secolo, così ricco di coscienza storica, è che i suoi crimini
peggiori sono stati commessi nel nome di una qualche necessità, o nel nome — che é poi lo stesso
— della “forza del progresso”. Di individui che si sottomettono a tutto ciò, che rinunciano cioé alla
loro libertà e al loro diritto di agire, anche se la morte può essere il prezzo della loro illusione,
difficilmente si potrebbe dire qualcosa di più indulgente delle parole con cui Kafka conclude Il
processo: "Era come se la vergogna dovesse sopravvivergli". […]
Per gli abitanti del villaggio K. è strano non tanto perché sia stato privato degli aspetti essenziali
dell’esistenza, ma perché li rivendica.» Arendt Hannah 1994, Antologia. Pensiero, azione e critica
nell’epoca dei totalitarismi, Feltrinelli, Milano 2006,27,28, 30. [ricorda: la caverna platonica; la
reazione dei “prigionieri” nei confronti del filosofo – liberatore di ritorno dal mondo della luce]
12
3. Che cos’è la politica? nella storia, non in generale, ma nella storia contemporanea
(la realtà, la concretezza della situazione)
La domanda si pone non in astratto ma a partire dalle vicende della storia contemporanea.
Vale in particolare per Arendt una convinzione dei pensatori politici del ‘900 (in particolare
Gramsci, Adorno, la Scuola di Francoforte…): «Di fronte a un fatto storico “totale” come la politica
disumana del nazismo, volta al dominio dell’intera umanità, è necessario impegnarsi in uno sforzo
di comprensione non banale» Deconchy Jean-Pierre, Dru Vincent 2007, L’autoritarismo, il
Mulino, Bologna 2011, presentazione di Augusto Palmonari,p.7-8)
Vale il metodo di Aristotele: «Infatti non bisogna solo cercare la costituzione assolutamente
migliore, ma anche quella che può essere realizzata e, di seguito, la più facile da realizzarsi e la più
comune.» (Aristotele, Politica, 1288b37-39)
«Alla questione del senso della politica si può dare una risposta così semplice e convincente, da
rendere in apparenza del tutto superflue ulteriori risposte. La risposta è: il senso della politica è la
libertà. La sua semplicità e la sua concludenza derivano dal fatto di essere contemporanea, se non
della domanda che naturalmente nasce già da un dubbio ed è ispirata da una diffidenza, per lo meno
dell’esistenza del politico. Ma oggi proprio questa risposta non è né ovvia né immediatamente
evidente, come dimostra già il fatto che la nostra domanda odierna non si interroga più
semplicemente sul senso della politica, come in passato ci si interrogava in sostanza muovendo da
esperienze di natura non politica, o addirittura antipolitica. La nostra domanda odierna nasce da
esperienze politiche molto reali: essa è suscitata dalle sciagure che la politica ha già provocato nel
nostro secolo, e da quelle ancora più grandi che rischiano di scaturirne. La nostra domanda è
dunque molto più radicale, molto più aggressiva, e anche molto più disperata: la politica ha ancora
un senso? Dalla questione così posta - ed è così che deve porsi per chiunque - traspaiono due
fattori: in primo luogo l’esperienza dei regimi totalitari, che pretendevano di politicizzare appunto
totalmente l’intera esistenza degli uomini; con il risultato che lì la libertà cessa di esistere. In
quest’ottica, e dunque tra l’altro partendo da circostanze che sono specificamente moderne, sorge il
dubbio se politica e libertà siano compatibili, se la libertà non cominci proprio dove termina la
politica, per cui per l’appunto la libertà non esiste più laddove al politico non è posto alcun termine
o confine. Forse, rispetto all’antichità dove politica e libertà erano identiche, le cose sono cambiate
al punto che nelle circostanze attuali bisogna scinderle completamente l’una dall’altra.
In secondo luogo la domanda è inevitabile se si considera l’enorme sviluppo dei moderni strumenti
di distruzione [e, in aggiunta non di Arendt, di distrazione] il cui monopolio è detenuto dagli stati,
che senza quel monopolio statale non avrebbero mai raggiunto una tale espansione e il cui impiego
è possibile solo nell’ambito della sfera politica. Qui è in gioco non soltanto la libertà ma la vita, la
sopravvivenza dell’umanità e forse di ogni forma di vita organica sulla terra. La questione che ne
deriva rende discutibile tutta la politica; essa mette in dubbio che nelle circostanze attuali la politica
sia compatibile con la conservazione della vita, e spera in cuor suo che gli uomini si ravvedano ed
eliminino in qualche modo la politica prima che la politica elimini tutti loro.» (Arendt 1993, 21-22)
La concretezza della storia contemporanea cui Arendt sempre si ispira può essere richiamata con
riferimento a due eventi del ‘900 di cui Arendt specificamente si occupa: 1. il totalitarismo nelle
forme che assume tra le due guerre, in particolare il nazismo e il progetto di sterminio degli ebrei,
2. l’impegno militare totale degli Stati Uniti nella logica di un mondo ideologicamente bipolare e
opposto. È un terreno di riferimento in cui le domande (la domanda assillante e centrale) di Arendt
“che cos’è la politica” prendono senso, assumono forma di una presenza etica, rispondono alla
decisione di impedire alla cultura (e agli intellettuali) di essere collaterali alla politica, avallandone
di fatto (magari inconsapevolmente) la direzione, in forza della scelta di dedicarsi al pensiero puro,
avviando una riflessione filosofica astratta e pura che non si accorge (come accade al maestro
Heidegger o chiude gli occhi per non vedere) del proprio stare accanto, dentro e al servizio di una
non-politica, cioè dell’oppressione e della violenza. 3. A chiarificazione del senso e della funzione
13
politica delle tesi di Arendt è forse bene ragionare, a partire da esse, su di un terzo evento (cui
Arendt non ha potuto assistere, muore nel 1975) che ha segnato radicalmente il ‘900 e
rappresenterebbe emblematicamente per molti (a partire da Hobsbawm) la sua fine, la fine del
“secolo breve” (1914-1989): il collasso dei comunismi in Europa e la fine dell’URSS.
3.1. il totalitarismo non è un modello politico, non è politica
Il riferimento va all’opera forse più nota di Hannah Arendt 1951 Le origini del totalitarismo
(Einaudi, Torino, 2004; con introduzione di Simona Forti, Le figure del male)
«Il fascismo nelle democrazie liberali È noto come per la Arendt il totalitarismo costituisca l’evento
assoluto del XX secolo, la tragica e inattesa “creazione” con cui ha contribuito agli orrori della
storia. In una parola: il problema cruciale di un’intera epoca. Non si capisce il culmine della
modernità se non si capisce il totalitarismo e la sua novità, il suo carattere assolutamente
imprevedibile (perché, come tutti gli eventi della storia, essenzialmente contingente). La grande
opera che la Arendt dedica a questo tema esce nel 1951, ma è già completata nell’autunno del ‘49, e
sedimentata negli anni della guerra e ancor prima nelle riflessioni sulla “resistibile” ascesa del
nazismo. Ma, sottolinea la Arendt, «sino alla fine della seconda guerra mondiale, e anche durante i
primi anni del dopoguerra, la parola chiave per definire il male politico era “imperialismo”» (2, 84)
e non “totalitarismo”. Eppure si sapeva ormai quasi tutto di Auschwitz e della Shoah, e si era svolto
e concluso il processo di Norimberga contro i gerarchi nazisti per «crimini contro l’umanità”.»
(Flores D’Arcais 2006, 198-199)
«Certo non possono bastare le ricostruzioni fattuali, così come non può trasformarsi in alibi per il
silenzio, e di conseguenza per l’oblio, l’indicibilità di “Auschwitz”. Hannah Arendt si è assunta
questo difficile compito, impegnandosi nella comprensione di questo secolo anche quando ciò le ha
procurato l’isolamento dai suoi stessi amici. Il totalitarismo ne ha fatto un’esule, in qualche modo
una sopravvissuta, che ha cercato di pagare il suo debito per essere rimasta in vita attraverso
l’instancabile tentativo di far parlare l’orrore muto di Auschwitz. Tutta la sua opera io credo,
compresa The Life of Mind, può essere letta come lo sforzo costante, tanto necessario quanto
impossibile, di dare un nome al male che ha segnato il Novecento. […] Le origini dell’evento
catastrofico diventano per lei una sorta di ossessione teorica: esse vanno ricercate tanto da una
prospettiva storico-politica quanto da un punto di vista filosofico ed etico. L’opera del ‘51 si muove
contemporaneamente su questi diversi livelli. Anche per questo essa ha suscitato durissime
polemiche ed è stata oggetto di una ricezione distorta; ma forse proprio per questa ragione è
diventata “il classico” da cui nessuna riflessione sull’argomento può esulare.» (Arendt 1951,
introduzione di Forti Simona XXVII, XXVIII)
3.1.1. Le domande e la tesi finale e di fondo. Le domande si collocano al centro dell’esperienza dei
totalitarismi del ‘900: se il totalitarismo sia una degenerazione delle tradizionali forme politiche
precedenti, se invece abbia una propria natura e debba venire annoverato tra le forme di governo
che la tradizione storica dei modelli politici definisce e cataloga; questione che si definisce
attraverso la ricostruzione della logica totalitaria che abbina il massimo della legge e
dell’inquadramento sociale fino a immaginare un ordine nuovo e totale per l’umanità, per l’Uomo,
con il massimo della violenza; la paura e il terrore sono principio e logica dell’agire, fino all’unione
di legge e terrore in reciproca giustificazione.
La concezione della politica che Arendt presenta si traduce nella tesi che il totalitarismo, la
tirannide nel senso moderno (non greco), nella varietà dei modi in cui si presenta (nazismo,
fascismo, stalinismo), non è una forma politica. Arendt non la annovera tra le forme o i modelli di
politica ma la considera la negazione della politica; «Sullo sfondo, negativa per tutti, sta la
tirannide, che la filosofia non ha mai riconosciuto come forma di governo.» (Arendt 1993, 136-137
Ludz); è la più compiuta negazione della politica nell’età contemporanea. (Flores D’Arcais 2006,
214) La “volontà di potenza” per Arendt non costituisce affatto politica, perché oppressione anziché
libertà.
Sorprendente al riguardo il ricordo della affermazione di Aristotele: «Sembra che i più considerino
il dominio dispotico come una forma politica e nessuno si vergogna di fare nei confronti degli altri
14
ciò che nei propri riguardi proclama né giusto né utile. Vanno in cerca di un governo giusto per se
stessi, ma nelle relazioni con gli altri non si curano affatto della giustizia.» (Aristotele, Politica
1324b32-36)
A commento le affermazioni di A. Touraine: «Un regime totalitario non è dunque retto da uno stato
forte, ma da uno stato debole, assoggettato a un partito, a un capo supremo e a un apparato. Esso
distrugge, nel medesimo tempo, il popolo, a cui confisca la parola, e lo Stato, di cui rimpiazza
l’amministrazione pubblica con una clientela.» (Touraine Alain 1997 Libertà, uguaglianza,
diversità. Si può vivere insieme?,il Saggiatore, Milano 1998, 234-235)
In breve sintesi, in tre (e più) modi il totalitarismo si presenta come la negazione della politica:
modo 1. per l’uso della forza e della violenza: interpreta il potere come violenza. Per Arendt la
violenza è la negazione del potere politico nella sua specifica essenza. Da un punto di vista storico,
sono esistite epoche che conoscevano il politico e altre cui fu negato di viverlo appieno. Ciò
riguarda in particolare il ventesimo secolo, in cui «lo spazio politico-pubblico era divenuto un luogo
di violenza» (p. 57). Le nostre esperienze con la politica «sono fatte essenzialmente nel campo della
violenza» (p.104). U. Ludz in Arendt 1993 p.125)
modo 2. perché riduce la pluralità degli uomini ad un unico Uomo, un Uomo-Stato (il fascista, il
nazista, il comunista perfetto, alla fine il duce, il Fuhrer …) Di contro il “postulato” più volte
richiamato: «La politica si fonda sul dato della pluralità degli uomini». («Solo gli uomini devono
interessarci quando sono in gioco la politica e il «politico», gli uomini nella loro diversità e nella
loro uguaglianza relativa.» U. Ludz in Arendt 1993 p122)
modo 3. perché proclama la propria forma “imperiale” come un Assoluto, imperituro, un’era eterna
(nei progetti e nei desideri); mentre la politica è per essenza “contingenza”; attenzione alla
concretezza del sociale e del mondo nella sua pluralità (tale è il senso della formula ripetuta: «i
criteri del politico [siano] desunti dalla politica stessa» (Arendt 1993 p. 42; cfr. anche p. 62, e U.
Ludz in Arendt 1993 p.122).
3.1.1.1. Il concetto stesso di biopolitica (se con tale espressione si allude a una implicazione diretta
tra azione politica e determinazione biologica – R. Esposito 2004, 194) e il modo in cui il nazismo
la incarna, pur non presentandosi come tema diretto nella riflessione di Arendt, conferma la sua tesi
sul carattere impolitico del nazismo. «Del resto non sarebbe stato facile afferrarla — penetrare nella
macchina della biopolitica nazista — a partire da una riflessione sulla politica fortemente segnata
dal riferimento alla pòlis greca. Il problema — relativo non solo alla Arendt — è che non si dà
accesso diretto dalla filosofia politica, moderna o premoderna che sia, alla biopolitica. Il nazismo
nella sua essenza biocratica, resta muto per il pensiero politico classico. […] il totalitarismo, in
particolare quello nazista, ha prodotto un’ulteriore chiusura del corpo su se stesso. E ciò attraverso
una duplice mossa: da un lato portando ad assoluta coincidenza l’identità politica con quella
biologico-razziale; dall’altro incorporando nello stesso corpo nazionale la linea di discrimine tra
interno ed esterno, vale a dire tra la porzione di vita da conservare e quella da distruggere. È a
questa traduzione immediata della vita in politica — o dello spirituale nel biologico — che era
funzionalizzato il concetto di corpo politico in antitesi, più ancora che a ciò che gli è esterno, a
quella parte di sé giudicata inidonea a simile conversione bio-spirituale.» (Esposito Roberto 2004
Bìos. Politica e filosofia, Einaudi, Torino, 164, 173) La tesi di Hannah Arendt sul carattere non
politico del totalitarismo nazista deriva cioè dalla definizione di politica quale si è venduta
costituendo dalla tradizione greca, pur nella varietà delle forme di governo; il nazismo, soprattutto
nella sua adozione della biopolitica, si rivela essere tecnica contro la vita, tanatologia.
3.1.1.2. Se vi è relazione tra la concezione moderna della politica e il nazismo si tratta di
svelamento; nessuna fatale necessità né filosofie della storia; si è nei tratti della contingenza della
politica.
Non si tratta di una relazione di causa ed effetto, né un risultato di un disegno storico in progressivo
sviluppo ma, ad una analisi culturale ampia del totalitarismo del ‘900, si coglie una capacità di
trasformare in sistemi di distruzione elementi di ampio spettro, quanto alla potenzialità, già presenti
nella cultura e nella struttura dello Stato moderno. «Anche se il totalitarismo non è iscritto nel
15
codice genetico della filosofia occidentale e non rappresenta il destino a cui la ratio inevitabilmente
conduce, resta pur vero che non viene spiegato dall’autrice soltanto attraverso l’analisi delle sue
componenti storiche e sociali. Il fenomeno totalitario, piuttosto, è dalla Arendt affrontato anche
filosoficamente, per metterne in luce la continuità con una tradizione a cui ha paradossalmente
messo fine. In Ideology and Terror è infatti possibile enucleare quella che potremmo definire una
sorta di «metafisica» del totalitarismo: un insieme di tutti gli elementi lato sensu ideologici che
danno forma alla cosiddetta «mentalità totalitaria». […] La sua [del totalitarismo] «assoluta novità»
non è però riducibile a una «patologia», ma il «disvelamento» di quella verità che la politica e la
filosofia della nostra tradizione tenevano custodita. Sì, perché «lo sterminio è per l’Occidente la
terribile rivelazione della sua essenza». » (Arendt 1951, S. Forti XXXVI, XXXVII)
3.1.2. Direzioni documentabili dell’interesse di Hannah Arendt per lo studio del totalitarismo e per
le tematiche che sarebbero state discusse nella sua Introduzione alla politica, si riscontrano nelle
sue opere fin dall’agosto 1950. … Una lunga comunicazione a Karl Jaspers, scritta dopo l’uscita
della prima edizione americana, ne dà testimonianza. Hannah Arendt scrive il marzo 1951: «Il male
si è dimostrato più radicale del previsto... oppure: la tradizione occidentale soffre del pregiudizio
che il male peggiore che l’uomo possa commettere derivi dai vizi dell’egoismo, mentre noi
sappiamo che il male peggiore ovvero il male radicale non ha più nulla a che fare con simili motivi
peccaminosi concepibili in termini umani. Che cosa sia realmente il male radicale, non lo so, ma mi
sembra che esso abbia in qualche modo a che fare con i seguenti fenomeni: la riduzione di uomini
in quanto uomini a una condizione di superfluità, il che consiste non già nell’utilizzarli come mezzi,
ciò che lascerebbe intatta la loro natura umana e offenderebbe soltanto la loro dignità di uomini, ma
nel renderli superflui in quanto uomini. Ciò avviene non appena si elimina ogni unpredictability,
quella imprevedibilità alla quale corrisponde, negli uomini, la spontaneità. Tutto ciò a sua volta
scaturisce, o meglio è connesso con l’illusione di una onnipotenza (non semplicemente di una
smania di potere) dell’Uomo. Se l’Uomo in quanto uomo fosse onnipotente, allora davvero non si
capirebbe perché debbano esistere gli uomini; esattamente come, nel monoteismo, soltanto
l’onnipotenza di Dio rende Dio UNO. In questo senso, l’onnipotenza dell’uomo rende gli uomini
superflui...» (Arendt 1993, 114-115 Ludz)
3.1.3. L’attenzione al totalitarismo e alla sua logica compare quando Arendt affronta, in più
contesti, il tema della menzogna nella politica e la relazione particolare tra menzogna e
totalitarismo: la contraffazione totale della realtà fattuale è operata con sistematicità e come
progetto completo (senza remore, pudori e vergogna) di ragion di Stato per la prima volta nella
storia umana dai regimi totalitari del XX secolo. Il procedimento consiste nella deliberata volontà di
trattare le verità di fatto - le numerose e dettagliate informazioni che provenivano dal lavoro di
intelligence sul campo - come se fossero opinioni, e come tali trascurabili, o modificabili a proprio
piacimento, al fine di accreditare una teoria che con quei dati di fatto cozzava prepotentemente. …
questo è l'atteggiamento di disprezzo per i fatti, quell'atteggiamento ideologico per il quale «non
avevano bisogno dei fatti né di alcuna informazione; avevano una "teoria" e tutti i dati che non vi si
adattavano venivano ignorati o negati.»
3.1.4. La riflessione sul senso della politica dopo le esperienze dei totalitarismi, considerato che
questi si presentavano come realizzazione dello politica in modo assoluto e nello Stato assoluto, che
il loro obiettivo era quello di “politicizzare appunto totalmente l’intera esistenza degli uomini “, e
questo ha comportato la negazione distruzione della libertà, porta a domande centrali: che ne è della
tesi “il senso della politica è la libertà” e della tesi aristotelica dell’uomo come animale sociale –
politico («animale per natura politico» «zoon politikon” (Etica Nicomachea 1097b11, Politica
1253a2); «Da queste considerazioni è evidente che lo stato è un prodotto naturale e che l’uomo per
natura è un essere socievole: quindi chi vive fuori della comunità statale per natura e non per
qualche caso o è un abietto o è superiore all’uomo … quindi chi non è in grado di entrare nella
comunità o per la sua autosufficienza non ne sente il bisogno, non è parte dello stato, e di
conseguenza è o bestia o dio.» Aristotele, Politica)
16
3.1.5. Prende forma allora la tesi della natura non necessaria della politica, se ne teorizza
l’intrinseca contingenza; anzi solo la consapevolezza della sua contingenza salva la politica dalla
sua degenerazione nei totalitarismi. Viene dunque posta in dubbio la tesi aristotelica dell’uomo “per
natura animale politico”; sul tema la tesi di Arendt è dichiaratamente anti-aristotelica nei confronti
della presentazione dell’uomo come animale politico, o meglio “vivente-politico”… (anche se la
definizione di Aristotele accadeva all’interno di alcuni specifici aspetti dell’antropologia, qui non
richiamati.)
3.1.5.1. In realtà la tesi di Arendt non è anti-aristotelica, sul tema della politica come espressione
naturale della vita dell’uomo. Occorre infatti ricordare quanto osserva Giorgio Agamben a
proposito della terminologia della cultura greca sul tema. «I Greci non avevano un unico termine
per esprimere ciò che noi intendiamo con la parola vita. Essi si servivano di due termini,
semanticamente e morfologicamente distinti, anche se riconducibili a un etimo comune: zoé che
esprimeva il semplice fatto di vivere comune a tutti gli essere viventi (animali, uomini o dei) e bìos,
che indicava la forma o maniera di vivere propria di un singolo o di un gruppo. Quando Platone, nel
Filebo, menziona tre generi di vita e Aristotele, nell’Etica nicomachea, distingue la vita
contemplativa dei filosofo (bios theoreticos) dalla vita di piacere (bios apolausticòs) e dalla vita
politica (bios politicòs), essi non avrebbero mai potuto servirsi del termine zoé (che,
significativamente, in greco manca di plurale) per il semplice fatto che per entrambi non era in
questione in alcun modo la semplice vita naturale, ma una vita qualificata, un particolare modo di
vita. […] parlare di una zoé politiké dei cittadini di Atene non avrebbe avuto senso. Non che il
mondo classico non avesse familiarità con l’idea che la vita naturale, la semplice zoé come tale,
potesse essere in sé un bene. […] La semplice vita naturale è, però esclusa, nel mondo classico,
dalla pòlis in senso proprio e resta saldamente confinata, come meta vita riproduttiva, nell’ambito
dell’oicos (Pol. 1252a, 26-35). All’inizio della sua Politica, Aristotele pone ogni cura nel
distinguere l’oiconòmos (il capo di un’impresa) e il despòtes (il capofamiglia), che si occupano
della riproduzione della vita e della sua sussistenza, dal politico e schernisce coloro che
immaginano che la differenza fra di essi sia di quantità e non di specie. E quando, in un passo che
doveva restare canonico per la tradizione politica dell’Occidente (1252b, 30), egli definisce il fine
della perfetta comunità, lo fa proprio opponendo il semplice fatto di vivere (to zen) alla vita
politicamente qualificata (to eu zen): «nata in vista del vivere, ma esistente essenzialmente in vista
del vivere bene» (nella traduzione latina di Guglielmo di Moerbeke, che tanto Tommaso che
Marsilio da Padova avevano davanti agli occhi: facta quidem igitur vivendi gratia, existens autem
gratia bene vivendi).» Agamben Giorgio 1995 Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita,
Einaudi, Torino.
3.1.5.2. in conclusione: nel sistema totalitario nazista, fondato sulla invenzione della razza come
base di accesso alla cittadinanza e alla politica, l’animalità (la zoé), la nuda vita, ha assorbito in sé
la polis (il bìos). La cultura e l’etica sono bandite dalla polis e persistono nell’oikos (i gerarchi
nazisti si presentano come buoni, premurosi padri di famiglia), l’animalità si è fatta legge (solo se
sei ariano allora sei cittadino) o meglio ha sancito l’assenza della legge e del suo ruolo (l’eu zen). Si
è attuato un totale ribaltamento del pensiero politico classico, che persiste solo, oggi, per segnalare
la tragica distruzione dell’umanità che quel ribaltamento ha provocato. Avvertiva infatti Aristotele:
«Infatti l’uomo che, se ha realizzato i suoi fini naturali, è il migliore degli animali, quando non ha
né leggi né giustizia è il peggiore.» (Aristotele, Politica 1253a32-33)
3.2. La logica dell’impegno degli Stati Uniti a “contenimento del comunismo” in un mondo
dichiarato ideologicamente bipolare e in opposizione interna.
Il riferimento va in particolare agli studi di Hanna Arendt: Arendt Hannah 1967 Verità e politica,
Bollati Boringhieri, Torino 2004; Arendt Hannah 1972 La menzogna in politica. Riflessioni sui
“Pentagon Papers”, prefazione di Olivia Guaraldo, La verità della politica, ed. Marietti 1820,
Genova – Milano 2006 (quanto riportato è estratto e sintesi disinvolta e libera di tre apporti: Hannah
Arendt, Olivia Guaraldo, Simona Forti, Spettri della totalità, in Micromega 5 (2003) 198-209).
17
Arendt Hannah 1972 … Politica e menzogna, SugarCo, Milano 1985; e all’opera complessiva di
Cedroni Lorella 2010 Menzogna e potere nella politica occidentale, Le Lettere, Firenze.
«I Pentagon Papers - ovvero il nome con cui la Storia del processo decisionale statunitense sulla
politica in Vietnam in quarantasette volumi (commissionata dal segretario della difesa Roben S.
McNamara nel giugno del 1967 e completata un anno e mezzo dopo) è divenuta familiare fin dal
giugno 1971, quando il "New York Times" pubblicò questo resoconto, top secret e accuratamente
dettagliato, sul ruolo che svolsero gli Stati Uniti in Indocina tra la seconda guerra mondiale e il
maggio del 1968 - raccontano storie diverse e offrono differenti lezioni a lettori irretenti. Alcuni
sostengono di aver compreso solo ora come il Vietnam fosse il "logico" prodotto della Guerra
fredda e dell'ideologia anticomunista, altri, invece, affermano che questa è un'opportunità unica per
comprendere i processi decisionali del governo, ma la maggior parte dei lettori, tuttavia, concordano
che la questione centrale sollevata dai Papers è l'inganno. Ad ogni modo, è abbastanza ovvio che
questa fosse la questione di gran lunga più importante nella mente dei giornalisti che hanno
collazionato i Pentagon Papers per il "New York Times", ed è quantomeno probabile che lo fosse
anche per il gruppo di autori che hanno compilato i quarantasette volumi dello studio originale. Il
celebre vuoto di credibilità che ci ha accompagnato per sei lunghi anni si è improvvisamente
trasformato in un abisso. Le sabbie mobili delle dichiarazioni menzognere di tutti i tipi, volte ad
ingannare gli altri tanto quanto sé stessi, sono in grado di fagocitare qualsiasi lettore tenti di
esaminare questo materiale, il quale, sfortunatamente, ha costituito la struttura portante della
politica interna ed estera degli Stati Uniti per quasi un decennio. A causa della straordinaria
diffusione della pratica della menzogna in politica, ai livelli più alti del governo, e a causa della
concomitante proliferazione di tale pratica a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, tanto
militare che civile, i resoconti fasulli sulle vittime delle missioni "trova e distruggi", i rapporti
falsificati dell'aviazione, compilati solo a cose fatte, le relazioni circa i "progressi" che i subordinati
inviavano a Washington, consapevoli che le loro prestazioni sarebbero state valutate in base alle
loro stesse relazioni, si è facilmente tentati di dimenticare lo sfondo della storia passata - non
proprio una storia di immacolata virtù -, sfondo a partire dal quale gli episodi più recenti vanno visti
e giudicati.
La segretezza - ciò che la diplomazia chiama "discrezione", così come gli arcana imperii, i misteri
del comando - e l'inganno, la menzogna deliberata e la bugia manifesta usati come strumenti
legittimi per l'ottenimento di fini politici, ci hanno accompagnato fin dall'inizio della storia scritta.
La veridicità non è mai stata annoverata tra le virtù politiche, e le menzogne sono sempre state
considerate come strumenti giustificabili nella gestione degli affari politici. Chiunque rifletta su tali
questioni non può che sorprendersi della scarsa attenzione che la nostra tradizione politica e
filosofica ha dedicato ad esse, da un lato in forza della natura dell'azione, dall'altro per la natura
della nostra capacità di negare nel pensiero e nelle parole qualsiasi cosa ci si presenti davanti.
Questa attiva ed aggressiva facoltà è chiaramente diversa dalla passiva disposizione ad essere preda
di errori, illusioni, distorsioni della memoria e di qualsiasi altro fenomeno possa essere imputato
alle carenze del nostro apparato sensitivo e mentale.»
3.2.1. Menzogna e disprezzo dei fatti. Arendt interviene sulla questione dell'uso politico della
menzogna, sostenendo che ciò che emerge dalle carte segrete dei Pentagon Papers non è
semplicemente la segretezza richiesta ad ogni potere politico per certe operazioni delicate (secondo
l'antica tradizione degli arcana imperii). Ciò che l'autrice sottolinea, invece, è la deliberata - e
ribadita, questo il carattere scandaloso, a suo avviso, del documento - volontà, da parte degli esperti
a capo degli uffici strategici di Washington, di trascurare, se non addirittura disprezzare i fatti.
3.3. note sul ruolo storico – politico della menzogna (aspetti comuni nei due casi storici
studiati: totalitarismo, “imperialismo”)
3.3.1. una distinzione e una differenza di fondo: la verità della politica e la verità della logica.
«La verità della politica è quindi radicalmente diversa dalla verità della logica: la prima si
costruisce nella pluralità di prospettive, la seconda sulla rigorosa unitarietà del procedere
18
argomentativo. Nella misura in cui tale modo di procedere nel ragionamento è riservato alla scienza
o alla matematica, esso non costituisce problema. I problemi cominciano quando questo "amore per
la teoria" si diffonde tra gli uomini d'azione, i quali, a differenza degli scienziati, si muovono in una
sfera contingente e modificabile. Grande è la tentazione di applicare la teoria, che, nella sua
purezza, fa tornare i conti, ad una realtà dove i conti non tornano mai. Grande è la tentazione di
governare non secondo prudenza ma secondo scienza. Non è forse questa la grande invenzione
hobbesiana della modernità politica come qualcosa di plasmabile more geometrico?» (Arendt 1972
La menzogna in politica, Guaraldo)
Per affiancare e valorizzare la distinzione di logica e di metodo che Arendt propone, è il caso di
ricordare, dalla tradizione di Aristotele, la distinzione tra tre metodi dimostrativi, apodittico,
dialettico, analogico (o le diverse ragioni come metodo), e la distinzione tra tre tipologie di scienze,
teoretiche, pratiche, poietiche. Quando indica i propri irrinunciabili la politica si trova in situazione
apodittica, come accade per lo più alle scienze teoretiche; quando si confronta con situazioni reali la
politica procede con metodo dialettico, come accade nelle scienze pratiche, quando privilegia
nascita e inizi a sostenere la libertà, la pluralità e la diversità la politica procede soprattutto
analogicamente, come accade per lo più alle scienze poietiche.
3.3.1.1. Arendt, in The Origins of Totalitarianism, ci ricorda spesso come l'abominio totalitario
consistesse nel rendere reali, attraverso il terrore, le costruzioni ideologiche la cui capacità
persuasiva si basava interamente su un rozzo ragionamento logico fondato sulla mera
consequenzialità di causa ed effetto. La realtà fittizia fabbricata dai regimi totalitari seguendo
ciecamente i dettami dell'ideologia - i cui contenuti erano sempre mutevoli, non però le modalità
rigide di inferenza logica - nulla ha a che fare con
3.3.1.2. la frivola preoccupazione da Madison Avenue degli esperti del Pentagono, ossia l’immagine
dell'America, la sua reputazione. Gli stessi obbiettivi della guerra, in virtù del perseguimento di fini
"interni", di immagine, cambiavano continuamente, sprezzanti verso ogni concreta attuabilità sia
tattica che strategica: dapprima fu proclamato che gli Usa intervenivano per aiutare il popolo
sudvietnamita ad autodeterminarsi, in un secondo tempo l'aiuto al Vietnam del Sud era
essenzialmente in funzione anticomunista, poi arrivò il contenimento della Cina, la volontà di
evitare il tanto temuto "effetto domino", e infine «la necessità di salvaguardare la reputazione
dell'America "in quanto garante nella lotta contro la sovversione"». Sebbene le differenze fra un
regime totalitario e una democrazia di massa siano enormi, e sebbene mai ci fu negli esperti di
Washington la volontà sistematica di annientamento di intere porzioni di umanità, ci pare che in
questo saggio Arendt si sforzi di celare un timore, quello del pericolo di una deriva totalitaria anche
in una democrazia avanzata. Ci pare, insomma, che in esso aleggino, in maniera velata ma
percepibile, quelli che Simona Forti, in un brillante saggio, ha chiamato «spettri della totalità» … Se
vi è un retroterra totalitario comune esso ha a che fare, secondo Arendt, con l'atteggiamento
mentale, con «l'arroganza della mente» che rende superflua la realtà, e con essa le singolarità che la
popolano, in nome di un'idea, acriticamente posta e rozzamente esplicitata in una visione del
mondo. Tuttavia, tale atteggiamento di disprezzo per la realtà, il considerarla superflua, non è
moralmente innocente, anzi. Esso è la premessa che consente di intervenire in maniera violenta
sulla realtà, è ciò che apre la strada all'implementazione violenta dell'ipotesi: alla verità di fatto non
si può che violentemente sostituire la «verità di ragione». … Il modello teorico (l'ideologia
totalitaria, le ipotesi calcolate dei problem solvers) nelle mani degli uomini d'azione, produce
nefasti effetti: la negazione ideale della contingenza della realtà implica la sua violazione materiale.
Ciò che quindi accomuna i differenti tentativi di manipolazione della realtà (come "fatto", nel caso
totalitario, come "immagine" nel caso vietnamita) sono gli effetti politici delle finzioni.
Come detto prima, l'uso politico della menzogna deliberata non è nocivo nella misura in cui esso è
saltuario, ma diviene nefasto quando si fa sistematico, e alla singola menzogna contrappone un
reticolo di menzogne che mira a sostituire la realtà. Se è pur vero che questa sostituzione non riesce
mai completamente da un punto di vista epistemologico, non è detto che essa non riesca
politicamente. Il deliberato disprezzo per la realtà fattuale, in Vietnam, ha portato ad agire come se
19
fosse possibile sostituire alla realtà la finzione delle ipotesi, con le conseguenze che conosciamo.
Sono gli effetti, e non le intenzioni, delle menzogne che, politicamente, siamo chiamati a giudicare.
Le ipotesi trasformate in fatti, i fatti ridotti ad opinioni: questi due movimenti sovvertono quel
tessuto ad un tempo contingente e fattuale che costituisce la realtà politica. …
nota 1. Non diversamente dalle aberranti conseguenze di una implementazione della "logica"
inerente alle ideologie totalitarie - la coerenza di un ragionamento fatto discendere in maniera
stringente da premesse inindagate e date per "vere" - la verità logica su cui si basavano le teorie dei
problem solvers del Pentagono procede per inferenze inattaccabili, incontrovertibili. Il problema, in
questo caso, non sta tanto in un contenuto ideologico forte che sostanzia una premessa da cui il
ragionamento parte (come nel caso dell'ideologia totalitaria, che partiva da premesse del tipo: «Gli
Ebrei sono parassiti», «I proprietari sono nemici di classe»). Esso consiste piuttosto nella deliberata
volontà di trattare le verità di fatto - le numerose e dettagliate informazioni che provenivano dal
lavoro di intelligence sul campo - come se fossero opinioni, e come tali trascurabili, o modificabili a
proprio piacimento, al fine di accreditare una teoria che con quei dati di fatto cozzava
prepotentemente. … questo è l'atteggiamento di disprezzo per i fatti, quell'atteggiamento ideologico
per il quale «non avevano bisogno dei fatti né di alcuna informazione; avevano una "teoria" e tutti i
dati che non vi si adattavano venivano ignorati o negati. »
nota 2. La menzogna, in genere, ha lo scopo di nascondere la verità, di camuffarla, ma presuppone
essa stessa una chiara nozione di cosa è vero e cosa è falso. I problem solvers, invece, avevano
finito per credere ciecamente nelle loro teorie e ipotesi, tanto da perdere completamente la
percezione di quella distinzione. La prima vittima della menzogna deliberata e continuativa, afferma
Arendt, è il bugiardo stesso, che finisce per esser inghiottito dal meccanismo che pretende di
controllare. Ma ben oltre l’autoinganno … è il costante gioco di luci e ombre messo in scena dagli
stessi esperti al fine di rendere impossibile una chiara e netta distinzione fra reale e fittizio, fra dati
di fatto riscontrabili e teorie che spregiudicatamente li trascuravano. L'antitesi politicamente
rilevante, quindi, per Arendt, è quella che oppone realtà e finzione, nella misura in cui il reale è
caotico, irriducibile a schemi probabilistici, a cornici ideologiche onnicomprensive, mentre la
finzione prende le fattezze di una costruzione logicamente coerente in ogni suo aspetto e nulla è
lasciato al caso.
3.3.2. anche la menzogna si presenta con volti diversi. Il tema domina l’opera di Arendt Hannah,
Verità e politica, Torino, Bollati Boringhieri, 1995 (qui ripresa e commentata da Flores D’Arcais
2006)
3.3.2.1. La menzogna degli antichi e dei moderni [sull’onda, credo, del richiamo all’opera di
Benjamin Constant, La libertà degli antichi e la libertà dei moderni]
Ad Arendt «interessa, invece, mettere in chiaro la differenza di qualità fra la “menzogna degli
antichi” e la “menzogna dei moderni”. [1] Nel passato “mentire” vale soprattutto come nascondere,
evitare che tutta la verità appaia. E la diplomazia, più che menzogna, è mise. La “virtù” dell’astuto
Ulisse, insomma. [è utile qui richiamare il ruolo di medicina che Platone attribuiva alla menzogna:
il problema è posto in termini di menzogna come fármakon: «si deve tenere in gran conto la verità.
Se poco fa non parlavamo a torto e se realmente non è utile agli dei il falso, e lo è invece agli
uomini come può esserlo un farmaco, è chiaro che l’uso di questo farmaco è riservato ai medici:
non è cosa che competa a privati qualunque. – E’ chiaro, rispose. – Ora, se c’è qualcuno che ha
diritto di dire il falso, questi sono i governanti, per ingannare nemici o concittadini nell’interesse
dello stato. Ma non c’è altri che debba arrogarsi un simile compito.» (Repubblica III, 389b)]
[2] Il mondo moderno sembra invece in preda a un’autentica hybris da menzogna. La «completezza
e [il] potenziale carattere definitivo [della menzogna], che erano sconosciuti nelle epoche
precedenti, sono i pericoli che derivano dalla moderna manipolazione dei fatti. Anche nel mondo
libero, dove il governo non ha monopolizzato il potere di decidere e dire cosa effettivamente è o
non è, gigantesche organizzazioni di interesse hanno generalizzato una sorta di mentalità da raison
d’état, che prima era circoscritta al trattamento degli affari esteri» (Arendt, Verità e politica). Con
20
una conseguenza di particolare rilievo, che stabilisce una seconda differenza fra menzogna moderna
e antica. Il modo moderno di mentire spinge la logica della menzogna a un punto tale che
«l’autoinganno è diventato uno strumento indispensabile», mentre gli antichi non sono mai stati
disposti a diventare vittime delle loro proprie falsità.» (Flores D’Arcais 2006, 143-144)
3.3.2.2. i vantaggi (logici) della menzogna e la sua maggior probabilità di successo
«La menzogna è possibile perché gode di numerosi vantaggi e privilegi.» (Flores D’Arcais 2006,
144)
3.3.2.2.1. la possibilità di rivendicare per se il metro di battersi per la Verità assoluta; e questa è la
prima e più grande menzogna che, nascosta dietro le vesti della Verità assoluta, accompagnata dalla
denuncia-disprezzo nei confronti del relativismo, scetticismo, nichilismo, disfattismo, tradimento,
codardia … rivolti a posizioni diverse, favorisce il successo della menzogna più grande, quella della
Verità assoluta. «Il totalitarismo ha bisogno di distruggere il passato, di poterne disporre à merci,
dal momento che il potere totalitario trova legittimazione solo nella pretesa di incarnare una Verità
assoluta nella contingenza del tempo storico.» (Flores D’Arcais 2006, 140)
3.3.2.2.2. «La menzogna… gode di infinita autonomia. Alla fantasia si chiede solo di creare
secondo coerenza. Se vi riesce, nessuna verità di fatto potrà mai disturbare il mentitore. Vedremo
come, per fortuna, tale ideale non sia mai perfettamente raggiungibile. La menzogna, inoltre, è in
genere assai più verosimile dei fatti realmente accaduti.
Proprio perché costruita secondo il criterio della coerenza, le oscurità e gli elementi inspiegabili
saranno ridotti al minimo. Che è quanto l’uomo in genere cerca. I fatti realmente accaduti, al
contrario, si discostano assai da un disegno a filigrana razionale. Offrono resistenza a una
spiegazione che si pretenda esaustiva. Conservano “impurità” irrazionali che nessun alambicco
storicistico sarà mai in grado di rettificare.» (Flores D’Arcais 2006, 144-145)
3.3.2.2.3. «Ma soprattutto, la menzogna moderna, quella che cancella e distrugge una realtà fattuale,
gode il vantaggio dell’impunità. La Arendt vive come tragedia la circostanza che un fatto, una volta
che ne sia stata distrutta o alterata la memoria (scritta, orale, fossile, archeologica eccetera), è
irreversibilmente perduto. Precipita in un irrimediabile nulla. Nessun indizio sopravvive al misfatto.
Le verità di fatto, insomma, conducono un’esistenza assolutamente fragile e precaria, epperciò tanto
più preziosa (Arendt, Verità e politica). I teoremi di Euclide, anche se perduti, non sono
definitivamente perduti. Pascal giovinetto può riscoprirli. La ragione può ripercorrere un cammino
già percorso e le cui tracce siano state cancellate. Questa fortuna non è concessa alle verità di fatto,
una circostanza sufficiente a sottolineare in che grado la menzogna moderna (manipolazione o
cancellazione) sia una forma di violenza. (Flores D’Arcais 2006, 145)
È questa la tragedia (e non solo la menzogna e la falsità) contenuta in ogni negazionismo,
soprattutto nel negazionismo di crimini contro l’umanità, specie i sistematici genocidi.
3.3.2.3. gli impliciti che decretano in politica una situazione a favore della menzogna.
3.3.2.3.1. Il primo implicito. La negazione dei fatti si presenta come un primo implicito (postulato)
del ruolo e del luogo della menzogna in politica. Punto di partenza della analisi di Hannah Arendt è
la distinzione tra verità razionale e verità di fatto; soltanto queste ultime hanno maggior rilevanza
nel rapporto tra verità e politica: «fatti ed eventi [...] costituiscono la tessitura stessa dell’ambito
politico. [...] Il dominio (per usare il linguaggio di Hobbes), quando attacca la verità razionale,
oltrepassa — per così dire — la propria sfera; al contrario quando falsifica o cancella i fatti, esso dà
battaglia sul proprio terreno. Le probabilità che la verità di fatto sopravviva all’assalto del potere
sono veramente pochissime; essa rischia sempre di essere bandita dal mondo non solo
temporaneamente, ma potenzialmente per sempre.» (Verità e politica, p. 35) (Cedroni 2010 p.140)
La politica — per Arendt — è, in ogni caso, la «sfera del contingente, delle cose che possono essere
altrimenti», ed è politico il tentativo di «negare l’esistente per far sì che esso possa essere
modificato», come ha sottolineato Olivia Guaraldo nella Prefazione alla traduzione italiana di Lying
in Politics: «La politica si muove fra una fragile contingenza e una ostinata fattualità». (La
menzogna in politica p. XI) (Cedroni 2010 p.147). La negazione del dato di fatto nega la politica.
21
Quando si parla di menzogna, afferma Hannah Arendt, e «specialmente della menzogna tra uomini
che agiscono, bisogna tenere a mente che la menzogna non è sgattaiolata dentro la politica per un
qualche caso dell’umana tendenza a peccare. [...] La falsità deliberata ha a che fare con fatti
contingenti; cioè a dire, con questioni che non contengono in sé nessuna verità inerente, nessuna
necessità di essere come sono. Le verità fattuali non sono mai necessariamente vere.» (La menzogna
in politica, p.13). (Cedroni 2010 p.150)
3.3.2.3.1.1. per oggetto “ciò che è contingente”. A commento: raramente la politica aggredisce
verità di ragione, verità filosofiche e raramente mina la coerenza dei ragionamenti con cui quelle
verità sono ribadite e conservate (ad esse compete, in un certo senso, la necessità della coerenza); la
gestione “libera” e la falsità compete ciò che è contingente, non dunque le verità di ragione, ma le
verità di fatto; in questo campo della contingenza e quindi della possibilità si manifesta la
disinvoltura e la discrezionalità di una gestione che si sente svincolata dalla verità; è questo il
campo della menzogna in politica. Si tratta di una strategia che, salvando la coerenza dei principi, la
svuota nella sua realizzazione, attraverso la sistematica negazione o alterazione dei fatti contingenti;
questi, del resto, risultano capaci di una efficacia persuasiva superiore ai generici (vuoti, riempibili
in varietà imprevedibile di modi, non “falsificabili”) enunciati di principio e quindi fonte
determinante di consenso e di adesione. Questo spiega l’attenzione e l’accanimento per una loro
gestione, manipolazione.
3.3.2.3.2. Il secondo implicito (postulato) presente nell’analisi sulla menzogna svolto da Hannah
Arend è «Il potere trasformativo della menzogna. Il punto fondamentale è che la menzogna è una
«forma di azione»: il bugiardo, afferma Arendt è un «uomo di azione», mentre chi dice la verità, sia
essa razionale o di fatto, «non lo è in alcun caso». Esiste pertanto un’evidente asimmetria tra
menzogna e verità, asimmetria ancor più evidente se questa forma di azione si svolge in ambito
politico. Una asimmetria a favore della menzogna giocata dunque su due campi: 1. colui che mente
è uomo d’azione, sta agendo infatti sul contingente e lo modella, esercitando in ciò, in apparenza, il
ruolo tipico della politica; 2. colui che dice il falso non dubita mai (anche per autoinganno), non è
tenuto a provare quanto afferma e ripetutamente ribadisce; mentre chi dice il vero compie
affermazioni che è tenuto a provare con un processo di ricerca e dubbio; il mentitore usa il dubbio
per demolire verità altrui e il concetto stesso di verità. «Se colui che dice la verità di fatto vuole
avere un ruolo politico, e quindi essere persuasivo, il più delle volte cercherà in tutti i modi di
spiegare perché la sua particolare verità serve meglio gli interessi di quale gruppo. E come il
filosofo ottiene una vittoria di Pirro quando la sua verità diventa un’opinione dominante tra coloro
che hanno delle opinioni, così chi dice la verità di fatto, quando entra nell’ambito politico e si
identifica con qualche interesse parziale e con qualche gruppo di potere, compromette l’unica
qualità che avrebbe potuto far apparire plausibile la sua verità, e cioè la sua sincerità personale [...].
È difficile che esista una figura politica che abbia più probabilità di destare un giustificato sospetto
di colui il quale per professione dice la verità e ha scoperto qualche felice coincidenza tra verità e
interesse. Il bugiardo, al contrario, non necessita di tali dubbi adattamenti per apparire sulla scena
politica; egli ha il grande vantaggio di essere sempre, per così dire, già al centro di essa. Egli è un
attore per natura; dice ciò che non è perché vuole che le cose siano differenti da ciò che sono, e cioè
vuole cambiare il mondo. Egli trae vantaggio dall’innegabile affinità esistente tra la nostra capacità
di agire, di cambiare la realtà, e questa nostra misteriosa facoltà che ci consente di dire “il sole
splende” quando sta piovendo a dirotto.» (Verità e politica, p.60) (Cedroni 2010 p.144)
3.3.2.3.2.1. La menzogna, scrive Arendt, è sempre stata considerata uno strumento giustificabile
negli affari politici, una forma di azione come altre, e il ricorso a essa sembra essere perfettamente
compatibile con la politica se non addirittura utile. Al contrario, la sincerità «non è mai stata
annoverata tra le virtù politiche, perché essa può contribuire veramente poco a quel cambiamento
del mondo e delle circostanze che è tra le più legittime attività politiche. Soltanto là dove una
comunità si è imbarcata nella menzogna organizzata per principio (e non soltanto in riferimento a
dei particolari), la sincerità in quanto tale, non sostenuta dalle forze deformanti del potere e
dell’interesse, può diventare un fattore politico di prim’ordine. Dove tutti mentono riguardo a ogni
22
cosa importante, colui che dice la verità, lo sappia o no, ha iniziato ad agire; anche lui si è
impegnato negli affari politici poiché, nell’improbabile caso in cui sopravviva, egli ha fatto un
primo passo verso il cambiamento del mondo.» (Verità e politica p. 61) Ma, rispetto a colui che
dice la verità, il bugiardo ha un vantaggio: egli è libero di modellare i suoi “fatti” per «adattarli al
profitto e al piacere, o anche alle mere aspettative del suo pubblico», inoltre «egli sarà molto
probabilmente più persuasivo di colui che dice la verità.» (Verità e politica p. 62) (Cedroni 2010
p.145)
3.3.2.3.2.2. «Per Arendt, considerare la politica «dalla prospettiva della verità» vuol dire, pertanto,
«collocarsi al di fuori dell’ambito politico» (Verità e politica, p. 72). Concettualmente, la verità è
«ciò che non possiamo cambiare»; la verità ha una natura non politica, se non addirittura
antipolitica, mentre la menzogna è sorprendentemente affine alla politica: «la capacità di mentire e
la possibilità di cambiare i fatti — la capacità di agire — sono tra loro connesse», afferma Arendt in
Lying in Politics affrontando il problema dell’uso politico della menzogna (La menzogna in
politica, p. 11). La politica è l’ambito pubblico in cui si realizza l’umana capacità di «dare inizio a
qualcosa di nuovo», per cui: agire politicamente significa «realizzare qualcosa che sia imprevisto
ma che tenga conto di ciò che è e di ciò che è stato» (La menzogna in politica, prefazione Guaraldo,
p.XIII). (Cedroni 2010 p.149)
3.3.2.3.3. Il terzo implicito, postulato del ruolo della menzogna nella politica è fornita dalla natura
specifica dell’inganno operante: si tratta dello stretto legame tra inganno e autoinganno.
«La prima questione rimanda alla relazione tra inganno e autoinganno, secondo cui risulta molto
«difficile mentire agli altri senza mentire a se stessi» (Verità e politica, p. 65-66). Si tratta del
cosiddetto processo di «autoinganno interno», secondo il quale coloro che hanno ingannato gli altri
hanno cominciato «ingannando se stessi» (La menzogna in politica, p. 65). Tale assunto, che
sembra trovare in letteratura «grande tolleranza e indulgenza», si basa sulla convinzione che «più
un bugiardo ha successo, più è probabile che egli cadrà vittima delle sue stesse fabbricazioni»
(Verità e politica p.65-66). Colui che mente «a sangue freddo» — afferma Arendt — resta
consapevole della «distinzione tra verità e falsità» pertanto: «la verità che egli sta nascondendo agli
altri non è stata ancora eliminata completamente dal mondo» (Verità e politica p. 66).
Mentre nelle moderne democrazie «l’inganno senza autoinganno risulta quasi impossibile» (Verità
e politica p. 68), nei regimi totalitari la verità viene completamente distrutta e vanificata, rendendo
tutto incerto: «L’esperienza di un movimento tremolante e vacillante di tutto ciò cui facciamo
affidamento per il nostro senso dell’orientamento e della realtà è tra le più comuni e vivide
esperienze degli uomini sotto il dominio totalitario» (Verità e politica p.60).
Siamo giunti alla definizione della «menzogna coerente» — quella che maggiormente presenta
«un’innegabile affinità con l’azione, con il cambiare il mondo — in breve, con la politica», quella
«che ci fa mancare la terra sotto i piedi» (Verità e politica p.70).» (Cedroni 2010 p.148)
(segue al punto 3.2.2.5. e segg.)
3.4. come conclusioni. Mettendo provvisoriamente a confronto la natura del totalitarismo del
‘900 e le finalità della menzogna di Stato come negazione programmata dei fatti nella prassi
“imperialistica” con i postulati del pensiero di Arendt sul tema che cos’è la politica, risalta come
quella prassi “politica” è la negazione della politica nella sua essenza, nelle condizioni fondamentali
che la definiscono e la pongono in esistenza. È la negazione della pluralità, della contingenza e della
misura. Per chiarirla e contrario, è l’affermazione dell’Uomo unico contro gli uomini e le loro
naturali differenze; è l’affermazione della necessità che nega ogni possibilità presentando se stessa
come realizzazione piena di ciò che il processo storico portava con sé in nuce da anni se non da
secoli; è l’affermazione della “dismisura”, della potenza totale e senza limiti, della violenza allo
stato puro contro il valore della saggezza e della mediazione attenta a cogliere e valorizzare le
differenze (delle virtù cardine del modello politico di Aristotele: phrònesis, mesòtes).
«Gli avvenimenti totalitari, con la loro nichilistica ostinazione a oltrepassare e a negare la legge
della finitudine si fanno portatori della «dismisura». […] Tale pretesa, che porta con sé la negazione
23
della pluralità) e della contingenza, manifesta tutta la sua potenzialità davvero nichilistica soltanto
nei campi di sterminio. […] Il tema della città, e successivamente dello Stato, come opera d’arte,
come prodotto dell’artificio umano, è dunque il motivo che a partire da Platone si costituisce come
discorso dominante della filosofia politica occidentale. E decisivo risulta il fatto che in età moderna
esso si coniughi perfettamente, quasi fosse un suo sbocco naturale, con la «filosofia della storia»
della tradizione tedesca. Nella prospettiva teleologica dello sviluppo storico, «mettere in opera»,
costruire, la comunità politica assume il significato di aprirsi alla necessità di realizzare ciò che il
processo storico portava in nuce dentro di sé.
«Assolutizzazione del soggetto»; «progettualità» e «artificialità» che reificano lo stare insieme degli
uomini; «annullamento della pluralità e della differenza» costitutive del mondo; «prospettiva
processuale» propria delle filosofie della storia sono tutti elementi che rimandano a quell’insieme di
idee, mai distesamente e ordinatamente esposte, che connettono, anche nella riflessione arendtiana,
il totalitarismo alla metafisica. Una connessione che consente di affermare che anche per la Arendt
una delle più significative chiavi di lettura delle dinamiche totalitarie è quella che le interpreta come
parossistico ricongiungersi di idea e realtà. […] Nel dominio totalitario si incontrano infatti il
delirio volontaristico moderno, secondo cui «tutto è possibile», e quella mentalità evoluzionistico processualistica della tarda modernità, che rifiuta di considerare e accettare «qualsiasi cosa così
com’è» per interpretare «tutto come semplice stadio di un ulteriore sviluppo».» (Arendt 1951, S.
Forti XXXVIII-XXXIX)
3.5. uno spiraglio: il pericolo di una deriva totalitaria anche in una democrazia avanzata e l’ipotesi
di uno spiraglio, una via di uscita, in ripresa della libertà della ragione e delle emozioni resa
possibile dal ritorno della vergogna, quindi dello stupore, quindi dell’iniziativa. Nella disinvoltura
politica della menzogna e nell’annullamento della vergogna sia nel contesto politico che nell’ambito
dell’opinione pubblica assuefatta allo stile politico della disinvolta menzogna, si profilano quelli
che Simona Forti chiama «spettri della totalità»; in questo caso anche nella democrazia con forti
presenze demagogiche compare l'atteggiamento mentale dell’«arroganza della mente» che rende
superflua la realtà, e con essa le singolarità che la popolano, in nome di un'idea, acriticamente posta
e rozzamente esplicitata in una visione del mondo. Tale atteggiamento di disprezzo per la realtà, il
considerarla superflua, non è moralmente innocente, anzi. Esso è la premessa che consente di
intervenire in maniera violenta sulla realtà, è ciò che apre la strada all'implementazione violenta
dell'ipotesi: alla verità di fatto non si può che violentemente sostituire la «verità di ragione». È
difficile pensare che solo attraverso la persuasione, la manipolazione dell'opinione pubblica, sia
possibile adattare la realtà alla propria immagine. È solo attraverso la violenza, la forza dispiegata
ed efficace dell'apparato coercitivo, che l'uomo politico è in grado di realizzare concretamente le
sue ipotesi. Il connubio fra politica e violenza non è una prerogativa totalitaria. La manipolazione
totalitaria della realtà ci ha tuttavia insegnato che ogni ipotesi teorica (ideologica), che chiede di
essere realizzata, ha bisogno della violenza. Oggi, anche di fronte allo svelamento delle menzogne,
l'opinione pubblica non si indigna, come se oggi, a differenza di allora, fossimo di fronte ad una
costruzione molto più efficace, molto più riuscita, di un reticolo di finzioni che sostituisce la realtà.
Come se, in altri termini, la fiduciosa convinzione di Arendt, per la quale nessuna finzione è tanto
grande da occultare in maniera totale - e politicamente efficace - la realtà, fosse davvero svanita nel
nulla, proprio perché ciò a cui oggi assistiamo è l'efficacia politica delle finzioni - ideologiche e
mediatiche - pur di fronte allo svelamento della loro falsità. «Non siamo impotenti, passivi e
conformisti, solo per paura o vigliaccheria, ma anche perché "il falso indiscutibile" organizza
magistralmente l'ignoranza di ciò che succede e, qualora ce ne fosse bisogno, allestirebbe
successivamente l'oblio di quanto si è riusciti a intuire. Gettati in una sorta di avvicendamento
perenne di immagini, impossibilitati ad avvertire quali riportano i fatti e quali li stanno inventando,
ci vorrebbe davvero un balzo potente per cercare di riafferrare ciò di cui siamo stati defraudati:
l'esperienza di un mondo fattuale che resiste alla mediatizzazione» (Simona Forti, Spettri della
totalità, in Micromega 5 (2003) 98-109).
24
3.5.1. C'è, per così dire, una risposta immediatamente politica alla questione della menzogna, ed
essa risponde nei termini di una condanna non moralistica nei confronti di chi nega le realtà di fatto
e pretende di sostituirvi le finzioni: tale risposta si limita a giudicare politicamente quali sono gli
effetti politici di quelle finzioni. Una simile risposta è stata la forza del movimento pacifista contro
la guerra in Vietnam, a cui le rivelazioni dei Pentagon Papers hanno fornito ulteriori argomenti. Ad
essa Arendt aderisce, mettendo in luce le contraddizioni, le insensatezze, le ingiustizie di quel
conflitto.
3.5.2. C'è poi una seconda risposta, che radica le sue ragioni profonde nell'ontologia arendtiana,
ovvero in quella descrizione normativa e allo stesso tempo fattuale della condizione umana che la
pensatrice elabora ed affina nel corso della sua vita. Tale risposta ontologica ha dunque a che fare
con la natura plurale e contingente dell'agire umano, così come Arendt l'ha originalmente formulata.
Ad essa l'autrice consegna l'ottimistica convinzione che nemmeno i più tremendi fra i metodi
totalitari - il terrore, lo sterminio - riescano a cancellare completamente il tessuto ontologico plurale
che costituisce la realtà. In altri termini, la condizione umana della pluralità non permette, di
principio, una perversione totale della realtà dal momento che chi agisce non lo fa mai in solitudine
- l'azione, per definizione, è qualcosa che avviene sempre in un contesto pubblico, visibile - e si
deve, per così dire, "accordare" con gli altri in vista di una attuabilità delle proprie "intenzioni". Se
agire è sempre agire di concerto, ciò significa appunto che al centro di ogni movimento
genuinamente politico c'è una irriducibile pluralità di prospettive che si possono - o non possono accordare al fine di realizzare qualcosa di nuovo. È a questa pluralità di prospettive che Arendt
affida il compito politico del mutamento - anche rivoluzionario, come già si è detto - e la positiva
facoltà di "negare l'esistente".
3.6. un terzo evento (cui Arendt non ha potuto assistere, muore nel 1975) che rappresenta
emblematicamente la fine del “secolo breve”: 1989, il collasso dei comunismi in Europa e la fine
dell’URSS. (o la fine del bipolarismo, un’opportunità mancata)
3.6.1. Un caso ancora di automenzogna o di mancata occasione; a chiarirne la logica tornano le
analisi di Hannah Arendt tanto efficaci nella diagnosi quanto con evidenza trascurate. «…la caduta
del Muro di Berlino, il collasso dei comunismi in Europa, la fine dell’URSS come impero e come
grande potenza, pongono fine all’esistenza del Nemico». (Flores D’Arcais 2006, 228) Diventa
l’occasione, forse unica, per uscire dalla logica della costruzione politica del Nemico, mezzo
strategico cui ricorre il totalitarismo per imporre un unanimismo politico. Por fine alla impresa
politica della costruzione del Nemico significa porre fine «all’alibi dietro il quale l’apologia
dell’esistente aveva tentato di far valere come buon diritto le sue pretese contro il pensiero critico.
Scomparso il nemico scompare l’alibi. E se davvero fosse stata l’esistenza e la pericolosità del
Nemico a rendere plausibile la tesi della giustificabilità dei “mali minori”, quello era il momento di
guardarli in faccia, tali “mali minori”, liberi ormai dal timore di “fare il gioco di...”.» (Flores
D’Arcais 2006, 228)
3.6.2. «Eppure l’Occidente non usa affatto la fine dei comunismi per fare i conti con se stesso e i
propri “mali”. Al contrario. Vaticina un mondo che ha concluso la sua storia e profetizza l’eden a
portata di mano, attraverso l’estensione universale (globalizzazione) del liberismo-liberalismo,
libero mercato e libero profitto, da cui fioriranno tutte le altre libertà. Eppure non erano e non sono
tanto “minori” i nostri mali. Quegli stessi che già Hannah Arendt aveva con precisione identificati.
Ricordiamoli. […] il crescere a dismisura delle diseguaglianze sociali, pur nel miglioramento
globale delle condizioni di vita delle società occidentali. […] Questo Nemico è stato trovato nel
Terrorismo e nel fondamentalismo islamico. Mentre la tragedia delle Torri Gemelle — il più grave
atto di terrorismo mai avvenuto — poteva e doveva essere l’occasione per una comprensione del
fenomeno che fosse insieme autocomprensione, secondo la lezione di Hannah Arendt. Perché,
sempre secondo la lezione di Hannah (che non sognò mai “fuoriuscite” dal capitalismo al
socialismo) la lezione da trarre sulla base di un’analisi critica poteva bene essere (e doveva essere):
più Occidente.
25
L’Occidente può sopravvivere al terrorismo solo diventando più Occidente, ponendo fine allo
scarto, fin qui strutturale, che ne ha accompagnato l’esistenza: tra i principi solennemente
proclamati, e pratiche di governo che troppo spesso li hanno smentiti e infangati, o comunque
trascurati.
Porre fine allo scarto, ridurlo a epifenomeno: già i più elementari provvedimenti antiterrorismo
impongono questa strada. Come si finanzia, infatti, questa sporca jihad, se non, tra l’altro, con il
riciclaggio del papavero e della cannabis? E come può sfuggire ai controlli, se non grazie ai paradisi
offshore? Gli stessi che garantiscono mafie, corruttori ed evasori. E nessun altro. L’Occidente, se
vorrà togliere questo vantaggio al terrorismo, dovrà agire in coerenza con i propri valori (che
condannano mafia, corruzione, evasione fiscale) e in rottura con le proprie pratiche (che hanno
lasciato prosperare i paradisi offshore, alimentando mafie e corruzione ed evasione fiscale).» (Flores
D’Arcais 2006, 229-231 passim). La possibilità di abbandonare la lettura del nuovo nemico (impero
del male) nella “primavera” in atto nei paesi arabi (2010-2011).
3.6.3. «Pensare il futuro con Hannah Arendt Il pensiero di Hannah Arendt ce ne offre alcuni
irrinunciabili strumenti. La rinuncia all’alibi del Nemico, intanto. Il rifiuto della il-logica della irrealtà fondata sulla rimozione dei “mali minori”. La comprensione del conformismo (in tutte le sue
articolazioni e manifestazioni) come il “ventre sempre fecondo” da cui possono scaturire nuove
derive totalitarie o inedite distruzioni della democrazia. L’Occidente ha molti nemici, dunque, ma
un solo vero Nemico: il rifiuto di fare i conti con se stesso e con i suoi “mali minori”.» (Flores
D’Arcais 2006, 232)
4. Che cos’è la politica? la proposta (il modello)
4.1. La sede della politica nello Stato – Nazione come sede problematica
Stato di diritto e dei diritti o Comunità per consanguineità ed etnia (Società o Comunità)?
«In sintesi, si potrebbe dire che i momenti cruciali della storia moderna da lei indagati investono
tutti la relazione sempre più problematica tra lo sviluppo universalizzante dello Stato-nazione e i
vari movimenti che si originano dalla sua forma ormai svuotata di contenuto. Lo Stato-nazione in
realtà per la Arendt ospita già al proprio interno una logica contraddittoria, il cui motore è la
tensione tra i suoi due elementi costitutivi: lo Stato, come costruzione razional-legale, e la nazione,
nutrita invece dall’idea di una comunità sostanziale e omogenea quanto a ethos ed ethnos. Se lo
Stato è, almeno in via teorica, quella struttura volta a garantire i diritti di tutti, la nazione si regge
invece sul presupposto di una comunità escludente. Da qui il paradosso secondo cui solo coloro che
condividono suolo, sangue e lingua di una nazione possono pretendere di godere della piena
protezione legale da parte dello Stato. Le minoranze etniche, e ancor più gli apolidi — i prodotti per
così dire degli sconvolgimenti di fine Ottocento e inizi Novecento — porteranno in piena luce tale
costituzione contraddittoria dello Stato-nazione. Il suo presentarsi, da una parte, come garante di
quei diritti individuali pensati come una continuazione dei diritti di natura, e, dall’altra, il suo
riconoscere, di fatto, tali diritti soltanto a chi si trova già in possesso dei requisiti richiesti per
l’appartenenza nazionale. Il duro attacco mosso dalla Arendt alla fictio dei diritti umani — condotto
nei passaggi cruciali che chiudono la parte su L’imperialismo — non è sorretto certo soltanto da
vecchi argomenti “tradizionalisti” o “storicistici”, ma dalla preveggente consapevolezza, ritornata
oggi di scottante attualità, della inefficacia di astratti proclami sull’universalità dei diritti umani.
Nella nuova congiuntura storica del primo dopoguerra, chi non nasce cittadino, chi non possiede la
nazionalità, è come se non fosse nemmeno umano. Così come chi non sarà tedesco-ariano, non sarà
nemmeno a pieno titolo appartenente all’umanità.
Tali contraddizioni diventano esplosive per la Arendt quando la struttura giuridica dello Statonazione viene dissolta in una dinamica imperialistica. Non solo il principio di espansione senza
limiti stravolge il principio di territorialità, ma gli stessi ideali della sovranità popolare e
dell’inviolabilità dei diritti dei cittadini capitolano di fronte ai metodi arbitrari sperimentati dai vari
governi dei territori conquistati: quei metodi che vengono poi adottati dai pan-movimenti politici
26
dell’Europa orientale, pressoché privi di un’eredità costituzionale. […]L’approccio genealogicoarcheologico, che procede secondo un andamento disordinatamente diacronico, lascia il posto, nella
terza parte, a un’analisi dei tratti strutturali di tali regimi. Essi non rappresentano l’ultima figura,
ancorché esasperata e irrigidita, della costruzione statuale moderna. Lungi dal comporsi in una
struttura monolitica, l’apparato istituzionale e legale totalitario rimane estremamente duttile e
mobile, per permettersi la più assoluta discrezionalità. Per questo, gli uffici vengono moltiplicati, le
giurisdizioni tra loro sovrapposte e i centri di potere continuamente spostati. Soltanto il capo
totalitario, assieme a una cerchia ristrettissima di collaboratori, tiene nelle sue mani gli ingranaggi
effettivi del potere, che non viene affatto utilizzato per servire interessi di parte. La Arendt non si
stanca di ripetere che per questi regimi le considerazioni utilitaristiche sono inessenziali, poiché ciò
a cui essi mirano è assai più ambizioso e smisurato: modificare la realtà per ricrearla secondo gli
assunti dell’ideologia. Da qui la differenza tra veri e propri regimi totalitari, quali il nazismo e lo
stalinismo, e regimi autoritari, quali il fascismo. Questi ultimi si servono ancora dei metodi
tradizionali di potere che, per quanto oppressivi, mirano soltanto all’obbedienza e all’eliminazione
degli oppositori. Quanto le dinamiche totalitarie eccedano ogni criterio tradizionale di dominio è
dimostrato per lei dal fatto che la polizia segreta entri davvero in azione soltanto quando, una volta
liquidata la reale opposizione, si passa a eliminare il cosiddetto «nemico oggettivo»: colui che non
ha intenzione di opporsi al regime, ma che è avversario per definizione ideologica. Tale
procedimento serve principalmente a tenere in funzione il terrore, vero motore di un regime che
raggiunge il proprio culmine nel momento in cui investe persino il «nemico possibile», vale a dire
quando le vittime vengono scelte in modo del tutto casuale ed arbitrario.
Il cuore del funzionamento totalitario è il campo di sterminio, interpretato dalla Arendt come «il
laboratorio» in cui si vuole sperimentare l’assunto secondo cui «tutto è possibile».» (Arendt 1951,
S. Forti, XXIX-XXXI) «…il pensiero accomodante sostituisce l’analisi con l’individuazione di un
nemico» (Flores D’Arcais 2006, 198)
4.2. Le forme di negazione del politico. La facile (e ricorrente) familiarità, teorica e pratica, tra i
termini: Stato, sovranità, potere, potenza, forza, violenza, dominio … e la tesi che tale prassi
annulla il politico.
4.2.1. Aristotele ricorda come c’è chi mette in dubbio la legittimità stessa della vita politica ed
esalta una vita solitaria e c’è anche chi fa del dominio sugli altri il fine della vita politica. E osserva:
«Tuttavia a chi si prendesse la briga di riflettere potrebbe sembrare ben strano che l’opera del
politico possa consistere nell’escogitare modi di sottomettere e dominare gli altri, volenti o nolenti.
Come potrebbe essere opera degna del politico e del legislatore ciò che non è neppure conforme alle
leggi? […] Sembra che i più considerino il dominio dispotico come una forma politica e nessuno si
vergogna di fare nei confronti degli altri ciò che nei propri riguardi proclama né giusto né utile.
Vanno in cerca di un governo giusto per se stessi, ma nelle relazioni con gli altri non si curano
affatto della giustizia.» (Aristotele, Politica 1324b22-27,32-36)
4.2.1.1. nella forme di gestione della informazione e nella menzogna. (riprendendo il passo già
sopra citato)
«Si affaccia qui, sul terreno della menzogna, la natura e il destino politico della violenza.
Modificare la realtà secondo le proprie ipotesi diviene un pericoloso crinale su cui l'uomo d'azione
facilmente - e irreversibilmente - può scivolare. Che cosa, del resto, permette all'uomo d'azione di
realizzare, rendere reali le proprie finzioni teoriche? È difficile pensare che solo attraverso la
persuasione, la manipolazione dell'opinione pubblica, sia possibile adattare la realtà alla propria
immagine. È solo attraverso la violenza, la forza dispiegata ed efficace dell'apparato coercitivo, che
l'uomo politico è in grado di realizzare concretamente le sue ipotesi. Il connubio fra politica e
violenza non è una prerogativa totalitaria. La manipolazione totalitaria della realtà ci ha tuttavia
insegnato che ogni ipotesi teorica (ideologica), che chiede di essere realizzata, ha bisogno della
violenza. Comune a entrambi gli usi della finzione teorica è, in fondo, la violenza che quelle teorie
implementa. …
27
Il meccanismo della violenza - bombardare non per sconfiggere il nemico, ma "per risollevare il
morale" degli alleati - risponde meccanicamente; il suo funzionamento non dipende, come per ogni
meccanismo, dagli "scopi" che esso deve conseguire - la violenza ha a che fare esclusivamente con i
mezzi, è dei mezzi che si occupa essendo essa stessa un mezzo. Il problema, afferma Arendt nel
saggio On Violence, è quello per cui la categoria mezzi-fini, quando viene applicata alla sfera degli
affari umani, tende a far prevalere il mezzo sul fine, ad autonomizzarsi da qualsiasi ragionevolezza
e prevedibilità. Se vi è quindi un rapporto privilegiato fra violenza e teoria (o consequenzialità
logica), dovuto al fatto che la teoria sostituisce la realtà e vuole essa stessa rendersi reale attraverso
mezzi violenti, tale rapporto sfugge di mano per il fatto, altrettanto evidente, che la violenza
difficilmente resta dentro l'alveo di prevedibilità che la teoria prospetta. Il fallimento dei modelli
teorici dei problem solvers riguarda anche la loro eccessiva fiducia nel potere della teoria di tenere a
bada la violenza. Ciò che tuttavia qui importa è l'effetto che l'azione scatenante di tale rapporto ha
con la realtà: esso diviene operativo, efficace, proprio quando la realtà è resa superflua (si veda
l'esempio più volte riportato da Arendt, del terrore totalitario che diventa sistematico quando non c'è
più un'opposizione da eliminare - la violenza del terrore non ha legami con i "bisogni del reale", ma
con la costruzione ideologica che crea la finzione del "nemico oggettivo", e del "delitto possibile").
Cosa resta quando la realtà è resa superflua? Resta, ovviamente, la teoria, quale efficace e
totalizzante sostituto di un mondo caotico, plurale, incoerente. Una teoria resa ostaggio della
produzione di violenza. Dal momento in cui la realtà è resa superflua all'interno del meccanismo
astratto dell'esperimento mentale, essa è concretamente violabile, con ogni mezzo, nella sua stessa
datità.» (Arendt Hannah 1972 La menzogna in politica, Guaraldo)
4.2.1.2. nella forma dello slogan «non c’è alternativa» (nessun altro mondo è possibile …da «un
altro mondo è possibile). Osserva Urlich Beck (Beck Urlich 2002 Potere e contropotere nell’età
globale, Laterza Roma-Bari 2010, pp. 71, 74, ) :
In effetti il potere del non-intervento minacciato è già oggi onnipresente. Perciò, la globalizzazione
non è un’opzione. La globalizzazione è il dominio da parte di nessuno. […] Questo meta-potere
discorsivo della globalizzazione si concretizza, non ultimo, nel principio TINA: There Is No
Alternative. I1 meta-potere dell’economia mondiale comporta la vulnerabilità alla violenza e la
dipendenza dalla violenza
Hannah Arendt (1970 trad. it. 1996, Sulla violenza) ha richiamato l’attenzione sul contrasto tra
potere e violenza, contrasto che si radicalizza nel corso della modernità. «[...] politicamente
parlando è insufficiente dire che il potere e la violenza non sono la stessa cosa. Il potere e la
violenza sono opposti; dove l’uno governa in modo assoluto, l’altra è assente. [...] parlare di potere
non violento è di fatto una ridondanza. La violenza può distruggere il potere: è assolutamente
incapace di crearlo» (p. 56 [trad. it. p. 61]). «La violenza può sempre distruggere il potere; dalla
canna del fucile nasce l’ordine più efficace, che ha come risultato l’obbedienza più immediata e
perfetta. Quello che non può mai uscire dalla canna di un fucile è il potere» (p. 53 [trad. it. p. 57]).»
«… Hannah Arendt considera la violenza un principio opposto al potere (allo spazio pubblico dove
i liberi progetti si incrociano) e con esso incompatibile. La violenza non sarà mai potere, sarà
sempre dispotismo, prevaricazione. Dalla violenza non potrà mai nascere la libertà.» (Flores
D’Arcais 2006, 133)
Arendt interpreta e definisce il potere come potenzialità, possibilità e promozione o esercizio del
fare, del produrre, dell’assumere iniziative e del loro successo legato inesorabilmente al consenso;
cosa che non si può assolutamente ottenere con la violenza; va dunque rivisto e ripensato il luogo
comune che lega il potere alla violenza, definendo correttamente, in senso antropologico,
sociologico e storico sia l’un termine che l’altro. Quindi la tesi: nessun potere (duraturo ed efficace)
si può costruire sulla violenza, il potere duraturo ed efficace si basa sul consenso [come in
Aristotele: il rispetto della legge non si ottiene con la violenza, ma quando la legge diventa éthos,
costume, abitudine, seconda natura, senso civico…]. Il problema ulteriore è anche quello che si può
ottenere il consenso con la violenza, non tanto la violenza esplicita e fisicamente esibita con
repressioni e armi, ma la violenza soft che sfianca e annulla con modelli di vita a-civici il pensiero,
28
l’autonomia di giudizio, la volontà di sapere … o quella che crea rimozioni e determina
autoassoggettamento e campa, si nutre e ingrassa, sulla paura.
«Non è certo un caso che quasi contemporaneamente a Hannah Arendt negli anni Sessanta del XX
secolo due altri teorici della società moderna — ossia Talcott Parsons e Ralf Dahrendorf —
affermassero con argomenti del tutto analoghi la dipendenza del potere dal consenso e quindi
arrivassero a una previsione sistematica del crollo dell’impero sovietico. Scrive Parsons: «Ma il
potere, nel senso stretto di medium sociale generale, contiene essenzialmente un elemento di
consenso. Infatti, il potere si basa sull’esistenza e l’utilizzo di possibilità di esercitare influenza;
grazie alle possibilità di influenzare e di acquisire influenza il sistema di potere è fornito di
consenso nel contesto dei valori sociali. La peculiare prestazione delle istituzioni democratiche non
è la legittimazione generale del potere e del dominio, bensì l’ottenimento di un consenso del potere
e del dominio da parte di persone e gruppi bene determinati e da parte di decisioni ben determinate
e vincolanti; nessuna istituzione che si distingua fondamentalmente dalle istituzioni democratiche è
in grado di fornire questa prestazione. …» Beck Urlich 2002 Potere e contropotere nell’età globale,
Laterza Roma-Bari 2010, 75
4.2.1.3. nelle forme di un totalitarismo “soft”: un totalitarismo “post-ideologico”, “democratico”.
«Mentre l’Ideale ideologico costituiva, come ha mostrato lucidamente Hannah Arendt, il
fondamento ultimo dei regimi totalitari storicamente determinati — in quanto l’ideologia esprimeva
la spinta alla realizzazione integrale dell’idea, «in modo tale che ogni cosa che accade, accade
secondo la logica propria di un’idea» — le forme contemporanee dei totalitarismi postideologici, o,
se si preferisce, la tendenza totalitaria immanente ai regimi liberal-democratici nell’epoca
dell’affermazione incontrastata del discorso del capitalista, si manifestano a partire da una spinta
alla riduzione disincantata di ogni Ideologia. Se l’idealismo infatuato che animava le forme storiche
dei regimi totalitari consisteva nel piegare la contingenza particolare alla logica fatale di una
Necessità Universale —della Storia o della Natura —, ora le forme contemporanee del totalitarismo
postideologico sembrano qualificarsi dal rigetto cinico di ogni riferimento verticale all’Ideale. […]
Il legame totalitario come legame retto da un’ipnosi verticale centrata sulla figura del padre
totemico — impersonificato dallo sguardo carismatico dei Führer — e contrassegnato da una
fusione identificatoria conformista «a massa», ha lasciato in Occidente il posto a una sorta di
rovesciamento dell’ipnosi. Anziché porre il fondamento del potere nell’Ideale ideologico e nella
seduzione mortifera delle masse, le nuove incarnazioni del totalitarismo si incardinano nell’oggetto
di godimento svincolato da ogni legame con l’ideale. Si tratta di quella nuova forma di potere
dell’oggetto che orienta la globalizzazione dei mercati e la stessa riduzione del soggetto alle
pratiche di manipolazione tecnico-scientifica più sofisticate.» Recalcati Massimo, Introduzione.
Totalitarismo postideologico in Recalcati Massimo (a cura di) 2007 Forme contemporanee del
totalitarismo, Bollati Boringhieri, Torino, p. 7,8.
4.2.1.4. Una simile attenzione alla trasformazioni storiche, imprevedibili, del totalitarismo è tema
rilevante nelle stesse riflessioni di Arendt; eloquente su questo tema il saggio di Flores D’Arcais:
Hannah Arendt e il totalitarismo nelle democrazie in (Flores D’Arcais 2006, 193-232).
Il problema nasce dallo stupore già richiamato, dalla «Presa di coscienza del fatto che
l’«irrazionalità», il totalitarismo e la barbarie possono salire al potere per vie inizialmente
democratiche, contro tutti gli angelismi religiosi e ideologici del momento e, si credeva, di sempre.
E tutto ciò in una società intellettualmente raffinata e creativa, erede dell’illuminismo e impregnata
in modo dominante dal protestantesimo liberale. Esperienza di un «fatto sociale totale» che sfuggiva
in tutti i sensi a qualunque genere di norma e si rivelava completamente fuori fase rispetto a ciò che
quelle stesse norme autorizzavano a pensare in merito all’avvenire della società.» Deconchy JeanPierre, Dru Vincent 2007, 20)
L’attenzione di Arendt si concentra sui diversi meccanismi che in modo indolore, ma con processi
che si riveleranno (a cose accadute) tanto inesorabili quanto inavvertiti («come minaccia sempre
gravida, dentro la pratica democratica e la sua eclissi» Flores D’Arcais 2006, 6), possono costituire
29
una transizione, improvvisa ma non priva di legami, a dimensioni del totalitarismo in regimi
ufficialmente democratici.
4.2.1.4.1. (primo meccanismo) il “conformismo” come stile diffuso di non presenza, non presa di
posizione di tipo politico (il contrario dello spoudàios).
«Quali sono questi elementi pretotalitari, presenti massicciamente nelle democrazie liberali, senza i
quali i fascismi non avrebbero mai visto la luce? Potremmo sussumerli sotto una sola categoria,
riassumerli in una sola parola: conformismo. Quando nei suoi famosi reportage da Gerusalemme sul
processo Eichmann parlerà di «banalità del male», Hannah Arendt vuole ricordare esattamente
questo: i nazisti a cui dobbiamo il “male radicale” di un’intera epoca storica erano anche
borghesucci qualunque. Già nel gennaio del 1945, a guerra non ancora conclusa, in uno
straordinario articolo sulla rivista «Jewish Frontier» (“Organized Guilt and Universal
Responsability”, 19-23), la Arendt sottolineava che «l’organizzazione totale di Himmler non conta
sui fanatici, né sugli assassini per natura, né sui sadici; essa fa interamente assegnamento sulla
normalità dei lavoratori e dei padri di famiglia». (Flores D’Arcais 2006, 202)
« Il male contemporaneo, desunto proprio dal totalitarismo come male radicale, è infatti la banalità
del male. L’espressione è diventata quasi un marchio DOC per caratterizzare il pensiero della
Arendt. E giustamente: molto al di là, anzi, di quanto gli strali polemici che l’hanno colpita non
sospettino.» (Flores D’Arcais 2006, 39)
«Totalitarismo e conformismo
Il padre di famiglia. Il suo conformismo. Il suo disinteresse per la sfera pubblica. La sua divorante
«solenne determinazione ad assicurare alla moglie e ai figli una vita agiata... Divenne chiaro che un
uomo simile era pronto a sacrificare per la pensione, per l’assicurazione sulla vita e per la sicurezza
della moglie e dei figli le proprie convinzioni, il proprio onore e la propria dignità umana». […]
Il mondo borghese delle democrazie liberali, dunque, può sempre precipitare nel totalitarismo
proprio perché il male è banale, fa tutt’uno con la “normalità” dell’egoismo individuale, con la
routine della disaffezione per la sfera pubblica, con la massificazione crescente dei comportamenti e
delle coscienze. E se «l’evoluzione di questo moderno tipo di uomo, che è l’esatto opposto del
citoyen, ha goduto di circostanze particolarmente favorevoli in Germania», sarà bene non illudersi.
Il “de te fabula narratur” vale per l’intero Occidente: «L’uomo-massa, il risultato finale del
bourgeois, è un fenomeno internazionale e noi faremmo bene a non lasciarlo cadere in tentazione,
fidando ciecamente nel fatto che solo l’uomo-massa tedesco sia capace di atti tanto spaventosi»
(ibidem).» (Flores D’Arcais 2006, 202,203)
E ancora: «Il totalitarismo è il grado zero dell’esistenza autonoma, dunque della libertà.
L’annientamento — senza residui — del carattere irripetibile dell’esistenza umana nell’identico del
replicante. La conclusione di Hannah Arendt — proprio nelle pagine finali delle Origini del
totalitarismo — è inequivoca: «Il dominio totale, che mira a organizzare gli uomini nella loro
infinita pluralità e diversità, come se tutti insieme costituissero un unico individuo, è possibile
soltanto se ogni persona viene ridotta a un’immutabile identità di reazioni, in modo che ciascuno di
questi fasci possa essere scambiato con qualsiasi altro. Si tratta di fabbricare qualcosa che non
esiste, cioè un tipo d’uomo simile agli animali, la cui unica libertà consisterebbe nel preservare la
specie». L’esistenza irripetibile e il replicante costituiscono dunque i due poli estremi della vita
umana: la libertà a un capo, la necessità all’altro. […] Il progetto totalitario mira all’insieme della
società, all’abrogazione del cittadino, trasformato in essere perfettamente fungibile, perfettamente
riproducibile, sostituibile, convertibile: ma nel benessere. Il totalitarismo ha sempre il suo coté
“sociale”. Il totalitarismo è la produzione (e riproduzione) del totalmente conforme. Il conforme,
all’opposto e ad annientamento totale dell’autonomia del ciascuno, è il segreto del totalitarismo. Il
successo totalitario è l’annichilimento totale della differenza e della singolarità che nella libertà
dell’agire può esprimersi. […] Il con-forme, vale a dire tutto ciò che uni-forma i comportamenti,
che riduce «gli uomini nella loro infinita pluralità e diversità» all’Uno, «come se tutti insieme
costituissero un unico individuo». (Flores D’Arcais 2006, 10-11)
30
4.2.1.4.2. (secondo meccanismo) la teoria del “prezzo da pagare” [il passaggio è già citato a
commento di un passo della Politica di Aristotele]; un esempio: la fallacia di una analogia volta «a
giustificazione dei “costi umani” inevitabili nella lotta per l’emancipazione di tutti»,
apparentemente presentata per sostenere la realizzazione di un ideale in realtà per giustificare ogni
ricorrente e varia riduzione dell’umanità a semplice mezzo per fini preordinati: «Non si può fare
una frittata senza rompere le uova.» Un detto che domina per decenni la vita del movimento
operaio, con Lenin, poi soprattutto con Stalin, ma che può essere ripreso in molti altri contesti: in
nome del progresso, sviluppo, futuro… «“la saggezza” dei proverbi genuinamente popolari è in
genere la cristallizzazione di una lunga tradizione di autentico pensiero filosofico o teologico»
(Hannah Arendt) […] Il successo, quando è inteso come valore in sé, e dunque “a qualsiasi prezzo”,
può diventare la tomba della politica, perché invece di costituire il culmine di un’azione può
annientarne la possibilità stesa, può sottrarre cittadinanza, può eclissare la democrazia» (citazione e
note [non del tutto fedeli] da Flores D’Arcais Paolo 2006 Hannah Arendt. Esistenza e libertà,
autenticità e politica, Fazi editore, Roma, 206-7, 211)
4.2.1.4.3. (terzo meccanismo) la teoria del “male minore” e la scarsa attenzione o la voluta
trascuratezza nei confronti di elementi etichettati come dettagli, aspetti secondari, dati irrilevanti o,
appunto, “male minore”: «La teoria del “male minore” consente insomma di cancellare tutti i mali
delle democrazie liberali e di rendere sospetta in anticipo (di filocomunismo, e al limite di
tradimento) ogni analisi critica dei medesimi. Ma questi “mali minori”, che in realtà sono forme
pesantissime di oppressione ed emarginazione, dunque di abrogazione pratica della cittadinanza e di
vera e propria disumanizzazione per chi vi trascorre la vita, costituiscono proprio il brodo di coltura
per la rinascita, sebbene in forme inedite, dei trascorsi totalitarismi. Ecco perché «ogni evidenza
storica e politica indica chiaramente il nesso assai stretto che esiste tra il male minore e il male
maggiore» (ibidem). Una sola conclusione si impone, perciò, come «conclusione ovvia […] la
negazione radicale del concetto stesso di male minore in politica, poiché, lungi dal proteggerci dai
mali maggiori, i mali minori ci hanno invariabilmente condotto ai primi» (2,45).» (Flores D’Arcais
2006, 215) «Solo la coerenza e l’intransigenza nel combattere tutte le ingiustizie, tutti i mali politici
e sociali, può salvarci dal rischio del totalitarismo, sempre incombente nelle nostre fragili
democrazie. Solo la radicalità della (auto)critica nei confronti delle nostre forme di convivenza può
impedire quella lenta assuefazione all’eclissi della democrazia che, in quanto rischio, è l’ombra che
accompagna in permanenza la democrazia stessa. E l’assuefazione a tale eclissi, così come
l’assuefazione a ogni “male minore” politico o sociale, è la via maestra dell’abbattimento delle
barriere immunitarie contro la deriva totalitaria. Un percorso che Hannah Arendt ha potuto
osservare di persona, nella metamorfosi della Germania del buon “padre di famiglia”, da Weimar
alla Notte dei Cristalli.» (Flores D’Arcais 2006, 216)
Chi sceglie il male minore dimentica rapidamente di avere scelto a favore del male.
Questa riflessione richiama ancora Aristotele: «I rivolgimenti politici avvengono a volte perché si
trascurano i piccoli mutamenti: voglio dire che spesso sfugge che si sta producendo un grande
mutamento nelle istituzioni legali, quando si trascura un dettaglio.» (Aristotele, Politica 1303a20s)
«Le sedizioni nascono non per cose di poco conto ma da occasioni di poco conto per cose
importanti.» (Aristotele, Politica 1303b17)
Un’eco nell’opera di Abbott A. Edwin 1884 Flatlandia (Einaudi, Torino 2011, p. 58). «Il pericolo
era invero grande. I Sacerdoti parevano non avere altra scelta che la sottomissione o lo sterminio; e
poi, all’improvviso, il corso degli eventi fu rovesciato da uno di quei singolari episodi che gli
Statisti non dovrebbero mai sottovalutare, bensì spesso prevedere e talora persino innescare, data la
forza assurda e spropositata con cui riescono a far leva sui sentimenti del volgo.»
4.2.1.4.4. (quarto meccanismo) rivendicazione e massimizzazione di appartenenze identitaria (e il
parallelo sottrarsi alla partecipazione civile)
«Questo deserto di partecipazione e di senso fa esplodere la tentazione di appartenenze e identità
surrogatorie della cittadinanza sottratta. Identità concorrenziali e infine incompatibili con essa (non
solo, sia chiaro, quando si arriva all’estremo dei fondamentalismi: ma ogni volta che una
31
appartenenza parziale, cioè privata, conti più dei comuni valori di libertà eguale scritti nelle
costituzioni e calpestate nelle pratiche di governo). Il rafforzarsi di questa pulsione alle identità
surrogatorie [e il moltiplicarsi della prassi o abuso della obiezione di coscienza] spegne
ulteriormente l’impegno per la cittadinanza, e ne rende l’ulteriore sottrazione da parte del politico di
professione ancora più agevole. E via ricominciando. La cittadinanza sottratta produce perciò nuova
sottrazione di cittadinanza, in una spirale viziosa che asintoticamente tende al totalitarismo.» (Flores
D’Arcais 2006, 15)
In questo contesto Arendt interviene con coraggiosa posizione critica sul tema della identità ebraica
e osserva: «Dicendo “un'ebrea” non mi riferivo neppure a una realtà dotata di una storica
specificità. Al contrario, non riconoscevo altro che un fatto politico, attraverso il quale il mio essere
un membro di quel gruppo finiva per avere il sopravvento su tutte le altre questioni di identità
personale o piuttosto le decideva in favore dell’anonimato. Oggi un tale atteggiamento potrebbe
sembrare una posa. Ecco perché oggi é facile notare che quelli che si sono comportati in quel modo
non hanno imparato molto alla scuola dell'“umanità", anzi sono caduti nella trappola di Hitler; ossia
sono stati succubi dello spirito dell’hitlerismo a modo loro. Sfortunatamente, il principio
maledettamente semplice che è qui in questione rientra in quelli che è particolarmente difficile
comprendere in tempi di diffamazione e persecuzione: non ci si può difendere se non nei termini
dell'identità che viene attaccata. Coloro che rifiutano le identificazioni che vengono loro imposte da
un mondo ostile, possono sentirsi mirabilmente superiori al mondo, ma la loro superiorità non e più
di questo mondo; e la superiorità di un "paese dei sogni” più o meno ben attrezzato.» (Arendt 1994,
nel saggio L’umanità in tempi bui. Riflessioni su Lessing, 223) E afferma ancora «L’umanità
specificamente ebraica, caratterizzata dall’acosmia, era qualcosa di molto bello.» (Arendt 1994, 19).
Il detto forte di Arendt, “sono caduti nella trappola di Hitler”, può lasciarsi interpretare: 1. Hanno
assunto quell’identità (ebraica) come unica e uniforme per loro, separandola dalla sua ricchezza e
varietà storica, dal mondo, dalle relazioni in cui era pienamente e produttivamente inserita,
ipostatizzandola, imponendola in astratto come un assoluto… vittime in questo del progetto
hitleriano di sterminio. 2. Creando Israele hanno fortemente legato l’ebraismo al concetto di
nazione, negandone le caratteristiche cosmopolitiche che lo contrassegnavano e lo contrassegnano e
si sono autodeportati (usando il sionismo e ancora vittime) geograficamente e culturalmente (come
avrebbe voluto, follemente, Hitler in un suo primo progetto).
4.2.1.4.5. (quinto meccanismo) apparati e populismo per un consenso/consumo gaudente
«Questi sono infatti due modelli che si rincorrono nel moderno oscurarsi della promessa
democratica: la partitocrazia dei partiti macchina, sempre più simili fra loro, con i rispettivi
ingegneri del consenso e il gigantismo di apparati burocratici e autoreferenziali. E il populismo
taumaturgico, con i suoi improbabili unti del signore, i suoi inverecondi piazzisti di felicità e il
frastuono ebete dell’applauso a comando. I due modelli non si escludono affatto, del resto, e in
variegato meticciato sembrano anzi celebrare ormai postmoderni baccanali in versione catodica.
Ovunque nel mondo.
Insomma. Hannah Arendt ha precocemente diagnosticato nell’insediarsi strutturale del
conformismo e nell’affermarsi onnivoro del consumismo i vettori di un oscuramento della
democrazia che la espone alla distruzione attraverso le tossine dell’apatia e la palude delle
irresponsabilità. Nulla di diverso ci si può infatti aspettare dall’annientamento di pluralità e
individualità che accompagna l’occupazione della sfera pubblica da parte della logica privata. Una
deriva niente affatto fatale, però. Nell’esistenzialismo libertario di Hannah Arendt, un fatto non
viene mai trasfigurato a destino. La contingenza del reale offre sempre spazio alla volontà. È una
scelta-per-l’accidia quella che in effetti governa e produce le intimazioni e intimidazioni di ogni
filosofia della necessità. […] Quella populista, che avanza in Europa con accattivante passo
cadenzato e conosce in USA i nuovi fasti di un sabba, ha solo qualche luccicante apparenza di
alternativa alla partitocrazia, poiché recluta fuori degli apparati tradizionali i nuovi padroni del
consenso, e parla il linguaggio azzerato degli spot, questa koiné dello spirito acritico
contemporaneo. […] La sottrazione di politica e responsabilità ai singoli individui, cioè la
32
spoliazione di autonomia, libertà e potere che colpisce la volontà di tutti, privata del suo habitat di
sfera pubblica, si è fatta solo più devastante anche se meno avvertita, ora che a propiziarla non è più
l’anonimo grigio di macchine burocratiche, ma il sontuoso vuoto multicolore di macchine per
sognare.
La fedeltà dell’obbedienza si conferma più che mai virtù “civica” per eccellenza, con il
perfezionamento che la vuole esultante. La voluttà teleonanistica dell’applauso acritico seppellisce
con il suo perentorio entusiasmo ogni residuo “vizio” critico. Del resto i nuovi potenti, quando già
non siano riciclaggio del passato prossimo, si installano perfettamente nella logica del ceto politico
come gilda di cooptazioni, e vieppiù la trincerano. […] L’Occidente dell’onnipervasività televisiva
non è il totalitarismo, ma la descrizione precedente è fedele resoconto della condizione
comunicativa media nelle società video-opulenti. Siamo al grado zero della simmetria
comunicativa. Ci si parla solo lasciandosi parlare dalla non-parola del piccolo schermo. Ci si
comunica le rispettive realtà solo attraverso il suo mondo fittizio, assunto come unico mondo
comune epperciò vero. Si entra in relazione passando per l’assunzione e interiorizzazione di un
codice conformizzante e cloroformizzante, ma con ciò si può comunicare solo una onnilaterale
abdicazione alla critica.» (Flores D’Arcais 2006,186-189 passim)
4.3. Chiarificazione e contrapposizione: Che cos’è la politica?
4.3.1. nascita e inizio: libertà e possibilità: la politica è tale solo quando produce un “nuovo
inizio”
4.3.1.1. la libertà. Riprendendo il passo già citato [in 3., introduzione] e riassumendone le questioni:
«Alla questione del senso della politica si può dare una risposta così semplice e convincente, da
rendere in apparenza del tutto superflue ulteriori risposte. La risposta è: il senso della politica è la
libertà. […] Ma oggi proprio questa risposta non è né ovvia né immediatamente evidente […] La
nostra domanda è dunque molto più radicale, molto più aggressiva, e anche molto più disperata: la
politica ha ancora un senso? […] in primo luogo l’esperienza dei regimi totalitari, che
pretendevano di politicizzare appunto totalmente l’intera esistenza degli uomini; con il risultato che
lì la libertà cessa di esistere. […] In secondo luogo la domanda è inevitabile se si considera
l’enorme sviluppo dei moderni strumenti di distruzione [e di distrazione (io)] il cui monopolio è
detenuto dagli stati, che senza quel monopolio statale non avrebbero mai raggiunto una tale
espansione e il cui impiego è possibile solo nell’ambito della sfera politica. »
Arendt Hannah 1993 Che cos’è la politica?, Edizioni di Comunità, Milano 2001, p. 21-22
4.3.1.2. l’inizio… i molti inizi contro la coercizione totalitaria e ideologica, la logica politica. Ogni
nascita è inizio; questo è il senso e l’essenza (politica) dell’umano (naturale e sociale).
«Questa coercizione interiore è la tirannia della logicità alla quale non si oppone altro che la grande
capacità umana di dare inizio a qualcosa di nuovo. La tirannia della logicità comincia con la
sottomissione della mente alla logica come processo senza fine, su cui l’uomo si basa per produrre
le sue idee. Con tale sottomissione egli rinuncia alla sua libertà interiore (come rinuncia alla sua
libertà di movimento quando si inchina a una tirannia esterna). La libertà in quanto intima capacità
umana si identifica con la capacità di cominciare, come la libertà in quanto realtà politica si
identifica con uno spazio di movimento fra gli uomini. Sull’inizio nessuna logica, nessuna
deduzione cogente ha alcun potere, perché la sua catena presuppone l’inizio, sotto forma di
premessa. Come il ferreo vincolo del terrore è inteso a impedire che, con la nascita di ogni nuovo
essere umano, un nuovo inizio prenda vita e levi la sua voce nel mondo, così la forza autocostrittiva
della logicità è mobilitata affinché nessuno cominci a pensare, un’attività che, essendo la più libera
e pura fra quelle umane, è l’esatto opposto del processo coercitivo della deduzione. Il regime
totalitario può esser sicuro solo nella misura in cui riesce a mobilitare la forza di volontà dell’uomo
per inserirlo in quel gigantesco movimento della storia o della natura che usa l’umanità come suo
materiale e non conosce né nascita né morte. […] Il suddito ideale del regime totalitario non è il
nazista convinto o il comunista convinto, ma l’individuo per il quale la distinzione fra realtà e
finzione, fra vero e falso non esiste più.» (Arendt 1951, 648-649)»
33
4.3.1.3. Anche dal punto di vista di una filosofia della storia: né essenze astratte né cammini
precostituiti; essenze e storie a disegno che hanno nelle ideologie il proprio fondamento.
4.3.1.3.1. le essenze universali. «… mette in chiaro come a suo giudizio tutti gli approcci
«essenzialistici», volti a scoprire delle presunte «essenze atemporali» che si rivelerebbero nella
storia, sono fuorvianti e si precludono la reale comprensione delle specificità degli avvenimenti. Dal
canto suo, afferma di non aver cercato «una rivelazione graduale dell’essenza del totalitarismo» in
quanto, a suo parere, «quest’essenza [..] non esiste prima di essere venuta alla luce» (Arendt 1951,
S. Forti XXXV)
4.3.1.3.2. la storia a disegno. «Il ricorso a un fondamento metastorico (declinato in tutte le forme di
surrogato di Dio: Natura, Sangue e Suolo, Destino eccetera) è del resto il vizio ricorrente con cui la
filosofia (anche la filosofia politica!) ha emarginato la politica degli uomini reali, cioè plurali, o l’ha
considerata con gran sospetto.» (Flores D’Arcais 2006, 224)
«In altre parole, non esiste un progetto razionale della storia: né in positivo né in negativo. La
critica che Hannah Arendt rivolge, nelle sue opere pubblicate, sia alle idee apocalittiche che a quelle
di progresso, traspare anche dai frammenti postumi. In quest’ottica, il «progresso» appare
«necessariamente catastrofico», e induce a dubitare che gli uomini «possano ancora mantenere la
padronanza del mondo da essi costruito e delle faccende umane che vi si svolgono» (p. 65).
Dall’attuale situazione estrema e in apparenza senza vie d’uscita, sembra d’altro canto derivare una
certa costrizione, che può indurre gli uomini a riflettere sul pericolo in cui si sono cacciati con le
loro stesse mani. La speranza deriverebbe allora dalla possibilità che tale riflessione prepari il
terreno a un agire, nel senso di una affermazione dell’umanità. Non è scritto testualmente, ma
corrisponde al pensiero della Arendt in quel periodo. Nei manoscritti si afferma che «un
cambiamento decisivo in direzione della salvezza può giungere solo per una sorta di miracolo» (p.
24), e che in tale contesto l’autore del miracolo è l’uomo, il quale, essendo a sua volta un inizio, può
cominciare qualcosa di nuovo: può agire (p. 26).» (Arendt 1993, 126 di Ursula Ludz)
4.3.1.3.3. il no alla storia a disegno, fatalistica e necessitante, è il no alla ideologia che di quella
concezione è fonte e radice continua, instancabile e versatile.
«Le ideologie — ismi che per la soddisfazione dei loro aderenti possono spiegare ogni cosa e ogni
avvenimento facendoli derivare da una singola premessa — sono un fenomeno molto recente e, per
parecchi decenni, hanno avuto una parte trascurabile nella vita politica. Solo col senno di poi
possiamo rintracciare in esse certi elementi che le hanno rese così utili per il dominio totalitario,
tanto che le loro grandi potenzialità politiche non sono state scoperte prima di Hitler e Stalin.
Le ideologie sono note per il loro carattere scientifico: esse combinano l’approccio scientifico con
risultati di rilevanza filosofica e pretendono di essere una filosofia scientifica.» (Arendt 1951, 641)
«Un’ideologia è letteralmente quello che il suo nome sta a indicare: è la logica di un’idea. La sua
materia è la storia, a cui l’«idea» è applicata; il risultato di tale applicazione non è un complesso di
affermazioni su qualcosa che è, bensì lo svolgimento di un processo che muta di continuo.
L’ideologia tratta il corso degli avvenimenti come se seguisse la stessa «legge» dell’esposizione
logica della sua «idea». Essa pretende di conoscere i misteri dell’intero processo storico — i segreti
del passato, l’intrico del presente, le incertezze del futuro — in virtù della logica inerente alla sua
«idea».» (Arendt 1951, 642)
«Appena la logica come movimento di pensiero — e non come suo necessario controllo — viene
applicata a un’idea, questa si trasforma in una premessa. Le visioni ideologiche del mondo hanno
compiuto questa operazione molto prima che diventasse così fruttuosa per il ragionamento
totalitario. La coercizione puramente negativa della logica, la messa al bando delle contraddizioni,
diventava «produttiva», di modo che tutta una linea di pensiero poteva essere iniziata, e imposta alla
mente, traendo conclusioni nella maniera della mera argomentazione.» (Arendt 1951, 643)
«… la storia non può essere comandata o progettata e insomma costruita dall’uomo, così come si
fabbrica un oggetto. E non può esserlo, perché la storia è il “prodotto” della pluralità degli essere
umani. Pluralità irriducibile (la pluralità è la legge della terra: «gli uomini, e non l’Uomo, vivono
sulla terra e abitano il mondo»). L’agire comune non è mai un agire-Uno, non dà mai luogo a un
34
Soggetto della Storia. Nella realtà non si danno maiuscole, se non come umana pulsione alla fuga
metafisica. Per questo motivo la storia è contingenza.
La storia è un mero «labirinto dei fatti», e tutte le filosofie della storia, benché in polemica
concorrenza reciproca, condividono per la Arendt il vizio della filosofia della storia per eccellenza,
quella hegeliana: di voler leggere nella Storia un senso, una razionalità, una logica, un destino,
dunque un Soggetto, sia esso la Divina Provvidenza di una religione rivelata, o l’autorealizzazione
dello Spirito (che quella religione del resto invera), o la dialettica del conflitto di classe, o la
diltheyana auto-oggettivazione della coscienza che si trascende senza fine. O, si potrebbe
legittimamente aggiungere, l’ascolto dell’Essere e del suo ri-velarsi attraverso le sue epoche.»
(Flores D’Arcais 2006, 52)
[si potrebbe dire forse che la storia costituisce una quarta idea trascendentale della ragione secondo
la logica della dialettica esposta da Kant nella Critica della Ragion pura: principio di sistema ma
fonte di illusione se considerato come esistente in sé o reale.]
«La critica impietosa di ogni filosofia della storia costituisce in Hannah Arendt una sorta di
interfaccia tra il suo pensiero politico e la sua filosofia tout court (se queste distinzioni in “generi”
hanno poi senso.)» (Flores D’Arcais 2006, 58-59)
«Hannah Arendt muove da premesse opposte, come sappiamo, e le tiene ferme. La vicenda umana è
il luogo dell’inatteso, delle conseguenze impreviste, degli effetti perversi. La varietà delle situazioni
non è calcolabile, sfugge alla previsione, e perciò al controllo, non per difetto di strumenti e
tecniche diagnostiche (ritardi metodologici ed epistemologici colmabili in futuro), ma per status
ontologico degli eventi stessi, che sono prodotti di azioni, si svolgono sotto la categoria della
possibilità, eccedono sempre, almeno virtualmente, sul già accaduto. […] In altri termini. L’evento
è contingenza. Ciò che avrebbe potuto anche non essere. […] La storia non è persona. Proprio così,
invece, la immagina la filosofia della storia. Che produce per questa via, ipostasi.» (Flores D’Arcais
2006, 157, 158, 167)
E ancora. « La pretesa che esista un’azione politica “scientifica” può farsi strada, esattamente come
le filosofie della storia, solo sulle macerie della volontà, solo a partire dal disconoscimento di una
scelta libera.» (Flores D’Arcais 2006,168) Il pensiero di Hannah Arendt «costituisce anche una
sistematica e affascinante caccia alla produzione di ipostasi da parte della filosofia, poiché
l’ipostasi, quali che siano le forme che assume, è sempre anche un annientamento e un
disconoscimento dell’esistenza finita. Una sua riduzione a predicato dell’universale trasformato in
persona. […] Si può procedere per ipostasi, si può tener fermo il finito» (Flores D’Arcais 2006,169,
170)
4.3.1.3.3.1. una deriva ideologica che annulla l’azione libera del cittadino nelle attese messianiche o
negli improvvisi risvegli di senso politico.
«Questo positivo risveglio non è tuttavia privo di rischi e pericoli. La soluzione di problemi
complessi e antichi non si improvvisa, l’epoca dei miracoli è finita, non esistono bacchette magiche.
I risvegliati debbono partecipare con tenace intelligenza alla costruzione della nuova società; è
giusto che chiedano fatti e non parole, ma i fatti non cadono dal cielo, sono le tappe d’un percorso e
d’un impegno.
I risvegliati debbono contribuire alla costruzione di quel percorso e garantire il loro impegno,
altrimenti il vento nuovo si affievolirà, tornerà la bonaccia e l’indifferenza, l’attesa di improbabili
miracoli e d’una nuova figura carismatica che si proponga come l’ennesimo uomo della
provvidenza. Non esistono uomini della provvidenza se non nella fantasia di sudditi che si rifiutano
di diventare cittadini.» (Scalfari Eugenio, in la Repubblica 26.06.2011)
4.3.1.4. potere inteso dunque come inizio e libertà del cittadino.
«Solo nella sfera pubblica, invece, dunque nell’essere insieme dell’esistenza politica, è dato
davvero agire. Laddove azione significa non già «l’applicazione delle leggi o l’implementazione
delle regole o qualsiasi altra attività gestionale, ma l’inizio di qualcosa di nuovo il cui esito sia
imprevedibile» (2, 199-200). Libertà e potere, per Hannah Arendt, ineriscono sempre e solo
esclusivamente all’azione, intesa in questa accezione.
35
Il potere, come essenza della politica, va dunque rigorosamente distinto tanto dal successo quanto
dalla violenza. Si può avere successo (e relative gratificazioni) nella sfera privata, senza per questo
essere liberi. Si può godere di privilegi anche enormi, senza per questo esercitare potere (nel senso
di dar inizio a qualcosa di imprevedibile). E si può esercitare violenza e oppressione (“potere” nel
senso tradizionale), ma con ciò si porta all’estremo la distruzione della politica e della capacità di
azione degli esseri umani. E si annienta il potere degli individui in quanto tali, nella loro libertà di
sottrarsi agli imperativi di logiche e percorsi già prefigurati. Solo l’uomo in-calcolabile è davvero
un uomo libero, un individuo autentico.
«Il potere di tutte le cose reali […] è il potere di oltrepassare e superare tutti i nostri calcoli e
aspettative» (2, 94), tanto che «la parola arché significa sia inizio che governo» (2, 95), perché è
proprio l’azione-potere-libertà che crea la norma, questa realtà puramente umana, che non si trova
in natura, questo dover-essere che eccede sempre e inesorabilmente l’essere. L’uomo è libero,
esercita potere, “fa” politica, in quanto è il creatore e signore della norma (benché per millenni, di
fronte all’abisso di responsabilità di questo potere, abbia immaginato la norma stabilita ab aeterno
dall’Alto e dall’Altro). In quanto, insomma, attraverso la comunicazione tra eguali in uno spazio
pubblico simmetrico, decide e dice la norma (e crea le istituzioni corrispondenti, e inventa le forme
di lotta per realizzarle).
Ecco perché la certezza del diritto — e dunque la divisione dei poteri, e l’autonomia di quello
giudiziario — costituisce una precondizione irrinunciabile perché si diano cittadino, libertà, potere.
Commentando Montesquieu, Hannah Arendt annota: «Il declino delle nazioni comincia con il venir
meno della legalità, o perché vi è un abuso della legge da parte del governo in carica o perché viene
messa in dubbio o contestata l’autorità della loro fonte. In entrambi i casi, le leggi non sono più
ritenute valide. Ne consegue che la nazione, oltre a non “credere” più nelle proprie leggi, perde la
propria capacità di agire politicamente in maniera responsabile: gli individui cessano di essere
cittadini nel senso pieno della parola» (2; 88).» (Flores D’Arcais 2006, 204-205)
4.3.1.5. Intesa come luogo di perenne inizio e di piena presenza dei cittadini, depurata dei pregiudizi
e delle degenerazioni o distruzioni, allora la politica diventa fine a sé, endofinalistica perché sede
del bene supremo. Vi è un evidente sintonia tra la convinzione di Aristotele che pone la politica al
vertice delle scienze e dell’agire dell’uomo («Il fine che si propongono tutte le scienze e le arti è un
qualche bene, ed è il bene massimo e più alto quello che si propone la più importante di tutte le
scienze. La più importante è la politica e il bene che la politica si propone di raggiungere è la
giustizia, cioè ciò che è utile alla comunità.» Aristotele, Politica 1282b14) e l’affermazione di
Arendt «La politica non ha uno scopo più elevato di se stessa». (Flores D’Arcais 2006, 208) Ma non
vi è qui nulla dell’Assoluto, o dello Stato Assoluto cui avrebbero pensato Hegel e molti rami della
tradizione del pensiero politico. La situazione si configura come un ossimoro: la politica è fine a se
stessa ed è la forma più perfetta del sociale, si presenta quindi come un assoluto o un principio, la
politica è strutturalmente definita dalla contingenza.
4.3.2. responsabilità storica (non naturale) nelle cose e la contingenza della politica.
«Cosa è dunque per Hannah il male? È la giustificazione attraverso la deresponsabilizzazione. La
“giustificazione” proprio nel senso delle dispute teologiche: il rendersi giusti agli occhi di... (in
questo caso degli uomini, e solo eventualmente di un Dio). È la giustificazione attraverso l’ordine
ricevuto, ma ancor più in nome di quell’impersonale «si faceva così» che dovrebbe significare “lo
facevano tutti” ma consente di cancellare quanti NON si piegarono, furono capaci di opporsi e
resistere. […] Si tratta infatti non solo della giustificazione attraverso l’obbedienza, ma ancor più
attraverso quell’obbedienza senza comando personale che è il conformismo, l’interiorizzazione del
comportamento medio anonimo come proprio dovere personale. Di replicante, appunto.» (Flores
D’Arcais 2006, 40) Il nomos, qui (così inteso o usato) rende irresponsabili; è indicato come il
principio e la base della propria irresponsabilità, del proprio chiamarsi fuori (che è un chiamarsi
fuori ad un tempo dall’etica e dalla politica).
36
«L’obbedienza alla uni-formità, il piegarsi ovvio, a-problematico e magari appagato alla logica
dell’Uno (dalla «suprema volontà del Führer», al «si fa», al «Dio lo vuole», al «‘twas my yob»: ed
ennesime varianti postmoderne). Non più l’autos nomos e la responsabilità verso di esso, ma il
nomos qualunque purché degli altri. Purché ci renda irresponsabili.
E se tutto ciò si compie nel totalitarismo in modo totale, nondimeno caratterizza con vari gradi di
intensità e pervasività anche le società di massa che si vogliono democratiche (ma nelle quali la
simmetria della comunicazione e la libertà di agire-per-la-decisione sono state private, a vantaggio
di nomenklature e altri establishment). […] Si pensi, ad esempio, alla giustificazione — ormai da
nessuno più contestata — di tutti i mali sociali (dalla disoccupazione ai paradisi fiscali, passando
per gli omicidi bianchi) messi regolarmente in conto come inevitabili al Mammona del mercato o al
Vitello d’Oro della modernità. Mai alle responsabilità di governo…» (Flores D’Arcais 2006, 41)
[va forse indicato, nell’elenco, il ricorso strumentale e disinvolto alla obiezione di coscienza per
opportunismo e carriera, per utili appartenenze identitarie…]
4.3.2.1. Si tratta di giustificazioni che segnalano una doppia situazione: 1. come si possa sospendere
la responsabilità senza avvertire tale assenza come un abbandono dell’etica; 2. come tale
atteggiamento sia diffuso e sia diventato un costume sociale, una normalità politica. A denuncia di
tale abuso, che diventa aberrazione nella politica, spunta (errata se enfatizzata) una
contrapposizione di impostazione tra l’etica della responsabilità e l’etica dell’intentio, se la
definizione della moralità dell’atto con riferimento all’intentio di chi lo compie diventa una abile
strumento per sottrarsi alle responsabilità del vivere con e nel mondo. (cfr. (Flores D’Arcais 2006,
60)
4.3.2.2. Si tratta dell’abbandono completo dell’etica ma con una forte giustificazione (e alibi):
attraverso il richiamo al diritto e all’obbedienza (quindi alla stessa etica); si accede di conseguenza
ad un ordinamento politico del tutto estraneo all’etica (all’ethos di cui parlava Aristotele come
condizione di realizzazione della polis, della sua costituzione e delle sue leggi, in termini di
koinonìa e di libertà), consegnato quindi al potere come polizia e violenza, educazione alla
sudditanza. La politica e le sue leggi diventano la possibilità per chiamarsi fuori da ogni moralità
universale, dalla dimensione dell’umanità. Se persiste una morale questa resta consegnata al
perbenismo dell’oikos. Va dunque ripensato il rapporto tra morale e politica. Il rapporto etica e
politica è indubbiamente complesso, definito da due imprescindibili aspetti: autonomia e relazione.
Come nell’impostazione di Aristotele, la politica rimanda all’etica, ma entrambe hanno una propria
irriducibile autonomia. Se l’etica assorbe in sé la politica rischia di trascurare la logica che ispira la
convivenza sociale e che sostiene l’arte di governo; se la politica assorbe l’etica annulla la persona
come sede prima dei principi e dei valori etici e morali e piega la morale alla sola logica di governo.
Non possono fondersi, non possono ignorarsi devono entrare in una relazione che rispettandone
autonomie e principi le valorizzi entrambe in vista dei fini iscritti nei loro postulati. Tra etica e
politica si impone dunque una separazione e una responsabile relazione; con l’effetto di rilanciare
l’etica e riscoprire la politica.
4.3.2.3. circolarità autodistruttive della politica e della morale. Arendt ricostruisce i tentativi di
autoassoluzione espressi dai gerarchi e burocrati del nazismo, responsabili della shoah, ricordando
come vengano formulati attraverso il ricorso a molti alibi deresponsabilizzanti: ho rispettato gli
ordini, ho svolto la mia funzione, mi sono mosso nel sistema giuridico allora vigente, ho fatto
quello che tutti avrebbero fatto… È in riferimento a questa normale consapevolezza e diligente
scrupolo adottato nella esecuzione del progetto di sterminio di uomini, modalità che Arendt
definisce con la nota espressione “la banalità del male”, che si pone un problema politico di grave
rilevanza; si tratta della situazione creata dal totalitarismo per cui la distruzione della politica è
realizzata dalla politica, la distruzione della morale è ottenuta dalla morale, del diritto attraverso il
diritto. Una circolarità autodistruttiva che pone al centro della riflessione politica due domande
fondamentali:
37
4.3.2.3.1. la prima è la domanda che Arendt persegue in continuazione e che diventa,
emblematicamente, il titolo dell’ultimo suo progetto d’opera (incompiuto e pubblicato postumo):
che cos’è la politica? La politica ha ancora un senso?
4.3.2.3.2. la seconda è un tema classico, presente con trattazione esplicita in Platone e in modo
esteso nella Politica di Aristotele: lo studio della “degenerazione” (o, in modo più neutro,
trasformazione, evoluzione, relazione con…) delle diverse forme politiche. Poiché nazismo e
fascismo possono sostenere una presa del potere avvenuta per vie legali, o dimostrare che la politica
liberal-democratica ha reso possibile il loro avvento, il problema è quale strategia di governo possa
garantire ad un tempo l’evoluzione dei (o tra i) modelli politici, senza distruggere, in questa
evoluzione, l’essenza stessa della politica.
4.3.2.4. il caso da cui parte la riflessione. «Il processo ad Eichmann, però, avvia una riflessione
diversa e complementare a quella inaugurata con The Origins. Quasi che la Arendt si accorga che
non è più sufficiente guardare dall’esterno il rapporto tra totalitarismo, metafisica e politica; come
se non le bastasse più decostruire i bastioni con cui la metafisica ha soffocato la politica. Assistere,
come inviata del «New Yorker», al processo di Gerusalemme equivale per lei a un nuovo trauma.
Le procedure giuridiche portano ad evidenza che non serve soltanto indagare le origini e il
funzionamento di un sistema totalitario. Davanti alla corte sta una singola persona per giudicare la
quale bisogna andare al di là del sistema politico e ideologico di cui faceva parte. L’interrogativo a
cui si deve ora cercare di rispondere riguarda le “ragioni” di singole persone che hanno dato il loro
assenso attivo al regime. Bisogna indagare il funzionamento soggettivo dei «docili» funzionari del
regime. E da questa prospettiva che il totalitarismo mostra un volto terrificantemente banale.»
(Arendt 1951, pref. S. Forti p. XLV-XLVI)
4.3.2.4.1. il metodo autogiustificativo giuridico politico ed etico. «L’imputato al processo di
Gerusalemme si difende dalla realtà e trova rifugio nel ragionamento logico. Ricordiamo, di
passaggio, la dura polemica già condotta dalla Arendt nelle Origins e ripresa in The Life of the
Mind, sulla pericolosa autoreferenzialità del ragionamento logico e della concezione della verità
come adeguazione di cosa e rappresentazione. Seppure in maniera del tutto inconsapevole e
grottesca, anche la mente di Eichmann, come quella del filosofo, elude la realtà per attenersi
esclusivamente alla ferrea logica delle premesse ideologiche da cui parte. […] Eichmann, dotato
come sembra soltanto di una capacità deduttiva, si attiene rigidamente nelle sue risposte
all’applicazione di regole assolutamente prevedibili. Il suo continuo richiamarsi al dovere,
all’obbedienza della legge, all’esecuzione di ordini non è solo una strategia suggeritagli dalla difesa.
Egli, tuttavia, non è particolarmente stupido, o non più di milioni di altri tedeschi che al suo posto si
sarebbero comportati come lui. […] La mente di Eichmann, come la mente di tutti gli allineati, si
rifiutava di ammettere tutto ciò che poteva contraddire in un modo o nell’altro il sistema di
riferimento. Egli osservava infatti con zelo e lealtà l’imperativo del nuovo ordinamento. E il nuovo
comandamento, appunto, non recitava più «non uccidere», ma «tu devi uccidere»; non un nemico
che minaccia, ma persone inoffensive che avevano la colpa di fuoriuscire dai parametri di umanità
stabiliti dal regime. Il principio supremo, condiviso con numerosi suoi connazionali, la sua virtù per
eccellenza, consiste nell’obbedienza, nella convinzione che senza obbedienza nessuna comunità
politica si possa mantenere. […] Ma nel momento in cui l’uccisione degli ebrei diventa un dovere
morale, applicano il nuovo «imperativo categorico» senza la minima trasgressione. «La coscienza di
Eichmann — scrive la Arendt — era come un contenitore vuoto; essa non aveva un proprio
linguaggio, ma articolava la lingua della “società rispettabile”». […] Gli improbabili suoi rimorsi
vengono del tutto tacitati non appena assiste allo zelo con cui la «buona società» reagisce nel suo
stesso modo. […] La bancarotta novecentesca dell’etica può annoverare tra le sue cause anche la
lunga tradizione dell’obbligatorietà dei precetti morali, che ha posto quale proprio presupposto una
deresponsabilizzante relazione di comando e obbedienza.» (Arendt 1951, pref. S. Forti p. XLVIXLVIII)
Osservava Max Weber: « Sono proprio le nature di funzionari di grande levatura morale a far dei
cattivi politici, irresponsabili secondo il concetto politico della parola, e, in questo senso,
38
moralmente vili; tali, quali purtroppo ne abbiamo sempre avuti nei posti direttivi: ed è questo ciò
che chiamiamo «dominio dei funzionari » (Beamtenherrschaft)…» Weber Max 1919 Il lavoro
intellettuale come professione.La politica come professione, Einaudi, Torino 1966, 73
4.3.2.5. lettura, bilancio e proposta. «Si situa all’interno di queste considerazioni il problema del
giudizio riflettente che occupa la Arendt nell’ultima parte della sua vita. L’inesorabile banalità del
male sembra potersi arrestare soltanto attraverso un giudizio che riesce a distinguere, in assenza di
leggi e criteri condivisi, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In tale prospettiva la Arendt recupera,
dandole una curvatura del tutto particolare e assolutamente non trascendentale, la Terza Critica
kantiana. Il giudizio morale è affine al giudizio estetico che afferma «mi piace o non piace»; proprio
perché non è un giudizio determinante — che sussume il particolare sotto l’universale — ma un
giudizio riflettente, esso non può avvalersi di norme stabilite a priori. Ella individua un esempio
fattuale a favore del suo giudizio riflettente in «quei pochi» che rifiutarono il loro consenso al
regime, che non collaborarono e non si prestarono ad alcun tipo di azione. Se erano loro precluse le
vie della «responsabilità politica» — era forse assolutamente impossibile fare crollare il regime —
rimaneva pur sempre la chance della resistenza passiva. Una strada percorsa non dai convinti
assertori della perennità dei valori morali, ma semmai da chi era abituato a non attenersi al già
giudicato. Nell’astenersi, il criterio di quest’ultimi non ha coinciso con l’applicazione di una legge
universale al caso particolare, ma con la semplice impossibilità di convivere con se stessi qualora
avessero compiuto determinati atti. Come se avessero messo in pratica gli insegnamenti di Socrate:
è meglio subire un torto piuttosto che commetterlo; è meglio per me, essendo uno, essere in
contrasto con tutto il mondo piuttosto che con me stesso.» (Arendt 1951, pref. S. Forti p. XLVIIIXLIX)
Il giudizio determinante segue la logica della necessità e applica con rigore deduttivo le forme a
priori al dato dell’esperienza classificando secondo universalità. Il giudizio riflettente considera in
vista di un fine la cui realizzazione non prevede un termine storico o fisico: si tratta di una ripresa in
gestione del realtà dal punto di vista di una finalità che trasmette al reale e all’agire in esso un
nuovo principio di significato.
Qui si torna all’origine, ai postulati del pensiero politico di Arendt, in essi si incontrano la realtà
storica nella sua concretezza e l’agire dell’uomo che vive nel mondo, «non l’Uomo, ma gli uomini
abitano la terra»: la libertà, la contingenza e la possibilità. «La verità della politica è dunque la sua
pluralità, e riguarda il fatto che essa non può essere sottoposta a quella reductio ad unum di cui
spesso la filosofia (politicamente) si serve per semplificare le differenze. Ne consegue che la virtù
propria della sfera politica concerne l’essenziale rispetto per tale pluralità e contingenza.»
E si torna alla speranza per una umanità responsabile.
4.3.2.6. ma si è rotto l’incantesimo della politéia delineata o auspicata da Aristotele. Quello della
polis in cui la legge (nòmos) diventa costume (éthos), azione e stile di vita, habitus e seconda
natura.
«Ancora una volta il totalitarismo, ora impersonificato nel funzionario Eichmann, sollecita
l’attitudine decostruttiva di Hannah Arendt, che ora pone in questione i fondamenti stessi della
nostra tradizione etica. Il mondo odierno è un mondo post-totalitario non soltanto perché la politica
va ripensata radicalmente, essendo stata letteralmente spazzata via dai totalitarismi, ma anche
perché non è più possibile pensare l’etica e la morale come la filosofia e la religione le hanno
pensate. Non è più credibile pensare la virtù come un habitus che si può insegnare: si è visto con
quanta velocità può essere sostituito; così come è ormai inconcepibile un comportamento morale
inteso quale arretramento del particolare di fronte a una legge universale: se il «tu devi» rimane
vuoto e viene utilizzato come condizione necessaria e trascendentale del comportamento morale
effettivo, può giungere persino a giustificare l’impossibilità di resistere al male. Ma soprattutto non
si può più aderire a un’etica della virtù come al contributo soggettivo per la costruzione e il
mantenimento di un ethos condiviso. Nell’aristotelismo, sia esso antico o contemporaneo, come in
tutte le fogge di comunitarismo, la questione non è mai il comportamento etico del singolo, il valore
39
etico della scelta, ma se questa scelta è buona per il contesto in cui egli vive. Sia che si segua
l’universalismo kantiano, per cui morale è ciò che è giusto per tutti, sia che si segua il
particolarismo aristotelico, per cui morale, etico, è ciò che è bene per noi, la politica e la morale
rimangono strettamente connesse. Mentre per la Arendt il vero problema etico emerge in quelle
situazioni in cui morale e politica entrano in conflitto, quando il seguire le ragioni dell’una o
dell’altra costituisce un vero e proprio dilemma. La preoccupazione che percorre le riflessioni sul
giudizio e la potenzialità morale del pensiero non è quella di porre rimedio al possibile crollo dei
valori condivisi di una comunità. È semmai esattamente quella opposta: come è possibile resistere
al conformismo di un ethos collettivo.» (Arendt 1951, pref. S. Forti p. LI)
4.3.2.7 tornano antiche distinzioni: legge e arte di governo. Sia Platone che Aristotele più volte e
con forza sottolineano la necessità che l’arte di governo si eserciti nel rispetto delle leggi; solo
nell’ambito delle leggi e della costituzione che le guida e compone in armonia l’arte di governo
trova fondamento e giustificazione. Richiamato il contesto, necessario e imprescindibile del
governare, Platone e Aristotele tuttavia distinguono tra legge e arte di governo e danno a
quest’ultima un carattere di arte e di scienza autonomo. Perché se è necessario difendere l’uomo
dall’arbitrio governativo richiamando il governare al rispetto della legge, il massimo terrore viene
esercitato dal governare proprio quando intende ridurre l’uomo alla legge conformandone
biologicamente e culturalmente la natura secondo un’ideologia che diviene, allo scopo, un insieme
di legalità, giustizia, violenza e terrore. «La legalità pone dei confini alle azioni, ma non le ispira; la
grandezza, ma anche la limitazione delle leggi nelle società libere è che dicono soltanto quello che
non si deve, ma mai quello che si deve fare» (Arendt 1951, 639)
4.3.3. morale e politica: il problema della relazione. La ragione di una profonda frattura e come
rilanciare l’etica e la politica nella loro autonomia e nella loro relazione. Dalla loro separazione la
salvezza dell’etica e della politica.
4.3.3.1. la frattura. Il totalitarismo ha posto, creato il problema di una frattura tra etica e politica: ha
«creato una sorta di impossibilità di agire moralmente secondo precetti e norme»; e il problema di
un’etica possibile, per la sua autonomia e per la sua fondazione, solo fuori (e contro?) le regole;
un’etica che non ha nelle regole la propria legittimazione e ne deve avere una propria: la
responsabilità.
4.3.3.2. la separazione dell’etica dalla politica e l’etica della responsabilità diventa l’incontro con la
libertà, la singolarità, l’azione come inizio. Un doppio (introduttivo) aspetto: 1. responsabilità
morale e coinvolgimento del soggetto nella concretezza della sua storicità “io empirico; 2.
responsabilità morale e incontro, esperienza dell’“abisso della libertà” (non appendice di sistemi e
di processi storico-etici di assimilazione); l’incontro morale è esperienza dell’“abisso della libertà”.
«Non è possibile chiarirla per esteso, visto che l’autrice ha lasciato la sua elaborazione allo stato
aurorale. Si può tuttavia affermare che l’etica da lei prospettata separa la morale dalla politica; anzi
pone questa distinzione come propria condizione di possibilità; un’etica, dunque, che, oltre a
opporsi al primato dell’ethos collettivo sulle istanze dei singoli, decostruisce la concezione di un
soggetto morale che, confidando sull’autonomia della propria ragione, si pone a legislatore
universale. La messa in discussione di questi presupposti ci autorizza a pensare a una sorta di etica
radicale, che pensa insieme assenza di leggi e responsabilità, libertà e singolarità. Nel vuoto
dell’etica, la responsabilità morale è qualcosa che si rivolge a me, e soltanto al mio «Io empirico»;
una responsabilità che viene allenata dalla concretezza degli eventi. Nessun criterio universale e
nessun richiamo al dovere verso l’ethos di una determinata comunità possono giustificarmi per la
mia mancata responsabilità, per il mio non avvenuto giudizio. Che per la Arendt il totalitarismo
abbia fatto esplodere tutti i criteri etici tradizionali, abbia cioè creato una sorta di impossibilità di
agire moralmente secondo precetti e norme, significa che nelle sue opere si trova già quella
consapevolezza — raccolta e pensata più a fondo, da alcuni filosofi contemporanei — che pone
l’impossibilità come condizione di possibilità della responsabilità, vale a dire dell’etica. Non vi è
infatti etica senza responsabilità, ma non vi è responsabilità senza qualcosa che impedisce, che
40
ostacola, senza un’obbligazione duplice e ultimativa. Non si è responsabili in senso proprio finché
non ci si confronta con l’assenza di criteri, col vuoto. Finché non si è di fronte a quello che la
Arendt chiama «L’abisso della libertà». Solo quando siamo «condannati a essere liberi» il giudizio
diventa la prassi della responsabilità. Non ci sarebbe responsabilità senza l’esperienza di un’aporia;
se potessimo appellarci alle regole di un sapere acquisito, la decisione sarebbe già presa, in questo
senso ci sarebbe irresponsabilità, mancanza di giudizio. Esercitare la responsabilità nell’ordine del
possibile, facendo del giudizio la semplice messa in atto di un sapere normativo significa
trasformare la morale in una tecnica; una tecnica da esercitare, però, soltanto «in tempi normali». La
possibilità della vera responsabilità si apre quando si è costretti a giudicare in quelle situazioni in
cui le condizioni del giudizio determinante sono venute meno. Quest’etica, allora è ciò che resiste
alla normalizzazione, alla socializzazione globalizzante all’universalizzazione di ogni tipo,
soprattutto quando essa assume le grottesche sembianze della Gleichschaltung.» [assimilazione,
equiparazione, livellamento del voler essere in conformità con lo spirito dei tempi, spinti dal timore
di non essere in linea con il momento, o dal “fervore improvviso di non perdere il treno della
storia”]. (Arendt 1951, pref. S. Forti p. LII-LIII)
4.3.3.3. per una ripresa del doppio in politica e, di nuovo, il rilancio dell’etica e della politica. Le
basi per riprendere la relazione tra politica ed etica: la responsabilità, il potere-libertà di ciascuno
nel partecipare è rilancio dell’etica e della politica: cooperanti in forza della loro autonomia e del
loro rafforzamento.
«… dopo l’esperienza cruciale del totalitarismo, «l’interesse per la politica è diventato una
questione di vita e di morte per la filosofia stessa» (2, 217). Solo la politica ci può salvare (e può
salvare la filosofia), perché solo l’azione (in senso arendtiano, cioè il potere-libertà di ciascuno nel
suo essere-con-gli-altri e nel partecipare di una democrazia rappresentativa radicalmente rinnovata)
può costituire un antidoto efficace ai virus pre-totalitari presenti nel liberismo-liberalismo.» (Flores
D’Arcais 2006, 225)
I termini libertà, possibilità, inizio, contingenza… definiscono l’essenza della politica; su queste
basi la logica del politico, come visto, non è quella della deduzione rigorosa secondo necessità da
postulati di natura ideale universale e astratta, ma è quella della possibilità legata ad un tempo a
obiettivi, progetti e fini, ma anche alla complessità delle relazioni e alla contingenza delle soluzioni.
Questo il terreno dell’incontro politica e morale. Forse è ancora utile ricordare il modello
aristotelico che lega morale e politica (l’agire virtuoso nella polis) dopo aver rigorosamente trattato
in forma separata i due campi. Non è la politica a determinare con le proprie leggi i valoti, i principi
e i fini dell’etica, né viceversa in traduzione immediata. Si rende necessaria l’autonomia fondativa
dei due ambiti e la loro relazione. A questa logica, dell’autonomia e della relazione, è consegnata la
loro reciproca realizzazione e, meglio, la vita dell’umanità in senso pieno.
4.3.3.3.1. La logica del complesso (e la logica del problem solving) è la logica del doppio, del
doppio agli estremi. Non pone un principio unico da cui dedurre ma indica gli estremi entro cui
stare, in quanto questi estremi individuano il campo del movimento per conseguire conoscenza e
prendere in gestione. Libertà e legge; individuo e società; privato e pubblico; ideale e reale … Non
si può stare agli estremi (essere estremisti) si starebbe fuori dal campo; al contrario ignorarli
significa non cogliere la realtà nella sua ampiezza e complessità: le semplificazioni non risolvono il
problema, semplicemente annullano la realtà o mentendo la nascondono.
Occorre tornare, se necessario, ad Eraclito, che presentando il logos (principio e definizione di
ragione e realtà) afferma: «Non comprendono come, pur discordando in se stesso, è concorde:
armonia contrastante, come quella dell’arco e della lira.» (fr. 51). In questa tradizione logica si
iscrive la politica di Aristotele che pone al centro dell’arte di governo proprio la mesòtes, la
“medietà”, richiama la virtù della phrònesis (saggezza) e non della sophìa (sapienza) come
necessaria per quel compito, e conclude il proprio testo invitando a perseguire «il giusto mezzo, il
possibile, il conveniente» (Aristotele, Politica 1342b33-34).
4.3.3.3.2. L’arte di governo può definirsi come arte di gestire il possibile e il contingente favorendo
iniziative in rapporto al reale riscoperto nella complessità e diversità che solo gli estremi,
41
individuati e rispettati, sono in grado di rendere presenti. Il contrario dell’arte di governo, e della
politica, è quello di mirare all’uno, all’Uno-Tutto; ad una unità che impone identificazioni con
l’obiettivo di escludere ogni doppio, ogni doppiezza dalla politica, doppiezza considerata e
denunciata come fonte di debolezza e di inganno, addirittura di tradimento. È quanto è in opera nei
totalitarismi del ‘900, come Arendt con lucidità e passione denuncia.
4.3.3.3.3. «Nel regime totalitario il posto del diritto positivo viene preso dal terrore totale, inteso a
tradurre in realtà la legge di movimento della storia o della natura» (Arendt 1951, p.636); l’obiettivo
dichiarato è quello di identificare uomo e legge; ma per garantire la legalità e la giustizia, impedire
che la legge continui ad essere considerata come una autorità esterna che esige solo obbedienza, la
legge diventa l’Assoluto, sola proprietà del potere, imposta con il terrore.
4.3.3.3.4.. «La legge naturale della sopravvivenza del più forte è appunto una legge storica, e come
tale poté essere usata dal razzismo» (Arendt 1951, p.635). L’obiettivo è quello di identificare storia
e natura in un unico nuovo movimento: il trionfo politico (storia) della razza (natura) rappresenta
una simile fusione; la biopolitica si snocciola qui in tutta la propria ampiezza fino a entrare a
regolamentare non il solo vivere sociale (bìos) degli uomini, ma il loro vivere naturale (zoé): il
nascere e il morire, l’alimentazione e la cura del corpo, le dimensioni ideali del fisico che fanno
appartenenza alla razza, la razza come base per i diritti di cittadinanza sociale e politica, la vita
come offerta sacrificale a cui il buon cittadino deve sempre essere, e con gioia, disponibile…
4.3.3.3.5. «…distrugge la pluralità umana fondendola nel tutto unico che agisce infallibilmente
come se fosse parte del corso della storia o della natura.» (Arendt 1951, 655). Occorre identificare
il singolo con la totalità, fondendolo con la folla, portandolo all’unisono con il popolo, la razza, il
destino nuovo, l’Impero, l’idea … e consegnandolo, in realtà, al suo destino di isolamento e di
impotenza «stati tipici delle tirannidi» (Arendt 1951, 650), poichè nella massa («Distruggendo ogni
spazio tra gli individui, comprimendoli l’uno contro l’altro, si annientano anche le capacità creative
dell’isolamento…» Arendt 1951, 655) l’individuo non esiste come persona che pensa dice e decide,
come tale è superfluo, ma esiste come numero che tace con il pensiero e osanna a comando;
4.3.3.3.6. Se la doppiezza, il doppio, era considerata elemento in grado di indicare l’ampiezza e le
potenzialità del politico, l’area in cui il politico poteva esprimere, di volta in volta, nella sua
produttiva contingenza, le proprie forme plurali e funzionali all’arte di governo, nel regime
totalitario quell’impostazione e quell’ambito vengono contratti ed eliminati in nome dell’UnoTutto; se il doppio è l’essenza del politico, allora la sua negazione ne è anche la morte; perciò
Arendt non intende annoverare il totalitarismo tra le forme della politica e tra le sue degenerazioni:
è la negazione della politica, ne nega infatti l’essenza: la libertà e la contingenza.
4.3.3.4. Come prima conclusione. Prende corpo il richiamo etico e politico alla responsabilità, nei
confronti del reale, nei confronti dell’ideale, come terreno di relazione, incontro e rilancio dell’etica
e della politica.
«La morale della democrazia
Di conseguenza, e una volta di più: la democrazia si misura sulla sua capacità di ri-produrre il
cittadino in quanto critico-dissidente. Di riprodurlo in forma allargata. La democrazia è la
produzione (in forma allargata, sempre più critico-dissidente) di cittadini a mezzo di cittadini (il suo
prodotto interno lordo è il tasso generale diffuso di critica-dissenso)
La morale si dà invece — senza alibi — solo dentro l’orizzonte della responsabilità. Ma allora la
democrazia non è disgiungibile dalla morale (e viceversa), perché, entrati nella costellazione del
disincanto, solo laddove è libertà (azione) ivi è responsabilità. Il male moderno è proprio il
moltiplicarsi sociale della possibilità di invocare l’irresponsabilità. Il bene è la possibilità di
praticare l’autos del nomos, effettivamente e quotidianamente.» (Flores D’Arcais 2006, 42,43)
La domanda Che cos’è la politica non è più oggetto di teoria o di costruzione di modelli è coraggio
del porre in discussione e del portare a chiarezza. «L’ultima riflessione di Hannah Arendt ci pone
più problemi di quanti ne risolva e ci lascia più che mai con un’eredità priva di testamento.»
(Arendt 1951, pref. S. Forti p. LIV). Forse per questo motivo Flores D’Arcais nota: «Oggi Hannah
Arendt è riconosciuta anche in Italia come una delle grandi voci della filosofia contemporanea.
42
Almeno a parole, perché al riconoscimento – spesso retorico, spesso orecchiato – si accompagna
quasi sempre il fraintendimento, o la rimozione, delle sue tesi più scomode e più radicali.» (Flores
D’Arcais 2006, terza di copertina) Anche nel pensiero, e nel pensiero teoretico in particolare,
spesso, come bambini intimoriti, si preferiscono le coccole, si cerca il conforto del sistema e non il
fastidio del dubbio e della domanda aperta e coraggiosa.
«Analogo conflitto opera anche presso il cittadino comune, e perfino il cittadino che si vuole
democratico, che per “riconciliarsi col mondo” ha spesso bisogno assai più di fole, di miti, di
superstizioni, di pietose bugie, di manipolazione dei fatti e di “oscurantismo” della memoria, che
non dei lumi e dell’impietoso esercizio di un sapere critico. Per consolarsi è troppo spesso
necessaria, insomma, la credulità volontaria, foriera però di servitù volontaria e manna per gli
establishment di ogni tasso di autoritarismo. Il bisogno di consolazione, insomma, pure
indisgiungibile dall’essere umano, se diventa dominante anziché episodico, è il miglior amico del
conforme. Dunque il peggior nemico della libertà. […] L’ostinata volontà di dare un senso alla
storia (o di vaticinare qualche «fine della storia», il che è funzionalmente equivalente), malgrado lo
sciorinarsi quotidiano e traboccante di evidenze che ne garantiscono lo shakespeariano «signifying
nothing», potrebbe costituire un estremo rifugio del nostro wishful thinking metafisico, che rifiuta di
affrontare il disincanto perché incapace di metabolizzare la ferita da esso inferta al nostro
narcisismo. E dunque pretende di scoprire un superiore significato finalistico per l’esistenza
dell’animale homo sapiens sapiens che tutti noi siamo, malgrado sia venuta definitivamente meno
di fronte al tribunale della ragione (empirica e logica) dapprima la centralità cosmologicoastronomica del nostro essere-uomo e infine la sua illusione di annunciato e culminante approdo
natural-evolutivo.» (Flores D’Arcais 2006 56-57)
4.3.4. dalla politica di professione alla politica dei consigli / movimenti
4.3.4.1. La politica come professione; il partito macchina e la fine di ogni autonomia
«Gli elementi di una diagnosi tanto impietosa sono tutti già in Max Weber. Nella realtà, non è vero
che chi aderisca a una organizzazione paghi il prezzo di rinunciare al dettaglio delle proprie
opinioni per dare maggior forza alla sostanza di quelle. Logica e motivazioni dell’adesione rivelano
tutt’altra natura. Non l’autonomia della volontà o un residuo di opinione, bensì la fedeltà. Proprio
nella «dedizione del seguace al “carisma” puramente personale del “capo”» trova «le sue radici il
concetto della professione nel suo aspetto più caratteristico». […] Fedeltà contro autonomia,
dunque. L’opposizione non potrebbe essere più netta: «Quel che conta è la dedizione dei suoi
fautori: di una schiera di discepoli, di seguaci, di uomini legati al suo partito personale». Culto della
personalità e culto della «macchina», del resto, non si escludono affatto. In genere si rafforzano a
vicenda, capo e apparato.
Giunto a compimento il processo che trasforma la politica in una vera e propria professione, per il
politico, ormai uomo di partito, svanisce ogni possibilità di autonomia. Quando appare è poco più
che velleità. Materialmente e simbolicamente, infatti, il professionista della politica dipende in tutto
e per tutto (dal partito, dal capo, dalla «macchina») già a partire da epoca precocissima. Da quando,
sul trascorrere dell’adolescenza, si affaccia al mondo.
Un principio di legittimità, intanto, si è silenziosamente dileguato. La metamorfosi della politica in
professione comporta la sostituzione della legalità con la fedeltà personale. Lealtà alla macchina o
al capo, personificazioni del partito, perché proprio nel partito è stata messa a custodia la propria
identità politica. Ovvio che la spregiudicatezza, invece che il rispetto della legge, emerga come
virtù civica per eccellenza, ogniqualvolta sia in gioco il bene del partito. Questo, per quanto
riguarda il politico «attivo», ormai divenuto imprenditore. Nessuna meraviglia, allora, che il politico
«passivo» non abbia più interesse per le opinioni, e il grado di coincidenza fra le sue e quelle (ormai
solo di facciata) di un partito. A motivare il suo voto saranno altri fattori: il favore, la
raccomandazione, la logica della clientela insomma. «Nella società di massa il voto di opinione sta
diventando sempre più raro: oserei dire che l’unica vera opinione è quella di coloro che non votano
perché hanno capito o credono di aver capito che le elezioni sono un rito cui ci si può sottrarre
43
senza grave danno, e come tutti i riti, ad esempio la messa la domenica, sono in fin dei conti una
seccatura» [Norberto Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi 1984, p.137]. […] Il
politico, ormai politico di professione, non può più avere quale scopo della propria attività
l’affermazione delle proprie opinioni. Quando ciò avvenisse sarebbe eccezione, residuo, frivolezza.
il carattere professionale impone anche alla politica le sue regole. Quella di cittadino era una
funzione separata dalle attività nella società civile, dalla propria identità sociale. Separata, ma
aperta a tutti. Come professione, la politica diviene invece identità. Carriera. La “professionalità”,
vale la pena sottolinearlo, è innanzitutto di carattere negativo. Fuori della politica, il politico di
professione è senza arte né parte. […] Il politico paventa quello che paventa ogni altro
professionista: essere espulso dal mercato, essere retrocesso in gerarchia, essere licenziato.
Il politico deve, perciò, rafforzare la propria organizzazione. È lo strumento del suo lavoro,
l’utensile tramite il quale raccoglie consenso. Rafforzare l’organizzazione vuol dire, però, disporre
di risorse da distribuire: onori e cariche. La tendenza a moltiplicare le risorse, la cui “giurisdizione”
ricade di fatto sotto i partiti, trova qui la sua origine. Meno cariche, meno organizzazione, minori
chance di consenso. E viceversa. […] Bisogna leggerlo più spesso, Max Weber, anche nei passi che
suonano critica (più che mai attuale) dell’esistente. Di una democrazia che, umiliata a professione,
esce dalla metamorfosi corrotta e indebolita. […] Ma, reciprocamente, e con lo stesso rigore, va poi
evidenziato che la riduzione della libera azione politica in termini di esecuzione o di
amministrazione (riduzione inevitabile quando la politica diventi professione esclusiva, e quindi
sottratta a chi può alla politica dedicare solo — da cittadino — ritagli di tempo libero, e viverla
come bricolage) già implica l’idea che l’opposizione sia lusso superfluo, impaccio, “lacci e
lacciuoli” di cui far pulizia. In altri termini. L’idea di un sapere “obiettivo” nella sfera politica
contiene già in sé l’attribuzione di tutto il potere a un monocrate che possieda le chiavi della
dialettica storica; o sia in altro modo l’unto del Signore. E quindi abolisca il molteplice e libero
“fare” politico degli individui. Per il loro bene, evidentemente.» (Flores D’Arcais 2006, 111-117,
passim; le citazioni, salvo altra indicazione, sono da Max Weber, Il lavoro intellettuale come
professione, Torino, Einaudi 1996)
4.3.4.2. i movimenti di opinione, i consigli: una via di uscita, un rilancio della iniziativa politica.
«Ma Hannah Arendt … ritiene …che proprio il mondo moderno produca spontaneamente …
l’istanza (insopprimibile) di un superamento della stessa rappresentanza quale forma della politica.
Il riferimento è rivolto alla tradizione della democrazia dei consigli, che costituisce una «strana e
triste storia». […] Hannah Arendt muove da una constatazione di fatto. In molteplici occasioni
(assai diverse quanto a contingenza storica), i cittadini tendono spontaneamente a dar vita a forme
di partecipazione politica che richiamano l’ideale di Jefferson delle «repubbliche elementari». Le
“sezioni” parigine in alcuni momenti della Rivoluzione francese, la Comune del 1871, i soviet nel
1905) e nel febbraio del ‘17 (e poi nel ‘21 con l’insurrezione di Kronstadt), i Räte in Austria e
Germania nella crisi che fa seguito al primo conflitto mondiale, infine il diffondersi, con incredibile
rapidità e in tutte le pieghe del tessuto sociale, dei consigli durante la rivoluzione ungherese del
1956. Tutto ciò, secondo la Arendt, ed è questo un punto di particolare rilevanza, in assenza di una
qualsiasi memoria storica, poiché proprio l’attività dei partiti che si vogliono rivoluzionari, che
organizzano rivoluzionari di professione, e che rappresentano la forma estrema e nefasta della
professionalizzazione dell’agire politico, volta a volta, ma sistematicamente, spezzano, occultano,
distruggono quella tradizione e quella memoria. Di qui la conseguenza. Che si tratti di una tendenza
spontanea, insopprimibile, ricorrente perché in qualche modo contenuta proprio nelle moderne
condizioni di esistenza.» (Flores D’Arcais 2006, 123-126)
Ipotesi per un modello politico del consiglio / movimento. «Metodologicamente, allora, e proprio
allo scopo di vagliare praticabilità e consistenza dell’ipotesi consiliare, sarà opportuno esaminare il
modello scegliendo quale riferimento uno degli episodi storici richiamati, e indagarlo con l’ottica
sistematicamente negativa dell’avvocato del diavolo di vaticana memoria. Il precipitato di
un’analisi così condotta non potrà essere sprezzantemente liquidato come “utopismo”.
[messi o richiamati in ordine numerico non del testo, per citazioni sommarie, perciò le virgolette:]
44
1. «non intendere in nessun caso conquistare il potere. Malgrado si trovino ad esercitarlo, anzi,
intendono al più presto cederlo».
2. «Frammentare il potere. … Dividere il potere, quindi, nel senso di diffonderlo secondo la logica
dei contrappesi, ma anche nel senso di disperderlo, disseminarlo. Tale divisione avrebbe la funzione
di garantire ciascun cittadino rispetto a ogni centro di potere.»
3. «Se la divisione in quanto frammentazione del potere corrisponde alla vecchia preoccupazione
liberale, la stessa divisione, in quanto dispersione e disseminazione del potere, soddisfa poi al
contempo l’istanza democratica radicale della partecipazione popolare, del potere che è democratico
solo se e quando condiviso.»
4. «Ogni individuo si troverebbe a essere titolare di più poteri, alcuni da esercitare in forma diretta e
altri in forma delegata, alcuni nella modalità della partecipazione, altri in quella del controllo.» 129
«Libertà dal potere. Libertà di (partecipazione al) potere.»
5. «Ma, reciprocamente, questa frammentazione delle funzioni rende possibile che ciascuno le
pratichi come bricolage, perché nessuna di esse è tale da esigere (e perfino favorire) una
“dedizione” che escluda altre attività lavorative, e quindi renda “professionisti della politica” ma
anche “senza arte né parte”.» Forse l’ostacolo contemporaneo alla partecipazione democratica è
costituito da una violenza indiretta e inavvertita: si tratta «dell’ossessione consumistica divenuta
modello di vita per le masse. Modello nei fatti costrittivo, forse anch’essa “devastatrice” di ogni
possibilità di esistenza per il cittadino, cioè per la politica disinteressata.»
6. «I consigli sono il prodotto di una situazione eccezionale, rivoluzionaria appunto. Partecipano di
quell’entusiasmo delle origini destinato a venir meno con il ritorno alla routine.» (Flores D’Arcais
2006, 126-130, 139 passim)
4.3.5. conclusione in bilancio e proposta: un modello non modello (non schema per una teoria,
ma modello per presenza: pensare-agire critico)
4.3.5.1. Il lavoro di Hannah Arendt non fornisce teorie, impone il pensiero. «Quella di Hannah
Arendt non sarà mai politologia» (Flores D’Arcais 2006, 20) E Arendt non vorrebbe mai per sé il
titolo di “filosofo” o peggio “filosofa”.
«E se rifiuterà ostinatamente (e forse con una punta di snobismo) l’etichetta di «filosofo”, è con la
motivazione che «l’atto di nascita della filosofia è iscritto nell’impossibilità, per il pensiero, di
sopportare la maledizione del finito, nella sua incapacità di accettare il mondo segnato dal lutto
della contingenza. [...] I fondamenti della metafisica [...] non sono altro che la manifestazione di un
desiderio ossessivo di durare, che rimuove la morte e il tempo».
Maledizione del finito e lutto per la contingenza. Proprio ciò che andrebbe invece considerato
benedizione (e che tale infatti Hannah dipinge, in pagine ricorrenti) dal punto di vista della libertà,
perché condizione di quella pluralità senza la quale la libertà resta inafferrabile.» (Flores D’Arcais
2006, 62) «Quello che troppe volte Hannah esprime come un rifiuto della filosofia (a vantaggio
della politica e del pensiero politico) altro non è insomma che lo smantellamento radicale della
metafisica, in una accezione amplissima e rigorosa, però, che abbraccia tutte le fughe dalla
finitezza. Il rifiuto della filosofia (i.e. metafisica) come rifiuto — teoretico ed esistenziale — del
pensiero “per-sempre”, che con la mortalità uccide soprattutto la natalità, condizione della libertà.
(Flores D’Arcais 2006, 63)
Tuttavia (precisando), «se il compito della filosofia è comprendere il proprio tempo nel concetto,
Hannah Arendt è il filosofo per eccellenza della nostra epoca.» (Flores D’Arcais 2006, 6)
«La filosofia di Hannah Arendt costituisce un prezioso antidoto contro il “pensiero unico” oggi
dominante, e dunque contro la mistificazione ricorrente della “fine della storia” che di quel
“pensiero” costituisce il versante filosofico-politico (quello economico è noto). Antidoto
insostituibile, anzi. Poco o nulla, nella filosofia di questo dopoguerra, sembra infatti capace di
offrire strumenti per pensare l’imprevisto (e imprevedibile) che con la sua irruzione trasforma il
mondo. […] La filosofia di Hannah Arendt ha invece questa capacità. Riesce a intrecciare
inestricabilmente lucidità teorica, realismo politico e passione civile. Di più: dispiega straordinaria
45
lucidità teorica e realismo politico proprio a partire dalla passione civile. Mostrando come la
perdita di quest’ultima sia devastante e irreparabile per le due precedenti “virtù”. Forse quella della
Arendt è grande filosofia, anche perché si tratta di una riflessione esplicitamente e
programmaticamente non accademica.» (Flores D’Arcais 2006, p.195)
4.3.5.2. Tornando alla radice, ancora contro le filosofie della storia e il loro implicito postulatopretesa e per rilanciare il realismo della responsabilità: «É proprio contro questi artefici della storia
che una società libera deve imparare a difendersi, a prescindere dalla loro visione del mondo. E ciò
comporta qualcosa di più della naturale avversione che proviamo istintivamente verso l'arroganza di
persone impegnate in simili missioni "sublimi”. L’idea di poter fare qualcosa di più che agire per e
nel presente (l’idea cioè di poter fare il futuro) implica due errori fondamentali: che io conosca il
fine, e che possa quindi decidere liberamente sui mezzi, e che io sappia che cosa sto facendo
quando agisco, non diversamente da come so che cosa sto facendo quando fabbrico delle cose. La
prima cosa é impossibile perché sono mortale; non conoscerò mai il fine della storia perché non ne
vedrò mai la fine. La seconda è sbagliata perché l’azione umana é per definizione imprevedibile
nelle sue conseguenze ultime. La grande tradizione del pensiero politico occidentale lo ha sempre
saputo e lo ha interpretato come un impedimento. […] Ma non c’è nulla di definitivo nella storia
[history] – la storia [story] che essa narra ha molti inizi ma nessuna fine.» 193 (Arendt 1994, nel
saggio articolo Gli ex comunisti, 1953, 190, 193].
4.3.5.3. Riassumendo e semplificando: vi sono due modi di impostare il problema politico. 1. In
termini di dominio, forza, potenza, violenza … all’insegna, per così dire, dell’homo necans, della
morte; 2. In termini di iniziativa, libertà, innovazione, immaginazione, proposta, produzione,
responsabilità… all’insegna, ancora per così dire della mulier generans, della nascita e della vita.
Per Arendt (come per Aristotele) il primo modo rappresenta e attua la morte della politica; la
politica è invece nascita e, si notava, ogni nascita è inizio; questo è il senso e l’essenza politica
dell’umano naturale e sociale (zoé e bìos). È il caso di riprendere le parole di Ermanno Bencivenga:
«Per duemila anni una filosofia maschile ha vincolato la ricerca della saggezza alla morte: alla
consolazione apportatavi dal pensiero o alla dimostrazione di una vita incorporea. Nel ventesimo
secolo, finalmente, una donna, il quarto cavaliere dell’apocalisse che invoco sulla tradizione, ha
pronunciato con forza gli assiomi di una filosofia fondata sulla nascita.» Bencivenga Ermanno 2010
La filosofia come strumento di liberazione, Raffaello Cortina Editore, Milano, p. 90
46