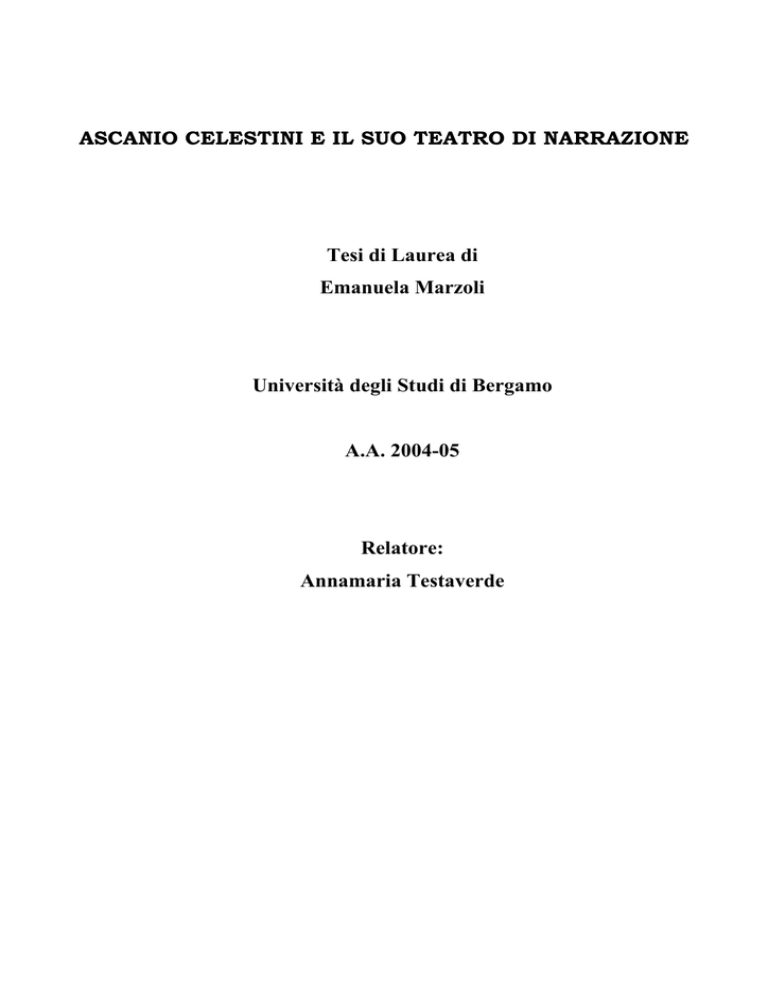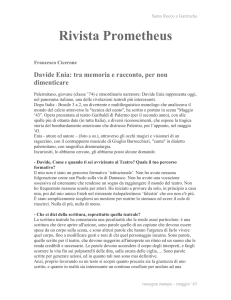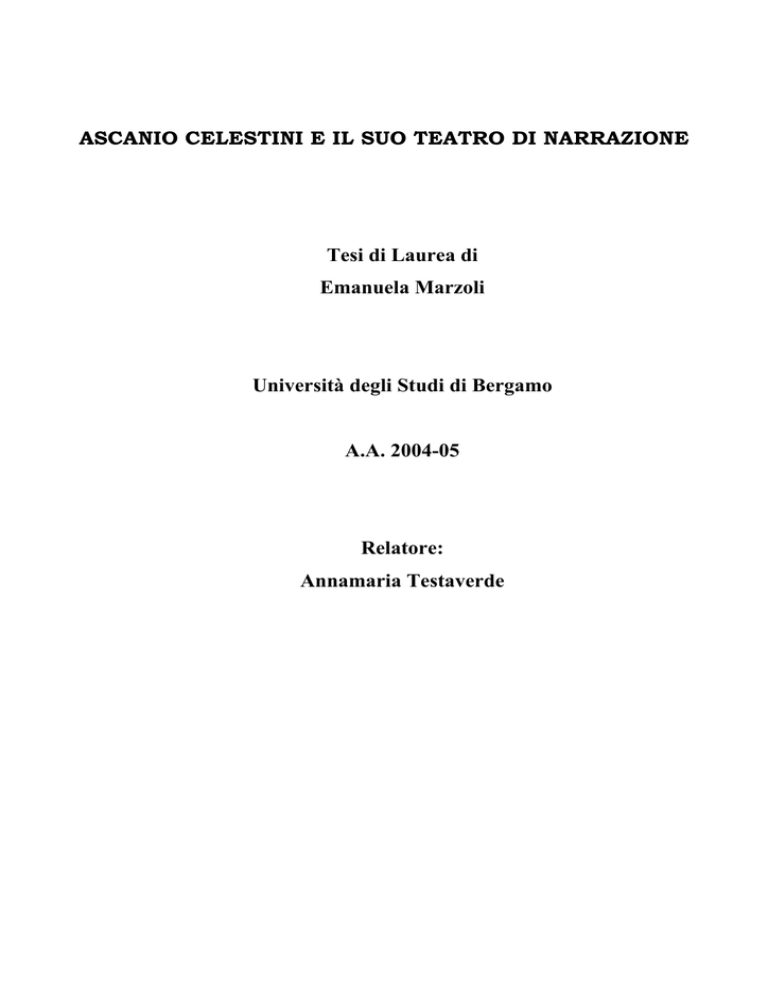
ASCANIO CELESTINI E IL SUO TEATRO DI NARRAZIONE
Tesi di Laurea di
Emanuela Marzoli
Università degli Studi di Bergamo
A.A. 2004-05
Relatore:
Annamaria Testaverde
IL TEATRO DI NARRAZIONE
“Teatro di narrazione” è una definizione recente nell’ambito degli studi teatrali (tanto che, con un
azzardo linguistico, si potrebbe considerare una “neodefinizione”) tuttavia questa terminologia
appare già abusata. Purtroppo si rischia di incorrere in un termine inflazionato ancor prima di essere
stato argomentato a sufficienza, o forse proprio perché si è lontani dall’esaurire le argomentazioni;
il concetto definito “teatro di narrazione” potrebbe diventare un serbatoio in cui riversare senza
criterio ogni creazione teatrale contemporanea inconsueta rispetto al teatro tradizionale, rendendolo
il vessillo del modernismo e dello sperimentalismo “a tutti i costi” e non il risultato di progetti
ragionati e curati. Per non incorrere quindi nel fraintendimento grossolano, cadendo nella tentazione
dello smaltimento, nella realtà drammaturgica narrativa, anche di prodotti scadenti e facilmente
smerciabili è necessario stabilire quali coordinate risultino funzionali ad individuare con precisione
l’oggetto da analizzare, escludendo immediatamente l’equazione “moderno” uguale “teatro di
narrazione”. Si tratta di un genere artistico recente, non tanto sotto l’aspetto “narrazione”, poiché
l’uomo narra dal momento in cui ha acquisito l’uso della parola; quanto per la giunzione tra
narrazione e teatro. Questa tipologia scenica che raccoglie dalle tradizioni popolari più antiche di
cantastorie, letture infantili, racconti del folklore il materiale poi proposto sulla scena, ha già dato
modo di creare una categoria; si accrescono quindi il pericolo del semplicismo e della
generalizzazione. La capacità d’indagine riguardo un evento (oppure un luogo), infatti, sembra
essere
inversamente
proporzionale
alla
sua
vicinanza
spazio–temporale,
è
lampante:
l’allontanamento diatopico e diacronico favorisce una visione unitaria, razionale e oggettiva,
funzionale alla ricerca. In parole povere, analizzare un evento concluso e circoscritto è meno
aleatorio che prendere in considerazione un processo, qui il “teatro di narrazione”, che ancora è in
fieri e lungi dall’esaurirsi e che può prestarsi ad evoluzioni impreviste e catastrofiche (prendo
questo termine in prestito dalla teoria di Renè Thom 1 ).
TP
PT
È però possibile ed indispensabile considerare il fenomeno teatrale detto “di narrazione” sulla
base di caratteristiche condivise nel mondo dell’analisi e critica di teatro. Quindi, in primo luogo, di
fronte ad una casistica che evidenzia empiricamente la frequenza con cui l’attore narratore si
presenta solo in scena e propone opere drammaturgiche di cui è anche autore, è comprensibile
risalire da questo primo elemento discriminante alla differenza tra narratori, attori interpreti di un
1
Renè Thom espone la teoria delle catastrofi nelle sue opere Stabilità strutturale e morfogenesi, Torino,
Einaudi, 1980 e Parabole e catastrofi, Milano, Il saggiatore, 1980. Con il termine “catastrofe” si indica, nella teoria
sistemica, il passaggio di un sistema da uno stato stabile ad un altro altrettanto stabile, ma fino ad allora solo potenziale,
ed attuato dalla comparsa di un fenomeno critico che interrompe il cammino del sistema, lineare fino a quel determinato
momento. La transizione catastrofica identifica, pertanto, un mutamento repentino, non necessariamente disastroso,
caratterizzato tuttavia dalla discontinuità di un processo che può darsi anche in seguito ad una variazione infinitesima.
TP
PT
monologo, ed esecutori di letture teatralizzate, trattandosi, negli ultimi due casi, di un lavoro svolto
su un testo predisposto, fissato a priori e generalmente invariato. Che si tratti del testo di un
copione, oppure letterario poi riadattato, esso è certamente pre-esistente all’atto scenico e
condivisibile in modo univoco, la fruizione oggettiva è infatti caratteristica ontologica della
scrittura. Questi testi drammaturgici potranno nascere o meno dall’inventiva dell’interprete: essere
autori e recitare un proprio testo non equivale a costruire un evento teatrale di narrazione; ma certo
imporranno un legame rigido con la parola da cui l’attore (o il lettore) potrà svincolare la propria
identità solo seguendo la via della creatività emotiva e della perfezione esecutiva, trovando un
numero ampio di soluzioni interpretative soddisfacenti sulla base di quel testo, che comunque c’era
ed è lì tuttora e ci sarà poi in maniera irreversibile. Ci si muove in definitiva all’interno della
scrittura. Diventa necessario, quindi, il concorso di un rigore tecnico ineccepibile nel costruire uno
spettacolo il più possibile “pulito” per dare vita al quale l’attore parte dall’impersonalità (l’attore
“nudo”) per poi rivestirsi di una nuova personalità (il personaggio) oppure di una grande
competenza esecutiva (il lettore).
Il percorso compositivo e interpretativo sopra descritto risulta estraneo al “teatro di
narrazione”: tale nuova modalità si caratterizza per un rapporto più libero, quando non totalmente
assente, tra il narratore ed il testo. Grazie ai frequenti inserti di improvvisazione non si pone il
problema dell’apprendimento mnemonico della scrittura, poiché la fase letteraria, presupposto della
messa in scena tradizionale che nel teatro si concretizza con il copione e nella cinematografia con la
sceneggiatura, è irrilevante in una realtà nella quale semplicemente non esiste il testo
drammaturgico a priori come base fondante dell’azione.
Una prima distinzione tra il teatro tradizionale
ed
TP
PT
il “teatro di narrazione” è individuabile
quindi a partire dalla definizione che Guido Di Palma propone per identificare il nucleo generativo
di quest’ultima tipologia scenica: non opera scritta antecedentemente e rigorosamente ripresa, ma
materia narrativa 2 . Il narratore espone il materiale trattato secondo le modalità della tradizione
TP
PT
favolistica tramandata oralmente. Il meccanismo non consiste nella ripetizione di parole predisposte
e invariate, ma nel susseguirsi di eventi narrabili il cui legame va ricercato in un ordine strutturato,
generato spesso da formule rituali e ripetizioni cantilenanti non dalla rigidezza testuale. In questo
ordine il raccontatore ha il dovere di muoversi con libertà tale da poter sempre rendere visibili le
storie narrate senza snaturare, o meglio garantendo in funzione di questa abilità icastica, il reiterarsi
del significato del racconto.
2
G. DI PALMA, Un testimone dell’apocalisse. Tradizione e invenzione nella fabulazione di Ascanio Celestini,
in A PORCHEDDU (a cura di), L’invenzione della memoria. Il teatro di Ascanio Celestini, cit., 2005, p. 87.
TP
PT
Il regista di un teatro amatoriale di provincia con cui collaborai per qualche tempo era solito
ripetere: «Il testo è un pretesto...». Per che cosa, mi chiedevo io? Ora è più chiaro, ma, anziché in
veste di pretesto, penso al testo come ad uno schermo posto tra l’attore ed il pubblico su cui trova la
propria proiezione l’immagine di un personaggio definitivo, frutto di prove e ricerche finalizzate
alla riproponibilità. Il rapporto con il pubblico è studiato nel tentativo di indurre l’emozione tramite
l’illusione mimetica del personaggio “altro da sé”. Il narratore orale, non solo quello teatrale, rifiuta
invece le forme di travestimento, né si tratta di ricercare le origini della rinuncia tra i grandi assunti
ideologici esistenziali, il raccontatore, anche il più modesto dei cantastorie, più semplicemente non
ricorre ad alcun mascheramento perché non gli serve a nulla: il suo obiettivo è quello di raccontare,
non di rappresentare, quindi il personaggio della finzione viene bandito, in prima istanza, in nome
della praticità.
Del resto nessuna persona che desideri riferire di essere stata multata indosserà una divisa da
vigile urbano per interloquire con chicchessia, ognuno vorrebbe però che, attraverso il proprio
discorso il vigile, precisamente quello della multa, risultasse visibile agli ascoltatori. Questo
esempio aderisce all’ordinario e al quotidiano, ma che cos’è il “raccontare” se non un’azione
fortemente reiterata nella umana quotidianità? Ecco un’altra caratteristica del narratore di teatro:
oltre al portare in scena se stesso, presentandosi come persona vera e non come personaggio,
collocandosi internamente alla storia (narrando in prima persona), oppure esternamente (come
testimone che riferisce in terza persona), egli rende la sua proposta drammaturgica accessibile ad un
vasto numero di fruitori, che la accolgono come momento di semplicità quotidiana, come un evento
che non è banalità pur senza essere straordinario. Questo rapporto con il pubblico, non più di
osservatori, ma di destinatari del racconto, evidenzia un ulteriore distacco dal teatro canonico: si
narra non per mostrare, ma per il bisogno di comunicare. Decade, nell’idea dell’andare a teatro,
ogni pregiudizio selettivo e snobistico, sostituito da un’esperienza ampiamente accessibile nel
momento stesso in cui l’atto scenico si traduce in volontà comunicativa che è già di per sé “evento”
e, soprattutto, evento reale, non in forza di un contenuto “realmente avvenuto”, ma perché la
comunicazione “realmente” avviene in quel momento e prende i suoi strumenti dal linguaggio
popolare. Che lingua usa, infatti, il narratore se non il lessico convenzionale per gli ascoltatori? Ne
consegue l’operazione contraria rispetto alla “pulitura” della rappresentazione drammaturgica
tradizionale in cui ogni accenno dialettale, ogni cadenza, accento o parlata vernacolare devono
essere funzionali alla diegesi oppure banditi, ora le parole non servono per recitare, servono per
conversare.
Accettando quindi la comunicazione come elemento fondante del “teatro di narrazione” è
possibile individuarne le coordinate cronologiche considerando questo genere in funzione della sua
capacità di risposta ad un’esigenza sociale di interscambio attivo e propositivo, emersa nell’epoca
della moltiplicazione di parole e messaggi privi (spesso privati) di contenuti, scaturita dalla cultura
di una insostituibile immediatezza di percezione dell’immagine, avara poi di significati.
Comunicare è una necessità umana e non è casuale che la riscoperta di un’azione narrativa
(riscoperta rispetto alla tradizione dei giullari e dei cantastorie per i quali non si parla però di teatro)
che ritrova la centralità dell’individuo e della parola in contrasto al momento prettamente
rappresentativo, avvenga nell’era di maggiore decadenza e nel contempo di maggiore potenziale
relazionale tra gli uomini.
Le radici storiche della performance narrativa teatrale, vengono collocate negli anni ’60 e ’70
del Novecento. Precursore riconosciuto è Dario Fo, che senza disporre ancora di definizioni
categoriche, con intenti forse più provocatori e sperimentali che per adesione consapevole ad un
genere, si affranca dalle avanguardie coeve votate alla sottrazione di significati e alla proposta di
significanti, cose e persone, puri e rinuncia a frapporre lo schermo del personaggio tra sé ed il
pubblico. Fo si muove ancora, nei tardi anni Sessanta, nell’ambito della realtà teatrale di gruppo
fondando, nel 1970, la compagnia La Comune, evoluzione dell’esperienza del collettivo Nuova
Scena nata nel 1968 e non rinuncia neppure ad esporre la sua adesione ai movimenti politici di
sinistra. Ma il con suo spettacolo del 1969, Mistero Buffo, tramite la costruzione dell’opera ispirata
ai testi dei giullari medievali ed alle tecniche dei cantastorie popolari delle valli varesine, traccia
una linea di demarcazione, permettendo di rilevare i prodromi di parte della successiva ricerca
contenutistica del “teatro di narrazione”.
La critica è concorde nel riconoscere la prima generazione di attori narratori in quella
successiva a Fo, negli anni ’80 e ’90, registrandovi i nomi di Marco Paolini, Marco Baliani, Laura
Curino, del regista Gabriele Vacis e, personalmente, concordo con coloro i quali ritengono
opportuno aggiungere anche Moni Ovadia quale promotore dell’identità culturale yiddish tramite la
fusione di musica e frammenti narrativi tratti dal repertorio orale popolare della tradizione ebraica.
Similitudini e divergenze coesistono nelle opere dei narratori di prima generazione, tuttora
attivissimi, tanto da diventare una coppia antinomica e complementare di termini ugualmente
necessaria per definire questo parziale orientamento teatrale sviluppatosi tra gli anni ’80 e ’90. Da
esperienze di teatro di formazione a contatto con il mondo infantile e dei ragazzi, si approda a forme
di teatro narrativo civile, il giornalista Pier Giorgio Nosari lo definisce “dramma narrativo” se
l’intreccio prevede la compresenza di diversi personaggi (ma di un solo attore). I tratti comuni alla
maggioranza degli spettacoli di questi artisti sono individuabili nella frequente, ma non
obbligatoria, proposta di temi di denuncia civile condotta in modo satirico e arricchita da spunti
autobiografici; ricerche approfondite riguardo fatti di cronaca; frammenti letterari o narrativi
sottoposti ad una originale personalizzazione narrativa prima di essere offerti al pubblico. Dovendo
ricorrere a degli esempi, sarebbe opportuno citare, forse con poca originalità, ma con sicurezza
esemplificativa, alcune opere di Marco Paolini, nell’ordine: Gli album, curati dal 1990 al 1995;
Vajont 9 ottobre 1963 per la regia di Gabriele Vacis; il Bestiario Veneto ed il Bestiario Italiano e I
TIGI canto per Ustica. Dal Vajont ad Ustica, sulle parole di Paolini si ripercorrono episodi della
storia nazionale, l’esposizione di documenti ufficiali ed il racconto di fatti di vita così piccoli, così
normali, tracciati come ricami sulla trama del racconto sostengono il paragone con le fonti epiche
della letteratura. Gli Album ed il Bestiario propongono ironicamente elementi più personali, senza
scinderli dallo sfondo degli eventi di cronaca e di storia ed in questo quadro emergono le molteplici
sfaccettature che il “teatro di narrazione” è in grado di assumere pure in riferimento alla poetica di
un medesimo autore.
La materia trattata è vasta, gli spunti arrivano dalla vita; dalla storia; dalla letteratura sacra e
profana: come non pensare, ad esempio, alla recente Leggenda Aurea. Le storie di Santa Barbara,
dal sapore agiografico, presentata da Laura Curino, oppure ai riferimenti dissacranti all’informalità
relazionale tra i mortali ed il mondo divino su cui Moni Ovadia imposta, senza scadere nel
blasfemo, gran parte delle sue proposte? Qualunque traccia si segua, si arriva sempre e comunque a
“stanare” il tentativo, neppure troppo occultato, di una riappropriazione del momento scenico da
parte dell’identità dell’attore e di una rinnovata collocazione del reale nell’evento.
Con precisione argomenti molteplici si stagliano su un panorama vario e variabile, rendendo
le divergenze quantitativamente equivalenti alle somiglianze. Ed è altrettanto frequente, nel “teatro
di narrazione”, un altro tipo di varietà che affianca quella contenutistica: il medesimo narratore, che
si trova ad ideare storie diverse, in cui la sua identità funziona da elemento correlante, riunisce
spesso in sé anche una molteplicità di competenze che rimanda all’impostazione più antica del
teatro sia di ambito professionale, la Commedia dell’Arte in cui ognuno dei comici inseriti in una
compagnia era responsabile del proprio repertorio, dei propri costumi, dei fondali comuni per le
rappresentazioni; sia di ambito amatoriale cortigiano in cui coesistevano, nella medesima
personalità artistica, il ruolo del drammaturgo, dello scenografo e spesso dell’attore dilettante. Nel
primo caso si trattava di necessità economiche, nel secondo di mettere in gioco la formazione
intellettuale aderente al modello umanistico a partire dal Rinascimento in poi, anche il narratore
attuale è investito, oltre che dell’onere performativo, di quello compositivo rispetto alla
strutturazione degli argomenti dello spettacolo, dell’impostazione scenografica e di quella registica,
pure se il termine appare improprio inserito in una realtà in cui non è previsto il lavoro collettivo di
una compagnia da dirigere, né l’attore si interpone tra un testo drammatico e l’interpretazione dello
stesso da parte di un regista esterno. Non è inusuale, tuttavia, che la narrazione teatrale si
arricchisca della compresenza sul palco di altri soggetti oltre all’autore, non attori ma portatori di
arti complementari che, attivi nella performance, accrescono la complessità dello spettacolo e
quindi la necessità di coordinare i vari momenti ed elementi in funzione della fluidità narrativa. In
scena, accanto a Paolini, si sono susseguiti nei suoi diversi spettacoli, la cantante Giovanna Marini
ed il gruppo italiano dei Mercanti di Liquori; Moni Ovadia ha esordito come musicista e attore e
spesso si è esibito con gruppi musicali; Celestini lavora da anni con due musicisti: Gianluca
Zammarelli e Matteo D’Agostino e per lo spettacolo Sirena dei mantici aveva al suo fianco la
Fisorchestra Fancelli diretta dal maestro Marco Gatti e la cantante Lucilla Galeazzi. Si tratta di
presenze sulla scena tutt’altro che nascoste o “separate” dall’atto narrativo in corso, perché celare la
loro presenza decurterebbe una porzione di realtà. Dunque come esplicita Guido Di Palma: «É
assolutamente vero che il tratto comune degli attuali protagonisti del teatro di narrazione è la loro
diversità...» 3
TP
PT
La varietà non si omologa rispetto ad un modello, neppure con quella che i critici definiscono
la “seconda generazione” di attori narratori. Ascanio Celestini, Davide Enia e Michele Sinisi sono i
tre nomi più citati in questo contesto e comunemente accreditati a raccogliere l’eredità teatrale
narrativa dei predecessori, non solo in funzione del mero scarto anagrafico. Nella poetica di questi
tre artisti è ravvisabile un distacco rispetto alla generazione precedente in merito al quale l’aspetto
autobiografico si inserisce nell’opera in modo ancora più pregnante, dal “teatro civile” ora si passa a
promuove la centralità della “narrazione pura”. Dal punto di vista narrativo la componente
favolistica e soggettiva si innesta, oppure accompagna, la trattazione di fatti storici e politici che
non obbediscono ad una catalogante esposizione didascalica, ma si arricchiscono dell’elemento
fantasioso e di una visione personalizzata, senza abbandonare tuttavia il territorio della correttezza
fattuale. Ancor più si evidenziano le radici dell’autore tramite la collocazione delle storie nei
rispettivi contesti di origine, per Enia Italia-Brasile 3 a 2, del 2002, è la tela su cui tracciare il
ritratto di una Palermo euforica per i mondiali di calcio ed il suo personale vissuto, Sinisi ambienta i
suoi ultimi spettacoli nella terra di Puglia da cui proviene e per Celestini Radio Clandestina e
Scemo di Guerra diventano il pretesto per raffigurare la topografia capitolina, seguendo i passi dei
protagonisti del racconto. Il personale diventa passaggio obbligato per veicolare il generale,
esplicative le parole di Enia: «...quali soluzioni avrei a disposizione? Solo quella di concentrarmi su
un particolare che, per la mia sensibilità ed esperienza, racchiude il tutto.» 4
TP
PT
Scegliendo l’adesione alla più esplicita spontaneità può verificarsi che la resa di una visione
personalizzata avvenga tramite il filtro dello sguardo infantile. Quindi senza travestimenti o
3
Ivi, p. 89.
P. PERAZZOLO , “La storia vista da vicino”, in «Famiglia cristiana», anno LXXV (n. 26/2005), pp. 98-99. Il
corsivo è dell’autore dell’articolo.
TP
PT
4
TP
PT
dissimulazioni, Enia racconta il bombardamento di Palermo in Maggio ’43 grazie a parole sue, ma
attraverso la percezione visiva del bambino Gioacchino. Analogo procedimento è quello di
Celestini in Scemo di guerra, dove la sovrapposizione della voce del narratore allo sguardo di suo
padre bambino durante la seconda guerra mondiale introduce l’ascoltatore nella zona di confluenza
di un’esperienza personale, inserita in un quadro storico ufficiale e più vasto. Infine anche negli
Album di Marco Paolini, autore situato in un’area artistica intermedia tra la “prima” e la “seconda”
generazione, lo spettatore scopre che lo sguardo interposto tra storia e racconto è quello di Nicola,
alter ego di Paolini stesso. In quest’ultima analisi non vedo altro che la conferma della vacuità di
ogni schematizzazione rigida per quanto riguarda il “teatro di narrazione” che, data la frequenza di
ricerca sperimentale delle diverse tecniche narrative, lo allontana da ogni sclerotizzazione.
L’aspetto linguistico concorre, una volta ancora, all’espressione dell’identità narrante,
affrancandosi dalla ricerca dei predecessori per i quali i termini del lessico popolare, l’inflessione
veneta per Paolini, varesina per Fo, il mai mascherato accento straniero conseguenza della parlata
yiddish per Ovadia, aderivano in ogni caso a dei modelli di correttezza grammaticale. La loro
ricerca si commuta in un’esposizione con richiami normativi alla lingua italiana, con il “taglio
letterario, un po’ estetizzante” che Italo Calvino, nella sua introduzione alle Fiabe Italiane del 1956
(Torino, Einaudi), attribuisce ai curatori di raccolte fiabesche in dialetto del secolo scorso. Celestini,
Enia e Sinisi scelgono invece di proporre l’oralità nella sua forma più pura tramite l’inserimento di
formule tipiche e reiterate delle favole, dei costrutti dialettali sgrammaticati, fino alla bizzarria del
non senso delle filastrocche. L’innovazione narrativa e linguistica degli ultimi autori segna pertanto
l’evoluzione ulteriore di un processo teatrale ben lontano dal concludersi e recettivo nei confronti di
innumerevoli nuove soluzioni performative.
Per concludere questa breve presentazione del “teatro di narrazione” è opportuna una
riflessione sui luoghi in cui l’evento scenico vede attuarsi la sua proposta al pubblico: non solo
edifici teatrali convenzionali, ma spazi connotati da una riconosciuta, condivisa funzione
comunitaria, luoghi in cui attuare quel potenziale relazionale, di interazione, comunicazione e
confronto che è fondante dell’atto del raccontare. La festa popolare, la diga del Vajont, la ferrovia,
la fabbrica, il circolo, la scuola, il Museo della Liberazione, risultano contesti ugualmente evocativi
e rispondenti alla necessità di rinnovare l’atto magico, per chiunque accetti di prendervi parte, del
riconoscimento di sé all’interno di una cultura e di una memoria condivise.
INTERVISTA CON ASCANIO CELESTINI 5
TP
PT
Emanuela Marzoli- Il “teatro di narrazione” da qualche tempo genera seguito e consensi,
penso, oltre al tuo lavoro, a quello di altri autori, per esempio Marco Paolini, Laura Curino, Moni
Ovadia. Secondo te si può parlare di “genere nuovo” oppure è più corretto pensarlo come
“recupero” di un genere più antico?
Ascanio Celestini- Credo sia nuova la percezione del fatto che anche questo è teatro. È nuovo
il bisogno di staccarsi dalla fabbrica teatrale dove per un secolo abbiamo visto la catena di
montaggio drammaturgo-regista-attore-costumista-scenografo... e forse è nuovo il bisogno di
staccarsi dalla parola scritta, dalla letteratura per avvicinarsi e pescare dalla parola orale.
E. M.- Se lo definissimo “genere”, per comodità linguistica, il “genere narrativo” e spesso i
contenuti delle tue opere appartengono ad una tradizione più o meno remota e radicata. Come
spieghi venga percepito come innovativo e contemporaneo e secondo te perché i nostri coetanei, o
ragazzi ancora più giovani, amano tanto il teatro di narrazione?
A. C.- Per quello che dicevo prima. Perché quando lavoro sulla parola non penso a
Shakespeare o a Pirandello o a Pinter. Penso alle parole che ascolto nelle interviste che faccio.
Cerco di parlare in teatro con parole dette e non con parole scritte.
E. M.- Spesso non hai vissuto in prima persona i fatti di cui parli, il momento autobiografico
è ravvisabile nell’averli “uditi raccontare”. Questo punto di vista ti permette di essere “testimonemediatore” più razionale e fedele, meno recriminatorio o passionale di un protagonista?
A. C.- Non credo che per lo spettacolo che porto in scena ci sia una grande differenza.
Semplicemente credo di non poter avere tanta esperienza per poter parlare di guerra, lavoro,
manicomi ecc... e devo appoggiarmi alla memoria degli altri. Ma poi anche io lavoro sulla mia
memoria. La mia memoria dell’ascolto delle memorie altrui.
E. M.- La “storia ufficiale” a volte sembra una verità imposta dall’alto, si può dire che tu
cerchi di divulgare la verità che parte dal basso, meno manipolata? Per esempio, la “radio
clandestina” con le sue informazioni, può essere simbolo del tuo lavoro che diffonde dati certi, ma
poco ufficiali?
A. C.- No, credo che quella che tu chiami “verità imposta dall’alto” sia una storia senza
persone. Una storia dove gli individui con la propria identità vengono frullati e resi indistinguibili in
una massa (che in maniera più ipocrita si potrebbe dire “popolo”, ma sempre indistinguibili restano
gli individui). Io cerco di raccontare le storie delle persone coi loro nomi e cognomi e forse in
5
La presente intervista è stata gentilmente concessa all’autrice da Ascanio Celestini, il quale ha fornito le
risposte per iscritto, si è quindi ritenuto opportuno non alterare il testo e riportarlo in forma integrale.
TP
PT
questo modo racconto una storia anche più parziale di quella “dall’alto”, ma più concreta. Il 24
marzo di ogni anno alle Ardeatine durante la cerimonia si leggono i nomi di tutti i morti
nell’eccidio. Bisogna ricordare i nomi, nel senso delle identità.
E. M.- La lingua che usi è un lessico popolare. Il linguista Gian Luigi Beccaria dice che le
forme vernacolari sono proprie dell’immediatezza e dell’azione, mentre l’italiano è della
riflessione e spiegazione, sei d’accordo?
A. C.- Da una parte c’è il problema del teatro che soprattutto in questi ultimi anni è diventato
l’ultimo baluardo di un italiano morto. Una lingua che non si parla da nessun’altra parte se non sul
palcoscenico. Una lingua che non è manco letteraria, è solo “teatralesca”, una lingua con le sue
pause ridicole e fintamente teatrali. Io cerco di parlare con la mia voce e con le mie pause, con la
mia lingua. Scrivo i miei testi, ma non li imparo a memoria. Anche nel momento in cui sono in
scena io scrivo. Pesco le parole da un vocabolario che mi appartiene. Non cerco di apparire
immediato e spontaneo, cerco di esserlo. L’unica cosa che mi preparo è la storia, ma non le parole
per dirla.
E. M.- Come vedresti la ripresa dei tuoi testi da parte di altri attori? Usare la lingua
popolare e raccontare vicende personali può costituire un limite a questo? Quanto può slegarsi,
questo lavoro, dall’autore per essere riproposto da altri interpreti?
A. C.- Ho visto il mio Fabbrica in Romania e in Belgio. In gennaio andrò a vederlo in
Portogallo. In Romania era una messa in scena molto tradizionale, ma in Belgio è stato molto
interessante. L’attore e il regista hanno pensato alla storia, pensavano che fosse interessante per loro
e l’hanno semplicemente portata in scena. In Belgio mi conoscono pochissimo e non c’è stato
nessun problema a portare in scena un mio testo, nessuno pensava come io lo porto in scena
normalmente. Il racconto è personale nel senso che riguarda la persona che lo racconta. Tutto il
teatro dovrebbe essere così. Non bisognerebbe scegliere un testo da portare in scena semplicemente
perché è ben scritto, perché è un capolavoro... ma proprio perché è personale: riguarda la persona
che lo porta in scena.
E. M.- Ancora alla luce di questo, il “teatro di narrazione” italiano raccoglierebbe, o ha
raccolto, consensi all’estero?
A. C.- Forse un po’ ho già risposto. Quando vado all’estero sono sottotitolato. Tutti seguono
benissimo (anche perché sono abituati ai film sottotitolati) e c’è una grande attenzione per questo
genere.
E. M.- Presenti scenografie semplici e non descrittivo-narrative, si può parlare di
ricostruzione sulla scena di uno spazio mentale, interiore, della memoria, un po’ com’era per il
regista polacco T. Kantor che concretizzava sul palco la soglia liminale della sua memoria da cui
irrompevano le immagini mentali?
A. C.- Penso alla scena come ad una stanza sul palcoscenico. Una stanza che non racconta la
storia, ma che la contiene. Così come la mia camera da pranzo contiene il pranzo che sto facendo. È
la mia camera e non rappresenta la storia che racconto, ma presenta una parte della mia identità.
E. M.- Quando proponi i tuoi lavori sei accompagnato dalla musica di Gianluca Zammarelli
e Matteo D’Agostino, oltre ad ascoltare la parola, si ascolta anche la musica, essa assume quindi
valore icastico, evocativo e descrittivo?
A. C.- In realtà ci sono solo due lavori che faccio con Gianluca e Matteo: La Fine del Mondo
e Cecafumo. Il primo è uno spettacolo vero e proprio e il secondo è la raccolta di un repertorio di
racconti più o meno tratti dalla tradizione popolare. Con loro il lavoro di improvvisazione per me si
moltiplica. Io improvviso seguendo la musica e loro improvvisano ascoltando me. La musica non
accompagna il racconto, ma è presente in maniera autonoma. Questa autonomia gli consente di
interagire col racconto senza dover essere subalterna a esso. È presente come in una festa
tradizionale dove la musica ha una sua autonomia rispetto al ballo (può essere ascoltata senza dover
per forza ballare), ma non suona contro chi sta ballando e chi vuole può ballarci sopra.
E. M.- La “morte”, i “morti”, compaiono spesso come concetto e come personaggi, perché?
Sono estremamente attivi e affaccendati, servono loro per tenere viva la memoria, quasi che i
“vivi” siano troppo impegnati ad esistere per ricordare?
A. C.- La morte è una grande possibilità per il racconto. Il trapasso è la soglia. Io parlo quasi
sempre di morti appena morti, di vivi che stanno morendo, di morti che risorgono. A me interessa
questa soglia (anche in Vita Morte e Miracoli dove c’è il marito di Mariona che è morto da molto
tempo: ma ora si trova nel momento in cui deve scegliere se andare all’inferno o in paradiso). A me
interessa la soglia. Il momento tra il-dentro-e-il-fuori. Mi interessa l’identità perciò lavoro sul tema
della crisi d’identità. Mi interessa quella che Ernesto De Martino chiamava crisi della presenza.
E. M.- In Bella Ciao, recentemente, distinguevi tra la “testimonianza” e la “memoria”,
preferendo quest’ultimo termine in rapporto al tuo lavoro. Per Primo Levi la “testimonianza” era
dovere e salvezza, per te cosa significa aiutare a ricordare e conoscere?
A. C.- La memoria è come quando uno ha bisogno di ritrovare dove ha parcheggiato la
macchina. L’ha parcheggiata ieri sera che era notte in qualche strada dietro casa sua e mo’ non si
ricorda dove l’ha messa. Incomincia a riflettere sulla strada che ha fatto a piedi per tornarsene a
casa, cerca di ricordarsi se gli è successo qualcosa di particolare, recupera l’immagine di una scritta
sul muro o l’insegna di un locale. La macchina è stata parcheggiata diverse ore fa, un tempo che
riguarda il passato. Ma è nel presente che ha bisogno di recuperare la memoria perché nel futuro
dovrà raggiungere il posto di lavoro e non può farlo senza la propria macchina. Nel senso che la
memoria riguarda noi come persone e il tempo che stiamo vivendo ora anche se ci ricollega al
passato. Ma non è un passato nostalgico, non è la storia che ci insegnano a scuola, la retorica storia
dei popoli che ha bisogno degli individui solo per trasformarli in santi ed eroi. Preferisco non usare
la parola “testimonianza” perché porta con sé un senso di oggettività che non credo sia adatto al
racconto personale. In tribunale una testimonianza può mandare in galera qualcuno.
La riproduzione e/o la citazione di questo testo, anche se parziali, sono consentite solo citando la fonte:
Emanuela Marzoli, Ascanio Celestini e il suo teatro di narrazione, www.klpteatro.it
Per leggere l’intera tesi di laurea o avere ulteriori informazioni contattare l’autore al seguente indirizzo:
[email protected]