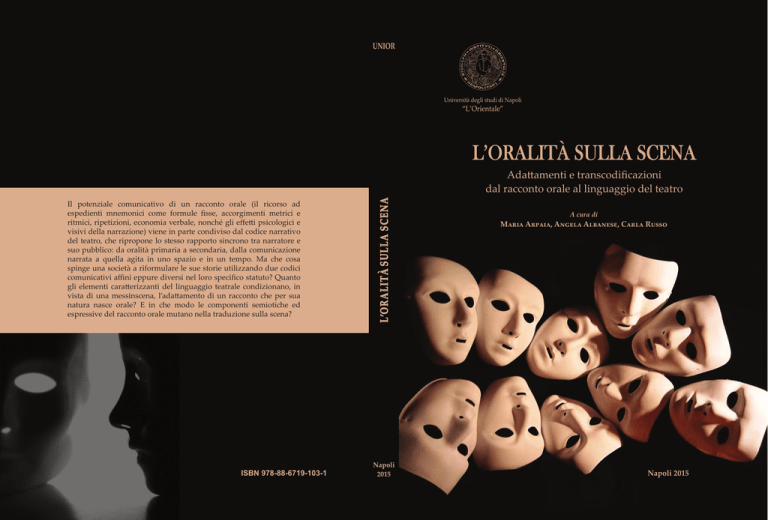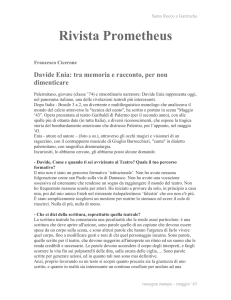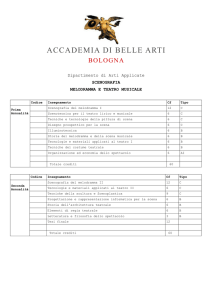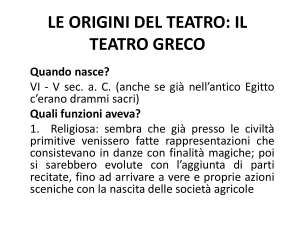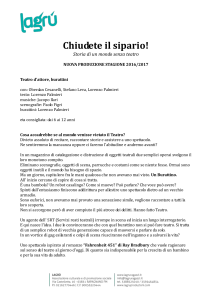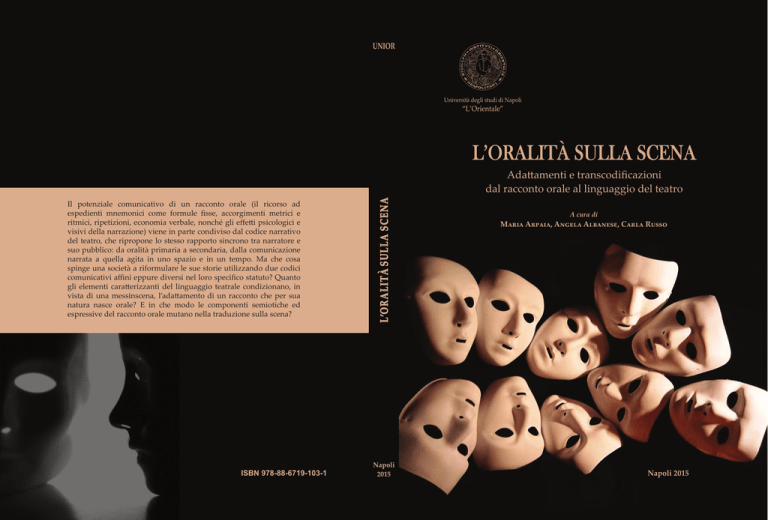
UNIOR
Università degli studi di Napoli
“L’Orientale”
L’ORALITÀ SULLA SCENA
Il potenziale comunicativo di un racconto orale (il ricorso ad
espedienti mnemonici come formule fisse, accorgimenti metrici e
ritmici, ripetizioni, economia verbale, nonché gli effetti psicologici e
visivi della narrazione) viene in parte condiviso dal codice narrativo
del teatro, che ripropone lo stesso rapporto sincrono tra narratore e
suo pubblico: da oralità primaria a secondaria, dalla comunicazione
narrata a quella agita in uno spazio e in un tempo. Ma che cosa
spinge una società a riformulare le sue storie utilizzando due codici
comunicativi affini eppure diversi nel loro specifico statuto? Quanto
gli elementi caratterizzanti del linguaggio teatrale condizionano, in
vista di una messinscena, l’adattamento di un racconto che per sua
natura nasce orale? E in che modo le componenti semiotiche ed
espressive del racconto orale mutano nella traduzione sulla scena?
ISBN 978-88-6719-103-1
L’ORALITÀ SULLA SCENA
Adattamenti e transcodificazioni
dal racconto orale al linguaggio del teatro
Napoli
2015
A cura di
Maria Arpaia, Angela Albanese, Carla Russo
Napoli 2015
Università degli studi di Napoli “L’Orientale”
Dottorato di ricerca in Letterature Comparate
Dottorato di ricerca in Storia del Teatro Moderno e Contemporaneo
2
Progetto scientifico a cura di
MARIA ARPAIA e ANGELA ALBANESE
Sito internet
https://graduateconferenceunior.wordpress.com/
CAPITOLO I
Le trasformazioni storiche del territorio
3
Università degli studi di Napoli
“L’Orientale”
L’oralità sulla scena
Adattamenti e transcodificazioni
dal racconto orale
al linguaggio del teatro
Atti della Graduate Conference
Università degli studi di Napoli “L’Orientale”
3-4 ottobre 2013
a cura di
Maria Arpaia, Angela Albanese, Carla Russo
NAPOLI
2015
4
CAPITOLO I
In copertina:
????????????????????, foto ????????
Questo volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Letterari,
Linguistici e Comparati e dei Dottorati di ricerca in Letterature Comparate e in Storia del
Teatro Moderno e Contemporaneo dell'Università degli studi di Napoli “L'Orientale”.
Tutti i contributi del volume sono stati sottoposti a procedura di blind peer review.
Proprietà letteraria riservata
© Università degli studi di Napoli “L’Orientale”
Napoli 2015
Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Sono pertanto vietate la conservazione in sistemi
reperimento dati e la riproduzione o la trasmissione anche parziale, in qualsiasi forma e mezzo
(elettronico, meccanico, incluse fotocopie e registrazioni) senza il previo consenso scritto
dell’editore.
INDICE
Prefazione
Maria Arpaia, Angela Albanese
9
Sezione I
Introduzione
Maria Arpaia, Mito tra narrazione e rappresentazione scenica
Massimo Fusillo, Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in
scena
Maria Arpaia, Il potere performativo della parola nelle scene di agnizione.
Comunicazione e rappresentazione fra epica e tragedia nella Grecia antica
Maddalena Giovannelli, Il teatro antico tra narrazione e performance: il
protagonista comico come demiurgo
Anna Livia Frassetto, Una rilettura giocosa per musica del mito di Lucrezia:
Lugrezia romana in Costantinopoli di Carlo Goldoni
Dario Migliardi, Il mythos dell'Eacide ne l’In-vulnerabilità di Achille di
Carmelo Bene
Anna Vinciguerra, Orghast di Peter Brook e Ted Hughes: il mito riscritto
13
19
33
45
53
59
71
Sezione II
Introduzione
Maria Arpaia, Angela Albanese, Messa in scena di racconti e storie
popolari di carattere folklorico
Stefano de Matteis, Alla Gioconda si possono fare solo i baffi (e il pizzetto)
Angela Albanese, Con Basile alle spalle: le Gatte di Roberto De Simone
Vincenza Di Vita, Vincenzo Pirrotta tra cunto e sacre-vie nell’apocalisse di un
Faro al Buio
Gabriella Sgambati, Till Eulenspiegel di Tawada Yōko: tra magie e straniamenti
linguistici
Enza Dammiano, Velimir Chlebnikov: ‘esorcismi‘ in scena tra mito e folclore.
Chiara Maria Buglioni, “Resta. Ti racconto qualcosa”. Il dramma popolare Das
glühend Männla da oralità primaria a tradizione incarnata
81
87
103
113
123
133
143
6
Indice
Dora Rusciano, Racconto, teatro e formazione nel Kaspar di Peter Handke
Alessandro Cimino, Donare la propria carne come pasto: un motivo letterario
indiano tra teatro, mito e folklore
Antonella Zapparrata, Il mito de “I sette dormienti di Efeso” nel teatro del
drammaturgo egiziano Tawfiq al-Hakim
Irene Starace, La fiaba della moglie gru e la sua trasposizione teatrale in Yūzuru
di Kinoshita Junji
151
163
175
189
Sezione III
Introduzione
Carla Russo, Costruzione dell’oralità e costruzione della scena
Gerardo Guccini, Dal narratore/bambino all'autore/performer. Aperture
problematiche su narrazione e memoria a partire dall'Histoire de ma vie
di George Sand
Carla Russo, Costruzione dell’oralità nell’operazione teatrale di Emma Dante
Silvia De Min, Una voce che contiene tante voci
Vera Cantoni, Testualmente: l’elaborazione drammaturgica delle fonti nel teatro
verbatim
Maria Cristina Zerbino, Pulci e pidocchi: il gioco dei pronomi sulla scena
plautina, tra oralità e scrittura
Luigia Tessitore, Cantastorie da cabaret: attualizzazione del Bänkelsang nel
cabaret tedesco degli anni ’20
Fatima Sai, Il corpo del poeta. Oralità secondaria nella poesia araba
contemporanea: Muzaffar al-Nawwab
Maia Giacobbe Borelli, Non c’è niente di più simile ad un fiume che un racconto:
la voce della natura nelle narrazioni di Sista Bramini
197
201
209
219
229
239
251
261
269
Sezione IV
Introduzione
Angela Albanese, Teatralizzazione di vicende storiche attraverso la loro
narrazione orale
Gabriele Vacis, La drammaturgia dell’attenzione
Davide Aliberti, The Ladino Players: dalla narrazione orale alla performance nel
teatro sefardita statunitense
279
283
291
Indice
Daniela Allocca, (R)Esistenze sonore. La traduzione dell’invisibile in Schwarze
Jungfrauen e Schattenstimmen di Feridun Zaimoğlu e Günter Senkel
Raffaella Di Tizio, Lavoravo all’OMSA: dalla cronaca al teatro, pensando a
Brecht
Indice degli Autori
7
299
307
315
8
Indice
MARIA ARPAIA – ANGELA ALBANESE
PREFAZIONE
Le storie non appartengono soltanto a chi vi assiste o a chi le
inventa.
Una volta raccontate appartengono a chiunque, si ripetono di
bocca in bocca e si modificano e si deformano.
Nulla viene raccontato due volte nella stessa forma né con le
stesse parole, neppure se quello che racconta due volte è la
stessa persona.
J. Marías, Domani nella battaglia pensa a me
Cosa spinge una società a raccontare le sue storie utilizzando due codici comunicativi, il racconto orale e il teatro, affini eppure diversi nel loro specifico statuto?
Quanto gli elementi convenzionali del linguaggio teatrale condizionano la struttura narrativa di un racconto che nasce orale? In che modo le componenti semiotiche
ed espressive del racconto orale mutano nella traduzione sulla scena?
Sono queste le domande che hanno dato vita al nostro progetto di ricerca comune, nato in seguito ad un incontro casuale, avvenuto a Bologna nel giugno del
2012,1 tra una classicista prestata alla comparatistica e una studiosa di teoria della
traduzione, di fiabe e di teatro. Da questa intesa e dall’urgenza critica di avviare
una ricerca comparata tesa a far interagire competenze e ambiti disciplinari differenti è maturata l’idea di riunire a confronto giovani ricercatori e studiosi per una
riflessione sulle dinamiche di adattamento che intervengono nella trasposizione
scenica di un racconto di solito tramandato per via orale.
L’idea ha preso forma in una Graduate Conference, tenutasi il 3-4 ottobre 2013
presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, dal titolo L’oralità sulla
scena. Adattamenti e transcodificazioni dal racconto orale al linguaggio del teatro. Le
quattro sessioni in cui si sono articolate le due giornate di lavori, rispettivamente
“Mito tra narrazione e rappresentazione scenica”; “Messa in scena di racconti e
storie popolari di carattere folklorico”; “Costruzione dell’oralità e costruzione della
scena”; “Teatralizzazione di vicende storiche attraverso la loro narrazione orale”,
hanno dunque cercato di dare conto delle principali declinazioni della contaminazione tra l’oralità e il linguaggio del teatro. I lavori si sono rivelati densi di spunti
di riflessione e di arricchimenti reciproci, sollecitando la stampa di questo volume
1 L’occasione è stata la partecipazione alla Graduate Conference L’adattamento: le trasformazioni delle
storie nei passaggi di codice, organizzata congiuntamente dall’Università di Bologna e dall’Università di
Cagliari e tenutasi presso le due sedi il 22 giugno 2012.
10
Prefazione
che raccoglie i contributi presentati e intende fornire una panoramica critica dei
nodi tematici e concettuali emersi durante i momenti di riflessione collettiva.
Nel licenziare questi atti i più sinceri ringraziamenti vanno a coloro che hanno
creduto nella nostra idea fin dall’inizio, sostenendola dal punto di vista sia scientifico che istituzionale: Donatella Izzo, Riccardo Palmisciano, Lorenzo Mango, Franco Nasi. Ringraziamo in particolare Donatella Izzo per la supervisione organizzativa e il suo fattivo supporto, oltre che per l’entusiasmo con cui ha costantemente
seguito le diverse fasi del progetto.
Ai Dottorati di ricerca in Letterature Comparate e in Storia del Teatro Moderno
e Contemporaneo; al Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati e al
Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo dobbiamo, oltre alla realizzazione del
convegno, anche la pubblicazione del presente volume.
A tutti i membri del Comitato scientifico, Francesco Chianese, Enza Dammiano,
Szilvia Jakab, Mara Matta, Carla Russo, Anna Vinciguerra, e in particolare a Carla
Russo, che ha condiviso con noi l’impegno di questa curatela, va la nostra gratitudine, nella consapevolezza che nulla sarebbe potuto avvenire senza il contributo
individuale di ciascuno di loro.
Tutta la nostra riconoscenza, infine, ai Keynote Speakers delle sessioni, Massimo Fusillo, Stefano De Matteis, Gerardo Guccini, Gabriele Vacis, che con la loro
partecipazione e le loro sollecitazioni critiche hanno arricchito le due giornate di
lavori, aprendo la riflessione verso ulteriori orizzonti di ricerca, e i cui contributi
hanno impreziosito il presente volume.
Questa esperienza napoletana ha posto le basi per ulteriori analisi, aprendo
l’indagine a nuovi orizzonti di ricerca. L’entusiasmo del dialogo multidisciplinare,
infatti, ha contagiato uno dei relatori del convegno, Vincenza Di Vita, che ha proposto – e generosamente organizzato – la seconda edizione della Graduate Conference, che si è tenuta a Messina il 17-18 ottobre 2014, dal titolo La scena dell’oralità.
Per una voce fuori luogo, realizzata con il sostegno del Dipartimento di Scienze cognitive, della Formazione e degli Studi Culturali dell’Università di Messina.
A lei e a Dario Tomasello, che si è occupato della supervisione organizzativa, la
nostra gratitudine: il pensiero dell’affettuosa ospitalità a noi riservata dall’intero
comitato organizzativo e il ricordo del clima di entusiasta collaborazione ci rimangono cari e ci confermano che le idee che crescono insieme sono in grado di gettare
radici, anche a distanza di tempo e di spazio.
Prefazione
Sezione I
11
12
Prefazione
MARIA ARPAIA
Introduzione
MITO TRA NARRAZIONE E RAPPRESENTAZIONE SCENICA
La messa in scena altro non è, nel suo fondamento, che
un’operazione di messa in uso.
I testi che richiedono l’oralità si “mettono in uso” ad alta voce
ed è condizione della drammaturgia (anche di quella che descrive azioni da compiere) avere una “scrittura inerte”.
Giorgio Agamben, Altissima povertà: regole monastiche e
forme di vita
Giorgio Agamben, nel suo saggio sulle regole della vita monastica, dedica alcune pagine al rapporto tra scrittura e lettura ad alta voce e si sofferma sul valore
performativo dell’atto verbale. Nell’ambito della pratica della lettura collettiva,
Agamben descrive la verbalizzazione del testo scritto come la sua “messa in uso”:
la scrittura prescrive una diffusione orale del contenuto, senza la quale esso rimarrebbe “inerte”, come un elemento in potenza senza atto.1 Questo processo, descritto come “messa in scena dell’oralità”,2 ci introduce nel cuore delle questioni teoriche di questo convegno, che si propone di riflettere sull’aspetto performativo
dell’atto poetico orale e sulla sua declinazione in differenti contesti esecutivi.
Il rapporto empatico tra emittente e destinatario, fisicamente compresenti al
momento dell’esecuzione, presuppone una focalizzazione costante sulla funzione
fatica del messaggio e sulla consistenza sonora e materiale della parola, che necessita della fisicità di un esecutore che la veicola, a sua volta visibile all’uditore.
“Il desiderio della viva voce abita in ogni poesia” – afferma Zumthor riflettendo
sul valore sostanziale dell’atto verbale – “e ogni poesia aspira a darsi voce, in una
identificazione del messaggio con la situazione che lo genera”.3 Ogni esecuzione
orale non si realizza solo nella ricezione uditiva, ma anche nella componente visiva
1 Devo questa citazione alla privilegiata lettura in anteprima della monografia di Piermario Vescovo
A viva voce. Percorsi del genere drammatico, Marsilio, Venezia, 2015, in c.d.s. Il suo testo, che apre
prospettive feconde nello studio dell’impiego dell’oralità e della voce nelle realtà teatrali
contemporanee, ci conduce in un percorso analitico sulla funzione scenica della comunicazione orale,
sia essa verbalizzazione di un testo scritto oppure intrusione di elementi del parlato nel sistema
semiotico della scena. Aver scoperto una sinergia di vedute e di orizzonti teorici con l’idea di fondo di
questo convegno, quando ho avuto il piacere di incontrarlo in occasione della seconda edizione di
questa Graduate Conference a Messina nell’ottobre del 2014, è stata una piacevole sorpresa.
2 Giorgio Agamben, Altissima povertà: regole monastiche e forme di vita, Neri Pozza, Vicenza, 2011, p. 94.
3 Paul Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 198.
14
Maria Arpaia
di un corpo che la genera e di uno spazio in cui si realizza. Spetta al corpo il compito di articolare il discorso, attivando non solo l’apparato fonatorio ma anche una
gesticolazione più o meno accentuata o codificata delle braccia o della testa, o mediante un uso particolare dello sguardo. Ma la voce e il gesto del performer orale si
proiettano nel luogo dell’esecuzione, che è molto vicino al concetto di ‘scena’, intesa come tutto ciò che cade sotto lo sguardo. Ogni comunicazione orale si vede e si
sente; si esperisce in maniera polisensoriale mediante una serie di sollecitazioni
uditive e visive: “si toccano qui i confini dove la poesia orale diviene teatro”.4
La modalità comunicativa del teatro, infatti, pur rispondendo ad esigenze rappresentative differenti, mostra non pochi punti di contatto con una performance
orale: il rapporto empatico tra spettatori e attori, che condividono spazio e tempo
dell’emissione del messaggio, e l’irripetibilità della performance, in entrambi i
generi legata ai condizionamenti dell’hic et nunc della sua realizzazione.
In una cultura orale l’unicità e l’evanescente temporalità dell’atto locutorio, che
si crea nell’istante stesso in cui viene prodotto e svanisce un istante dopo essere
stato ascoltato, determina un’attribuzione di potere quasi magico alla parola orale,
prodotta in maniera aleatoria sulle labbra del singolo e diffusa alla comunità in un
momento rituale, denso di significato simbolico.5
In tal modo la parola stessa diventa ritualizzata, cioè legata in modo imprescindibile ad una dimensione sociale d’incontro comunitario, e la sua esecuzione spettacolarizzata diviene spesso occasione di educazione collettiva. La trasmissione del
sapere tradizionale si avvale, così, della compartecipazione emotiva che si instaura
tra esecutore e pubblico: legati a doppio filo da un reciproco condizionamento, essi
stringono tra di loro un legame profondo che conduce l’uditorio a immedesimarsi
nelle vicende ascoltate quasi come se le osservasse a teatro.
Anche il genere teatrale, infatti, gode del fascino magico della parola detta, che
non preesiste né sopravvive alla sua realizzazione. E in questa immediatezza
dell’esecuzione, che coinvolge nell’unicità del momento performativo i suoi spettatori, il teatro svolge la sua funzione comunicativa, anch’essa basata su un’identificazione empatica nelle vicende narrate.
Dal punto di vista strettamente performativo, quindi, in entrambi i casi
l’uditorio assiste ad una esecuzione spettacolarizzata; subisce un forte impatto
emotivo e fruisce dei contenuti mediante un’immedesimazione più o meno accentuata nelle vicende.
Tuttavia, in alcuni casi, la comunicazione orale e quella teatrale non sono accomunate solo dall’elemento mimetico, più o meno accentuato, ma condividono anche i contenuti narrativi, quei racconti divulgati dalla tradizione orale e identifica-
4
5
Zumthor, La presenza della voce, cit., p. 255.
Livio Sbardella, Oralità. Da Omero ai mass media, Carocci, Roma, 2006, p. 18.
Mito tra narrazione e rappresentazione scenica
15
bili come ‘tradizionali’, modello archetipico di atteggiamenti individuali e collettivi
che costituiscono il deposito della memoria di una società.
Si assiste così ad un passaggio di codice, che coinvolge inevitabilmente anche
gli intenti comunicativi e gli effetti sulla ricezione del pubblico: dalla comunicazione narrata a quella agita per via di mimesi diretta in uno spazio e in un tempo;
dall’immedesimazione parziale di un uditorio a quella totale di un pubblico.
Sia nell’ambito di una tipologia di teatro naturalistica, che intenda adattare paradigmi di comportamento assunti dalla vita quotidiana, sia all’interno di un codice rigidamente formalizzato come quello estremo-orientale o di indirizzo brechtiano, ogni messa in scena presuppone l’applicazione di una serie di variabili concrete, come le condizioni e le dimensioni del luogo o l’uso o meno delle maschere o di
costumi; e di regole performative intrinseche al genere teatrale, come il rapporto
tra il discorso monologico e lo scambio dialogico, le didascalie sceniche interne o
esterne al testo, variazioni più o meno accentuate del registro stilistico.
Un approccio comparato che approfondisca le modalità con cui culture diverse,
nel tempo e nello spazio, hanno adattato le loro storie tradizionali alle diverse regole compositive del racconto orale e scenico risulta funzionale alla comprensione
dei legami tra i meccanismi della realizzazione estetico-poetica e la funzione educativa ad essa riservata nel contesto sociale di riferimento.
Nello specifico, in questa prima sezione di lavori, l’indagine si è concentrata sulle
modalità con cui culture diverse, nel tempo e nello spazio, hanno adattato il racconto
mitico alle regole compositive dell’oralità e della trasposizione scenica, con attenzione particolare alle fasi di passaggio dal mito narrato al mito rappresentato.
Nell’ambito del racconto tradizionale, il mito costituisce la categoria più produttiva per condurre questa analisi: esso, infatti, concilia l’esemplarità del racconto,
che veicola un vasto repertorio di usi, costumi, comportamenti e valori ed è di solito riferito ad un passato leggendario, ad una straordinaria vitalità.
La performance orale, infatti, dettata dalle esigenze dell’occasione, concede un
ampio spazio all’intervento del singolo, che interviene a modificare non solo il
modo narrativo, ma parzialmente anche il contenuto stesso del testo. L’apparente
fissità del contenuto, in realtà, si modella e si declina in base al contesto e alle esigenze del suo pubblico oppure in rapporto all’ideologia del singolo autore e alle
esigenze culturali e politiche del tempo in cui esso è narrato, mostrandosi aperto
ad inclusioni, adattamenti e varianti del plot narrativo.
Il racconto mitico, pertanto, è ricreato dal narratore in ogni esecuzione, in una
forma sempre nuova e irripetibile: potremmo quasi affermare che il ‘mito’, in senso
astratto, non esista; o meglio, sia una sorta di “racconto madre”, un insieme di
determinate funzioni narrative ad alto valore metaforico, di cui ci sono giunte solo
le varianti, articolate nelle singole narrazioni che hanno attraversato tutti i codici
della comunicazione, a partire da quello orale, passando poi per la fase scritta.
L’elemento universale che rende questa tipologia narrativa così versatile non risie-
16
Maria Arpaia
de quindi nella sua struttura, ma nell’efficacia comunicativa: si può dire che esso è
una forma della narrazione, un metalinguaggio che si adatta di volta in volta, come
un vestito cucito a misura, su contenuti sempre nuovi,6 al fine di veicolare quel
sistema di valori che l’uditorio richiede.
Nell’adattamento del mito alla messa in scena, invece, il legame con una committenza collettiva e compresente al momento della produzione del testo, come
avviene nel caso della performance orale, è meno vincolante. L’autore, infatti, può
addirittura cercare un legame più o meno esplicito con gli eventi di attualità in cui
si svolge la rappresentazione, giocando su molteplici risemantizzazioni della materia tradizionale. In tal modo il mito si offre ancora ricco di molteplici spunti di riflessione: ponendo in crisi il proprio passato mitico, la società prende atto dei suoi
problemi sociali da un punto di vista critico e straniato.
Riguardo all’adattamento del mito al linguaggio del teatro e all’intrusione
dell’elemento dell’oralità nella rappresentazione teatrale lo studio di Massimo
Fusillo, Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena, inaugura la
sessione di lavori con una lucida riflessione sulle funzioni che l’oralità può assumere sulla scena, adducendo esempi tratti dalla drammaturgia e dal cinema contemporaneo. Nella commistione tra le due forme comunicative, l’oralità contribuisce a mettere l’accento sul processo creativo della rappresentazione, oltre ad amplificare l’interazione con il pubblico e la contaminazione dei registri stilistici, consentendo al dialetto, al grottesco e perfino all’osceno di entrare anche nelle opere più
tragiche.
L’oralità di cui si occupa Fusillo, infatti, comprende sia quella del linguaggio
spontaneo della conversazione, in cui l’espressività del dialetto è in grado di dare
voce in modo immediato a sensazioni ed impressioni, sia quella codificata del racconto orale del cunto siciliano, contaminato con sonorità e ritualità provenienti
dalle culture popolari di tutto il mondo ‒ dai canti maghrebini alla ritualità giapponese, fino alla tammurriata napoletana. In tal modo l’oralità sulla scena assolve il
duplice compito di recuperare il legame con le tradizioni più ancestrali e viscerali e
di dilatare i confini narrativi della tragedia stessa, fino a minarne la struttura
dall’interno e ad assumere una funzione provocatoria e parodica.
Le radici di questa commistione tra il linguaggio del teatro e quello dell’oralità
sono fornite dai primi due interventi della sessione, che risalgono alla rappresentazione della tragedia e della commedia nell’antica Grecia e, in particolare, al differente rapporto che i due generi instaurano con il loro pubblico.
Nel mio intervento, Il potere performativo della parola nelle scene di agnizione. Forme
di comunicazione e modalità di rappresentazione fra epica e tragedia nella Grecia antica,
sono messe a fuoco le differenze espressive e le strategie comunicative che consen6 Bruno Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia Antica. Da Omero al V secolo, Feltrinelli, Milano, 2006, pp.
118-137.
Mito tra narrazione e rappresentazione scenica
17
tono ad un’oralità ‘interamente narrata’, come quella dell’epica greca, di adattarsi
alle norme rappresentative di un’oralità ‘narrata e agita’, come quella che si realizza sulla scena della tragedia.
Prendendo come caso di analisi una sequenza del racconto tradizionale molto
feconda sia in epica che in tragedia, come quella dell’agnizione, si è proceduto ad
un confronto testuale comparato delle differenti modalità narrative. Nell’epos il
narratore si lascia andare a lunghe digressioni e a pennellate descrittive che consentono più spazio creativo all’uditorio, il quale procede all’immaginazione degli
eventi ascoltati e si lascia emotivamente trasportare dalla corrente della narrazione
ciclica. Nella narrazione scenica, invece, la diegesi viene rifunzionalizzata per seguire le norme compositive del genere: il racconto si plasma, si mimetizza e diventa un dialogo e la voce monologica dell’epica si scinde e si moltiplica in quella dei
vari personaggi. Il dubbio stesso è drammatizzato e tradotto in atto locutorio, mediante una verbalizzazione del processo logico che conduce al riconoscimento.
Maddalena Giovannelli, invece, nel suo saggio L’attore comico: un artefice del proprio racconto, si sofferma sulle contiguità espressive tra le forme del racconto orale e
della commedia greca arcaica, identificate nel rapporto diretto e immediato tra gli
attori e gli spettatori. La prassi della commedia greca secondo cui l’attore, nella parabasi, si rivolge direttamente al pubblico, viene identificata come l’elemento di massima affinità tra la messa in scena comica e quella epica al punto da ipotizzare una
vera e propria inclusione dell’uditorio nel processo performativo della rappresentazione comica. L’attore comico è quindi in bilico tra l’identità di narratore e quella di
performer; l’oralità e la messa in scena sono intrinsecamente fuse nel genere comico,
che mantiene questa polimorfia e sopporta le inclusioni dell’oralità non solo narrata,
ma anche recitata, in maniera più naturale e funzionale della tragedia.
Con l’intervento di Anna Livia Frassetto, Una rilettura giocosa per musica del mito
di Lucrezia: Lugrezia Romana in Costantinopoli di Carlo Goldoni, siamo trasportati
in un altro linguaggio comico, quello dei frizzi e dei lazzi della commedia dell’arte
goldoniana.
Il dramma giocoso per musica reinterpreta, in chiave originale e assolutamente
trasversale, mediante una fusione di espedienti ereditati dal teatro dell’antichità
classica, dalla parodia carnascialesca e dalla commedia dell’arte, il mito tragico
raccontatoci da Livio, capovolgendone completamente la trama. Goldoni, infatti,
compie un’ardita inversione di senso, facendo narrare alla protagonista che Lugrezia ha solo inscenato la sua morte in combutta con il marito Colatino per fuggire
poi da Roma. La sovrapposizione di registri differenti, l’accostamento di elementi
bassi e scurrili, tipici di un discorso colloquiale, ad un contesto e a personaggi elevati è un espediente tipico della parodia a cui si affianca, però, un impiego insistito
dell’oralità parlata. Il plurilinguismo e un linguaggio ricco di onomatopee, lemmi
privi di significato, imitazioni di versi animaleschi e interiezioni costituiscono la
cifra caratteristica di questo adattamento goldoniano.
18
Maria Arpaia
Con il saggio di Dario Migliardi, Il mythos dell'Eacide ne L'In-vulnerabilità di
Achille di Carmelo Bene, si affronta un altro aspetto dell’adattabilità scenica del mito,
quello della rivisitazione semantica e simbolica mediante la contaminazione delle
fonti classiche e moderne. Il “progetto-ricerca” di Bene sul personaggio di Achille
gioca la sua potenzialità espressiva sulla doppia dicotomia, quella tra gli attributi
dell'invulnerabilità e della vulnerabilità dell'eroe e quella tra le città di Sciro e Ilio.
L’eroe delle fonti classiche del mito, una volta descritto a Sciro come puerilmente
innamorato della tenera gioventù di Deidamia e un’altra volta rappresentato ad Ilio
come ardente di una macabra passione necrofila per Pentesilea, viene fuso in un
unico personaggio duplice, che ‘sconta’ la sua invincibilità come una condanna. La
sua invulnerabilità, infatti, si rivela puramente nominale: l’eroe proposto da Bene
vive nella ferita di essere liminale, tra due realtà polarmente opposte, tra illusione di
edenica felicità e frustrazione del quotidiano, tra condizione adolescenziale, erotica e
vitale, e quella adulta, che vive nel rimpianto di un passato ormai perduto.
La rielaborazione semantica del mito nella sua trasposizione in scena cede invece il posto ad una riscrittura essenzialmente linguistica e orale nell’ultimo saggio
della sessione, quello di Anna Vinciguerra, Orghast di Peter Brook e Ted Hughes: il
mito riscritto. La trasposizione scenica del mito del Prometeo eschileo avviene qui
mediante il recupero dell’essenziale, dell’originario e dell’ancestrale, in cui il triangolo performativo attore-spazio scenico-spettatore è posto come premessa
all’intero lavoro di Peter Brook. È il linguaggio lo strumento privilegiato per compiere la riscrittura del mito e la sua trasposizione scenica, ma la lingua si articola in
forma quanto più possibile asintattica e spontanea, volta ad instaurare un tipo di
comunicazione rituale più che teatrale. Orghast, infatti, è interamente recitato in
una lingua inventata da Ted Hughes. Si tratta di un linguaggio uguale per tutti
perché posto oltre la sfera del significato, che risponde alla regola del comunicare
prima di comprendere, che non è traducibile, ma va interpretato mediante associazioni immediate e libere da significati concettuali. La riscrittura del mito per la sua
messa in scena diventa quindi un pretesto per riflettere sulla parola e sulla distinzione tra lingua e linguaggio, in una messinscena che combina le strutture sonore
inventate da Hughes alle parole riprese dal greco antico e dall’avestico, per esplorare i segni dell’azione teatrale nel teatro verbale e non verbale.
In ciascuno degli interventi della sessione ritorna, come un filo rosso, l’idea di
fondo codificata da Fusillo riguardo alle funzioni espressive che assume il mito nel
contesto teatrale: la sua opera di destrutturazione del racconto tradizionale si esplica ad ogni livello, sia esso sintattico, come nel passaggio di un tema tradizionale
dal racconto epico a quello tragico; esclusivamente performativo, come nel rapporto tra l’attore comico e il suo pubblico; parodico, come nel caso del rovesciamento
goldoniano; semantico, come nelle riscritture beniane dell’Achille; o infine puramente linguistico-lessicale, come nell’operazione mistico-rituale dell’invenzione da
parte di Ted Hughes di una lingua mitica del presente.
MASSIMO FUSILLO
LO SMONTAGGIO DEL MITO.
FUNZIONI ESPRESSIVE DELL’ORALITÀ IN SCENA
Fra l’oralità e il mito c’è un rapporto di “legittimazione reciproca”, come ci suggerisce Livio Sbardella nella sua sintesi storica:1 entrambi attingono a quella che Cassirer
definisce la “potenza primigenia della parola”, per trasmettere storie e saperi fondamentali di una comunità.2 A questo binomio è molto facile aggiungere un terzo elemento, la scena: il teatro sfrutta infatti da sempre la psicodinamica dell’oralità, quel
meccanismo che usa la seduzione del suono e la compresenza fisica fra attore e pubblico per ottenere un alto tasso di empatia. Ed è proprio in questa continua interazione fra
circuiti comunicativi che risiede il nucleo forte di ogni performance.
Aver delineato un intreccio molto fitto fra queste tre categorie, l’oralità, il mito e
la scena, può portare ad alcuni rischi. Potrebbe farci cadere in quella metafisica
dell’originario che tanto caratterizza la cultura occidentale: idealizzare dunque
questa fase aurorale di fusione fra parola, azione e racconto, considerando gli sviluppi successivi come un inevitabile declino o degradazione. In realtà la cultura
contemporanea attacca da lungo tempo i binarismi troppo rigidi, come quelli fra
maschile e femminile, pubblico e privato, epica e romanzo, originale e adattamento, e appunto oralità e scrittura. Ho scelto intenzionalmente polarità distanti fra di
loro e di portata assai diversa: tutte però hanno tratti in comune con il nostro tema,
e in tutte il primo termine ha sempre avuto una posizione gerarchica superiore,
una pienezza di senso, mentre il secondo risulterebbe un derivato, se non una ripetizione o una degradazione.
Se lasciamo da parte il piano della teoria e della riflessione filosofica, che con
Derrida ha raggiunto posizioni volutamente provocatorie riguardo al rapporto fra
oralità e scrittura, e guardiamo invece alle dinamiche storiche, ci accorgiamo subito
che le due categorie hanno convissuto spessissimo nella loro lunga durata
dall’Antichità al Medioevo e oltre; in realtà le epoche di oralità pura e primaria
sono piuttosto rare, mentre la coesistenza con la scrittura è un fenomeno frequentissimo, il che rende poco credibile una dicotomia netta.
Anche nella nostra epoca ipertecnologica, caratterizzata da una rivoluzione digitale che sta avendo un impatto certo non inferiore all’invenzione della stampa, si
parla giustamente di ritorno dell’oralità. Si tratta ovviamente soprattutto di una
oralità secondaria: innanzitutto la mimesi del linguaggio parlato che domina non
solo (e da tempo) la narrativa contemporanea, ma anche nuove forme di scrittura
1
2
Livio Sbardella, Oralità. Da Omero ai mass media, Carocci, Roma, 2006, p. 15.
Ernst Cassirer, Linguaggio e mito, SE, Milano, 2006, p. 72.
20
Massimo Fusillo
come l’email o l’sms. Penso poi soprattutto alle nuove forme di compresenza e di
interazione che si possono creare in rete fra produttori e destinatari di messaggi e
testi, come avviene nelle chat e nei blog: fenomeni di oralità mediata del tutto nuova. Infine, non sono da sottovalutare i ritorni all’oralità piena, immediata e primaria, che si verificano nel cosiddetto teatro dei cantastorie (Paolini, Baliani, Celestini), o nelle letture collettive integrali di poemi epici come l’Iliade o l’Orlando Furioso,
o di romanzi come il Don Chisciotte, o nei sempre più frequenti Festival della letteratura, dove opere pensate per la lettura solitaria e mentale, come romanzi o poesie
liriche, vengono recitate davanti a un pubblico sedotto dalla forza del suono.
Con queste premesse possiamo passare al nostro tema specifico, all’uso
dell’oralità sulla scena contemporanea, e in particolare nelle riscritture più o meno
dirette del mito. La ripresa di stilemi e tecniche dell’oralità nel teatro di oggi è un
fenomeno massiccio, per nulla episodico, e che risponde a precise poetiche e strategie espressive. Senza pretendere in alcun modo di essere esaustivo, individuerei
per ora una serie di funzioni che l’oralità può assumere sulla scena, molto legate
fra di loro, per poi passare ad una serie di esempi pratici, che dalla tragedia e dal
teatro ci porteranno fino al mito moderno e al cinema:
1) Lo smontaggio di ogni idea aristotelica e strutturalista del testo (drammatico e
scenico) come sistema chiuso ed autosufficiente.
2) La rottura di ogni linearità teleologica, il che significa spesso la decostruzione
del finale come momento forte di ricomposizione delle tensioni.
3) L’enfasi sul processo creativo come attività infinita, come produzione interminabile che tende a coincidere con il flusso esistenziale.
4) L’interazione spiccata con il pubblico, secondo le varie modalità della performance.
5) La contaminazione dei registri stilistici, che può immettere, anche nelle opere
più tragiche e sublimi, il grottesco, il dialetto, l’osceno.
Nel Novecento l’interazione fra mito e tragedia è stata assai intensa: gli artisti
che hanno riscritto e/o messo in scena le tragedie antiche hanno dialogato allo stesso tempo direttamente con questa entità più fluida che è il mito, spesso richiamandosi alle interpretazioni che ne dava l’antropologia. Lo si osserva facilmente se si
seguono le varie messinscene dell’unica trilogia completa che ci è pervenuta,
l’Orestea, come ha fatto Anton Bierl:3 varie regie ormai famose, come quella della
‘Societas Raffaello Sanzio’, lavorano sulle tracce mnestiche del mito, mentre tutte,
anche quelle più tradizionali, tendono a decostruire il finale positivo di Eschilo,
comunque non privo di una notevole ambiguità e tensione irrisolta. Le Eumenidi
novecentesche, a partire dai drammi di O’Neill e Hauptmann fino agli spettacoli di
3 Anton Bierl, L’Orestea di Eschilo sulla scena moderna. Concezioni teoriche e realizzazioni sceniche,
Traduzione di Luca Zenobi, Premessa di Massimo Fusillo, Prefazione dell’autore alla nuova edizione
italiana, Bulzoni, Roma, 2004.
Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena
21
Ronconi e Stein, non celebrano mai la nascita di un nuovo mondo democratico e
tendono a focalizzarsi, chi più chi meno, sul ritorno delle forze arcaiche rappresentate da Clitennestra, sulle tensioni celate dietro la sublimazione e la sintesi.
Per una scelta estetica del direttore artistico delle Orestiadi di Gibellina, Gianfranco Capitta, l’Orestea andata in scena nel 2004, coprodotta dalla Biennale di Venezia
diretta da Castri e dal Teatro di Roma, non poteva essere una rilettura organica e
filologica, affidata come era a tre registi dalle fisionomie diverse, anche se con punti
comuni, rafforzati dalla scelta di usare nei tre spettacoli la traduzione di Pasolini.
L’Agamennone di Roderigo Garcia è un esempio particolarmente efficace del radicalismo del suo teatro, che prende spunto dal testo e dal tema della guerra per mostrare
gli eccessi e le ossessioni alimentari del mondo contemporaneo, mentre le Coefore di
Monica Conti rileggono la ritualità antica nella prospettiva delle tradizioni rurali
dell’Italia meridionale e della Resistenza. L’ultima tragedia è stata affidata all’artista
che più ha applicato la tradizione orale siciliana del Cunto (seguendo il modello di
Mimmo Cuticchio) al dramma e al mito antico: Vincenzo Pirrotta.
Pirrotta aveva già lavorato sul mito di Oreste e continuerà a lavorarci, dato che
sta progettando ora un nuovo spettacolo dedicato alla figura di Clitennestra. Premiate dall’Associazione Nazionale dei critici teatrali, le sue Eumenidi giocano su piani
molteplici: reinterpretato in una forma meno filologica rispetto alla scuola di Cuticchio, il Cunto siciliano si contamina con tradizioni e canti maghrebini, con la ritualità
giapponese, con la tammurriata napoletana, per ottenere un’inedita scansione vocale,
un ritmo ancestrale che riprende le ricerche di Ernesto De Martino di Sud e magia.
L’oralità tende innanzitutto a destrutturare la chiusura e la verosimiglianza della forma tragica (o almeno dell’interpretazione tradizionale e classicista della tragedia), e a creare nuovi impasti comici e grotteschi. Nella scenografia ispirata a un
quadro di Francis Bacon (pittore tragico come pochi altri, attratto da questo mito e
dalla sua brutalità arcaica), domina un cubo di plexiglass, dentro il quale Pirrotta,
con la sua consueta, strabiliante vitalità corporea, impersona sia Oreste, sia Clitennestra, sia la sacerdotessa di Apollo, quindi entrambi gli antagonisti del conflitto,
mentre all’esterno tre figure maschili impersonano il coro delle Erinni.
La tecnica del Cunto dilata i confini del racconto: in un prologo epico-narrativo
Pirrotta recupera infatti punti chiave dell’antefatto di Atreo e Tieste, per configurare
il mito di Oreste come una lunga ripetizione insensata di delitti sanguinosi. La trasformazione più consistente riguarda però il finale: il momento chiave del primo
tribunale della storia che assolve Oreste non viene rappresentato direttamente, ma
viene narrato con una ripresa del Cunto iniziale, quindi ancora con un’immissione di
epica orale, aggiungendo uno sketch comico in cui i membri della giuria
dell’Areopago si mettono d’accordo per raggiungere il voto pari e non scontentare i
potenti. Inoltre le Erinni non sono persuase e placate, come nella scena cruciale di
Eschilo che tanto colpiva Pasolini per la sua carica metaforica di una sintesi fra arcaico e moderno, ma vengono solo violentemente represse: Pirrotta amplifica così quel-
22
Massimo Fusillo
la empatia con le figure arcaiche e femminili presente nella traduzione di Pasolini,
che è il suo materiale di partenza, sfociando in un finale cupo in cui le Erinni cantano
ripetutamente “oggi murìu a ggiusstizia”. Il contrasto fra il volere degli dèi olimpici
e le forze ctonie ha una potente trascrizione visiva e linguistica: la figura che più
incarna il nuovo ordine voluto dagli dèi, Atena, è impersonata da un contraltista che
gioca su un’androginia un po’ camp (l’ottimo Maurizio Rippa) e resta sempre
sull’alto del cubo di plexiglass, mentre Apollo si muove su degli alti trampoli.
Fig. 1 - Vincenzo Pirrotta, Eumenidi, 2004, per cortesia del regista
Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena
23
Fig. 2 - Vincenzo Pirrotta, Eumenidi, 2004, per cortesia del regista
Entrambi quindi si collocano a una fredda distanza dal mondo umano, sottolineata dal loro esprimersi in italiano, mentre tutte le altre figure, coinvolte sempre
in una fisicità dirompente, usano solo un siciliano aspro, ostico ed arcaico, traduzione dello stesso Pirrotta della traduzione di Pasolini, e forse proprio per questa
ardita duplicità paradossalmente vicino all’audacia stilistica di Eschilo.4
4 Cfr. Monica Centanni, Il cunto si addice ad Elettra; Stefania Rimini, Appunti per un’Orestiade siciliana;
rispettivamente Prefazione e Postfazione a: Vincenzo Pirrotta, Eumenidi. Riscrittura della tragedia di
Eschilo, Bonanno, Roma-Acireale, 2012.
24
Massimo Fusillo
Fig. 3 - Vincenzo Pirrotta, Eumenidi, 2004, per cortesia del regista
La celebrazione della democrazia e della giustizia è dunque radicalmente decostruita da Pirrotta attraverso lo straniamento, la contaminazione stilistica, la carnevalizzazione grottesca. Il finale già fortemente ambiguo di Eschilo diventa così un
rito atavico e popolare, in cui la violenza infinita della storia non trova un approdo
sensato.
Restiamo in Sicilia, per un’altra rivisitazione del mito in cui la componente orale, dialettale e popolare gioca un ruolo meno strutturale, ma sempre assai incisivo.
Per chi ripropone sulla scena una tragedia greca il coro costituisce il problema
principale: il rischio che risulti artificioso, letterario e poco credibile è sempre in
agguato. La scelta di Emma Dante per la sua Medea (Napoli, Teatro Stabile Mercadante, 2004)5 funziona invece alla perfezione: il coro di uomini solo leggermente
travestiti da donne, che recitano in siciliano con straordinaria corporeità e dinamismo, crea, sin dall’inizio, un doppio parodico della vicenda tragica, quasi decostruendo quell’opposizione fra maschile e femminile di cui tanto si è parlato a proposito di Euripide, sia a livello creativo, se si pensa alla famosa messinscena di
Luca Ronconi (1996) in cui il ruolo di protagonista era affidato a un attore, Franco
Branciaroli, o a Olà Medea di Gianluca Bottoni, sia a livello critico, se si ricorda
5 Per il testo, corredato di intervista, contributi critici e vari materiali fotografici, si veda Emma Dante, “Medea”, Primafila, 106, 2004, pp. 16-20. Riprendo e rielaboro qui osservazioni svolte in Massimo
Fusillo, “Nuove Medee sulla scena e sullo schermo”, Dioniso, n.s. 1, 2011, pp. 267-280.
Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena
25
l’interpretazione gender di Helen Foley6. La scelta permette anche, in tutto lo spettacolo, un contrappunto continuo fra comico e tragico: un procedimento cruciale di
tanta drammaturgia, già in nuce nell’alternanza antica di tragedia e dramma satiresco, esploso per il suo potere destabilizzante nella modernità prima con Shakespeare, poi soprattutto con la rivoluzione romantica che lo metterà al centro della
sua estetica, e infine con il grottesco novecentesco, da Beckett a Dürrenmatt.
Su quest’ossatura di base, che proviene direttamente dai precedenti spettacoli
di Emma Dante – capolavori corali come m’Palermu o Carnezzeria, in cui le dinamiche identitarie e le violenze familiari e sociali hanno trovato realizzazioni di potenza inedita7 – si inserisce con grande efficacia la recitazione di Iaia Forte, scaturita da
un intenso lavoro interiore sul personaggio e sulla gestualità rituale del Meridione
(rileggendo dunque tanto Apollonio Rodio quanto Ernesto De Martino). E lo stesso
vale per Tommaso Ragno, che ridisegna un Giasone volutamente tronfio e volgare,
alla fine però impietrito da un’angoscia paralizzante. La critica ha molto attaccato
la scarsa integrazione fra questi due mondi, il coro e i due protagonisti che, infatti,
anche nella tormentata genesi dello spettacolo (sono ben noti i training massacranti
ai quali Emma Dante sottopone i suoi attori), hanno avuto un rapporto assai conflittuale. A mio parere però l’innegabile dissonanza produce alla fine un imprevisto potenziale creativo, che ci dice molto sulle funzioni dell’oralità in scena. La
libera affabulazione dialettale e quotidiana dei coristi relativizza ma in fondo non
destruttura in questo caso la tragedia: direi anzi che entrambe le componenti, quella comica e quella tragica, si potenziano a vicenda.
La Medea di Emma Dante è una riscrittura autonoma di Euripide (ampiamente
ripreso, comunque) e del mito (per cui si può godere anche come testo autonomo),
in quanto intesse sulla traccia greca numerose novità drammaturgiche. Innanzitutto l’idea di rappresentare Medea incinta, quasi un totem per un popolo di travestiti: il che dà vita a due scene di parto (il primo solo minacciato) frenetiche e corali, a
un episodio comico autonomo e irresistibile (le coccarde con cui gli uomini del coro
segnalano la loro finta gravidanza), e alla presenza in scena, straniante e antinaturalistica, di cinque neonati (uno per corista). La forza di Medea è dunque nella sua
“fertilità devastante e rigogliosa”, come scrive la regista nelle note di regia, contrapposta alla sterilità della città di Corinto. Questa invenzione drammaturgica non
solo dà alla scelta dell’infanticidio una nuova drammaticità (Medea progetta l’atto
mentre ha ancora dentro di sé il figlio: molto toccante la scena in cui colpisce violentemente le proprie viscere), ma trasforma soprattutto la vendetta personale in
un atto di ribellione contro l’intera comunità sterile di Corinto. Tutto ciò porta co6 Helene Foley, Female Acts in Greek Tragedy, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2001, che
reinterpreta il famoso “divided self” di Medea come conflitto fra desiderio maschile di vendetta e di
onore e passione femminile materna.
7 Si veda a riguardo, fra gli altri, Anna Barsotti, La lingua teatrale di Emma Dante. mPalermu,
Carnezzeria, Vita mia, ETS, Pisa, 2009.
26
Massimo Fusillo
me conseguenza un’altra, notevole creazione mitopoietica, che riguarda il nucleo
centrale del mito di Medea: appunto l’infanticidio, atto abnorme per eccellenza,
eliminato - come è noto - nel romanzo di Christa Wolf e nel dramma del cubano
Montero, in un recupero di versioni pre-euripidee del mito che dissolve però buona parte della tensione tragica. Fra le innumerevoli varianti di questo motivo, quella immaginata da Emma Dante è una delle più riuscite e più potenti, pari secondo
me solo a quella che si vede nella Medea più bella del Novecento, il film televisivo
di Lars von Trier (1991) basato sulla sceneggiatura di Dreyer (1965), con la sua
tremenda impiccagione in una landa deserta, grazie alla complicità suicida del
primo dei due figli.
Nello spettacolo di Emma Dante l’infanticidio avviene per annegamento nel fonte
battesimale, trasformando quindi un rito di vita in un rito di morte. È il punto culminante di un riuso sistematico dell’iconografia cristiana meridionale: un modo per radicare il mito antico in una tradizione popolare, un po’ come faceva Pasolini quando
traduceva nell’Orestea di Eschilo “templi” con “chiese” e “Zeus” con “Dio”.
Questa invenzione drammaturgica produce un finale straordinario, poco compreso, mi sembra, dalla critica (come in fondo tutto lo spettacolo). Ricevendo da
Medea in bocca una molletta dei panni come se fosse un’ostia, il coro appende i
vestitini inzuppati dei bambini. Questi oggetti quotidiani, che sono un vero e proprio Leitmotiv dello spettacolo, animano le scene di parto e sono al centro di una
delle più ardite intersezioni fra comico e tragico, cioè il dialogo in cui Medea rinfaccia a Giasone il suo tradimento, a sua volta contrappuntato dai commenti sarcastici dei coristi sui vestitini portati in regalo dal protagonista. Un Leitmotiv in cui si
percepisce tutto il gioco queer di Emma Dante con le identità sessuali, continuamente sovvertite e parodiate, denunciandone la loro natura performativa. Commovente e allo stesso tempo irriverente, il finale conserva dunque tutto l’impasto
comico-tragico, cifra di questa Medea. Grazie alla musica intensa e dissonante dei
fratelli Mancuso e al valore simbolico dell’acqua, altro motivo ricorrente nello spettacolo (e nel film di von Trier), la scena ha infatti una marcata carica mitica e sacrale. Siamo ben lontani dalle attualizzazioni che la storia di Medea ha conosciuto così
di frequente, soprattutto in tempi recentissimi, grazie alla sua innegabile carica
politica; operazioni certo legittime, ma che spesso riducono il mito a un episodio di
cronaca nera; e siamo ben lontani da ogni forma facile di dissacrazione. Siamo invece di fronte a una prova di come il mito e la tragedia antica possano trovare una
nuova sorprendente vitalità, se affidati a attori e registi che vivono il teatro come
esperienza totalizzante.
Un finale forte dunque, diverso dalla decostruzione radicale del mito compiuta da Pirrotta, anche se ha in comune la scelta di un impasto comico-tragico dissonante e stilisticamente sovversivo. Nonostante questa chiusura a suo modo
organica, Emma Dante ha voluto riprendere il suo rapporto con questo mito,
forse anche sulla scia di un’accoglienza non molto positiva della sua prima Me-
Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena
27
dea, con uno spettacolo che già nel titolo Verso Medea (2013) condensa una ricerca
ancora in corso e in fondo inesauribile. Depurata purtroppo dalle innovazioni
più dirompenti e originali dello spettacolo precedente (l’episodio delle coccarde,
i parti dei coristi, l’infanticidio, il finale) e dalla bella scenografia un po’ kant oriana (o kounellisiana) di vecchi armadi, questa nuova Medea più compatta e
tradizionale (un po’ ‘normalizzata’) è una sorta di oratorio popolare che segue
più da vicino il testo di Euripide, senza abbandonare oralità e coralità, ma senza
più contrapposizione fra il mondo degli attori di Emma Dante e altre figure attoriali. Domina al contrario una significativa e affascinante interscambiabilità dei
ruoli, dato che gli attori che impersonano Giasone (Carmine Maringola), Creonte
(Salvatore D’Onofrio) e il messaggero (Sandro Maria Campagna) sono anche
coristi (rispettivamente nelle parti di una Matriarca, Giuseppina, e Caterina), in
un impasto di napoletano e siciliano potenziato dalla musica dei Mancuso, qui
veramente punto forte dello spettacolo.
Fig. 4 - Emma Dante, Verso Medea, 2013, per cortesia del regista Fig. 5, Emma Dante, Verso
Medea, 2013, per cortesia del regista
28
Massimo Fusillo
Fig. 6 - Emma Dante, Verso Medea, 2013, per cortesia del regista
Restiamo sempre nell’ambito della tragedia e di Euripide e delle riscritture contemporanee sulla scena meridionale, ma passiamo all’opera più ambigua ed estrema del teatro greco, alle Baccanti, e alla “figura più originale e di lungo respiro”
(Taviani)8 dell’attuale drammaturgia napoletana cosiddetta post-Eduardiana, attore autore cantante regista e traduttore che ama la contaminazione fra i livelli stili-
8 Ferdinando Taviani, Uomini di scena, uomini di libro. Introduzione alla letteratura teatrale italiana del
Novecento, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 199.
Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena
29
stici fino al parossismo: Enzo Moscato. Il suo teatro sfrutta al massimo grado il
potere dell’oralità (molto accentuato nel recente Napoli ’43, una serie di testimonianze sulla fine della guerra), basato come è sulla magia ipnotica della parola, su
cantilene popolari e rituali, su un monologare tendenzialmente infinito, in cui si
contaminano riflessioni autoriali ed evocazioni di personaggi, citazioni colte e
espressioni oscene, alto e basso, sublime e comico.
Moscato inizia il rapporto con la tragedia di Dioniso come traduttore e adattatore nel 1989, scrivendo Mentre il dio semina contagio, in cui brani tradotti in un italiano molto poetico, quasi aulico, comunque scorrevole, si alternano a brevi inserzioni
in dialetto, che si fanno però poi sempre più incisive. Vediamo un esempio, tratto
dalla scena chiave del travestimento di Penteo, momento culminante di una sovversione dionisiaca delle identità che non poteva non ricevere una resa potente da
parte di Enzo Moscato, che ha messo al centro della propria poetica travestititi e
transessuali napoletani, fino a farne una figura retorica della metamorfosi.9 Proprio
in questo punto della traduzione-rielaborazione di Moscato il contagio del dialetto
si fa più corposo e la metamorfosi progressiva del testo da aulico a ibrido trova il
suo compimento:
Mai, se ragionasse, indosserebbe una veste femminile,
mentre fuori di sé, e proteso a scongiurare il vostro assalto
a queste mura,
la indosserà, e come!
Femmene, ie voglio,
ie voglio, me sentite?
Voglio che sia ferito a morte,
innanzitutto nello scherno,
da tutti gli abitanti, quanne, mano dint’a mano, ie stesso,
pe viche e vicarielle, o purtarraggio, vestito da matrona,
cortigiana rossa e’ scuorne,
isso, ch’è accussì superbo! –
pe viche e vicarielle, sì!, pe porte e scalinate,
p’ogne angulo e pontone,
sfottuto com’a nu zimbello da tutta sta città!
E nessuna gogna, nessun patibolo sarà più tremendo
di quello preparato dalle mani e’ mamma soia,
ca l’aspetta, dint’o vuosco, p’o scannà,
comm’a nu capretto mo’ mo’ nate!
È così che si rispetta Dioniso,
è così che si onora il tuono di Zeus!10
9 Cfr. Concetta D’Angeli, “La lingua cancerosa del teatro. Sui ‘limiti’ di Enzo Moscato”, ateatro, 55.9,
2009, <http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and9>.
10 La traduzione-adattamento delle Baccanti di Moscato è ancora inedita e sarà pubblicata presto da
Bulzoni editore; per una sua analisi dettagliata cfr. Massimo Fusillo, “Il doppio contagio. Le Baccanti
secondo Enzo Moscato”, Teatro e storia, 33, 2012, pp. 45-56.
30
Massimo Fusillo
Moscato amplifica fortemente l’aggressività del dio vincitore, puntando tutto
sullo scherno collettivo verso il travestito, sulla sua degradazione, sull’esibizione
della preda, e introducendo la città come nuovo personaggio, grazie alle consuete
ripetizioni cantilenanti e allitteranti (“pe’ viche e vicarielle”) e quasi evocando Napoli con la citazione del titolo del famoso romanzo di La Capria Ferito a morte.
Contagiate dal dialetto sempre crescente e da didascalie-saggio che si proiettano verso la scena, rielaborate con invenzioni drammaturgiche come il doppio o lo
stillicidio finale, che ne scompaginano alcuni luoghi più convenzionali, le Baccanti
si sono già avvicinate un po’ a quel modello di teatro antinaturalistico, non lineare,
monologico ed ossessivo che caratterizza la scrittura di Moscato e che ha fra i suoi
modelli Artaud, Beckett, Genet e Pinter. Ma nello stesso tempo sono rimaste, fondamentalmente, le Baccanti. È un caso felice insomma di traduzione creativa, o di
trad-invenzione, come definisce le sue traduzioni lo stesso Moscato in un’intervista
a Concetta D’Angeli, in cui racconta di aver tradotto sempre “con il mio sangue”, e
dice cose molto belle sull’importanza del tradimento, in una dialettica fra continuità e rottura della tradizione.11
Quando le Baccanti secondo Moscato diventano spettacolo qualche anno dopo,
nel 2005, al Festival di Benevento, con il titolo Disturbing a Tragedy, la destrutturazione si fa ben più radicale, attingendo pienamente a tutte le tecniche dell’oralità.
Fermamente convinto che la tragedia oggi si possa riproporre solo in chiave grottesca, Moscato fa partire lo spettacolo dalla seconda parte, quella dominata da Agave
e inserisce poi continui ritorni all’indietro, rinunciando a ogni linearità narrativa.
Immersa in una coralità babelica, l’azione tragica è inoltre continuamente interrotta
da inserti di un reality show, da canzoni di vario genere (dai classici come Banana
Boat di Belafonte o Il cielo in una stanza cantato da Mina, al techno ipnotico di Moby, con My Weakness), e da lunghe riflessioni teoriche pronunciate dallo stesso Moscato sull’impossibilità della tragedia oggi, in un’epoca in cui gli dèi sono scomparsi, riflessioni che spesso si trasformano in inserzioni più o meno scherzose sulla
psicanalisi soprattutto lacaniana, un tema assai caro a Moscato.
Il gioco della continua interruzione e sospensione del tragico diventa estremo
nel finale, ripreso e decostruito più volte, quasi a condensare simbolicamente
l’impossibilità tutta novecentesca a concludere l’opera, e in particolare a concludere un’opera tragica. Dopo il finale con Tiresia previsto nell’adattamento Mentre il
dio semina contagio e dopo alcuni minuti di silenzio, la voce di Moscato urla “Ma
vvuie state ancora acca’? Lebensraum Lebensraum”, frase che riapre il finto reality
e che poi sfocia in un ballo collettivo travolgente. Si ritorna a Euripide con il discorso finale di Dioniso, ancora di nuovo destrutturato da interventi del coro, del
personaggio particolarmente grottesco impersonato dall’attore Gino Curcione, di
11 Concetta D’Angeli e Anna Barsotti, “’Ossimori’. Intervista a Enzo Moscato (Livorno, 7 Dicembre
2003)”, ateatro, 59.10, 2010, <http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and10>.
Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena
31
grande verve comica e affabulazione orale, e di altre figure che alludono
all’attualità (kamikaze, soldati), fino alla scritta finale: “Cambiare il mondo non
basta”. Potenziata da una ricca scenografia di Mimmo Paladino, che, come nelle
rivisitazioni della tragedia greca di Mario Martone,12 evoca la dimensione arcaica
nelle tracce e nelle rovine del contemporaneo, Disturbing a Tragedy è allo stesso
tempo una riflessione saggistica sulla commercializzazione del dionisiaco, una
rivisitazione grottesca delle Baccanti, una auto-decostruzione di un regista-attore
che esaspera (e un po’ tradisce…) le scelte espressive di se stesso autore-traduttore.
E ci dà una conferma tanto preziosa quanto radicale di come l’oralità in scena tenda sempre ad avere effetti destrutturanti e a creare impasti stilistici dissonanti, con
continue contaminazioni grottesche.
Lasciamo la tragedia greca e la scena meridionale, e passiamo a un continente
come l’Africa in cui l’oralità è da sempre rigogliosa, e a uno scrittore che ha messo
al centro della propria poetica il viaggio, il paesaggio, il territorio: Gianni Celati.
Passar la vita a Diol Kadd (2011) è un diario del suo soggiorno in Senegal, in cui ha
incontrato il poeta Mandiaye N’diaye, che ha tradotto in wolof, adattato e messo in
scena il Pluto di Aristofane. La tradizione orale africana e le ragioni della performance trasformano il testo drammatico antico, soprattutto attraverso
un’interazione continua con gli spettatori che spesso diventano a loro volta attori.
La scrittura diaristica di Celati, del tutto calata nei ritmi di una temporalità assai
diversa dalla nostra e attenta alle innumerevoli sfumature del quotidiano, sa rendere mirabilmente questo intreccio fra mito antico, oralità e performance, che dà
vita a un processo creativo tendenzialmente infinito.
Terminiamo con un ultimo, breve esempio che ci fa uscire dall’antichità e ci fa
passare anche ad un altro medium: il cinema. Si è soliti affermare che la modernità
ha prodotto pochi miti, anche se bisognerebbe andare più cauti nell’utilizzare una
categoria così sfuggente e così soggetta a metamorfosi, fra l’altro molto presente
nella contemporaneità. In ogni caso, nessuno potrebbe obiettare che Faust è forse il
mito più famoso e diffuso della modernità, uno dei miti dell’individualismo revitalizzati dal Romanticismo.13 Fra le tante versioni che si sono scostate dal testo canonico di Goethe per recuperare la tradizione orale fiorente di questo mito,14 quella
del Volksbuch e del teatro di marionette, spicca il Faust di Jan Švankmajer (1994),
regista ceco di ispirazione surrealista, che usa in maniera straordinariamente inventiva l’animazione, smontando ogni linearità narrativa in favore di una visionarietà onirica e straniata. In questo caso il viaggio di Faust appare realmente un
12
Cfr. Alessandra Orsini, Città e conflitto. Mario Martone regista della tragedia greca, Bulzoni, Roma,
2005.
13 Ian Watt, Miti dell’individualismo moderno. Faust, Don Giovanni, Don Chisciotte, Robinson Crusoe,
Donzelli, Roma, 2007.
14 Un quadro molto utile in Luca Zenobi, Faust. Il mito dalla tradizione orale al post pop, Carocci, Roma,
2013.
32
Massimo Fusillo
percorso interminabile, fatto di continui passaggi di soglie che spesso portano a
teatri di marionette (è la ricca tradizione ceca del Puppenspiel) e che deformano
sistematicamente volti, identità, ruoli, con una cifra stilistica che sa dosare splendidamente surrealismo, comicità, affabulazione popolare.
Con il passaggio ad altri media degli ultimi due brevi esempi (quasi due flash
per dare idea di sviluppi ulteriori) abbiamo avuto una riprova del nesso stretto fra
oralità, mito e scena, e della sue funzioni espressive e stilistiche, che vanno sempre
nella direzione dello smontaggio di ogni forma di chiusura testuale.
MARIA ARPAIA
IL POTERE PERFORMATIVO DELLA PAROLA NELLE SCENE DI AGNIZIONE.
FORME DI COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE
FRA EPICA E TRAGEDIA NELLA GRECIA ANTICA
Coordinate metodologiche
Il sistema della comunicazione poetica dell’antica Grecia fondava i suoi presupposti sul rapporto di simultaneità che si stabiliva tra la performance del poeta e
la ricezione del pubblico: affidata all’esecuzione orale dinanzi ad un uditorio, accompagnata di solito da uno strumento musicale, la poesia veniva fruita in un contesto codificato, in cui era l’occasione che determinava le modalità esecutive ed
espressive della composizione.
Posta in stretta relazione con la realtà sociale e politica, l’espressione poetica era
costantemente adattata al contesto cui essa era destinata. Il banchetto di nobili allietato dall’aedo, la piazza gremita in occasione delle esecuzioni rapsodiche negli
agoni poetici panellenici, il simposio, la celebrazione pubblica di una vittoria sportiva, le feste di Dioniso in cui si assisteva a rappresentazioni teatrali serie o comiche
dettavano le regole compositive rispettivamente dell’epica, della lirica monodica e
corale, della tragedia e della commedia.1 Il sistema dei generi poetici disponeva
tuttavia di un contenuto tematico comune e trasversale: la materia mitica, che costituiva il patrimonio tradizionale condiviso dall’intera società, era adattata di volta
in volta al tipo di occasione e di pubblico presente alle varie esecuzioni. In questo
sistema comunicativo, pertanto, l’analisi delle modalità di adattamento di un racconto che, nato e diffuso oralmente, si adegua al codice espressivo del teatro risulta
particolarmente significativa per gettare nuova luce sui rapporti semiotici e performativi che intercorrono tra il semplice racconto orale e la sua rielaborazione
scenica.
Se si prendono in considerazione le coordinate metodologiche con cui la critica
definisce lo statuto di un racconto orale (trasmissione, rielaborazione o replicazioni
orali; assenza del criterio di autorialità; riuso del testo orale in contesti differenti e
da parte di esecutori improvvisati; elasticità della forma letteraria, soggetta a interpolazioni e a varianti),2 non si può non pensare alla categoria del mito greco come
la più pertinente delle oggettivazioni possibili. Eppure essa è, al tempo stesso, la
meno indicata, in quanto è impensabile astrarre il racconto mitico dalla forma lette1 Cfr. Luigi E. Rossi, “I generi letterari e le loro leggi scritte e non scritte nelle letterature classiche”,
Bics, 18, 1971, pp. 69- 94.
2 Cfr. Walter Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna, 1986, in part. pp.
59-117 (“La psicodinamica dell’oralità”).
34
Maria Arpaia
raria nella quale ci è stato tramandato. Non ha senso parlare di mito senza fornire
alcun riferimento specifico all’occasione cui era destinato e ai codici comunicativi
richiesti dal contesto esecutivo. Partendo da tali presupposti, quindi, il termine di
confronto più produttivo per indagare le modalità di adattamento di un racconto
orale tradizionale alle dinamiche del teatro è individuato nello statuto poetico
dell’epica arcaica.3
Partendo dall’economia stessa del racconto mitologico, che si fonda sul principio della ripetizione con variazione, si può individuare una sorta di modularità
comune sia alla diegesi epica che a quella drammatica, rispettivamente identificabile nelle cosiddette “scene tipiche”, con cui il cantore epico era solito trasmettere il
patrimonio del sapere tradizionale,4 e negli “story patterns”, temi tradizionali ricorrenti nella tragedia e capaci di generare varianti, su cui si articolano le trame.5
Scene di agnizione nella diegesi epica
Ai fini della nostra indagine potrebbe risultare particolarmente utile analizzare
una sequenza narrativa molto feconda sia in epica che in tragedia, quella del riconoscimento, da Aristotele stesso considerata come uno dei due temi fondanti della
vicenda tragica.6
3 Non si entrerà qui nel merito della vexata quaestio riguardo ai rapporti tra il lungo processo di formazione del racconto epico, a noi giunto nella più recente rielaborazione rapsodica, e la sua redazione
scritta. La fase di rielaborazione, sistemazione e raccolta dei singoli canti epici, messa a punto dalle
scuole rapsodiche, non può aver fatto a meno di un rapporto dinamico ed interattivo con la scrittura.
Dall’analisi di alcune uniformità stilistiche dei più comuni nessi formulari o, al contrario, dal riscontro
di una non rara infrazione della ben nota legge di economia formulare, Livio Sbardella, nel suo testo
Cucitori di canti. Studi sulla tradizione epico-rapsodica greca e i suoi itinerari nel VI secolo a. C., Edizioni Quasar (SemRom, Quaderni 14), Roma, 2012, riconosce la traccia di una rielaborazione del materiale epico
che sia stata condotta tra diversi gruppi di rapsodi e con l’ausilio di un testo ormai scritto.
L’attribuzione di “oralità” al testo omerico che noi ora possediamo, pertanto, deve essere ristretta alla
sola modalità di esecuzione performativa, esclusivamente orale rispetto alla rappresentazione teatrale,
che affianca la diegesi alla mimesi diretta. Per quanto riguarda, invece, le affinità narrative tra i due
generi poetici, si rimanda al lavoro di Barbara Goward, Telling tragedy. Narrative Tecnique in Aeschylus,
Sophocles and Euripides, Duckworth, London, 1999, in part. pp. 15-20, in cui si identificano nel testo
tragico alcuni passaggi dal carattere squisitamente narrativo (telling), alternati ad episodi riprodotti in
presa diretta sulla scena (showing).
4 Cfr. Walter Arendt, Die Typische Szenen bei Homer, Weidmann, Berlin, 1933. Per una aggiornata
bibliografia in merito si rimanda a Andrea Ercolani, Omero. Introduzione allo studio dell’epica, Carocci,
Roma, 2006, pp. 160-163.
5 Cfr. Peter Burian, “Myth into Mythos: the Shaping of Tragic Plot” in The Cambridge Companion to
Greek Tragedy, edited by P.E. Easterling, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pp. 178-208, in
part. p. 186.
6 L’agnizione, infatti, insieme alla peripezia, trasmette alla trama un capovolgimento improvviso
dall’ignoranza alla conoscenza (Poet. 1452 a 30). Aristotele si preoccupa anche di fornire una valutazione
qualitativa circa le differenti modalità di agnizione: rispetto all’artificio meccanico, dato dal riconoscimento di un segno tangibile del personaggio, egli considera di più alto valore artistico quel tipo di
agnizione che si fonda su processi psichici o su associazioni di idee (ivi, 1454 b 20).
Il potere performativo della parola nelle scene di agnizione …
35
In tale sequenza, infatti, le caratteristiche dell’adattamento acquistano una chiarezza macroscopica: l’agnizione non solo costituisce un elemento ineludibile per
ogni racconto fantastico, tanto da essere annoverata tra le più attestate funzioni di
Propp,7 ma ricorre con frequenza sia nel racconto epico – in particolare nell’Odissea,
che ha improntato sullo schema “riconoscimento/falso racconto” il suo intero plot
narrativo8 – sia in numerose tragedie, in cui la sequenza è impiegata come strumento privilegiato per ottenere un capovolgimento della sorte e generare un picco
emotivo nello spettatore.9
Sulla base della distinzione aristotelica (Poet. 1454 b 20 – 1455 a 15) che distingue almeno quattro modalità possibili di agnizione, comuni sia all’epica che alla
tragedia (riconoscimento attraverso un segno particolare; agnizione per rivelazione
in prima persona; riconoscimento per rivelazione da parte di un personaggio diverso dal protagonista; agnizione attraverso la conoscenza di un segreto particolare), si prenderà qui in considerazione il caso specifico del riconoscimento avvenuto
tramite un segno particolare.10
La prova fornita per convalidare l’identità rappresenta il mezzo narrativo con
cui si attribuisce un ruolo, un nome e si reintegra il personaggio nel suo status originario. La sua evidenza deve essere, quindi, condivisa da tutti e dotata di ineccepibile veridicità.11 Tuttavia il suo impiego giunge quasi sempre come atto finale di
una lunga fase preparatoria, in cui di solito il protagonista saggia la fedeltà
dell’interlocutore con falsi racconti e rassicurazioni riguardo l’imminente ritorno
dell’eroe. Solo in un caso si assiste ad un riconoscimento diretto e immediato, in
Cfr. Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, Einaudi, Torino, 2000, p. 55.
La sequenza narrativa del riconoscimento è stata considerata una “scena tipica” da Peter Gainsford che, nel suo articolo “Formal Analysis of Recognition Scenes in the Odyssey”, The Journal of Hellenistic Studies, 123, 2003, pp. 41-59, ha rinvenuto una serie di temi e motivi ripetuti con regolarità e chiaramente riconoscibili, tali da farla annoverare nel computo dei temi tradizionali del racconto epico.
9 Sugli effetti empatici della scena di riconoscimento Aristotele puntualizza: “Il riconoscimento e la
peripezia produrranno pietà e terrore (di azioni di questo tipo si è assunto che sia imitazione la
tragedia), giacché da riconoscimenti e peripezie dipendono il conseguire della sfortuna e della fortuna
(Poet. 1452 a 23 – 1452 b 5). Richardson commenta: “the pleasure which the reader or audience derives
from a work of literature (such as epic or drama) is for Aristotle actually one of recognition”. Cfr. Nicolas J. Richardson, “Recognition Scenes in the Odyssey and Ancient Literary Criticism”, Papers of the
Liverpool Latin Seminar, 4, 1983, pp. 219-235, in part. 221.
10 Nella sua classificazione tipologica, Aristotele considera di scarso valore artistico proprio
l’agnizione che avviene tramite segni di riconoscimento, siano essi congeniti o acquisiti (Poet. 1455 a 15).
Tuttavia, non omette di considerare che l’espediente della prova possa essere impiegato in modo
efficace solo se affiancato dall’introduzione dell’effetto sorpresa, come – appunto – nella scena omerica
del lavacro dei piedi da parte di Euriclea (ibid., 25).
11 Nell’Odissea l’espediente della cicatrice viene utilizzato in almeno quattro delle sei agnizioni.
Odisseo la mostra inconsapevolmente ad Euriclea (19, 388-391), ma consapevolmente ad Eumeo e
Melanzio (21, 217-224) e infine a Laerte (24, 330-335). Negli altri due casi l’identità del protagonista è
rivelata in prima persona, come fa Odisseo al figlio Telemaco (16, 186-219), oppure è provata mediante
la condivisione di un particolare privato, come nel caso della prova del letto a cui Penelope sottopone
l’uomo che si proclama suo sposo (23, 174-230).
7
8
36
Maria Arpaia
cui, al contrario degli altri, l’indizio occupa maggiore spazio narrativo: quella del
lavacro dei piedi e dell’agnizione da parte di Euriclea.
La scena, posta nella cornice dell’incontro tra Penelope e Odisseo, sembra aprirsi secondo il consueto schema del riconoscimento anche se, a differenza di quanto
ci si possa aspettare, viste le contingenze improvvise e impreviste con cui la nutrice
scopre l’identità del mendicante, il momento dell’agnizione non risulta immediato,
ma è ritardato dall’introduzione di una lunga digressione:
Lavava il suo padrone accostandosi e riconobbe all’istante
la ferita che un tempo gli inferse il cinghiale col bianco dente,
quando andò sul Parnaso, da Autolico e figli,
dal nobile nonno materno, che spiccava tra gli uomini
per latrocinio e spergiuro […]12
(Od. 19, 392-396)
Basta un semplice pronome relativo e un avverbio temporale per aprire una finestra narrativa di circa settanta versi (393-466), che si snoda su piani cronologici
complessi. Questa si conclude, poi, con andamento circolare, mediante la ripetizione del medesimo pronome, che ha il compito di riprendere le fila del discorso e
introdurre la scena del riconoscimento vero e proprio (467-468: “Questa la vecchia,
toccandola con le mani aperte, / riconobbe palpandola”).13 Dal punto di vista narrativo, nella digressione appena iniziata si innestano a loro volta una serie di dimensioni temporali, sia anteriori che posteriori rispetto all’episodio principale della
ferita. Il racconto della visita ad Itaca del nonno Autolico, che impone il nome al
nipote appena nato (395-412), e quello dell’adolescenza dell’eroe (413-427) precedono cronologicamente la scena del ferimento, mentre le cure prestate ad Odisseo
(455-462) e il suo ritorno a casa, tra le braccia apprensive dei genitori (462-466),
riguardano le conseguenze della battuta di caccia. Il piano della digressione, così, si
arricchisce di eventi passati e futuri, che contribuiscono ad articolare ulteriormente
il quadro della narrazione.
L’ascoltatore è trascinato in una sorta di complesso incastro temporale che lo
trasporta lontano, nello spazio e nel tempo, dalla scena del riconoscimento che
l’aedo narra in presa diretta, coinvolto in un racconto che sembra sgorgare
dall’episodio principale. Al termine della digressione, poi, egli è ricondotto quasi
naturalmente a focalizzare di nuovo l’attenzione su Euriclea. Dal punto di vista
12 Le traduzioni dell’Odissea sono di G. Aurelio Privitera in Omero, Odissea: libri XVII-XX,
introduzione, testo e commento a cura di Joseph Russo, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, Milano,
2001.
13 Sulla struttura circolare della digressione si veda Julia H. Gaisser, "A Structural Analysis of the
Digressions in the Iliad and the Odyssey", HSCP, 73, 1968, pp. 1-43, in part. pp. 20-21, in cui riscontra una
struttura di Ringkomposition anche all’interno del racconto digressivo stesso: la scena inizia e si chiude
ad Itaca, così come la battuta di caccia si apre e chiude con riferimenti temporali precisi.
Il potere performativo della parola nelle scene di agnizione …
37
performativo, la sospensione della vicenda principale in un momento di così forte
concentrazione emozionale, come la scoperta dell’identità di Odisseo da parte della
nutrice, doveva provocare un effetto di grande attesa nell’uditorio: accompagnato
dalla proposizione relativa iniziale, il pubblico seguiva con curiosità l’intera vicenda sull’origine della cicatrice, senza mai dimenticare però il racconto principale
momentaneamente sospeso. Il gusto del racconto per accumulo, del resto, era una
modalità narrativa tipica della diegesi omerica: nulla di cui si faceva menzione
poteva risultare anonimo o poco definito. Il piacere di narrare ed ascoltare storie,
oltre a incrementare la conoscenza mitologica del pubblico, costituiva uno degli
scopi ricreativi precipui della performance epica.
Ritardare la narrazione del riconoscimento vero e proprio, quindi, non determina la perdita della tensione narrativa, ma ne amplifica le potenzialità, tenendo costantemente desta l’attenzione degli ascoltatori.14
Lo stile del racconto stesso è caratterizzato da una straordinaria precisione descrittiva: il nascondiglio del cinghiale tra le frasche; l’accerchiamento dei cacciatori
per stanarlo; il duello con Odisseo, con la conseguente ferita inferta sopra il ginocchio e l’uccisione dell’animale sono dettagli funzionali alla creazione di un effetto
particolarmente realistico della narrazione, un ”effet de réel”, come direbbe Barthes, capace di suscitare quell’evidenza narrativa che rientra nella categoria
dell’enargheia.15 Le suggestioni visive e uditive (il vento che sferza le gole ventose
del Parnaso, il sole che batte le pianure di caccia, il cinghiale dalle setole irte e gli
occhi di fuoco) sono in grado di attivare le capacità immaginative del pubblico che
trasforma in immagini mentali le parole ascoltate.16
14 Sulla natura e sugli effetti delle digressioni molteplici sono le interpretazioni. Si ricorderanno, in
questa sede, quella di Eric Auerbach (Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi, Torino,
1956) che attribuiva alla digressione la precipua funzione di rilassare le tensioni e far dimenticare
all’ascoltatore ciò che accade nel racconto principale. Al contrario Norman Austin ("The Function of
Digressions in the Iliad", GRBS, 7.4, 1966, pp. 295-312) pone l’accento sul suo potenziale emotivo, mentre
Adolf Köhnken ("Die Narbe des Odysseus: ein Beitrag zur homerischen Erzähltechnik", AuA, 22.2, 1976,
pp. 101-114) sottolinea l’intima connessione della digressione con la storia principale. Suggestiva
l’interpretazione di Irene de Jong (“Eurykleia and Odysseus’ scar: Odyssey 19, 393-466”, CQ, n.s. 35.2,
pp. 517-518) secondo cui il flashback della battuta di caccia prende posto nella mente di Euriclea come
ricordo, nel momento in cui visualizza la cicatrice. In tal modo il racconto darebbe vita ad una
focalizzazione narrativa di secondo grado.
15 Già Aristotele aveva delineato la capacità del poeta di trasformare il discorso inanimato in
movimento. Nella Retorica, il filosofo si riferisce ad una serie di esempi tratti da Omero, che “rende
animate le cose inanimate” grazie al procedimento di “far risultare davanti agli occhi” un’immagine
raccontata (Rhet. 1411 b 23-33). Pseudo-Longino, nel suo trattato Sul Sublime, approfondisce la
suggestione aristotelica introducendo il concetto di enargheia, l’evidenza rappresentativa che non mira
solo a persuadere chi ascolta, ma addirittura a plagiarlo (Subl. 15, 1-2).
16 Gli effetti prodotti sull’uditorio dal racconto orale sono ben descritti nell’Odissea (11, 367 ss.) in cui
le parole di Odisseo, che racconta ai Feaci le sue avventure, “assumono forma” nella mente degli
ascoltatori. Per un’analisi approfondita del rapporto tra parola e immagine nel panorama letterario
greco si veda Roberto Velardi, “Parola e immagine nella Grecia antica (e una pagina di Calvino)”, AION
(filol.), 26, 2004, pp. 191-219.
38
Maria Arpaia
Scene di agnizione nella diegesi tragica
La capacità eidetica, che è caratteristica della narrazione epica, riguarda anche
la diegesi scenica, pur se declinata secondo criteri rappresentativi sostanzialmente
diversi. Il carattere dialogico della rappresentazione drammatica, infatti, ne caratterizza la struttura, costituita da un susseguirsi di dialoghi e narrazioni, alternati
agli intermezzi corali di musica e danza.17 Il racconto, quindi, di nuovo si fa protagonista della performance: gli eventi che fanno procedere lo sviluppo della trama,
che pure erano noti agli spettatori per la loro appartenenza al bagaglio culturale
mitico, non costituiscono infatti oggetto di mimesi diretta, ma sono raccontati sulla
scena dagli attori in modo indiretto, mediante una esposizione diegetica di una o
più voci. In tal modo, rispetto alla performance epica, non solo il punto di vista
della vicenda viene rifratto, articolato e moltiplicato per ogni personaggio narrante,
ma anche le facoltà immaginative dello spettatore risultano attivate in modo diverso. Le reazioni emotive dei personaggi sulla scena, infatti, indirizzano e in qualche
modo incanalano l’attività eidetica del pubblico, il cui coinvolgimento emotivo è
intensificato dalla visione dei personaggi sulla scena.
Le differenti esigenze comunicative della rappresentazione drammatica hanno
determinato un cambiamento sia nella sintassi narrativa che nel linguaggio del
racconto tradizionale: la sequenza dell’agnizione nelle trame tragiche può con efficacia illustrare questi adattamenti.
Nel celebre riconoscimento di Oreste da parte di Elettra nelle Coefore, primo
esempio a noi giunto di agnizione in scena, le esigenze performative portano il
tragediografo ad aumentare il numero delle prove che fungono da riscontro al
riconoscimento: la ciocca di capelli trovata accanto alla tomba, le orme di piedi
nelle vicinanze ed infine la stoffa tessuta da Elettra stessa.
La moltiplicazione degli indizi può essere considerata un espediente tipico del
linguaggio drammatico, che è solito articolare la sua narrazione sul dubbio e
sull’indagine di una verità spesso difficile da possedere. Lo spirito critico della
comunicazione tragica, in cui si mette in scena una realtà mai univoca ma oggetto
17 Sul carattere prevalentemente narrato della rappresentazione tragica e sugli aspetti evocativi della
recitazione sullo spettatore si dispone di una ben nutrita bibliografia. Rimando qui, tra gli altri, a Gone
Capone, L’arte scenica degli attori tragici, Università di Padova, Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e
Filosofia, Padova, 1935; Benedetto Marzullo, “La Parola scenica”, QUCC, n.s. 22, 1986, pp. 95-104 e “La
Parola scenica, II”, QUCC, n.s. 30, 1988, pp. 79-85; Luigi E. Rossi, “Livelli di lingua, gestualità, rapporti
di spazio e situazione drammatica sulla scena attica”, in Scena e spettacolo nell'antichità. Atti del Convegno
Internazionale di Studio, Trento, 28-30 marzo 1988, a cura di Lia De Finis, Firenze, 1989, pp. 63-78; Marco
Fantuzzi, “Sulla scenografia dell’ora (e del luogo) nella tragedia greca”, MD, 24, 1990, pp. 9-30; Angela
Andrisano, “Teatro di corpo e Teatro di parola in Grecia e Magna Grecia”, Dioniso, 61, 1991, pp. 231-243;
Andrea Ercolani, Il passaggio di parola sulla scena tragica. Didascalie interne e struttura delle rheseis, Verlag
J. B. Metzler, Stuttgart-Weimer, 2000, in part, pp. 1-13; Giovanni Cerri, “La tragedia greca: mimesi verbale
di un’azione verbale. Saggio di poetica”, Vichiana, Serie IV, 7.1, 2005, pp. 17-36.
Il potere performativo della parola nelle scene di agnizione …
39
costante di interpretazione, si esplica proprio nella drammatizzazione del dubbio.
La scoperta per accumulo dei primi due segni di riconoscimento, che Elettra rinviene uno per volta, consente di ingaggiare un dialogo serrato con il coro in cui si
prova a ricostruire l’identità del misterioso donatore. Le ipotesi sulla ciocca di capelli muovono dalle domande della corifea, che circoscrivono passo dopo passo
l’andamento stringente del ragionamento:
Elettra: Ecco, vedo una ciocca qui recisa sulla tomba.
Corifea: Di chi mai, di uomo o di fanciulla ben cinta? […]
Elettra: Non esiste chi l’avrebbe potuta tagliare, all’infuori di me. […]
Ma questa ha proprio l’identico aspetto ...
Corifea: Di quali chiome? È questo che voglio sapere.
Elettra: Ai capelli della mia gente è proprio simile d’aspetto.18
(Aesch. Coeph. 168-169; 172-176)
Aristotele, nella Poetica, identificava in questa scena l'esempio più chiaro di riconoscimento sostenuto dal ragionamento:19 il percorso deduttivo si articola, acquistando quasi visibilità agli occhi dello spettatore, nella sticomitia di domande e
risposte tra le due donne. La voce interna monologica si scinde nelle due voci che
avanzano ipotesi e tentano risposte plausibili. La Corifea, infatti, chiede a chi possa
mai appartenere la ciocca di capelli (169) e come sarebbe potuta giungere fino alla
tomba (179). Il processo logico, quindi, non solo è verbalizzato, ma anche impersonato, affinché i meccanismi della deduzione abbiano voce e volto e il pubblico possa seguirne lo sviluppo dialettico anche visivamente. La voce monologica interna
di chi si pone domande e cerca le risposte si scinde, impersonandosi nelle due voci
che si rispondono – e spesso si corrispondono – nell’avanzare ipotesi e nel tentare
risposte plausibili ai dubbi sollevati dal coro.20
Questa declinazione dello schema anagnoretico al linguaggio teatrale non risulta impermeabile ai condizionamenti del contesto culturale coevo. Lo spettacolo
tragico, infatti, promosso dalla polis per la polis stessa, esplicava il suo ruolo educa-
18 Le traduzioni delle Coefore sono di Luigi Battezzato in Eschilo, Orestea, introduzione di Vincenzo
Di Benedetto, traduzione e note di Enrico Medda, Luigi Battezzato, Maria Pia Pattoni, Rizzoli, Milano,
1997.
19 Cfr. Arist. Poet. 1455 a 5: “Una quarta specie di ragionamento è derivante dal ragionamento, come
ad esempio le Coefore, dove Elettra argomenta che è giunto uno simile a lei, ma a lei simile non c’è
nessuno se non Oreste, e dunque questi è giunto”.
20 Lo scarso rigore critico del ragionamento di Elettra ed alcune sue considerazioni troppo semplicistiche hanno provocato non poche rimostranze già nel contesto culturale coevo. Euripide, nella celebre
scena di riconoscimento della sua Elettra, muove una vera e propria critica razionalista contro i procedimenti logico-deduttivi messi in scena dal collega. Questi criticava le conclusioni troppo ingenue e
semplicistiche addotte sia in relazione alla ciocca di capelli recisa dal fratello e considerata compatibile
con quella della sorella (Eur. Elect. 524-531), sia riguardo all’indizio delle orme lasciate sul terreno (ibid.
534-537). L’obiezione più feroce era mossa sull’impossibilità di Oreste di indossare – ormai adulto –
vesti tessute quando era un bambino (ibid. 541-546).
40
Maria Arpaia
tivo riproducendo ogni aspetto della vita pubblica, pur traslato nel linguaggio
metaforico del mito: ritualità, usi e costumi, problemi etnici e sociali, inclusi gli echi
– più o meno lontani – degli eventi storici contemporanei, prendono posto sulla
scena. In particolar modo, nella conduzione dei dialoghi o dei lunghi monologhi
tragici, il dramma rifletteva lo sviluppo della retorica nella nascente democrazia
ateniese, a sua volta incrementata dalla crescente importanza del dibattito pubblico
nelle assemblee e nelle corti di giustizia. Il metodo ricostruttivo utilizzato da Eschilo nella scena preparatoria all’agnizione ripercorre – seppure in modo molto elementare – le tappe di una disamina giudiziaria intorno ad una prova: analisi
dell’oggetto; attribuzione di appartenenza per deduzione (168-176: la chioma ritrovata è simile a quella di Elettra; poiché non è di Elettra ed esiste solo un’altra chioma simile, cioè quella del fratello, allora il ricciolo è di Oreste); procedimento per
esclusione (187-194: a nessun altro degli Argivi possono appartenere i capelli e
l’unica che potrebbe avere una chioma simile, Clitemnestra, non può aver dedicato
il ricciolo); ed infine il procedimento per paradosso, tipico della scuola gorgiana
(195-204: se il ricciolo avesse voce, potrebbe risolvere il dubbio di Elettra).
Il ragionamento rimane tuttavia privo di una conclusione univoca, sia per
l’insufficienza delle prove che per l’ammissione da parte della donna (193-194: “Ad
affermarlo apertamente, che questo ornamento appartenga al più caro dei mortali,
ad Oreste, mi seduce la speranza”). La stessa compromissione emotiva dell’aspetto
razionale viene sottolineata dopo la scoperta del secondo indizio (211: “Mi minaccia lo spasmo del tormento e la perdita di senno”).
L’intero percorso che porta all’agnizione è quindi terminato nel dubbio ed è il
dubbio stesso che, nel dialogo con il coro, è tradotto in atto locutorio. Al tempo stesso
razionale e visivo, deduttivo ed emotivo, questo scambio di battute costituisce il
modo con cui rappresentare l’inquietudine e il desiderio di ricerca, spesso frustrato,
che segnano la sostanziale diversità del dramma rispetto al racconto epico.
Nei poemi omerici, infatti, i personaggi dubitano raramente e, qualora questo
accada, il dubbio viene spesso attribuito all’intervento di una divinità.21 Il meccanismo stesso dell’agnizione nell’Odissea ha bisogno della validazione di un elemento
divino per compiersi. Il ruolo di Atena nel velare e svelare l’eroe, a seconda delle
esigenze, risulta imprescindibile nel processo di riconoscimento di Odisseo da
parte dei diversi interlocutori, i quali non compiono alcun processo logicodeduttivo.22
21 Ogni specie di accadimento spirituale o fisico che non trova immediato collegamento nei nessi
causa-effetto veniva attribuito all’intervento di un daimon. Esprime con efficacia questo concetto Eric R.
Dodds, I Greci e l’irrazionale, La Nuova Italia, Firenze, 1978.
22 La dea trasforma al tocco di una verga Odisseo in un vecchio mendicante prima del suo incontro
con Eumeo (13, 429-438) e gli ridà poi giovinezza e dignità regale in funzione dell’agnizione di
Telemaco (16, 172-176). Di nuovo è celato da Atena sotto le spoglie del mendicante per evitare che
Il potere performativo della parola nelle scene di agnizione …
41
La rappresentazione scenica del dubbio costituisce così uno dei segni più evidenti di adattamento della scena di agnizione al linguaggio del teatro.
Anche dal punto di vista strettamente ricettivo sono marcate le differenze tra i
due generi. Rispetto all’epica, in cui intercorreva una lunga digressione tra la scoperta della cicatrice e la reazione emotiva della vecchia nutrice, il pubblico in teatro
assiste da subito alle implicazioni affettive che i ritrovamenti degli oggetti suscitano nei personaggi. In primo luogo, è proprio l’effetto di sorpresa ad essere preservato integro nel suo potenziale comunicativo: subito dopo il kommos del coro, in cui
si piange la morte di Agamennone tra esclamazioni di dolore e elementi tipici del
canto funebre, il ritrovamento del ricciolo reciso interrompe a metà un discorso
incipiente della donna: “Ecco, già bevuti dalla terra, mio padre riceve i libami. Oh,
compagne, udite anche voi questa strana cosa!” (166). L’impatto emotivo è subito
verbalizzato dalla corifea (167: “Parla: Il cuore mi balza in gola per lo spavento”)
che, tuttavia, non conosce ancora cosa sia stato effettivamente trovato. Un verso
contribuisce a chiarire a tutti ciò che Elettra ha visto: “Vedo qui, sulla tomba, una
ciocca recisa di capelli” (168). Il verbo iniziale “ὁρῶ” e il deittico “τόνδε” sono spie
linguistiche di una didascalia scenica, che suggerisce un’azione paraverbale da
parte del personaggio. In un testo privo di accessorie indicazioni sceniche, in cui si
verbalizza tutto ciò che accade con una precisione che è ridondante a noi lettori
moderni,23 si può presumere che l’attore indichi o addirittura prenda in mano il
ricciolo posto sulla tomba e che lo mostri persino al coro (e al pubblico stesso) in
connessione con il dimostrativo che attira l’attenzione sull’oggetto stesso. La verbalizzazione del ritrovamento (e la presunta azione gestuale di grande effetto scenico) contribuisce ad amplificare l’enfasi emotiva del dialogo seguente tra Elettra e il
Coro, già caratterizzato dall’intensità drammatica della sticomitia. La successione
delle domande intorno all’oggetto risulta così incalzante da interrompere il filo del
ragionamento di Elettra, con il risultato che la donna sembra riprendere, nella battuta successiva, il pensiero rimasto inespresso in quella precedente, scavalcando
quasi l’intervento della corifea (174-176: “Elettra: Ma questa (scil. chioma) ha proprio l’identico aspetto... / Corifea: Di quali chiome? È questo che voglio sapere. /
Elettra: Ai capelli della mia gente è proprio simile d’aspetto”). L’elemento empati-
Eumeo e Penelope lo riconoscessero (16, 454-459) ma riacquista il suo splendore dopo il bagno
purificatore che segue la strage dei pretendenti (23, 156-163).
23 Riguardo alla ricostruzione performativa del teatro greco antico e sulla catalogazione di azioni
verbali e paraverbali si vedano, tra gli altri, Luigi E. Rossi, Livelli di lingua, gestualità, cit.; Vincenzo Di
Benedetto - Enrico Medda, La tragedia sulla scena, La tragedia greca in quanto spettacolo teatrale, Einaudi,
Torino, 1997; Massimo Di Marco, La tragedia greca. Forma, gioco scenico, tecniche drammatiche, Carocci,
Roma, 2000; Andrea Ercolani, “Le didascalie sceniche del teatro tragico”, in Angela Zampetti e Andrea
Marchitelli (a cura di), La tragedia greca. Metodologie a confronto, Armando, Roma, 2000, pp. 15-30;
Giovanni Cerri, La tragedia greca: mimesi verbale, cit., pp. 17-36.
42
Maria Arpaia
co domina il riconoscimento fino alla fine, quando entra in scena Oreste.24 Dopo la
breve interruzione monologica, in cui Elettra si lascia andare ad un momento di
sconforto, il dialogo, intrapreso questa volta con il fratello, ritorna in sticomitia. Il
pathos è mantenuto alto da una fitta rete di corrispondenze pronominali, che legano
i due personaggi in un gioco di identità che funge da premessa al reciproco riconoscimento:
Oreste: Sono io: non cercare nessuno che ti sia legato più di me (ἐμοῦ).
Elettra: Straniero, trami forse un inganno intorno a me (μοι)?
Oreste: Allora ordirei astuzie contro me stesso (αὐτοῦ).
Elettra: Vuoi ridere di fronte ai miei (ἐμοῖς) mali?
Oreste: Miei (ἐμοῖς) anche, se tuoi (τοῖσι).25
(Aesch. Coeph. 219-223)
L’“io” e il “tu” si fronteggiano nelle battute dei due personaggi e si fanno strumento del riconoscimento stesso. Nel momento in cui Oreste fornisce le prove definitive per convalidare la sua identità, poi, è ancora un uso pronominale che rivela
al pubblico l’avvenuto ricongiungimento dei due fratelli: le personalità, precedentemente così circoscritte alla prima e alla seconda persona, si fondono in un duale
che le accomuna nel destino funesto (233-234: “Resta in te, non colpire di gioia il
tuo cuore: infatti lo so, i più cari parenti sono amari per noi due [νῷν]”).
Conclusioni
L’analisi fin qui condotta ha consentito di verificare in che modo l’associazione
integrale tra il livello verbale di un testo e il suo contesto di destinazione influiscano sulle modalità narrative di una sequenza tradizionale, che si articola sia nel
genere epico che in quello tragico. Si assiste, infatti, all’adattamento di una storia
tradizionale da un’oralità ‘interamente narrata’, come quella dell’epica orale, ed
un’oralità ‘narrata e agita’, come quella che si realizza sulla scena.26
24 Anche qui l’effetto sorpresa è ripetuto: il personaggio comincia a parlare senza alcuna battuta
introduttiva pronunciata dagli altri attori, come si soleva fare per presentare l’identità del personaggio e
descriverne gli attributi scenici. Ma in questo contesto sarebbe stata superflua per il pubblico, che ben
conosceva l’identità di Oreste e il suo nascondiglio fin dal prologo, non funzionale certo all’andamento
narrativo del racconto (cfr. 20-21: “Pilade, stiamo in disparte, perché io sappia con certezza che cosa sia
questa supplica di donne”).
25 Si noti l’effetto sonoro dei vv. 222-223 in greco: Ηλ. ἀλλ’ἐν κακοῖσι τοῖς ἐμοῖς γελᾶν θέλεις; /
Ορ. κἀν τοῖς ἐμοῖς ἄρ’, εἴπερ ἔν γε τοῖσι σοῖς. La ripresa al mezzo tra i due versi dell’aggettivo in
dativo plurale “ἐμοῖς” e dell’omoloteleuto “κακοῖσι”-“ τοῖσι”, oltre alla ripetizione nello stesso verso
dell’omoteleuto “ἐμοῖς”-” σοῖς” contribuiscono a legare fortemente i due personaggi in una biunivoca
rispondenza ancora prima di giungere al conclamato riconoscimento, costituendo una sorta di
anticipazione emotiva della scena del ricongiungimento ormai prossima a verificarsi.
26 Tale distinzione è ben argomentata da Livio Sbardella (Oralità. Da Omero ai mass media, Carocci,
Roma, 2006, pp. 27-31) che, sulla scia degli studi di Goody e Watt sulle interferenze tra oralità e scrittura
Il potere performativo della parola nelle scene di agnizione …
43
Questa differenti strategie comunicative richiedono modalità espressive differenti. Le pennellate descrittive del narratore epico, infatti, lasciano più spazio creativo all’uditorio, che procede ad un’autonoma immaginazione degli eventi ascoltati
e si fa emotivamente trasportare dalla corrente della narrazione ciclica. La sintassi
narrativa, quindi, si comporta come materia fluida e aperta alle inclusioni: il suo
intento è quello di trasmettere un bagaglio di conoscenze e di informazioni di natura religiosa, etica e anche pratica, altrimenti di difficile fruizione, occupandosi di
divulgare e consolidare il sistema di valori della tradizione eroica.
Nella narrazione scenica, invece, la diegesi viene rifunzionalizzata, per seguire
le norme compositive del genere. Il racconto si plasma, si mimetizza e diventa un
dialogo; si assiste ad una moltiplicazione delle prove a sostegno dell’identità del
personaggio e si procede ad una verbalizzazione del processo logico che conduce
al riconoscimento. Il dubbio stesso è drammatizzato e tradotto in atto locutorio e la
voce monologica dell’epica si scinde in serrati dialoghi sticomitici.
I cittadini presenti a teatro, quindi, potevano da un lato esercitare le competenze logiche e retoriche richieste dalle nuove istanze politiche della nascente democrazia ateniese, dall’altro attivare una riflessione autonoma sul senso dell’uomo e
dei suoi rapporti col dio, sulle relazioni tra l’agire umano e il destino ineluttabile,
mediante il coinvolgimento emotivo dovuto alla mimesi diretta della scena tragica.
Tale immedesimazione empatica annullava la distanza tra il soggetto e il personaggio, che invece era presente nell’epica nello spazio immaginativo riservato
all’uditore. Il pubblico, colpito passivamente dalla visione dei personaggi sulla
scena, era educato a guardare alla realtà in modo mai univoco, ma come oggetto di
costante interpretazione. Il linguaggio del teatro, in tal modo, risponde a nuove ed
incalzanti esigenze culturali che la modalità narrativa epica, per sua natura monologica e narrativa, non è in grado di soddisfare.
(Jack Goody – Ian Watt, “The Consequences of Literacy”, in Jack Goody (a cura di), Literacy in
Traditional Societies, Cambridge University Press, Cambridge, 1968, pp. 27-68), identifica per la cultura
greca classica un lungo periodo di convivenza dinamica tra questi due mezzi comunicativi, una fase di
transizione, che dura fino all’età ellenistica, in cui l’uso della scrittura influenza la composizione e la
trasmissione della comunicazione poetica, ma non interviene ancora nella fase di pubblicazione, che
resta orale e quindi performativa. La definizione di Ong sulla fase ‘aurale’ (Ong, Oralità e scrittura, cit.,
p. 119-167) o quella di Zumthor dell’‘oralità impura o mista’ (Paul Zumthor, La presenza della voce.
Introduzione alla poesia orale, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 36-36), devono, quindi, essere lette alla luce
della considerazione che la cultura umana possa fruire di differenti gradi di oralità, in cui ciascuno
influenzi l’altro nelle sue modalità espressive.
44
Maria Arpaia
MADDALENA GIOVANNELLI
L’ATTORE COMICO: UN ARTEFICE DEL PROPRIO RACCONTO
La riflessione sul passaggio tra oralità e linguaggio teatrale risulta di particolare
interesse per il dramma antico: gli adattamenti e le transcodificazioni sono alla
base di una prassi teatrale che nasce e si sviluppa nell’ambito di uno stretto legame
con la tradizione epico-rapsodica.
Proprio come in ogni forma di racconto orale, nel teatro greco era la parola a condurre lo spettatore attraverso il mutare dei luoghi e delle condizioni atmosferiche:
l’apporto immaginativo doveva giocare un ruolo determinante a fronte di una scenografia senza alcuna pretesa di naturalismo. La drammaturgia antica si distingue
dunque per una notevole attitudine descrittiva; i testi sono costellati di indicazioni
sceniche che segnalano l’identità dello spazio, l’ingresso di un oggetto o il passaggio
del tempo. Il precedente epico sembra dunque aver avuto profonda influenza al
punto che, come è stato più volte osservato, l’attore va concepito “piuttosto come
aedo e cantore di lunghe narrazioni che come personaggio vivo e agente”.1
Aristotele, nella Poetica (1148 a 28-29), definisce dramata tanto le opere di Omero
quanto quelle di Sofocle, perché entrambe “imitano persone che agiscono”. Egli
riconosce, cioè, tanto alla poesia diegematica quanto a quella drammatica in senso
stretto la medesima tensione alla rappresentazione di azioni e parole.
La commedia antica: una parola poietica
È possibile riscontrare una simile tendenza alla descrizione tanto nella tragedia
quanto nella commedia, ma i due generi mostrano anche in questo aspetto significative differenze. Nelle indicazioni sceniche tragiche la potenza immaginifica dei
versi e l’intento informativo appaiono difficilmente scindibili. Basti pensare
all’incipit dell’Agamennone: in pochi versi e senza forzature, la sentinella riesce a
evocare il buio notturno, lo sconforto del lungo attendere, il luogo solitario della
vedetta (1-10). Le indicazioni sceniche si caratterizzano per marcata intensità lirica
anche in Sofocle e lo stesso Euripide, malgrado la scelta di un linguaggio più
asciutto e realistico, raggiunge, nella scenografia verbale, momenti di “icastica
drammaticità”.2
Nella commedia di Aristofane le cose appaiono ben diverse: lo spazio – che nella tragedia tende a rimanere fisso – muta di continuo, costringendo lo spettatore a
un continuo cambiamento di prospettiva e le indicazioni che guidano tale vorticoso
1
2
Gone Capone, L’arte scenica degli attori tragici greci, CEDAM, Padova, 1935, p. 3.
Ivi, p. 6.
46
Maddalena Giovannelli
movimento risultano sintetiche, asciutte, disinvolte. Nella Pace, per esempio, il
protagonista si eleva in volo a bordo di una μηχανή (il viaggio dura dal v. 154 al v.
176) e atterra poco dopo davanti alla dimora di Zeus (“Ma ormai, mi sembra, sono
vicino alla sede degli dei: questa è la casa di Zeus”, 178). 3 L’attore è tornato, con
tutta probabilità, esattamente nel punto da cui è partito: il palco è lo stesso, ma la
parola scenica (in particolare le particelle καὶ δὴ e il successivo καθορῶ)4 ne ha
mutato l’identità. A segnalare i fulminei cambi di luogo sono semplici particelle,
deittici,5 verbi legati alla vista o sezioni di dialogo tra i personaggi.
Nelle Rane Aristofane presenta una vera e propria mimesi di un viaggio scandito dalla parola.6 Alcune brevi scene, che si susseguono in modo incalzante, segnano
uno spostamento progressivo verso Atene, poi l’arrivo presso una palude, attraverso una bolgia di tenebra e fango e poi ancora in una terra di mostri e una pianura fiorita, fino alla casa di Plutone. Il nuovo paesaggio si dispiega davanti agli occhi
dello spettatore, attraverso rapidi scambi di battute: “- E questo, cos’è? - Non vedi?
La palude di cui si parlava, per Zeus, eccola qua” (180-181).
A dissipare ogni dubbio sul fatto che, nell’affrontare la drammaturgia antica,
sia necessario prescindere da una prospettiva di realismo, dovrebbe dunque essere
sufficiente la sola lettura delle Rane : commedia che costituisce uno degli esempi
più interessanti dell’intero corpus aristofaneo per un indagine sulla scenografia
verbale. Si tratta di una disinvoltura evocativa che non può che far pensare al racconto folklorico e ad ogni forma di racconto orale:7 ciò che viene nominato assume
esistenza senza alcuna difficoltà.
Quale regia per uno spazio dell’immaginario?
La necessità di rinunciare a una scena descrittiva e realistica – per avvicinarsi a
una prospettiva ben più simile a quella del racconto orale – si pone dunque come
una necessità per chiunque voglia mettere in scena la commedia aristofanea. Come
La traduzione è di Guido Paduano, in Aristofane, La Pace, Rizzoli, Milano, 2002.
“Il sintagma καὶ δὴ” - precisa Benedetto Marzullo (“Lo spazio scenico in Aristofane”, Dioniso 59. 2,
1989, pp. 187-200, in part. p. 193) - “vocalizza una drammatica sorpresa, emotiva ed espressiva”. Cinzia
Roncoroni (“Osservazioni sullo spazio scenico in Aristofane”, Dioniso, 64, 1994, pp. 65-81, in part. p. 72)
nota come il verbo καθορῶ indichi l’idea di una visione dall’alto.
5 Si veda, per esempio, al v. 70 il deittico τουτονὶ che segna l’arrivo di un morto (“Ecco, fanno il funerale a un morto” traduce Dario Del Corno in Aristofane, Le Rane, a cura di Dario Del Corno, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, Milano, 2000).
6 Carlo Ferdinando Russo (Aristofane autore di teatro, Sansoni, Firenze, 1962, p. 326) nota come in
questa commedia Aristofane sia “tenuto a escogitare di continuo situazioni e immagini capaci di significare e di evocare con intensità il movimento e il paesaggio, e capaci di far inavvertitamente progredire,
ma sempre in maniera appropriata, quel particolarissimo e difficile spettacolo”.
7 Cfr. le importanti osservazioni di Diego Lanza, “Lo spazio scenico dell’attor comico”, in L. de Finis
(a cura di), Scena e spettacolo nell’antichità. Atti del convegno Internazionale di Studio, Trento 1988, Olschki,
Firenze, 1989, pp. 179-191.
3
4
L’attore comico: un artefice del proprio racconto
47
viene affrontata la sfida nel teatro di oggi? Quali sono le soluzioni più efficaci e
convincenti adottate negli ultimi anni?
A caratterizzare gli allestimenti che meglio interpretano la lezione della commedia è spesso la scelta di una scena scarna, anti-naturalistica, con pochi elementi
che permettano, con il mutare dello spazio, un progressivo riutilizzo e un’agile
risemantizzazione.
La regia deve immaginare diversi stratagemmi per trasporre gli spostamenti
spregiudicati dei personaggi comici: il palco deve trasformarsi di continuo, passando non di rado da un’ambientazione quotidiana ad una non terrestre, in una
fantasiosa e illimitata espansione dello spazio. Le Rane – come abbiamo già accennato – offrono al regista una prova particolarmente ardua, costringendolo a un
vero e proprio tour de force: le tappe dei viaggio si susseguono una dopo l’altra fino
all’approdo del protagonista nel regno degli Inferi.8
Ha affrontato con efficacia le difficoltà legate a una così vorticosa dinamica lo
storico “Teatro Due” di Parma con una creazione collettiva interpretata e diretta da
un ensemble di otto attori.9 Lo spettacolo presenta non poche soluzioni fantasiose e
sorprendenti: le metamorfosi dell’ambientazione si realizzano davanti agli occhi
degli spettatori con la stessa semplicità e immediatezza che contraddistinguono le
prassi del racconto orale.
La scena (a cura di Alberto Favretto) è astratta e fortemente geometrizzata, a
rimarcare il carattere simbolico e metaforico del percorso. Sullo sfondo è visibile
una linea blu, che evoca la cesura tra il regno dei vivi e il paesaggio ultraterreno. Il
passaggio tra i due mondi è del resto in Aristofane tutt’altro che netto: è piuttosto
l’incontro progressivo con ambienti e creature anomali a segnalare la collocazione
non più terrena dei due protagonisti e a scandire la progressione del paesaggio
infero. Compaiono d’improvviso un corteo funebre, un’oscura imbarcazione, una
palude dove gracidano le Rane, il terribile mostro Empusa, un coro di iniziati che
suona il flauto, una pianura fiorita. Quali di questi elementi risultavano effettivamente visibili sul palco e quali invece erano solo evocati con la parola?
Gli studi sulle Rane si sono concentrati, quasi immancabilmente, su complessi
tentativi di ricostruzione di quale fosse l’effettiva dinamica scenica, al punto che
l’apparizione della barca di Caronte e le sue modalità10 sono state definite “one of
8 Russo (Aristofane, cit., p. 326) parla di “spettacolo viatorio”, che possiede una “propria dimensione
artistica”.
9 Interpretato e diretto da Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Gigi
Dall’Aglio, Luca Nucera, Tania Rocchetta, Marcello Vazzoler. Musiche di Alessandro Nidi. Scene di
Alberto Favretto. Costumi Marzia Paparini. Luci di Luca Bronzo. Debutto Novembre 2011.
<http://www.teatrodue.org/1183/20112012/le-rane-2/> (1/2/2014).
10 Tra le congetture più frequenti, quella di un’imbarcazione dotata di ruote in grado di attraversare
l’orchestra. In questa prospettiva si muovono le ipotesi di Arthur Pickard-Cambridge (The theatre of
Dionysus in Athens, Clarendon Press, Oxford, 1946, p. 67); Russo (Aristofane, cit., p. 328); Kenneth Dover
(Aristophanes’ Frogs, Clarendon Press, Oxford, 1993, p. 179), Roberto Pretagostini (“L’episodio di
48
Maddalena Giovannelli
the perennial chestnuts of Aristophanic study”.11 Le ipotesi non sono talvolta prive
di interesse e di attendibilità, ma paiono non di rado troppo complesse per una
prassi teatrale per lo più indifferente ad effetti scenografici e ad una prospettiva
mimetica in senso stretto. Come spesso accade, la visione di un allestimento riuscito sgombra il campo da simili problemi e ricorda come siano spesso il riuso e la
risemantizzazione dei medesimi oggetti e, più in generale, la semplicità a prevalere
sulla scena.
La nave immaginata da “Teatro Due” non è altro che la stessa bara che apriva il
corteo funebre, riadattata attraverso una vela improvvisata; l’Empusa vive solo
attraverso le parole del servo Xantia, che si diverte a spaventare il pauroso Dioniso;
il protagonista, una volta arrivato a destinazione, può bussare ad una porta immaginaria. Ma l’elemento che caratterizza in modo più forte l’allestimento è una circonferenza rossa che evoca il cerchio di chi ascolta, embrionale palcoscenico di
ogni racconto: la semplice traccia diviene la palude, la reggia di Plutone e sarà infine il ‘ring’ della contesa tra Eschilo ed Euripide.
Lo spettacolo ha dunque il pregio di non mettere in moto ingombranti macchine sceniche che a fatica potrebbero seguire il caleidoscopio di ambienti e di immagini evocato da Aristofane, ma di utilizzare pochi e agili segni capaci di seguire il
ritmo dell’azione. “Teatro Due” mette in pratica gli antichi segreti del racconto
orale: il palco, illuminato da luci fioche, lascia modo al pubblico di seguire con
l’immaginazione il fantasioso viaggio.
Il ruolo del protagonista comico: un regista in scena
Le indicazioni sceniche che scandiscono il mutare dello spazio nella commedia
sono per lo più affidate al protagonista, che appare agli occhi dello spettatore
l’inventore della vicenda: le sue parole e le sue azioni sceniche dimostrano una
vera e propria capacità demiurgica.
Tale capacità si manifesta su due piani. Il primo è quello della fabula: il protagonista dà vita, attraverso le proprie azioni, a una realtà nuova e più vivibile di quella
precedente. Il punto di partenza della trama aristofanea è infatti, di consueto,
l’insofferenza di un uomo nei confronti della realtà circostante; a dispetto di qualunque criterio di verosimiglianza egli riesce, con le proprie sole forze, ad attuare
Caronte (Aristoph. Ran. 180-270)”, A&R, 21, 1976, pp. 60-66), Alan Sommerstein (Aristophanes. Frogs,
Aris & Phillips, Warminster, 1996, p. 172) e Maria Paola Funaioli (“Osservazioni sulla drammaturgia
delle Rane: la tenebra dell'Ade, Eracle e i Centauri, Palamede e la macchina del volo”, Dioniso, 63.2, 1993,
pp. 219-226). Altri ‒ come Christopher William Dearden (The stage of Aristophanes, Athlone Press, London, 1976, pp. 67-69) o Pascal Thiercy (Aristophane. Fiction et dramaturgie, Belles Lettres, Paris 1986, pp.
80-81) ‒ pensano all’utilizzo dell’ἐγκύκλημα per simulare l’avanzata della barca sull’acqua. Jean
Carrière (“Aux enfers avec Aristophane: le passage du lac dans les Grenouille”, Dioniso, 41, 1967, pp.
137- 143) immagina l’impiego di una fune per trainare il veicolo.
11 Dearden, The stage of Aristophanes, cit., p. 68.
L’attore comico: un artefice del proprio racconto
49
un cambiamento drastico e risolutivo nel proprio stile di vita. Negli Uccelli – ed è la
commedia in cui il passaggio risulta più evidente – Pisetero fonda la città di Nubicuculia nello spazio aereo in cui vivono i volatili; nelle Donne al Parlamento, per
citare un altro caso, la comunione dei beni ottenuta da Prassagora coincide con
l’abbattimento delle private dimore e la creazione di un spazio comune.12
Non si tratta – come risulterà chiaro anche solo da una lettura superficiale dei
testi aristofanei – di concrete proposte di cambiamento da realizzare, ma della
messa in atto di un’utopia, non di rado contraddittoria e incoerente, ma non per
questo meno desiderabile. Cinzia Roncoroni ha notato, a questo proposito, come
l’intervento del protagonista provochi per lo più il passaggio da uno spazio reale a
uno spazio immaginario13; e come anche in questo – nella capacità, cioè, di trasformare il piano di realtà in utopia – siano riscontrabili quelle caratteristiche che
fondano lo statuto dell’eroe comico:14 la forza di stravolgere il presente con il solo
aiuto della propria volontà, la fiducia nella possibilità dell’uomo di risolvere ogni
genere di difficoltà, anche se solo sul piano dell’immaginario.
Il potere poietico del protagonista ha altresì un riscontro dal punto di vista della
performance: al primo attore sono affidate le più significative indicazioni sceniche e,
con queste, l’intera dinamica dello spazio. Proprio come un narratore o un aedo,
egli può evocare gli altri personaggi della storia chiamandoli per nome (gli ingressi, non a caso, sono nella commedia quasi sempre annunciati),15 far esistere gli oggetti o i tratti caratterizzanti dell’ambiente.
Il protagonista è dunque una personalità dal carattere intrinsecamente performativo: egli non si limita ad agire per sé, ma dirige e coordina (proprio come farebbe un moderno regista) l’intera realtà circostante.16 Nulla che possa risultare
troppo sorprendente se si tiene conto che il drammaturgo era, alle origini del teatro
classico, anche il regista e l’unico performer.
Il duplice compito dell’attore comico era dunque ben chiaro al pubblico antico,
che non arrivava mai a concepire una totale identità (né un’identificazione) tra
12 “Prendi la città: giù le pareti. Voglio un grande open space, un’abitazione polifunzionale”. Traduzione di Andrea Capra, in Aristofane, Donne al Parlamento, Carocci Editore, Roma, 2010, 673-675.
13 Roncoroni, “Osservazioni sullo spazio scenico”, cit., p. 78.
14 Il riferimento è alla fondamentale monografia di Cedric Hubbell Whitman (Aristophanes and the
Comic Hero, Harvard University Press, Cambridge, 1964).
15 Le tipologie di annuncio di ingresso e di uscita sono state analizzate da Massimo Vetta (“La prima
apparizione di Clitemestra nell’Agamennone di Eschilo. Problemi di scena tragica”, in Maia, 28.2, 1976,
pp. 109-119); Fabio Cannatà (“Aristofane, Rane 180-183 e la prassi dell’entrata in scena annunciata nel
teatro attico”, Seminari romani di cultura greca, 3.1, 2000, pp. 49-63) e più recentemente da Ignacio
Rodríguez Alfageme (Aristófanes: Escena y Comedia, Editorial Complutense, Madrid, 2008), che studia tali
passaggi soprattutto in funzione della divisione in scene.
16 Ho affrontato l’argomento anche in “Raccontare lo spazio. La commedia di Aristofane tra
dramma e narrazione performativa”, in Atti del convegno COMPALIT. Performance e performatività,
Novembre 2010, Università di Messina, Mantichora, 1, 2011, pp. 343-349.
50
Maddalena Giovannelli
attore e personaggio.17 È l’eroe comico stesso, del resto, a fare continuamente riferimento alla propria condizione di attore e ad altri elementi legati alla realtà della
rappresentazione teatrale: basti pensare alla celebre e accorata esortazione al macchinista da parte di Trigeo (173-176), il protagonista della Pace, che levandosi sopra
le teste degli spettatori a bordo di una mechanè, teme qualche spiacevole effetto
collaterale della propria cavalcata aerea.
Si è parlato spesso, per la commedia antica, di caduta o intermittenza
dell’illusione scenica;18 ma si tratta di una dimensione del tutto aliena al teatro di
Aristofane che, come ogni forma di comico, vive del costante e scoperto rapporto
tra pubblico e attori. Il continuo rivolgersi agli spettatori (spesso in termini poco
lusinghieri) è del resto uno tra gli ingredienti caratterizzanti – e più celebri – della
commedia aristofanea: ed è un ruolo che spetta per lo più al primo attore.19
Abbiamo già ricordato la costante sollecitazione dell’immaginario del pubblico
attraverso l’uso di una parola fortemente descrittiva, eredità diretta dell’epos; ma
anche nel peculiare statuto dell’attore la commedia antica dimostra la propria contiguità alle forme del racconto orale. La comunicazione esplicita con gli spettatori è
elemento costitutivo di entrambe le prassi, al punto che è lecito parlare di una vera
e propria inclusione dell’uditorio nel processo performativo.20
Il protagonista dà vita al personaggio mostrandone al contempo tutta la finzione: egli ‘scopre’ il proprio ruolo e l’intero meccanismo teatrale. Ci troviamo ben
lontani da ogni genere di teatro di interpretazione.
L’attore comico sulla scena di oggi
Dare vita sul palco a un ruolo multifunzionale come quello dell’attore comico,
in bilico tra narratore e performer, non è una sfida semplice. Gli strumenti interpretativi orientati alla ricostruzione psicologica del personaggio che, da Stanislavskij
17 Nella commedia la maschera è infatti sempre percepita e raffigurata ‒ nelle testimonianze vascolari in nostro possesso ‒ come un oggetto, un elemento di scena scisso dal corpo dell’attore e distinguibile come tale. In ambito tragico, invece, il personaggio, l’attore e la maschera sono considerati in una
totale identità: nelle testimonianze figurative, le tre immagini vanno infatti immancabilmente a coincidere. Su questo cfr. Andrea Capra, Maddalena Giovannelli, “’Prince of Painters’, the Grimacing Mask of
Power and Seduction in Aristophanes’ Assemblywomen”, in Silke Knippshild, Marta García Morcillo (a
cura di), Seduction and Power. Antiquity in the Visual and Performing Arts, Bloomsbury, New YorkLondon, 2013, pp. 95-107.
18 Per una meditata ricostruzione degli studi che hanno preso in considerazione il concetto di illusione scenica nella commedia greca cfr. Alfageme, Aristófanes, cit., pp. 52-60. Tra questi, significativo il
lavoro di Geoffrey Arthur Hart Chapman, “Some Notes on Dramatic Illusion in Aristophanes”, AjPh,
104, 1983, pp. 1-23, che stila un elenco delle presunte interruzioni dell’illusione.
19 Cfr. ex. gr. Aristoph. Pax 821-823: ἀπὸ τοὐρανοῦ φαίνεσθε κακοήθεις πάνυ / ἐντευθενὶ δὲ
πολὺ τι κακοηθέστεροι.
20 Gerardo Guccini, “Il teatro narrazione: tra scrittura oralizzante e oralità che si fa testo”, Prove di
drammaturgia, 20, 2004, pp. 15-21, in part. p. 16.
L’attore comico: un artefice del proprio racconto
51
in poi, sono alla base della preparazione attoriale contemporanea risultano del
tutto inadeguati quando non controproducenti.21
Una felice eccezione in questo è costituita da un allestimento delle Nuvole firmato dal regista Antonio Latella (Premio Ubu nel 2012 e nel 2013) su una riscrittura
della giovane e talentuosa Letizia Russo.22 In scena solo tre attori, proprio come
accadeva ai tempi di Aristofane, ricoprono tutti i ruoli richiesti dal testo; scelta che
testimonia la volontà consapevole di evitare un’identificazione tra personaggio e
interprete. E mentre il primo attore Annibale Pavone è costantemente impegnato
con Strepsiade, Massimiliano Speziani si destreggia fra tre parti: Fidippide
(all’inizio un pupazzo di gommapiuma, poi attore in carne ed ossa), Socrate, il
Discorso Ingiusto. Marco Cacciola è invece un metamorfico tuttofare: interviene
incarnando ogni ruolo minore, dal discepolo di Socrate al susseguirsi dei creditori,
dal servo al Discorso Giusto.
I tre performer si cambiano e si trasformano davanti agli spettatori, ricordandoci – con i loro costumi da mimi e con le loro scarpe da clown – di essere innanzitutto
attori, che prestano voce e corpo volta per volta a uno o all’altro personaggio, proprio come farebbe un narratore che si trasforma in agente.23 Coerentemente, la
dimensione meta-teatrale si rivela poi vero e proprio Leitmotiv di questo allestimento: gli attori si fanno i dispetti (Socrate/Speziani costringe il discepolo/Cacciola
a prestare la sua schiena per farne un “sacro lettuccio”) vendicandosi persino di ciò
che avviene dietro le quinte. Così il discepolo di Socrate aspetta invano che gli
passino da fuori scena il necessario per la sua parte; occhieggia, gesticola e ottiene
un bastone. Non è quello che si aspettava: insulta l’interlocutore invisibile e finge,
complice il pubblico, di potersela cavare ugualmente.
Il rapporto con gli spettatori è esplicito ed essi vengono continuamente sollecitati e incalzati: gli attori scendono in platea, chiamano in causa il pubblico, lo includono nel processo comunicativo. Non stupisce quindi scoprire che le Nuvole –
coro di non semplice interpretazione – siamo in realtà noi: quando Socrate spiega
al poco duttile studente Strepsiade che si tratta di forme incostanti e mutevoli, le
luci vengono alzate e gli attori guardano a lungo, silenziosi, in sala.
La presenza di una dimensione esplicitamente performativa non viene mai meno e
proprio su questa allusione lo spettacolo si apre e si chiude: “one, two, three, four” è la
battuta di incipit e di finale, simbolico segnale che segna i contorni della narrazione.
Gli interpreti, fermi e neutri sul palco, si dichiarano a tutti gli effetti artefici del
proprio racconto.
21 Si vedano a questo proposito le osservazioni di Massimo Castri sui limiti, per il teatro antico, di
un educazione “di tipo psicologico stanislavskiano” (“La responsabilità del regista”, Dioniso, 63, 1993,
pp. 155-162.
22 Per un’analisi completa dell’allestimento, cfr. Martina Treu, Maddalena Giovannelli, Andrea Capra, “Aristofane senza filtro: Le Nuvole di Latella-Russo”, Stratagemmi, 13, 2010, pp. 249-262.
23 Si vedano le osservazioni aristoteliche sul narratore che si trasforma in agente: Poet. 1448 a 20-4.
52
Maddalena Giovannelli
ANNA LIVIA FRASSETTO
UNA RILETTURA GIOCOSA PER MUSICA DEL MITO DI LUCREZIA:
LUGREZIA ROMANA IN COSTANTINOPOLI DI CARLO GOLDONI
LUGREZIA:
Dimmi e inarca per stupore il naso.
Di Lugrezia romana i strani casi
uditi avrai; io quella sono, io quella
che da Sesto Tarquinio assassinata,
ho fatto senza colpa la frittata.
ALBUMAZAR:
Dell’illustre matrona
è famosa l’istoria
ma come quella sei
se Lugrezia romana si ammazzò per non vivere … eccetera?
LUGREZIA:
Ammazzarmi! Marmeo! Non fui si matta,
finsi di sbusarmi il petto
ed il ferro mostrai di sangue sporco
ma quello era, o signor, sangue di porco (I. VIII, 260-273).1
Così Carlo Goldoni racconta il mito di Lucrezia, la virtuosa matrona romana
che nel 509 a. C., divenuta oggetto della cupidigia di Sesto Tarquinio, figlio del re
di Roma, fu vittima della di lui violenza. A seguito dello stupro, Lucrezia si uccise
in presenza del marito Collatino, del padre e di Bruto. Il suo gesto - così narra la
leggenda - fu all’origine della rivolta che portò alla cacciata dei Tarquini e all’inizio
dell’età repubblicana.
Goldoni, nel 1737, alle soglie, dunque, della sua riforma del teatro, ne fa un
dramma giocoso per musica dal titolo Lugrezia romana in Costantinopoli in cui reinterpreta, in chiave originale e assolutamente trasversale, questo mito. L’opera rientra
nella prima produzione dell’autore e, in particolare, tra quei drammi musicali, pochi
e concentrati nel periodo che va dal 1735 al 1743, composti per i comici della compagnia Imer del “Teatro San Samuele” di Venezia. La trasposizione teatrale goldoniana
del mito è tutta giocata sulla fusione di espedienti ereditati dal teatro dell’antichità
classica, dalla parodia carnascialesca e dalla commedia dell’arte, colorati con toni
settecentescamente esotici e completati dall’arguzia dell’autore. Se a questo si aggiunge che sarà proprio Carlo Goldoni, con la sua Scuola moderna del 1748, a fissare
1 Il testo della Lugrezia Romana in Costantinopoli cui si fa riferimento è tratto dall’edizione di Anna
Vencato (a cura di), Carlo Goldoni. Drammi musicali per comici de San Samuele, Marsilio, Venezia, 2009.
54
Anna Livia Frassetto
nella forma del “dramma giocoso per musica” la definizione di un tipo di opera buffa italiana in grado di imporsi come modello su scala nazionale,2 si può considerare
la sua Lugrezia un testo che, se da una lato rimane legato alle tradizione, dall’altro si
affaccia, con spirito innovativo, su una nuova dimensione teatrale.
La vicenda è narrata all’imperatore Albumazar dalla protagonista in persona.
Il sovrano turco, proprio come il pubblico che assiste alla rappresentazione, c onosce la storia della matrona romana nella sua versione, per così dire, tradizion ale ‒ cioè quella liviana ‒, ma ben presto sia lui che gli spettatori scopriranno che
le cose stanno un po’ diversamente. Lugrezia, dopo aver inscenato la sua morte
non da sola bensì in combutta con il marito Colatino (ribattezzato, così come la
consorte, con una versione romanizzata del proprio nome), è fuggita da Roma. A
causa di un malessere della protagonista, di cui si parlerà più avanti, i due fanno
naufragio. Colatino scompare tra i flutti mentre Lugrezia si salva e giunge così a
Costantinopoli.3 Il sovrano Albumazar si invaghirà di lei e tenterà di conquistarla, di sposarla e, infine, di stuprarla. Ma Colatino ritornerà e i due si contend eranno la virtuosa matrona romana e, insieme ad una serie di altri nuovi personaggi, porteranno avanti la vicenda interpellando addirittura un finto oracolo
per giungere ad un finale altrettanto innovativo. Qui, proprio come in apertura,
la morte è annunciata per poi essere allontanata poiché tutti i protagonisti, dopo
aver tentato di darsi la morte in ogni modo possibile e immaginabile, vi rinunceranno in un coro di voci:
TUTTI
El pensier de morir lassar andar
Bravi bravi ,viva viva
Che si goda, che si viva
Tutti assieme in allegria
Stiamo uniti in compagnia
Pace, pace e non più guerra
Che si goda, che si viva
Bravi bravi, viva viva
(III, ultima, 1074-1081)
2 Paolo Gallarati nel suo testo Musica e maschera. Il libretto italiano nel Settecento, EDT, Torino, 1984,
offre un’interessante panoramica, ricca di stimolanti spunti, sull’attività di Goldoni come librettista e,
più in generale, sull’opera seria, l’opera buffa e il dramma giocoso.
3 Qui inizia la nuova avventura che, però, è in realtà la seconda variazione del mito presente in
questa opera comica. Il libretto goldoniano offre, infatti, due riletture del mito: la prima, con cui si apre
l’opera, è quella raccontata da Lugrezia e consiste sostanzialmente nella narrazione della vicenda ancora
nella sua veste più tradizionale, ma con un diverso epilogo. Si pongono così le basi per la seconda e più
estesa rilettura che, muovendo dai suddetti presupposti, destruttura il mito e lo scardina in maniera
ancora più ampia e dissacrante, mantenendo comunque fermo il tema centrale della vicenda, ovvero
quello della violenza anche se, naturalmente, rivisitato e corretto.
Una rilettura giocosa per musica del mito di Lucrezia …
55
Il punto di partenza della rivisitazione goldoniana del mito è la finta morte della protagonista. Questo è il primo strumento proveniente dal teatro antico utilizzato da Goldoni, il quale fa ruotare la sua rilettura del mito di Lucrezia proprio attorno a quel “procedimento narratologico chiamato anche mors mimica, che consisteva
nel far morire il protagonista per poi, ad un certo punto della storia, farlo resuscitare, giocando con il criterio della verosimiglianza e con gli orizzonti di attesa dello
spettatore”.4 Questo espediente sopravvive al mondo antico come dimostra, per
fare un solo esempio, il finale della tragedia shakespeariana di Romeo e Giulietta.5
La mors mimica, oltre che strumento per la rilettura scenica del mito, è anche un
riferimento ad uno dei possibili testi che ispirarono Goldoni6 ovvero la novella di
Bernabò da Genova (Giornata seconda, Novella nona) contenuta nel Decameron.
Quello che avvicina la novella boccaccesca al libretto goldoniano è soprattutto
l’idea di parodia del mito che è sottesa al testo e le modalità con cui questa viene
esercitata: qui la protagonista – vittima non di una violenza reale ma piuttosto
millantata – non si uccide ma, per sfuggire all’ira del marito, si finge morta, si traveste e parte per mare. Gli espedienti della parodia e del comico, appartenenti alla
tradizione, quali la finta morte ed il travestimento, pongono in luce un primo avvicinamento tra i due autori, ma ciò che rende peculiare il legame tra Boccaccio e
Goldoni è che le riletture del mito di Lucrezia che utilizzano tali artifici non sono
assolutamente frequenti.
Tutto è originale e particolare in Lugrezia Romana in Costantinopoli.
L’accostamento di elementi bassi, dichiaratamente scurrili, a un contesto e a personaggi elevati è un espediente tipico della parodia: la sovrapposizione di registri
differenti e il contrasto tra il linguaggio dei protagonisti, la loro statura eroica e le
aspettative che ne derivano sono all’origine della comicità. Così gli ideali dei principi e degli illustri personaggi storici sono sostituiti da appetiti e desideri culinari.
Dal cibo deriva anche quell’umorismo talvolta definito “da toilette” che richiama
ancora agli espedienti tipici della tradizione antica e poi carnevalesca. Questi hanno determinato la definizione, tra l’altro, della Lugrezia goldoniana come “una insolita concessione alle scurrilità”.7 Il carnevale con il suo mondo alla rovescia – in
cui governa la liberazione temporanea dalla verità dominante, l’abolizione di privilegi, regole e tabù – e con l’abbassamento e il trasferimento di tutto ciò che è alto e
4 Luciano Cicu, Il mimo teatrale greco-romano. Lo spettacolo ritrovato, Università “La Sapienza” Editore,
Roma, 2012, pp. 156-58.
5 Si veda Cicu, Il mimo teatrale greco-romano. Lo spettacolo ritrovato, cit., p. 201.
6 Forse l’autore conosceva la parodia Die Kleinmuethige Selbstmoerderin Lucretia oder Die Staats-Thorheit
des Brutus di Reinhard Keiser (1705), e l’opera musicale bernesca Die Römische Lucretia del 1731 di Johann
Heinrich Rademin. Aveva certamente letto ben undici volte (lo racconta egli stesso nelle sue Memorie) la
Mandragola di Machiavelli, che al mito di Lucrezia si rivolge e in cui la parodia scaturisce non solo dal
confronto con il mito ma anche dalla critica che Agostino ne aveva fatto nella Città di Dio.
7 Walter Binni, “Carlo Goldoni”, in Emilio Cecchi e Natalino Sapegno (a cura di), La letteratura
Italiana, vol. 11, Garzanti, Milano, 2005, p. 317.
56
Anna Livia Frassetto
spirituale sul piano materiale e corporeo, è fortemente presente nel libretto goldoniano. Così, in perfetta sintonia con l’intento parodistico dell’autore, si scopre che
all’origine del naufragio che porterà Lugrezia e Colatino sulle rive turche vi sono le
“intemperanze” intestinali della protagonista8 che richiamano la tradizione carnascialesca e, ancor una volta, quella antica (si pensi al Satyricon di Petronio e in particolare all’episodio del Mimo di Crotone, citazione - a sua volta - de Le Rane di Aristofane).9 Nel libretto musicale di Lugrezia, in questo crogiuolo di temi e influenze,
si combinano naturalmente anche elementi appartenenti a quella commedia
dell’arte che di lì a poco Goldoni traghetterà verso nuove forme. In quest’ottica si
inquadra, tra l’altro, l’inserimento di personaggi nuovi ma figli delle commedie del
tempo, quali il principe Maimut o la coppia di servi Ruscamar e Mirmicaina. Anche l’ambientazione, pur coincidendo con il mondo inverosimile in cui si è soliti
ambientare le vicende di maschere, è assolutamente settecentesca e in linea con
l’esotismo del secolo delle Mille e una notte e delle Lettere Persiane. Dalla commedia
dell’arte deriva il plurilinguismo ed il linguaggio ricco di onomatopee, lemmi privi
di significato (“euh”, “gnagnao”, “alachalabalà”, “marmute”, “fripute”, “scialcabalà”), imitazioni di versi animaleschi e interiezioni di cui Goldoni fa un uso del tutto
originale e centrale. Con il tema del linguaggio e di quella pluridialettalità della
commedia dell’arte - che però aveva ormai perso la sua funzione caratterizzante
diventando irreale e stereotipata - giocano in primo luogo i protagonisti.10 Goldoni
utilizza tale pluralità rinnovandola e fondendola con quella lingua franca mediterranea già impiegata, anche se in termini più limitati, nella Birba (1735), creando così
un idioma del tutto originale. Da questa unione scaturisce una forte musicalità
creata da rime e allitterazioni ma, nel contempo, caratterizzata da quelle stonature
che sono determinanti per la parodia. Uno dei tanti esempi ne è l’alterco tra Lugrezia e Mirmicaina che si contendono la corona di regina di Costantinopoli: “MIRMICAINA: Tiolé sto canelao / La reggina vu sé de gnababao. / LUGREZIA: Un canelato a
me? / Femina sciocca / Se mi levo una scarpa / Ti insanguino la bocca” (I. IX, 419420). A tutto questo si aggiunga il tocco personale dell’autore capace di creare degli
spassosi ‘a parte’, come quelli in cui Lugrezia, riflettendo sulla morte (presunta
anche qui) di Colatino, dice: “Che fo? Che penso? Colatino è già morto. Lo stato
vedovil poco mi piace” (I. VIII, 331-333) o quando Albumazar, nel momento clou
del suo alterco con Colatino redivivo, gioca con il tema del teatro nel teatro e, dopo
8 Si allude anche ora al mito classico e, in questo specifico caso, ci si riferisce a quel tema molto
delicato, ovvero al timore di una possibile gravidanza a seguito dello stupro: “quando mi sopraggiunse
un certo male /con dolori al ventre così atroci/che quasi mi pareva esser incinta….ma tutto alfin si
disciolse in flato” (I. VIII, 288-90; 293).
9 Petr. Sat. 116-141; Aristoph. Ranae 10.
10 Come il sovrano Albumazar, quando stabilisce di imporre ai suoi sudditi l’uso della lingua
italiana in onore della sua futura sposa: ”Oggi ciascuno/benché sia maometano/se brama il mio favor,
parli italiano” (I. I,4) e anche la stessa Lugrezia che, rivolta al sultano, dice: “Se deggio imitar il tuo
parlare/certo mi sembrerà di bestemmiare” (II. X 661-662).
Una rilettura giocosa per musica del mito di Lucrezia …
57
averlo mandato al diavolo, si rivolge così a Lugrezia: “Mia cara la scena seguitiam”
(I. IX, 352-353). Per non dire dell’abilità dell’autore nel concepire la versione scenica – direi ‘fisica’ - della coppia Lugrezia-Colatino in modo talmente definito da far
sì che anche colui che legge soltanto il libretto abbia l’impressione di averli davanti
agli occhi esattamente come lo spettatore seduto in teatro. Albumazar, infatti, descrive così i coniugi quando, rivolgendosi a Lugrezia, esclama: “Lascia che se ne
vada [scil. Colatino] / che vuoi far di colui? Tu granda e grossa / egli piciolo e magro” (I. X, 402-3). Le parole del sultano sono tanto taglienti quanto capaci di rendere tutta la vis comica dei personaggi e di suggerire perfettamente come doveva
apparire la coppia sul palcoscenico. Se a ciò si aggiunge che già in questa opera,
cosiddetta ‘minore’, le maschere sono assenti, si può affermare che il ruolo della
Lugrezia non sia poi tanto marginale ma rappresenti, in un modo che è tutto suo,
un primo passo verso la riforma goldoniana.
E poi la musica. Attribuita al musicista Giacomo Maccari, essa è sfortunatamente andata perduta. Goldoni è stato uno dei più fecondi e più influenti librettisti
comici del Settecento, sebbene egli spesso sentisse l’asservimento della poesia alla
musica come un ostacolo all’efficienza e all’organicità strutturale e stilistica del
dramma.11 Ma forse egli cercava già una rappresentazione della realtà – fondamento della sua riforma - che il melodramma non era ancora in grado di offrire. Se,
talvolta, la produzione librettistica goldoniana sembra essere stata considerata di
secondo piano rispetto alle commedie e approfondita prevalentemente nel caso di
specifici interessi, secondo Binni “i motivi più interessanti del noviziato teatrale si
troveranno nei melodrammi giocosi e tanto meglio negli ‘intermezzi giocosi’ per
musica. È soprattutto in questi che si rivela meglio la vera natura goldoniana, liberi
come sono dall’impaccio della regolarizzazione di precedenti componimenti o
scenari”.12
Goldoni ha dunque preso e fatto suo un mito impegnativo, ‘scomodo’13 e poco
utilizzato dall’opera seria a causa della mancanza del lieto fine, che invece era presente nel melodramma il quale, però, preferiva dare risalto alla dimensione storicopolitica. Dalla rilettura goldoniana nasce un’opera eccentrica, un libretto fuori dal
comune ma soprattutto sperimentale: un crocevia tra il mondo classico, i mimi, le
commedie, il mondo alla rovescia e l’abbassamento carnevaleschi, la parodia e,
ancora, la musica, gli intermezzi, l’opera buffa, l’esotismo settecentesco e molto
11 Si veda Carlo Goldoni, De Gustibus non est disputandum, (L’autore a chi legge) del 1754: “… molto
più imperfetto il dramma buffo esser dee, perché cercando si degli scrittori di tal barzellette servire più
alla musica che a sé medesimi, e fondando o nel ridicolo o nello spettacolo la speranza della riuscita,
non badano seriamente alla condotta, ai caratteri, all’intreccio, alla verità come in una commedia buona
dovrebbe farsi”.
12 Binni, Carlo Goldoni, cit., p. 316.
13 Si veda a tal proposito il concetto di “uncomfortable myth” in Ian Donaldson, The Rapes of
Lucretia. A Myth and Its Transformations, Clarendon Press, Oxford, 1982.
58
Anna Livia Frassetto
altro ancora. La scelta del mito di Lucrezia è coerente – forse anche di più di quanto non sembri - con la posizione che questo libretto occupa nella produzione goldoniana. Lugrezia romana in Costantinopoli è un‘opera di rottura, composta in un
momento di passaggio, legata sicuramente al passato ma, nel contempo, protesa
coraggiosamente verso nuove forme.
L’eroina romana ne è l’inaspettato ma, in realtà, perfetto soggetto: quale mito
meglio di questo può infatti rappresentare sia l’attaccamento alle tradizioni che la
spinta al cambiamento? Sembra quasi che questa Lucrezia si senta stretta nelle sue
vesti di mito, nella tragicità dello stupro, del suicidio, nella rigidità della sua condizione di exemplum. Goldoni capisce questa sua sofferenza e la libera aiutandola a
trovare una nuova dimensione, pur mantenendo quella “attitudine a nascere e
rinascere trasformandosi continuamente”14 che è propria del mito. Da qui ha origine Lugrezia Romana in Costantinopoli che diviene così simbolo di una voglia di cambiamento, di un mondo diverso, magari anche ”alla rovescia” ma che, pur rivolgendosi al nuovo, non dimentica il passato.
14
Jean Rousset, Il mito di Don Giovanni, Pratiche, Parma, 1980, p. 6.
DARIO MIGLIARDI
IL MYTHOS DELL'EACIDE NE L'IN-VULNERABILITÀ DI ACHILLE
DI CARMELO BENE
Il lavoro ‒ o meglio lo studio ‒ di Carmelo Bene sul personaggio di Achille abbraccia un arco di tempo lungo all'incirca dieci anni. Comincia sul finire degli anni
'80 in corrispondenza - ma sarebbe più corretto dire in ragione - della formulazione
del concetto di ‘macchina attoriale’ e ha una sua significativa tappa nello spettacolo
al “Teatro Argentina” di Roma, tenutosi nel 2000.
La prima versione dell'opera si presenta dunque sotto forma di un ‘progettoricerca’ le cui fonti sono espressamente dichiarate: Stazio, Kleist, Omero e i Posthomerica.1 Questa prima fase dell'Achilleide beniana si articola in due performance, rispettivamente: Pentesilea la macchina attoriale - attorialità della macchina, momento n°1,
andato in scena nel 1989 nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco di Milano,
e Pentesilea la macchina attoriale - attorialità della macchina, momento n°2, rappresentato nel 1990 al “Teatro Olimpico” di Roma. Nel 1993 Bene pubblica una versione a
stampa del suo lavoro con il titolo Pentesilea ovvero della vulnerabile invulnerabilità e
necrofilia in Achille, poesia orale su scritto incidentato, mentre del 1997 è la versione
televisiva: In-vulnerabilità di Achille (tra Sciro e Ilio), libera versione poetica da Stazio, Kleist, Omero.2 Si arriva, infine, alla già accennata versione del 2000 al “Teatro
Argentina” di Roma: In-vulnerabilità di Achille, impossibile suite tra Sciro e Ilio, che
porta come sottotitolo didascalico: “spettacolo-sconcerto in un momento”.
Ai fini del presente discorso non privo di interesse sarà soffermarsi brevemente
sui titoli che identificano le varie tappe del lavoro di Bene su Achille, focalizzando
l’attenzione sulla loro sostanziale formulazione, basata su una doppia dicotomia,
quella tra gli attributi dell'invulnerabilità e della vulnerabilità dell'eroe e quella tra
le città di Sciro e Ilio. La valenza filologico-simbolica di queste due coppie di termini in opposizione sarà esplicata più avanti.
Menzione a parte merita il titolo del libro del '93, quel Pentesilea ovvero della vulnerabile invulnerabilità e necrofilia in Achille, caratterizzato dall'attribuzione all'eroe
argivo della macabra perversione. Al riguardo, una versione del mito di Achille e
Pentesilea narrava che il Pelide, dopo aver ucciso la regina delle amazzoni, che si
era schierata al fianco dei Troiani nell'annosa guerra contro i Greci, se ne fosse poi
intempestivamente innamorato e ne avesse posseduto il cadavere in preda a un
raptus dei sensi. A tal proposito si veda lo scolio al v. 445 del Filottete di Sofocle, in
Cfr. Piergiorgio Giacché, Antropologia di una macchina attoriale, Bompiani, Milano, 2007, pp. 197-220.
Regia, scene, costumi e voce solista Carmelo Bene; tecnico del suono Andrea Macchia; montaggio
Mauro Contini; produzione Nostra Signora S.r.l., Rai.
1
2
60
Dario Migliardi
cui vengono riportati due avvenimenti: il primo è l'uccisione da parte di Achille del
soldato acheo Tersite, macchiatosi della colpa di aver cavato con la lancia gli occhi
al cadavere di Pentesilea; il secondo invece è il congiungimento carnale dell'eroe
con l'ormai morta regina delle amazzoni (“Si diceva anche che dopo la morte [μετὰ
θάνατον], innamorato di lei, Achille si congiunse con lei”). Si veda anche lo scolio
a Licofrone, Alessandra 999, in cui lo scoliaste attribuisce l'episodio della necrofilia
di Achille a una presunta maldicenza dello stesso Tersite, punita dall'eroe con la
morte. All'episodio fa un implicito riferimento anche Libanio, retore tardoantico, in
uno dei suoi esercizi scolastici (Progymnasmata 9, 1, 22 F.), un brano costituito da un
incalzante susseguirsi di interrogative retoriche. Libanio si chiede, ironicamente, se
davvero Achille vada considerato il miglior soldato giunto a Troia, proprio lui argomenta il retore - la cui insaziabile foia non risparmiava né le vive (Briseide) né
le defunte (Pentesilea). Infine, ulteriore attestazione di questa variante del mito è
costituita dal commento di Servio al v. 661 del libro XI dell'Eneide, dove, alla voce
“Ippolita”, leggiamo: “Hyppoliten haec Amazonum fuit regina, cui victae Hercules
balteum sustulit. Huius filia fuit Antiopa, quam Theseus rapuit, unde Hippolytus.
Martia aut bellicosa, aut Martis filia. Quae ab Achille occisa ac mortua adamata est:
ut non nulli vero adserunt, cum Achille concubuit, et ex eo Caystrum filium edidit,
ex quo flumen Lydiae ita appellatur”. In Quinto Smirneo (Posthomerica 1, 716-754)
v'è solo l'innamoramento da parte dell'Eacide per l'amazzone oramai morta, senza
alcuna allusione alla necrofilia; resta invece l’allusione all'episodio del soldato greco Tersite, che osa biasimare Achille illanguidito dalla bellezza quasi divina della
regina. Lo smarrimento di Achille di fronte alla venustà dell'amazzone esanime è
tale da fargli rimpiangere d'averla uccisa e non averla invece condotta sposa a Ftia.
Il passo in questione è molto suggestivo: la dolente riflessione dell'Eacide è suscitata dallo svelamento della reale identità di Pentesilea. Sotto l'apparente androginia
della furiosa virago, sotto la crosta metallica della bellicosa lorica e dell'elmo scintillante si cela un femminino seducente, propriamente e divinamente femminile. Il
cambiamento d'atteggiamento nell'eroe greco è repentino: un attimo prima è intento a schernire l'amazzone; dopo lo 'svelamento' ne piange disperato la morte:
E ora giaci nella polvere, in pasto a cani e uccelli,
sventurata! Chi mai ti ha indotto con l'insidia a contendere
con me? Pensavi forse che di ritorno dalla pugna
avresti ricevuti immensi doni dal vecchio Priamo,
sterminati gli Argivi? Ma per te tal proposito gli immortali
non hanno condotto a termine, giacché siamo di gran lunga i migliori
tra gli eroi; grande luce per i Danai, sventura per i Troiani;
e anche per te, che hai avuto destino funesto, ché le cupe Chere
eccitarono il carattere, abbandonate le opere delle donne,
a scendere nella mischia, che perfino gli uomini paventano”
Così parlando estraeva il legno il figlio di Peleo,
dal veloce cavallo e dalla triste Pentesilea,
Il mythos dell'Eacide ne L'In-vulnerabilità di Achille di Carmelo Bene
61
insieme palpitavano straziati dalla stessa asta.
Le tolse dal capo l'elmo scintillante,
simile ai luminosi raggi del sole e al bagliore di Zeus;
e di lei, pur caduta nella polvere e nel sangue,
brillò sotto l'amabile fronte il bel volto,
sebbene morta. Come la videro, accerchiandola
stupirono gli Argivi, perché a dea era simile.
Invero giaceva in armi a terra, come Artemide
instancabile, figlia di Zeus, mentre dorme, quando abbia affaticato
le membra dando la caccia a veloci leoni sugli alti monti.
Invero così mirabile la rese, perfino tra i morti,
Cipride dalla bella corona, sposa di Ares valente,
affinché fosse motivo di sdegno per il figlio del glorioso Peleo.
Molti pregavano perché, una volta fatto ritorno nelle loro case,
potessero dormire nel letto di una tale sposa.
Anche Achille senza sosta si affliggeva nell'animo suo,
perché l'aveva uccisa, e non condotta come mirabile sposa
a Ftia dai bei puledri; giacché per statura e sembianze
era perfetta e simile alle immortali.3
Sulla ricezione del mito della necrofilia di Achille da parte di Bene, ci informano alcune interessanti notazioni rintracciabili negli appunti dell'attore concernenti la figura dell’eroe greco, in primis la frase: “Il mito di Achille / Pentesilea =
necrofilia”.4 L'equivalenza, scontata forse per il filologo, non doveva esserlo per
un non addetto ai lavori. 5 Essa può essere considerata, dunque, testimonianza
della consapevolezza da parte dell'attore di una tradizione del mito orientata in
quel senso. Del resto, per quanto concerne il rapporto tra Achille e Pentesilea
nella versione dei Posthomerica, sappiamo che Bene aveva a disposizione l'edizione del testo di Quinto de “Le Belles Lettres”, di cui si conserva tra le sue carte
una copia annotata dei vv. 320-585. Ora, in margine all'episodio del biasimo di
Tersite, nella prestigiosa edizione francese dei Posthomerica troviamo una lunga
nota che riferisce della probabile conoscenza, da parte di Quinto, dello scabroso
episodio, nonché un elenco delle fonti - quelle suindicate - riguardanti la necrofilia di Achille. Non è azzardato supporre, dunque, che la cosa non sia sfuggita
all’occhio attento del ‘filologo’ Bene. In seconda istanza poi Bene, sempre negli
3 Quint. Smyrn. Posthom. 1, 619-765; trad. Emanuele Lelli in Quinto di Smirne, Il seguito dell'Iliade,
coordinamento e revisione di Emanuele Lelli, Bompiani, Milano, 2013.
4 Appunti inediti consultati presso “La Fondazione l’Immemoriale” di Carmelo Bene. Si tratta, nella
fattispecie, di un esiguo numero di fogli scritti a mano e privi di esplicite indicazioni cronologiche parte
di un cospicuo dossier sullo spettacolo ancora tutto da catalogare e datare.
5 Si noti che nel bel libro di Katherine King, Achilles, Paradigms of the War. Hero from Homer to the
Middle Age, University of California Press, Los Angeles, 1987, che pur costituisce un indispensabile
contributo alla conoscenza della figura di Achille tra mito e letteratura, non si fa alcun accenno alla
questione.
62
Dario Migliardi
appunti, parlando dell'Achilleide stavolta, definisce il poemetto staziano: “patologia del contadino alla ricerca del cadavere interrato”. Non si sta parlando di Pe ntesilea in questo caso, bensì di Deidamia e, come più avanti vedremo, del cadav ere della fanciullezza. Tuttavia, ciò che ci interessa qui sottolineare sono le modal ità con cui l'ossessione necrofila dell'Achille beniano, con tutte le sue implicazioni
filosofiche e teatrologiche e la sua passione per la morte/ricordo, trovi spunto nel
mito stesso. Il rimpianto dell'eroe di non aver amato Pentesilea da viva, di averla
combattuta, il suo vano e patetico tentativo di amarla da morta fanno il paio
nell'opera beniana con l'incapacità dell'eroe di accettare lo scorrere del tempo,
con il suo vivere in un passato necrotico.
Necrofilo dunque, necrofilo e in-vulnerabile
Ritorniamo alla questione dei titoli e della loro valenza simbolica. Tralasciando
le due versioni/'momenti' di Pentesilea la macchina attoriale – attorialità della macchina,
possiamo constatare che gli altri titoli delle varianti dell'Achilleide beniana si fondano su un’opposizione morfologica e simbolica: la vulnerabile invulnerabilità di
Achille ('93) e l'In-vulnerabilità del medesimo ('97), con il prefisso “in” separato da
un trattino dal resto della parola. Per quanto riguarda invece i sottotitoli, un semplice inciso tra parentesi, che recita: “tra Sciro e Ilio”, caratterizza la ripresa televisiva del '97; mentre per lo spettacolo del 2000 il sottotitolo muta in: “impossibile
suite tra Sciro e Ilio”.
Questa “In (trattino) vulnerabilità” dell'eroe beniano forse sta ad intendere non solo o non semplicemente - il contrario di una invincibilità, che a conti fatti si
rivela semplicemente nominale per il povero Achille (pur sempre destinato a brevissima esistenza, ma di questo aspetto parleremo più avanti), ma paraetimologicamente - in un gioco linguistico che auspichiamo non sarebbe spiaciuto
a Bene - sta forse a indicare lo stare in una ferita, l'essere per e nella ferita, la ferita
tra due realtà polarmente opposte, la ferita tra “Sciro” e “Ilio” appunto. Essere
nella piaga, questa sì irricucibile e inguaribile, che si forma quando la mente cerca
di recuperare una condizione di edenica felicità. Lo sforzo di ricordare, e in tal
maniera recuperare (nella vana speranza di poterlo addirittura rivivere) un momento di spensieratezza, di ludico puerile erotismo, di omoerotica sensualità adolescenziale genera rappresentazione, quella rappresentazione che per l'artista pugliese è sempre un male, è il malessere del teatro in quanto illusione di verità, in
quanto sedicente specchio di una verità testuale (mentale o eidetica), sussunzione
del fenomeno-teatro nella trinità testo-spettacolo-pubblico. La ferita nella quale
sprofonda l'Achille beniano è il ricordo, inteso come fallimentare rappresentazione
della 'fanciullezza' (in sé ri-presentazione, quindi falso tentativo di rivivere o far
rivivere sulla scena un passato oramai perduto, “vanito” come direbbe Bene). A
questo proposito si legga quanto dice Goffredo Fofi: “Achille o Amleto sono la
Il mythos dell'Eacide ne L'In-vulnerabilità di Achille di Carmelo Bene
63
dimostrazione del fallimento, ora alto e ora comune”.6 È in ragione di questa messa
in scena del fallimento della rappresentazione che Bene può affermare che egli ha
voluto mettere in scena con l'In-vulnerabilità di Achille “la crisi del teatro”:
Non ci sono personaggi, non c'è qualcuno che li interpreta, non c'è una storia. È il superamento di tutto: questo teatro non è più... ho vergogna di entrare in scena, in una
scena che stupidamente è considerata ancora come luogo di rappresentazione. Ma
rappresentazione di cosa? Di chi?... Finché si penserà al teatro come a un raduno
mondano, per assistere alla recita di gente imparruccata, che ha imparato a memoria
il testo di chissà chi, per scodellarlo a una platea di gente, che si alza presto al mattino e che quindi la sera ha voglia di dormire, la crisi del teatro sarà perenne.7
Il ricordo suppura implacabile tra il “lembo di carne” uomo e il lembo di carne
bambino; la ferita non si rimargina e la piaga produce mostri, simulacri del corporicordo. Negli appunti leggiamo: “N.B. = il contadino Achille scava in un cimiterodeserto a cercare, ricordare dove è [(ha)-fu] sepolto la sua Deidamia-bambina = il
suo proprio essere 'stato' Lui-Bambina”.8
È un autentico sparagmos questo beniano, folle scomposizione del divino fanciullo operata dalla memoria e dal tempo, impossibile ricomposizione dei disiecta
membra del passato. Ancora negli appunti si legge: “Achille eternamente colono
inglorioso – (scava a colpi di vanga) e via via dalla fossa risonanti emergono braccia e gambe i busti di bambole e manichini di femmine adulte insudiciati dal fango”.9
A tal proposito, in una intervista televisiva rilasciata in occasione della messa in
scena dell'In-vulnerabilità di Achille all'”Argentina” di Roma (novembre 2000), Bene
spiega in maniera sintetica, ma non per questo meno suggestiva, alcuni dei principali elementi scenografici della performance:
Achille strappa le vesti da sposa (e quelle dello sposo) per sottrarsi alle nozze con
una donna adulta, per andare a frugare quei tronchi di cadaveri e ricomporre il corpicino della Deidamia, la figliola/bambina. Quando Teti, per nasconderlo a Ulisse,
truccò Achille da bambina (infanzia felice di bambino/bambina)... Achille cerca di assemblare Deidamia ma, al contempo, quello stesso momento felice di una infanzia di
bambina. Ma i pezzi non gli tornano perché il ricordo è una nostra rappresentazione.
Da qui lo sconcerto dello spettacolo che guadagna il sublime nel ridicolo.10
Carmelo Bene, Opere: con autografia di un ritratto, Bompiani, Milano, 2002, p. 1381.
Emilia Costantini, Carmelo Bene: con i testi di Omero porto sulla scena la crisi del teatro, “Corriere della
Sera”, 19 novembre 2000, p. 37.
8 Cfr. n. 4.
9 Cfr. n. 4.
10 Cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=fojen-9yjf0> (09/13).
6
7
64
Dario Migliardi
La scelta delle fonti
La scelta delle fonti operata da Bene è indicativa del suo modo di procedere,
prediligendo le ‘minoranze’, come direbbe Deleuze: via gli autori perfettamente
inseriti nel proprio secolo, via gli autori ‘di stato’, a favore di una letteratura cosiddetta ‘minore’ e antistoricistica. Kleist, la cui produzione era stata bollata da Goethe come ‘patologica’, figlio imperfetto dell'equilibrato classicismo di stampo tedesco, ne è un vessillo perfetto:
Sapete quali sono gli autori che vanno visti nel loro secolo? Quelli detti Maggiori,
Goethe per esempio: non lo si può vedere al di fuori della Germania del suo tempo
oppure, se abbandona il suo tempo, è per raggiungere subito l'eterno. Ma i veri
grandi autori sono i minori, gli intempestivi. È il minore che dà i capolavori veri, il
minore non interpreta il suo tempo, l'uomo non ha un tempo determinato, il tempo
dipende dall'uomo: Francois Villon, Kleist o Laforgue.11
Al contempo, per Bene, i maggiori devono esser trattati come fossero minori,
esser ridotti alla minorità del divenire, affinché venga loro strappato il turgore
museale del ‘classico’ e siano restituiti al loro momento ideativo – ‘genesico’ (come
direbbe Artaud), affinché da essi suppurino nuove significazioni. Deleuze in proposito ci dice: “Non è dunque molto interessante far subire ad autori considerati
maggiori un trattamento da autore minore, per ritrovare le loro potenzialità di
divenire?”.12
Bene problematizza il classico dunque, mettendolo in comunicazione con le sue
declinazioni e varianti letterarie. Un procedimento dissacratorio ma al contempo
eminentemente filologico. Per quanto concerne Omero e l'Achille iliadico, ad
esempio, la scelta di Quinto, ma soprattutto di Stazio come fonte letteraria è davvero illuminante da questo punto di vista.
L'Achilleide di Stazio (95 d. C.) è un poema incompleto che offre un ritratto inedito dell'eroe acheo, un ritratto in contrasto soprattutto con l'immagine che di
Achille ci ha trasmesso l'Iliade. Nel modello omerico l'Eacide era il paradigma
dell'ideale eroico e di un sistema di valori sentito come alternativo alla dimensione
affettiva privata, tra cui le mollezze dell'eros ma anche quelle degli affetti familiari.
Stazio, per quanto progettasse di scrivere un poema che narrasse tutto l'arco esistenziale di Achille, compresa la sua vita oltremondana,13 ci ha lasciato in realtà il
racconto della sola fanciullezza del Pelide, dello sbocciare del suo primo amore e
Carmelo Bene, Gilles Deleuze, Sovrapposizioni, Quodlibet, Macerata, 2002, p. 91.
Ibid.
13 Come suggerisce lo studioso Giampiero Rosati, traccia del più vasto progetto di Stazio può forse rinvenirsi nella gelosia di Deidamia per un possibile innamoramento tra Achille e Elena. Sappiamo, infatti,
che esisteva una variante del mito che prevedeva appunto le nozze oltremondane tra Achille e Elena. Cfr.
Giampiero Rosati, Introduzione in Publio Papinio Stazio, Achilleide, Rizzoli, Milano, 1994, pp. 56-57.
11
12
Il mythos dell'Eacide ne L'In-vulnerabilità di Achille di Carmelo Bene
65
del forte legame con la madre Teti. Abbiamo dunque un'opera che descrive un
Achille non più bambino ma nemmeno uomo. Egli vive un'età ambigua, di transizione fra l'infanzia e l'età adulta: il suo bilicare tra le due età confinanti diviene il
suo carattere precipuo. Questa ambiguità è di natura caratteriale e fisica ed è l'elemento che permette alla madre Teti di mettere in atto il suo furtum ai danni di Licomede re di Sciro, facendo indossare a suo figlio le vesti di donna. Tuttavia quella
del figlio travestito sarà una femminilità non piena, ma anch'essa di confine: una
fanciulla dai tratti un po' maschili, una ragazza non ancora del tutto femminile,
come lo sono del resto le stesse figlie di Licomede. Deidamia, infatti, la cui bellezza
è paragonata a quella di Diana, non è priva di una certa severità o energico piglio
mascolino.14
Dunque nell'opera beniana, la ferita, la scissione di cui si è parlato in precedenza, non è solo simbolica ma potremmo dire che si articola, anche da un punto di
vista filologico, in rapporto alle fonti. Da un lato abbiamo dunque la Sciro edenica
di Stazio, ossia uno spazio in cui gli affetti familiari e le gioie della fanciullezza
prevalgono sui tratti bellicosi e aggressivi dell'eroe omerico,15 così come i primi
turbamenti emotivi ne addolciscono quello che sarà l'indomito e ferino carattere
rendendone fascinosamente incerta perfino la stessa identificazione sessuale;
dall’altro lato abbiamo invece la Ilio di Kleist e Omero in cui l’efebico fanciullo
staziano ha lasciato il posto a un sanguinario e capriccioso guerriero.
A Sciro il piacere si consuma nello sconfinamento dei generi e il rapporto tra
l’eroe e la madre è molto forte soprattutto da un punto di vista fisico.16
La scena del travestimento dell'Eacide è estremamente indicativa sia della dimensione di ambiguità nella quale questi è presentato nel poema staziano sia del
forte ascendente che la madre esercita su di lui. Teti, nel passo in questione, mette
in atto un sublime gioco di seduzione: la dea trucca il figlio sulla spiaggia di Sciro
proprio mentre su quella stessa spiaggia stanno danzando le figlie di Licomede, tra
le quali spicca Deidamia. Teti convince Achille a indossare le vesti femminili, a
mitigare l'asprezza del suo portamento grazie soprattutto alla visione della figlia
del re di Sciro che attira l'attenzione del giovane Achille. La fanciulla suscita turbamento nell'animo dell'eroe, un incomprensibile turbamento che trova uno sbocco
inizialmente in una sorta di ansia mimetica, nel desiderio del ragazzo di mischiarsi
alle fanciulle e ai loro giochi. Il mutamento di atteggiamento di Achille è molto
Stat. Achil. 1, 283-346.
Teti rimprovera Chirone di aver lasciato che il suo “bambino”, letteralmente “puer”, si allontanasse dall'egida del vecchio centauro, ma lo stesso Chirone ammirato e paterno ricompone i capelli
scarmigliati del fanciullo e gli accarezza il petto e le spalle (ivi, 126-128).
16 Achille abbraccia la madre sulla soglia della grotta di Chirone con commovente abbandono, lascia
immediatamente il bottino della sua crudele caccia - cuccioli di leonessa - per cingere Teti “fra le sue
braccia ardenti”(ivi, 167-173).
14
15
66
Dario Migliardi
suggestivo: dall'iniziale ritrosia egli passa alla voglia “di esser costretto”, “e chi lo
guarda rimane ingannato dall'incertezza del sesso”.17
Altrettanto indicativo dell’idilliaca, trans-generica felicità insulare, è, in Stazio,
il gioco di reciproca seduzione che sorge spontaneo tra Deidamia e Achille appena
quest’ultimo è accolto, fanciulla tra le fanciulle, nella casa di Licomede: il giovane
eroe travestito insegna alla ragazza i canti avventurosi e la inizia al suono della
cetra, mentre ella a sua volta ne corregge il portamento e gli insegna a filare la lana.
Di gioco si tratta, di gioco di bambini, un gioco che procede anche a colpi di ghirlanda e di tirso.18 A questo proposito, la ripresa Beniana ‒ nella versione televisiva
del '97 ‒ del colpo di tirso è geniale: l’attore sintetizza magistralmente il ludico e
ambiguo corteggiamento tra i fanciulli presente nel poemetto latino, o meglio, lo
sintetizza trasfigurandolo in mero ricordo grazie all'inanità di un gesto meccanico,
compiuto con stolido abbandono.
Se nell’isola di Licomede c’è ancora posto per i giochi, per un ludus erotico
spensierato, a Ilio si respira tutt’altra aria. Qui abbiamo un Achille oramai uomo
fatto, per quanto ancora giovanissimo; un soldato che ha abbondantemente dimostrato il suo valore (siamo all'indomani dell'uccisione di Ettore nella Pentesilea di
Kleist) sia in guerra che in amore, o più propriamente nelle imprese erotiche. A
Deidamia hanno fatto seguito, si suppone, le 'spose di guerra' e in primis Briseide,
ma è interessante notare come la stessa Deidamia possa essere considerata un premio di guerra se, come suggerisce la studiosa Katherine Callen King, identifichiamo la Sciro saccheggiata dal giovane Pelide, in Omero, Il. 9, 668, con la città di Licomede e Deidamia e non con un'omonima località di cui sarebbe stato re un certo
Enieo.19 Un Achille eroe di guerra dunque, solingo, non certo dedito agli sdilinquimenti di Afrodite se non nella misura della conquista, del saccheggio, del premio di guerra appunto, un guerriero dall'armatura scintillante che oltretutto si fa
un vanto, nell’opera di Kleist, di non essere mai stato respinto da alcuna donna: “Io
non fui mai respinto dalle femmine piacenti. Se a costei mi rifiuto è perché ancora
non ho trovato tra le fronde un deserto dove come lei brama a questo petto di ferro
in un bruciante amplesso stringerla”.20
La seduzione del resto, in Kleist, passa attraverso la violenza della guerra: l'altro è
un territorio da espugnare, saccheggiare. Per quanto i caratteri degli eroi siano affini,
non v'è posto per unioni idilliache di sorta. I giochi dei grandi sono mortali, passano
attraverso il ferro delle spade e delle lance; l'amore qui ha la sua massima punta di
realizzazione nell'uccisione dell'amato, l'amore è un atto antropofago.
Ivi, 335-337.
Ivi, 560-583.
19 King, Achilles, cit., p. 178.
20 Bene, Opere, cit., p. 1339 e cfr. H. Von Kleist, Pentesilea, Einaudi, Torino, 1989, p. 20.
17
18
Il mythos dell'Eacide ne L'In-vulnerabilità di Achille di Carmelo Bene
67
I sessi sono definitivamente separati. Il femminino si riconosce nell'incontro con
l'uomo, nel suo assoggettarsi al dominio del maschio, ma questo stesso dominio è
effimero e la resa è un momentaneo vaneggiamento del guerriero. Pentesilea in
Kleist si pasce del corpo dell'altro, tuttavia anche in questo gesto non v'è simbolica
unione, bensì annullamento dell'individuo, di entrambi gli individui: divorante e
divorato.21 In Bene l'epilogo antropofagico è irrilevante: Pentesilea, “casalinga perfetta”, come la definisce l'artista nei suoi appunti, è letale in quanto alternativa
borghese e adulta alla felicità irrecuperabile della fanciullezza del bambino/bambina.
In-vulnerabile bambino
Il problema del rapporto tra età adulta e divina fanciullezza è cruciale nell'ultimo Bene. Egli ci dice, infatti, che negli adulti (come negli attori, giacché il dramma
degli attori è proprio quello di essere cresciuti) la scissione tra maschio e femmina,
condannati a caratteri sessuali, cancella da una parte l'erotismo (che Bene esplica
con il concetto deleuziano di “ripetizione” come “differenza senza concetto”, ossia
come l'indeterminato, ciò che vive sulla e per la maschera e non sotto di essa, ciò
che va quindi al di là dell'identificazione del genere), dall'altra “l'osceno” come
“eccesso del desiderio” (fuori scena, fuori di sé, emorragia dell'immaginazione).22
Ma al di là dell'armamentario concettuale di derivazione deleuziana, gli adulti
per Carmelo Bene (e in parallelo ancora gli attori) hanno dimenticato di dimenticarsi, perché hanno conosciuto il linguaggio, la parola, la legge, ed avvizziscono
nel circo della nomenclatura, nella giostra dei nomi. Bene in proposito ci dice:
“L'infanzia bambina è afasia del nominare, è il venir meno della parola… Bambina
presente = donna assente = parola che nel dirsi vien meno”.23
Questo ci riporta all'importanza che ha per Bene la condizione di estrema giovinezza e paradossale fragilità che caratterizza il personaggio di Achille, a conti
21 Nel mondo greco l'omofagia contrassegnava lo stato selvaggio e bestiale in contrapposizione al modello di civiltà offerto dalla polis, ma soprattutto sanciva l'oblio di dike, la giustizia, che costituisce un limen
indispensabile, superato il quale l'uomo subisce un vero e proprio processo di imbestiamento. In Omero,
almeno per quanto concerne Achille, v'è un solo passo che lascia intravedere scabrosi scenari omofagici. Si
tratta in realtà solo di una crudele ipotesi, una raccapricciante alternativa che l'Eacide spietato offre all'immaginazione di un Ettore morente che lo supplica di restituire il suo cadavere a degna sepoltura: “Non
starmi, cane, a pregare per ginocchia e per genitori! / Mi bastassero animo e rabbia a sbranare e divorare /
io stesso le tue carni crude, per quello che hai fatto” (Il. 22, 345-347, trad. a cura di Giovanni Cerri in Omero, Iliade, Rizzoli, Milano, 2008.) Cfr. Valeria Andò, Cannibalismo e antropopoiesi nella poesia iliadica, in Valeria
Andò, Nicola Cusumano, Come bestie? Forme e paradossi della violenza tra mondo antico e disagio contemporaneo,
Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2010, p. 4.
22 Bene, Opere, cit., p. 1039.
23 Ivi, p. 1047.
68
Dario Migliardi
fatti, nelle sue varie declinazioni letterarie. Un fanciullo costretto dal mito e dal
proprio destino eroico a doversi precipitare nel mondo degli adulti.
Dall'Iliade sappiamo che, al momento della partenza per la guerra di Troia (è
Fenice, precettore di Achille, a raccontarlo in Il. 9, 440-441), l'eroe era poco più che
un ragazzino, per l'esattezza: “ancora un ragazzo inesperto di guerra crudele”.
Tuttavia, anche se nove anni di conflitto e dodici città saccheggiate gli hanno permesso di prendere definitivamente il suo posto tra gli andres (uomini), nel poema
omerico è sempre circonfuso come da un'aura di estrema giovinezza.
Lo stesso Patroclo, suo fedele compagno e confidente, è dipinto da Omero come
più anziano di lui. Ma, in buona parte, è la madre Teti a mettere in evidenza l'estrema giovinezza di Achille e, soprattutto, la brevità della sua esistenza. Teti a
colloquio con Zeus definisce il figlio come colui “che a più breve vita fra tutti è
nato”.24 Ma se in Omero la brevità della vita è direttamente proporzionale alla
grandezza e agli onori che si possono ottenere morendo giovani in battaglia, in
Bene ‒ che mutua da Stazio l'episodio (assente in Omero) dell'immersione parziale
del corpo di Achille da parte di Teti nello Stige con l’intento di renderlo immune al
proprio destino mortale ‒ la caducità dell'esistenza di Achille è una sorta di dolente
Leitmotiv.
Gli evanescenti simulacri ora di Teti ora di Achille stesso, che brulicano nei versi dell'attore pugliese evocati scenicamente dalla sua complessa e ricca modulazione vocale ‒ ora in presa diretta, ora come voci fuori campo ‒ sottolineano più volte
la sfortunata condizione dell'Eacide: egli è dotato di una divinità bastarda che gli
deriva dall'essere divino per parte di madre.25 In Bene l'eroe sente questa terribile
vulnerabilità, anche al disotto delle armi forgiate per lui dal divino Efesto:
Madre un dio mi ha forgiato le armi
immortali le armi immortali
ma terribile sento
penetrare le mosche
ne le piaghe del ferro brulicare
vermi sfigura il corpo.26
Persa la condizione di edenica fanciullezza nella terra di Sciro, l'Achille beniano
è abbandonato a una fragile età adulta che non gli appartiene, che egli rifiuta. Solo,
davanti alle responsabilità che l'incontro col femminino adulto implica, malde-
24 Cfr. Il. 1, 505-506. Teti accorre a consolare il figlio allorquando questi si lamenta d'esser stato depredato da Agamennone del suo premio di guerra Briseide ed aggiunge al suo lamento il proprio rimpianto di madre consapevole del nefasto destino della sua prole.
25 Nella cultura greca vigeva la concezione della donna come mero contenitore del seme dell'uomo
che era il vero donatore della vita. Cfr. Aesch. Eum. 657-666; Eur. Or. 552-554.
26 Bene, Opere, cit., p. 1336.
Il mythos dell'Eacide ne L'In-vulnerabilità di Achille di Carmelo Bene
69
stramente e in maniera ridicolmente sublime, egli affronta la furia di Pentesilea, la
donna con le sue impossibili nozze di sangue.
Achille in scena
Risultando impossibile, in questa sede, un puntuale confronto tra il lavoro
dell’attore pugliese sulle fonti letterarie relative al mito di Achille e Pentesilea e le
varie elaborazioni sceniche delle performance che ne sono scaturite, lo spettacolo
televisivo del ’97 può essere considerato un punto di riferimento, una sorta di banco di prova delle riflessioni contenute nel presente intervento, in ragione della sostanziale coincidenza del suo ordito versificatorio con il testo a stampa del ‘93 e per
la sua prossimità formale – gestione dello spazio scenico, suono etc. - con lo spettacolo del 2000 all’”Argentina” di Roma.
Nell’In-vulnerabilità di Achille la dicotomia tra le due realtà inconciliabili di Sciro
e Ilio, tra infanzia perduta e età adulta, tra continuità transgenere e castrante codificazione dell’identità di genere è scenicamente sottolineata, per quanto riguarda
Ilio, dalla presenza, sul fondo della scena, di due servi muti che sorreggono i simulacri di uno sposo e di una sposa: la giacca di un elegante frac nero, un classico
abito bianco da sposa. Ilio come fantasma di una unione impossibile, una dimensione domestica, adulta e borghese, una sorta di paradossale richiamo dell’uomo ai
suoi doveri, alla guerra coniugale, all’abbandono di un eros ludico e spensierato.
Sciro invece è richiamata dal piccolo arsenale protesico che campeggia al centro
della scena, parti di un manichino femminile (una testa, un tronco, una mano, un
braccio etc.). Sono le vestigia mnemoniche dell’infanzia di Achille, frammenti di
ricordi perduti nel tempo: il corpo di Deidamia fanciulla ancora troppo giovane
per esser ingabbiata in corpo di donna, nonché il fanciullo Achille anch’egli
nell’incertezza somatica dell’età che non fa di lui un mero uomo tra gli uomini. Ma
il manichino assume anche un altro significato, sul versante opposto a quello di
Sciro: addobbato con l’abito da sposa, ricomposto in forma muliebre, esso costituisce, verso il finale dello spettacolo, il minaccioso simulacro di Pentesilea stessa,
l’amazzone antropofaga, la sposa borghese, la “perfetta casalinga” che di tanto in
tanto si solleva a sedere (un meccanismo di scena permette al manichino di passare
dalla posizione supina a quella seduta per alcuni secondi e a intervalli regolari),
per osservare lo sposo recalcitrante e neghittoso, a tratti spaurito dall’invisibile
piglio severo della moglie assassina.
Un suono di acqua che scorre apre lo spettacolo: si tratta del mare che circonda
Sciro, ma anche delle onde increspate dalla nave achea su cui l’Itacese, come nel
finale dell’Achilleide di Stazio, conduce Achille alla morte adulta in Ilio. Ma il lieve,
equoreo sciabordio simboleggia anche la fragilità dell’eroe Achille, la caducità della sua esistenza mitica, la sua estrema, disarmante giovinezza, la sua paradossale
mortale immortalità. Sono le acque dello Stige in cui la Teti staziana ha immerso il
70
Dario Migliardi
frutto del suo grembo ancora acerbo per donargli un’eternità imperfetta; si tratta
della causa primaria della maladresse di Achille, che non a caso si autodefinisce
“mai finito Malnato”.
Carmelo Bene/Achille con indosso una camicia bianca e un cravattino nero, seduto in mezzo alla scena armeggia con il suo passato componendo e scomponendo
impossibili ricordi con i pezzi di manichino a disposizione. Vengono fuori improbabili e inquietanti aborti, che l’attore osserva tra la rassegnazione e il disgusto, il
terrore e la sorpresa. Per ben due volte l’Achille beniano indossa la giacca di frac
che si trova sul fondo della scena: è lo stolido tentativo di divenir uomo, di assumersi le responsabilità dell’età adulta.
Tuttavia la trasfigurazione è sistematicamente minata dallo stesso attore: questi
dopo poco si toglie l’odioso indumento tentando al contempo, in maniera ridicolmente sublime, di svestire lo stesso manichino/Pentesilea per riportarlo alla sua
innocua natura di inerme surrogato umano. L'elemento della svestizione della
sposa adulta/Pentesilea è una ripresa in chiave di rovesciamento parodico delle sue
fonti, sia di Quinto, che ci descrive Achille che resta folgorato dalla bellezza della
morta amazzone quando le toglie l’elmo, sia di Kleist, che riprende Quinto ma con
maggior audacia, consentendo al suo Achille addirittura di slacciare la lorica alla
regina svenuta: “ACHILLE: (slacciando l'armatura alla regina) Non vive più”.27
27
Kleist, Pentesilea, cit., p. 46.
ANNA VINCIGUERRA
ORGHAST DI PETER BROOK E TED HUGHES: IL MITO RISCRITTO
È cara a Peter Brook la riflessione sulla rappresentazione teatrale che non
diventa ripetizione, ma che tiene conto di chi compie l’azione e di chi la osserva. La
liberazione dalla ripetitività del quotidiano e dal sistema di repliche porta a
rintracciare i segni originari della modalità espressiva dentro di sé e attraverso gli
altri. Il recupero dell’essenziale, attraverso il triangolo che sta alla base del teatro
(attore - spazio scenico - spettatore), ha condotto Brook al confronto con la
trasposizione scenica del mito, meno accessibile, secondo lui, allo spettatore, carico
di quella giusta distanza utile all’assimilazione e distante da implicazioni che il
racconto di un fatto di cronaca o di un avvenimento temporalmente più vicino può
originare.1
Nel 1965 Peter Brook richiese a Robert Lowell la traduzione della versione di
Eschilo del mito di Prometeo, accantonato poco dopo in favore dell’Edipo di
Seneca, adattato dal poeta Ted Hughes. Con quest’ultimo si sarebbe incontrato
qualche anno più tardi per analizzare e ri-scrivere miti contaminati con segni della
scena, attraverso un linguaggio asintattico e forme di teatro popolare, volte a
instaurare un tipo di comunicazione rituale più che teatrale.2 Orghast veniva messo
in scena nell’agosto del 1971 nell’ambito del Festival di Shiraz-Persepoli:3 è il
racconto di episodi frammentati, che non riguardano un personaggio o una
vicenda in particolare, ma la condizione umana nella sua interezza.
Nel programma di sala, Peter Brook lo presentava in questi termini:
Orghast nasce da determinati miti di base – il dono del fuoco, il massacro degli innocenti, l’imprigionamento del figlio da parte del padre, la ricerca della liberazione nella vendetta, la distruzione del tiranno da parte del figlio e la ricerca della liberazione
attraverso la conoscenza – quali vediamo rispecchiati negli inni di Zoroastro, nelle
storie di Ercole e di Prometeo, ne La vita è sogno di Calderon, nelle leggende persiane
e in altre analoghe fonti.4
Se posizioniamo Orghast lungo la linea del percorso creativo di Peter Brook, lo
ritroviamo nella fase avviata dal regista intorno alla metà degli anni Sessanta
Peter Brook, Il punto in movimento. 1946-1987, Ubulibri, Milano, 2005.
Stefano Locatelli, “Lo spettatore in Orghast di Peter Brook”,
<http://promo.piccoloteatro.org/elementi/articolo.php?idRub=5&news=130> (09/13).
3 Manifestazione a cadenza annuale che aveva luogo nelle zone intorno le città di Shiraz e Persepoli
negli anni tra il 1967 e il 1977. Il Festival di Shiraz-Persepoli ha svolto un’importante funzione nello
sviluppo dei rapporti artistici tra Oriente e Occidente.
4 Anthony C. H. Smith, Teatro come invenzione. Orghast di Peter Brook e Ted Hughes, Feltrinelli,
Milano, 1974, p. 179.
1
2
72
Anna Vinciguerra
(1965), con i primi esperimenti, sostenuti dalla “Royal Shakespeare Company”, dal
“Teatro della Crudeltà”, passando per l’esperienza al “Théâtre des Nations” su
chiamata di Jean Louis Barrault, poi sfociata nella formazione del CIRT, il “Centro
Internazionale di Ricerca Teatrale”. Quest’ultimo, sulla scia delle esperienze
precedenti, nasce dall’idea di mettere insieme attori provenienti da diversi Paesi
che, nel lavoro quotidiano, abbiano il compito di indagare forme di comunicazione
non esclusivamente verbali, costruendo così un linguaggio unitario e universale,
distante da quello in cui vengono alla luce le differenze.
A partire dal primo incontro, al “Mobilier National” di Parigi (novembre 1970),
degli attori che formavano il nucleo di quella che sarebbe diventata la compagnia
definitiva dello spettacolo,5 Orghast si preparava a diventare un esempio di teatro
che indaga e che non si ripete, in cui la scrittura scenica è in continuo divenire.
Brook chiedeva ai suoi attori di abbandonare le proprie storie, di diventare senza
memoria né passato; li conduceva, come avrebbe notato qualche anno più tardi lo
stesso Hughes, in un “pellegrinaggio interiore verso il vero sé, l’origine del vero
essere” e contemporaneamente esplorava “un mondo esterno fatto di collisioni,
conflitto e passione animale: l’inesauribile abbondanza del mondo profano”.6 Il
lavoro di quel periodo su La vita è sogno (1635), di Calderon de la Barca, e Kaspar
(1968) di Peter Handke, non era casuale. Senza addentrarci nelle trame, basterà
notare che la figura che unisce i due protagonisti delle pièces è quella di un
prigioniero, inteso in senso letterale o metaforico, che ci mostra, come nel caso di
Sigismondo, l’ambiguità della libertà nella lotta tra realtà/sogno – verità/invenzione
e che si sofferma, come nel caso di Kaspar, sul ruolo della parola come strumento
di formazione nell’esperienza umana. I due personaggi, disorientati, primitivi e
ineducati al linguaggio, sarebbero stati un riferimento per Ted Hughes e guide
iniziali per gli attori nell’analisi di una comunicazione fatta di azioni, suoni e gesti,
che va oltre le implicazioni semantiche.
Procedendo per livelli, il primo approccio che abbiamo con lo spettacolo è nel
titolo: Orghast non è riconducibile a una vicenda, a un luogo, a un protagonista.
‘Orghast’ è il nome della lingua inventata da Ted Hughes. Sappiamo dall’autore
5 La compagnia di attori che recitò in Orghast era così formata: N. Azadi (Persia), M. Bagayogo
(Mali), F. Baver (Persia), M. Collison (USA), C. Confortès (Francia), S. Corthay (Francia), D. Farhang
(Persia), M. Ghaffari (Persia), H. Ghovalou (Persia), D. Kamwa (Camerun), A. Katsulas (USA), R. Lloyd
(Inghilterra), P. Matta (Spagna), J. Mota (Portogallo), P. Munro (Inghilterra), B. Myers (Inghilterra), K.
Oida (Giappone), S. Oveysi (Persia), N. Parry (Inghilterra), P. Porhosseini (Persia), S. Tahmoures
(Persia), I. Worth (Inghilterra), S. Zahed (Persia), L. Zeldis (USA). All’autore Ted Hughes e al regista
Peter Brook si aggiungevano gli scenografi Eugene Lee (USA), Franne Lee (USA) e Jean Monod
(Svizzera), il compositore Richard Peaslee (USA) e gli assistenti alla regia A. Ovanessian (Persia), G.
Reeves (Inghilterra), A. Serban (Romania).
6 Ted Hughes, “Orghast: il pellegrinaggio verso il vero sé”, in Georges Banu e Alessandro Martinez
(a cura di), Gli anni di Peter Brook: l'opera di un maestro raccontata al Premio Europa per il Teatro, Ubulibri,
Milano, 1990.
Orghast di Peter Brook e Ted Hughes: il mito riscritto
73
che il nome è composto di due sequenze: ‘Or-‘, inteso come ‘Vita, Essere’ e ‘Ghast’,
‘Spirito, Fiamma’. ‘OrGhast’ rappresenterebbe quindi la ‘Fiamma dell’Essere’,
l’origine di ogni cosa. La scelta di porre in primo piano la lingua rispetto a ciò che
si racconta mette in risalto l’azione stessa della creazione di un linguaggio uguale
per tutti perché posto oltre la sfera del significato. Si tratta di una lingua che
risponde alla regola del comunicare prima di comprendere, che non è traducibile e
non va interpretata in ogni suono che la costituisce. A questo proposito Hughes
dice: “Quando le poesie vengono spiegate preliminarmente non ci si apre con
l’immaginazione alle parole. Ogni parola in Orghast ha una sua storia, ma sarebbe
molto scolastico ripercorrerla ogni volta. Credere che tutta l’arte sia spiegabile
razionalmente e che si possa dar conto di tutto vorrebbe dire fare il gioco dei
critici”.7 La lingua ‘orghast’ nasceva dall’idea di Hughes del disseppellimento,
secondo cui tanto più si scava nel linguaggio, tanto meno la metaforicità è visibile:
al di sotto di una comprensione razionale esiste un significato metaforico che può
essere condiviso universalmente.
Riprendendo la teoria di Claude Lévi-Strauss, secondo il quale la struttura dei
miti si svela per mezzo di partiture,8 Ted Hughes fu guidato nella scrittura
dall’accostamento con la musica, sul piano dei linguaggi che trascendono
l’espressione articolata. A discapito di una comprensione razionale, quindi, Hughes
preservava un suono dettato da associazioni immediate. Esortato da Brook, egli era
spinto a creare una lingua fatta di suoni e toni, libera da significati concettuali, una
lingua depurata, che corrispondesse a un mondo semibarbarico, inteso come privo
di strutture. Partendo da alcuni suoni che definiva “fisiologicamente giustificati”,
Hughes costruiva un glossario di macrocampi esplorativi, fatto di segmenti fissi e
suffissi mobili. Le uniche indicazioni fornite agli attori riguardavano le modalità
con cui leggere quei suoni, nati per essere dilatati, urlati, sussurrati. In linea con
questa idea Brook riportò nel programma di sala un passo tratto dal suo testo Il
teatro e il suo spazio:
La parola non comincia a esistere come tale, ma è un prodotto finito che nasce come
impulso, stimolato dall’atteggiamento e dal comportamento; e sono appunto questi
che impongono l’espressione. Tale processo si verifica nell’intimo del drammaturgo e
si ripete nell’intimo dell’attore. Può anche darsi che sia l’uno che l’altro siano consci
soltanto delle parole, ma tanto per l’autore quanto, in seguito, per l’attore, la parola
non è che una minuscola parte visibile di una gigantesca formazione invisibile ...
l’unico modo di trovare la vera via alla dizione di una parola consiste in un processo
che corre parallelamente al processo creativo originale.9
Smith, Teatro come invenzione, cit., p. 179.
Per l’accostamento del mito alla musica, cfr. Claude Lévi-Strauss, Mito e significato. Cinque
conversazioni radiofoniche, Il Saggiatore, Milano, 2010, pp. 57-64 e Claude Lévi-Strauss, Il crudo e il cotto, Il
Saggiatore, Milano, 1966, pp. 25-28.
9 Peter Brook, Il teatro e il suo spazio, Feltrinelli, Milano, 1968, pp. 15-16.
7
8
74
Anna Vinciguerra
Orghast riscrive i miti, ma ancor prima li utilizza come pretesto per riflettere
sulla parola e sulla distinzione tra lingua e linguaggio, in una messinscena che
combina le strutture sonore inventate da Hughes agli effetti musicali e ‘suoni
organizzati’ rintracciati da Richard Peaslee, insieme con le parole riprese dal greco
antico e dall’avestico, la lingua dello zoroastrismo. Orghast è un invito a esplorare i
segni dell’azione teatrale, nel teatro verbale e non verbale, e cerca di individuare la
posizione del gesto trasformato in parola, intesa come vibrazione, concetto, musica,
più che come parte di un codice linguistico.
Ted Hughes non forniva traduzione del testo agli attori, ma muniva loro di un
glossario fatto di sillabe ritmiche, istintivi riconoscimenti di uno stato mentale,
avvertiti come frammenti di un’unità centrale. L’unità spezzata, creata dall’autore e
da lui disegnata per gli attori, è ‘Pramanath’ (da Prometeo), il divino in forma
umana. È luce, fuoco creatore, ma internamente è diviso, consapevole dell’eternità
che deve vivere nel tempo.
Il corpo di Pramanath secondo la figurazione di Hughes rappresenta un
conflitto, destinato a perpetuarsi senza prospettiva di risoluzione. Conflitto inteso
come padre di ogni cosa, principio che determina chi sono gli dei, chi gli uomini e,
tra questi, quali prigionieri e quali liberi. Il conflitto, che Pramanath racconta
attraverso la matita di Hughes, si concretizza nella lotta tra ‘Krogon’, la Ragione,
trasformata in uccello da preda, e ‘Moa’, fuoco distruttore, Caos e istinto10. A
generare il conflitto è ‘Hoan’, la ‘Luce creatrice’, che comprende tutto e conserva
l’armonia, che esternamente al corpo esiste in forma pura mentre, al suo interno, si
articola nelle forme degradate che da essa discendono: ‘Moasha’ – ‘Ussa’ – ‘Furorg’.
Pramanath è contemporaneamente Uomo e Donna, sue stesse creazioni; è
un’essenza paradossale, allo stesso tempo Uno e Molti, Unione e Divisione,
incrocio tra la Luce eterna e il Dolore materiale. Ha dentro di sé, al centro, ‘Sogis’,
uno dei discendenti di Krogon, che cercherà di annientare il male e il dolore.
Imprigionato per sopravvivere alla violenza di Krogon, Sogis sarà istruito dalla
Luce, imparerà a parlare e sarà liberato per tentare la riconciliazione finale.
Parallelamente alla trascrizione del mito in linguaggio teatrale si svolgeva il
lavoro sull’attore, iniziato a Parigi attraverso la preparazione del corpo e della voce
e l’improvvisazione, combinate insieme in un linguaggio, il ‘bash/ta/hon/do’,
utilizzato solo durante le prove come strumento ritmico. Gli attori erano stati
invitati a disimparare il codice linguistico utilizzato abitualmente e a rendersi
disponibili a indagare la natura dell’espressione vivente.11 Il lavoro continuò in
Persia, anche grazie alla conoscenza degli elementi basilari della cultura locale. Lì
gli attori assistettero a rappresentazioni di teatro popolare come il ta’zieh
Nel bozzetto di Ted Hughes Krogon, la Ragione, è disegnata sulle spalle della figura, e Moa, il
Caos, è posizionato nella pancia. Si rimanda alla figura riportata in A. C. H. Smith, Teatro come
invenzione, cit., p. 77.
11 Brook, Il punto in movimento, cit., pp. 101-104.
10
Orghast di Peter Brook e Ted Hughes: il mito riscritto
75
(letteralmente ‘cordoglio’), un genere popolare religioso recitato dagli abitanti del
villaggio, e parteciparono al ruhozi, una forma di teatro/festa basata su un
canovaccio, simile alla nostra commedia dell’arte, che veniva rappresentata nei
cortili con uno stagno nel mezzo, coperto per l’occasione da tavole di legno che lo
trasformavano in palcoscenico. La compagnia di Orghast era così condotta a una
riflessione sulla condivisione di un’esperienza teatrale anche in assenza di comuni
radici culturali. “Il nostro lavoro – dice Brook – è basato sul fatto che alcuni fra gli
aspetti più significativi dell’esperienza umana possono manifestarsi attraverso i
suoni e i movimenti del corpo umano, in un modo che tocca la stessa corda in ogni
spettatore, qualunque siano i suoi condizionamenti culturali e razziali”.12 Mario
Verdone identifica la musicalità e l’internazionalità come categorie che segnalano
la ricerca di un linguaggio essenziale e collettivo, caratteristiche da lui rintracciate
in Orghast e in generale nell’edizione del 1971 del Festival di Shiraz-Persepoli, il cui
tema era il ‘teatro rituale’.13
Nell’ analisi di Verdone particolare rilievo assume la ‘cosmicità’, intesa come
partecipazione dell’ambiente paesaggistico naturale o dell’elemento ambientale
storico, che ci accompagna, nella riscrittura di un mito, alla scelta dello spazio
scenico. Brook, infatti, pensava a un luogo che potesse restituire allo stesso tempo
sacralità e potenza registica. Dopo numerosi sopralluoghi scelse, in accordo con
Jean Monod e il resto della compagnia, le necropoli dei re dell’antica Persia a
Persepoli: quei luoghi ricchi di storia e carichi di valenza rituale avrebbero
contribuito in modo naturale alla scrittura scenica. Orghast è una storia in cui il
dono del fuoco segna il passaggio dalle tenebre alla luce, dalla natura alla cultura,
dal “crudo al cotto”, per dirla come Lévi-Strauss. Rinunciando alla scenotecnica,
furono scelte due ambientazioni per due momenti di rappresentazione distinti,
scardinando le regole di linearità temporale e rendendo visibile la metafora di
tenebre e luce: la prima parte di Orghast sarebbe stata messa in scena al tramonto,
la seconda parte all’alba.
La prima parte si svolgeva intorno al mausoleo di Artaserse II a Persepoli. I
posti a sedere erano suddivisi in tre file lungo i due lati della tomba e davanti a
essa. La compagnia era riunita in un coro seduto su due file di cuscini sui quali gli
attori erano disposti uno di fronte all’altro. Un uomo è incatenato alla montagna: è
Prometeo; altri attori, più distanti, sono posizionati a diverse altezze.
Nella rappresentazione dei segni, il fuoco è l’elemento chiave: è il dono di
Prometeo agli uomini, da cui deriva il dono della sapienza, il mezzo per lo
sviluppo di arti e mestieri, quindi della civiltà. Il fuoco arriva dall’alto, viene
diffuso per mezzo di torce, adorato e utilizzato per cercare, liberare, imprigionare.
Marco De Marinis, Il nuovo teatro, 1946-1970, Bompiani, Milano, 1995, p. 110.
Mario Verdone, “Persepolis e Orghast”, in Antonella Ottai (a cura di), Teatro Oriente/Occidente,
Bulzoni, Roma, 1986, pp. 421-430.
12
13
76
Anna Vinciguerra
È la specificità dell’umano, strumento di conoscenza, unica fonte di luce nell’intero
spettacolo. Sulla scena vediamo una donna, la luce e un uomo; il coro rappresenta
le creature della terra e ci parla con un mormorio staccato, un insieme di voci
disgregate nel momento in cui il fuoco si manifesta. I movimenti sono lenti, ieratici,
costruiti per dare la misura di azioni che inesorabilmente si ripetono. È una
cerimonia segreta, a cui lo spettatore assiste senza essere fisicamente coinvolto.
Nello scorrere degli episodi così frammentati, Prometeo è solo, incatenato alla
roccia, nell’ossessione del suo dono che è un inganno, per sé e per gli uomini, che
sono invece affascinati e desiderosi di conquistarlo. Egli geme per il dolore
provocato dall’avvoltoio che mangia il suo fegato, in attesa che il sole tramonti e
che la cicatrizzazione, come tutte le notti, abbia inizio. Metaforicamente la ferita
può essere rimarginata dalla nascita di ‘Sogis’, spirito riconciliante che porta
armonia attraverso un canto intonato da ‘Agoluz’, proiezione di Sogis e della sua
forza spirituale in termini fisici e terreni. Agoluz, istruito dall’avvoltoio, è eroe
mortale, rappresentazione del fallimento dell’Uomo, condannato a non capire e a
morire ogni volta che sarà creato.
Alcune ore dopo, all’alba, davanti a un colle roccioso lungo 220 metri e alto 70,
la necropoli in cui sono scavate le tombe di Dario I e Dario II, Serse I e Artaserse I,
si svolgeva la seconda parte di Orghast. Krogon, la Ragione, vaga moribondo. Lo
vediamo comparire da un pozzo, cieco e morente, mentre attraversa la collina
rocciosa seguito da Furorg, da Ussa e da Moasha e dai parenti assassinati in cerca
di vendetta, mentre un persiano elenca i nomi dei capitani di Serse intervenuti
nella battaglia di Salamina. Un corteo di attori, vestiti con tuniche marroni, inizia a
muoversi attraverso salite e percorsi e costringe gli spettatori a seguirlo,
confondendosi con questi, in un errare continuo che diventa simbolo della
condizione umana, ora governata dal caos. Parole in greco e in avestico si
incrociano a suoni ‘orghast’ e a canti blues scritti da Peaslee, che ricordano nella
loro struttura la ciclicità della vita ed appaiono come variazioni intorno ad un
unico tema. Mentre tutte le figure scompaiono oltre il colle, tra suoni metallici e
percussioni, un uomo attraversa lo spazio scenico verso il sorgere del sole con una
vacca, simbolo della creazione e della Madre Terra nello zoroastrismo. Il dramma
giunge a compimento mentre fa giorno e le luci dell’aurora si spandono su Naqshe-Rostam. Il sole non risolve ma non nasconde, crea e dà avvio a un nuovo corso.
Possiamo immaginare che la Fiamma dell’essere, che Hughes ci ha svelato essere
contenuta in ‘Or-Ghast’, possa essere identificata nel Sole stesso.
Orghast è fatto di grida, lacrime, pianti; esprime l’impotenza dell’uomo, cieco,
alla ricerca della luce tra natura e sepolcri. Orghast è riscrittura di miti in cui colui
che crediamo essere il protagonista, Prometeo, è in realtà spettatore del dolore che
si perpetua. È un Prometeo che si lamenta ma non parla, che, da solo, osserva e
soffre. Attraverso i segni della scena, utilizzando una lingua fatta di suoni/strutture
sonore, movimenti, luci naturali, spazi, una lingua che non esiste ma di cui
Orghast di Peter Brook e Ted Hughes: il mito riscritto
77
possiamo percepire il senso, Peter Brook e Ted Hughes ci presentano un mito che si
ripete nei tempi, in uno spettacolo fatto di richiami e di simboli.
Andrew Porter scrisse, in un articolo per il “Financial Times”,14 che Orghast
rendeva gli uomini in grado di attraversare il fuoco, come una purificazione.
Orghast drammatizza l’ambiguo stato dell’uomo, riscrive il mito attraverso una
serie di contaminazioni di codici espressivi: vengono impiegati personaggi di altre
pièces teatrali; una lingua che non comprendiamo, ma che ci accompagna nella
partecipazione; un pattern musicale creato a mo' di partitura; forme teatrali
popolari e immediate; una ninnananna e un blues; gesti che raccontano, come
l’attraversamento dello spazio scenico verso il nuovo giorno.
Il tentativo di creare un linguaggio immediatamente espressivo, lontano da una
struttura razionale, non fu compreso da alcuni critici che videro una barriera
intellettuale e verbale in questa azione (Irving Wardle, “The Times”);15 altri misero
in evidenza, invece, come gli spettatori provassero una sorta di confusione nella
prima parte, cui seguiva, nella seconda parte, un coinvolgimento nell’imponente
da parte del pubblico, riconoscendo così l’alto valore rituale e teorico dell’intera
operazione.16 Nella lettura che ne diede Peter Wilson, riportata nel bollettino
ufficiale dello spettacolo, riusciamo a cogliere il senso di intima condivisione creato
in questa comunità estemporanea. Wilson riassumeva con queste parole la
sospensione tra la partecipazione reale e il valore eterno di Orghast:
Un gruppo di spettatori umani è precipitato, con una visione magica, nel mezzo di
una cerimonia dimenticata, celebrata ogni notte dagli spettri fin da quando l’ultimo
re venne chiuso nell’ultima tomba eretta in questa piana. (…) In un mondo dominato
dalla scienza, che rifiuta il mito o crede che esso non rappresenti altro che il modo in
cui l’uomo prescientifico ‘traveste’ la vera storia, la potenza del mito provoca un ritorno di fiamma. L’uomo è più che mai dominato dal mito, ma, rifiutandosi di ammetterlo, si lega a una continua ripetizione dei suoi aspetti più orrendi: invece del
deus ex machina abbiamo la macchina considerata come un dio; invece dell’Orco o del
Gigante, abbiamo la megamorte; invece della peste, la defoliazione. L’area in cui il
mito deve essere allineato con il mondo moderno è senza dubbio il teatro. Per la prima volta, e dopo molto tempo, abbiamo la sensazione di assistere a un teatro fatto di
temi esaltanti, che guarda non solo all’uomo sub-animale, ma all’uomo creatore di
miti.
Cfr. Andrew Porter, Financial Times, 11 settembre 1971.
Cfr. Irving Wardle, “Rituals in the desert: The Shiraz Festival”, The Times, 10 settembre 1971, p. 21.
16 Richard Findlater, The Observer, 12 settembre 1971 e Ossia Trilling, “Playing with words at Persepolis”, Theatre Quarterly, 5, 1972, pp. 33-41.
14
15
78
Anna Vinciguerra
Orghast di Peter Brook e Ted Hughes: il mito riscritto
Sezione II
79
80
Anna Vinciguerra
MARIA ARPAIA – ANGELA ALBANESE
Introduzione
MESSA IN SCENA DI RACCONTI E STORIE POPOLARI
DI CARATTERE FOLKLORICO
La fiaba […] è cosa da ascoltare, in cui gesto e intonazione,
mimica e pause, tengono un ruolo capitale. Ancora un passo e
diremo tranquillamente che la fiaba è un genere teatrale, che
postula un recitante e un pubblico, anche ridotto a un ascoltatore solitario.
E. Sanguineti, La donna serpente come fiaba1
L’accostamento del genere fiabesco a quello teatrale conduce necessariamente
ad una riflessione sui loro punti di contiguità più evidenti. Entrambi sono innanzitutto identificabili come spazi di finzione. Il lettore o ascoltatore instaura con il
narratore un implicito patto di “sospensione dell’incredulità”,2 dimostrandosi disposto a comportarsi ‘come se’ quello che gli viene riportato fosse vero. La dimensione della inverosimiglianza e della finzione identificano il regime fiabesco già a
partire dalla consueta formula iniziale del “c’era una volta”: questo incipit mette
subito in crisi ogni possibilità di ambientare la storia in un tempo e in uno spazio
riconoscibili: “nel momento stesso in cui il narratore della fiaba […] pronuncia la
sua prima parola – precisa Lavagetto – instaura con i propri ascoltatori o lettori un
contratto che mette in mora ogni possibile riferimento al mondo reale. […] le leggi
sono sospese; il cronotopo in pezzi; gli orologi frantumati; le distanze si dilatano o
si contraggono a piacere”.3
Purché ci si muova nel rispetto delle regole comunicative del codice, che crea
uno speciale spazio e tempo di finzione, il destinatario è disposto a farsi ingannare
e a concedersi, per tutta la durata del racconto, di credere senza reticenze a tempi
incalcolabili, luoghi inverosimili e accadimenti meravigliosi.
E lo stesso accade anche a teatro. Come il lettore di fiabe, anche il pubblico di
una rappresentazione teatrale è consapevole di partecipare ad una finzione a cui,
con la complicità degli attori, decide di aderire per tutto il tempo della messa in
scena come se si trattasse della verità. Il tempo e lo spazio del teatro, come quelli
1 La presente citazione e gli assunti teorici iniziali sono tratti dal libro di Angela Albanese,
Metamorfosi del Cunto di Basile. Traduzioni, riscritture, adattamenti, Longo, Ravenna, 2012, pp. 217-220.
2 S.T. Coleridge, Biographia Literaria, a cura di P. Colaiacomo, Editori Riuniti, Roma,1991, p. 236.
3 M. Lavagetto (a cura di), Racconti di orchi, di fate e di streghe, Mondadori, Milano, 2008, pp. XVIXVII.
82
Maria Arpaia – Angela Albanese
delle fiabe, sono anch’essi un tempo e uno spazio speciali, di sospensione delle
categorie della realtà in cui prende forma l’evento teatrale, considerato come “gioco artistico di finzione d’un vero”.4 Lo spettatore prende parte a quel gioco, accettando l’illusione teatrale e prestandosi a credere alle verità messe in scena.
Alla logica di finzione che il genere teatrale e quello fiabesco hanno in comune
si affianca la dimensione della oralità, connaturata del resto alla stessa origine orale
dei racconti di fiabe. Lo suggerisce Sanguineti nella riflessione posta in esergo,
parlando della fiaba come “cosa da ascoltare”. Le fiabe, infatti, erano originariamente scritte per essere lette o recitate ad alta voce; pertanto la forte predisposizione teatrale è connaturata all’architettura narrativa e al linguaggio. La vocazione
performativa dei testi scritti che richiedono di essere letti ad alta voce è analoga
alle componenti linguistiche ed extralinguistiche che danno forma all’evento teatrale: la voce degli attori, l’intonazione, il timbro, il gesto, la mimica, la prossemica.
Alla combinazione di tutti questi codici di scena è affidata la trasmutazione del
testo scritto nella sua rappresentazione drammatica, il passaggio dalla pagina al
palcoscenico. Questo passaggio e la sua modalità di realizzazione sono l’oggetto di
questa seconda sessione dei lavori.
L’intervento che apre la discussione lancia in modo provocatorio la questione
dell’oralità in scena, dando un’interpretazione nuova e feconda di futuri spunti di
riflessione. Stefano De Matteis, nel suo saggio Alla Gioconda si possono fare solo i baffi
(e il pizzetto), verifica le categorie della spontaneità e dell’improvvisazione alla luce
del concetto – forse troppo inclusivo – di ‘oralità’.
Partendo dal presupposto, suffragato da numerosi esempi e da personali indagini sul campo, che ogni tipo di comunicazione sia sempre e comunque un artefatto che si adatta automaticamente al contesto situazionale e allo schema comunicativo previsto, De Matteis preferisce parlare di ‘costruzione della spontaneità’. La
categoria dell’oralità dovrà allora essere intesa come un modo di dire, formulare e
non certo spontaneo: l’idea stessa della spontaneità è costruita come una sorta di
pratica, se non di voluto inganno. Ad ogni codificazione, infatti, corrisponde una
buona dose di teatralità, da cui deriva inesorabilmente un minore spazio di libertà,
d’invenzione e di reinvenzione su un modello narrativo che risulta troppo forte e
quasi “intoccabile”. Da qui il senso del titolo dell’intervento: dinanzi ad una narrazione formalizzata, con un linguaggio standardizzato e strutturato, al pari di un
capolavoro come la Gioconda, non è possibile aprire margini d’invenzione o trasformazione, ma solo di parodia, come disegnare su una sua riproduzione baffi e
pizzetto.
Alla riflessione sull’inevitabile stabilità di un testo così fortemente codificato
come quello teatrale fanno da contrappunto altri interventi di questa sessione, che
4
R. Alonge, R. Tessari, Lo spettacolo teatrale. Dal testo alla messinscena, LED, Milano, 1996, p. 13.
Messa in scena di racconti e storie popolari di carattere folklorico
83
pongono invece come fondamento proprio l’idea della consustanziale fluidità del
racconto folklorico e fiabesco.
Nel saggio Con Basile alle spalle: Le Gatte di De Simone, Angela Albanese tenta di
mettere in evidenza l’identità mobile e molteplice delle fiabe, concentrando
l’attenzione su quella di Cenerentola, la cui tradizione, anche quando è stata scritta
e codificata in una testo apparentemente ‘fisso’, è stata continuamente contaminata
dalle molteplici versioni orali e dalle diverse riformulazioni, riscritture, trasposizioni in altri codici e forme mediatiche. Partendo dalla prima versione occidentale
presente nel Cunto de li Cunti di Giambattista Basile, Albanese compie un lavoro
comparativo tra il testo barocco e la sua messa in scena del 1976 da parte di Roberto De Simone, mettendo in evidenza l’intento del drammaturgo e regista di recuperare e potenziare l’elemento tradizionale orale di cui era già imbevuto il testo basiliano. I racconti del Cunto, scritti per essere letti o recitati ad alta voce, sono di fatto
del tutto impregnati di oralità e contaminati dalle diverse riformulazioni orali che
li hanno tramandati, complice anche la forma vivace del dialetto che ne esalta il
ritmo e la virtualità performativa.
Il mondo popolare, con le sue sonorità ritmiche iterative e ancestrali, costituisce
la cifra dell’oralità trasposta in scena anche nella recitazione di Vincenzo Pirrotta,
la cui modalità rappresentativa, sempre molto vicina alle radici antiche del racconto orale, è delineata nel saggio di Vincenza Di Vita, Vincenzo Pirrotta tra cunto e
sacre-vie nell’apocalisse di un Faro al Buio. Il testo della pièce teatrale, scritto da Dario
Tomasello per la regia di Vincenzo Tripodo, è stato non solo interpretato, ma rivisitato dall’attore alla luce della sua personale attitudine all’improvvisazione corporea e vocale. Ogni ruolo pirrottiano, infatti, si mostra occasione di ricerca sul potere
comunicativo della parola, su cui innestano le tradizioni del cunto siciliano e il linguaggio della satira e commedia classica. La fiducia assoluta nell’atto verbale che
diventa un’azione sacra, incarnazione di una lingua primigenia e dimenticata, provoca uno smontaggio del testo sulla scena: Pirrotta va alla ricerca di radici profondissime e popolari, costituite di puro ritmo e manifestazione fonetica, anche a discapito del senso.
Lo scollamento tra suono e senso costituisce uno degli strumenti espressivi privilegiati mediante il quale il linguaggio del teatro ingloba in sé il fenomeno
dell’oralità e lo fa agire dall’interno del suo codice narrativo come elemento destrutturante e straniante, capace di generare una riflessione metacomunicativa. In
particolare, nel saggio di Gabriella Sgambati, Till Eulenspiegel di Tawada Yōko: tra
magie e straniamenti linguistici, si mette in evidenza come la scena possa farsi luogo
di incontro di lingue differenti, di voci decontestualizzate e di frasi sconnesse. La
pièce teatrale del 1998, scritta da Tawada Yōko, scrittrice nippo-tedesca, utilizza la
commistione delle sue due lingue, giapponese e tedesco, per creare un senso di
straniamento nello spettatore, il quale ignora il significato di ciò che viene detto
nell’idioma straniero. L’incomprensione regna sovrana sulla scena e il senso del
84
Maria Arpaia – Angela Albanese
linguaggio viene irrimediabilmente perso a favore di un assoluto trionfo
dell’aspetto sonoro e musicale della comunicazione. Lo svuotamento di significato
della lingua si realizza sulla scena mediante i giochi linguistici di Till, un personaggio del folklore del nord della Germania, burlone irriverente che spesso gioca
con le parole e il loro suono: assonanze tra parole omofone o la riproduzione simultanea di battute in tedesco e in giapponese portano alle estreme conseguenze la
marca di un’oralità trans-linguistica e trans-soggettiva.
La medesima attenzione al superamento del ‘segno’ linguistico e della sua arbitrarietà verso il raggiungimento di una parola primigenia che possa essere al contempo “suono” ed “evento” è riscontrabile nell’universo poetico di Velimir Chlebnikov, presentato da Enza Dammiano nel suo lavoro Velimir Chlebnikov: ‘esorcismi‘
in scena tra mito e folclore. Nell’ambito del recupero di un complesso miticofolklorico di natura sincretica, che affianca la mitologia classica alla demonologia
popolare russa, il tentativo di ricostruire l’elemento orale in maniera mediata pervade l’opera di Chlebnikov: nei suoi testi si incontrano formule magiche, esorcismi,
profezie, formule matematiche, cantilene, litanie, dèmoni, personaggi storici, mitologici, popolari e fiabeschi. Il suo obiettivo è quello di creare una parola che sia
‘auto-validante’, che riconosca le sue potenzialità di sviluppo autonome. La poesia
si configura così come ‘costruzione verbale’, profilandosi come la sede privilegiata
per la formulazione di un linguaggio trans-mentale e per la creazione di uno stadio
originario della parola magico-sacrale e rituale.
Oltre all’introduzione di una ‘lingua-suono’, l’oralità in scena può realizzarsi
anche mediante l’inserimento nella rappresentazione teatrale di performance orali
quotidiane o stralci di conversazione, frasi fatte e modi di dire. Il linguaggio parlato, questa volta non depauperato del suo senso, ma anzi inserito proprio in funzione del suo significato usuale, a tratti perfino scontato e banale, costituisce la caratteristica comune dei due casi di studio successivi.
Chiara Maria Buglioni, nel suo contributo dal titolo “Resta. Ti racconto qualcosa”.
Il dramma popolare Das glühend Männla da oralità primaria a tradizione incarnata,
mette in luce come il pensiero orale, la struttura e l’esecuzione di tipo formulaico
dominano le trentatré scene-lampo dell’opera, il cui nucleo è costituito da forme di
oralità primaria: narrativa orale tradizionale, racconti dell’estraneo da sé, racconti
del passato e della propria vita. Le radici popolari, costituite da un’antica leggenda
francone, investono l’intero dramma di un realismo magico dai connotati fiabeschi,
che trasfigura gli eventi invece scarni e lineari della trama e che serve ai personaggi
per autocensurare la propria incapacità di stabilire un contatto reale con i rispettivi
destinatari. L’esecuzione orale in Das glühend Männla, quindi, acquisisce i confini di
un flusso di parole a senso unico; è cifra dell'isolamento dei personaggi, che parlano solo a se stessi e per se stessi.
L’introduzione del linguaggio parlato sulla scena svolge la medesima funzione
di analisi critica dei disagi esistenziali della società nei “pezzi teatrali parlati” di
Messa in scena di racconti e storie popolari di carattere folklorico
85
Peter Handke. Dora Rusciano (Linguaggio, teatro e formazione nel Kaspar di Peter
Handke) riflette sulla funzione assunta dal linguaggio in questa forma di teatro in
cui l’ascolto predomina sulla vista. Il plot narrativo, ripreso da un racconto leggendario riadattato per la scena, non presenta una struttura organica e sequenziale, in
quanto il centro della rappresentazione non è più una narrazione mimetica, ma
l’atto stesso del parlare come azione in sé.
La serie di voci fuori campo, senza corpo e impersonali, che tempestano Kaspar
di domande simboleggiano la violenza verbale cui l’individuo è sottoposto nella
società attuale. Il linguaggio imposto dall’esterno ingabbia l’individuo in una griglia interpretativa, condannandolo all’impossibilità di costruirsi un proprio discorso. La tensione critica del pubblico è quindi indirizzata verso una strategia comunicativa che ridà peso al linguaggio in sé rispetto alla narrazione mimetica,
all’ascolto rispetto alla visione, alla partecipazione attiva rispetto
all’immedesimazione.
Nei saggi fino ad ora passati in rassegna l’oralità è quindi intesa come cifra
espressiva, tratta dal linguaggio quotidiano oppure destrutturata mediante la sottrazione dell’elemento semiotico e il trionfo di quello sonoro, con una precipua
funzione meta-riflessiva sull’atto stesso della comunicazione. Nella seconda parte
di questa sessione, invece, diventa protagonista il racconto folklorico in quanto tale
e i suoi vari adattamenti, contenutistici e lessicali, al codice performativo del teatro.
Dall’India all’Egitto, fino ad arrivare in Giappone, personaggi delle storie popolari
indossano le vesti di scena per dare corpo e voce alle storie tradizionali.
Nel contributo Donare la propria carne come pasto: un motivo letterario indiano tra
teatro, mito e folklore, Alessandro Cimino traccia l’evoluzione di uno dei motivi tipici
della cultura indiana e ne segue gli adattamenti scenici tra teatro, fiaba e cinema
moderno. Il dono della propria carne come pasto, che rappresenta la ‘perfezione
della generosità’, un elemento dottrinale fondamentale per la tradizione buddhista,
si mescola con un motivo tipicamente folklorico, quello dell’“ospitalità ricompensata”, che viene ripagata, appunto, con la propria stessa vita. Nelle varie messe in
scena del motivo folklorico la narrazione è incentrata sul momento cruciale del
dramma, in cui il protagonista ha la possibilità di beneficiare il mondo con la sua
suprema generosità; in altri contesti letterari indiani, invece, come quello della
fiaba popolare, il dono della propria carne gode di una dinamicità maggiore, spaziando tra esiti narrativi spesso agli antipodi, pur conservando quei tipici elementi
strutturali che lo caratterizzano in modo imprescindibile.
Alla tradizione folklorica e religiosa egiziana appartiene, invece, il mito de “I
Sette Dormienti di Efeso”, la cui trasposizione scenica è analizzata da Antonella
Zapparrata, in Il mito de “I Sette Dormienti di Efeso” nel teatro del drammaturgo egiziano Tawfīq al-Ḥakīm. La storia – sette fanciulli che si addormentano nascosti in una
grotta e che si risvegliano trasportati in un’altra epoca – costituisce solo un punto
di partenza: al-Ḥakīm rielabora la tradizione per rivalutare in senso nazionalistico
86
Maria Arpaia – Angela Albanese
l’antico Egitto in cui essa era ambientata a discapito di quello moderno degli anni
Trenta, ancora in cerca della propria identità e indipendenza. Il significato simbolico del dramma diviene quindi chiaro: i protagonisti si risvegliano e tentano di reinserirsi nella vita del tempo, ma lo sfasamento temporale li ricaccia all’interno della
grotta. L’identità che la società vuole imporre agli individui non è valida, così come non lo è neanche quella creduta dai dormienti. L’adattamento della storia alla
scena apre così una discussione sul rapporto tra l’individuo e la società, tra fede e
dubbio, per approdare poi al trionfo della fede e del cuore.
L’intervento di Irene Starace (La fiaba della moglie gru e la sua trasposizione teatrale
in Yūzuru di Kinoshita Junji) ci trasporta infine nelle atmosfere delicate ed evanescenti della cultura giapponese, in un clima di rivendicazione nazionalistica in cui
il folklore costituisce il contrappunto nostalgico alle spinte di modernità e di occidentalizzazione e, al tempo stesso, uno schermo efficace per poter eludere la censura ed esprimere parole di denuncia storico-politica. Nell’adattare il tema principale della fiaba della moglie gru - un giovane povero è interdetto dal guardare la
sua bellissima sposa mentre tesse una stoffa di grande valore, grazie alla quale
diventa ricco - alla scena teatrale, Kinoshita apporta varie modifiche, intervenendo
sul numero e sulla caratterizzazione dei personaggi, che acquisiscono evoluzione e
spessore psicologico, e sul finale triste, determinato dall’avidità con cui l’uomo
costringe la donna a continuare a tessere con grande dolore, staccando piume dal
suo corpo. Il tema della storia è completamente cambiato, in quanto affronta una
questione tipicamente ‘moderna’: il conflitto tra denaro e amore. La messa in scena
del folklore diventa così funzionale a vestire la tradizione di un nuovo significato
politico e sociale, tale da richiamare la contemporaneità al senso etico delle storie
del passato.
In tal senso l’adattamento alle convenzioni sceniche di un racconto tradizionale
agisce sull’aspetto educativo, modificando in profondità il messaggio che porta con
sé. La struttura dialogica della messa in scena, la personificazione dei personaggi
che diventano identità complesse a tutto tondo, l’effetto immedesimativo della
mimesi diretta rispondono all’urgenza comunicativa della contemporaneità e plasmano il racconto orale, affinché esso sviluppi una riflessione critica e parli alla
modernità.
STEFANO DE MATTEIS
ALLA GIOCONDA SI POSSONO SOLO FARE I BAFFI (E IL PIZZETTO)
1. Vorrei cominciare con una precisazione a partire dal titolo che è stato dato a
questi due giorni di incontri, L’oralità sulla scena. Adattamenti e transcodificazioni dal
racconto orale al linguaggio del teatro.
Il fatto che sulla scena si possano (anche) dire, pronunciare, usare ‘delle parole’
e che si procede per mezzo di quella forma di comunicazione che chiamiamo ‘orale’, non vuol dire che ci situiamo nell’orizzonte di quel particolare tipo di oralità
che riguarda – almeno per come viene intesa generalmente e genericamente – il
discorso ‘spontaneo’, inteso nel senso di ‘immediato’ e cioè nato sul posto, scaturito da una relazione immediata e che tirerebbe in ballo un’altra categoria, altrettanto
ingombrante, che è quella di improvvisato o improvvisazione… Anzi, da questo
punto di vista – quello della parola ‘orale’ in scena – , dovremmo cominciare con lo
stabilire quasi il concetto opposto, e cioè che oralità e scena combinate assieme
potrebbero addirittura rappresentare un ossimoro, in quanto sulla scena non vi è
nulla di spontaneo, di improvvisato e, forse, nulla di più costruito.
A mano a mano che andremo avanti, cercherò di spiegare e problematizzare
questi concetti a partire da una iniziale considerazione generale.
Siamo in tanti – ovviamente sulla scia di molti altri prima di noi, a cominciare
da Goffman e Turner e, andando ancora più lontano, da William James (e comunque non è questa l’occasione per costruire alberi genealogici) – a sostenere
l’esistenza di un meccanismo di costruzione di ‘maschere’ individuali utili alla
scena sociale, che ogni individuo elabora in relazione alla sua ‘parte’ pubblica, in
rapporto alla propria condizione e alla propria rete di relazioni. Questo segue un
percorso dettato dalle storie personali e dalle strategie individuali, dalle occasioni o
dagli obiettivi personali. Tutto questo è venuto maggiormente alla luce – chiarendosi o ingarbugliandosi a seconda dei punti di vista – anche a seguito del buono e
cattivo uso che è stato fatto del concetto di Self: altro argomento che non tratteremo
in questa sede.1 All’opposto della scena sociale, figuriamoci quanta ‘costruzione’ e
preparazione (tecnica, artigianale, esperienziale…) riscontriamo da parte degli
attori più o meno professionisti che incontriamo sulla scena di un teatro, di un rito
o di un semplice spettacolo di strada.
Potremmo dire, semplificando, che ciascuno di questi ambiti mette in scena, utilizza e fa ricorso ‘a un linguaggio’ ed è proprio ‘il linguaggio’ la questione cui vo1 Rimandando però a Giovanni Jervis, Significato e malintesi del concetto di ‘Sé’, in Massimo Ammaniti
(a cura di), La nascita del Sé, Laterza, Roma-Bari, 1989, pp. 15-52 e a Stefano De Matteis, Introduzione a
Victor Turner, in S. De Matteis (a cura di), Antropologia dell’esperienza, trad. it. M. Zemira Ciccimarra, Il
Mulino, Bologna, 2014, pp. 7-31.
88
Stefano De Matteis
glio arrivare: per cui, dandoci questo come obiettivo, partiamo dalla questione
dell’oralità ribadendo alcune cose essenziali: se detta oralità dovesse essere intesa
come ‘spontaneità’, si trasformerebbe in un serio problema che ci farebbe scivolare
immediatamente in un terreno a dir poco sdrucciolevole. E le cose si complicherebbero ancora di più se tale concetto di spontaneità venisse a coniugarsi con quello di creatività. Per fortuna, su tali argomenti ho un alleato a dir poco illustre –
forse dovrei dire un maestro – in Giovanni Jervis: in un periodo in cui i movimenti
extraparlamentari degli anni Settanta cercavano di giustificare le loro azioni politiche ricorrendo a termini quali spontaneità e creatività, Jervis ebbe a dire, come suo
solito, parole essenziali.2 Poi, se a tutto questo aggiungiamo quanto è accaduto in
antropologia negli ultimi trent’anni sul fronte del lavoro di campo e
dell’interpretazione – a seguito del famoso seminario-libro Writing Culture3 – mi
trovo ad avere a disposizione elementi sufficientemente forti che mi permettono di
rinsaldare ancora di più il tema della ‘costruzione’ e dell’’elaborazione’ delle varie
forme della comunicazione orale, e di poter far leva su quel sistema performativo
che vive nelle relazione sociali e che, di seguito, si rafforza in quegli ambiti ancor
più solidi delle relazioni artistiche e teatrali.
2. Detto questo e avviata la premessa – che però come vedremo alla fine si rivelerà molto di più di un preambolo introduttivo – partiamo proprio da qui per formulare la prima domanda chiedendoci se esiste un’oralità nel senso di racconto
‘spontaneo’. Perché rispetto a questo tema abbiamo una serie di questioni e di implicazioni culturali, scientifiche e tecniche che vanno oltre quelle citate finora e di
cui vado a costruire un elenco, cercando di fare ricorso a delle esemplificazioni in
modo da agevolare il compito di chi mi deve seguire.
L’antropologia e la linguistica, con il teatro che le unisce, mi hanno insegnato a
considerare la comunicazione sempre e comunque come un artefatto. Benveniste o
Jakobson, con tutte le distinzioni e differenze che li separano, almeno su questo e
da questo punto di vista convergono: ogni volta che si pronuncia il pronome ‘io’, si
inaugura un nuovo schema di relazioni che, a sua volta, costruisce nuovi modelli
di relazione che vanno ad accumularsi agli altri modelli, precedenti o prestabiliti,
che noi gestiamo e che funzionano come dei canovacci. Queste partiture vengono
da noi reinterpretate soggettivamente e declinate relazionalmente.
Quindi, a seconda della persona a cui mi riferisco o a seconda di chi sia il referente, e grazie alla situazione in cui mi trovo, prende l’avvio un canovaccio, una
maschera, uno schema prestabilito entro cui agirò, costruirò i miei comportamenti.
2 Cfr. Giovanni Jervis, Il mito dell’interiorità. Tra psicologia e filosofia, a cura di G. Corbellini e M. Maraffa, Bollati Boringhieri, Torino, 2011; Id., Contro il sentito dire. Psicoanalisi, psichiatria e politica, a cura di
M. Marraffa, Bollati Boringhieri, Torino, 2014.
3 James Clifford, George E. Marcus (a cura di), Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography,
University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1986.
Alla Gioconda si possono solo fare i baffi (e il pizzetto)
89
Una tale affermazione poggia ovviamente sul lavoro di Goffman, maestro nel
mostrare gli artefatti umani di quella che, in questa sede, potremmo appositamente
chiamare la ‘costruzione della (cosiddetta) spontaneità’.
Se un tale meccanismo vale nella quotidianità delle relazioni sociali, immaginiamo cosa può succedere nella pratica di quella particolare relazione che si realizza nel lavoro di campo con quei ‘personaggi’ che vengono chiamati ‘informatori’.
Infatti, accanto alla storia dell’antropologia, ne andrebbe fatta una parallela che
è la storia degli informatori che ne hanno fatto la storia: partendo ad esempio da
quelli che hanno assunto fisionomie ‘romantiche’ come i collaboratori di Malinowski4 oppure dagli ‘ndembu’ di Turner, come lo straordinario ‘filosofo’ Muchona il
Calabrone,5 ma anche ricostruendo le tracce di quelli negati, nascosti, obliati, fino
ad arrivare a tempi più recenti in modo da esaminare quei casi in cui l’informatore
è diventato un vero e proprio mestiere. Mi hanno raccontato che esistono luoghi in
cui informatori specializzati forniscono materia preconfezionata che risponde ai
desideri e alle aspettative del ricercatore. Mi dicono anche che siamo arrivati al
punto che è addirittura possibile fare un’indagine per telefono (se prima hai provveduto al bonifico, of course).
Comunque tornando al nostro argomento, conviene ribadire quanto si diceva
prima: il concetto di costruzione della narrazione non riguarda solo gli informatori
prezzolati, perché ogni volta che si fanno racconti o discorsi, spesso anche noi stessi seguiamo esposizioni narrative preordinate e precostituite: a volte non solo ripetiamo discorsi o espressioni, ma facciamo leva su variazioni linguistiche comprovate, in modo da tentare di ‘metterci’ la stessa spontaneità della prima volta.
Se foste degli attenti osservatori – come capita a me, ad esempio, che sorveglio
me stesso e gli altri fino all’ossessione – vi accorgereste delle ripetizioni, delle variazioni, degli ‘errori’ e anche delle imitazioni che facciamo ‘spontaneamente’.
Inoltre, quando parliamo di una comunicazione ‘spontanea’, dobbiamo chiarire
che la cosiddetta spontaneità non riguarda solo le parole che diciamo, ma anche
come le diciamo. Proprio da qui deriva un’altra interessante annotazione: è stato
Michail Bachtin a sottolineare l’importanza delle sfumature nel linguaggio parlato
e della capacità delle classi popolari di organizzare una comunicazione utilizzando
un vocabolario ristretto o magari misero, fino ad essere ridotto in alcuni casi a una
sola parola, ma ripetendola in modo da far ricorso a un numero infinito di inflessioni e di variazioni sonore, comuni e condivise, in modo da articolare, con le sonorità, un discorso lungo quanto ampio. Un’osservazione questa che ha smentito i
tanti luoghi comuni che hanno imperato in passato, come quello sostenuto da Da4 Citati tanto in Bronislaw Malinowski, Argonauti del pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana
nella società primitiva, trad. it. M. Arioti, Newton Compton, Roma, 1978, quanto in Id., Il giornale di un
antropologo, trad. it. C. Bonucci, Armando, Roma, 1992.
5 Cfr. Victor Turner, Muchona il Calabrone, interprete religioso, in J. B. Casagrande (a cura di), La ricerca
antropologica. Venti studi sulle società primitive, vol. II, Einaudi, Torino, 1960, pp. 425-454.
90
Stefano De Matteis
rio Fo in un suo famoso spettacolo: L’operaio conosce 300 parole il padrone 1000 per
questo lui è il padrone.
3. Se tutto questo è vero – cioè che ‘oralità’ è un modo di dire, un modo di formulare e di porgere ma che non viene ‘spontaneamente’ dal nulla e non la possiamo considerare come un’invenzione estemporanea – affrontiamo allora la seconda
domanda: come si acquisiscono queste comunicazioni orali? Da qui deriva una
questione supplementare che riguarda il modo in cui queste comunicazioni orali
vengono utilizzate, che sarà poi la terza ed ultima domanda cui cercheremo di
rispondere alla fine.
Per affrontare in modo concreto questi argomenti, riferiamoci prima
all’antropologia e poi al teatro, così da restare all’interno degli interessi ‘guida’ del
nostro incontro.
Rispondere in modo corretto a tali domande vuol dire seguire non solo questioni teoriche o tecniche: se decliniamo tali domande in ambito etnografico, esse
finiscono di fatto col mettere in discussione anche la cosiddetta ‘scientificità’ del
lavoro di ricerca e il modo in cui avviene e si realizza la raccolta dei dati, la qualità
e la quantità dei materiali ‘vivi’, fino ad obbligarci a ragionare sul rapporto tra
questi materiali, i metodi di elaborazione e l’uso finale che se dovrà fare (monografia, film, teatro…).
Per affrontare la complessità che il problema solleva, prendiamo il primo dei
casi che tratterò in questa relazione. Quello che vi presento l’ho scelto tra i miti più
noti e famosi: si tratta di una storia che è diventata un libro che potremmo anche
definire di ‘successo’, in quanto la sua diffusione è andata ben oltre la portata disciplinare che gli era propria. Ed è diventato, secondo me, un libro importante
anche per la sua capacità di narrare una storia molto bella, frutto di uno straordinario lavoro interdisciplinare.
Alla base c’è il mito del Briccone divino.6
4. La storia è stata raccolta da Paul Radin.7 Radin ha svolto il suo lavoro di campo tra i Winnebago, popolazione di indiani dell’America del Nord, dove, tra le
altre numerose ricerche, ha raccolto il mito del Briccone.
Sentiamo dalle sue parole quali sono state le tecniche cui ha fatto ricorso per garantirsi l’autenticità del mito: i sistemi, le procedure ‘scientifiche’ e i metodi usati
per raccoglierlo, trascriverlo e documentarlo.
6 Cfr. Carl Gustav Jung, Karol Kérényi, Paul Radin, Il briccone divino, trad. it. N. Dalmasso e S. Daniele, SE, Milano, 2006.
7 Di cui do solo qualche notizia essenziale: nato nel 1883 a Lodz in Polonia, figlio di un rabbino, si
trasferisce presto in America, anche se torna in Europa per studiare a Monaco e a Berlino. A New York
sarà allievo di Franz Boas, e avrà come colleghi Edward Sapir e Robert Lowie.
Alla Gioconda si possono solo fare i baffi (e il pizzetto)
91
Il mito del Briccone dei winnebago, così come l’ho trascritto in queste pagine, mi è
stato trasmesso nel 1912 da uno dei miei principali informatori, Sam Blowsnake, che
lo ebbe da un vecchio indiano winnebago residente in un villaggio del Nebraska. Il
testo era composto nella scrittura sillabica di questo popolo che, introdotta una generazione prima dell’attuale, veniva quasi esclusivamente usata per redigere lettere ed
era conosciuta solo da un numero relativamente limitato di persone. Essendo assolutamente necessario dimostrare l’autenticità del documento che ho presentato in questa sede, mi sembra utile soffermarmi brevemente sulla figura di Sam Blowsnake. 8
Questa iniziale precisazione già pone qualche dubbio che richiederebbe ulteriori approfondimenti. Radin parla di una scrittura sillabica da poco in uso alla quale
si faceva ricorso, quasi esclusivamente, per redigere lettere. Era utilizzata da un
numero ristretto di persone. Di questa scrittura non conosciamo l’ampiezza del
vocabolario e quindi non sappiamo le possibilità che essa offre di trasferire per
iscritto l’oralità del mito, né l’autore ci informa sulle abilità di chi l’ha impiegata.
Torniamo alla storia di Sam Blowsnake:
Costui era un vecchio winnebago purosangue e apparteneva al clan dell’Uccello del
Tuono (Thunderbird). Suo padre era un notabile, rimasto fedele alle forme della vecchia civiltà winnebago sin quando si era convertito alla religione del peyote, intorno
al 1909-10. Tutti i suoi figli erano istruiti nel rispetto delle antiche usanze: digiunavano alle epoche prescritte, erano stati iniziati agli antichi riti e avevano appreso i miti
sacri e profani per tradizione. Il vecchio Blowsnake era noto come un buon narratore,
per cui suo figlio aveva avuto l’opportunità di familiarizzarsi con i principali miti
della tribù nella loro forma autentica.9
Di questo passaggio è utile sottolineare un dato: il padre era un buon narratore
e da questo deriva che il figlio ha avuto non solo l’opportunità di familiarizzarsi
con i miti, ma di farlo “nella loro forma autentica”, e questo grazie proprio alle sue
capacità narrative. Potremmo dire che l’autenticità del mito risiede nella capacità
narrativa di riproporlo? “Che il vecchio Blowsnake conoscesse il mito del Briccone
è fuor di dubbio, ma non era disposto a raccontarlo, neppure ai suoi stessi figli,
senza essere autorizzato dalla tradizione, e sembra che non lo fosse”.10 Tra tutti i
miti che il vecchio conosceva c’era quello del Briccone, ma non era autorizzato a
narrarlo. Ma per gli altri miti era autorizzato? O forse c’erano miti che potevano
essere narrati ed altri no?
Sam Blowsnake si rivolse dunque, come peraltro gli avevo consigliato, a un indiano
ancor più anziano, che deteneva questo diritto. Non chiesi chi fosse il narratore: numerosi motivi, che non posso enunciare in questa sede, mi fecero giudicare imprudente informarmi su di lui, poiché quello del Briccone è un mito sacro, e io ero uno
Jung, Kérényi, Radin, Il briccone divino , cit., p. 95.
Ibid.
10 Ibid.
8
9
92
Stefano De Matteis
straniero, e per di più un bianco. L’unica cosa certa è che il narratore non apparteneva ai credenti della nuova religione del peyote, una religione semicristiana che
all’epoca del mio arrivo era già diffusa in tutta la tribù winnebago.
L’identità del narratore non ha tuttavia grande importanza.11
Il vecchio Blowsnake, su suggerimento di Radin, si rivolse a un anziano che non
solo aveva il diritto di raccontare un mito sacro, ma anche la facoltà di autorizzarne
la narrazione; si trattava di un anziano che non aveva accettato la nuova religione
semicristiana restando legato alle vecchie tradizioni.
Radin suggerisce la strategia e, evidentemente, sosterrà l’operazione anche da
un punto di vista economico, ma si tiene in disparte essendo uno straniero, e bianco per giunta.
Inoltre per Radin l’identità del narratore non è importante in quanto
l’”essenziale è invece che il mito sia stato trasmesso nelle circostanze appropriate e
che sia stato trascritto da Sam Blowsnake così come gli è stato narrato. Per ‘circostanze appropriate’ intendo i doverosi doni di tabacco e le regalie, commisurate al
valore tradizionale del mito, che devono essere offerti al narratore. Sono certo che
queste norme furono osservate”.12 Le norme furono applicate perché, molto probabilmente, fu lo stesso Radin a ‘sovvenzionare’ anche su questo fronte le ricerche.
Per molte ragioni posso inoltre affermare che Sam Blowsnake ha trascritto fedelmente il testo. Un winnebago non oserebbe mai travisare, neppure in minima parte, un
mito trasmessogli da una persona che detiene il diritto tradizionale di narrarlo e alla
quale egli ha offerto doni rituali in cambio. La miglior prova dell’assoluta fedeltà della trascrizione risiede però nella maniera stessa di raccontare il mito e nel vocabolario
usato. Conosco molto bene lo stile di Blowsnake, poiché mi aveva dettato o aveva
annotato per me innumerevoli testi.13
È necessario soffermarsi anche su queste frasi in quanto, anche queste, sollevano non pochi problemi. C’è un motivo legato all’onore, tradizionale e rituale, che
certifica la veridicità della trascrizione e garantisce da eventuali travisamenti; cui si
aggiungono l’autorità della persona che ha comunicato il mito e la transazione che
ha sancito l’accordo. Inoltre la controprova viene infine dallo ‘stile’ caratteristico e
unico dello stesso Blowsnake, dal suo modo di raccontare e dal suo ‘classico’ vocabolario. In qualche modo Radin fa riferimento a una sorta di personale impronta
che caratterizza e ‘sigla’ il testo e lo rende autentico e unico, tradizionale e personale. Passiamo ora alla traduzione.
La traduzione venne fatta da due giovani indiani, John Baptiste e Olivier Lamere, i
quali, soprattutto il primo, conoscevano perfettamente la lingua inglese. Ho poi conIvi, pp. 95-96.
Ivi, p. 96.
13 Ibid.
11
12
Alla Gioconda si possono solo fare i baffi (e il pizzetto)
93
trollato personalmente il testo. So leggere la scrittura sillabica e capisco bene il winnebago.
Possiamo dunque cominciare la nostra analisi nella certezza che il testo è autentico,
che è stato acquisito secondo i modi prescritti, che è stato tradotto in maniera appropriata e che si tratta di una versione indiscussa del mito del Briccone quale fu raccolto presso i winnebago nel 1912.14
I due indiani conoscevano l’inglese e lo stesso Radin ha supervisionato la traduzione. Quanto Radin ci ha detto finora costruisce l’elenco delle ‘prove’ riguardanti l’autenticità del mito, la sua acquisizione secondo i modi prescritti, l’autorità
del narratore e il fatto che sia autorizzato a raccontarlo e, infine, che ci sia stato un
risarcimento economico. Ma anche che esso è stato tradotto in maniera adeguata.
Insomma tutti elementi che ci assicurano di trovarci davanti a una ‘indiscussa’
versione del mito.
A tutto questo possiamo solo aggiungere, generalizzando, che il metodo scientifico esposto da Radin era quello in vigore in quel determinato periodo e che veniva
utilizzato per la raccolta e la transcodifica di ogni passaggio dall’oralità alla pagina
scritta. Un’oralità di per sé definita e strutturata da una abilità individuale che si
aggiunge a un canone narrativo, tradizionale e condiviso.
Ed è proprio grazie a questo metodo – o forse bisognerebbe dire ‘nonostante’? –
che abbiamo un libro straordinario come Il briccone divino cui ci stiamo riferendo,
ma anche i tanti altri miti e tutti gli scritti indigeni sulla religione, come quelli raccolti da Franz Boas tra i Kwakiutl o dagli altri membri della scuola nata attorno al
suo lavoro alla Columbia University. Anche se il tempo, gli studi e gli aggiornamenti ce ne mostrano i limiti prima ‘metodologici’ e poi ‘scientifici’.15
Dalle questioni che abbiamo sollevato finora commentando le parole di Radin
che introducono il testo del Briccone, derivano due ulteriori questioni se non da
affrontare, almeno da accennare: la prima riguarda il rapporto tra mito e racconto
e, di seguito, il funzionamento di quella che è stata chiamata la ‘macchina mitologica’. Vedremo poi, più avanti e separatamente, quella che potremmo chiamare la
‘reincarnazione’ del mito dovuta all’abilità dei suoi interpreti. Ma cominciamo
dalla prima questione.
5. Ogni volta che parliamo del mito, in realtà, ci riferiamo principalmente alle
mitologie: nel senso che il mito, ogni mito, è fatto dalle mitologie che lo compongono e lo accompagnano. E su questo tema conviene chiarire immediatamente
quella che potrebbe apparire come una contraddizione. Dire che senza i racconti
mitologici non ci sarebbe il mito significa affermare che il mito non ha possibilità di
Ibid.
Su questi argomenti cfr. Stefano De Matteis, Tecniche e trucchi rituali. Un seminario
sull’interpretazione, in S. De Matteis (a cura di), Quesalid. Il metodo dello sciamano, trad. it. C. Cavaliere, J.
Cirillo, S. Salese, Laboratorio Annabella Rossi, Fisciano, 2012, pp. 5-32.
14
15
94
Stefano De Matteis
esistere senza la quantità e la qualità delle narrazioni mitologiche che lo rendono
tale: un’affermazione che porta a considerare il mito come un qualcosa che in realtà
non esiste. E anche qui entriamo nel rapporto contraddittorio tra struttura e ripetizione, tracciato narrativo e capacità esecutiva.
Gli esempi sul tema sono numerosi. Se vogliamo rimanere in casa basta rifarsi a
quello che è stato riconosciuto come il più geniale dei mitologi ‘nostrani’, Furio
Jesi. Cominciamo citandolo prima di tutto su una sorta di ‘presupposto di metodo’:
“Il mito, ammesso per ipotesi che esista, è un qualcosa che l’uomo di oggi non può
presupporre ‘come immediatamente dato dalla rappresentazione’. ‘Immediatamente data dalla rappresentazione’ è bensì la mitologia, ma l’etimologia stessa di
‘mitologia’ rivela che questa parola, derivante dal greco mythos e lógos, può essere
intesa come una ‘mescolanza di contrari’”.16
Passiamo ora alla questione dell’autorevolezza del mito e della capacità dei suoi
narratori. La storia della parola mythos è inizialmente, a partire da Omero, storia
della retorica e in particolare dell’eloquenza. L’eloquenza dell’eroe omerico ‘buon
parlatore’, come Odisseo o come Nestore, è alimentata da almeno due facoltà:
l’astuzia di usare le parole giuste al momento giusto (in cui eccelle Odisseo) e la
capacità di attingere solennemente a un repertorio di storie preesistenti che conferiscono al parlatore e ai suoi argomenti l’autorevolezza di un passato consacrato
(capacità in cui eccelle Nestore).17
Ed eccoci al punto centrale: è la mitologia a costruire e tramandare i miti; tale
comunicazione, tuttavia, è retta sì dalla capacità di conoscere un repertorio di storie preesistenti che conferiscono autorità, ma anche dalla capacità strettamente
narrativa di usare le parole giuste al momento giusto. Tutto questo rimanda quindi
a una capacità esecutiva che ha direttamente a che vedere con le doti individuali
dell’esecutore, ma che regge anche sulla sua perizia tecnica, retorica e, anche, recitativa.
Ora, senza scomodare grecisti che tanto hanno insistito sull’argomento – approfitto di quest’occasione per ricordare Bruno Gentili con cui ho condiviso anni di
lavoro alla facoltà di Lettere e filosofia all’Università di Urbino – appare chiaro che
esiste un’arte della costruzione retorica e della sapienza narrativa utile a far vedere,
mostrare, conquistare il pubblico con delle narrazioni mitologiche eseguite come se
fossero spontanee, in modo da ‘fermare’ gli spettatori seducendoli con le abilità
della narrazione. Per una sintesi del mito come una questione prettamente di linguaggio sentiamo ancora Furio Jesi:
Se per ‘mito’ intendiamo il quid, alla cui esistenza la macchina mitologica allude come
a quella del suo presunto motore immobile, e per ‘materiali mitologici’ i prodotti storicamente verificabili della macchina, la scienza del mito è una tipica scienza di ciò
16
17
Furio Jesi, Il mito, Mondadori, Milano, 1980, p. 13.
Ivi, pp. 15-16.
Alla Gioconda si possono solo fare i baffi (e il pizzetto)
95
che storicamente non c’è, mentre la scienza della mitologia è lo studio dei materiali
mitologici in quanto tali. La scienza del mito, nella mia prospettiva, tende ad attuarsi
come scienza delle riflessioni sul mito, dunque come analisi delle diverse modalità di
non-conoscenza del mito. La scienza della mitologia, per il fatto di consistere nello
studio di materiali mitologici ‘in quanto tali’, tende ad attuarsi innanzitutto come
scienza del funzionamento della macchina mitologica, dunque come analisi della interna ed autonoma circolazione linguistica che rende mitologici quei materiali. Uso la
parola mitologia per indicare, appunto, tale circolazione linguistica e i materiali che
la documentano.18
6. Se restassimo ancora fermi alla confluenza tra queste diverse strade, in cui
mito e linguaggio, narrazione e racconto, interpretazione e oralità si incrociano,
potremmo ricorrere esplicativamente ai riferimenti che su questi temi troviamo in
Lévi-Strauss in quanto, a cominciare da Antropologia strutturale fino alle Mitologiche,
dedica gran parte del suo lavoro alla raccolta, alla documentazione e
all’interpretazione dei racconti mitologici dove, contemporaneamente, sottolinea
anche la forza e l’importanza dell’esecuzione: anzi Lévi-Strauss afferma e ribadisce
l’importanza dell’esecuzione che spesso è fortemente teatrale, in quanto muove
dalle capacità espressive del protagonista al fine di creare partecipazione nel soggetto narrato, ma che si avvale della presenza e del coinvolgimento del pubblico
presente. Da questo punto di vista, il testo forse più importante e famoso è Lo stregone e la sua magia, del 1949, dove in un certo senso fonda il teatro e contemporaneamente scopre quella sorta di psicologo primitivo che vive nello stregone o nello
sciamano. Nonostante questo, proprio qui, Lévi-Strauss usa in maniera molto libera e approssimativa il dato etnografico: mi riferisco al racconto raccolto da Franz
Boas del giovane Quesalid che voleva smascherare i finti sciamani e che fa da base
su cui costruisce la sua ‘carriera’.19 Da questo punto di vista, sfogliare le Mitologiche
di Lévi-Strauss è utile perché la sua costruzione si affina nel tempo ma, in merito a
quanto stiamo argomentando, è importante soffermarci in particolare sull’ultimo
volume, sulle conclusioni de L’uomo nudo.20 Queste potremmo riassumerle – sperando di non essere eccessivi nella sintesi – riferendo che la narrazione del mito si
alimenta di storie sedimentate e di abilità nella riproduzione. Ma con una diversificazione: l’atto della massima formalizzazione spetta alla ritualità, che ricuce e ricostruisce la trama (nel senso di reticolo, maglia…) del mito che sopravvive comun-
18 Cit. da Andrea Cavalletti, La maniera compositiva di Furio Jesi, in Furio Jesi, Materiali mitologici. Mito
e antropologia nella cultura mitteleuropea, a cura di A. Cavalletti, Einaudi, Torino, 2001, p. 367.
19 Su questi temi cfr. De Matteis, Tecniche e trucchi rituali. Un seminario sull’interpretazione, cit., e Quesalid. Il metodo dello sciamano, cit.
20 Claude Lévi-Strauss, L’uomo nudo. Mitologica 4, trad. it. E. Lucarelli, Il Saggiatore, Milano, 1974 (1ª
ed. 1971).
96
Stefano De Matteis
que sfilacciato e di cui si danno solo elementi frammentari e frammentati che
l’azione rituale cerca di ricostruire.21
Il rapporto tra mito e rito in Lévi-Strauss o la macchina mitologica di Jesi costituiscono due formidabili artifici rappresentativi, due straordinari strumenti che
traducono in termini di linguaggio qualcosa che si offre come imprendibile. Anzi la
sua prendibilità è qualcosa di natura sostanzialmente diversa che vive e si alimenta
della capacità del linguaggio di tradurla e di comunicarla.
7. A tutto questo, per avviarci al paradigma teatrale conclusivo, aggiungiamo
ancora un altro passaggio: molte delle descrizioni dei riti (a partire da quelle degli
etnologi ‘da tavolino’ come Marcel Mauss), lasciano trasparire che gli autori stanno
costruendo, narrativamente, uno ‘spettacolo’ per noi lettori.22 Infatti la formalizzazione rituale viene narrata e interpretata spesso facendo ricorso alla metafora teatrale: a partire da Goffman, da Turner, da Geertz…
Ma al racconto del rito a mezzo del paradigma teatrale si aggiungono nel tempo
altri esperimenti. Come quello elaborato da Victor Turner quando ricorre alle narrazioni teatrali come artificio pedagogico: come fa, ad esempio, quando affronta la
questione dell’etnografia messa in scena sperimentalmente.23 Sul versante opposto,
un brandello di realtà lo possiamo interpretare come sinonimo dell’oralità ma che
può anche essere usato come una metafora del lavoro o come una sorta di coup de
théâtre, una scheggia di verità che viene inserita in un contesto della trattazione per
essere scioccante come un colpo di frusta. È così che avviene per esempio in de
Martino: basta vedere come l’antropologo riesce a raccogliere la documentazione
per Morte e pianto rituale, indagando i modi in cui si innesca il pianto, oppure come
racconta ne La terra del rimorso della postura delle tarantate. Ma non solo, perché in
questo caso la realtà viene anche trasformata in una scheggia che ferisce tutti, lettori compresi che, complici della lettura coinvolgente e partecipata de La terra del
rimorso, si trovano spiazzati. Sul campo il ricercatore è stato presentato ai “malati”
con la qualifica di dottore in modo da avere accesso alle case e studiare i casi da
vicino. Tempo dopo, terminata la ricerca sul campo, mentre l’autore è alle prese
con la stesura del testo ecco che, come un fulmine a ciel sereno, arriva un telegramma. Sentiamo de Martino:
I familiari di Carmela erano tuttavia fiduciosi anche sulle possibilità della scienza in
questo campo, come mostrava non tanto il fatto che più volte si erano recati dai migliori psichiatri di Lecce, quanto la commovente devozione con la quale cercavano di
aiutarci nella nostra indagine, segretamente sperando che avremmo trovato il modo
21 Cfr. Stefano De Matteis, Echi lontani, incerte presenze. Victor Turner e le questioni dell’antropologia contemporanea, (Quaderni dell’Istituto di Filosofia), Edizioni Montefeltro, Urbino, 1995.
22 Ho affrontato quest’argomento in Stefano De Matteis (a cura di), Introduzione a Victor Turner, Antropologia della perfomance, trad. it. S. Mosetti, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 9-52.
23 Cfr. Turner, L'etnografia messa in scena, in Antropologia della perfomance, cit., pp. 243-263.
Alla Gioconda si possono solo fare i baffi (e il pizzetto)
97
di guarire la loro ragazza e di metter fine a una vicenda che dissestava economicamente la famiglia e teneva ogni estate gli animi sospesi. Quando l’équipe fece ritorno
a Roma, ci raggiunse dopo pochi giorni un telegramma che ci fece sentire tutta la responsabilità della nostra indagine, ricordandoci nel modo più brutale che i tarantati
erano non soltanto documenti di un’altra età, ma persone vive verso le quali avevamo dei doveri attuali. Nel telegramma si leggeva: «Carmela balla. Venite».24
8. La questione cui sto girando attorno per cercare di mettere meglio al fuoco il
centro riguarda, come ho detto fin dall’inizio, il linguaggio: nel senso che noi possiamo avere come riferimento una storia vera, un mito o una cronaca… rispetto a
questo frammento di realtà, ci sarà sempre una trasformazione che vivrà nella rielaborazione, nella riscrittura, nella ri-narrazione. È da questo punto di vista, credo,
che bisognerebbe valutare se risulta più significativa – e fulminante – la pagina di
Ernesto de Martino o il tentativo di teatralizzazione o travestimento di ricerche
etnografiche, camuffandoci da tarantati o da fujenti della Madonna dell’Arco.
E per farlo, bisogna comunque tenere presente che alla formalizzazione (rituale,
in gran parte dei casi) corrisponde anche una buona dose di teatralità (descrittiva).
Abbiamo qui due modi di relazionarsi al linguaggio, sia che si parta dalla quotidianità sia che si ripeta il mito: ma entrambi sono formalizzati. E questo vale tanto per la narrazione (mitologica), quanto per la rappresentazione (rituale) che ne
tenta la ricostruzione. E questo credo sia un elemento importante, da tenere ben
presente perché ritorna in più occasioni.
9. Prima di prendere in esame gli ultimi due casi a riguardo del rapporto tra
oralità e rappresentazione, voglio fare una precisazione in merito a un altro concetto che potrebbe creare non pochi fraintendimenti e riguarda l’improvvisazione. E
per farlo devo, ancora una volta, partire da un preambolo.
Ho sempre lavorato cercando di comparare elementi molto diversi tra loro in
modo da elaborare una sorta di antropologia come esercizio critico dei sistemi
sociali ma partendo da comportamenti e modelli. E ho sempre fatto ricorso a indagini dirette e misurazioni etnografiche, ma mi sono avvalso anche di confronti con
la letteratura e il teatro, oltre alla frequentazione di discipline affini come la sociologia e la psicologia. Ho seguito in modo particolare – con un impegno dettato
anche dagli interessi politici propri di quegli anni coincidenti con il periodo di
formazione – il lavoro pedagogico (alla Mensa dei Bambini proletari di Napoli) o il
lavoro sociale. Quest’ultimo, guidato da una linea d’interesse a metà tra la produzione artistica e la partecipazione sociale, mi portava ad indagare in zone di confine. Proprio in questo ambito, ho avuto l’occasione di seguire, ad esempio, il lavoro
di Carlo Cecchi per la messa in scena del Woyzeck, realizzata con gli immigrati me24 Ernesto de Martino, La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, il Saggiatore, Milano, 2008, p. 115.
98
Stefano De Matteis
ridionali di un quartiere popolare di Torino, oppure il lavoro di Leo De Berardinis
e Perla Peragallo quando si trasferirono a Marigliano, un paesino in provincia di
Napoli.
Faccio questa premessa perché è con loro che ho avuto modo di confrontarmi su
concetti come l’improvvisazione, l’immediatezza e la spontaneità.
Quando Leo e Perla stavano preparando il loro film A Charlie Parker, dedicato al
grande jazzista, abbiamo attraversato tutta l’opera del musicista per mettere a fuoco un dato importante: quando si allontanava dalla partitura, lo faceva creando
delle variazioni su una modularità prestabilita, su un intreccio di elementi preordinati che, con leggere variazioni, venivano ripetuti, leggermente modificati e reinseriti nel corpo dell’esecuzione.
Questo perché spesso quando si parla di improvvisazioni si pensa – anche in
questo caso – a un qualcosa di immediato e ‘naturale’, a una produzione spontanea, come se venisse creata veramente sul momento. In realtà – mi spiegava Leo –
il suo concetto di attore era molto vicino a quello del jazzista, perché vive di repertori consolidati, di moduli recitativi o musicali pronti, che vengono semmai adattati alla situazione solo per trovare una adeguamento e una collocazione. Come fosse
un processo modulare, di riposizionamento, ma non certo di creazione
all’impronta come spesso si è portati a credere.
A questo si aggiungono poi gli accidenti, i casi, il fato, come una qualsiasi intromissione imprevista nel corso naturale delle cose. E su questo l’esempio migliore è
quello che segue e che ci permette di rimanere in ambito jazz: ecco un brano da una
recente ‘lezione’ di Herbie Hancock in cui racconta il suo lavoro con Miles Davis:
Fu Miles Davis, che nel 1963 lo chiamò a far parte della sua leggendaria band, a insegnargli “come trasformare il veleno in medicina” durante un concerto del loro quintetto a Stoccolma, nel 1967. «Era una di quelle rare serate di perfezione musicale e di
totale sintonia con il pubblico», racconta, spiegando che, «dopo uno straordinario assolo di Miles, in una pausa chiave, inciampai su una corda, stonando clamorosamente». Hancock si rese subito conto dell’errore. «Mi sembrava di aver frantumato una
magnifica scultura di cristallo». Ma il vero shock arrivò subito dopo, quando si accorse che Davis aveva risposto al suo errore con un’improvvisazione musicale che lo
incorporava nel fraseggio, rendendolo plausibile. «Invece di giudicare la mia stonatura come brutta e sbagliata, Miles la accolse come uno input inatteso, trasformandola in qualcosa di bello e virtuoso».25
Un accidente si trasforma così in una acquisizione di sonorità e viene inserito in
un repertorio preordinato che Davis avrebbe dovuto eseguire.
Questi esempi sono utili per dire che, tanto sul piano dell’azione teatrale quanto
in quello dell’esecuzione musicale, l’idea della spontaneità viene costruita come
25 Herbie Hancock, “Miles Davis mi insegnò: si può stonare”, La lettura. Il Corriere della sera, 116, 9
febbraio 2014.
Alla Gioconda si possono solo fare i baffi (e il pizzetto)
99
una sorta di pratica, se non di voluto inganno, per attirare il pubblico e mostrargli
attraverso la costruzione la verità dell’immediatezza. Avviene come ammoniva il
Sik Sik di Eduardo: il trucco non c’è e, se lo vedete, vi siete sbagliati.
10. Passiamo ora a due casi presi dal teatro, molto vicini a noi, geograficamente
e culturalmente.
All’inizio degli anni Settanta era vivissima l’attenzione a quelle che erano le cosiddette ‘culture popolari’. E in Campania non mancavano le occasioni: feste, riti,
pellegrinaggi. Ci si recava in tutti i luoghi dove c’erano musiche e spettacoli tradizionali per documentare quanto avveniva. Le campagne dell’hinterland e delle varie province venivano quindi passate al setaccio e i periodi caldi delle festività erano quelli più attesi.
Il racconto che sto per fare riguarda una di queste spedizioni realizzata nelle
campagne di Pomigliano d’Arco e mi riferisco, in particolare, a una serata passata
in uno dei grandi cortili contadini dove ci si fermava a sentire e registrare canti e
dove spesso ci veniva offerto del cibo.
Le spedizioni potevano avere partecipanti e testimoni molto diversi tra loro: si
andava dai gruppi di noi giovani che ruotavamo attorno alla cattedra di antropologia culturale di Luigi Maria Lombardi Satriani, ad Annabella Rossi, Paolo Apolito e Roberto De Simone, spesso accompagnati dal gruppo operaio “’E Zezi” di
Pomigliano per visitare le ‘cortine’, come venivano chiamati in dialetto i cortili
delle masserie della zona.
Una sera, in una di queste masserie dove ci eravamo fermati, a un certo punto si
scatenò tra alcune donne una discussione che andava infiammandosi sempre di
più fino a prendere i toni di un vero e proprio litigio. Si trattava di vicini e la vertenza riguardava le presunte generosità (di una) e avarizia (dell’altra). Dalle iniziali
provocazioni si passò alle dichiarazioni di guerra, poi alle offese fino alle ingiurie e
stavano per arrivare alle mani.
Gli uomini guardavano, quasi divertiti dello spettacolo: nessuno di loro interveniva altrimenti da “una cosa tra donne” il litigio si sarebbe trasformato in uno
scontro veramente serio.
Senza andare troppo per le lunghe, credo che questo litigio vero e reale, che fu
registrato e documentato e a cui hanno assistito in tanti, fa da riferimento realistico,
da base concreta, da rimando veritiero, in quella riscrittura de Lo Cunto de li Cunti
di Basile che venne trasformato e tradotto, proprio grazie a questo riferimento, in
una delle scene centrali della Gatta cenerentola.26
26 Cfr. Roberto De Simone, La Gatta Cenerentola. Favola in musica in tre atti, Einaudi, Torino, 1977;
Angela Albanese, Metamorfosi del Cunto di Basile. Traduzioni, riscritture, adattamenti, Longo, Ravenna,
2012, pp. 230-236.
100
Stefano De Matteis
La spontaneità di un litigio (informale) entra nello spettacolo, serve a riposizionare il testo originale di Basile, diventando una cosa ancora diversa: il riferimento
subisce le regole della formalizzazione che lo trasforma in linguaggio e lo trasferisce nello spettacolo. Acquisendolo al testo di Basile, ne diventa la modularità di
base.
E se non fosse stato formalizzato? Se non fosse stato utilizzato come corpo su
cui dare nuova vita a Basile? Sarebbe stato utilizzabile? Sarebbe servito a qualcosa?
Forse sarebbe rimasto solo un ‘documento’; probabilmente sarebbe sopravvissuto
come un frammento di realtà, forse come un reperto sonoro di un numero infinito
di appellativi; ma come oralità ripetuta ‘tale e quale’, come testo ‘da riprodurre’
sarebbe stato inutilizzabile, oltre che poco efficace e di scarso valore.
11. Rispetto a quanto abbiamo detto facciamo ancora una controprova: prendiamo come esempio La canzone di Zeza, quel contrasto comico che popolarmente si
mette in scena nel periodo di Carnevale.
Sempre Roberto De Simone con la Nuova compagnia di canto popolare ha messo in scena una Canzone di Zeza nel 1974, due anni prima di realizzare La Gatta.
In Campania ci sono due modelli popolari di riferimento per la Canzone di Zeza:
c’è la versione che si mette in scena nell’area di Pomigliano d’Arco, che il gruppo
operaio dei Zezi replica ogni anno, e la versione di Bellizzi Irpino realizzato da
attori anonimi.
De Simone, per trasferire in scena La canzone di Zeza, ha scelto il modello del
gruppo operaio, il ‘canovaccio’ di Pomigliano.
Tra le due, secondo me, si tratta della versione più spuria e immediata, mi verrebbe da dire la più ‘ruspante’. Partendo da questa ha costruito lo spettacolo: da
questa ha creato un nuovo spettacolo che, ovviamente, reinventa quell’originale.
Mi sono sempre chiesto perché la scelta sia caduta proprio su questo modello e
non sull’altro. La spiegazione che mi sono dato (e che non per forza deve essere
quella giusta) riguarda un dato estetico e linguistico: la Zeza di Bellizzi Irpino è,
secondo me, una delle versioni più formalizzate che esistono: è di grande forza
rappresentativa, segue un rigido canovaccio e una rigorosa ‘messa in scena’. Infatti,
il lavoro di preparazione è lungo; è difficile essere chiamati a interpretare uno di
quei ruoli che richiede un lavoro di preparazione significativo. Sebbene in entrambi i casi si tratti di spettacoli interpretati da soli uomini, c’è una differenza sostanziale. Nel caso di Bellizzi, sono gli uomini a essere donne e a creare degli straordinari ruoli femminili. Attenzione, ho detto ‘essere’ donne e non ‘fare’ le donne. Perché è facile cadere, come spesso succede nella versione pomiglianese, in uno spettacolo dove gli uomini fanno delle caricature femminili, offrendo dei risultati sicuramente comici, ma che paiono più delle prese in giro.
Ovviamente non entro in argomento – perché questo ci porterebbe a un’altra
questione che non affronterò in questa sede – ma una cosa è un uomo che ‘fa’ la
Alla Gioconda si possono solo fare i baffi (e il pizzetto)
101
donna, un’altra è un atteggiamento maschile che scimmiotta, play, recita e gioca a
fare la donna.
Secondo me anche in un territorio a noi prossimo e con un campione semplice
come la Canzone di Zeza, potremmo trovare la controprova di quanto sto cercando
di affermare dall’inizio: maggiore è la formalizzazione (linguistica, rituale, teatrale)
minore è lo spazio di libertà, d’invenzione e di reinvenzione da parte di un regista
o di una compagnia, di un interprete o di un artista. In quanto il modello risulta
troppo forte e diventa quasi ‘intoccabile’.
La versione di Bellizzi Irpino è infatti altamente formalizzata. È un linguaggio
standardizzato e strutturato, fermo e pronto ad essere ripreso e replicato con prove
e travestimenti lunghi e complicati. E questo rende difficile esportarlo e utilizzarlo.
Come dire, è troppo perfetta per riuscire a intervenire o a reinventarla ricavandovi
uno spazio per delle modifiche. Il suo linguaggio è troppo stabilito e costruito. Non
lascia margini d’invenzione e di trasformazione. Siamo di fronte a uno di quei casi
in cui l’originale non lascia spazio né alla copia, né alla reinvenzione. È questo il
motivo per cui credo che alla Gioconda si possono fare i baffi (e il pizzetto) come
Duchamp, i surrealisti o, ancor oggi, le si possono fare i capelli lisci o ricci, come
nella pubblicità. Ma non si può imitarla o migliorarla.
12. Per arrivare alle conclusioni. Se intendiamo l’oralità come atto di pronuncia
spontaneo, possiamo solo dire che l’oralità sulla scena è l’impossibile, allo stesso
modo come il realismo è l’impossibile: e Walter Siti ce l’ha mostrato sia negli scritti
teorici recenti27 sia nei romanzi (“Mi chiamo Walter Siti, come tutti” è l’incipit di
Troppi paradisi).28 Ogni volta che diciamo oralità costruiamo un linguaggio che usa
parole e espressioni. Possiamo fare un rito o possiamo fare teatro. O giocare sul
rapporto tra rito e teatro.
Ma sento che qui mi sto infilando in un guaio ancora più grosso per cui il rapporto tra rito e teatro lo lascerei per un eventuale altro seminario.
27
28
Walter Siti, Il realismo è l’impossibile, Nottetempo, Roma, 2013.
Id., Troppi paradisi, Einaudi, Torino, 2006.
102
Stefano De Matteis
ANGELA ALBANESE
CON BASILE ALLE SPALLE: LE GATTE DI ROBERTO DE SIMONE
“La parola è come acqua di rivo che riunisce in sé i sapori della roccia dalla quale sgorga e dei terreni per i quali è passata”.1 È questa la lezione autentica che si
ricava anche dalla lettura delle memorabili Pagine stravaganti di un filologo che
Giorgio Pasquali, filologo fra i più autorevoli e decisivi per la critica testuale, ha
dedicato all’arte allusiva e alle dinamiche intertestuali che essa innesca.
L’idea di mouvance e di “apertura del testo” (ouverture de chaque texte) sostiene
anche la riflessione di Paul Zumthor, a cui siamo debitori di studi fondamentali
sull’oralità della poesia e della letteratura del Medioevo, ossia di un’epoca a cui è
estranea la nozione di autenticità testuale. Mouvance nel senso di instabilità dei
testi, di una loro ‘mobilità essenziale’2 data non solo dalla mancanza di una fonte
autoriale dichiarata, ma anche dalla molteplicità delle versioni orali e scritte che li
hanno tramandati. Il testo, innanzitutto quello medievale nell’esempio più evidente dato dalla Chanson de Roland, è caratterizzato per Zumthor da “una incompiutezza virtuale”;3 è un’opera che “fluttua, non si circonda tanto di frontiere quanto
di un alone dove si producono mutamenti incessanti”. Così concepita, – commenta
Zumthor ad ulteriore chiarimento della sua idea di mouvance – l’opera “è per definizione dinamica. Essa cresce, si trasforma, declina. La molteplicità e la diversità
dei testi che la manifestano costituiscono il suo sfondo sonoro intimo”.4
E convergono verso una simile idea di instabilità e di movimento dei testi, già
nella loro veste originale oltre che nelle diverse forme di attualizzazione, anche le
riflessioni che il critico americano John Bryant ha raccolto nel saggio The fluid Text,
in cui insiste appunto sul concetto di ‘fluidità’ dei testi.5 È necessario per Bryant
innanzitutto imparare a guardare alla mutevolezza del testo non come elemento di
corruzione che ne minaccia l’autorità e la stabilità, ritenuta del resto una pura illusione (“this fantasy of textual stability…”),6 ma come strumento prezioso di comprensione della complessità di quel testo e della sua vivificante tradizione.
Instabilità, fluidità, movimento, metamorfosi dei testi che ne mettono in discussione l’identità unica. E le cose sembrano tanto più complicarsi nel caso delle fiabe,
1 Giorgio Pasquali, Arte allusiva, in Id., Pagine stravaganti di un filologo. II. Terze pagine stravaganti.
Stravaganze quarte e supreme, Le Lettere, Firenze, 1994, p. 275.
2 Paul Zumthor, Semiologia e poetica medievale, tr. it. M. Liborio, Feltrinelli, Milano, 1973, p. 72.
3 Ivi, p. 73.
4 Ivi, p. 74.
5 John Bryant, The Fluid Text. A Theory of Revision and Editing for Book and Screen, University of
Michigan Press, Ann Arbor, 2002.
6 Id., “Witness and Access. The Uses of the Fluid Text”, Textual Cultures: Texts, Contexts,
Interpretation, 2, 1, 2007, p. 17.
104
Angela Albanese
la cui tradizione scritta è stata ed è di continuo contaminata dalle molteplici versioni orali che si tramandano di bocca in bocca.
Ma qual è l’identità delle fiabe e dei racconti, anche nella loro forma scritta o letteraria? È un’identità ferma, bloccata nell’archetipo o piuttosto contaminata e aggiornata dalle loro continue repliche? Non è forse, quella delle fiabe, un’identità
mobile, rinnovata e risignificata di continuo dai diversi testimoni e dalle diverse
riformulazioni, riscritture, trasposizioni in altri codici e forme mediatiche? E riguardo alla fiaba di Cenerentola, qual è la sua vera storia? Ha davvero senso parlare, per dirla con Segre, di un unico originale corretto, o è piuttosto una storia fatta
di più originali corrotti?7
La prima versione occidentale della fiaba di Cenerentola in forma scritta si ritrova nel Cunto de li Cunti del napoletano Giambattista Basile, opera barocca che
inaugura la nascita del genere fiabesco. La diffusione orale della fiaba in circa settecento varianti è stata tuttavia rilevata un po’ in tutto il mondo: dall’America centrale e meridionale fino all’intera area indoeuropea e all’estremo oriente, partendo
dalla Cina del IX secolo, dove i folcloristi sembrano aver concordemente individuato la versione più antica del racconto.8 È merito di Marian Roalfe Cox aver intrapreso per prima il poderoso lavoro di ricostruzione di tutte le possibili varianti
della fiaba, nel suo studio pioneristico del 1893 in cui ne individuava 345 differenti
versioni. A questa prima indagine è seguita quella della folclorista svedese Anna
Brigitta Rooth che, nel suo libro Cinderella Cycle del 1951, ha provato l’esistenza di
circa ben 700 varianti, raddoppiando di fatto i numeri già sorprendenti di Cox.9
I racconti di Basile, complice anche la forma vivace del dialetto che ne esalta il
ritmo e la virtualità performativa, sono del tutto impregnati di oralità e contaminati dalle molteplici versioni orali che li hanno tramandati. Fiabe scritte per essere
lette o recitate ad alta voce, come forma di passatempo cortigiano nel momento
rituale del dopopranzo, in cui si dava spazio ai canti, ai giochi di corte, alle danze e
alla narrazione di storie. Il Cunto de li Cunti è una sofisticata opera letteraria, scritta
da un uomo di lettere che però era anche un uomo di corte, organizzatore di spettacoli e di feste. Per questo è anche un “copione teatrale, che non manca di includere i modi tipici dell’oralità”, dalle regole del ‘narrato intorno al fuoco’ a quelle ‘del
teatro di strada’.10
La dimensione della oralità e il potenziale performativo sono dunque connaturati alla stessa origine dei racconti di fiabe: “la fiaba” – suggerisce Sanguineti – “è
Cesare Segre, I segni e la critica, Einaudi, Torino, 1969, pp. 87-91.
Una nutrita rassegna di versioni di Cinderella è in Neil Philip (a cura di), Cinderella Story: The Origins and Variations of the Story Known as Cinderella, Penguin, Harmondsworth, 1989.
9 Cfr. Alan Dundes (a cura di), Cinderella. A Folklore Casebook, Garland, New York-London, 1982, che
raccoglie, insieme alle principali elaborazioni letterarie della fiaba, anche utili saggi critici.
10 Michele Rak, Introduzione, in Giambattista Basile, Lo cunto de li cunti, a cura di M. Rak, Garzanti,
Milano,1986, pp. XXXIII-XXXIV.
7
8
Con Basile alle spalle: le Gatte di Roberto De Simone
105
cosa da ascoltare, in cui gesto e intonazione, mimica e pause, tengono un ruolo
capitale. Ancora un passo e diremo tranquillamente che la fiaba è un genere teatrale, che postula un recitante e un pubblico, anche ridotto a un ascoltatore solitario”.11 E la conferma arriva direttamente dalle fiabe raccolte nel Cunto de li Cunti di
Basile, la cui virtualità scenica è stata perfettamente intuita da Roberto De Simone,
etnomusicologo, compositore, drammaturgo, regista teatrale e traduttore di Basile,
che nel 1976 riprende La Gatta Cenerentola, sesta fiaba della prima giornata del Cunto, per ricavarne l’omonimo copione teatrale. È a Spoleto, nell’ambito del Festival
dei Due Mondi del luglio 1976, che per la prima volta quel copione prende vita,
nella forma di una “favola in musica in tre atti”.
La trasposizione per la scena è per il regista napoletano occasione preziosa e necessaria per la vita del testo, per il suo movimento e contagio fecondo attraverso
inedite e persino inattese reincarnazioni; ad una relazione dinamica con la tradizione si affida la ricerca etnologica e teatrale di De Simone, ad un rapporto dialettico che sottragga i testi al loro congelamento in forme fisse e date una volta per
tutte, alla loro sterile relegazione in fondo alle biblioteche: “Il passato in sé non
serve a niente” - precisa il regista – “rischia di essere il culto mortuario di una tradizione che nessuno più conosce. Bisogna sezionarlo, violentarlo, renderlo umoralmente vivo. … Per avere forza, la tradizione deve ripassare nel sangue vivo
delle nostre vene e nella nostra carne”.12 La Gatta Cenerentola di De Simone dà appunto corpo alle parole irrequiete che affollano la fiaba di Basile, contaminandole
sapientemente sia con accennati rimandi ad altre fiabe del Cunto, sia con la voce, il
corpo e il ‘sangue vivo’ dei narratori di varianti orali campane della stessa storia.
Anche a questo scopo è programmaticamente assente dalla scena di De Simone
ogni rimando sia alle successive e più celebri riscritture letterarie della fiaba ad
opera di Perrault e dei fratelli Grimm, sia al moderno adattamento cinematografico
disneyano. Quello che davvero interessa al regista napoletano, anche in virtù della
feconda collaborazione e convergenza di ricerche con la “Nuova Compagnia di
Canto Popolare”, è integrare invece la fonte letteraria basiliana con alcune varianti
orali, da lui stesso registrate in area campana e poi raccolte, in traduzione italiana,
nel volume Fiabe campane. I novantanove racconti delle dieci notti.13
La prima variante, come noto, è quella riferita nel 1975 da due contadini di Boccia al Mauro, in provincia di Napoli, la cui versione de ‘A jatta Cennerentola (La
gatta Cenerentola) riprende esattamente il titolo basiliano oltre al contenuto generale, fatte salve alcune differenze. L’altra versione orale evocata nello spettacolo è
quella raccolta nel 1974 a Villa di Briano, in provincia di Caserta ed ha il titolo di
11 Edoardo Sanguineti, La donna serpente come fiaba, in Carlo Gozzi, La donna serpente con saggi critici
sul teatro di Gozzi, Edizioni del Tetro di Genova, Genova, 1979, p. 13.
12 Paolo Di Stefano, “Ma ora liberiamoci di Eduardo”, Corriere della Sera, 19 gennaio 2006, p. 58.
13 Roberto De Simone, Fiabe campane. I novantanove racconti delle dieci notti, Einaudi, Torino, 1994.
106
Angela Albanese
Rospacennere.14 Alle testimonianze desunte dalla tradizione orale campana De Simone affianca poi elementi mitici e rituali, sollecitati anche, ma non solo, dagli
studi di Ernesto de Martino sul mondo magico meridionale e le forme di sincretismo religioso, che tanta influenza hanno avuto sull’indagine etnologica del regista
partenopeo: per esempio, il riferimento al ballo terapeutico dei tarantati che ispira
con uguale funzione catartica il convulsivo ballo erotico delle lavandaie nel terzo
atto dello spettacolo; oppure il motivo della perdita della scarpetta presente nel
culto popolare della Madonna di Piedigrotta a Napoli. Secondo una tradizione
locale ancora ben presente ai pescatori di Mergellina – spiega il regista
nell’appendice al testo teatrale – alla stessa Madonna è successo di perdere una
pianella sulla spiaggia; la scarpa, poi ritrovata da un pescatore, avrebbe portato
alla scoperta nella grotta di Posillipo di una statua della Vergine, da cui ha avuto
origine il relativo culto simboleggiato proprio da “un talismano in forma di pianella (‘o scarpunciello d’ ‘a Maronna)”, simbolo di fecondità.15 Il riferimento esplicito
al culto religioso della Madonna di Piedigrotta è inserito, in forma di rievocazione
e di racconto, ancora nel terzo atto ed è affidato al visionario dialogo fra una zingara e alcune lavandaie, che spettegolano sull’evento della misteriosa perdita della
pianella a palazzo reale.
Di fatto sono numerosi i punti di contatto fra la versione letteraria di Basile e le
sue varie espressioni popolari che, ben amalgamate nel copione teatrale, la ripropongono come una “aggregazione e una stratificazione di diversi fatti mitici, religiosi, rituali d’iniziazione, fatti di costume, elementi storici e fattori psicologici”.16
Basta leggere la versione basiliana della Gatta Cenerentola, insieme a qualche variante orale di area campana, per rendersi conto di quanto questa Cenerentola,
seppure opera di letterato destinata al pubblico colto della corte, sia intimamente
legata agli aspetti più autentici della tradizione popolare di quella terra in cui per
la prima volta Lo Cunto de li Cunti ha visto la luce. Così come basta leggere la versione basiliana della fiaba e confrontarla invece con le sue successive riscritture
letterarie sette-ottocentesche o con le versioni cinematografiche, che riconosciamo
con rassicurante familiarità, per accorgersi che non si tratta esattamente della stessa
storia. Perrault e i Grimm omettono, per esempio, un particolare non di poco conto
dell’incipit di Basile: la storia si apre con un omicidio, quello della prima matrigna,
e l’assassina è proprio Cenerentola. Nella versione di Basile la protagonista Zezolla
è istigata dalla maestra di cucito ad uccidere la malvagia matrigna, con la promessa
che, se convincerà suo padre a prendere poi lei in sposa, le saranno riservate tutte
14 Per il dettagliato confronto fra il testo di Basile e le due versioni orali di Boccia al Mauro e Villa
Briano cfr. Roberto De Simone, La Gatta Cenerentola. Favola in musica in tre atti, Einaudi, Torino, 1977, pp.
121-122.
15 Ivi, p. 123.
16 Ivi, p. 122, ma per la dettagliata interpretazione in chiave mitica e rituale della fiaba cfr. l’intera
appendice di De Simone.
Con Basile alle spalle: le Gatte di Roberto De Simone
107
le attenzioni fino ad allora negate. Zezolla, convinta dell’esito positivo del piano, lo
esegue, e nella maniera più truce: approfittando della distrazione della matrigna,
mentre questa è ripiegata in un cassone a cercare un cencio di veste per la figliastra, le chiude violentemente il coperchio della cassapanca sulla testa rompendole
l’osso del collo.
In nessuna redazione della fiaba successiva a Basile, e in questo caso neanche
nelle varianti popolari campane pure così simili al testo secentesco, rimane traccia
di questo assassinio. Lo rimuovono i Grimm, pur nella loro efferata versione noir
della fiaba, e nessun matricidio si consuma neanche nella precedente versione sublimata di Perrault, né tanto meno nell’adattamento disneyano. È soltanto nella
trasposizione teatrale di De Simone che l’omicidio originario ritorna nella forma di
richiamo, di allusione. Leggiamo la didascalia del copione:
La matrigna abbassa la testa fino a sparire dietro la cassa. Il coperchio retto dalle mani di Cenerentola vacilla, come se esitasse a scendere pesantemente sulla testa della
donna china a cercare tra la biancheria. Il rullo di timpani cresce d’intensità fino ad
arrestarsi di colpo. A tale punto la matrigna ritrae il capo un attimo prima che il coperchio, sfuggito dalle mani della ragazza, cada con un sordo tonfo. Nel silenzio che
segue le due donne si guardano immobili.17
Dunque il delitto stavolta non è compiuto, anche se ci è mancato poco. In questo passaggio il riferimento intertestuale è chiaro. La differenza fra la favola di
Basile e la traduzione di De Simone sta nel dettaglio della esecuzione materiale del
matricidio, ma l’originaria volontà criminale di Cenerentola è tradotta e mirabilmente portata in scena dal regista con la felice intuizione del sottinteso rimando ad
un crimine che non accade ma che potrebbe accadere, come è già è accaduto
nell’ipotesto basiliano.
Esiste una evidente ‘relazione traduttiva’18 fra il testo originale e la sua trasposizione teatrale, che in questo passaggio, come si è detto, trascura intenzionalmente
le versioni orali della storia. “L’idea di fedeltà” – chiarisce bene Dusi – “si stempera
infatti, almeno in parte, quando si riconosce che si tratta di tenere assieme più di
una equivalenza, a seconda del livello del testo di partenza che si vuole cercare di
‘rendere’ nel nuovo testo”.19 E almeno due sono i livelli della fiaba di Basile che la
riscrittura scenica della Gatta Cenerentola prova a restituire, anche complici le sue
fonti orali ben incastonate nella messa in scena. Da una parte il ritmo del testo di
Basile e dell’altra il livello diegetico o narrativo, che porta De Simone ad assumere
proprio la dimensione del cunto come punto di vista privilegiato della messa in
scena.
Ivi, p. 19.
Nicola Dusi, Il cinema come traduzione. Da un medium all’altro: letteratura, cinema, pittura, Utet, Torino, 2003, p. 9.
19 Ivi, p. 72.
17
18
108
Angela Albanese
Partiamo dal livello narrativo della trasposizione. “L’azione si racconta nella fantasia di un antico cortile di Napoli”.20 Così recita la didascalia che De Simone riporta
in apertura del suo testo teatrale; una didascalia fortemente indiziaria in cui, mentre
dà indicazioni di regia, il drammaturgo preannuncia anche la propria strategia traduttiva, esplicitando l’intento di privilegiare il livello diegetico rispetto al modo strettamente rappresentativo. E di fatto ciò che il regista porta in scena non è tanto la
drammatizzazione della fiaba, quanto la sua rievocazione visionaria, onirica, rituale,
sapientemente distribuita fra la recitazione, il canto e la danza dei personaggi. E così,
la matrigna racconta nella “canzone dei sette mariti” la sua lunga e onorata carriera
di moglie e di vedova, mentre la capèra le acconcia i capelli in vista del ballo a palazzo reale; la prima lavandaia, nel ritmo convulso e febbrile del ballo, racconta alle altre
donne il sogno del suo immaginario incontro d’amore con il re; infine è la stessa Cenerentola, durante le tre notti del ballo, a raccontare ad un principe invisibile le diverse versioni che tramandano la sua storia, fino alla rievocazione della fiaba matricida di Basile con l’auspicio di riuscire a replicarne il gesto efferato.
Ai suoi personaggi De Simone assegna dunque lo stesso compito assunto nel Pentamerone dalle narratrici intradiegetiche, quello cioè di narrare la storia più che rappresentarla, di far avanzare il racconto di ciò che è già accaduto e che l’evento teatrale
rievoca. Nella sua Poetica, illustrando le forme della imitazione artistica, Aristotele
distingue fra quella narrativa, di cui si fa carico o l’autore in prima persona o un
interprete unico riferendo in forma indiretta i discorsi degli altri personaggi oppure
interpretandoli e prestando loro la voce, e la forma drammatica, in cui l’azione non è
più raccontata da un solo narratore, ma rappresentata dai diversi attori in scena. 21
Sembra chiara la differenza fra le due modalità delineate da Aristotele, eppure le
cose si complicano quando si cerca di ricondurre ad uno di questi due modi rappresentativi la trasposizione teatrale di De Simone, che sembra invece attingere sia
dall’uno che dall’altro: il modo del racconto, privilegiato rispetto alla drammatizzazione della fiaba, sembrerebbe inquadrare lo spettacolo nella forma narrativa, se non
fosse che La Gatta Cenerentola è invece un’opera corale, che affida la polifonica narrazione della fiaba alla presenza sulla scena non di uno, ma di più personaggi.
Nel disegnare una possibile mappa dei diversi tipi di teatro del racconto, Pier
Giorgio Nosari ha distinto la narrazione pura e la narrazione drammatizzata, variante della prima, dal dramma narrativo. La narrazione pura e quella drammatizzata prevedono entrambe la presenza di un autore/attore unico, nel primo caso in
una scena del tutto vuota, “senz’altro strumento che le proprie capacità affabulatorie”, e nel secondo coadiuvato invece da “scarni oggetti di scena che entrano
nell’affabulazione come elementi di rinforzo”,22 come accade per esempio per la
De Simone, La Gatta Cenerentola, cit., p. 4 (corsivo nostro).
Aristotele, Poetica, in Opere, vol. X, tr. it. M. Valgimigli, Laterza, Bari, 1988, p. 196.
22 Pier Giorgio Nosari, “I sentieri dei raccontatori di storie: ipotesi per una mappa del teatro di
narrazione”, Prove di drammaturgia, 10.1, 2004, p. 12.
20
21
Con Basile alle spalle: le Gatte di Roberto De Simone
109
lavagna o il tavolino di cui si serve Marco Paolini nel suo Vajont. Lontana dalle
prime due forme teatrali individuate da Nosari, La Gatta Cenerentola può forse essere accostata – con tutte le rigidità delle classificazioni e nella ribadita consapevolezza della complessa natura polisemica di uno spettacolo come quello del drammaturgo napoletano – al terzo tipo del dramma narrativo, definibile per il critico
“in termini di narrazione a più attori”, in cui la parte raccontata e quella agita “si
compenetrano e si rilanciano”.23 Precisa Nosari che “nel dramma narrativo
l’intreccio di piani … si moltiplica ulteriormente e su due fronti: nella presenza
contemporanea di più attori-narratori e nelle loro combinazioni ed interazioni.
Garanzia di unità è in questo caso l’architettura drammaturgica, che fonde le narrazioni e le comprende, magari riscoprendo moduli rituali”.24 E l’impalcatura
drammaturgica che nella Gatta ‘fonde’ le diverse narrazioni è data appunto dalla
perfetta modulazione ritmica di tutte le componenti dello spettacolo, dalla recitazione al gesto rituale alla danza al canto.
Il narrare è evidentemente anche un lavoro sul suono e sul ritmo, e proprio la
felicità del ritmo – sia quello barocco di Basile che quello connaturato alle narrazioni orali della fiaba - costituisce l’altro livello testuale che il regista restituisce e
potenzia con la sua messa in scena. Come unico esempio della dirompente portata
ritmica dello spettacolo, basti pensare all’animato scambio di ingiurie del terzo
atto, appena prima della fatidica prova della scarpa, fra la matrigna e la figlia Patrizia da un lato e le lavandaie dall’altro, a cui fa da comico sottofondo il ritmo
contrappuntistico del coro dei soldati. Ne riporto a titolo esemplificativo, un breve
stralcio e solo nell’originale perché l’attenzione rimanga ferma sull’effetto sonoro
del brano, anziché disperdersi nella ricerca dell’esatto significato dei termini:
MATRIGNA
Fuchèra!
LAVANDAIE
Capèra!
PATRIZIA
Chiachièra!
LAVANDAIE
Chiazzèra!
MATRIGNA
Lumèra!
LAVANDAIE
Trammèra!
PATRIZIA
Culèra! ….
LAVANDAIE
Concola ‘e cantenèra!
23
24
Ivi, p. 13.
Ibid.
110
Angela Albanese
PATRIZIA
Maneco ‘e cafettèra!
LAVANDAIE
Cuperchio ‘e ‘nzalatèra! ….
MATRIGNA
Zandraglia perigliosa! ….
PATRIZIA
Piera storta de papera!
LAVANDAIE
Tallune fatte a pprovola! ….
Brutta scigna cacata! ….
MATRIGNA
Zellosa!
LAVANDAIE
Fetosa!
PATRIZIA
Merdosa! ….
LAVANDAIE
Voccola rugnosa!
PATRIZIA
Maneco ‘e scopa ‘nfosa!
LAVANDAIE
Forbice ca taglia e cose!
MATRIGNA
Pettula chin’ ‘e pertose! ….
LAVANDAIE
Gatta cecata!
PATRIZIA
Tozzola spugnata!
LAVANDAIE
Pereta ‘mbarzamata!
MATRIGNA
Trummetta scurdata! …
LAVANDAIE
‘Furnacella sfunnata!
ASSO DI BASTONI
E mmò sfucate! …
E pigliateve a mazzate!25
È un passaggio centrale per comprendere il lavoro fatto da De Simone sulle potenzialità acustiche delle singole parole, tanto da indurlo a far recitare la scena non
solo sulla musica dei soldati, ma anche “con l’aggiunta del metronomo in modo
che non si potesse andare fuori tempo e non ci fosse spazio per le sbavature”.26
De Simone, La Gatta Cenerentola, cit., pp. 103-106.
Annamaria Sapienza, Il segno e il suono. La Gatta Cenerentola di Roberto De Simone, Guida, Napoli,
2006, p. 175.
25
26
Con Basile alle spalle: le Gatte di Roberto De Simone
111
Una mirabolante impalcatura di ingiurie, un’architettura linguistica e ritmica
esemplare che De Simone riesce ad allestire in virtù della sua conoscenza profonda
non solo della tradizione orale campana, ma anche dell’intero corpus dialettale di
Basile, oltre che del Cunto. E di fatto questa volta non dal Cunto né dalla fiaba di
Cenerentola il drammaturgo trae suggestione per la scena delle ingiurie, ma dalla
quarta egloga delle basiliane Muse napolitane, i cui le due donnacce Pascadozia e
Colospizia si scambiano un elenco di oltraggi virulento, variopinto e di straordinaria musicalità.27 Ragioni di spazio non consentono qui il confronto fra i due brani,
ma la loro somiglianza è davvero sorprendente, per il comune ricorso non solo alla
cadenza rimata degli insulti, ma anche ad identiche voci di repertorio quali “zandraglia perigliosa”, “piera storta de papera”, “tallune fatte a pprovola”, “brutta
scigna cacata”.
Uno speciale patto di fedeltà sembra stabilirsi fra la riscrittura teatrale di De
Simone, la fiaba originaria di Basile e le sue varianti orali: fedeltà alla dimensione
del racconto e ai ritmi del testo, fedeltà alle tonalità di una fiaba che si presenta a
chi legge, a chi ascolta e a chi guarda in un “pullulare di motivi che vengono da
tutte le parti”,28 come sempre accade per le fiabe. Ancora qualche riflessione conclusiva affidata alle parole di Gianni Celati:
Ascolta. Se tu prendi una narrazione come un oggetto ben determinato, chiuso nei
limiti della pagina scritta, sarai sempre ossessionato dall’incombenza del profitto,
delle vendite, del pubblico. Se invece tu prendi una narrazione non come un oggetto
determinato, ma come un evento – qualcosa che accade, come una ventosità che passa da una testa all’altra … ecco … se non prendi una narrazione come un oggetto ma
come una ventosità che ti investe, come un flusso immaginativo, che porta emozioni
e pensieri, allora non c’è dubbio che corrisponda a un moto espansivo di contentezza. E
non viene fuori niente di buono se non c’è quella contentezza, che è la stessa degli incontri con sconosciuti dove ci si scambia pensieri e fantasie, o la stessa degli incontri
amorosi segreti e fluidi.29
La trasposizione scenica della Gatta Cenerentola sembra davvero un’esperienza
di “contentezza assoluta” per De Simone, proprio perché quel testo di partenza,
così fortemente contaminato di oralità, si è rivelato al regista un testo aperto, “con
finestre ovunque”.30 Proprio in virtù dell’essere testi con finestre ovunque, le fiabe
possono essere di continuo riscritte e ri-raccontate. È come quando si fa rotolare un
sasso e si scopre un verminaio. Non si può far finta di niente, ricoprirlo, e via.
27 Giambattista Basile, Lo Cunto de li Cunti overo lo trattenemiento de peccerille, Le Muse napoletane e le
Lettere, a cura di M. Petrini, Laterza, Bari, 1976, pp. 495-497.
28 Gianni Celati, Conversazioni del vento volatore, Quodlibet, Macerata, 2011, p. 108.
29 Ivi, p. 110 (corsivo nostro).
30 James Hillman, Re-visione della psicologia, tr. it. A. Giuliani, Adelphi, Milano, 1983, p. 93.
112
Angela Albanese
VINCENZA DI VITA
VINCENZO PIRROTTA TRA CUNTO E SACRE-VIE NELL’APOCALISSE
DI UN FARO AL BUIO
La grande poesia è sempre una liturgia. Ma questa liturgia
non è più riferita, come in altri tempi, alla celebrazione delle
divinità; essa piuttosto si lega alla celebrazione del nulla.
Georges Lapassade, Stati modificati e transe
La parabasi era il momento clou delle commedie del V secolo: il
coro deponeva la maschera uscendo dalla trama, sfilava davanti al pubblico e gli parlava in prima persona, a nome del poeta.
Il tema era l’attualità teatrale e politica, che il poeta affrontava
apertamente con tanto di nomi e cognomi.
Andrea Capra, Catalogo INDA 11 maggio/23 giugno 2013
La scrittura scenica di Vincenzo Pirrotta si realizza nella modalità vocale che
diviene corpo e gesto attraverso un sapiente e inedito uso del racconto orale, alimentato da antiche ed esoteriche radici. Un misterioso logos generato dal cunto
siciliano reca nuova linfa alla potenza espressiva di una mitologia legata alla satira
e alla commedia classica, come esemplificato dal suo adattamento da Le Donne al
Parlamento di Aristofane.1 L’urgenza di raccontare la verità attraverso la finzione
mediata dalla rappresentazione è resa con vigore e spiazzante potenza cronachistica, trovando ottimi esiti in operazioni drammaturgiche come Terra Matta, Sacre-Stie
o Supplici a Portopalo per la regia di Gabriele Vacis.
Ogni ruolo interpretato dall’attore diviene luogo di ricerca sulla parola e sulla
scrittura, rilevabile soprattutto attraverso la tecnica di rimodulazione del testo teatrale e della sceneggiatura nell’opera Il Faro al Buio,2 lavoro in cui il ruolo del performer assume un’imponente caratura, avviando un processo d’improvvisazione
1 Andato in scena dal 13 maggio al 17 giugno 2013 al Teatro Greco di Siracusa in occasione del XLIX
ciclo di rappresentazioni classiche.
2 Sullo spettacolo non esiste una bibliografia attualmente. Questo contributo si basa pertanto
sull’osservazione diretta della lavorazione, dalla progettualità alla realizzazione dello spettacolo,
avvenute tra aprile e luglio 2011. Il supporto documentativo, utile in questa sede è fornito da coloro che
hanno lavorato al progetto prodotto da Gigi Spedale per “Querelle”, supportato dall’Assessorato al
Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e dal “Circuito del Mito”. L’avventura scenografica ha
condotto lo spettacolo in location sempre diverse e itineranti, attraverso un’accurata ricerca, da parte del
regista e dei suoi collaboratori, che si sono recati in luoghi con fari evocativi nell’arcipelago delle Eolie;
dopo il debutto messinese, nel mese di luglio, Salina e Stromboli hanno ospitato il coraggioso evento,
allestito su spiagge, in riva al mare e non in consueti teatri. Chi scrive ha lavorato al progetto come aiuto
regia.
114
Vincenza Di Vita
corporea e vocale. Gesti e suoni creano così la scenografia d’insieme, sovrapponendosi a costumi e maestosi oggetti di scena, che appaiono tuttavia a una prima
superficiale visione come mero ologramma o fittizio supporto didascalico. È animata da un pulsante ritmo la costruzione dello spazio con l’apparizione di manufatti scenici, seguendo un’arcana magia che traghetta la parola, la cerca e le si appella, mediante ampie azioni drammaturgiche, rivolte a una sacralità invocata:
incarnata nella ricerca orale di una lingua primigenia e dimenticata.
La salvezza di Bilal, protagonista di questa storia apocalittica, dipende dal ritrovamento di una parola definitiva e originaria e dalla visione di una luce, metaforicamente ritratta in un faro, ovvero un minareto che il novello muezzin Bilal
proverà a raccontare invocando preghiere in arabo a un Allah senza tempo e senza
luogo. Da una preghiera sussurrata e poi recitata, infine urlata, nasce una messa in
scena che si rivela improvvisazione incessante di un mito della salvezza preesistente all’umano, dagli uomini forse occultato.
Comprendere come la tradizione orale possa essere incarnata sulla scena e trasmessa, operando un adattamento linguistico, in Pirrotta si configura presupposto
d’interesse privilegiato. Nel momento in cui la parola diviene l’attendibile protagonista di un’azione prima scritta e poi enunciata e, quindi perseguita oralmente
su un palcoscenico itinerante, l’istante visivo prende davvero il sopravvento
sull’azione vocale? Il buio allegorico di una luce spenta segna la fine dello spettacolo e l’accoglienza degli applausi. La metafisica del buio potrebbe ospitare la brutale
estetica di un vacuo silenzio o interrogare la presenza di un sacro assente o, forse,
l’accettazione di un umano e travolgente divino che brami una presa di posizione
corporea e, quindi politica.
Breve sinossi dello spettacolo
In un ipotetico futuro un evento apocalittico ha distrutto la terra. Bilal è l’unico
sopravvissuto a un’esplosione atomica, lo intuiamo dai continui riferimenti a
boati e radiazioni. Durante il corso della vicenda lo spettatore si troverà davanti a
un’ambientazione grigiastra e verde con sprazzi di vernice fosforescente intesi a
evocare, attraverso gli oggetti e i costumi scenografati, la contaminazione radioattiva. I costumi imitano divise militari, l’attrezzeria da caserma lascia intendere che l’esercito ha offerto aiuti ai superstiti o che semplicemente sovrabbo ndassero tali elementi. Il personaggio di Francu è anch’egli fortemente intriso di
verde e grigio, i volti degli interpreti e le loro mani sono imbrattati di polvere e
fango (vedi figura 1)3. La profonda solitudine in cui si trova il protagonista è
ciclica e sarà interrotta solo dall’arrivo di un altro uomo, forse solo immaginato, a
3
Il ruolo di Fungu è interpretato dal coreografo Antonio Gullo.
Vincenzo Pirrotta tra cunto e sacre-vie nell’apocalisse di un Faro al Buio
115
cui Bilal racconta di non riuscire a ricordare una formula, forse una preghiera,
che potrebbe trarre in salvo gli ultimi uomini rimasti. Alla fine Bilal si ritroverà
solo come all’inizio della pièce e al buio. In questa ultimissima scena è egli stesso
ad aver spento con un soffio una speranza ormai impossibile, evocata infatti da
una fioca luce.
Il dramma di parole di sangue
“Napoli da un lato, l’Isola di Sicilia dall’altro: antropologicamente e storicamente terre di teatro” scrive Anna Barsotti;4 ed è una motivazione territoriale e quindi
geografica quella che si ravvisa in modalità assimilabili a un vero e proprio caso di
Dramma Sud.5 Nella azione collettiva dell’oralità condivisa si trova la capacità di
superare un rigido binarismo sessuale e performativo, tipico di azioni riconoscibili
nell’adattamento antropologico a un’origine matriarcale, che tende a fondere e
confondere dettami non più resistenti alla odierna ‘nostalgia del nulla’.6 L’oralità
attuale è pertanto ‘meccanicamente oralizzata’7 accogliendo in sé una compresenza
del virtuale animato. La fiducia nella parola8 che provoca uno smontaggio del testo
sulla scena diviene corpo androgino e imponente, così evidente da sovrastare con
la voce la parvenza scenica e superare i limiti delle leggi della fisica, mediocre giustificazione apparentabile a un’etica estranea e puramente didascalica. Così la contaminazione dei registri e dei linguaggi diviene modello estetico ed esercizio ginnico, impossibile tuttavia senza un confronto con il pubblico. Il mito e la tragedia
rendono viva l’azione enfatizzata dal processo empatico con gli spettatori, rivelando una drammatica rappresentazione di un vissuto negato, rimosso, narrato.
È palese fin dal primissimo tentativo drammaturgico intrapreso con N’gnanzoù9
che l’autore e attore Pirrotta voglia giocare con il linguaggio, apprendere e andare
alla ricerca di radici profondissime che trovano luogo privilegiato nella memoria di
figure sacerdotali o totemiche. Ma sono ritmo e manifestazione fonetica che danno
vita alla rielaborazione del popolare. Così il ‘raisi’ della tonnara di Favignana, luogo divenuto ormai un museo, attraverso una formazione innestata su teatro
d’avanguardia e sperimentale, assume le forme di una phoné che incarna la sua
4 Anna Barsotti, La lingua teatrale di Emma Dante. mPalermu, Carnezzeria, Vita mia, Edizioni Ets,
Pisa, 2009, p. 43.
5 Cfr. inserto speciale “Dramma Sud”, in Prove di drammaturgia, 15.2, dicembre 2009, pp. 20-26.
6 Ernesto De Martino, Furore Simbolo Valore, Feltrinelli, Milano, 2002.
7 Cfr. Massimo Fusillo, Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena, infra, pp. 19-31.
8 Sebbene in contesti differenti e riguardo ad artisti in cui l’oralità assume altre connotazioni e
urgenze, tale rapporto tra corpo e voce viene indagato in L. Amara e P. Di Matteo (a cura di), Teatri di
voce, (Culture Teatrali, 20), 2010.
9 Il testo fa parte della trilogia I tesori della Zisa, che comprende oltre N’gnanzoù, La fuga di Enea e La
morte di Giufà. Cfr. V. Pirrotta, N’gnanzoù. Storie di mare e di pescatori, prefazione di A. Lezza, Plectica,
Salerno, 2005.
116
Vincenza Di Vita
compresenza mimetica nel cunto da una parte, ma quello di Mimmo Cuticchio10 –
per cui un teatro d’opera che scarifica la tradizione palermitana, per insinuarsi
fortemente nel Maggio francese, con una poetica innovatrice e politica – e in Carmelo Bene dall’altra. Pirrotta, riferendosi al suo rapporto con il teatro di chi lo ha
preceduto, facendo sì che l’iterazione di “o issa” venga apparentemente svuotata di
significato e tradotta nel mantra originario di “n’gnanzoù” rivela:
Sento di avere un forte legame con quello che un tempo era il teatro di ricerca e che
adesso è diventato teatro di tradizione: sicuramente Carmelo Bene per l’uso della voce e Gianni Santuccio per la ricerca del personaggio […] Ogni gesto, infatti, ha il suo
ritmo, perderlo equivale a infrangere un’armonia. […] Dentro i gesti c’è la Commedia
dell’Arte, il cunto e il racconto della città. Un gesto che appare naturale ma che, in
realtà, esige uno studio meticoloso e paziente.11
Porcheddu ha recentemente scritto su questa primissima opera pirrottiana:
Nel suo recitare Pirrotta non si fa narratore, neppure interprete. Tiene consapevolmente, sin da questo suo primo lavoro, un filo sospeso tra un teatro di narrazione
(ormai inascoltabile) e uno di rappresentazione (ormai impossibile): lui, così possente e presente, resta comunque se stesso, anche quando dà voce all’uno o all’altro
dei protagonisti di questa storia, ne assume gesti, toni, pensieri. Il fatto poi di intervallare il racconto con le canzoni, “strania” ancor più la possibile immedesimazione,
nel momento in cui la riafferma: i pescatori cantavano, infatti, proprio quelle canzoni
là e dunque, nella filologia, la ricerca si apre, in modo intrigante, a un esito scenico
paradossalmente (post) brechtiano, ossia miracolosamente critico, accentuato dal bel
fondale dipinto di Lele Luzzati, tutt’altro che verista.12
L’oralità è quindi rinnovata nel continuo darsi sulla scena mediante le opere e il
racconto che mai si stacca dal rapporto rinnovato con il pubblico, non seguendo la
scrittura d’inchiostro ma quella fatta delle reazioni del pubblico, di una magia
straniante, di respiri e sguardi sui quali si tesse l’armonia della violenza di un racconto iterato e ritmico.
L’incontro immaginario con Pasolini presente nell’opera All’ombra della collina
viene così descritto mediante un dialogo-parola che violentemente s’impone:
VICIUZZU: Chi sei?
PIER PAOLO: Pier Paolo Pasolini.
VICIUZZU: Che sei venuto a fare? Cosa vuoi da me?
PIER PAOLO: Parlare con te.
Cosa è successo dopo la scoperta dei libri?
10
Cfr. Valentina Venturini, Dal Cunto all'Opera dei pupi. Il teatro di Cuticchio, Dino Audino, Roma,
2003.
Vincenzo Pirrotta, Proseguire fuggendo la via della tradizione, in Prove di drammaturgia, cit., pp. 29-31.
Andrea Porcheddu, A Messina vibra ancora il cunto di Pirrotta, Linkiesta, Milano,
<http://www.linkiesta.it/blogs/l-onesto-jago/messina-vibra-ancora-il-cunto-di-pirrotta> (11/13).
11
12
Vincenzo Pirrotta tra cunto e sacre-vie nell’apocalisse di un Faro al Buio
117
Pier Paolo, e Viciuzzu si siedono accanto sulla panchina,
come due anziani e cominciano a raccontarsi.
VICIUZZU: Sono cresciuto con loro, insieme a loro, era
la mia scoperta, era come se avessi io stesso generato
quei volumi, come se fossi stato padre di ognuno di
loro, li nutrivo e mi nutrivo di loro, li mangiavo, li
divoravo, come quando in campagna non finivo mai
di mangiare i gelsi rossi, aggattaiolato sull’albero,
mangiavo gelsi e il loro succo dolce e aspro insieme
scendeva dalle mie labbra e sporcava la camicetta di
quel sangue di frutto, così quei libri hanno sporcato
la mia pubertà, il loro sangue è sceso nelle mie viscere
fino a violentarmi, il loro sangue di parole, pensieri,
concetti, anime, ha rubato la mia verginità, ha
sedotto la mia debole mente di ragazzo di provincia,
sporco nell’anima e nelle arterie, di creta, di terra
arsa dal sole, di zolle odorose di sterco di pecora.13
L’ombra delle colline è un romanzo di Giovanni Arpino del 196414 ed è un romanzo
di formazione, come l’opera di Pirrotta, la quale viene incorniciata in una drammaturgia civile, legata ai dettami laici partigiani, attraverso un viaggio nell’infanzia del
protagonista. In Pirrotta l’infanzia diviene esplicito ricordo di un’iniziazione alla
lettura percepita però come uno stupro, mediata da un’implicita metafora che rende
l’inchiostro assimilabile a sangue che scorra sulle pagine, ma anche a terra umida di
escrementi, viva e primigenia oracolare forma di comunicazione.
Pasolini e Pirrotta assumono le sembianze di anziani che siedono su una panchina a ricordare e raccontare, intesa e confronto svelano la ricerca di una complicità che agisce attraverso la memoria. “L’incontro di civiltà è sempre qualcosa che
riguarda un uomo e un altro uomo: un’ultima possibilità per accogliere chi ha bisogno o per respingerlo definitivamente nel mare aperto e sconfinato del rifiuto”.15
È pur vero, però, che “randagio è l’eroe”, citando un altro scritto di Arpino.16
Dario Tomasello configura il suo testo scritto per Pirrotta, dal titolo Il faro al buio, in
una dimensione da subito connotata dalla ricerca ossessiva di quell’unico gesto, da
parte del protagonista Bilal, che possa creare una rinnovata fiducia nella parola
salvifica e ultima. Vincenzo Tripodo, regista del Faro rivela:
Solo pochi versi, prima dell’inceppamento, in una ciclica disperata ossessione alla ricerca della parola perduta. Non a caso l’autore ha scelto questo nome per il personaggio, lo stesso dello schiavo di colore, liberato dal Profeta, con doti vocali che as-
Vincenzo Pirrotta, All’ombra della collina, in Id., Teatro, Editoria&Spettacolo, Spoleto, 2011, pp. 18-19.
Giovanni Arpino, L’ombra delle colline, in Id., Opere scelte, a cura e con un saggio introduttivo di R.
Damiani, Mondadori, Milano, 2009².
15 Si legge nel programma di sala, nelle note dell’autore di Lampi eclissi. Il faro al buio.
16 Giovanni Arpino, Randagio è l’eroe, Lindau, Torino, 2013.
13
14
118
Vincenza Di Vita
similano il culto a una sorta di cunto del Corano in versi […] Pirrotta è attore difficile
da dirigere, poiché la sua voce ti incatena come quella delle sirene, è un creatore di
mondi che molto facilmente risveglia, in chi l’ascolta, un’ancestrale voglia di storie.17
Fig. 1, Vincenzo Tripodo, Il faro al buio, 2011, Messina, per cortesia del regista.
L’elemento legato al sangue e alla lacerazione della ferita sono pertanto assimilabili alla dimensione fisica dell’oralità, incarnata nella cavità corporea, che finalmente possiede il palcoscenico, evocando un immaginario negato dalle convenzioni culturali; a tal proposito, esemplificativo diviene il Canto del sangue presente nel
testo di Malaluna.18
“Le formule” – secondo Ong – “aiutano a dare ritmo al discorso e agiscono di
per sé come aiuti mnemonici [.…]. In una cultura orale, pensare in termini non
formulaici, non mnemonici, se anche fosse possibile, sarebbe una perdita di tempo,
poiché il pensiero, una volta formulato, non potrebbe più essere ricordato se non
con l’aiuto della scrittura”.19 L’apparato liturgico e le enunciazioni nei testi di Pirrotta seguono spessissimo le trame di canti, e il canto, quindi il cunto, sono elemen-
17
18
Note di regia.
Pirrotta, Malaluna, in Teatro, cit.; alla versione in vernacolo segue la versione in lingua italiana, pp.
39-90.
19
Walter J. Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna, 1986, pp. 63-64.
Vincenzo Pirrotta tra cunto e sacre-vie nell’apocalisse di un Faro al Buio
119
ti essenziali nella sua scrittura scenica.20 Dove non si trovino esattamente dei canti,
s’incontra lo snocciolamento di rosari, per cui nella Ballata delle Balate21 abbiamo un
protagonista latitante, che indossa una corona di spine e un rosario che, stretto tra
le mani del performer, diviene strumento sciamanico per recitare i misteri gaudiosi
ovvero dello Stato, che coincidono con invocazioni o inni di gioia per delle masculiate,22 metafora festiva per descrivere l’esplosione degli attentati ai danni di Giovanni Falcone e di Giuseppe Borsellino: “Nel quinto mistero gioioso si contempla a
masculiata di Capaci e via d’Amelio/ Chi botti chi sparamu nni n’tisi tuttu u munnu/ Ddi machini firmamu facennu capuliatu/ Chista è mattanza no chidda di lu
tunnu/ Pareva capurannu pi quantu amu brinnatu”.23 Anche in quest’opera il testo
è scandito da canti, scritture in versi, pastiche ricavati da riscritture di passi biblici e
ritornelli recitati o cantati. Illuminante si rivela quanto dichiarato da Rimini, sulle
Eumenidi pasoliniane:
L’esito di tale corpo a corpo è una scrittura irta di suoni, echi e immagini di brutale
evidenza, in cui la ferocia delle Erinni viene rivissuta attraverso il baccaghiu, il gergo
della malavita isolana, in un crescendo di furore e tetro entusiasmo. La proiezione archeologica del lessico infatti, lungi dall’attenuare la potenza evocativa del dettato mitico, assicura un surplus di violenza e pathos, e così da ogni pagina traspira l’odore
del sangue, il miasma della vendetta e della colpa.24
La fuga dalla tradizione?
Una vita in comune viene scandita da cinque cubi rossi sulla scena, che sembra
ondeggino al suono delle campane che intonano l’avvio della omonima commedia
di Aristofane Le Donne al Parlamento, diretta e interpretata nel ruolo di Blepiro da
Vincenzo Pirrotta.25 Pirrotta esegue una parabasi in un’opera in cui, rivela il traduttore Andrea Capra, “la lingua è la rappresentazione sonora di quello che uno pen20 Su cunto e parola segnaliamo il saggio di Guido Di Palma, La fascinazione della parola. Dalla narrazione orale al teatro: i cantastorie, Roma, Bulzoni, 1991.
21 Lo spettacolo debutta al Teatro Montevergini di Palermo il 28 ottobre 2006, con le musiche dal
vivo eseguite da Giovanni Parrinello.
22 Fuochi d’artificio.
23 Pirrotta, Teatro, cit., p. 97. Traduzione: “Nel quinto mistero gioioso si contempla la masculiata/ di
Capaci e via d’Amelio/ Coi botti che abbiamo sparato ci ha sentito tutto il mondo/ Quelle macchine
abbiam fermato facendone tritato/ Questa è mattanza non quella del tonno/ Sembrava capodanno per
quanto abbiamo brindato”. In quest’ultimo verso si allude alla notizia trapelata dal carcere
dell’Ucciardone, secondo la quale i detenuti pare abbiano brindato alla notizia dell’avvenuta strage nel
1992.
24 Stefania Rimini, Appunti per un'Orestiade siciliana, in Vincenzo Pirrotta, Eumenidi, Bonanno
Editore, Acireale-Roma, 2010.
25
L’analisi qui accennata è stata pubblicata ed è fruibile per intero su
<http://www.rumorscena.com/2013/05/13/una-vita-in-comune-per-le-donne-al-parlamento-di-pirrotta/>
(05/13).
120
Vincenza Di Vita
sa, anche in un senso ritmico di ciò che succede sulla scena”.26 Prassagora, interpretata da Anna Bonaiuto, sembra danzare sugli archi che incedono attraverso le sue
parole, mentre dialoga con un lumino “vigile occhio” che “sui recessi delle cosce
fiammeggia” e trama perché le donne occupino il parlamento di Atene. Tale immaginaria e attuale surreale lezione che coinvolge molti altri drammaturghi siciliani, rivela in Pirrotta l’esigenza di includere i riferimenti al cunto siciliano e a gesti
da pupari di cui sono ricchi i lavori del regista, così da rendere lo “sproloquio di
lodi per le donne” un ritmato saltare a tempo, sulle battute come se si fosse mossi
da fili invisibili, come se si fosse una marionetta (vedi figura 2). Il coro delle donne
indossa un costume che ritrae sul petto i simboli dei due sessi appaiati, quasi a
significare che non debbano mai incontrarsi, bandiere rosse vengono issate, in una
sorta di scultoreo canto di vittoria futurista, srotolando quelli che poco prima erano
stati finti membri perché le donne si calassero meglio nella parte degli uomini nella
recita, dentro la simulazione. I colori sulla scena sono promessa di speranza e mutano tristi veli o forse leggeri burqa in magnifici teli coloratissimi che generano
danze gioiose, sulla scia di un albero della cuccagna impersonato da cinque donne.
D’altro canto “un pensiero protratto in una cultura orale è legato alla comunicazione”.27
Fig. 2, Vincenza Di Vita, Le donne al Parlamento, 2013, Siracusa.
Il faro al buio è una rimodulazione della dimensione orale mediante un’oralità
impossibile eppure veicolata da un generosissimo performer, la cui carica emotiva
e corporea non è in alcun modo distaccata dalla potenza vocale e musicale. Ogni
opera interpretata da Pirrotta è tessuta attraverso la musica, quando non c’è la
musica l’attore prova a creare una melodia: se non ha oggetti in scena con i quali
crearla, comincia a battere con un piede o con il palmo di una mano su una superficie in modo da fomentare la ricerca fortissima di ritmo. Questo spettacolo è metafora di una ricerca della parola dalle primissime battute inserite nel testo: l’attore in
scena è completamente coperto, incastonato in una scenografia post-apocalittica
26
27
Note del traduttore.
Ong, Oralità e scrittura, cit., p. 62.
Vincenzo Pirrotta tra cunto e sacre-vie nell’apocalisse di un Faro al Buio
121
con tutta una serie di elementi verdastri che rievocano un’innumerevole presenza
di radiazioni, che pur non essendo presenti nel contenuto incontrano le riflessioni
improvvisate dell’attore sullo scritto originario. In ogni replica il testo subisce dei
mutamenti e fin dalla primissima lettura, prima ancora di stabilire i movimenti sul
palcoscenico, accadono continui mutamenti.28 L’opera originaria scritta da Dario
Tomasello subisce variazioni continue durante le prove e non è ancora definitiva
quando diventa copione, in quanto la provvisorietà dei luoghi in cui avvengono le
repliche fa sì che venga continuamente adattata alle circostanze atmosferiche; dipendenti dal pubblico, dalla presenza di luce o di luna, dal vento e dai rumori provenienti dalla zona circostante, svolgendosi sempre all’aperto. Ma la trasformazione avviene anche rispetto alla lingua del testo: inizialmente abbiamo infatti un
testo scritto in un vernacolo vicino all’autore che viene immediatamente tradotto
da Pirrotta. Si passerà pertanto da un dialetto della Sicilia orientale a uno più confacente ai dettami linguistici di quello palermitano, come il performer di Partinico,
che non potrebbe altrimenti ibridarsi con il personaggio interpretato.
Sull’idea di rimozione è giocato tutto il testo del Faro. Il protagonista di nome Bilal invoca una parola silenziosa perché si rivolge a un dio e nel caso specifico ad Allah, le mani del performer vengono fuori da una fittizia coperta di stracci con ambientazione militare. Quando si è allestita la scenografia dello spettacolo, a cui ha
preso parte lo stesso Pirrotta con suggerimenti e adattamenti che gli permettessero di
muoversi al meglio sulla scena, per evidenziare la specificità del suo personaggio si è
fatto riferimento al film Codice Genesi.29 Sebbene la regia dello spettacolo sia di Vincenzo Tripodo, l’apporto registico di un autore-attore come Pirrotta ha un’influenza
decisiva sullo sviluppo drammaturgico dello spettacolo. Bilal incontra Francu, ancora una volta il nome ha una funzione esplicativa, indica che ci si trova di fronte a una
persona franca, genuina, sincera, un po’ bambina. È addetto al reperimento di cibo,
mentre l’acqua viene custodita da Bilal, leader. Se tuttavia nel film, il faro è identificato con una cisterna piena d’acqua ma anche con l’isola di Alcatraz che custodisce i
libri, la conoscenza, meta finale del viaggio del protagonista, la luce è connotata negativamente. La salvezza pertanto è identificata nella duplice possibilità data
dall’acqua-vita e dalla parola-conoscenza, in entrambi i casi.
28 Così si anticipano delle ‘prove di memoria’ che poi divengono un portentoso banco di prova con
un generoso dispendio di carattere fisico e vocale da parte del performer. “Allahu akbar Allahu akbar”
è la primissima battuta che il pubblico incontrerà. L’autore si rivolge ad Allah, la divinità ‒ cara alla sua
professione islamica ‒ che ha ispirato anche una precedente opera dal titolo Ultimo Giorno, con la regia
di Antonio Calenda, nel 2010.
29 Il titolo originale è The Book of Eli, dei fratelli Hughes, lungometraggio del 2010 interpretato da
Denzel Washington nel ruolo di Eli, il protagonista che custodisce la formula della salvezza per gli
uomini.
122
Vincenza Di Vita
Conclusioni
Il lavoro di Pirrotta, lo si è visto nei casi qui brevemente riferiti, avviene mediante la riscrittura di testi classici, come Aristofane o Eschilo, o sacri, come le sacre
scritture islamiche o ebraiche,30 vere e proprie vie di accesso alla memoria antropologica e artistica. Alla fine della parabola di Bilal la scrittura del nome del dio,
quando la salvezza viene negata e si cede alla disperazione, il nome scritto sulla
sabbia viene cancellato con aggressività e violenza e allora anche quel lumino che
era stato acceso viene spento, Francu decide di abbandonare Bilal e, nell’estrema
solitudine dell’attore solo sulla scena, nell’impossibilità di avere un pubblico, di
raccontare i suoi cunti per Bilal, diviene tutto buio. Quindi ciclicamente il buio torna come all’inizio, sebbene in questo caso nel finale rimanga una lucetta accesa
mentre l’attore evoca il buio. La possibilità di salvezza sembra quindi giungere
attraverso l’enunciazione del dramma che si conclude ciclico e in un buio senza
fine che nega la possibilità di trovare una difesa: “Unni c’è u lustru ci saravi u scuru e d’unni c’è u scuru… (Dove c’è una luce ci sarà il buio e dove c’è il buio…)”.31
La scenografia del Faro ha una disposizione verticale, come del resto hanno tutti i
testi di Pirrotta, volendo richiamare il minareto, con dispositivi come scale e ombrelli tirati fuori da una struttura che è insieme letto, armadio e alcova. Questo
spettacolo è in effetti poi diventato un suo testo, introiettato attraverso la parola
ovvero l’oralità della scena. C’è quindi una necessità profondissima da parte di
Pirrotta nel cercare di attraversare con la parola il suo pubblico, penetrare la conoscenza mediante la ricerca teatrale: ricerca sul testo che si tesse di anaforica liturgia.
30
31
Sacre-stie scritto e diretto da Pirrotta, debutta il 29 ottobre 2010 al Teatro Montevergini di Palermo.
Tomasello, Il faro al buio, cit., p. 17.
GABRIELLA SGAMBATI
TILL EULENSPIEGEL DI TAWADA YŌKO:
TRA MAGIE E STRANIAMENTI LINGUISTICI
La figura di Till Eulenspiegel
Till Eulenspiegel è un personaggio del folklore del nord della Germania, figura
che fu assunta dall’immaginario popolare prima e dalla letteratura poi a simbolo di
un’identità nazionale. Si tratta di una figura storico-leggendaria, la cui origine è
incerta. Il nome, nella sua forma odierna, evoca in tedesco la civetta (Eule) e lo
specchio (Spiegel): per questo motivo le sue rappresentazioni lo ritraggono spesso
con entrambi i simboli nelle mani. In realtà, sembra che il nome derivi da
un’espressione un po’ gergale e dal significato irriverente, ‘prendere per i fondelli’,
che si avvicina molto al modus dicendi italiano ‘essere specchio per le allodole’. Till
viene rappresentato come amante del divertimento, irriverente e sempre pronto a
farsi beffe degli altri, spesso fingendo di non capire ciò che gli viene detto.
Scacciato dal padre che gli rimprovera di essere troppo pigro, il giovane si trasferisce in città, lavorando per diversi padroni ed eseguendo gli ordini così tanto
alla lettera da causare disastri. È questo il suo modo beffardo di dimostrare quanto
gli esponenti di quella società cittadina s’ingannino nel credersi superiori ai campagnoli. Tra le sue burle è celebre quella in cui, pur avendo solo sentito il profumo
di un arrosto, paga l’oste che gli presenta comunque il conto, facendogli però solo
ascoltare il tintinnio della moneta battuta sul tavolo.
La vicenda di Till ha riscosso un successo tale che ha ispirato diverse opere musicali, satiriche e teatrali e perfino un museo gli è stato dedicato.1 Nel 1927 Gerhart
Haupmann scrive un’opera satirica su Till Eulenspiegel,2 attualizzando le sue avventure e conferendogli un doppio ruolo: quello di un soldato tornato dalla guerra
disilluso e quello di un buffone viandante che mostra al mondo un’immagine satirica della Germania dei primi anni ’20, in cui le vicende politiche del tempo sono
commentate con amarezza. Il celebre personaggio, però, aveva già ispirato uno dei
più bei poemi sinfonici di Richard Strauss: Tiri burloni di Till Eulenspiegel. Completato il 6 maggio 1595, Till Eulenspiegel lustige Streiche venne eseguito per la prima
volta ai concerti dell’orchestra Gürzenich di Colonia il 5 novembre dello stesso
anno, sotto la direzione di Franz Wüllner.
1 Il museo si trova nel Landkreis di Wolfenbüttel e conserva libri riguardanti le varie storie di Till
Eulenspiegel. Parte della mostra permanente è dedicata alla figura di Till in letteratura, nella musica e
nelle arti figurative. Cfr. <www.eulenspiegel-museum.de> (02/14).
2 Gerhart Hauptmann, Des Grossen Kampffliegers, Landfahrers, Gauklers und Magiers Till Eulenspiegel
Abenteuer, Streiche, Gaukeleien, Gesichte und Träume, Fischer, Berlin, 1928.
124
Gabriella Sgambati
Alla figura di Till è dedicata anche la pièce teatrale del 1998,3 su cui ci soffermeremo, scritta da Tawada Yōko, scrittrice giapponese che vive dal 1982 in Germania
e che pubblica opere sia in giapponese che in tedesco, ispirandosi proprio alle differenze e a improbabili analogie fra le due lingue.
Quest’opera può essere letta come una riscrittura interculturale del libro Ein
kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel del 1515,4 che narra le avventure del burlone
medievale. Opera anonima, si ritiene sia di Hermann Bote; è scritta in Frühneuhochdeutsch, ma alcuni giochi di parole suggeriscono che si rifaccia a una precedente versione basso-tedesca.
In Till la scrittrice nippo-tedesca utilizza sia il giapponese che il tedesco; il suo
intento è infatti quello di creare un senso di straniamento nel pubblico attraverso la
commistione delle due lingue. Durante la rappresentazione lo spettatore è periodicamente esposto al puro suono della lingua straniera, di cui ignora il significato,
ma può apprezzarne le sonorità;5 anche i gesti, la mimica e le coreografie giocano
un ruolo fondamentale per la comprensione della rappresentazione.
In questo lavoro si cercherà di indagare come nella pièce riescano a intersecarsi
elementi di oralità e scrittura e come i sensi del suono e della vista, tempo e spazio
abitino l’opera tawadiana.
Till: tra Giappone e Germania
Till consta di cinque atti e presenta parti dialogate e raccontate. La storia ruota
intorno ad un gruppo di turisti giapponesi che visitano la Bassa Sassonia accompagnati da un’interprete, il cui lavoro viene ‘vanificato’ con l’arrivo in scena di Till
Eulenspiegel.
Le parti raccontate non sono pensate come didascalie ma sono definite dalla
stessa autrice come: “Bilder, die man frei bearbeiten kann”6 (“immagini che si possono rielaborare liberamente”). Entrambe le lingue echeggiano nello stesso spazio
ma non appartengono allo stesso tempo: i turisti giapponesi incontrano un gruppo
di abitanti di una città medievale che parlano tedesco; da entrambe le parti la situazione è percepita in maniera assolutamente naturale, sebbene non si comprendano tra di loro. L’unico personaggio bilingue è la guida turistica che usa il linguaggio principalmente per fornire informazioni ai turisti nipponici, i quali però la
Tawada Yōko, Orpheus oder Izanagi. Till, Konkursbuchverlag Claudia Gehrke, Tübingen, 1998.
Wolfgang Lindow (a cura di), Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel. Nach dem Druck von 1515 mit
87 Holzschnitten, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1978.
5 Cfr. Emanuela Costa, “Migrazione, scrittura e (in)traducibilità nella narrativa di Mizumura Minae
e Tawada Yōko”, in Giorgio Amitrano e Silvana De Maio (a cura di), Nuove prospettive di ricerca sul
Giappone, Il Torcoliere, Napoli, 2012, pp. 157-170, in part. p. 165.
6 Tawada, Till, cit., p. 43.
3
4
Till Eulenspiegel di Tawada Yōko: tra magie e straniamenti linguistici
125
ignorano del tutto e pare non abbiano bisogno delle sue traduzioni linguisticheculturali, nonostante sia evidente che non conoscano il tedesco.
Gli aspetti non verbali di entrambi gli idiomi, che passano in primo piano attraverso la desemantizzazione del linguaggio, creano uno spazio comune che in qualche modo unisce i personaggi. Nella sua introduzione all’opera, infatti, Tawada
afferma: “Durch Gesten, Mimik, Sprachklang oder Choreographie muss eine gemeinsame Welt auf der Bühne geschaffen werden. Für die Zuschauer, die nur eine
der beiden Sprachen verstehen, bleibt ein Teil der Bühne ein Geheimnis, aber musikalische oder bildliche Zugänge zu dem Geheimnis müssen möglich sein“.7
Una delle caratteristiche più interessanti per Tawada del personaggio di Till Eulenspiegel è senza dubbio la propensione del burlone a usare il linguaggio come
strumento per ingannare la gente. La scrittrice, infatti, non perde l’occasione per
mettere in risalto l’inaffidabilità del linguaggio stesso. Till, così com’è evidenziato
anche dal titolo del suo racconto giapponese Futakuchi otoko8 (L’uomo con due bocche,
1998), adattamento della pièce bilingue Till, ha due bocche dalla nascita:
Als Till aus dem Bauch seiner Mutter wie stolpernd herausfiel, kam sein erster Schrei
nicht nur aus dem Mund, sondern auch aus dem After, so dass seine erste Stimme im
Duett zu hören war ... Das faltige, hässliche Gesicht und den glatten, rosaroten Hintern vergleichend sagten seine Eltern und Nachbarn, wie schade, dass nicht sein Gesicht der Hintern und nicht sein Hintern das Gesicht ist. Der Teufel hätte sie umgetauscht, sagte der Pfarrer ...9
Till ha due bocche anche per un’altra ragione: uno dei turisti giapponesi si
chiama Inondo, il quale può essere considerato (e vuole essere considerato) il ‘Till’
giapponese. È l’unico personaggio che trova divertenti le battute e gli scherzi del
burlone medievale ed è l’unico di cui, oltre a Till, conosciamo il nome, che tuttavia
non è tipicamente giapponese. In effetti Inondo è l’equivalente giapponese di Dill10
(Dil Ulenspegel), che in giapponese indica un’erba medicinale. Inondo si identifica
con Till, affermando che: “das bin doch ich. Ich! Irgendwann war ich er, sein Jetzt
ist mein Jetzt, früher einmal”.11 Mentre Till corre come una lepre, raffigurando la
7 Ivi, p. 44. “I gesti, la mimica, il suono della lingua o la coreografia creano un mondo comune sul
palcoscenico. Per gli spettatori che comprendono solo una delle due lingue, parte del palco rimane un
segreto, ma devono essere possibili accessi al segreto musicali e figurati”. (Traduzione mia).
8 Yōko Tawada, Futakuchi otoko, Kawade Shobō-Shinsha, Tōkyō, 1998, pp. 7–57.
9 Tawada, Till, cit., p. 56. “Quando Till venne fuori dal ventre di sua madre inciampando, il suo
primo grido uscì non solo dalla bocca ma anche dall’ano, così che la sua voce è stata ascoltata in duetto.
[…] Il viso rugoso e brutto e il fondoschiena liscio e rosa erano equiparabili, dicevano i genitori e i
vicini: «Che peccato che il suo volto non sia il suo fondoschiena e il suo fondoschiena il suo volto». «Il
diavolo li avrà scambiati», disse il parroco”. (Traduzione mia)
10 Cfr. Ulrich Apel, Wadoku Jiten, Japanisch-Deutsches Online Wörterbuch, Wadoku e.V.,
<www.wadoku.de>.
11 Tawada, Till, cit., p. 85. “Questo sono io. Io! Una volta io ero lui, il suo Ora è il mio Ora, una
volta”. (Traduzione mia).
126
Gabriella Sgambati
flüchtige Leben12 (“vita fugace”, “vita superficiale”), e quando passa, scrive ovunque
con il gesso alla parete “ich war hier”13 (“io ero qui”), Inondo lo imita, giocando
con la somiglianza in giapponese tra ore (“io”) e kore (“questo”).14 Till ha dunque
due bocche non solo nel suo corpo: il suo alter ego, che appartiene a un altro tempo
e parla un’altra lingua, è la seconda bocca di Till.
Gli scherzi di Till consistono spesso nel prendere alla lettera alcuni modi di dire
in tedesco; tuttavia anche in giapponese sono presenti molti giochi linguistici basati
su assonanze tra varie parole che si pronunciano quasi allo stesso modo, ma che
hanno significati diversi.15 Non solo, dunque, la compresenza di due lingue diverse, ma anche l’associazione di parole omofone portano a uno svuotamento di significato o ‒ per meglio dire ‒ creano una magia linguistica di benjaminiana memoria:
“Il problema originario della lingua è la sua magia. (...) Poiché la lingua non è mai
soltanto comunicazione del comunicabile, ma anche simbolo del noncomunicabile”.16 Anche Inondo afferma più volte in diverse occasioni che la sua
intenzione era quella di andare in un paese di cui non conosceva la lingua, per
poter acquisire “una nuova visione del mondo”.17
Dunque, attraverso l’atto dell’imitazione i personaggi cercano di decifrare ciò
che li circonda. Till utilizza l’imitazione per capire atteggiamenti diversi: egli osserva, infatti, come i turisti, straniati e attoniti, guardano gli oggetti e cerca di imitarli scrutando curioso, perplesso e impacciato le cose che lo circondano. Prova a
riprodurre l’incomprensione, si appropria dello sguardo estraneo/estraniato e in
questo modo supera la lingua funzionale. In Verwandlungen18 (raccolta delle tre
lezioni di poetica che ha tenuto a Tubinga nel 1997) nella lezione intitolata Stimme
eines Vogels oder das Problem der Fremdheit (Voce di un uccello o il problema
dell’estraneità), Tawada affronta il problema dell’estraneo, paragonando la Fremdheit alla voce di un uccello. Una delle più importanti caratteristiche degli uccelli è
che imitano il canto dei loro simili. Se un uccello imitasse la lingua umana, non ne
capirebbe né il contenuto né la grammatica. Allo stesso modo, anche l’uomo non
potrà mai capire la lingua degli uccelli. Tuttavia un’accurata riproduzione di una
lingua incomprensibile – ovvero straniera ‒ può aumentare le possibilità di com-
12 Christine Ivanovic, "Alles fließt: Die Uneinheitlichkeit von Zeit und Raum. Zum Ort der Geschichte
im interkulturellen Dialog“, in Ortrud Gutjahr (a cura di), Fremde Wasser, Vorlesungen und wissenschaftliche
Beiträge, Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, Tübingen, 2012, pp. 394-416, in part. p. 401.
13 Tawada, Till, cit., pp. 64, 82.
14 Ivi, p. 99.
15 Vedi il gioco di parole di Inondo: fukuro ("sacco“), fukurô ("civetta“), ofukuro ("mia madre“). Cfr.
ivi, pp. 100-101.
16 Cfr. Walter Benjamin, Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen (1916), in
Gesammelte Schriften vol. II.1, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1991, pp. 140- 157.
17 Cfr. Tawada, Till, cit., pp. 94, 101.
18 Tawada Yōko, Verwandlungen. Tübinger Poetik-Vorlesungen, Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke,
Tübingen, 1998, pp. 7-22.
Till Eulenspiegel di Tawada Yōko: tra magie e straniamenti linguistici
127
prensione. Tawada afferma che, quando parla tedesco, si sente come una compositrice che, in un bosco, tenta di ascoltare, annotare e imitare la musica degli altri
uccelli. Proprio per questo crede che chi si esprima in una lingua che non sia la
propria è, allo stesso tempo, un ornitologo e un uccello. Quando si è circondati da
voci estranee, alcuni cercano di adattare il proprio timbro all’ambiente circostante.
Ogni lettera dell’alfabeto penetra nel corpo e trasforma la persona. Secondo Tawada la voce straniera resta invece impenetrabile e interrompe la melodia della lingua. La scrittrice non considera dunque il linguaggio come strumento di comunicazione basato su caratteristiche referenziali, ma valorizza le sue qualità poetiche e
sensoriali, in particolar modo sonore. Anche in Till, attraverso il puro suono della
lingua estranea e della sola voce, anche se incomprensibile, i personaggi riusciranno a decifrare il mondo circostante e a comunicare senza l’ausilio di alcuna traduzione o mediazione.
Dal testo alla rappresentazione
Il gruppo teatrale “Lasenkan”19 (trascrizione fonetica dei caratteri giapponesi di
‘spirale’ e ‘spazio’), diretto dal regista Shimada Saburo, attivo dall’Ottantanove sia
in Germania che in Spagna e Giappone, ha chiesto a Tawada il permesso di poter
utilizzare i suoi testi per una collaborazione con la “Theaterwerkstatt” di Hannover. Così nel 1998 nasce Till, composto dalla stessa autrice in tedesco e in giapponese, affinché potessero recitare insieme gruppi teatrali provenienti dalle due aree
linguistiche. Viene rappresentato nella primavera del Novantotto in Germania e
nell’autunno successivo in Giappone. Non vi sono sottotitoli, la messa in scena fa a
meno della traduzione dei dialoghi. L’unica traduttrice è l’accompagnatrice turistica che parla durante tutta la rappresentazione unicamente in giapponese e solo con
i turisti giapponesi.
La figura di Till conduce non solo i turisti giapponesi ma anche il pubblico nel
Medioevo tedesco; ha capelli e occhi verdi, è personaggio ambivalente, creatore e
distruttore allo stesso tempo, buono e cattivo, prende in giro tutti con scherzi, indovinelli e giochi di parole; compone parole inesistenti, cuoce pane a forma di
animali. Tawada mette in scena alcune delle storie di Till, combinandole con elementi di altre culture, come ad esempio quando allude alla fiaba danese di Hans
Christian Andersen I vestiti nuovi dell’imperatore (1837),20 raccontando come Till
regali vino immaginario, visibile solo alle persone di cultura (Kulturmenschen).
Kultur è l’argomento ‘scottante’ che domina il dialogo in tedesco all’inizio della
rappresentazione, insieme a quello del turismo che diventa il discorso principale
dei giapponesi. Se da un lato questo tema viene rappresentato in maniera ironica,
19
20
Cfr.< http://lasenkan.com/Lasenkan.html> (02/2014).
Cfr. Ivanovic, “Alles fließt”, cit., p. 398.
128
Gabriella Sgambati
dall’altro offre la possibilità di entrare in contatto con un nuovo mondo. “Der Tourismus ist die Pflicht des Gegenwartsmenschen”,21 arriva ad affermare la Dolmetscherin.
Fig. 1, Brochure dello spettacolo, per cortesia di Saburo Shimada, Kana Torino e Kei Ichikawa.
Come si può notare dal Bühnenprospekt, in cui anche qui è messa in evidenza la
compresenza di entrambe le lingue, la pièce è scansionata dalle 16 stazioni che segnano la vita di Till.
21
Tawada, Till, cit., p. 93.
Till Eulenspiegel di Tawada Yōko: tra magie e straniamenti linguistici
129
Fig. 2, Brochure dello spettacolo, per cortesia di Saburo Shimada, Kana Torino e Kei Ichikawa.
I turisti giapponesi (Inondo, la farmacista e la guida turistica) sono interpretati dai
tre componenti principali del gruppo “Lasenkan”; gli altri attori (non tutti di origine
tedesca) interpretano i personaggi medievali, e come si può notare dalla foto, indossano costumi dal taglio medievale prodotti però con un materiale moderno, morbido, una sorta di lattice. Inoltre ci sono dei personaggi che vengono rappresentati
unicamente attraverso immagini (Pilzmenschen, die Armen, die Frau des Händlers).
La pièce si apre con un bianco sipario di garza trasparente che separa il palcoscenico dal pubblico. Davanti all’auditorio vi è una superficie su cui vengono
proiettati frammenti di testo e antiche silografie in bianco e nero. Intanto si intravede da subito ciò che sta accadendo nel backstage.
130
Gabriella Sgambati
La scrittura, dunque, compare non solo nella fase compositiva, ma anche durante la rappresentazione.
Saburo Shimada crea una particolare interazione con il pubblico, introduce
nuovi elementi ogni qual volta la rappresentazione viene ripetuta. Il cambiamento,
la metamorfosi, la variante diventa condizione necessaria di una rappresentazione.
In diversi momenti della rappresentazione i suoni di entrambe le lingue vengono presentati simultaneamente sulla scena, così che li si comprende solo in parte;
gli spettatori non sono in grado, anche a causa delle lingue differenti, di elaborare
tutti i segni presentati. Come afferma anche Hans-Thies Lehmann in Segni teatrali
del teatro post-drammatico: “L’apparato umano dei sensi tollera difficilmente la mancanza di collegamenti”;22 lo spettatore dunque diviene attivo e sarà sempre alla
ricerca di connessioni, correspondances tra i dati.
Prima di andare in scena a Tokyo, Tawada in una conferenza ricorda la circostanza per cui prima di approdare in Europa la lingua fosse solo un fatto visivo.
Ma l’incontro con la lingua tedesca segna per lei una svolta, in quanto quell’idioma
riesce anche ad ascoltarlo. In Germania è diffusa, per Tawada, una lebendige Hörkultur.23 Ella stessa è solita incontrare i suoi lettori durante le sue Lesungen, che possono essere considerate delle vere e proprie performance, anche se differiscono ovviamente dal teatro in cui sono presenti più persone e in cui nasce una dialogicità che
ha da sempre affascinato e spinto Tawada verso il mondo della rappresentazione
scenica. La scrittrice si diverte nel vedere come sul palco le parole si allontanino
dalla forma scritta e assumano un’altra forma. Il teatro, che getta i testi nello spazio, è un luogo di gioco tra signifiant/signifié, in cui si incrociano traduzioni molteplici; il testo non è più fisso, ma aperto, soggetto a modifiche del lettore e dello
spettatore che diventano creatori dell’opera.
Tawada concepisce un paesaggio eterotopico e anacronistico, creando due
mondi linguistici, che divergono sia dal punto di vista temporale che spaziale.
Ogni componente del gruppo parla la sua lingua, tedesco o giapponese, così che lo
spettatore riesce a comprendere a pieno solo metà dell’opera. Il pubblico tedesco
che non conosce il giapponese, esperisce la lingua straniera come suono e “Gestarium”24: intonazione, prosodia, gestualità e mimica giocano un ruolo fondamentale
sulla scena e l’introduzione di tali elementi durante la rappresentazione ricorda
l’espediente dei V-Effekte del teatro brechtiano. Il gesto, elemento strutturale del
teatro epico, viene così definito da Brecht in un saggio del 1932: “’Gestuale’ è un
22 Hans-Thies Lehmann, “Segni teatrali del teatro post-drammatico”, Biblioteca teatrale, 74-76, 2005,
pp. 23-47, qui p. 27.
23 Cfr. Michiko Tanigawa, “Performative Über-setzungen / über-setzende Performance. Zur
Topologie der Sprache von Yōko Tawada“, in Christine Ivanovic (a cura di), Yōko Tawada. Poetik der
Transformation. Beiträge zum Gesamtwerk, Stauffenburg Verlag, Tübingen, 2010, pp. 351-367, qui p. 360.
24 Cfr. Franziska Schößler, ”‘Ein Opernstück über meine Köpfe‘ – Klang(t)räume in Yōko Tawadas
Theaterstücken“, in Gutjahr, Fremde Wasser, cit., pp. 417-436.
Till Eulenspiegel di Tawada Yōko: tra magie e straniamenti linguistici
131
linguaggio che si basa sul gesto così inteso: un linguaggio che dimostra determinati
atteggiamenti che colui che li tiene assume davanti ad altre persone”.25 Non il gesticolare, il generico muovere le mani con cui si accompagna e si sottolinea il discorso, ma “l’atteggiamento d’insieme in rapporto agli altri”.26 Brecht insiste su
questo punto anche in altri scritti: gesto è qualsiasi azione nel momento in cui accade in Hinblick auf andere, rispetto agli altri e sotto agli occhi degli altri.
Gli spettatori che non conoscono il giapponese riescono a concentrarsi unicamente sul suono della lingua, poiché non hanno la possibilità di ingabbiare la parola-suono nella scrittura, non conoscendo il sistema ideografico. Senza la scrittura, le
parole come tali non hanno una presenza visiva, anche quando gli oggetti che rappresentano sono visibili. Ciò permette una riflessione sulla natura del suono in
quanto tale. Come afferma Ong,27 il suono che l’orecchio registra è evanescente, è
flusso irreversibile, tempo. La vista invece percepisce non solo il movimento, ma
anche l’immobilità. Il suono ha un rapporto speciale col tempo: esso esiste solo nel
momento in cui sta morendo, è labile e come tale viene percepito. Questo è anche
l’intento del regista Saburo Shimada: scoprire il ‘qui e ora’28 della parola pronunciata. Al contrario dello sguardo, la voce è sempre relazionale. Essa vibra nell’aria
colpendo l’orecchio altrui, anche qualora non ne abbia l’intenzione. L’ascolto afferisce alla dimensione della reciprocità.29
Negli ultimi dieci anni si assiste a una sensibile evoluzione nelle performance
dei “Lasenkan”, che dal 1996 lavorano e collaborano con Tawada. Impressionante è
l’incremento di elementi utilizzati sul palco, oggetti ed espedienti che creano
un’atmosfera estraniante e soprattutto la combinazione di effetti di distanziamento
e immersione. L’aspirazione dei “Lasenkan” a sviluppare una forma di teatro moderna ai confini di lingue e culture e il tentativo di fusione di diverse tecniche teatrali orientali e occidentali crea spazi e identità transnazionali. Il gruppo teatrale
giapponese attualizza l’opera tawadiana che diventa work in progress sulla scena, in
continuo cambiamento. La performance mostra processi e non risultati finiti, facendo emergere ulteriori significati del testo e portando alle estreme conseguenze
la marca di oralità, un’oralità trans-linguistica e trans-soggettiva della sua scrittura.
Cfr. Bertolt Brecht, Sulla musica gestuale, in Id., Scritti teatrali, Einaudi, Torino, 2001 , p. 212.
Ibid.
27 Cfr. Walter J. Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 59-60.
28 Saburo Shimada, “Der Erinnerung einen neuen Namen geben. Über Sancho Pansa und andere
Produktionen von Stücken Tawadas“, in Ivanovic, Yōko Tawada. Poetik der Transformation, cit., p. 59.
29 Cfr. Adriana Cavarero, A più voci: filosofia dell‘espressione vocale, Feltrinelli, Milano, 2003.
25
26
132
Gabriella Sgambati
ENZA DAMMIANO
VELIMIR CHLEBNIKOV:
‘ESORCISMI‘ IN SCENA TRA MITO E FOLCLORE
Nel corso della sua vita, breve e raminga, il budetljanin Velimir Chlebnikov abita, o si sforza di abitare, un futuro che paradossalmente coincide con un passato
arcaico e utopico: il suo universo poetico, infatti, risulta caratterizzato da un costante procedere ‘all’indietro’ che, se da un lato sembra realizzarsi nei tentativi di
recupero di un complesso mitico-folclorico di natura sincretica, dall’altro si sviluppa in una intensa ricerca sulla lingua volta al superamento del ‘segno’ e della sua
arbitrarietà, verso il raggiungimento di una parola primigenia, universale che possa essere al contempo ‘suono’ ed ‘evento’.1 Un dislocamento, uno sdvig2 poetico ed
esistenziale in un tempo cosmico che si esprime nella sua evidenza già a partire dal
1908, quando con la pubblicazione dei suoi primi componimenti in versi, il poeta
sostituisce il proprio nome e patronimico, Viktor Vladimirovič, con lo slavo Velimir; al successivo soggiorno in Persia, nel 1921 al seguito dell’Armata rossa, risale,
invece, l’appellativo di ‘derviscio russo’, urūs derviš,3 che ne designa
l’atteggiamento mendico e mistico al contempo e ritorna nel ciclo La tromba del Gul
mullā (Truba Gul'-Mully) dello stesso anno: “Oggi sono invitato dal mare. / …. Di
dietro lo steccato: ‘Urūs derviš, derviš urūs’”.4
Uno stile di vita ramingo, errabondo e discinto, che non può non ripercuotersi
sulla sua opera e sul suo rapporto con la scrittura, intesa innanzitutto come supporto fisico e materiale alla propria arte, da subito controverso; a tal proposito scrive Angelo Maria Ripellino:
* Le traduzioni dal russo, ove non diversamente indicato, sono da intendersi dell’autrice.
1 Walter Ong, Oralità e scrittura, Il Mulino, Bologna, 1982, p. 59.
2 Lo sdvig indica letteralmente uno spostamento; prima in pittura e poi in poesia ‒ soprattutto grazie
alle formulazioni teoriche di Aleksej E. Kručënych ‒ il termine arriva a designare ogni tipo di dislocazione di elementi pittorici o linguistici, assumendo un ruolo centrale nell’avanguardia cubo-futurista.
“Questa operazione analitico-decostruttiva sul linguaggio ‒ scrive Vittorio Strada ‒ che costituisce il
momento tattico, per così dire, della strategia transmentale, prende il nome di sdvig, parola centrale del
futurismo russo (sia poetico che pittorico). Sdvig significa spostamento e, come termine geologico, smottamento. Per quel che riguarda l'’arte verbale’, come i futuristi chiamavano la poesia, e lasciando da
parte la pittura (lo sdvig cubistico richiederebbe un discorso a sé per poter poi seguire il suo rapporto
con lo sdvig della poesia futurista), lo sdvig è un fenomeno fonetico …”. Vittorio Strada, Simbolo e storia:
aspetti e problemi del Novecento russo, Marsilio, Venezia, 1988, p. 94.
3 Cfr. Dennis Ioffe, “Velimir Khlebnikov on the Margins of Islam: 'Urus Dervish' and 'Gul-Mulla'
from the vantage point of Khlebnikov’s biography and poetics”, Philologica, 8, 2005, pp. 217-258.
4 Velimir Chlebnikov, Poesie di Chlebnikov. Saggio, antologia, commento a cura di A. M. Ripellino,
Einaudi, Torino, 1968, p. 104.
134
Enza Dammiano
Con una scrittura di ghirigori minuti … schiccherava i suoi versi all’inizio su casuali
brandelli di carta, e li portava con sé alla rinfusa in una federa di cuscino, spesso
smarrendoli. Dal ‘cofanetto di cipresso’ del simbolista Ànnenskij dunque alla ‘nàvoločka’, la Federa di Chlebnikov. Più tardi preferì un registro da computista, un libro
mastro, un Grossbuch, sul cui dare e avere spargeva in disordine schegge di liriche,
poemi, colonne di cifre e vocaboli, appunti, squarci di lettere e quelle formule algebriche con cui per tutta la vita andò astrologando intorno alle ‘leggi del tempo’.5
Il suo stesso relazionarsi con il supporto-testo sembra così determinato da una
invariante costituita da un residuale elemento di oralità: la federa in cui raccoglieva
brandelli di scritti o il registro in cui figuravano in ordine sparso i suoi frammenti
sono indice del dinamismo di una parola fluida, suscettibile di modificazioni potenzialmente infinite che, lungi dal definirsi compiute, ben rispondono all’utopia
chlebnikoviana: “La compiutezza delle sue cose stampate” — scrive Vladimir Majakovskij nel suo testo dedicato al poeta, V. V. Chlebnikov (1922) — “è una finzione.
La parvenza di compiutezza è il più delle volte dovuta alle mani dei suoi amici.
Scegliendo in un mucchio di minute da lui buttate, noi facevamo stampare quelle
che ci sembravano le più pregevoli”.6
La parola di Velimir Chlebnikov, mutevole e precaria nella sua forma scritta, si
configura, allora, principalmente come parola-suono che è al contempo parolaevento: “Senza la scrittura” – si legge in Walter Ong – “le parole […] sono soltanto
suoni che si possono ‘richiamare’, ricordare, ma non c’è luogo alcuno dove ‘cercarli’. Non li si possono mettere a fuoco né rintracciare …, e non hanno nemmeno una
direzione. Sono occorrenze, eventi”.7 O ancora: “Chiunque abbia un’idea di che
cosa siano le parole in una cultura orale primaria, o in una cultura non molto lontana dall’oralità primaria, non rimarrà sorpreso dal fatto che il termine ebraico
dabar significhi ‘parola’ ed ‘evento’”.8 Il recupero della parola come unità fonica,
prima che fonematica, e la conseguente riflessione “sulla natura del suono in quanto tale”,9 così come il riconoscimento della stessa in forma di eventus, accadimento,
costituiscono gli snodi cruciali del passaggio dall’oralità ‘primaria’, che “non conosce affatto la scrittura, né la pensa possibile”,10 a quella che Ong chiama “’oralità
secondaria’ o di ritorno […] la cui esistenza e il cui funzionamento dipendono dalla
scrittura e dalla stampa”.11
5 Angelo Maria Ripellino, “Tentativo di esplorazione del continente Chlebnikov”, in Id., Saggi in
forma di ballate. Divagazioni su temi di letteratura russa, ceca e polacca, Einaudi, Torino, 1978, p. 78.
6 Vladimir V. Majakovskij, in Ripellino, “Tentativo di esplorazione del continente Chlebnikov”, cit.,
p. 87.
7 Ong, Oralità e scrittura, cit., p. 59.
8 Ivi, p. 60.
9 Ivi, p. 59.
10 Ibid.
11 Ivi, pp. 29-30.
Velimir Chlebnikov: ‘esorcismi‘ in scena tra mito e folclore
135
L’elemento orale, o meglio il tentativo di ricostruirlo in maniera mediata, quindi
‘secondaria’, pervade l’opera di Chliebnikov: il suo ‘mandato’ poetico — come ben
evidenzia Roman Jakobson — risiede proprio nella creazione di una parola che ‘si
auto-validi’12 e che si riconosca potenzialità di sviluppo autonome; la poesia si riconfigura, allora, nella definizione jakobsoniana di ‘costruzione verbale’, slovesnaja
postroenija,13 soprattutto se si aggiunge che il russo slovesnyj — da slovo “parola”,
ma anche “racconto”, “canto”14 — indica, nel suo secondo significato, proprio “to
že, što ustnyj”, ovvero “ciò che è orale”.15
Riacquisito il proprio valore intrinseco e al contempo ‘orale’, il segno linguistico
non risulta più arbitrario, ovvero immotivato nel rapporto significante-significato
— come secondo gli assunti della teoria di Saussure16 —, ma fortemente correlato
al referente in una dimensione che, parafrasando Ernst Cassirer, nel recupero delle
sue espressioni ‘irriflesse’, prevede l’identità di significato e significante, approssimandosi al ‘pensiero mitico’: “So ist es für die ersten gleichsamen naiven und
unreflektierten Äußerungen des sprachlichen Denkens,” — scrive Cassirer — “wie
für das Denken des Mythos bezeichnend, daß sich für sie der Inhalt der ‘Sache’
und der des ‘Zeichens’ nicht deutlich scheidet, sondern daß beides in völliger Indifferenz ineinander überzugehen pflegt”.17
Anche per i budetljane, e in particolare per Chlebnikov, la parola si approssima
al mito; nell’introduzione-manifesto al Sadok sudej n. 2 (Il vivaio dei giudici n. 2),
edito nel 1913, si legge: “11. Noi consideriamo la parola come creatrice del mito”.18
Ma l’associazione parola-mito, così costituitasi, rimanda a sua volta a referenti
precisi di matrice simbolista, con cui Chlebnikov si confronta in maniera intensa e
continua: se da un lato attinge alla teoria della creazione mitica, mifotvorčestvo, di
Vjačeslav I. Ivanov,19 dall’altro non può prescindere dall’opera di Konstantin D.
12 Cfr. Roman O. Jakobson, “Novejšaja russkaja poezija. Nabrosok pervyj: Podstupy k Chlebnikovu”, in Selected Writings, V, Mouton, La Hague, 1922-1988, pp. 274-275: “Se l’arte figurativa è la
formalizzazione del materiale auto-validato delle rappresentazioni visive, […] la poesia è la
formalizzazione della parola auto-validata, ‘autonoma’, come dice Chlebnikov” (sulla parola autonoma,
samovitoe slovo, e la sua rappresentazione cfr. anche Viktor P. Grigor'ev, Velimir Chlebnikv v
cetyrechmernom prostranstve jazyka, Jazyki slavjanskich kul’tur, Moskva, 2006, pp. 286-293).
13 Cfr. ivi, pp. 280-281.
14 Cfr. Sergej I. Ožegov, Natalja Ju. Švedova (a cura di) Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka, Moskva 2006,
p. 730: alla voce Slovo si legge “unità della lingua”, ma alle occorrenze 2, 3 e 5, 9 rispettivamente
“discorso”, “conversazione”, “racconto”, “testo con accompagnamento musicale”.
15 Cfr. ibid.: se la prima occorrenza rimanda al lemma slovo, la seconda definisce slovesnyj, “ciò che è
orale”.
16 Cfr. Ferdinand de Saussure, Corso di Linguistica generale, Laterza, Bari, 1967.
17 Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, I, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1985, p. 21.
18 “Da Il vivaio die giudici n. 2” in
Serena Vitale (a cura di), Per conoscere l’avanguardia russa,
Mondadori, Milano, 1979, p. 51.
19 Cfr. Aleksandr V. Lavrov, “Mifotvorčstvo’argonavtov’”, in Vasilij G. Bazanov et alii, Mif. Fol'klór.
Literatura, Nauka, Leningrad, 1978, pp. 137-170.
136
Enza Dammiano
Bal’mont. Quest’ultimo, infatti, nel suo saggio Poezija kak volšebstvo (Poesia come
magia, 1915), unisce speculazioni cosmologiche a teorie linguistiche, al fine di indagare proprio il linguaggio della poesia: “In principio, se mai ci fu un principio era il
Silenzio, dal quale nacque la Parola secondo la legge dell’aggiunta, della corrispondenza e della ambivalenza. Dal mutismo - la voce, dal tacere - la canzone,
dalla quiete - la completa esplosione dei suoni, lo smisurato ciclone dei rumori,
delle grida, dei lamenti, dei bisbigli, dei fremiti, dei balbettii …”;20 o ancora, in merito alla ri-formulazione delle lettere dell’alfabeto: “Con umile amore guardo ogni
lettera, e ognuna mi ricambia con cortesia …”.21 Alle interferenze simboliste, si
aggiungono reminiscenze settecentesche che riecheggiano in stilizzazioni del gusto
barocco e nel ricorso a elementi declamatori che — come ha notato G. G. Isaev —
sembrano accostare l’opera del poeta al genere dell’ode;22 mentre le elucubrazioni
mistico-matematiche si integrano in una teoria del linguaggio che aspira
all’universale.23
È a partire da queste premesse che Chlebnikov va incontro a un recupero strutturale del ‘pensiero mitico’ e tenta, attraverso la formulazione di un linguaggio
transmentale, zaum’, la ri-costruzione di uno stadio originario della parola, in cui la
creazione linguistica si configura innanzitutto come “nemico per la fossilizzazione
della lingua del libro”24 e riacquista il suo carattere aurale, fluido, per cui — tornando a Ong — “non si può emettere un suono senza esercitare potere” e “ogni
suono … è dinamico”.25
Assumendo su di sé la veste di cantore, profeta, derviscio, veggente, Chlebnikov recupera meccanismi verbali dell’oralità: la sua parola, al contempo suono ed
evento, si muove perfomata nel tempo e nello spazio, con effetto rituale e paradossalmente visivo. Strutturalmente mitica,26 l’opera chlebnikoviana non può che nutrire l’elemento aorgico che la determina e attingere a voci del folclore e della demonologia popolare russa — come ribadisce lo stesso Jakobson27 —, commiste a
fonti della mitologia classica; si incontrano allora nei suoi testi formule magiche,
esorcismi, profezie, formule matematiche, cantilene, litanie mantriche, filastrocche,
20 Konstantin D. Bal’mont, “Poezija kak volšebstvo“, in Sočinenija, Verch. Volš. kn. izd-vo, Jaroslavl‘,
1990, <http://az.lib.ru/b/balxmont_k_d/text_0360.shtml> (09/13).
21 Ibid.
22 Gennadij G. Isaev rintraccia nell’opera di Chlebnikov una vicinanza al poeta Michail V. Lomonosov (1711-1765): cfr. Mečet i chram nesёt nizina: Volgo-Kaspij i ego narody v tvorčestve Velimira Chlebnikova,
Monografija, Astrachan’, 1999, pp. 90- 92.
23 Cfr. Donatella Ferrari-Bravo, Slovo: geometrie della parola nel pensiero russo tra '800 e '900, ETS, Pisa,
2000; Anke Niederbudde, Mathematische Konzeptionen in der russischen Moderne: Florenskij, Chlebnikov,
Charms, O. Sagner, München, 2006.
24 Velimir Chlebnikov, Werke, I-II, Peter Urban (Hrsg.), Reinbek, Hamburg, 1972, II, p. 326.
25 Ong, Oralità e scrittura, cit., p. 60.
26 Cfr. Rainer Goldt, Sprache und Mythos bei V. Chlebnikov, Liber Verlag, Mainz, 1987.
27 Cfr. Jakobson, “Novejšaja russkaja poezija. Nabrosok pervyj: Podstupy k Chlebnikovu”, cit., p. 296.
Velimir Chlebnikov: ‘esorcismi‘ in scena tra mito e folclore
137
preghiere, personaggi storici, mitologici, popolari e fiabeschi, dèmoni, demòni,
diavoli, in una sincresia totalizzante di forme e generi. Così scrive Ripellino:
[…] in tutte le sue poesie il linguaggio somiglia a quello di formule magiche […]. Con
tutti quei riferimenti a numi, a fiumi divinizzati, a demoni, questa sembra la lingua
di testi sacri primitivi. [...] L’impressione che si tratti di un linguaggio da incantesimo
e da esorcismo pagani è confermata, non solo dalle enumerazioni, ma dalla stessa
struttura ricca di omonimie e omofonie, di parole a iniziale comune, di costanti sonore.28
A partire dal suo più noto ‘esorcismo linguistico’, Zakljatie smechom (Esorcismo
col riso) del 1908, Velimir Chlebnikov lavora, dunque, alla ‘parola-suono’; con
“esercitazioni da stregone-grammatico”29 sulla radice sme-, il poeta esorcizza il riso,
lo libera dalle limitazioni che gli si impongono, in maniera rituale e dissacrante al
contempo, evidenziandone il legame imprescindibile con l’elemento orale:30
Oh, mettetevi a ridere, ridoni!
Oh, sorridete, ridoni!
Che ridono di risa, che ridacchiano ridevoli,
oh, sorridete ridellescamente!
Oh, delle irriditrici surrisorie – il riso dei riduli ridoni!
Oh, rideggia ridicolo, riso di ridanciani surridevoli!
Risibile, risibile,
ridifica, deridi, ridùncoli, ridùncoli,
ridàccoli, ridàccoli.
Oh, mettetevi a ridere, ridoni!
Oh, sorridete, ridoni!31
“Il fatto che negli esorcismi, nelle formule magiche” — scrive il poeta — “la lingua transmentale predomini e rimpiazzi quella mentale, dimostra che essa detiene
un potere particolare sulla coscienza, dei diritti speciali sulla vita …”;32 è una lingua mitica che aspira al superamento del ‘mentale’, per affermarsi come linguaggio
universale.
Angelo Maria Ripellino, “Chlebnikov e il futurismo russo”, Convivium, 5, 1949, pp. 679-680.
Chlebnikov, Poesie di Chlebnikov. Saggio, antologia, commento, cit., p. 179.
30 Cfr Jurij M. Lotman, Boris A. Uspenskij, “Il mondo del riso: oralità e comportamento quotidiano”,
in Jurij Michajlovicˇ Lotman, Tesi per una semiotica delle culture, a cura di F. Sedda, Meltemi, Roma, 2006,
pp. 157-184.
31 Chlebnikov, Poesie di Chlebnikov, cit., p. 10; Id., Sobranie proizvedenij, I-IV, II, a cura di Jurij N. Tynjanov, Nikolaj L. Stepanov, Izdatel'stvo Pisatelej v Leningrade, Leningrad, 1928-1933, p. 35: “O, rassmejtes’, smechači! / O, zasmejtec’, smechači! / Čto smejutsja smechami, čto cmejanstvujut smejal’no,/ O,
zasmejtes’ usmejal’no!/ O, rassmešišč nadsmejal,nych - smech usmejnych smechačej!/ O, issmejcja
raccmejal’no, smech nadsmejnych smejačej/ Smejevo, smejevo!/ Usmej, osmej, smešiki, smešiki!/ Smejunčiki, smejunčiki./ O, rassmejtes’, smechači! O, zasmejtes’, smechači!".
32 Chlebnikov, Sobranie proizvedenija, cit., p. 235.
28
29
138
Enza Dammiano
Ma come si traspone tutto ciò sulla scena? “Quasi tutti i cubofuturisti” — si legge in Majakovskij e il teatro russo d’avanguardia di Ripellino — “scrissero per il teatro,
ma più di tutti Chlebnikov”.33 Spazio intersemiotico per eccellenza, il teatro diventa per il poeta (autore, fra l’altro, di testi drammatici), autentica ‘scena della parola’:34 ”Se la poesia e la prosa” ‒ scrive Carla Solivetti ‒ “mettono in scena conflitti
strutturati in forma dialogica, il teatro esibisce l’incanto del ritmo e la fascinazione
della parola […]. Si può anzi sostenere che nella produzione di Chlebnikov il teatro
rappresenti un’articolata espansione di quello spazio mitico rituale proprio alle
formule magiche”.35
È proprio da queste forme magico-rituali della tradizione orale e dalla loro interazione dinamica che attinge il linguaggio transmentale chlebnikoviano; gli elementi linguistici ed extralinguistici si compenetrano per la costruzione di uno spazio scenico sincretico, verso una nuova mitopoiesi. Gli spiriti silvestri e pseudoslavi, infatti, popolano il dramma Devij bog (Il nume delle vergini, 1913), “composto
febbrilmente” e con il quale Chlebnikov “mirava a cogliere il puro principio slavo
… lungo fili tesi dal Volga alla Grecia”,36 mentre divinità appartenenti a mitologie
variegate e giustapposte appaiono nel dramma Bogi (Gli dei, 1921). A figure della
tradizione presudo-cristiana, invece, fanno riferimento Čertik (Il diavoletto, 1914) e,
in particolare, Ošibka smerti (L’errore della morte, 1917), che si apre con un ballo dalla
chiara connotazione rituale:
BARYŠNJA SMERT’. Druz’ja! Načalo
bala Smerti. Voz’memtec’ za ruki i
budem kružit’sja.
SIGNORINA MORTE. Amici! Che abbia
inizio il ballo della Morte. Prendiamoci per
mano e giriamo in tondo.
Zapevalo. V šali šalyj šel
Moroznyj slyšu skrežet
Treščit i gnetcja pol,
kogot’ šagajuščij nežit.37
Si canta. Nello scialle cammina lo sciocco.
Sento lo strepitio gelato
Scricchiola e si ricurva il suolo,
l’artiglio segue il passante.
Chlebnikov ricostruisce, sin dalla prima battuta, la dimensione collettiva e la
valenza tipologica del canto, della danza concentrica; la pièce, di chiara matrice
33
34
Angelo Maria Ripellino, Majakovskij e il teatro russo d’avanguardia, Einaudi, Torino, 1959, p. 42.
Velimir Chlebnikov, Neizdannye proizvedenija, a cura di N. Chardžiev, T. Gric, Moskva, 1940, p.
339.
35 Carla Solivetti, “Sverchpovest’ (Super-racconto) come forma di ipertestualità? Un’ipotesi di
lettura di Zangezi”, in Giovanna Pagani Cesa, Ol'ga Obukhova (a cura di), Studi e scritti in memoria di
Marzio Marzaduri, Quaderni del Dipartimento di studi eurasiatici dell’Università degli Studi Ca’ Foscari
di Venezia, 66, 2002, pp. 400-401.
36 Remo Faccani, “Chlebnikoviana”, Annali della Facoltà di lingue e letterature straniere Ca’ Foscari, 22,
1983, p. 212.
37 Velimir Chlebnikov, Sobranie Sočinenij, I-VI, Imil Ran, Moskva, 2003, III, p. 227.
Velimir Chlebnikov: ‘esorcismi‘ in scena tra mito e folclore
139
mistico-simbolista,38 si popola di voci che si compenetrano, fino a inscenare un
esorcismo ironico-burlesco che fa della Morte stessa la sua vittima: in una sorta di
bettola-purgatorio, dodici cadaveri bevono in compagnia della ‘signorina Morte’. Il
‘tredicesimo ospite’, che si presenta inatteso e per il quale sembra manchi il bicchiere, provoca la Morte affinché definisca la propria testa “vuota come un bicchiere”;39 traslando la metafora sul piano dell’evento, il cadavere ne esige e ne ottiene
la testa. La parola-evento, allora, determina l’inscenarsi di un rito di rovesciamento,40 per cui la morte è sconfitta: “Verso due calici” ‒ si legge in una delle sue ultime battute ‒ “la vita e la morte - e scelgo per me l’altro …“;41 ritorna ancora la valenza magico-rituale della musica: “Oh, con il mio cranio, suonate il liuto / con le
mie ossa, la balalaika”,42 mentre i cadaveri rivivono:
BARYŠNJA SMERT’. Ja p’ju, - užasnyj
vkus. Ja padaju i zasypaju. Eto zovetsja
ošibkoj baryšni Smerti. Ja umiraju….
SIGNORINA MORTE. Bevo, - un sapore
terribile. Cado e crollo. Si chiama errore
della signorina Morte. Muoio.…
DVENADCAT’ oživajut tolčkami po mere
ee umiranija. Vecelyj pir osvoboždennych.43
DODICI risorgono con la forza della sua
morte. L’allegro convivio dei liberati.
Il passato mitico-fiabesco, invece, irrompe in uno dei primi testi drammatici,
Snežimočka (La fanciulla di neve), edito nel 1915 ma a cui Chlebnikov lavora già nel
1908. La vicenda della fanciulla di neve, Snegurka o Sneževinočka, si ritrova narrata,
in alcune delle sue varianti, nell’opera dello scrittore e folclorista Aleksandr N.
Afanas’ev, che la include nelle ‘visioni’ poetiche degli slavi sulla natura, Poetičeskie
vozzrenija slavjan na prirody.44 A questa figura del folclore si ispira anche il drammaturgo Aleksandr N. Ostrovskij, che ne trae l’opera Snegúročka (1868-1873), trascritta
dal librettista Nikolaj Rimskij-Korsakov e musicata nel 1873 da Čajkovskij. Costante dell’intreccio narrativo della fiaba-mito, al di là delle sue varianti, è
l’evanescenza della protagonista, creata dalla neve e soggetta a sciogliersi nuovamente, a sparire dunque, in seguito a un allontanamento dal suo nucleo di appar38 Come notò Mikhail Alekseevič Kuzmin recensendo l’opera per Severnye zapiski (Janvar’, Peterburg, 1917, pp. 263-264), risulta evidente il legame con l’opera di Aleksandr A. Blok (1880-1921) e con il
Romanticismo tedesco. Si evidenzia, inoltre, il rimando alla simbologia cristologica.
39 Chlebnikov, Sobranie Sočinenij, cit., p. 231.
40 Cfr. Adam B. Seligman et al., Rito e modernità: i limiti della sincerità; trad. it. M. Bortolini, Armando,
Roma, 2011.
41 Chlebnikov, Sobranie Sočinenij, III, cit., p. 233.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Cfr. Aleksandr N. Afanas’ev, Poetičeskie vozzrenija slavjan na prirody, I-III, Sovremennyj pisatel’,
Moskva, 1995.
140
Enza Dammiano
tenenza. La Snežimočka chlebnikoviana ricostruisce la situazione della narrazione e
conserva le funzioni del suo modello ‘orale’, ricollocandole sulla scena, intesa come
spazio ‘mitico’ di rappresentazione: il dramma in tre atti, popolato di spiritelli naturali, dèmoni, personaggi mitologici, corali e umani, inscena l’irruzione
dell’elemento slavo — inteso come forza dionisiaca rigeneratrice — che si libera
attraverso un atto sacrificale e si compie in un nuovo incantesimo-esorcismo. La
pluralità di voci diventa una componente strutturale della pièce, che riporta
l’elemento orale nell’interazione parlante-ascoltatore esasperandolo nella sua costruzione formulaico-iterativa:
BELYJ BOJARIN Čestnoj narod! Ušla
ona! Kak dym v nebo. Kak sneg v vesnu.
Ušla. Istajala.
VSE Kto? Kto?
SNEŽNYE MAMKI Da Snežimočka!
Snežimočka! Snežimočka že!
BELYJ BOJARIN … Snežimočka!
VSE Kuda?
SNEŽNYE MAMKI Da v gorod že! V
gorod. V gorod ušla.
VSE V gorod ….45
IL BOIARO BIANCO Popolo rispettabile! Se
ne è andata! Come fumo in cielo. Come neve a
primavera. Se ne è andata. È sparita.
TUTTI Chi? Chi?
LE NIVEE MATRIARCHE Sì, Snežimočka!
Snežimočka! Snežimočka!
IL BOIARO BIANCO … Snežimočka!
TUTTI Dove?
LE NIVEE MATRIARCHE Sì, in città! In
città. In città è andata.
TUTTI In città ….
Svanita dal bosco, Snežimočka si ritrova in una città moderna immobile, grottesca e, come lei, fredda. Il superamento dello stato d’immobilismo, che la pervade
e la irrigidisce, sembra possibile solo attraverso lo ‘scioglimento’ e il conseguente
svanire della fanciulla: Snežimočka svanisce ancora, ma questa volta con valenza
rituale e vitalistica: la morte si fa rinascita. Ciò che avviene sulla scena è un esorcismo del fuoco, cantato, che ridona la vita e riequilibra il rapporto tra uomo e natura, nell’utopica sovrapposizione di passato e futuro:
Ja telo čistoe nesu
I vam, o ulizy, otdam.
Ego besgrešnym donesu
I placham goroda predam.
Ja žertva čistaja rasklam,
I, otdavajas’ vsem raspjat’jam,
Sožgu vas ognennym glagolom,
Zavjanu ognennym zakljat’em.46
Possiedo un corpo puro,
E, dalla strada, lo dono a voi,
senza paura lo conduco fino a voi
e mi abbandono al tronco della città.
Agli scismi come vittima pura.
E, libera da tutti i crocifissi,
brucio per voi il verbo di fuoco,
recito l’esorcismo di fuoco.
Sono proprio gli spiriti della natura a trovare espressione compiuta nell’ultima
opera di Chlebnikov, il poema drammatico o tragicommedia Zangezi (1922), spesso
45
46
Chlebnikov, Sobranie Sočinenij, III, cit., p. 168.
Ivi, p. 175.
Velimir Chlebnikov: ‘esorcismi‘ in scena tra mito e folclore
141
assurto a testamento di poetica dell’autore. Messa in scena nel 1923 da Tatlin a
Pietrogrado, l’opera presenta un complesso tessuto scenico-testuale, il cui creatore
è lo stesso Zangezi, poeta e profeta in interazione continua e dinamica con le folle a
cui si rivolge. In una sorta d’implosione dialogica, gli ideofoni sovrastano la struttura del dramma che si dispiega in venti ‘superfici della parola’, ovvero ‘scene’,
entro le quali si succedono declamazioni e litanie onomatopeiche, incantesimi e
cantilene, che attingono a quelle fonti dell’oralità così care al poeta. L’unico linguaggio autentico, quello transmentale, si dispiega in una pluralità di creazioni
ideofoniche proprie agli uccelli, alle stelle, agli dei — come nell’esempio riportato
di seguito —, in una lingua a-mentale e scomposta che realizza, attraverso la parola-suono, un universo utopico e armonico:
EROS
Mara-roma,
Biba-bul’!
Uks, kuks, èl’!
Redèdidi dididi!
Piri-pèpi, pa-pa-pi!
Èogi guna, geni-gan!
Al’, El’, Il’!
Ali, Eli, Ili!
Ek, ak, uk!
Gamč’, gèmč’, io!
— Rpi! Rpi!
DEI (in risposta)
Na-na-na!
Eèi, uèi, oèi!
Kezi, nezi, dzigaga!
Nizarizi oziri.
Mèamura zimoro!
Pips!47
Il teatro diventa allora totale e ricorre alle qualità poetico-magiche del rituale e
della poesia: mito e folclore, che ne informano modalità e contenuti, si compenetrano in uno spazio che letteralmente ‘risuona’, prospettandosi come potenzialmente infinito.
47 Massimo Lenzi, “La scena del verbo: Zangezi-Chlebnikov. Un'autoicona fra ultramondi”, Baubo,
<http://www.baubo.unito.it/archivio/chl.pdf> (09/2013).
142
Enza Dammiano
CHIARA MARIA BUGLIONI
“RESTA. TI RACCONTO QUALCOSA”.
IL DRAMMA POPOLARE DAS GLÜHEND MÄNNLA
DA ORALITÀ PRIMARIA A TRADIZIONE INCARNATA
L’anno di stesura di Das glühend Männla coincide con la caduta del muro di Berlino e con la cancellazione – almeno fisica – della linea di demarcazione tra le due
Germanie. L’autrice Kerstin Specht, originaria di Kronach, piccolo paese francone
al confine tra RDT e RFT, debutta nel mondo teatrale con un’opera a metà tra il
nuovo kritisches Volksstück1 e il magischer Realismus, termine che ella stessa utilizza
per definire la sua scrittura. In un’intervista del 2004 dichiara: “ich möchte, dass in
meinen Stücken eine Irrealität und Surrealität durchschimmert, die den realen
Raum und damit auch den Denkraum erweitert“.2 Il titolo, traducibile in italiano
come L’omino incandescente, prende spunto da una leggenda francone: di notte,
spettri infuocati si aggirano sulla terra nel vano tentativo di riparare agli errori
compiuti in vita nella posa di pietre confinarie.3 Proprio sul concetto di limes, “topographische Metapher” per la divisione tra sessi, generazioni e abitanti del paese,
si è soffermata la critica letteraria:4 i protagonisti del dramma sono situati, per varie
ragioni, ai margini della società, predestinati anelli di quella catena di violenza che
la comunità perpetua nei confronti degli individui più deboli. La critica ha altresì
letto la pièce alla luce degli stilemi tipici del Volksstück5 e della cosiddetta scrittura
1 Dramma popolare degli anni Settanta che, rifacendosi all’esempio di Horváth, Fleißer e, in parte,
di Brecht, trasforma il teatro in strumento di denuncia socioculturale, portando in scena spaccati di vita
delle classi meno abbienti e personaggi emarginati. Per una definizione del genere si veda Hugo Aust et
al., Volksstück: vom Hanswurstspiel zum sozialen Drama der Gegenwart, C. H. Beck, München, 1989, p. 317345.
2 “Desidero che nei miei testi teatrali traspaia un’irrealtà, un surrealismo, che amplifichino lo spazio
reale e, con questo, anche lo spazio del pensiero”(Britta Kallin, “Junges deutsches Theater in den USA:
Interview mit Kerstin Specht über ihre Theaterstücke”, The German Quarterly, 77.4, 2004, p. 485). Qui e
nel seguito la traduzione è di chi scrive.
3 Cfr. Christa Hinze und Ulf Diederich (a cura di), Fränkische Sagen, Bechtermünz Verlag, München,
1998, p. 204 s. e Jakob Grimm, Deutsche Mythologie, 2. Bd., Akademische Druck, Graz, 1968, p. 764.
4 Il termine ‘metafora topografica‘ compare in Angelika Führich, “Topographie der Grenze in Kerstin Spechts Dramatik”, Zs. für Literaturwissenschaft und Linguistik 27, 106, 1997, p. 151. Il tema del confine
è sicuramente presente nell’opera della Specht, come ella stessa esplicita nell’introduzione alla prima
pubblicazione di Das glühend Männla (Kerstin Specht, “Das glühend Männla”, Theater heute, 31.1, 1990,
p. 30). Il fatto, però, che questa introduzione sia stata eliminata per l’edizione in volume sembra un
invito a evitare la lettura unidimensionale dell’opera.
5 Già nel 1990 Andreas Roßmann definì Das glühend Männla un “Fegefeuer im Frankenwald”
(“inferno nella foresta francone”), con chiaro riferimento al dramma Fegefeuer in Ingolstadt della Fleißer
(Andreas Roßmann, “Fegefeuer im Frankenwald. Uraufführung am Schauspiel Bonn: Das glühend
144
Chiara Maria Buglioni
femminile, quali la violenza come unica forma d’interazione possibile, o la discriminazione delle donne all’interno di una società androcentrica.6 L’elemento lasciato tuttavia in ombra è proprio il realismo magico, quel sovra-realismo dai connotati
fiabeschi che trasfigura poeticamente una trama oltremodo scarna e lineare.
L’espediente drammaturgico a cui l’autrice ricorre per realizzare questa commistione di stili e generi è la trascrittura di performances orali. Il pensiero, la struttura
e l’esecuzione orale, spesso di tipo formulaico, dominano le trentatré scene-lampo
dell’opera, ambientate tutte all’interno di una casa, tra la cucina e la camera da
letto al piano superiore.7
Lo spazio claustrofobico ospita i tre personaggi principali (il figlio, la madre e la
nonna) e vede sporadicamente la comparsa dell’adolescente Anke, fidanzata del
figlio, e del vicino Berthold, originario dei Tatra, attratto sessualmente dalla madre.
Gli unici personaggi presentati con un nome proprio sono quelli destinati ad avere
la peggio al termine del dramma: in una climax di soprusi, vizi, vendette e aggressività, il figlio uccide Anke con il coltello lasciato in casa da Berthold e la madre,
rincasata a delitto compiuto, si fa subito complice del figlio promettendo di accusare il vicino dell’omicidio. L’apice drammatico viene dunque raggiunto nell’ultima
scena che, peraltro, si apre a delitto già compiuto. Le precedenti trentadue scene
sono costruite attorno a un breve monologo o a uno scambio di battute, spesso
apparente, tra due personaggi8 e si concludono, come indicato nella didascalia, nel
buio. In ciascuna scena il nucleo è costituito da forme di oralità primaria: narrativa
Männla”, Theater heute, 31.5, 1990, p. 36). L’allora trentaquatrenne Specht venne dunque ribattezzata
“Fleißers Enkelin”, nipote della Fleißer.
6 Riprendendo la chiave interpretativa di Susan L. Cocalis, la Führich si concentra sui meccanismi di
aggressione fisica e verbale tra i personaggi, all’interno di un mondo patriarcale in cui le donne sono sia
vittime che complici del “sexually politicized discourse of power and violence” (Angelika Führich,
“Borderlands in Kerstin Specht’s Dramas Das glühend Männla and Lila”, in Susan L. Cocalis (a cura di),
Thalia’s Daughters. German Women Dramatists from the Eighteenth Century to the Present, Franke, Tübingen
u.a., 1996, p. 294). Anche Bourke dipinge le donne del dramma come “end-products of a calamitous
past”: “[a]s a result of their own emotional starvation they overmother the son” in una battaglia spietata
per la conquista dell’unico uomo di casa (Thomas E. Bourke, “Kerstin Specht and the Critical Volksstück. A New Voice in a Seasoned Genre” in Arthur Williams und Stuart Parkes (a cura di), The Individual, Identity and Innovation. Signals from Contemporary Literature and the New Germany, Lang, Bern u.a.,
1994, p. 140).
7 La scelta dell’ambiente domestico rispecchia sì il Küchenrealismus dei drammi di Kroetz, ma qui le
mura di casa ospitano la reclusione volontaria della madre e della nonna. Nel corso della pièce le due
donne si separeranno fisicamente anche l’una dall’altra. A questo proposito, si veda Gérard Thiériot,
“Nouvel élan du Volksstück critique? Le théâtre de Kerstin Specht, après Fleißer et Kroetz (Das glühend
Männla, Amiwiesen, Lila)”, Allemagne d'aujourd'hui, 119, 1992, p. 145 s.
8 Solo nella 14ª scena, quando il figlio tenta di introdurre la fidanzata nel ménage familiare, i personaggi che agiscono sul palcoscenico sono tre. La scena finale ripresenta la stessa struttura, ma in questo
caso Anke è morta. Il testo di riferimento per l’ordine delle scene e per le citazioni è Kerstin Specht, Lila,
Das glühend Männla, Amiwiesen. Drei Stücke. Verlag der Autoren, Frankfurt a. M., 1900 (d’ora in poi
indicato con la sigla DgM, seguita dal numero di pagina).
“Resta. Ti racconto qualcosa”. Il dramma popolare Das glühend Männla …
145
orale tradizionale, racconti dell’estraneo da sé, racconti del passato e della propria
vita.
Per quanto riguarda i racconti della tradizione popolare, si evidenzia il ricorso
alla mitologia, alla fiaba, alla superstizione e alla devozione religiosa. La scelta del
titolo è emblematica, non solo per la leggenda germanica ad esso collegata, ma
anche per la collocazione di questo racconto all’interno del dramma. Nella scena
sesta, la madre, dopo aver aspettato il rientro a casa del figlio, cerca di dissuaderlo
dall’andare a letto:
MUTTER: Bleib. Ich erzähl dir was. Der Sohn stöhnt.
Als ich so war wie du, hab ich mich nachts immer gfürcht. Vor Gespenster.
Weißt, zum Rosenkranz, da mußt ich immer am Wurbacher Wasser vorbei. Da ham
sie gsacht, da rennt ein Gaul ohne Kopf rum und des glühend Männla. Ein milchweißer Gaul. Ich hab immer gelacht, aber amoll hab ich tatsächlich einen gsehn.
Milchweiß war er.
SOHN: Aber einen Kopf hat er gehabt?
MUTTER: Schon.
SOHN: Na dann… Ich geh jetzt ins Bett.9
Il segmento di racconto utilizzato per intrattenere il figlio presenta un elemento
formulaico (“Als ich so war wie du”), l’utilizzo di epiteti, la ripetizione del dettaglio significativo, un verbo con funzione fatica. All’interno di tutti i racconti riportati nel dramma si incontrano termini provenienti dal mondo dei Grimm, quali
Lebkuchenhaus (“casa di marzapane”) o alte Hexe (“vecchia strega”), modi di dire
come “Grübchen im Kinn, den Teufel im Sinn” o “Immer, wenn ich denk es geht
nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her”10 ed espressioni legate al
mondo animale, tra cui si evidenziano: “Bist wie ein Käfer unter einem Stein.
Fremd. Und rührst dich net”, “Des Vögela war ausn Nestla gfallen”, “Was es alles
gibt, auch bei die Tiere. Hams eine Panzerhaut und nutzt auch nix”.11 L’ultima
scena, inoltre, è occupata dalla nenia che la madre canticchia, in cui l’attenzione è
posta sulle giovani oche e sulle piume che queste, inevitabilmente, perdono. Il rife-
9 DgM, p. 58 s. “MADRE: Resta. Ti racconto qualcosa. Il figlio si lamenta. Quando ero come te, ho
sempre avuto paura di notte. Dei fantasmi. Sai, all’ora della lettura della Bibbia dovevo sempre passare
per la fonte di Wurbach. Là, dicevano, là ci corre un cavallo senza testa e l’omino incandescente. Un
cavallo bianco come il latte. Io ci ho sempre riso su, ma una volta l’ho visto veramente. Come il latte era
bianco. FIGLIO: Ma una testa ce l’aveva? MADRE: Certo. FIGLIO: Ah, be’ allora… adesso me ne vado a
letto”.
10 DgM, p. 71 e 69. La traduzione letterale ovviamente non corrisponde a modi di dire italiani:
“Fossette sul mento, diavolo in testa”, “Ogni volta che penso di non farcela più, spunta da qualche parte
una piccola luce”.
11 DgM, p. 62, 71, 73. “Sei come uno scarafaggio sotto un sasso. Indifferente. E non ti muovi”,
“L’uccellino era caduto dal nido”, “E che cosa non c’è, anche tra gli animali! Hanno la scorza dura
eppure non serve a niente”.
146
Chiara Maria Buglioni
rimento alla morte di Anke è implicito, poiché la madre aveva subito associato la
ragazzina a un’oca.12 A livello strutturale, gli elementi più significativi della trascrizione del discorso orale sono la sintassi e l’iterazione degli avverbi tipici delle
narrazioni “amoll”, “wenn”, “(n)immer” e “schon”,13 volti a rallentare e a distendere il ritmo complessivo della pièce che, di fatto, è estremamente franto. L'andamento delle singole narrazioni è paratattico: i periodi sono costituiti quasi sempre da
una sola, brevissima proposizione o da due proposizioni principali unite per asindeto, cosa che rende sì la limitatezza e la scarsa elaborazione del pensiero, ma anche l'urgenza comunicativa. La lingua stessa è degna di nota, dal momento che i
personaggi si esprimono in un gergo modellato sulle influenze del dialetto francone, con alcuni termini dialettali, molte forme sincopate o apocopate, l’assenza del
genitivo. Il pensiero delle dramatis personae, allora, si articola in espressioni formulaiche, frasi fatte, ripetizioni e temi noti. Da un lato, ciò rivela la necessità dei personaggi di attingere a un fondo mitico-archetipico per comunicare il loro profondo
malessere: tramite la tradizione popolare essi legittimano le paure e giustificano i
comportamenti, facendo corrispondere all’autenticità del racconto la verità del
sentimento. D’altro lato, però, è evidente che i personaggi si avvalgono del mito,
della fiaba e della religione per autocensurare la propria interiorità. Il racconto
serve a interporre un velo tra l’intimità esasperata della famiglia – che, come afferma la stessa autrice, si esprime soprattutto tramite la violenza14 – e il desiderio
del singolo di rivendicare la propria autonomia, la propria storia. Quanto è formulaico è prefabbricato, ossia si appoggia a clichés e rinforza i tabù, evitando qualsiasi
espressione della soggettività.15
Questo aspetto coercitivo della tradizione ripetitiva del mondo orale emerge
con forza anche dalla seconda forma di racconto trascritta nel dramma, quella della
comunità voyeuristica che rende l’altro, l’estraneo, oggetto di pettegolezzi o accuse. La scelta delle parole e delle forme espressive dipende qui dalla volontà di costruire delle antitesi indirette: nel momento in cui si racconta con sospetto qualcosa
dell’altro, per contrasto, si mette se stessi in una luce positiva. Questo è il meccanismo prediletto dalla madre, vittima delle malelingue del paese, poiché figlia illegittima e vedova di Kurt, un disertore dell’esercito della Germania Est, impiccatosi in
casa. La sua unica occupazione è quella di rispondere alla comunità che la esclude
con la stessa arma, ossia la maldicenza: ella racconta – al figlio, a Berthold o a se
12 “Die Gung hat genau so an Gang. Heb nur dein Näsla net so weit hoch, sonst bollerst noch drauf.
Siehstes, stolpert sie schon.” (DgM, p. 60). “L’ochetta ha proprio lo stesso andazzo. Solo non mettere il
tuo nido troppo in alto, se no caschi giù con un tonfo! Lo vedi, già inciampa”. Si noti anche la
distorsione emblematica del concetto di casa come nido.
13 “Una volta”, “quando”, “mai/ sempre”, “già”.
14 Kallin, “Junges deutsches Theater in den USA”, cit., p. 48.
15 Cfr. Walter J. Ong, Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, Routledge, London and
New York, 2002, p. 77.
“Resta. Ti racconto qualcosa”. Il dramma popolare Das glühend Männla …
147
stessa – la condotta biasimevole dei conoscenti o i danni che Kurt le ha arrecato. In
ciascuna narrazione condotta dalla donna si riscontra il conflitto tra la realtà oggettiva e la verità filtrata dalle usanze e dalle credenze del paese.16 Inevitabilmente,
però, il racconto dell’altro si trasforma in racconto di sé. Sia la madre che la nonna
sono impazienti di raccontare il loro passato: la trattazione narrativa della loro
esperienza è un darne conto alla generazione successiva. Se entrambe cercano di
dare un nuovo ordine agli eventi più significativi della loro vita è, essenzialmente,
per far emergere le memorie più rilevanti per il presente.17 La nonna tenta di rievocare l’arrivo di Kurt al villaggio con toni lirici e fiabeschi:
Er reut mich, der Kurt. Der arm Maikäfer.
Wie ein Maikäfer ist er ins Licht gflogen.
Des ganze Dorf war dunkel, wie er rüber die Grenz is.
Bloß in unserm Haus war Licht. Da ist er drauf zu.
Bin auf den Tod erschrocken, wie er ans Fenster geklopft hat. Mit seiner Uniform.
Hab ich gedacht, ein Russ is. ….
Dageblieben ist er, und deine Mutter hat er genommen. Die Hiesigen, die ham ihr
schlechte Goschen gekannt.18
L’anziana porta delicatamente in superficie anche il periodo nazista, la divisione della Germania, l’occupazione straniera e la crescente americanizzazione, tutto
in una narrazione frammentata e dolorosa, che trova prima il nipote come ascoltatore distratto, poi diventa un delirio solipsistico che culmina con un ferimento fisico, forse letale.
L’atto di raccontare dà alle due donne l’illusione di creare un legame, un dialogo autentico con i propri interlocutori. D’altronde, la comunicazione fallisce perché
i personaggi non sono in grado di mettersi nei panni del destinatario, di stabilire
un contatto pre-comunicazione verbale, di prevedere le possibili reazioni
dell’uditorio; ognuno è interessato esclusivamente al tornaconto personale e finge
soltanto di prestare attenzione alle parole di chi sta narrando. Ne consegue, quindi,
che l’esecuzione orale non è in Das glühend Männla un dialogo, ma solo un flusso a
16 Come quando, ragazzina, i suoi coetanei le misero del gesso sulla porta di casa: un modo per rendere
pubblici gli amori clandestini, anche se non sempre l’accusa corrispondeva al vero. Cfr. DgM, p. 81.
17 Kapusta afferma che la nonna assume nella pièce una funzione speciale grazie ai suoi ricordi:
“ihren Tiefenblick in die Vergangenheit und die Gegenwart der anderen Figuren zu versenken”
(“immergere il suo sguardo profondo nel passato e nel presente degli altri personaggi”). Cfr. Danijela
Kapusta, “Die Dämonisierung des Weiblichen. Zu Kerstin Spechts Das glühend Männla”, Zagreber Germanistische Beiträge, 17, 2008, p. 142. Considerando, però, anche i racconti della madre, è piuttosto la
verbalizzazione dei ricordi delle due donne ad assumere quella funzione speciale.
18 DgM, p. 65 s. “Mi fa pena, quel Kurt. Il povero maggiolino. Come un maggiolino è volato nella
luce. L’intero paese era buio come è passato dal confine. Solo in casa nostra c’era luce. Così è venuto. Mi
sono spaventata a morte quando ha bussato alla finestra. Con la sua uniforme. Ho pensato: è un russo.
…. È rimasto, e si è preso tua madre. Quelli di qui conoscevano il suo caratteraccio”.
148
Chiara Maria Buglioni
senso unico di parole e modi fissi per ordinare i tasselli dell’esperienza. Il racconto
iniziato e interrotto dalle figure è un aborto di ri-computazione, è cifra dell'isolamento e dell'impotenza dei personaggi, del loro parlare solo a se stessi e per se
stessi, dell’interiorizzazione dei precetti e del modello socioculturale della comunità che li rende inibiti e che li porta a sviluppare complessi di colpa e pulsioni aggressive. Emblematica è la scena tra nonna e nipote che si apre con la battuta
dell’anziana: “Erzählst nix. Sagst nix. / Manchmal is schon recht. Wennst bei einem
gscheiten Menschen bist, mußt net immer du sprechen. Mußt zuhören. Still sein.
Dann kannst was lernen. Aber deine Oma. Die is bei die Ameisen und net der König”.19 Il messaggio sorprende per l’ambiguità del destinatario: non è chiaro, infatti, se la donna si stia rivolgendo al nipote, invitandolo ad ascoltare quanto lei ha da
dire, finendo, però, per screditare il valore dei suoi racconti o, al contrario, se si stia
rivolgendo a se stessa, invocando per sé il diritto di non ascoltare nessuno e di
raccontare il passato. La replica da parte del ragazzo è non-verbale: si alza dalla
sedia e cerca nell’armadio della nonna qualche oggetto di valore da vendere. Ciò
che manca, allora, è tanto l’autorità del narratore quanto la voglia di imparare da
parte dell’astante. La fallita trasmissione culturale nell’endemica lotta tra generazioni e sessi porta incomprensione e violenza. Il desiderio di fagocitare, possedere
e dominare l’altro (figlio, nipote o compagna che sia) caratterizza questo spaccato
di società – non a caso, una famiglia – scosso dalle forze di un cambiamento epocale che minano la tradizione. Nessuno è interessato a conoscere ragioni diverse dalle
proprie o ad assumersi il peso del disagio di un altro; l’oralità primaria, quindi,
non ha più valore di storia condivisa, di conoscenza da coltivare, ma solo di strumento d’inganno e sottomissione.
In questo solco lasciato dal testo scritto, sullo sfacelo illustrato nel dramma,
s’inserisce la messinscena: la trasposizione sul palco diventa ricostruzione, rivendicazione estetica, storica e personale. Con ‘trasposizione scenica’ si presuppone uno
spostamento di attenzione dalla verbalizzazione all’azione fisica, con quella che si
potrebbe definire doppia performatività: la performance squisitamente orale, basata sul senso dell’udito, viene trasformata in performance agita, che coinvolge anche
altri sensi, primo fra tutti quello della vista. Questa trasformazione non elimina i
connotati dell’esecuzione orale, ma li inserisce all’interno della materialità della
scena, presupponendo l’interazione del pubblico. In Das glühend Männla l’azione è
quasi esclusivamente subita: ciò che il figlio subisce è la smania narrativa e possessiva della nonna e della madre, ciò che le donne subiscono è l’aggressione verbale
o fisica. È dunque il racconto a dominare la pièce, il flusso di parole quanto i punti
di sospensione e il silenzio, perché proprio a livello di uditorio si realizza il cam19 DgM, p. 77. “Non raccontare niente. Non dire niente. / A volte è giusto così. Quando sei con una
persona buona, non devi sempre parlare tu. Devi ascoltare. Stare zitto. Allora puoi imparare qualcosa.
Ma tua nonna. Lei è con le formiche e non il re”.
“Resta. Ti racconto qualcosa”. Il dramma popolare Das glühend Männla …
149
biamento più importante da comunicazione narrata nel testo a resa sul palcoscenico. Il pubblico è l’ascoltatore indiretto, fortuito del racconto tra i personaggi e, contestualmente, l’ascoltatore consapevole, il fruitore diretto della comunicazione
agita. A teatro lo spettatore contribuisce a completare quelle narrazioni cadute nel
vuoto della vita fittizia dei personaggi, a farsi anello di una catena di dialogo continuo, di scambio di memorie e valori, di collaborazione a tutti i livelli della società.
La funzione del teatro è lasciare uno spazio libero per raccontare di sé, per sentirsi
vivi ora, offrendo un’interpretazione del passato e ponendo le basi per il futuro. Il
racconto nel dramma della Specht è, dunque, il punto di partenza per rappresentare sia quel legame necessario al mondo degli avi, sia il ruolo che l’arte deve assumere per mettere in contatto i singoli con diverse percezioni del mondo. Solo in
questa dimensione il kritisches Volksstück può essere ancora politico.20
A questo proposito è bene osservare il grande assente nel testo teatrale: il padre,
inteso sia come autorità genitoriale sia, soprattutto, come passato, come origine. In
qualità di fuggiasco della RDT, Kurt rappresenta la diversità rispetto alle consuetudini della comunità a cui appartengono le donne e il legame con il periodo postbellico.21 Il figlio è desideroso di farsi un’idea propria del genitore scomparso, ma
si trova davanti a continue negazioni della figura paterna, come nello scambio di
battute:
SOHN: Den Vater sein Arbeitskollegen hab ich getroffen.
Der hat mir Gschichten erzählt.
MUTTER: Des sind alles Lügen. Mir ham keinen Vadder.
Hast nie einen ghabt.
Hast mich immer blutig gebissen, wie ich dir die Brust geben hab.
Mit meinem Blut hab ich dich genährt.
Bist von meinem Blut allein.
Keinen Vadder brauchen mir nicht.
Hab auch keinen ghabt.22
20 Thiériot ben intuisce la valenza politica del raccontare “la poésie de la souffrance pour dépasser
cette souffrance, pour échapper au nihilisme du no future.” (Gérard Thiériot, “Rupture, déchirement: le
drame peut-il encore donner un sens à la vie? Les pièces de Kerstin Specht”, in Françoise Knopper et
Alain Cozic (a cura di), Le déchirement. Formes et figures de la Zerrissenheit dans les lettres et la pensée
allemandes. L’Harmattan, Paris, 2006, p. 334).
21 Se si analizza l’onomastica del testo alla luce della tradizione germanica, si nota un interessante
riferimento: il nome Kurt designava lo spirito buono della casa, mentre Berchtold era per gli Svevi lo
spettrale capo dell’esercito furioso. Cfr. Grimm, Deutsche Mythologie, cit., pp. 761 e 777.
22 DgM, p. 55. “FIGLIO: Ho incontrato un collega di papà. Mi ha raccontato delle storie. MADRE:
Sono tutte balle. Non abbiamo un padre. Non ne hai mai avuto uno. Hai morso me fino a sanguinare
quando ti porgevo il seno. È con il mio sangue che ti ho nutrito. Sei solamente del mio sangue. Non
abbiamo bisogno di un padre. Neppure io ne ho avuto uno”.
150
Chiara Maria Buglioni
La negazione assoluta del valore dei padri comporta crisi d’identità da parte del
ragazzo, il quale crede che l’unico modo per scappare dalla gabbia familiare sia, in
primis, comprarsi un motorino e uniformarsi ai suoi coetanei, in secundis, dominare
il genere più debole, scaricando verso l’esterno le proprie frustrazioni. Non avendo
un’identità definita, ma solo il ruolo di figlio, egli si sceglie un obiettivo ambizioso
per auto-determinarsi: diventare ginecologo. Nell’atteggiarsi a futuro medico conoscitore del corpo femminile, il ragazzo ricorre spesso a citazioni letterarie decontestualizzate e manipolate. Con questo elemento si apre un discorso meta-letterario
sulla funzione e sulla responsabilità sociale dell’arte e della cultura. Gli autori citati
dal figlio sono Freud, Rimbaud e Nietzsche, i cui scritti sono utilizzati per ribadire
la superiorità del genere maschile, per legittimare la sottomissione fisica e culturale
delle donne. Lontana da una rivendicazione femminista,23 la Specht si sofferma
piuttosto sui danni che tanto la demonizzazione indiscriminata e la rimozione del
passato, quanto un’errata trasmissione di conoscenze, scoperte e riflessioni possono causare alle nuove generazioni. Il dramma composto per la messinscena diventa, quindi, il pretesto per rappresentare, assieme al pubblico, vicende, situazioni,
fatti reali che altrimenti sarebbero taciuti o non-fruiti direttamente. Se nel testo i
verbi “raccontare”, “dire”, “ascoltare” si susseguono quasi in ogni scena e se i personaggi si biasimano a vicenda perché nessuno può capire cosa pensano o come
era una volta, la scelta poetica dell’autrice è chiara: invitare il pubblico
all’attenzione e alla partecipazione, in una declinazione inusuale del kritisches Volksstück. Il teatro di Kerstin Specht non è teso a svelare la miseria morale e sociale
piccolo-borghese, bensì a incorporare lo spettatore nel processo creativo, nella produzione di significato, nella definizione dello spazio e del tempo in cui egli stesso
vive.
23 A proposito dell’omicidio in Das glühend Männla, la Specht dichiara: “Das ist ein ganz zärtlicher
Moment” (“è un momento di vera tenerezza”), in cui un giovane osserva la sua ragazza stesa a terra
(Anika Wiesbeck, “Entlang der Biographie: Die Enkelin Fleißers. Kerstin Specht im Gespräch mit Anika
Wiesbeck”, in Andrea Bartl (a cura di), Transitträume: Beiträge zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
Interviews mit Raoul Schrott, Albert Ostermaier, Hanns-Josef Ortheil, Andrea Maria Schenkel, Kerstin Specht,
Nora-Eugenie Gomringer, Olaf Neopan Schwanke und Franzobel, Wißner-Verlag, Augsburg, 2009, p. 453).
L’accoltellamento che non viene mostrato, infatti, sposta l’attenzione dalla vittima donna al giovane
carnefice: l’uccisione di Anke è stata per il figlio la forma massima di avvicinamento a lei, “[d]u kommst
jemandem so nahe, dass du ihm die Luft nimmst” (“arrivi così vicino a qualcuno da togliergli l’aria”)
(ivi, p. 452).
DORA RUSCIANO
LINGUAGGIO, TEATRO E FORMAZIONE
NEL KASPAR DI PETER HANDKE
Nell’ambito della vasta ed eterogenea produzione artistica di Peter Handke,
quella teatrale è forse la meno nota al grande pubblico, ma di certo non la meno
interessante. Poeta, romanziere, sceneggiatore, traduttore, saggista e appunto
drammaturgo: fin dagli esordi, l’autore austriaco si è confrontato con una moltitudine di generi e forme espressive e lo ha fatto in maniera molto consapevole e produttiva, lavorando sulle rispettive specificità. Al teatro iniziò a dedicarsi molto
presto: dopo che il romanzo d’esordio I calabroni gli era valso l’interesse della critica e dopo che un’aspra polemica con alcuni esponenti dell’influente “Gruppo 47”
aveva attratto su di lui l’attenzione della stampa, Handke scrisse tra il ’66 e il ’67
quattro pièce brevi, i cosiddetti Sprechstüke, termine variamente tradotto con “pezzi
vocali” o “pièce linguistiche” e che forse potrebbero essere definiti come ‘pezzi teatrali parlati’ in quanto non ruotano intorno a una narrazione o rappresentazione
mimetica, bensì alla riflessione sul linguaggio, sull’atto stesso di parlare (das Sprechen) come azione in sé. L’autore viennese mostra dunque fin dal titolo il proprio
intento di non accontentarsi delle forme tradizionali di teatro e di voler fare del
lavoro sulla forma il centro stesso della propria produzione teatrale. Benché siano
in esso riconoscibili elementi di novità rispetto alle opere teatrali precedenti, Kaspar
viene generalmente considerato l’ultimo pezzo teatrale parlato, quello in cui probabilmente la riflessione sul linguaggio – centrale nella poetica dell’autore – e sul
teatro trovano la loro espressione più complessa e riuscita.
Andata in scena in contemporanea a Francoforte, nel “Theater am Turm”, per la
regia di Klaus Peymann e ad Oberhausen per la regia di Günther Büch, la pièce non
si lascia facilmente riassumere: il plot narrativo non si presenta organicamente
diviso da un inizio, un’evoluzione e una fine. Se nei pezzi teatrali parlati è il linguaggio a farsi azione, per presentare brevemente la pièce bisognerebbe isolarne le
singole frasi.
Nella lunga premessa del testo a stampa Handke illustra il suo modo di intendere la messa in scena: descrive Kaspar che non deve assomigliare a un “Kasperle”, ossia una marionetta, ma piuttosto a Frankenstein o King Kong; immagina un
occhio magico che deve segnare la violenza verbale in scena con lampi di luce; fa
riferimento a voci fuori campo che devono sembrare metalliche e impersonali e
avere diversi modi di espressione; descrive la scena che deve essere riconoscibile
come scena teatrale e non come ambiente ricostruito ed infine ritorna a prendere in
considerazione la maschera che deve portare Kaspar. Essa deve conferire
un’immagine di stupore e sgomento non solo al personaggio, ma anche a tutti i
152
Dora Rusciano
suoi sosia che a un certo punto entrano in scena. L’ultima indicazione riguarda la
premessa stessa, che va trasmessa a voce bassa dagli altoparlanti mentre le luci in
sala sono ancora accese e il sipario aperto, accorgimento che rivela l’importanza
attribuita dall’autore a questa premessa e la sua volontà di evitare
l’immedesimazione totale degli spettatori nella vicenda.
La scena si apre con il protagonista che si muove in scena con difficoltà e pronuncia un’unica frase, attribuita al Kaspar storico: “Vorrei diventare come già un
altro fu”. Attraverso questa frase egli ha la convinzione di poter dominare la realtà
e di mettervi ordine. Il suo tentativo è messo in crisi da una serie di voci di suggeritori, che non trovano corpo sulla scena ma vengono trasmesse da altoparlanti. Esse
tentano di indurre Kaspar a parlare; lo tempestano di battute alle quali egli tenta di
opporre la propria unica frase. Nel corso dell’opera il protagonista viene ancora
sottoposto alla violenza verbale dei suggeritori, ai rumori infernali prodotti da altri
attori in tutto simili a lui, al frastuono generato dal sovrapporsi delle registrazioni
di diversi tipi di discorsi pubblici. Tutto ciò lo costringe più volte al silenzio o a
parlare come i suoi suggeritori, a esaltare il potere delle frasi con cui poter mettere
ordine nel reale, a esprimersi in rima o a pronunciare frasi prive di significato
compiuto, chiedendosi talvolta egli stesso il senso di ciò che sta dicendo. A chiudere la pièce è proprio la ripetizione ossessiva di una frase apparentemente senza
senso, “Capre e scimmie”, nella quale lo spettatore colto può cogliere una citazione
dall’Otello di Shakespeare.
Ad oggi Handke ha scritto ben venti opere teatrali ma, al di là del numero cospicuo, ciò che colpisce è la qualità della ricerca formale che in esse viene condotta,
sia per quanto riguarda lo specifico del genere teatrale, sia per la posizione che esse
di volta in volta occupano nell’ambito più vasto della poetica dell’autore. Kaspar
rappresenta certamente una delle vette più alte di questa produzione, come dimostrano anche gli innumerevoli spunti critici da esso offerti. Particolarmente rilevanti sembrano essere le considerazioni che, a partire da essa, si possono fare sulla
questione del nesso tra oralità e teatro. Il presente contributo si propone di analizzare l’opera cercando di mettere in luce i diversi modi in cui tale rapporto trova
espressione nella pièce, sia dal punto di vista della genesi dell’opera, in quanto il
plot narrativo risulta una ripresa di un racconto dal carattere leggendario riadattato per la scena, sia dal punto di vista stilistico, per la scelta di rinunciare ad una
forma di teatro in cui la visione predomini sull’ascolto, prediligendo una rappresentazione che abbia nel linguaggio il centro stesso dell’opera. Il linguaggio imposto dall’esterno ingabbia l’individuo in una griglia interpretativa ed incide inevitabilmente sulla formazione del cittadino, che si fonda anche sulla rielaborazione
teatrale del patrimonio orale condiviso.
Partiamo dal primo punto. Nell’opera è evidente un chiaro riferimento alla vicenda di Kaspar Hauser, ambientata all’inizio dell’Ottocento: un adolescente è
tenuto per anni segregato in assoluta solitudine, incatenato al pavimento di una
Linguaggio, teatro e formazione nel Kaspar di Peter Handke
153
cella e privato di qualsiasi contatto umano, se si eccettua l’uomo che gli porta da
mangiare. Il prolungato isolamento ha privato il giovane del naturale sviluppo
psicofisico per cui, al momento del suo ritrovamento in una piazza di Norimberga,
presenta le abilità linguistiche e motorie di un bambino di tre anni. Accudito da
diversi notabili della zona, Kaspar impara a leggere, a scrivere e a comportarsi
secondo le convenzioni del vivere comune, ma non smette mai di destare nelle
persone una curiosità quasi morbosa, al punto tale che la sua vita termina con
l’uccisione in circostanze misteriose, quanto quelle della sua apparizione.
Anselm von Feuerbach, che più di altri si è interessato alle sorti del ragazzo, ha
scritto, prima di essere a sua volta ucciso, una biografia intitolata Kaspar Hauser. Un
delitto esemplare contro l’anima,1 che ha costituito il nucleo intorno al quale si è costruita la leggenda del “fanciullo d’Europa”2. Data la singolarità della storia, non
sorprende che essa sia stata ripresa con successo da molti autori. Come evidenzia
tra gli altri Ulrich Sturve nell’introduzione al volume Der Findling Kaspar Hauser in
der Literatur,3 Kaspar è divenuto simbolo dello stato di natura che cade vittima
delle regole imposte dalla società, nonché, soprattutto dall’interpretazione di Paul
Verlaine in poi, emblema dell’estraneità del poeta alla società. In realtà, ricondurre
il Kaspar di Handke a uno di questi due simboli è limitativo: si potrebbe dire che
l’autore austriaco non impiega nessuna di queste immagini, ma piuttosto si concentra su una questione specifica, quella linguistica, che comprende in sé qualsiasi
altro tema.
In un’intervista pubblicata nel volume Die Arbeit des Zuschauers. Peter Handke
und das Theater, Handke racconta di come gli sia capitato tra le mani per caso il
libro di Anselm von Feuerbach, mentre curiosava nella libreria di un’amica, e di
aver scorto in questa storia un elevato potenziale drammatico:
In effetti con il Kaspar sono diventato un autore di teatro – afferma Handke – solo
non sapevo come funzionava, come si scrive per il teatro. Come bisognava riraccontare la storia di Kaspar Hauser? Quale il rapporto tra costruzione, concrezione
e astrazione? […] Con il Kaspar ho iniziato nuovamente a raccontare e a costruire figure. Ma procedendo con molta esitazione. Il problema era: come si dialoga? Come si
esercita il potere parlando?4
Anselm von Feuerbach, Kaspar Hauser. Un delitto esemplare contro l’anima, Adelphi, Venezia, 1996.
È questo l’appellativo con il quale viene spesso fatto riferimento a Kaspar Hauser, non solo per la
sua origine incerta ma soprattutto per la vasta fama che in breve tempo raggiunse la sua storia,
diventata presto fonte di ispirazione per i letterati di tutto il continente. Cfr. anche Johannes Mayer e
Peter Tradowsky, Kaspar Hauser. Das Kind von Europa, Urachhaus Geistesleben, Stuttgart, 1996.
3 Ulrich Struve, Der Findling Kaspar Hauser in der Literatur, Metzler Verlag, Stuttgart, 1992.
4 Peter Handke, Ein Gespräch mit Thomas Oberender, in Klaus Kastberger e Katharina Pektor (a cura
di), Die Arbeit des Zuschauers. Peter Handke und das Theater, Jung und Jung, Salzburg, 2013, p. 14.
1
2
154
Dora Rusciano
Nel costruire l’opera, Handke crea in effetti una sorta di precipitato degli elementi salienti della leggenda del trovatello e allo stesso tempo estrae da essa la
questione del linguaggio e del nesso tra parola e potere. Nel corso del dramma egli
riprende alcuni aspetti principali del Kaspar storico, quali la goffaggine nei movimenti e la ripetizione della frase: “Vorrei diventare come già un altro fu”. In realtà,
però, la chiave di interpretazione della figura di Kaspar Hauser si trova, come detto, nella lunga premessa al testo drammatico che si apre come segue: “Kaspar non
mostra COS’È REALE o cosa È STATO REALE per Kaspar Hauser. Mostra semplicemente cosa PUÒ ACCADERE a qualcuno. Mostra come qualcuno può essere portato alla
parola mediante la parola. Questa pièce potrebbe anche chiamarsi ‘Tortura della
parola’”.5 Nelle intenzioni dell’autore, dunque, la storia del “fanciullo d’Europa”
non è ripresa come drammaturgia finita, come storia già data: le azioni che hanno
luogo sulla scena non sono finalizzate alla rappresentazione della sua specifica
vicenda, ma vogliono mettere in scena il linguaggio e le sue potenzialità coercitive,
per cui le parole e i gesti minimi che il protagonista compie in scena hanno di per
sé un valore drammatico. Questa idea di teatro è spiegata bene da Handke in un
breve saggio del 1968 dal titolo Theater und Film. Das Elend des Vergleichens (Teatro e
film. La desolazione del confronto):
A Parigi ho recentemente visto il “Bread und Puppet Theater” di New York che mi
ha persuaso delle possibilità non del teatro, ma della presentazione immediata delle
azioni. La drammaturgia teatrale classica, che conosce solo parole e azioni che sono
funzionali ad una storia, viene qui ridotta ad azioni e parole, rumori e suoni per se
stessi: essi diventano azioni che non mostrano nient’altro che se stesse come azioni
teatrali: le azioni hanno luogo per se stesse e le parole parlano per se stesse: lo spettatore che a teatro si aspetta che ogni parola e ogni azione tendano verso una finalità in
senso teatrale, verso una storia, viene lasciato da solo con l’azione. Alzare una mano
è una storia, canticchiare a bocca chiusa è una storia. Stare seduti, sdraiati o in piedi
sono storie. […] Ne deriva un’incredibile sincronia, del vedere, del respirare, del distinguere. Lo spazio forma un’unità teatrale in cui si è sempre più attenti, sempre più
tesi.6
Se dunque le azioni e le parole non sono subordinate alla rappresentazione di
una determinata storia, il riferimento, comunque evidente, alla storia di Kaspar
Hauser può essere inteso come un tentativo di creare un ulteriore motivo di tensione e attenzione, un modo per giocare – in maniera molto seria – con le aspettative del pubblico, aspettative che sono di fatto inevitabili quando si fa riferimento a
storie che fanno parte del patrimonio culturale condiviso.
Peter Handke, Kaspar, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1968, p. 7.
Peter Handke, “Theater und Film. Das Elend des Vergleichens“, in Id., Ich bin ein Bewohner des
Elfenbeinturms, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1972, pp. 65-77, qui p. 76.
5
6
Linguaggio, teatro e formazione nel Kaspar di Peter Handke
155
La ripresa di una leggenda popolare per la creazione di un’opera nuova, del resto, è interessante non solo dal punto di vista della ricezione del pubblico e delle
dinamiche di fruizione e interpretazione dell’opera, ma anche dal punto di vista
creativo-formale per la comprensione delle modalità di ripresa e adattamento dei
racconti ‘originari’. Laddove, come in questo caso, il pubblico viene spinto più
verso la tensione critica che verso l’immediato riconoscimento del racconto leggendario, esso viene anche in qualche modo reso partecipe di una riflessione sulle
modalità di costruzione letteraria. Tale riflessione viene legata strettamente anche
alla questione che percorre tutto il Kaspar, ossia la possibilità/impossibilità di costruirsi un proprio linguaggio, un proprio discorso, una propria narrazione
all’interno del linguaggio, dei discorsi e delle narrazioni già date. In questo senso,
la scelta di rielaborare un racconto leggendario ben noto si presenta come scelta
ben consapevole che pone in essere un problema non solo formale – come passaggio dal registro espressivo del racconto orale a quello della messa in scena –, ma
anche culturale in senso lato. In realtà risulta impossibile scindere le due questioni,
in quanto è proprio a partire da questioni formali che Handke fonda e dà sostanza
alle proprie riflessioni. Basti pensare alla già menzionata polemica con alcuni
membri del “Gruppo 47”, da lui accusati di insulso realismo e rimproverati di proporre mere descrizioni della realtà senza riflettere sulle modalità di costruzione
della stessa. È proprio quest’ultimo aspetto ad essere di primaria importanza per
l’autore e in questo senso il teatro si rivela per lui un luogo privilegiato per il coinvolgimento del pubblico.
I pezzi teatrali ‘parlati’ nascono appunto da questo intento poetico: lavorare sulle forme espressive per giungere a una forma teatrale che affini le capacità critiche
piuttosto che coinvolgere lo spettatore in interpretazioni ideologiche già date della
realtà. Come spiega bene Fritz Wefelmeyer,
Con questa etichetta egli si dissocia da tutte le categorie tradizionali, quali quelle di
dramma, tragedia e commedia, e sottolinea che il punto cruciale per lui è il linguaggio in forma di discorso come attività che crea la realtà. Inoltre egli prende le distanze
dal teatro epico di Brecht tanto quanto dalla littérature engagée di Sartre con il loro
impegno politico diretto.7
Emblematica è in questo senso la strategia messa in atto nel primo dei pezzi
teatrali parlati, Insulti al pubblico, che consiste appunto nel rivolgersi direttamente
ad esso. All’inizio della pièce, alcuni rumori fanno immaginare allo spettatore che
sulla scena si stiano apportando le ultime modifiche alla scenografia, ma quando si
leva il sipario la scena non presenta la ricostruzione di un particolare ambiente, ma
solo un semplice palco con degli attori. Lo spazio scenico si presenta come luogo in
7 Fritz Wefelmeyer, “Handke’s Theater”, in David N. Coury e Frank Pilipp (a cura di), The Works of
Peter Handke. International Perspectives, Ariadne Press, Riverside, 2005, pp. 194-235, qui p. 200.
156
Dora Rusciano
cui ‘viene detto’ e non ‘rappresentato’ qualcosa, mentre la distinzione tra lo spazio
della finzione e lo spazio del pubblico viene ulteriormente ridotta dall’inusuale
utilizzo delle luci in sala. Gli attori si rivolgono direttamente al pubblico dichiarando che tra loro e il pubblico si creerà gradualmente un’unità, illustrando quello
che gli spettatori non vedranno. In tal modo essi distinguono coscientemente le
intenzioni comunicative del teatro tradizionale da quelle della pièce alla quale stanno prendendo parte. Gli attori esortano il pubblico ad abbandonare la comoda
posizione di spettatori di un teatro di finzione in cui viene proposta una determinata visione della realtà. La pièce si chiude infine con gli attori che rivolgono al
pubblico gli insulti ai quali si fa riferimento nel titolo, spiegati in maniera esplicita
come ulteriore strumento di coinvolgimento dei presenti in sala.
L’opera suscitò reazioni forti e contrastanti tra gli spettatori e fu per molti versi
vista come una mera provocazione; la stessa stampa non mancò di attaccare ad
Handke l’etichetta di enfant terrible della letteratura tedesca. In realtà non si trattava
di una provocazione o di un gioco, bensì di un lavoro molto serio con precise finalità poetiche, che furono poi spiegate dall’autore nelle Note ai pezzi teatrali parlati:
I pezzi teatrali parlati sono spettacoli senza immagini in quanto non danno
un’immagine del mondo. Essi rappresentano il mondo non in forma di immagini,
bensì in forma di parole e le parole dei pezzi teatrali parlati mostrano il mondo non
come qualcosa che sta al di fuori delle parole, bensì il mondo che c’è nelle parole
stesse. Le parole di cui i pezzi teatrali parlati sono costituiti non propongono
un’immagine del mondo bensì un concetto del mondo. I pezzi teatrali parlati sono
teatrali nella misura in cui si servono di forme naturali dell’esprimersi nella realtà. Si
servono di forme che anche nella realtà devono essere naturalmente delle espressioni, cioè: si servono di forme linguistiche che nella realtà vengono espresse oralmente.
I pezzi teatrali parlati si servono della forma naturale di espressione che è propria
dell’insulto, dell’autodenigrazione, della confessione, dell’enunciato, della domanda,
della giustificazione, della scusa, della profezia, del grido d’aiuto. Essi dunque richiedono un interlocutore, almeno una persona che stia ad ascoltare; altrimenti non
sarebbero espressioni naturali bensì espressioni imposte dall’autore. In questo senso i
pezzi teatrali parlati sono pezzi di teatro. Essi imitano ironicamente in teatro la gestualità di tutte le forme d’espressione naturale elencate. Nei pezzi teatrali parlati
non può esserci un’azione, perché sulla scena qualsiasi azione sarebbe soltanto
l’immagine di un’altra azione: i pezzi teatrali parlati si limitano, nella misura in cui
ubbidiscono alla loro congenita forma naturale, alle parole, e non forniscono immagini, neppure immagini in forma di parole, che sarebbero soltanto le immagini, imposte dall’autore, di uno stato di cose interiore, per natura non espresso e muto e non
in forme naturali. I pezzi teatrali parlati sono prefazioni ormai autonome agli antichi
pezzi di teatro. Essi non intendono rivoluzionare, bensì destare l’attenzione.8
È evidente in questo passo il forte peso che la filosofia di Wittgenstein ha avuto
nell’elaborazione di un tale modello di teatro, nel segno della migliore tradizione
8
Peter Handke, Stücke 1, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1972, p. 201.
Linguaggio, teatro e formazione nel Kaspar di Peter Handke
157
letteraria austriaca, da sempre sensibile al problema delle possibilità del linguaggio. La ricerca personale di Handke si è tradotta in un tipo di drammaturgia che
ruota dunque intorno ad alcuni elementi chiave. Prima tra tutte, si pone l’idea che
il teatro non sia un luogo di rappresentazione, bensì un luogo fisico in cui l’autore
può interloquire con il proprio pubblico attraverso il medium degli attori; un luogo
privilegiato in cui il pubblico ascolta, dando senso alla creazione artistica che, per
sua intrinseca natura, richiede una persona che stia ad ascoltare, per poterne destare l’attenzione. In questo senso i pezzi teatrali parlati mettono in atto una strategia
comunicativa che ridà peso al linguaggio in sé rispetto alla narrazione mimetica,
all’ascolto rispetto alla visione, alla concentrazione rispetto alla fruizione passiva,
alla partecipazione attiva rispetto all’immedesimazione in una visione del reale già
data. Per queste loro caratteristiche i pezzi teatrali parlati sono molto più vicine
alla partecipazione a una performance orale che a una messa in scena teatrale.
Con il Kaspar questo tipo di lavoro diventa ancora più complesso. Cosa cambia?
Innanzitutto, come accennato, la scena non è più vuota, anche se gli oggetti di scena sono pochi e devono essere chiaramente riconoscibili come tali e non come parti
di un ambiente artificiosamente ricostruito. Vi è poi un occhio magico che aiuta a
scandire il grado di violenza con cui le voci provenienti dagli altoparlanti si rivolgono a Kaspar, ma questo aspetto visivo è comunque subordinato a quello acustico, in quanto sottolinea ciò che in realtà si è ascoltato. Gli attori, infine, indossano
una maschera – una maschera che deve essere come una seconda pelle e conferire
al protagonista un’espressione di stupore e turbamento – e dunque non costituiscono più solo gli interlocutori del pubblico, ma non sono più neppure
l’incarnazione dei personaggi in senso tradizionale. Rispetto ai precedenti pezzi
teatrali parlati si crea dunque una dinamica diversa tra il ‘dire qualcosa a teatro’ e
portare in scena una storia. La peculiarità di questa traduzione da racconto orale a
dramma è la rinuncia alla modalità stessa del racconto, strutturato con un inizio e
una fine, e la concentrazione sull’elemento del linguaggio che si fa azione. Per riprendere una terminologia della teoria della traduzione,9 si potrebbe dire che la
dominante che Handke riconosce nella storia di Kaspar Hauser è la formazione
dell’individuo attraverso il linguaggio, o meglio, il suo essere ingabbiato all’interno
di pattern linguistici. Ciò che porta in scena dunque non è la storia di un giovane
dal destino avverso, ma quella che egli stesso chiama ‘tortura del linguaggio’.
Handke non vuole raccontare la violenza, ma metterla in scena; non cerca
l’immedesimazione in una storia, ma l’attenzione del suo pubblico verso la que-
Numerosi sono gli studi sulla traduzione che mettono in rilievo l’importanza della delineazione
delle dominanti di un testo per la sua traduzione. Per un approfondimento sulla questione si veda ad
esempio Bruno Osimo, Propedeutica della traduzione, Hoepli, Milano, 2010, testo ricco a sua volta di
riferimenti bibliografici interessanti.
9
158
Dora Rusciano
stione del dominio attraverso il linguaggio non solo della realtà, ma soprattutto
dell’individuo.
Scrive Fritz Wefelmeyer: “Nelle sue opere teatrali Handke, d’altra parte, non si
preoccupa di presentare o imitare la realtà sociale al di fuori del teatro, ma piuttosto evidenziare come e attraverso quali mezzi viene prodotta la realtà. Le sue domande sono: cosa presupponiamo? Cosa diamo per scontato? Quali modelli preconcetti segue la nostra immaginazione”.10 Questa questione si lega sottilmente con
quella dell’oralità, che si fonda proprio sulla condivisione ampia di narrazioni che
fungono non solo da modello ad altri racconti, ma anche da griglia interpretativa
per la realtà e la formazione dell’individuo.
Nel linguaggio stesso Handke sembra scorgere dunque un potenziale strumento coercitivo. In un volume uscito per la Suhrkamp che raccoglie le prime opere
drammatiche dell’autore, oltre alle già citate Note ai pezzi teatrali parlati, Handke
pubblica una sorta di schema nel quale la ‘formazione’ di Kaspar attraverso il linguaggio viene scandita in sedici fasi da cui risulta evidente quanto il confine tra
formazione e manipolazione sia labile:
Prima fase:
Seconda fase:
Terza fase:
Quarta fase:
Quinta fase:
Sesta fase:
Settima fase:
Ottava fase:
Nona fase:
Decima Fase:
Undicesima fase:
10
Può Kaspar, che possiede una frase, partire da questa frase e intraprendere qualcosa?
Può Kaspar fare qualcosa con questa frase contro le altre frasi?
Può Kaspar con la sua frase almeno tenere testa alle altre frasi?
Può Kaspar difendersi dalle altre frasi e rimanere in silenzio,
benché le altre frasi lo incitino a parlare?
Può Kaspar, per il solo fatto di parlare, comprendere qualcosa di
ciò di cui parla?
Può Kaspar, che possiede delle frasi, ottenere con queste frasi
qualcosa non solo nei confronti delle altre frasi, ma anche degli
oggetti delle altre frasi?
Può Kaspar con l’aiuto delle frasi qualcosa sull’ordine o meglio:
con frasi ordinate fare ordine in se stesso?
Può Kaspar a partire dall’ordine di una frase costruire una serie
di frasi che rappresentano un ordine esteso?
Può Kaspar imparare, qual è di volta in volta il modello con il
quale si può creare a piacimento un numero infinito di frasi
sull’ordine?
Può Kaspar comprendere gli oggetti attraverso i modelli di frasi
appresi o almeno avere accesso a degli oggetti?
Può Kaspar con le sue frasi dare un contributo alla grande società
delle frasi?
Wefelmeyer, “Handke’s Theater”, cit., p. 195.
Linguaggio, teatro e formazione nel Kaspar di Peter Handke
Dodicesima fase:
Tredicesima fase:
Quattordicesima fase:
Quindicesima fase:
Sedicesima fase:
159
Può Kaspar essere portato, attraverso frasi che rimano, a capire
qualcosa degli oggetti delle sue frasi?
Può Kaspar porsi delle domande?
Può Kaspar con frasi spontanee, che egli applica alle proprie vecchie frasi non spontanee, raddrizzare il mondo distorto di queste
frasi?
Può Kaspar con un mondo distorto di frasi imporsi nei confronti
di frasi distorte del mondo? Ovvero: può Kaspar, stravolgendo
frasi distorte, evitare almeno la falsa apparenza di verità?
Chi è Kaspar adesso? Kaspar, chi è adesso Kaspar? Cos’è adesso,
Kaspar? Cos’è adesso Kaspar, Kaspar?11
Queste sono le domande che Handke si pone nel riscrivere la storia di Kaspar
Hauser e probabilmente quelle che vorrebbe si ponesse il lettore. In sostanza, dopo
una prima parte in cui si interroga sulle possibilità del linguaggio riguardo alla
comprensione e organizzazione del mondo, nella seconda parte, dalla fase tredici
in poi, sembra concentrarsi sulle possibilità che esso offre in termini di libertà e
individualità. Handke sembra chiedersi fino a che punto Kaspar abbia la possibilità
di problematizzare la propria esperienza della realtà senza essere inglobato in uno
schema interpretativo rigido, insito nel linguaggio stesso; se possa sottrarsi a questi
meccanismi con frasi spontanee, agendo contro le frasi ‘non spontanee’, contro la
falsa apparenza di verità. In sostanza si chiede – e questo è il suo ultimo interrogativo – cosa ne sia di Kaspar alla fine di questa tortura linguistica, cosa resti
dell’individuo dopo che ha ingaggiato la sua battaglia con il linguaggio.
È difficile, in effetti, rispondere a questa domanda, il finale stesso dell’opera resta aperto. Come si è detto, essa si chiude con una citazione dall’Otello: Kaspar
continua a ripetere la frase “capre e scimmie”, apparentemente senza senso. Questo potrebbe essere interpretato come una riduzione al silenzio del protagonista o
come una sua strenua ribellione all’ordine del discorso già dato. Oppure, se si
guarda al contesto in cui, nell’opera di Shakespeare, la frase viene pronunciata, si
potrebbe intendere come un’ulteriore sottolineatura del potenziale manipolatorio
del linguaggio. Nell’Otello, che del resto si fonda sulla manipolazione del pensiero
e dei sentimenti altrui, il protagonista ripete appunto ossessivamente questa frase
quando crede di avere le prove del tradimento di Desdemona: egli riprende una
delle immagini che Iago ha instillato nella sua mente per rendere ancor più squallido il pensiero dell’adulterio, per sostituire nella mente del protagonista
l’immagine di una Desdemona angelicata con quella di una donna lasciva dalla
sessualità animalesca. In questo senso la frase “capre e scimmie” può essere vista
come un esempio del potere condizionante del linguaggio. Se si accetta
11
Handke, Stücke 1, cit., pp. 207-208.
160
Dora Rusciano
quest’interpretazione, il tema della manipolazione assume un peso ancora maggiore all’interno dell’opera. Allo stesso tempo, però, va sottolineato che, a differenza
dell’Otello, i manipolatori sono principalmente delle voci fuori campo che non
prendono corpo sulla scena e in questo senso sono più difficili da contrastare. Esse
non sono riconoscibili, non prendono la forma di un nemico concreto con il quale
scontrarsi apertamente ma giungono da tutte le parti aumentando a dismisura la
loro capacità di imporsi e risultare perciò inattaccabili. Come propone giustamente
Roberto Menin, il loro ruolo nell’opera potrebbe essere accostato a quello dei media nella società contemporanea:
Nel Kaspar Handke sembra individuare il grande responsabile della Zerrissenheit, ovvero il linguaggio come viene usato e inculcato dalle istituzioni della modernità: i
mass media innanzitutto, i centri propulsori della cultura e della modernità nel suo
complesso. Il linguaggio banale delle comunicazioni di massa, moderno per eccellenza, fingendo di dotare ogni individuo di un comodo strumento di dominio e ordine
sul mondo esterno, lo ingabbia in una realtà artificiale, in apparenza docile e trasparente, in realtà fittizia e invalicabile.12
Indubbiamente quest’ipotesi è molto plausibile, ma si potrebbe addirittura ampliare questo discorso a un altro tipo di istituzione: quella del teatro stesso. Nel
testo a stampa, infatti, le voci vengono indicate con il termine “Einsager”, ossia
suggeritori, come coloro che a teatro suggeriscono la battuta a chi non ha imparato
bene la parte. Una parte che è fissa e non può essere detta in altro modo, non può
essere improvvisata. Il teatro è una delle istituzioni alle quali è stata attribuita storicamente un ruolo formativo dell’individuo e del cittadino. Non è solo ai nuovi
media, dunque, che Handke fa riferimento nella sua pièce, ma anche ad
un’istituzione antica come il teatro.
Più in generale si può dire che il riferimento dell’autore austriaco sia ai discorsi
dominanti che condizionano quasi inconsapevolmente gli individui e ai loro diversi modi di espressione. Come afferma Gunther Segooris, “La manipolazione attraverso il linguaggio nella nostra cosiddetta ‘democrazia pluralistica’ non è altro che
una forma legalizzata di violenza: siamo tutti Kaspar”.13
Non sembra dunque azzardato scorgere un’attenzione per una critica politicosociale: non solo lo stesso Handke parla dell’esercizio del potere attraverso il linguaggio come uno dei problemi che egli stesso si è posto, ma anche molti suoi collaboratori dell’epoca hanno recentemente sottolineato il valore politico di questa
forma di teatro. Particolarmente interessante è la testimonianza del regista Klaus
Peymann che curò la prima messa in scena dell’opera a Francoforte, alla quale
12 Roberto Menin, “Peter Handke Kaspar”, in Marino Freschi (a cura di), Il teatro tedesco del
Novecento, CUEN, Napoli, 1998, pp. 317-323, qui p. 319.
13 Gunther Segooris, Peter Handke und die Sprache, Bouvier Verlag, Bonn 1979, p. 96.
Linguaggio, teatro e formazione nel Kaspar di Peter Handke
161
prese parte Handke stesso. Egli racconta di come la mattina della première la compagnia prese parte alle manifestazioni di piazza che sfociarono in scontri con la
polizia e parte dell’ambiente di sinistra di Francoforte considerò un tradimento la
scelta di andare in scena. L’intera compagnia vedeva in realtà nel proprio lavoro
una sorta di ‘guerriglia teatrale’, in quanto considerava l’opera espressione del
malessere che stava al fondo stesso delle proteste del Sessantotto. Come spiega
Peymann,
il Kaspar di Handke si riferisce a un mito antico, al leggendario Kaspar Hauser – il ragazzo senza casa, il trovatello, una sorta di Parsifal. Come il suo modello storico, il
Kaspar di Handke viene addomesticato, inserito a forza nella società. Fatto crescere.
Diventa un robot. Questo era esattamente quello che combattevamo. Non volevamo
essere regolamentati, volevamo autodeterminarci. (Le donne volevano realizzarsi!).
Volevamo il potere, volevamo un’altra Germania, un’altra società, un’altra Europa,
un altro mondo. Il Kaspar di Handke – protagonista e vittima – sta per tutto questo. I
suggeritori sono i manipolatori, i violentatori, il sistema.14
Altrettanto interessante è la testimonianza dell’editore ed esperto di teatro
Karlheinz Braun, il quale parlando del Kaspar, afferma:
A me come a moti altri sembrò reagire in maniera diretta agli eventi del giorno. Noi
tutti eravamo dei Kaspar, ai quali i suggeritori – leggi: il governo – cercavano di suggerire precise prescrizioni. Molte frasi dei suggeritori corrispondevano ai discorsi dei
politici e la pièce divenne – certamente contro l’intenzione dell’autore – una pièce politica: la cornice astratta del linguaggio venne riempita con la realtà concreta
dell’undici maggio. Il ricordo di questa prima ha significato per me e forse per molti
altri un ampliamento del concetto di teatro politico.15
Questo toccato da Braun è un punto molto importante, in quanto egli sottolinea
come Kaspar non solo sia riuscito a creare un nesso tra teatro e attualità politica, ma
che sia riuscito a farlo innovando le forma stessa del teatro, senza fare della sua
opera un’opera ideologica. La scelta di portare in scena una vicenda parte del patrimonio culturale; la decisione di concentrare i mezzi comunicativi sull’ascolto e
sulle potenzialità del linguaggio piuttosto che sulla recitazione di una storia,
creando una dinamica particolare tra il vedere e il sentire, contribuiscono a creare
un’opera che tiene costantemente desta l’attenzione dello spettatore. In qualche
modo Handke insegna al pubblico a guardare:
Gli spettatori dovrebbero imparare a guardare alla natura come a una drammaturgia,
come drammaturgia del sistema dominante, non solo in teatro, anche altrove. Ma è a
Klaus Peymann, “Theater für ein neues Jahrhundert“, in Kastberger - Pektor, Die Arbeit des
Zuschauers, cit., pp. 87-98, qui p. 90.
15 Karlheinz Braun, “Der Beat von achtundsechzig“, in Kastberger - Pektor, Die Arbeit des Zuschauers,
cit., pp. 59-66, qui 63.
14
162
Dora Rusciano
teatro che dovrebbero impararlo, che dovrebbero acquisire uno sguardo straniato.
[…] Per questo è più che mai importante occuparsi di estetica. Solo l’estetica può
rendere l’apparato di percezione così preciso che la natura in questa società diventa
riconoscibile come falsa, manipolata. Solo una nuova estetica può fornire queste prove e queste argomentazioni.16
16
Peter Handke, “Die Arbeit des Zuschauers“, in Id., Ich bin ein Bewohner, cit., pp. 88-101, qui p. 99.
ALESSANDRO CIMINO
DONARE LA PROPRIA CARNE COME PASTO:
UN MOTIVO LETTERARIO INDIANO TRA TEATRO, MITO E FOLKLORE
Introduzione
Il presente lavoro si propone di indagare le modalità con cui gli elementi fissi
del plot narrativo di un racconto tradizionale si adattino alla sua messa in scena nel
panorama teatrale sanscrito. Il teatro classico indiano prende spunto, specialmente
nel caso del nāṭaka (“dramma”),1 da materiale mitologico tradizionale facilmente
riconoscibile dallo spettatore, riadattato però alle esigenze imposte dalle finalità
della rappresentazione. Il motivo del dono della propria carne, che esamineremo in
queste pagine, rappresenta l’elemento portante di due drammi e si ritrova, poi, in
testi di vario genere, nei quali esso può svilupparsi liberamente e in modi spesso
assai differenti, sottratto alle rigide regole e convenzioni cui è soggetta la trama del
dramma indiano.
Il Lokānanda (La gioia del mondo) è un testo teatrale in sanscrito datato nel IV sec.
d. C. e attribuito a Candragomin,2 perduto tuttavia nella sua versione originale3 e
tramandatoci in modo particolarmente lacunoso nella sua traduzione in tibetano,4
risalente al XIV sec., di cui ovviamente non si può fare a meno per la piena comprensione del dramma.5
L’opera, uno dei pochissimi esempi di drammaturgia buddhista,6 ripercorre la
vita del principe vidyādhara7 Maṇicūḍa (dal nome parlante: “che ha una gemma
sulla sommità del capo”), erede al trono del regno di Kosala.8 Il protagonista, pur
aspirando alla pratica ascetica, è tenuto a prendere moglie, in modo da poter
1 Il nāṭaka, che insieme al prakaraṇa (“fiction”) rappresenta una delle due forme principali di teatro
classico indiano, ”riprende una storia tradizionale con un protagonista di alto lignaggio”. Cfr. Giuliano
Boccali, “La letteratura classica”, in Giuliano Boccali et al., Le letterature dell’India, Utet, Torino, 2000, pp.
383-552, in part. p. 403.
2 “Oltre che drammaturgo, grammatico e filosofo buddhista” lo definisce Giuliano Boccali ( ivi, p. 515).
3 Restano soltanto undici versi della versione originale in sanscrito. Cfr. Michael Hahn, “The Play
Lokānandanaṭaka by Candragomin”, Kailash, 7.1, 1979, pp. 51-67 , in part. p. 51.
4 Sulla questione della trasmissione del testo si vedano Michael Hahn, “Some Remarks Concerning an
Edition of the Tibetan Translation of the Drama Lokānanda by Candragomin”, Indo-Iranian Journal, 13.2,
1971, pp. 104-112; Michael Hahn, Candragomins Lokānandanāṭaka nach dem tibetischen Tanjur herausgegeben
und übersetzt. Ein Beitrag zur klassischen indischen Schauspieldichtung, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1974.
5 Hahn, “The Play Lokānandanaṭaka by Candragomin”, cit., p. 51.
6 Boccali, “La letteratura classica”, cit., p. 516.
7 Particolare essere semidivino generalmente dotato di poteri magici. Cfr. Sanskrit-English Dictionary,
s.v. “vidyādhara” (Monier Monier-Williams, Sanskrit-English Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 1899).
8 Famoso regno antico, con capitale Ayodhyā, situato a nord del Gange. Cfr. Sanskrit-English Dictionary,
cit., s.v. “kosala”.
164
Alessandro Cimino
assicurare una successione al regno e garantire il compimento dei riti tradizionali.9
I primi tre atti (aṅka) sono così totalmente incentrati sulle nozze del principe con la
bellissima Padmāvatī, che ritraggono l’uomo diviso tra l’obbedienza ai propri
doveri e il desiderio di una vita ascetica.10 Il nucleo principale dell’azione
drammatica è concentrato però negli ultimi due aṅka, quando Maṇicūḍa, dopo
essersi spogliato di ogni avere, è per tre volte messo alla prova dal dio Indra, il
quale vuole testare l’immensa generosità dell’eroe. Questi, infatti, senza mostrare
un attimo di esitazione, è pronto a donare la propria carne come pasto a un rākṣasa,
particolare tipo di demone antropofago,11 per superarsi poi in generosità offrendo
la moglie e il figlio ad un antico e sapiente veggente mitico, il ṛṣi Marīci. La terza
prova da superare è la donazione della gemma (maṇi) “concresciuta nel suo capo”12
per la salvezza di un paese nemico. Tutte e tre le prove di generosità rappresentano
casi esemplari di dānapāramitā (“perfezione della generosità”), elemento dottrinale
molto importante nella tradizione religiosa buddhista, in quanto la capacità di
donare incondizionatamente e senza attaccamenti “ha l’effetto di purificare e
trasformare la mente dell’offerente”.13 Nell’aṅka IV.f-i del testo ricostruito,14 un
terribile rākṣasa entra in scena e chiede carne umana macellata di fresco come pasto;
Maṇicūḍa offre se stesso, mentre la moglie Padmāvatī e il brāhmaṇa15 Gautama,
presenti sulla scena, tentano invano di sostituirsi a lui in una gara di generosità.
Mentre il principe offre il resto del proprio corpo per finire di saziarlo, il rākṣasa
rivela di essere in realtà il dio Indra e l’eroe moribondo è miracolosamente curato
delle sue ferite e salvato dalla morte. Questo particolare episodio deve essere
considerato centrale all’interno della struttura del dramma non solo per la sua
posizione nello schema narrativo, ma soprattutto perché sancisce l’inizio, e in un
certo senso anche uno dei suoi apici più tragici, della materia principale dell’opera,
cioè la professione di dānapāramitā da parte del protagonista.
Una vicenda analoga si trova al centro di un’altra opera teatrale, il Nāgānanda
(La gioia dei Nāga), datato intorno al VII sec. d. C., il cui autore si identifica nel so-
9 Brajendra Nath De, “The Story of King Maṇicūḍa”, Journal and Text of the Buddhist Text Society of India,
1.3, 1893, pp. 27-39; Ratna Handurukande, “The Maṇicūḍa Study”, Buddhist Studies, 5, 1976, pp. 309-368;
Phyllis Granoff, “The Sacrifice of Maṇicūḍa: The Context of Narrative Action as a Guide to Interpretation”,
in V. N. Jha (a cura di), Kalyānamitra (Festschrift for H. Nakamura), Poona University, Poona, 1990, pp. 225239.
10 Boccali, La letteratura classica, cit., p. 516: “Sul piano teatrale, tale contrasto si traduce in quello fra lo
śṛṅgārarasa (“sentimento dell’amore”) e lo śāntarasa (“sentimento della quiete”)”.
11 Si tratta infatti di un caso di dehadāna (“dono del proprio corpo”). Cfr. Reiko Ohnuma, Dehadāna: The
“gift of the body” in Indian Buddhist Narrative Literature, University of Michigan, Michigan, 1997.
12 Boccali, “La letteratura classica”, cit., p. 516.
13 Stewart McFarlane, “Making moral decisions”, in Peter Harvey (a cura di), Buddhism, Continuum,
London, 2001, pp. 181-204, in part. p. 186.
14 Hahn, The Play Lokānandanaṭaka, cit., pp. 63-64.
15 Sacerdote addetto al culto. Cfr. Sanskrit-English Dictionary, cit., s.v. “brāhmaṇa”.
Donare la propria carne come pasto: un motivo letterario indiano tra teatro, mito e folklore
165
vrano Harṣa.16 Anch’esso di ispirazione buddhista,17 il dramma si richiama esplicitamente al Lokānanda18 ma l’eroe di questa seconda rappresentazione, tuttavia, risulta essere non più ‘la gioia del mondoʹ, bensì quella dei Nāga, serpenti mitici
dotati di molteplici teste e volto umano, che saranno gli unici a beneficiare della
sua condotta generosa.
Anche in questo caso il testo risulta bipartito: i primi tre aṅka sono incentrati su
un matrimonio, quello del principe vidyādhara Jīmūtavāhana con la bellissima principessa siddhā19 Malayavatī; gli ultimi due trattano nel complesso la dānapāramitā
del protagonista, il quale offre il proprio corpo come pasto per il dio Garuḍa.
Jīmūtavāhana si imbatte per caso in un mucchio di ossa di Nāga e scopre che ogni
giorno Garuḍa si nutre di uno di essi; Śaṅkhacūḍa, che pure l’eroe aveva appena
conosciuto, è destinato a tale tragica sorte, ma il principe decide di sacrificarsi al
suo posto. Nonostante il giovane Nāga insieme alla madre tenti di distoglierlo, in
una gara di generosità che duplica quella del testo precedente, Jīmūtavāhana si
offre a Garuḍa, che non si accorge dello scambio avvenuto. Quando infine il dio
comprende l’errore e si pente della sua condotta, interviene la dea Gaurī,20 che
resuscita compiaciuta Jīmūtavāhana insieme a tutte le precedenti vittime di
Garuḍa. Anche in quest’opera, dunque, si ripetono le caratteristiche precipue della
vicenda mitica: un principe vidyādhara offre il proprio corpo come pasto per un
essere sovrumano e ʹgareggiaʹ con altri personaggi al fine di realizzare la dānapāramitā. La vita che egli stesso ha sacrificato, però, gli viene risparmiata grazie
all’intervento divino, che agisce quale deus ex machina. L’unica differenza con il
Lokānanda è che nel Nāgānanda il sacrificio di sé costituisce di per sé prova suprema
di generosità e non si somma ad ulteriori prove di nobiltà d’animo.
Il mito di Maṇicūḍa e quello di Jīmūtavāhana, dunque, appaiono strettamente
connessi sia per il comune riferimento alla dottrina buddhista della dānapāramitā,
che per il carattere tipicamente fiabesco di questi esseri semidivini21 che sono identificati come potenti sovrani vidyādhara. Differenti però sono le dinamiche che nei
due testi inducono il sovrano a compiere l’estremo sacrificio. Nel primo si riconosce facilmente la presenza di un motivo tipicamente folklorico, chiamato da W.
16 Harṣavardhana di Kanauj (regnante 606-647), “l’ultimo sovrano prima dei Mughal a dominare su
gran parte dell’India settentrionale”. Cfr. Boccali, “La letteratura classica”, cit., p. 520.
17 Biscoe Hale Wortham, The Buddhist Legend of Jīmūtavāhana and the Nāgānanda, George Routledge
Sons, London, 1911; Bak Kun-Bae, Śrīharṣa’s Plays, Indian Council for Cultural Relations, London, 1964;
Bak Kun-Bae, Nāgānanda of Harṣa, Motilal Banarsidass, New Delhi, 1992.
18 Boccali, “La letteratura classica”, cit., p. 521.
19 Particolare essere celeste. Cfr. Sanskrit-English Dictionary, cit., s.v. “siddha” e “siddhā”.
20 La dea è manifestazione di Pārvatī, moglie di Śiva, in contrasto dunque con Garuḍa, che è invece la
cavalcatura (vāhana) di Viṣṇu. Cfr. Sanskrit-English Dictionary, cit., s.v. “gaurī” e “garuḍa”.
21 Boccali, “La letteratura classica”, cit., pp. 501-502.
166
Alessandro Cimino
Hansen dell’”ospitalità ricompensata”:22 un essere divino, dopo essersi camuffato
sotto mentite spoglie, premia o punisce chi lo ospita, a seconda che questi si sia
mostrato generoso o scortese. Nella seconda opera, invece, il motivo è del tutto
assente. L’eroe Jīmūtavāhana non è sottoposto a nessuna prova, anzi è il protagonista che dà volontariamente saggio di estrema generosità sostituendosi ad una
vittima già designata al sacrificio. Possiamo allora ipotizzare che il motivo del dono della propria carne come pasto si articoli in due differenti sottorappresentazioni: una concessione indotta e una concessione volontaria.
Versioni parallele del medesimo motivo folklorico: un’indagine comparata
Per poter analizzare più approfonditamente il motivo letterario riconosciuto, si
prenderanno in considerazione altri casi, qui elencati secondo un criterio di maggiore o minore presenza dell’elemento folklorico. L’esempio più famoso nella letteratura hindū è quello di Śibi, la cui storia è narrata in Mahābhārata III 130-131 (Il
grande poema dei Bhārata), scritto probabilmente tra IV sec. a.C. e IV sec. d.C.23 Un
colombo inseguito da un falco si rifugia presso il re Śibi e ottiene protezione dal
predatore, ma quest’ultimo avvilito dalla fame suscita compassione e ottiene di
potersi cibare della carne dello stesso re. Śibi pone su una bilancia la propria carne,
in modo che risulti dello stesso peso del colombo, ma l’uccello diventa sempre più
pesante e il re è costretto a cedere l’intero suo corpo, finché i due volatili svelano di
essere gli dei Agni ed Indra, compiaciuti per la prova di generosità superata dal
sovrano e disposti a sanarlo ed onorarlo come merita. La finzione metateatrale
organizzata dalle due divinità consente di identificare agevolmente nel testo
l’elemento folklorico dell’”ospitalità ricompensata”. Tuttavia è interessante notare
come il sacrificio del protagonista sia considerato dal punto di vista esclusivamente
’laico‘24 e politico come un elemento imprescindibile dei doveri civici del sovrano,
il quale, dopo aver accolto qualcuno sotto la sua protezione, è tenuto a salvaguardarne la salvezza sino al punto di sacrificare la propria vita. Il motivo del dono del
proprio corpo come pasto, quindi, se da un lato non risulta esclusivo della tradizione buddhista ma è ben attestato anche in uno dei testi più rappresentativi della
22 William Hansen, Ariadne’s Thread. A Guide to International Tales Found in Classical Literature, Cornell
University Press, Ithaca, 2002, pp. 211-223. Nel sistema di Antti Aarne e Stith Thompson il motivo
dell’”ospitalità ricompensata” corrisponde a tre sottocategorie: AT 750A, I desideri, AT 750B, Ospitalità
ricompensata, e AT 750*, Ospitalità benedetta. Cfr. ivi, p. 211, e Antti Aarne, Stith Thompson, The Types of the
Folktale: A Classification and Bibliography, The Finnish Academy of Science and Letters, Helsinki, 1961.
23 Mahābhārata, III 130-131. Per le edizioni di riferimento del testo di vedano Shripad Krishna Belvalkar
et al. (Edd.), The Mahābhārata, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1933-1966; Pratap Chandra
Roy (a cura di), The Mahābhārata of Krishna-Dwaipayana Vyasa, traduzione di Kisari Mohan Ganguli, Bharata
Press, Calcutta, 1883-1896.
24 Il termine laico non deve essere qui inteso in senso assoluto, in quanto anche i doveri di un re
rientrano tra gli obblighi religiosi codificati dalla tradizione sacra hindū.
Donare la propria carne come pasto: un motivo letterario indiano tra teatro, mito e folklore
167
religiosità hindū, dall’altro si mostra duttile ad essere articolato secondo diverse
prospettive tematiche.
In Mārkaṇḍeyapurāṇa25 3 (Il Purāṇa rivelato da Mārkaṇḍeya), datato intorno al IX-X
sec., è contenuto un altro esempio tratto dalla letteratura di confessione hindū.26
Quattro uccelli, personaggi fondamentali nella struttura narrativa dell’opera,27
raccontano al saggio Śamīka di essere stati nella vita precedente figli del ṛṣi Sukṛṣa.
Quando erano umani, il dio Indra si recò nell’eremo di Sukṛṣa28 sotto le sembianze
di vecchio uccello affamato chiedendo protezione e carne umana di cui potersi
cibare; il ṛṣi non esitò ad offrire i propri figli, i quali però si rifiutarono di obbedire29
e furono per questo maledetti dal padre a rinascere come uccelli. Sukṛṣa, pur di
rispettare l’ospitalità concessa, offrì la propria carne, ma subito l’uccello mostrò la
sua natura divina: il dio Indra si rivelò così compiaciuto per la liberalità dell’asceta
e lo benedì prima di andare via. I figli del ṛṣi, i quali chiedevano al padre di essere
salvati dalla maledizione, ottennero da questi di poter almeno conservare la conoscenza acquisita sino a quel momento, motivo per il quale diventarono quattro
uccelli dotti. In questa storia, l”ospitalità ricompensata” si articola in modo ancora
diverso. Alle caratteristiche ricorrenti del dio che, sotto mentite spoglie, testa la
generosità di un mortale e al premio finale, qui identificabile nella benedizione
divina, si contrappone la mancata guarigione miracolosa, in assenza della scena
cruenta dell’aggressione o della macellazione della carne offerta. La maledizione
dei figli di Sukṛṣa corrisponde poi alla punizione inflitta a chi non mostra gentilezza e liberalità nei confronti degli ospiti e non supera la prova di generosità.30 La
punizione ai figli, tuttavia, è inflitta dallo stesso Sukṛṣa, invece che dal dio offeso,
in quanto la disubbidienza dei quattro giovani al padre rappresenta una colpa
assai grave. Essi vengono meno ai loro doveri di figli e discepoli,31 mostrando così
di meritare la maledizione, che tra l’altro si mostra, in gran parte della letteratura
25 Mārkaṇḍeyapurāṇa, Veṅkaṭeśvara Mudraṇālaya, Bombay, 1901; The Mārkaṇḍeya Purāṇa, tradotto da
Frederick Eden Pargiter, Indological Book House, Varanasi, 1969.
26 L’opera, ritenuta dagli studiosi uno dei Purāṇa più antichi, è famosa in quanto contiene negli adhyāya
(‘capitoli’) 81-93 la Devīmāhātmya (La celebrazione della Dea), “che è il testo fondamentale della religione
śākta”. Cfr. Stefano Piano, “La tradizione, la nuova rivelazione e la letteratura scientifica”, in Giuliano
Boccali et al., Le letterature dell’India, cit., pp. 123-381, in part. p. 247.
27 Sono i quattro dotti uccelli che rispondono alle domande di Jaimini, discepolo di Vyāsa, attraverso le
quali si sviluppano i vari argomenti del testo; ivi, p. 248-249.
28 L’eremo di un ṛṣi in questo caso sostituisce facilmente la tipica corte di re incontrata nei precedenti
casi del motivo esaminato.
29 Si verifica dunque l’esatto opposto della gara di generosità del Lokānanda e del Nāgānanda.
30 Hansen, Ariadne’s Thread, cit., pp. 211-223.
31 André Couture ha ben evidenziato la correlazione tra i doveri di un figlio verso il padre e quelli di
un discepolo verso il guru (“maestro”), così come la fondamentale importanza di tali doveri nella società e
nel cerimoniale hindū. Cfr. André Couture, “Kṛṣṇa’s Initiation at Sāndīpani’s Hermitage”, Numen, 49.1,
2002, pp. 37-60, in part. pp. 50-52.
168
Alessandro Cimino
di matrice hindū, prerogativa precipua dei ṛṣi, tanto che essi sono capaci di maledire lo stesso dio Indra.32
In Jātakamālā33 8 (La ghirlanda delle vite anteriori) della fine II sec., Ārya Śūra34 narra la storia del re Maitrībala, esempio buddhista di dānapāramitā perfettamente
conseguita. Un giorno cinque demoni (yakṣa), dopo essere stati accolti a corte sotto
le mentite spoglie di un brāhmaṇa (“bramino”), chiedono al sovrano carne e sangue
umani come cibo e bevanda. La vicenda si svolge secondo il modo consueto: nonostante i ministri tentino in ogni modo di dissuaderlo, l’eroe offre il proprio sangue
e la propria carne, e ancora una volta, dopo che il gesto supremo è compiuto, i
cinque yakṣa si pentono e il dio Indra guarisce il re morente. Tuttavia, l’elemento di
variazione che entra in relazione oppositiva con la vicenda di Śibi è di nuovo identificabile in un motivo ’laico‘ che però viene in questo testo articolato al contrario.
Le motivazioni su cui si basa la dissuasione dei ministri riguardano i doveri di un
sovrano nei confronti dei propri sudditi: egli deve garantire il benessere e la prosperità e non può disporre della propria vita in maniera così egoistica, anche perché i medesimi ministri si dichiarano pronti a sacrificare se stessi al posto del re.
Tuttavia, proprio in virtù di tali ragioni, l’eroe non si lascia dissuadere, anzi si mostra ancora più convinto che la sua scelta sia quella giusta; qualora rinunciasse ad
offrire il proprio corpo agli ospiti come promesso lasciando che altri si sacrifichino
per lui, si macchierebbe delle colpe di spergiuro e egoismo, a causa delle quali non
sarebbe più in grado di garantire il benessere del suo popolo.
Un ennesimo caso è contenuto in Siṃhāsanadvātriṃśikā35 11 (Le trentadue storie del
trono) del XI-XIII sec. con protagonista Vikrama, sovrano semi-leggendario36 assurto a paradigma di santo nella tradizione jaina.37 Il re, riposando sotto un albero,
ascolta il discorso di alcuni uccelli, uno dei quali rivela la triste sorte di un brāh32 Basti pensare ai casi di Gautama, che priva il dio della virilità, in Rāmāyaṇa I 48-49 (L’itinerario di
Rāma, I-II sec.), e Durvāsas, che gli fa perdere il dominio sul triplice mondo, in Viṣṇupurāṇa I 9 (Il Purāṇa di
Viṣṇu, III-IV sec.).
33 Il testo è conosciuto anche come Bodhisattvāvadānamālā (La ghirlanda delle imprese del bodhisattva).
Ārya Śūra, The Jātakamālā, edito da Hendrik Kern, Harvard University Press, Cambridge, 1943; Ārya Śūra,
La ghirlanda delle rinascite. Le vite anteriori del Buddha, a cura di Raniero Gnoli, Rizzoli, Milano, 1991. L’opera
raccoglie trentaquattro tra le più celebri vite anteriori del Buddha, “allo scopo di ammaestrare i laici con
l’esempio delle virtù praticate dal bodhisattva”. Cfr. Boccali, “La letteratura classica”, cit., p. 532.
34 Non tutti sono concordi nel riconoscere in lui l’autore dell’opera, a volte identificato con Mātṛceta;
Saverio Sani, “Le letterature religiose”, in Giuliano Boccali et al., Le letterature dell’India, cit., pp. 3-121, in
part. p. 115.
35 Il testo è conosciuto anche come Vikramacarita (Le gesta di Vikrama). La narrazione ruota intorno alle
trentadue storie relative al re Vikrama, raccontate dalle altrettante statuette che adornano il trono
appartenuto a questo sovrano. Cfr. Boccali, “La letteratura classica”, cit., pp. 505-506. Di questo testo
esistono cinque recensioni principali, di cui una di tradizione jaina. Ho seguito qui il preciso confronto
testuale operato da Franklin Edgerton in Vikrama’s Adventures, Harvard University Press, Cambridge, 1926.
36 Vi è incertezza sull’identità di Vikrama, identificato a volte con un personaggio storico, il re
Candragupta II Vikramāditya; ivi, pp. lviii-lxvi.
37 Ivi, pp. lxiv-lxv.
Donare la propria carne come pasto: un motivo letterario indiano tra teatro, mito e folklore
169
maṇa che era stato suo amico in una vita precedente: l’uomo, abitando in una città
infestata da un rākṣasa che costringe i cittadini a consegnare ogni giorno un essere
umano come pasto, deve di lì a poco sacrificare se stesso o il suo unico figlio.
Vikrama si reca immediatamente in quella città e offre se stesso come pasto al
rākṣasa. Il demone, dopo essersi stupito dell’aspetto sereno del re, apprende da
questi che ha scelto volontariamente di offrirsi come pasto al posto di uno sconosciuto. Stupitosi del suo coraggio, il rākṣasa promette di esaudire un desiderio di
Vikrama, il quale chiede che cessi di nutrirsi di carne umana, ponendo così fine al
sacrificio degli abitanti della città. Anche in questo caso, come in quello di Mārkaṇḍeyapurāṇa 3, il pasto di carne umana è soltanto minacciato, ma mai consumato
materialmente, neanche nella forma di un’aggressione o dell’offerta della carne
tagliata. Si riconosce qui una maggiore somiglianza con la vicenda di Jīmūtavāhana e il volontario atto sacrificale dell’eroe, non condizionato da elementi esterni e
impositori. Il dovere peculiare di un sovrano di sacrificarsi per i propri sudditi è
insito nel ruolo del protagonista, il quale non esita a intervenire persino a favore di
cittadini di un paese sconosciuto. Il fulcro della narrazione rientra comunque nella
casistica della dānapāramitā, qualità morale celebrata anche dalla tradizione religiosa jaina cui il testo appartiene.38
Ancora in campo buddhista si deve citare il Vyāghrījātaka (La vita anteriore relativa alla tigre femmina) in Jātakamālā 1 di Ārya Śūra.39 In una delle sue precedenti incarnazioni come bodhisattva,40 il Buddha scopre in una grotta una femmina di tigre
affamata, troppo stanca per cacciare a causa del recente parto e intenzionata a divorare la sua prole per sopravvivere. Vinto dalla compassione il bodhisattva si getta
da una rupe nella grotta della tigre, in modo che la stessa possa cibarsi della carne
del suo cadavere e desistere dal crudele proposito. Si assiste ancora a un caso di
dānapāramitā: il sacrificio di sé al fine di salvare un essere più debole, destinato a
tragica sorte.41 Questo è l’unico racconto in cui al dono della propria carne segue
un pasto effettivo, in quanto la tigre si ciba letteralmente del cadavere del bodhisattva. Manca del tutto invece sia l’elemento dell’”ospitalità ricompensata” sia il motivo del deus ex machina finale. Chi pratica la dānapāramitā non ottiene qui alcuna
ricompensa immediata; è un estremo atto di generosità disinteressata che comporta
a tutti gli effetti la morte dell’offerente. Questa integrità morale disinteressata, priBoccali, “La letteratura classica”, cit., p. 506.
Ārya Śūra, The Jātakamālā, cit.; Ārya Śūra, La ghirlanda delle rinascite, cit. Yuan Ren mette in relazione
questo racconto con la storia di Maṇicūḍa in Yuan Ren, Maṇicūḍāvadāna: The Annotated Translations and a
Study of the Religions Significance of Two Versions of the Sanskrit Buddhist Story, McMaster University,
Hamilton, 1998, p. 9.
40 “Chi è in procinto di ottenere la perfetta conoscenza avendo raggiunto lo stadio immediatamente
precedente a quello di Buddha”. Cfr. Sanskrit-English Dictionary, cit., s.v. “bodhisattva”.
41 In questo caso il protagonista è un bodhisattva e non un re; la presenza però di discepoli al suo seguito
lo innalza alla stregua di un sovrano, poiché occupa una posizione di rilievo su un gruppo, quasi si
trattasse di una vera e propria corte.
38
39
170
Alessandro Cimino
va di favori personali, è perfettamente in linea con la dottrina buddhista della
dānapāramitā e non dovrebbe dunque sorprendere, se non fosse per il fatto che questa versione costituisce un unicum rispetto a tutti gli altri casi qui presi in considerazione, in cui alla fine è sempre assicurata una continuazione della vita dell’eroe.
Conclusioni
Come si evince dai numerosi casi di narrazione del motivo folklorico dell’offrire
la propria carne come pasto, qui presi brevemente in considerazione, il topos narrativo di matrice orale e tradizionale presenta alcuni elementi fissi, intorno a cui si
articolano poi le differenti varianti narrative. In tutti i racconti un uomo, che gode
di una posizione privilegiata o superiore, come un re, un principe, un bodhisattva o
un ṛṣi, sacrifica la propria vita per la salvezza di un altro essere vivente, offrendosi
come cibo ad una belva affamata. L’atto di estrema generosità, come nel caso di
Jīmūtavāhana, di Vikrama e del Vyāghrījātaka, può essere del tutto volontario o
addirittura casuale, come conseguenza di un incontro fortuito del protagonista con
una creatura in estrema difficoltà, oppure il sacrificio è richiesto da un essere divino come prova suprema di nobiltà d’animo e abnegazione nei confronti del prossimo. Infatti, da questo punto di vista, la vicenda del principe Maṇicūḍa si avvicina
a quelle del re Śibi e del ṛṣi Sukṛṣa, in quanto in tutte e tre il dono della propria
carne risulta necessario per superare una prova di generosità imposta da Indra
sotto mentite spoglie. Nel solo Vyāghrījātaka il dono della propria carne comporta la
morte definitiva del protagonista, differenziandosi così dagli altri racconti, dove
l’eroe invece è sempre salvato da un dio, che lo guarisce o arriva perfino ad evitargli del tutto l’aggressione fatale. I quattro figli di Sukṛṣa rappresentano invece
l’unico caso di punizione, dovuta alla mancanza di generosità nei confronti
dell’ospite divino.
È possibile, quindi, distinguere in due modalità narrative il motivo folklorico:
un primo tipo, che accomuna le vicende di Maṇicūḍa, Śibi, Sukṛṣa e Maitrībala, è
caratterizzato dall’elemento dell’”ospitalità ricompensata” e dal motivo religioso
del deus ex machina; un secondo, invece, in cui il gesto sacrificale risulta quasi casuale, ma non per questo meno qualificante per l’eroe.
L’ultima storia da prendere in esame è quella del cammello alla corte del leone.
Questa favola era contenuta in origine nel perduto Pañcatantra42 (I cinque libri, II-VI
sec.) di Viṣṇuśarman,43 ma ci è stata comunque tramandata nelle successive riela-
42 Una ricostruzione filologica dell’opera è stata realizzata da Franklin Edgerton, il quale inserisce
questa favola nell’ottavo capitolo del primo libro. Cfr. Franklin Edgerton, Pañcatantra Reconstructed,
American Oriental Society, New Haven, 1924.
43 L’autore scrive quest’opera con l’intento di insegnare in soli sei mesi la scienza politica “ai tre
svogliati figli del re del Deccan, Amaraśakti”. Cfr. Boccali, “La letteratura classica”, cit., p. 503.
Donare la propria carne come pasto: un motivo letterario indiano tra teatro, mito e folklore
171
borazioni44 dell’opera, delle quali si prende qui in esame la Kathāsaritsāgara45 X.LX
84F (L’oceano dei fiumi dei racconti, 1063-1081) di Somadeva.46 Un cammello, giunto
presso la corte del leone, è accolto da questi come ospite sotto la sua protezione; un
giorno il leone, impossibilitato a trovare da mangiare, decide di cibarsi del cammello. Per evitare che si commetta un’ingiustizia nei confronti dell’ospite, gli animali feroci, che corrispondono ai ministri della corte di cui il leone è re, ingannano
il debole animale con una falsa gara di generosità: si offrono l’uno dopo l’altro
come pasto per il proprio sovrano, ma il leone accetta l’offerta solo al turno del
cammello, sbranandolo senza che si commetta alcun torto nei suoi confronti. Questa favola presenta somiglianze e divergenze con il motivo esaminato e si mostra
particolarmente vicina ad un contesto folklorico anche per l’origine animale dei
protagonisti, spesso attori di vicende tradizionali che celano il loro messaggio morale sotto le spoglie ferine dei personaggi. La favola, infatti, si mostra più disincantata delle versioni precedentemente analizzate: il re, un tempo generoso protettore
del più debole non accetta di sacrificare la propria vita, ma al contrario approfitta
della stoltezza del suo protetto per soddisfare la propria fame e riesce a tradire i
sacri vincoli dell’ospitalità senza commettere colpa, ma servendosi addirittura dei
ministri che inscenano una falsa gara di generosità.
Questo racconto si rivela un perfetto rovesciamento di quanto accade nel Lokānanda e nel Nāgānanda. Tale rovesciamento è in sintonia con la tipica finalità ironica di certo materiale favolistico, che qui assume le caratteristiche di una vera e
propria parodia del mito. Da questo punto di vista, infatti, la favola del cammello
alla corte del leone, messa a confronto con le singole narrazioni precedenti, risulta
essere proprio una parodia del motivo dell’”ospitalità ricompensata”.
Il motivo indiano del dono della propria carne come pasto è stato utilizzato anche da alcuni autori moderni. Gustav Meyrink, nel suo racconto Tshitrakarna, das
vornehme Kamel (Citrakarṇa, il nobile cammello),47 riadatta la favola del cammello alla
corte del leone, con richiami però all’attualità della società a lui contemporanea.
L’elegante cammello Harry S. Tschitrakarna, dopo essere stato accolto alla corte del
leone, insegna agli animali selvaggi l’essenza del Bushido, codice etico giapponese
riservato ai samurai, trasfigurato però nel racconto in una serie di futili e vacue
norme comportamentali tipiche dell’alta società. In un primo momento le belve
feroci sono entusiaste di questa moda sofisticata, al punto che tentano di imitare il
44 In relazione a questa favola si segnalano a mero titolo esemplificativo Pañcākhyānaka I 13 (I cinque
racconti, 1199) del monaco jaina Pūrṇabhadra e Hitopadeśa IV 11 (Il buon insegnamento, XII sec.) di Nārāyaṇa.
45 Somadeva, Kathāsaritsāgara, Nirṇaya Sāgara Press, Bombay, 1889; Norman Mosley Penzer, The Ocean
of Story, Grafton House, London, 1924-1928. Nell’opera è conservata una riduzione del Pañcatantra
derivante da quella inserita nella recensione kaśmīra della Bṛhatkathā (Il grande racconto, I sec. a.C.), da cui
appunto il Kathāsaritsāgara deriva. Cfr. Boccali, “La letteratura classica”, cit., p. 502.
46 L’autore è attivo alla corte del re Ananta del Kaśmīr. Cfr. ivi, p. 500.
47 Gustav Meyrink, Des deutschen Spießers Wunderhorn. Gesammelte Novellen. Albert Langen Verlag,
München, 1913.
172
Alessandro Cimino
comportamento da dandy del nuovo ospite. Quando le stesse sono poi afflitte dalla
fame, il corvo escogita un piano per mangiare Tschitrakarna, contro il quale prova
un profondo rancore a causa dell’arrogante ironia del cammello relativa alla sua
goffaggine in fatto di moda. Anche in questa rivisitazione moderna interviene
l’elemento metateatrale: il corvo inscena con i compagni una falsa gara di generosità per offrirsi come pasto per il leone, finché al turno dell’ospite ingannato il sacrificio volontario è accolto di buon grado. La trama del racconto è fedele a quella
della favola indiana, pur con elementi innovativi legati a una critica sarcastica della
società da parte dell’autore, tra i quali il Bushido e la moda dandy.
Anche Pier Paolo Pasolini, in Appunti per un film sull’India,48 cita una sua versione del motivo indiano: in un ipotetico film ancora da realizzare un mahārāja incontra dei tigrotti affamati e spinto da compassione offre il suo corpo per nutrirli. La
storia raccontata da Pasolini è palesemente un’alterazione del Vyāghrījātaka; la trama è pressoché identica, ma il protagonista, invece di essere un bodhisattva, è un
mahārāja, cioè un re, come in tutte le altre versioni del motivo indiano. La vicenda
offre al regista lo spunto per alcune interviste a influenti personaggi dell’India
contemporanea e a certe riflessioni critiche sulla società e le tradizioni culturali del
luogo. La stessa storia è utilizzata senza sostanziali differenze da Bernardo Bertolucci all’interno di Little Buddha:49 la bambina indiana Gita racconta ai suoi nuovi
compagni di gioco, l’americano Jesse e il nepalese Raju, che suo nonno, un grande
rāja, offrì il suo corpo come pasto a una tigre affamata con i cuccioli. La trama è
appunto la medesima variazione del Vyāghrījātaka utilizzata da Pasolini in Appunti
per un film sull’India; ciò che più colpisce nella versione di Bertolucci è che il piccolo
Raju rimprovera Gita di aver sentito quella storia migliaia di volte, a differenza di
Jesse che è americano: il regista ammette in pochissime battute che si tratta di un
racconto popolare, un prodotto del folklore locale.
Possiamo concludere che il motivo indiano del dono della propria carne come
pasto, riconosciuto in prima istanza nel Lokānanda e nel Nāgānanda, rappresenti un
aspetto tipico della mitologia dell’India, ma si interseca con il variegato e complesso mondo del folklore. La struttura narrativa che ne è alla base si adatta di volta in
volta a contesti formali ed esigenze comunicative assai variegati, risultando perciò
fruibile a più di un genere letterario. Nel reimpiego che ne fa il teatro classico indiano esso risulta centrale all’interno di un plot piuttosto vasto, nel quale confluiscono altri elementi marginali, ma pur sempre essenziali allo sviluppo dei vari
momenti narrativi. La messa in scena teatrale prepara con lo svolgersi degli atti la
drammatizzazione finale di tale motivo, posta sempre all’apice del dramma, nel
momento in cui il protagonista ha la possibilità di beneficiare il mondo con la sua
suprema generosità. In altri contesti letterari indiani il motivo del dono della pro48
49
Pier Paolo Pasolini, Appunti per un film sull’India, Italia, 1968.
Bernardo Bertolucci, Little Buddha, Italia, France, U.K., 1993.
Donare la propria carne come pasto: un motivo letterario indiano tra teatro, mito e folklore
173
pria carne gode di una dinamicità anche maggiore, spaziando tra trame ed esiti
narrativi spesso agli antipodi, pur conservando quei tipici elementi strutturali che
lo caratterizzano in modo imprescindibile. Grazie a tali presupposti, esso riesce ad
essere assimilato anche da autori europei moderni, nei quali però è trasfigurato e
rimodellato in nuove soluzioni rappresentative, così come ci si aspetta da un racconto folklorico, sempre pronto, nella sua flessibilità all’interno di una pur rigida
struttura narrativa, ad interpretare o re-interpretare la quotidianità in cui esso viene ripetuto.
174
Alessandro Cimino
ANTONELLA ZAPPARRATA
IL MITO DE “I SETTE DORMIENTI DI EFESO”
NEL TEATRO DEL DRAMMATURGO EGIZIANO TAWFIQ AL-HAKIM
Fin dalla nascita, l’Islam presenta strette relazioni col Cristianesimo, anche se,
dal punto di vista dogmatico, sussistono profonde e tenaci divergenze tra le due
religioni. Il pensiero musulmano è, infatti, culturalmente lontano dalla cultura
greco-romana, eppure molti aspetti della Rivelazione coranica sono riconducibili
alle religioni ebraica e cristiana, primo fra tutti l’esistenza di un Dio onnisciente,
onnipotente e misericordioso, che ha collocato al centro della creazione un uomo
dotato di anima, il quale, alla fine della sua vita terrena, dovrà rendere conto della
propria condotta, per averne ricompensa – il paradiso – o punizione, l’inferno.
Il mito dei Sette Dormienti di Efeso appartiene ad entrambe le religioni – cristiana e musulmana – ed è noto anche in altre vaste aree, dall’Etiopia all’Asia Centrale. La leggenda è ambientata nell’Impero Romano, durante il regno di Decio
(249-251 d.C.), ossia in un periodo di persecuzione per i cristiani. Sette giovani che
lavoravano a stretto contatto con l’Imperatore, per sfuggire alla persecuzione, furono costretti a nascondersi in una grotta, che venne poi murata. Dopo molti anni, i
sette furono risvegliati da un pastore in cerca di un luogo adatto alla costruzione di
un ovile. Al risveglio, i giovani credettero di aver dormito solo una notte, ma pian
piano compresero di trovarsi invece in un’altra epoca, quella di Teodosio I, durante
la quale il cristianesimo aveva trionfato. L’Imperatore stesso fu chiamato sul luogo
della scoperta per accertare il miracolo della resurrezione, avvenuta proprio nel
momento in cui si stava diffondendo un’eresia che dichiarava impossibile la resurrezione dal mondo dei morti.1 Dopo aver attestato il miracolo, i sette si riaddormentarono, rendendo definitivamente le proprie anime a Dio e, su tale luogo di
sepoltura, per volontà dell’imperatore Teodosio fu eretta una basilica.2
Come molte altre storie di morti apparenti o di risvegli prodigiosi, il mito è stato adottato nelle forme popolari di devozione come prova dell’immortalità
dell’anima e della resurrezione dei corpi. Esso appartiene al genere letterario della
leggenda pura e custodisce un principio fondamentale delle religioni cristiana ed
islamica: la speranza umana della resurrezione finale dei corpi e della sopravvivenza dopo la morte corporea. L’origine del mito sembra risiedere proprio ad Efeso, come attestano alcuni dati: innanzitutto la persecuzione, iniziata nel 249 d.C. a
seguito dell’editto dell’imperatore Decio verso chi non adorava e sacrificava agli
Si trattava della setta dei Sadducei.
Per una versione più dettagliata della leggenda cfr. Gregorio Di Tours, I Sette Dormienti. Una leggenda fra Oriente e Occidente, a cura di G. Avezzù, Medusa, Milano, 2002.
1
2
176
Antonella Zapparrata
dei pagani, e poi la costruzione nel v secolo d. C., ad Efeso, di una basilica dedicata
ai Sette Dormienti sulla grotta dove la leggenda localizza il loro rifugio dalle persecuzioni.3
Efeso era diventata la capitale della provincia romana nell'Asia Minore e sede
del prefetto romano al tempo di Ottaviano Augusto (30-23 a.C.). Città ellenisticoromana, era tenuta in grande considerazione perché possedeva il titolo di Neokoros,
cioè sede del tempio provinciale per il culto dell’imperatore. Era un famoso centro
di pellegrinaggio al tempio della dea Artemide e, anche come metropoli della cristianità, godeva di un forte prestigio tra le comunità cristiane dei primi secoli per la
presenza preso di essa di due degli apostoli di Gesù, Paolo e Giovanni.4
Durante il regno di Decio (249-251), l’impero, assediato dai barbari, attraversava
un periodo di crisi. L’imperatore intese restaurare il culto delle divinità protettrici
di Roma per ripristinare le tradizioni che, un tempo, avevano determinato la grandezza della città. A tal fine, nel 249, emanò un editto in cui ordinava a tutti i cittadini dell’impero di manifestare pubblicamente la devozione a tali divinità tradizionali, offrendo incenso, vino o vittime sacrificali.5
Fu solo con l’imperatore Teodosio II (408-450) che il Cristianesimo divenne religione ufficiale dell’Impero. Nel 431, su disposizione dell'imperatore stesso, proprio
ad Efeso si tenne un concilio che si occupò, principalmente, del nestorianesimo. La
problematica discussa era la natura unica di Gesù Cristo, allo stesso tempo umana
e divina. Più precisamente si trattava di scegliere tra due distinte interpretazioni:
quella ‘unitaria’ di Cirillo di Alessandria6 e quella ‘divisiva’ di Nestorio.7 Secondo
quest’ultimo la Vergine Maria aveva dato vita a Gesù come uomo e non come Dio.
Maria doveva quindi essere chiamata Christotokos, "Madre di Cristo". Il patriarca
alessandrino Cirillo affermava, invece, che Maria aveva dato alla luce Dio come
uomo e che quindi doveva essere chiamata Theotokos “Madre di Dio”. Il Concilio
Maria Verga Bandirali, La leggenda dei sette dormienti, Sergio Trezzi, Crema, 1981, pp. 7-8.
San Paolo, infatti, era stato ad Efeso nel 53 d.C. per diffondere la nuova religione cristiana, e quando i commercianti pagani efesini lo aggredirono, perché contrario al culto della loro Dea Artemide, partì
per i suoi pellegrinaggi che lo portarono a Roma dove, in seguito, fu ucciso. Capo della chiesa di Efeso
diventò, così, San Giovanni a cui, secondo il Vangelo, Gesù aveva affidato la madre. Giovanni prese con
sé Maria e si recò ad Efeso. Nonostante l'età avanzata viaggiò in tutta l'Anatolia per diffondere il cristianesimo, mentre cresceva l'ostilità contro i Cristiani. Tornò poi ad Efeso, dove scrisse il Vangelo, morì e
fu sepolto nel luogo in cui si trova, oggi, la chiesa a lui dedicata (cfr. Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiatica, a cura di F. Migliore, Città Nuova, Roma, 2001, p. 39).
5 Una commissione di magistrati in ogni città convocava i sudditi per costringerli ad effettuare sacrifici ricorrendo, se necessario, anche a svariati mezzi coercitivi (prigionia, tortura, rogo, lapidazione). La
stessa rilasciava, poi, un certificato detto Libello, di attestazione dei sacrifici compiuti. Cfr. Edward
Gibbon , William Smith, Storia delle decadenza e rovina dell’impero romano, G. Barbera, Firenze, 1863, pp.
56-60.
6 Papa della chiesa copta dal 412 al 444.
7 Patriarca di Costantinopoli dal 428 al 431.
3
4
Il mito de “I Sette Dormienti di Efeso” nel teatro del drammaturgo egiziano Tawfiq Al-Hakim
177
condannò l’insegnamento del nestorianesimo, affermando la natura umana e al
contempo divina di Gesù.8
Tale quadro culturale riflette il clima religioso delle prime comunità cristiane,
lacerato dalle tensioni fra varie visioni e varie correnti religiose.
La leggenda dei Sette Dormienti di Efeso sembra aver avuto origine in seguito
alla scoperta, nel 448, dei corpi in buono stato di conservazione di sette giovani in
una caverna del monte Celio, l’antico Monte Pion. È probabile che, ben presto, se
ne diffuse una versione greca, legittimata anche dalla chiesa Efesina. Il mito fu poi
tradotto nelle lingue orientali, con redazioni siriache, armene, copte, arabe, etiopiche9 e, seguendo diversi percorsi d’irradiazione, arrivò infine al Corano, nella sura
(“capitolo”) XVIII. 10
Straordinaria è la traccia storica di questa meditazione, che tenta di scorgere nel
tempo le apparizioni dei Sette Dormienti: nell'anno III del regno del primo abbaside Saffāḥ (750-1258), che aveva dichiarato di voler mantenere il potere legittimo
fino a quando Gesù l’avesse reclamato, si annuncia il ritrovamento di otto personaggi, i Sette Dormienti e il loro Guardiano, in un cimitero di Damasco, come precursori di questa Venuta. I sovrani abbasidi, assai preoccupati di tale scadenza,
tentarono di determinare quanto questa fosse imminente, inviando degli ambasciatori per verificare su quale lato del loro corpo i Sette Dormienti fossero stati girati
da Dio. Il califfo Mu̒tasim mandò così un ambasciatore a Efeso che ritornò con
numerosi manoscritti greci, per i quali creò a Baghdad un ufficio di traduzioni.11 Si
sa anche che Edoardo il Confessore12 ebbe una visione relativa al ‘rivoltamento’ sul
lato sinistro dei Sette Dormienti, dopo 600 anni che avevano trascorso rivolti sul
lato destro, il che annunciava 74 anni di calamità per l'Impero Bizantino, dal 1051
al 1124 della nostra era.13 Questa meditazione collettiva si è dimostrata ancora più
8 Amleto Giovanni Cicognani, “Il concilio ecumenico di Efeso e la divina maternità di Maria”, in Atti del Congresso nazionale mariano, in commemorazione del 15° centenario del concilio di Efeso, Roma,
1931, pp. 193-196.
9 Tra esse ricordiamo quella di Giacomo di Sarugh, vescovo cristiano monofisita, (451-521) e quella
di Fozio, patriarca di Costantinopoli per due volte: dell’ 858 all'867 e dal 877 fino al 886. Egli è venerato
come santo dalla chiesa cristiana ortodossa. Fozio riporta una versione della Leggenda dei Sette Dormienti nella sua Biblioteca, imponente opera che raccoglie recensioni di varia ampiezza di testi teologici
e laici antichi. Il contenuto del suo racconto collima con quello di Gregorio di Tours. Nel suo ruolo di
volgarizzatore, Fozio documenta la circolazione di più versioni della Leggenda stessa. Cfr. Gregorio Di
Tours, I Sette Dormienti, cit.
10 Il Corano, come lo possediamo oggi, è articolato in capitoli (in arabo “sure”), esattamente 114, a
loro volta divisi in versetti. Ogni sura ha un numero variabile di versetti, che vanno dai 276 della 2 ai 3
della 108. Cfr. Massimo Campanini, Il Corano e la sua interpretazione, Laterza, Bari, 2004, p. 20.
11 Secondo una leggenda i libri furono trovati nella caverna dei Tesori di Apollonio di Tiana, ad
Amorium, identificato come un altro sito dei Sette Dormienti.
12 Primo Re d'Inghilterra della dinastia anglosassone. Regnò dal 1042 fino alla morte nel 1066. È santo
della Chiesa cattolica ed è stato canonizzato nel 1161 da Papa Alessandro III nella Cattedrale di Anagni.
13 Giuseppe Simonio Assemani, “De patriarchis”, Bibliotheca Orientalis, 2, 432, pp. 1719-1728.
178
Antonella Zapparrata
copiosa per quanto riguarda la localizzazione geografica della Caverna: nelle fonti
arabo-islamiche si parla, infatti, della città Afsus, in Cappadocia, il cui nome fu
sostituito con quello di Efeso per ragioni di omonimia. Altrove è citata invece una
città giordana, non lontano da Amman.14
La prima testimonianza scritta della leggenda sembra essere un testo greco, fatto compilare nel 449 d. C. da Stefano Vescovo di Efeso e tramandato fedelmente
dall’agiografo bizantino del X sec. Simeone Metafraste nel suo Menologio, una biografia di 140 santi. Dall’originale greco sono derivate sia una versione frammentaria in copto, dialetto parlato nella Palestina e nella Siria ai tempi di Gesù, sia alcune
recensioni siriache, che si differenziano nelle liste dei nomi dei Sette Dormienti.15
Fu poi Gregorio vescovo di Tours16 a tradurre la leggenda dal siriaco in latino
con il titolo Passio septem dormientium apud Ephesum. Quando Gregorio scriveva, la
leggenda era conosciuta già da più di un secolo e diffusa in molte regioni del Medio Oriente, essendo la maggior parte degli antichi manoscritti in greco e in latino,
le due lingue dominanti dell’Impero romano. La versione di Gregorio di Tours fu
poi ripresa e accolta, nel corso del Medioevo, nella Legenda Aurea di Jacopo da Varagine.17 È possibile ritrovare, nuovamente, la leggenda dei Sette Dormienti anche
nella Historia Longobardiorum di Paolo Diacono.18 Tali basilari traduzioni furono poi
riprese nelle letterature nazionali irlandese, tedesca, inglese, francese, italiana, spagnola.19
Dal VII secolo d.C. in poi, molte regioni dell’antico Impero romano cristiano furono conquistate dagli Arabi musulmani e i Sette Dormienti di Efeso divennero
così protagonisti di molti racconti scritti in arabo, tra cui anche una sura del Corano, precisamente la numero XVIII, intitolata in arabo “al Kahf”, “La Caverna”. In
essa si narrano tre storie, legate dal tema comune dell’attesa angosciosa dell’ora del
giudizio: la versione islamica della Leggenda dei Sette Dormienti, il viaggio alla
fonte della vita di Mosè e le gesta di Alessandro Bicorne, Dū al-Qarnayn secondo
gli esegeti musulmani, un profeta senza religione che, attraverso le sue conquiste,
portava in tutto il mondo il messaggio di ordine ed equità voluti da Dio. Le gesta
Verga Bandirali, La leggenda dei sette dormienti, cit., p. 10.
Ignazio Guidi, Testi orientali inediti sopra i sette dormienti di Efeso, Accademia dei Lincei, Roma,
1885, p. 3.
16 Vescovo dell’omonima città dal 573 al 594 d.C., Gregorio di Tours è ricordato per il grande valore
dei suoi contributi nella produzione agiografica latina altomedievale. La sua Passione dei santi martiri.
Sette Dormienti di Efeso è la traduzione in latino dell’omelia sui Sette Dormienti scritta in siriaco da
Giacomo di Sarugh. Cfr. Gregorio Di Tours, I Sette Dormienti, cit., p. 24 ss.
17 Jacopo da Varagine (Iacopo da Varazze), vescovo di Genova dal 1292, è l’autore della famosa Legenda Aurea, una monumentale raccolta di storie di santi come esempi di vita cristiana. L’opera costituì
per molto tempo il repertorio narrativo cui attinsero gli artisti per le raffigurazioni di santi e influenzò la
pittura europea fino al Settecento.
18 Monaco, storico, poeta e scrittore longobardo di lingua latina.
19 Una versione si deve anche a Brunetto Latini (1210-1294).
14
15
Il mito de “I Sette Dormienti di Efeso” nel teatro del drammaturgo egiziano Tawfiq Al-Hakim
179
di quest’ultimo sono identificate con quelle di Alessandro Magno, così come sono
raccontate nel Romanzo di Alessandro dello Pseudo-Callistene20 e nell’omelia in siriaco di Giacomo di Sarug.
Nelle tradizioni ebraiche e cristiane Alessandro Magno è rappresentato, come
Mosè, con due corna sulla fronte, simbolo di ardore e potenza. Egli è il servo fedele
di Dio, volto alla conquista del mondo per diffondere il messaggio divino sulla
Terra. Nel Romanzo di Alessandro si narra anche l’episodio di Mosè, citato nella stessa sura XVIII, riguardante il viaggio alla fonte della giovinezza compiuto da entrambi i personaggi, interpretato come testimonianza delle influenze e commistioni
che le tre religioni, ebraica, cristiana e islamica, ebbero l’una sull’altra.21
Sembra dunque che il Profeta Muḥammad abbia avuto coscienza di un'unità
"finale" di questa sura e abbia, quindi, voluto dare al testo un’impronta escatologica, ordinando i suoi centodieci versetti nell'ordine seguente:
1. Tema della Caverna, dove gli Eletti si rifugiano per proteggersi, abbandonandosi alla volontà divina, come in una barca (v. 78) che trasporta i Testimoni
della Fede rifugiati in Dio e perciò guidati da Esso.22
2. Tema della predestinazione e della sua realizzazione, possibile soltanto grazie al completo abbandono in Dio. Nel Corano, Dio è creatore di ogni cosa ed è lui
a decidere se destinare il cuore di un uomo alla fede o all’empietà, nonostante lasci
spazio anche per il libero arbitrio. La guida o la perdizione volute da Dio provengono, infatti, dalle azioni umane che peseranno sul Giudizio nel Giorno dei Conti.23
3. Tema del “Muro di Gog e Magog”, barriera protettrice dell'ortodossia e della
Comunità islamica, innalzata da Alessandro Magno con blocchi di ferro e bronzo
fuso. Nella Bibbia, Gog e Magog sono popoli del nord che aggrediranno Israele.
Nel Corano sono popoli anomali e crudeli che Alessandro Magno isolerà nella
propria terra, grazie alla costruzione del muro.24
Analizzando la leggenda dei Sette Dormienti si notano alcuni elementi che differiscono nettamente dalle versioni cristiane. Essi sono: la permanenza dei giovani
nella grotta, prima di essere resuscitati, per 309 anni (lunari e cioè 300 solari, come
attestato nella tradizione cristiana); la morte dei giovanetti, assente nella versione
20 Il Romanzo di Alessandro è una raccolta di racconti leggendari sulla vita di Alessandro Magno. Il
testo è un apocrifo falsamente attribuito a Callistene, citato spesso come "Pseudo Callistene", ed ebbe
grande diffusione nel Medioevo, con numerose versioni e revisioni. In epoca tardo-antica venne tradotto in latino, in siriaco, in arabo e in persiano. Costituisce forse la fonte della citazione di Alessandro
nel Corano, identificato in Dhū l-Qarnayn , “Quello delle due corna”. Cfr. Ernest Alfred Wallis Budge,
The History of Alexander the Great, being the Syriac Version of the Pseudo Callisthenes, Cambridge University
Press, Cambridge, 1889, pp. 1 e ss.
21 Ivi, p. 239.
22 Louis Massignon, “Les “sept dormants” apocalypse de l’Islam”, in Massimo Campanini (a cura
di), La Sura della caverna, La Nuova Italia, Firenze, 1986, p. 41.
23 Ibid.
24 Ibid.
180
Antonella Zapparrata
coranica e puntualmente riferita, invece, nel racconto cristiano;25 la presenza di un
cane posto a guardia della grotta che non è chiusa da pietre, come invece raccontano le traduzioni cristiane in cui è l’imperatore stesso ad ordinare che venga murata. Nel Corano essa è invece protetta solo dall’intervento divino attraverso il sole
(v. 17) e il cane (v. 18) che, secondo alcuni commentatori, è un portavoce di Dio
stesso.26
Simbolicamente, nel Corano, il sole è la luce o lo splendore che manca nel Paradiso, dove gli eletti non vedranno né sole né gelo. Per i credenti il sorgere e il tramontare del sole servono da riferimento per le preghiere quotidiane, dovendo essi
rivolgersi al Signore prima dell’alba e del tramonto. Anche il corso del Sole è uno
dei segni dell’onnipotenza divina: infatti nella storia della gente della caverna, esso
non illumina mai il luogo di riposo dei Sette.27 Si potrebbe interpretare questo atto
come un gesto protettivo che Dio compie nei loro confronti per nasconderli, al fine
di non farli giustiziare.
Altro simbolo presente nella sura è il cane che, per l’Islam, è sinonimo di impurità e di sporcizia, fatta eccezione per il cane da caccia, compagno fidato, cantato
anche nella poesia antica. Un ḥadīṯ, aneddoto sulla vita del Profeta Muhammad,
afferma che i latrati di questo animale allontanano per sempre gli angeli dalle case,
alludendo al fatto che la casa è il cuore degli uomini che deve mantenersi immune
dai cattivi propositi, simbolizzati per l’appunto dal cane. Ancora, nella tradizione
araba spesso i Ginn (“demoni”) si nascondono proprio nel cane nero. Solo nella
Leggenda dei Sette Dormienti questo animale è stato considerato in maniera benigna, rappresentando, da buon cacciatore, il guardiano della grotta.28 Secondo la
maggior parte dei commentatori coranici, il cane è il guardiano assimilato al Ḫaḍir,
depositario della scienza divina, che parla ai Sette Dormienti promettendo loro la
resurrezione. È possibile poi, in base alla sua posizione al suolo con le zampe anteriori distese, accostare il cane ad Anubi, guardiano delle tombe, che preserva i corpi per garantire poi la loro resurrezione.29
I versetti coranici sono fortemente allegorici e contengono degli archetipi che
potenziano il significato dei particolari della storia. Il tema della ‘caverna’ è meta-
25 Secondo i musulmani, essi giacciono ancora addormentati nella caverna in attesa che venga l’Ora
e si realizzi la promessa. Questo ‘sonno’ misterioso li pone nello stato mentale del perfetto abbandono a
Dio, condizione che renderà possibile la resurrezione (Cfr. Paolo Dall’Oglio, Speranze nell’Islam, Biblioteca Arabo-islamica, Genova, 1991, p. 59).
26 Massignon ipotizza un legame simbolico oltre che storico tra questo cane e il ruolo della Maddalena, la quale fu testimone della resurrezione di Gesù dopo aver vegliato il suo sepolcro. Anch’ella fu
sepolta ad Efeso. Cfr. Dall’Oglio, Speranze nell’Islam, cit., p.185. La figura del ‘cane vigilante’ è presente
anche in numerose opere letterarie islamiche, essendo uno degli animali paradisiaci dell’Islam. Cfr.
Gregorio Di Tours, I Sette Dormienti, cit., pp. 48 e 59.
27 Amir- Moezzi (a cura di), Dizionario del Corano, Mondadori, Milano, 2007, pp. 824-825.
28 Malik Chebel, Dizionario dei simboli islamici, Arkeios, Roma, 1997, p. 77.
29 Amir- Moezzi, Dizionario del Corano, cit., p. 36.
Il mito de “I Sette Dormienti di Efeso” nel teatro del drammaturgo egiziano Tawfiq Al-Hakim
181
fora della protezione che Dio garantisce a coloro che si allontanano dall’idolatria
per abbracciare la vera fede;30 i compagni della caverna diventano simbolo della
Resurrezione che suscita meraviglia in quegli uomini che ancora non percepiscono
pienamente l’universo come scena mossa dall’azione divina.31
Emerge, inoltre, una sorta di disputa insoluta sul numero dei dormienti, cui
corrisponde, simmetricamente, la rivelazione del numero di anni di permanenza
nella grotta. Sulla questione del numero di anni è interessante confrontare i vari
testi, per rilevare le oscillazioni tra le versioni orientali e quelle greco-latine: Gregorio di Tours scrive “Dopo questi fatti, morto Decio, nel prosieguo del tempo...” e in
seguito parla di “...molti anni”;32 Jacopo Da Varazze conclude, invece, così la sua
trascrizione: “Quando è stato detto che dormirono in pace per trecentosettantasette
anni, si potrebbero avere dubbi sul fatto che risorsero proprio nel 448. Decio infatti
resse l’impero soltanto un anno e tre mesi e perciò essi non dormirono se non centonovantasei anni”.33
In realtà i fatti descritti avvennero tra il regno dell’imperatore Decio (249-251) e
quello di Teodosio II (401-450): ciò significa che tra la reclusione dei giovani e il
loro miracoloso risveglio intercorsero tra i centocinquanta e i duecento anni. Eppure la sura XVIII parla di trecentonove anni: a questo proposito la numerologia è
venuta in soccorso degli studiosi che se ne sono occupati, per interpretarne i molteplici significati simbolici e mistici. La cifra ‘309’ è l’anagramma numerico del
totale delle lettere iniziali isolate del Corano (cioè 903). Quindi, in
un’interpretazione allegorica, il sonno miracoloso è collegato all’essenza della Rivelazione: non si può conoscere il numero esatto di anni, così come non è dato
comprendere la natura di Dio.34 Da non trascurare è la simbologia del numero ‘sette’ (comunemente accettato per i Dormienti), che è uno dei più importanti tra i
numeri sacri nella tradizione delle antiche culture orientali. Nel macrocosmo, esso,
infatti, rappresenta l’Universo, i sette pianeti visibili e i sette giorni della settimana;
in matematica è il primo numero perfetto: contiene infatti sia il primo dispari che il
secondo pari (3+4), sia il primo pari che il secondo dispari (2+5). Nel Corano il ‘sette’ è citato ventiquattro volte: sette sono i cieli creati da Dio, sette le terre, i mari, gli
abissi dell’inferno e sette le sue porte, sette sono le stelle dell’Orsa Maggiore e
30 La caverna è presente anche nell’iconografia cristiana, dove sia la stalla di Betlemme che la tomba
di Gesù sono rappresentate sotto forma di grotte rupestri. La caverna diventa quindi il luogo di accoglienza di forme rituali, quali l’iniziazione e la rinascita a un livello superiore di esistenza, forme che in
contesti diversi si ritrovano in molti ambiti culturali. Cfr. Hans Biedermann, Simboli, Garzanti, Milano,
2005, p. 104.
31 Ibid.
32 Gregorio Di Tours, I Sette Dormienti, cit., p. 24 e ss.
33 Iacopo Da Varazze, Legenda Aurea, a cura di A. e L. Vitale Brovarone, Torino, Einaudi, 1995, p.
553.
34 Il Corano, sura XVIII, 29: “La verità viene dal vostro Signore. Creda chi vuole, non creda chi non
vuole”.
182
Antonella Zapparrata
dell’Orsa Minore, grazie alle quali conosciamo il nord;35 sette sono anche le pratiche obbligatorie durante il pellegrinaggio alla Mecca. Sette sono i versetti della
prima sura, la più recitata dai fedeli, così come sette sono le parole della testimonianza di fede, pronunciando la quale si diventa musulmani. Analoga importanza
assume questo numero nell’Apocalisse di Giovanni, dove sette sono le chiese, le
corna del drago mostruoso e le coppe dell’ira nel Libro dei Sette Sigilli.36
Si può osservare, quindi, nella leggenda dei Sette Dormienti, la presenza di topoi, simboli e numeri che si rivelano funzionali sia al carattere della versione islamica che agli scopi di quella cristiana. Il portato più significativo, per entrambe, è
legato all’escatologia, la dottrina del premio o del castigo finale.37 La fede nella
resurrezione della carne alla fine dei tempi è comune a tutte e tre le religioni abramitiche e la storia dei Sette Dormienti ne è prova e profezia. Tuttavia, per il Cristianesimo solo la resurrezione di Cristo è fondante la fede nella resurrezione generale, mentre le resurrezioni miracolose (come quella dei dormienti, quelle descritte
nell’Antico Testamento o la stessa Assunzione di Maria) ne sono solo profezia,
illustrazione e dimostrazione, e di conseguenza questo mito ha carattere apologetico; per l’Islam il primato sta invece nella Parola, nella rivelazione coranica: la resurrezione è credibile perché Dio l’ha promessa nel Corano e il musulmano ci crede non per il ritorno in vita dei ‘Compagni della Grotta’, ma perché la legge nel
testo sacro. Questo testo è allora la forma linguistica di tale promessa ed ha carattere etico e teologico.38
Il mito dei Sette Dormienti, essendo parte delle tradizioni popolari musulmane,
è stato trasposto anche nel teatro egiziano dal drammaturgo Tawfīq al-Ḥakīm
(1898-1987), figura eminente della cultura egiziana del ‘900. Tra i suoi meriti ricordiamo, soprattutto, quello di aver creato un teatro in prosa realmente originale.
Per molti anni scrisse la maggior parte delle sue opere, soprattutto quelle di tendenza simbolista, psicologica e intellettuale, in arabo classico, con uno stile elegante e lineare. Tuttavia, a causa sia del carattere che della lingua, le sue opere ebbero
difficoltà ad essere rappresentate, in quanto prive di movimento o di azione scenica e difficilmente comprensibili da parte del pubblico. A tali critiche, al-Ḥakīm
rispose che il racconto scenico era un genere dotato di esistenza indipendente e
ordinata come quella di un quadro, mentre la rappresentazione scenica non era
altro che un’interpretazione non indispensabile all’opera stessa.39 Tra il 1928 e il
1949, Tawfīq al-Ḥakīm compose un insieme di opere che vanno ricordate con il
35 Riconoscere i punti cardinali è fondamentale per un musulmano, dal momento che la preghiera
deve essere sempre rivolta in direzione della città di La Mecca.
36 Bedermann, Simboli, cit., p. 489.
37 Ugo Bonanate, Bibbia e Corano, i testi sacri confrontati, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, pp. 236; 252.
38 Dall’Oglio, Speranze nell’Islam, cit., pp.189; 203.
39 William M. Hutchins, Tawfiq al Hakim: a Reader’s Guide, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2003,
p. 108.
Il mito de “I Sette Dormienti di Efeso” nel teatro del drammaturgo egiziano Tawfiq Al-Hakim
183
nome di “Teatro dello Spirito”. Esso fu il frutto della reazione dell’autore alla pratica drammaturgica araba dell’epoca, giudicata troppo lontana dalle esigenze
dell’arte e della letteratura, come spiegato nella sua prefazione all’Edipo Re, scritta
nel 1949, dove affermò che il teatro arabo, fino a quel momento, si era basato sui
canoni occidentali a cui aveva aggiunto siparietti musicali o comici, per venire
incontro al gusto orientale, dando all’opera le sembianze di un cabaret più che di
un dramma. A differenza del teatro egiziano dell’epoca che si preoccupava solo di
emozionare il pubblico, al-Ḥakīm intese, invece, raggiungere un altro obiettivo:
quello di istruire.
Inizialmente il teatro egiziano fu influenzato da quello italiano e spesso la rappresentazione di alcune opere fu vietata, in quanto i governanti temevano fossero
celate allusioni al proprio operato. Alla riapertura dei teatri nel 1882,40 cominciarono ad essere introdotte le prime novità, come i ruoli femminili interpretati da donne, fino a quel momento escluse dalla scena. Furono rappresentati anche lavori
patriottici, che tentavano di suscitare nei giovani il sentimento nazionalistico.41
Nonostante i tentativi di ammodernamento, il teatro egiziano era però ancora a un
livello modesto, privo di caratteristiche proprie e di autori valenti.42 Nel periodo
postbellico si tentarono, poi, i vari generi: dalle commedie, ai drammi psicologici,
storici o politici. Non mancarono lavori basati sulla quotidianità, espressi in dialetto egiziano, ai quali furono affiancate opere di maggiore spessore, scritte in lingua
letteraria.
Tawfīq al-Ḥakīm criticò la mancanza, in Egitto, di una forte tradizione drammatica, presente invece nella cultura europea grazie alla tradizione teatrale greca. Egli
consigliò ai letterati della sua epoca di rifarsi alla millenaria tradizione faraonica in
cui la civiltà egiziana affondava le proprie radici.43 Diventò, così, l’esponente principale del “Faraonismo”, sviluppatosi proprio in Egitto in quegli anni. Tale movimento identificava l’Egitto come un’entità territoriale distinta, con una propria
storia e caratteristiche diverse dal resto del mondo arabo-islamico. L’Egitto era
considerato come una nazione mediterranea, collegata storicamente e culturalmente all’Europa.44 La corrente accolse sia coloro che avrebbero voluto basare la cultura
egiziana sulla riesumazione di quella faraonica, sia quelli che proponevano di non
trascurare anche ulteriori apporti provenienti da culture diverse, come quella occidentale, tra i quali spiccava appunto al-Ḥakīm. La nuova generazione postbellica
40 I teatri erano stati chiusi nel 1878 per volere del Khedive Isma’il, che non approvò un lavoro di
Yusuf al-khayyat.
41 Tra essi ricordiamo: al Watan (La Patria) e al-Arab (Gli Arabi) di Muslim Abdallah Nadim.
42 Cfr. Umberto Rizzitano, “Il teatro arabo in Egitto, opere teatrali di Tawfiq al-Hakim”, Oriente Moderno, 23.6, 1943, pp. 243 e ss.
43 Ibid.
44 Cfr. Michael Wood, “The use of the Pharaonic Past in Modern Egyptian Nationalism”, Journal of
the American Research Center in Egypt, 35, 1998, pp. 179-196.
184
Antonella Zapparrata
assisté ad uno scontro, culturale e politico, tra la civiltà occidentale e quella islamica. Rinnegando una mera occidentalizzazione del paese, gli esponenti di questa
rinascita rifiutarono sia l’imitazione delle proprie tradizioni ormai fossilizzate, sia
la ripetizione dei costumi occidentali. Auspicarono invece, per la creazione di
un’identità moderna, l’apertura agli apporti esterni e l’approfondimento dei propri
valori tradizionali, soprattutto di matrice faraonica piuttosto che islamica.45 La
prima civiltà era riuscita, infatti, a dar vita ad un’arte di carattere meditativo e mitologico, grazie all’abbondanza di risorse materiali concessale dalla natura, condizione che rendeva possibile dedicarsi all’accrescimento dello spirito. La civiltà
islamica si era, invece, sempre dedicata alla conquista e aveva perciò dato origine
ad una arte basata sull’opulenza materiale e sul godimento veloce.
Antichi Egizi e Arabi erano ritenuti, così, agli antipodi: gli uni simboli di spirito
e stabilità, gli altri di materia, movimento e ornamento.
Secondo al-Ḥakīm, lo spirito del pensiero egiziano era rimasto immutato come
l’ambiente in cui si era sviluppato e, in base a questo, l’autore si propose di affermare il trionfo dell’Egitto sul tempo: come il Nilo moriva e risorgeva una volta
l’anno, così l’Egitto sarebbe risorto, attraverso la continua evoluzione ed innovazione sociale e culturale.46
Il primo grande lavoro teatrale di al-Ḥakīm fu proprio Ahl al-kahf, Quei della caverna, scritto ad Alessandria d’Egitto nel 1933 e rappresentato per la prima volta al
Cairo nel 1935: l’autore aveva, in realtà, destinato inizialmente l’opera alla sola
lettura, poiché si basava prevalentemente su dialoghi piuttosto che sul movimento
scenico, e poiché i personaggi in forma dialogata aderivano al movimento
d’insieme e si amalgamavano tra loro, a differenza di quando erano introdotti da
un’analisi psicologica interiore.47
La storia era ben impressa nell’animo dell’autore fin dalla giovane età, quando
l’ascoltava il venerdì alla Moschea.48 Il dramma sulla scena si presentava in quattro
atti ed era costruito sul tema della leggenda dei Sette Dormienti. La storia era solo
un punto di partenza, rielaborato da al-Ḥakīm secondo una propria concezione
filosofica che voleva rivalutare in senso nazionalistico l’antico Egitto. I due personaggi femminili di Prisca (l’antenata e la principessa) erano, infatti, associati ai due
volti dell’Egitto, quello antico e quello moderno degli anni Trenta, che
45 Anne Laure Dupont et Richard Jacquemond, “Les trasformations du monde arabe dans la premiere moitie du XX siècle”, in Boutros Hallaq, Heidi Toelle (a cura di), Histoire de la lettérature arabe
moderne, Sindbad Actes Sud, Arles, 2007, pp. 333-375.
46 Umberto Rizzitano, “Spirito faraonico e spirito arabo nel pensiero dello scrittore egiziano Tawfiq
al-Hakim”, AION, 3, 1949, pp. 487-497.
47 Rizzitano, Il teatro arabo, cit., p. 247.
48 Ancora oggi la preghiera musulmana del Venerdì prevede la lettura della sura XVIII.
Il mito de “I Sette Dormienti di Efeso” nel teatro del drammaturgo egiziano Tawfiq Al-Hakim
185
s’interrogava sulla propria identità e ricerca una forma d’indipendenza, ricordando il lontano passato faraonico dal quale era separato solo dal tempo.49
È facile da qui capire a cosa era dovuto l’interessamento di al-Ḥakīm per la leggenda de I sette Dormienti, risorti a nuova vita e simbolo quindi di eternità. Il suo
intento fu creare un dramma egiziano su basi egiziane: come il fondamento della
tragedia greca era il conflitto tra l’uomo e il destino, così il fondamento della tragedia egiziana sarebbe stato il conflitto tra l’uomo e il tempo, di cui Ahl al-kahf diventa piccola immagine;50 allo stesso modo in cui la pratica dell’imbalsamazione o la
costruzione delle Piramidi sono immagine della conservazione nel tempo e del
mantenimento in vita di una grandezza passata. Il trionfo dell’Egitto fu qui rappresentato dalla Resurrezione, di cui i dormienti erano testimoni.51 La Resurrezione,
nella concezione hakimiana, raccoglieva in sé quattro elementi: la morte, il tempo,
il cuore e l’eternità. Risorgere significava non soccombere nella lotta contro il tempo, ma rinnovarsi per raggiungere l’eternità dello spirito, attraverso il trionfo del
cuore.52
Seguendo la trama del mito storico, al-Ḥakīm lasciò intatta l’ambientazione
temporale all’epoca di Decio, ma trasferì gran parte dell’azione all’interno del palazzo imperiale, dove avvenne l’incontro fra i dormienti, risvegliatisi dopo trecento
anni, e la gente di Efeso. I protagonisti erano tre: i due Ministri di corte, Mashilinia
e Marnush, accompagnati dal pastore Yamlika con il suo cane Qitmìr. Rifugiatisi in
una caverna per sfuggire alle persecuzioni dell’Imperatore Decio pagano, essi si
addormentarono per poi risvegliarsi, miracolosamente, trecentotrenta anni dopo.
Mandato in paese a comprare viveri, il pastore Yamlika scoprì ben presto di essere
in un’epoca del tutto nuova e sconosciuta. Scoperto il miracolo, i tre furono condotti dal Re e trattati con riguardo, dal momento che il precettore della Principessa
Prisca riconobbe in loro i Santi preannunciati nell’antichità. In questa nuova vita le
loro passioni non erano mutate e quindi il pastore andò in cerca del proprio gregge, Marnush della moglie e del figlio, mentre Mashilinia diede inizio al corteggiamento della Principessa, rivedendo in lei la sua amata nella vita precedente.
I primi due furono delusi già durante il primo giorno, quando capirono che ciò
che cercavano non esisteva più e ritornarono quindi nella caverna, disperati. Solo
Mashilinia continuò nel suo intento, provando anche ad adeguarsi ai nuovi modi e
alle nuove abitudini dell’epoca, ma ben presto comprese che Prisca non poteva
accettare il suo amore non essendo la Prisca del suo tempo. Disilluso, fece ritorno
alla caverna dove si addormentò con gli altri due per altri due mesi. Al risveglio i
49 Umberto Rizzitano, “Introduzione”, in Tawfiq al-Hakim, Quei della caverna, a cura di U. Rizzitano,
Centro per le relazioni italo-arabe, Roma, 1960, p. 1 e ss.
50 Hutchins, Tawfiq al Hakim: a Reader’s Guide, cit., p. 110.
51 Umberto Rizzitano, “Introduzione”, in Tawfiq al-Hakim, Quei della caverna, cit., p. 1 e ss.
52 Tawfiq al-Hakim, Zahrat al-‘umr, in Umberto Rizzitano, “Il simbolismo nelle opere di Tawfiq alHakim”, Oriente moderno, 26, 7.12, pp. 116-123.
186
Antonella Zapparrata
dormienti credettero di aver sognato, ma quando Marnush spirò e i compagni tentarono di coprirlo con i propri abiti, capirono, dalla foggia di questi ultimi, di essere stati davvero testimoni di un salto temporale. Alla morte degli altri due, il Re
farà poi costruire una basilica sul luogo di sepoltura e Prisca, all’insaputa del padre, si farà murare viva all’interno, avendo sentito affinità con il suo amante spirituale.
L’opera apre una discussione sull’identità individuale e sul rapporto tra
l’individuo e la società. La tragedia è divisa in quattro atti che seguono i movimenti dei dormienti: dalla caverna al palazzo (atto I - II), dal palazzo alla caverna (atto
III – IV), indicando così l’uscita dei dormienti verso il mondo, il contatto tra questi
e la società del tempo, l’impossibile comprensione, il fallimento e il ritorno alla
caverna. Sono quindi messi a confronto due poli: la gente della caverna, individui
semplici con convinzioni precise sulla propria identità e sul tempo trascorso
all’interno della grotta, e la gente del palazzo, immagine della società con la sua
piramide gerarchica, basata non tanto sul potere (Il Re infatti è incerto sul da farsi)
quanto sul sapere, rappresentato da Galyas, precettore della principessa e garante
di ciò che la collettività considera come verità ufficiale: i dormienti della caverna
hanno dormito trecento anni e sono dei santi.
Nel dramma la verità è conosciuta soltanto dal lettore, il quale si rende conto
che l’identità che la società vuole imporre agli individui non è fondata: essi non
sono infatti santi, ma non è valida neanche la verità creduta dai dormienti, dal
momento che essi si ingannano sul vero tempo trascorso nella grotta.
Gli abitanti della caverna diventano, così, simboli di quattro livelli. Il cane Qitmìr, essendo un animale privo di ragione, è il primo a soccombere perché obbedisce solo ai suoi istinti; Yamlika il pastore, vicino al mondo animale, lo segue dopo
poco; Marnush, guidato solo dalla ragione, per la quale risulta impossibile accettare la verità, fallisce la sua ricerca. Solo Mashilinia riesce a stabilire un contatto con
Prisca; è il contatto del cuore, che trionfa perché coglie l’essenza della vita nel puro
amore.
Il significato simbolico del dramma è chiaro: ‘quei della caverna’ si risvegliano e
tentano di reinserirsi nella vita del tempo, ma lo sfasamento temporale li ricaccia
all’interno della grotta. Tra i protagonisti, solo i due amanti trovano il modo di non
perire, rivivendo il proprio amore in un’altra dimensione. In realtà, Mashilinia è
innamorato della Prisca del suo tempo, figlia dell’Imperatore Decio. Al momento
del risveglio, egli riconosce nella nuova Prisca ‒ discendente della stirpe di Decio,
ma figlia del nuovo re e cristiana come il padre ‒ la sua amata, non rendendosi
conto del salto temporale di cui è stato testimone. Quando non è riconosciuto dalla
giovane principessa, comincia a capire, ma ravvede nella ragazza una maggiore
cultura ed emancipazione, che lo rendono ancora più innamorato.
Prisca diventa così simbolo della continuità tra antico e nuovo Egitto: come
l’antica principessa del tempo di Decio, clandestinamente cristiana e poco colta, è
Il mito de “I Sette Dormienti di Efeso” nel teatro del drammaturgo egiziano Tawfiq Al-Hakim
187
sostituita dalla nuova principessa, maggiormente istruita e più consapevole delle
sue scelte, così l’antico Egitto risorge a nuova vita grazie all’apertura verso apporti
esterni.
Essendo consapevole che solo la forza dell’amore consente di vincere il tragico
destino di cui tutta l’umanità è partecipe – la morte – permettendo la resurrezione
in un altro tempo, la principessa Prisca decide di essere murata viva nella grotta
accanto a Mashilinia, perché a conoscenza della storia della propria antenata e
quindi conscia del suo legame spirituale con lui.
Nell’opera, anima e ragione, le due maggiori facoltà umane, lottano contro la
labilità del tempo e la prima, ferma ed immutabile, prevale, mentre invece la ragione, costretta a scandagliare tutti gli impulsi, le passioni e i tormenti senza trovare spiegazioni e certezze, cade sconfitta.
Dietro ad ogni simbolo che al-Ḥakīm pone sulla scena, c’è l’eterno contrasto tra
fede e dubbio, cuore e ragione. L’uomo, di cui parla l’autore, si affanna tra pessimismi mai disperati e ottimismi disincantati, per poi approdare al trionfo della fede e
del cuore, ma intanto rimane lì, sulla scena, come una figura di secondo piano, i cui
gesti e le cui azioni sono velate e offuscate dai dubbi e dalle incertezze che recitano,
invece, la parte principale. Ecco raggiunto lo scopo dell’autore: farci sentire
l’immensità delle sensazioni umane, senza per questo essere distratti
dall’accidente, rappresentato dalla creatura stessa che ha solo il compito di incarnare l’idea sul palcoscenico.
188
Antonella Zapparrata
IRENE STARACE
LA FIABA DELLA MOGLIE GRU E LA SUA
TRASPOSIZIONE TEATRALE IN YŪZURU DI KINOSHITA JUNJI
La fiaba
La fiaba della moglie gru è considerata una delle più rappresentative fiabe
giapponesi. Ne esistono, naturalmente, varie versioni, ma tutte hanno in comune la
seguente trama: un giovane povero salva una gru ferita; poco dopo, una bellissima
donna si presenta a casa sua e gli propone di sposarla. La donna è capace di tessere
una stoffa di grande valore, grazie alla quale il giovane diventa ricco, ma per tessere si chiude in una stanza e chiede al marito di non guardarla mai mentre si trova
lì. L'uomo, tuttavia, non riesce a reggere alla curiosità, spia nella stanza e vede che
sua moglie è in realtà una gru, che, una volta scoperta, è costretta a tornare al suo
mondo.1
La caratteristica universale di questa fiaba è il tema del divieto e della sua infrazione. Le sue caratteristiche tipicamente giapponesi sono l'eterogamia tra un uomo
ed una donna appartenente ad un altro mondo, il ruolo attivo della figura femminile e il finale triste.2
Le varianti di questa storia hanno in comune anche le caratteristiche stilistiche
proprie della fiaba: descrizioni essenziali, pochi personaggi, diegesi lineare. A volte
il protagonista ha un nome, a volte questo è taciuto. Sul piano del contenuto, anche
la morale è quella tipica delle fiabe: la buona azione è ricompensata, la trasgressione punita.
Contesto storico e culturale: la guerra, il mito, il folklore
La messa in scena di un’opera teatrale basata su una fiaba popolare, avvenuta
nel 1949 ad opera del drammaturgo Kinoshita Junji (1914-2006), uno dei migliori
autori teatrali giapponesi del Novecento, fu una novità assoluta nella storia del
teatro moderno giapponese. Per la prima volta dal periodo Meiji (1868-1912) il
teatro non si rifaceva a modelli occidentali o alla tradizione colta, ma alla cultura
popolare. Questo rispondeva ad una precisa intenzione dell'autore: portare il popolo giapponese a riappropriarsi del suo folklore, la cui importanza “è paragonata
Adele Fulciniti, "Yūzuru ("La gru della sera") di Kinoshita Junji", Il Giappone, 19, 1979, pp. 111-136.
Kayoko Takagi, Introducción a El espíritu del agua. Cuentos tradicionales japoneses, Alianza Editorial,
Madrid, 2009, pp. 13-17. Da questa raccolta (pp. 143-148) ho tratto anche il testo di riferimento della
fiaba, reperibile in traduzione italiana in Maria Teresa Orsi (a cura di), Fiabe giapponesi, Einaudi, Torino,
1998, pp. 281-283.
1
2
190
Irene Starace
a quella del mito nel teatro occidentale".3 Tuttavia è curioso che la scelta di queste
tematiche sia nata non da una libera volontà di conferire dignità teatrale ad
un’opera folklorica, ma probabilmente dalla necessità di sfuggire alla censura negli
anni della seconda guerra mondiale.4
Il materiale di cui si servì Kinoshita gli venne fornito dagli studi di folklore
giapponese inaugurati da Yanagita Kunio (1875-1962) e proseguiti, con un'attenzione particolare al rapporto tra i dati etnografici e la letteratura classica,5 da Origuchi Shinobu (1887-1953). Pertanto, la sua opera finì per inserirsi nel discorso di
rivalutazione della cultura popolare giapponese, particolarmente intensa in clima
di rivendicazione nazionalistica del Novecento. La tendenza a guardare con nostalgia all’antico folklore, che testimonia un mondo ormai scomparso, spazzato via
dalla modernità giapponese e dall’occidentalizzazione, si inserisce come contrappunto nostalgico alle spinte di radicale conservazione della propria cultura che,
proprio negli stessi anni, avveniva per il teatro occidentale, e in particolare in quello francese.
In Europa, infatti, ricorrevano con frequenza alcuni dei temi chiave rappresentati nel mito greco. È il caso, ad esempio, dell'Edipo (1930) di André Gide (18691951), di La macchina infernale (1934) di Jean Cocteau (1889-1963), e di Euridice
(1941), Antigone (1942) e Medea (1946) di Jean Anouilh (1910-1987). Almeno nel caso
dell'Antigone, definita “un drama político de oportunidad”,6 questa scelta è giustificata dalla necessità di eludere la censura, come nel caso di Kinoshita: nelle vesti
del mito e del racconto folklorico le parole di denuncia e di sensibilizzazione storico-politica potevano viaggiare in modo più sicuro, ma non per questo meno esplicite allo spettatore accorto. Tuttavia, al di là delle questioni politiche, è innegabile
che le ragioni principali di questa coincidenza sono ben più profonde: sia il mito
che il folklore offrono temi capaci di aiutare chi cerca un destino migliore e rappresentano tematiche e aspetti universali della condizione umana, che esulano le contingenze di un determinato periodo storico.7
Il Giappone di Kinoshita, infatti, era un Paese sconfitto, occupato dagli americani, impoverito, in cui i miti della propaganda militarista del decennio precedente
Fulciniti, "Yūzuru", cit., p. 112.
Cfr. <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/318835/Kinoshita-Junji>. Kinoshita aveva esordito
con drammi di taglio storico e sociale e nel dopoguerra continuò in questa vena, parallelamente alla
produzione di drammi basati sul folklore.
5 Takanori Shimamura, "Cultural Diversity and Folklore Studies in Japan: A Multiculturalist Approach", Asian Folklore Studies, 62.2, 2003, pp. 195-224.
6 José S. Lasso de la Vega, Los temas griegos en el teatro francés contemporáneo (Cocteau, Gide, Anouilh),
Departamentos de Latín y Griego, Universidad de Murcia, Murcia, 1981, p. 138.
7 Ibid., pp. 18-19 e p. 24. Secondo Keene, l'enorme successo di Yūzuru si dovette proprio al suo essere
insieme moderna e tradizionale, giapponese e universale. Cfr. Donald Keene, So Lovely a Country will
Never Perish. Wartime Diaries of Japanese Writers, Columbia University Press, New York, 2010, pp. 159160.
3
4
La fiaba della moglie gru e la sua trasposizione teatrale in Yūzuru di Kinoshita Junji
191
erano stati smentiti e distrutti dalla realtà. È comprensibile, quindi, che si cercasse
di rendere universali ed educative quelle tematiche morali che affondano le radici
nella cultura popolare, in un estremo tentativo di restaurazione morale prima che
sociale.
Kinoshita Junji e Yūzuru: caratteristiche e obiettivi della trasposizione teatrale
Nell'adattare la fiaba alla scena, Kinoshita apporta varie modifiche. La trama
rimane la stessa, ma il finale triste non è determinato solo dalla curiosità del protagonista: altri due personaggi, stimolati nella loro avidità dalla bellezza delle tele,
inducono il marito a richiedere alla moglie stoffe in quantità sempre maggiore,
esponendola al rischio della morte, visto che l’azione stessa della tessitura la costringe a strappare piume dal suo corpo. Quando la curiosità spinge gli uomini a
spiarla, causando l’abbandono definitivo della donna, solo allora il protagonista
maschile si rende conto delle conseguenze del suo comportamento e rimane tramortito dal dolore. L’avidità, dunque, accentua la tristezza del finale fino a farlo
diventare quasi affine ad una tragedia.
Kinoshita, inoltre, fornisce alla messa in scena un’originale ambientazione. Secondo alcune varianti della fiaba, la moglie gru comincia a tessere solo quando
nevica: il drammaturgo utilizza questo elemento e ripropone un paesaggio innevato, su cui si apre il sipario, che fa da cornice ad una casa modesta. Nella scenografia
viene poi aggiunto il particolare del cielo illuminato dal rosso del tramonto, che ‒
secondo le note di regia dell'autore ‒ ha la funzione di contenere e far presagire gli
sviluppi drammatici della storia.8
Su questo sfondo si assiste in primo luogo allo scorrere quotidiano della vita dei
due protagonisti, che fa da presupposto all’intera narrazione. Entra in scena un
gruppo di bambini, assenti nelle varie versioni della fiaba, che giocano e cantano, e
la coppia si unisce di buon grado ai loro giochi. Kinoshita mette in scena una vita sì
modesta, ma piena d’amore e di innocenza, simboleggiata dalla presenza dei bambini e dal candore dei due adulti che si uniscono a loro. Quest’armonia è interrotta
dall'arrivo dei due personaggi ‘malvagi’, che, parlando tra di loro dell’apparizione
improvvisa della donna, ipotizzano che possa essere in realtà una gru, ricordando
che storie simili sono già accadute. In questo modo, introducono lo spettatore al
mondo del dramma e chiariscono il suo legame con la cultura popolare. Stilisticamente, l'uso di questo flashback introduce una variazione rispetto alla narrazione
lineare della fiaba.
Tranne i bambini, tutti i personaggi hanno un nome: la moglie gru si chiama
Tsū, suo marito Yohyō, i due 'cattivi' Sōdo e Unzu. Uso le virgolette perché Kino8 Kinoshita Junji, "Enshutsu no tame no memo” (Note per la rappresentazione), in Henshū Iinkai (a cura di), Yūzuru no sekai (Il mondo di Yūzuru), Miraisha, Tōkyō, 1984, pp. 3-23.
192
Irene Starace
shita non aveva l'intenzione di far apparire questi due personaggi come dei personaggi negativi a tutto tondo. Nelle sue note di regia il drammaturgo commenta che
Sōdo, il più forte dei due, potrebbe essere semplicemente spinto dalla miseria e dai
troppi figli.9
Oltre al nome, Kinoshita conferisce ai personaggi anche un’individualità. Yohyō
è ingenuo e semplice, Sōdo e Unzu avidi, ma, come abbiamo detto, non malvagi.
Tutti e tre sono persone semplici, ma Tsū è diversissima da loro. Parla un linguaggio raffinato, a differenza degli altri personaggi che usano un dialetto inventato
dall'autore, mescolanza dei vari dialetti del Giappone; ha dei gesti non del tutto
umani (“piega il capo come un uccello”); non capisce quello che dicono Sōdo e
Unzu, in quanto il denaro non fa parte del suo mondo. È una creatura innocente e
dolce, il cui unico linguaggio è quello dell'amore. Il suo nome, che viene da una
lunga tradizione di donne sciamane,10 sottolinea il suo muoversi tra due mondi,
l'umano e il soprannaturale.
Nel corso del dramma tutti i personaggi vanno incontro ad un'evoluzione: l'ingenuo Yohyō è spinto all'avidità da Sōdo e Unzu, i quali a loro volta, si rendono
conto nel finale delle conseguenze tragiche del loro comportamento avido e sospettoso. Le trasformazioni più significative, ancora una volta, sono compiute da Tsū.
Di fronte al cambiamento del suo sposo, è costretta a perdere l’innocenza: per capire cosa gli stia accadendo, per la prima volta parla con lui dissimulando i suoi sentimenti.11 Quando si trova sola, invece, si sente finalmente libera di esprimere il suo
dolore e la sua lotta interiore e lo fa in due monologhi di grande intensità. Nel primo ricorda il suo incontro con l'amato, la felicità vissuta insieme e si chiede cosa
fare di fronte a questa nuova situazione, che rende l’uomo avido e prepotente come mai era stato prima. Nel secondo, invece, decide di tessere due ultime tele,
sperando che in seguito tutto possa presto tornare come prima.
Possiamo vedere che nell’adattamento scenico della fiaba il tema della storia è
completamente cambiato. Ora si tratta di un tema ‘moderno’: il conflitto tra denaro
e amore. Mentre nella fiaba il denaro è la ricompensa per il salvataggio della gru e
non stimola l'avidità dell'uomo, nel dramma esso diventa la causa della tragedia.
Anche se è la curiosità a costituire la causa scatenante del ritorno di Tsū al suo
mondo, l'avidità di Yohyō ha già minato, probabilmente senza rimedio, la loro
felicità. È questo il messaggio (o la nuova morale della fiaba) propugnato dal testo
di Kinoshita.12
Le differenze tra il testo della fiaba e quello del dramma nascono, più che
dall'appartenenza a forme espressive diverse, da esigenze extraletterarie differenti.
Ne è testimonianza non solo la necessità di spiegare agli spettatori l’origine della
Ibid., p. 12.
Takagi, El espíritu del agua, cit., p. 143.
11 Junji, "Enshutsu”, cit., p. 18.
12 Fulciniti, "Yūzuru", cit., pp. 118-119.
9
10
La fiaba della moglie gru e la sua trasposizione teatrale in Yūzuru di Kinoshita Junji
193
storia ‒ necessità che il narratore della fiaba, rivolgendosi a un pubblico che condivideva la sua stessa cultura, non aveva – ma anche il contesto storico-culturale in
cui il drammaturgo decide di mettere in scena questo adattamento. La drammatizzazione della fiaba contribuisce a modificare l’impiego sociale della tradizione
popolare, che ha come prima finalità la costruzione di una cultura comune e consolidata. La messa in scena del folklore, quindi, contribuisce a far passare una ‘cultura del consenso’ ad una ‘cultura del dissenso’, in cui i codici comunicativi si vestono di un significato politico e sociale, tale da scuotere le coscienze e da richiamare
al senso etico e morale di antica tradizione.
194
Irene Starace
La fiaba della moglie gru e la sua trasposizione teatrale in Yūzuru di Kinoshita Junji
Sezione III
195
196
Irene Starace
CARLA RUSSO
Introduzione
COSTRUZIONE DELL’ORALITÀ
E COSTRUZIONE DELLA SCENA
Parlare di ‘oralità’ significa parlare di ‘linguaggio’ e, dal punto di vista teatrale,
di linguaggio della scena. Partendo dalle riflessioni del regista francese Roger
Planchon in materia di scrittura scenica, autorevoli studi ‒ non ultimo quello di
Lorenzo Mango confluito nell’opera La scrittura scenica ‒ hanno permesso di affermare che tale scrittura
sembra avere, per più di un verso, le caratteristiche di un codice linguistico: indica,
cioè, una condizione materiale del linguaggio (ciò di cui materialmente è fatto), ma porta con sé anche la nozione di articolazione (il modo, cioè, in cui il dato materiale si dà
come nesso semantico) e, infine, si propone anche come tramite di relazione tra segno e
significato, indicando, così, la possibile finalizzazione del linguaggio ad un esito comunicativo.1
La scena ha una sua autonoma dimensione creativa e l’esperienza teatrale novecentesca ha avuto il merito di ‘scoprire’ quelle ‘verità da lungo tempo note’, per
rubare un’espressione usata da Stanislavskij nella sua autobiografia La mia vita
nell’arte quando, nel ricordare il percorso di ricerca che lo aveva condotto alla comprensione di alcuni principi fondamentali del fare teatro, arrivò a constatare che la
consapevolezza dell’età matura non fosse altro che la capacità di vivere con tutto il
proprio essere quanto da sempre intuito solo con la mente.2 La scrittura scenica,
dunque, “è una scrittura in sé … , ha, cioè, una sua logica interna, una sua grammatica, una sua forma e una sua intenzione”.3
Questa terza sezione di contributi ci mostra come le unità segniche (attore, spazio, musica,…), nella molteplicità delle possibili combinazioni, diano vita a generi
specifici dove il concetto di ‘oralità’, travalicando il significato originario, arriva ad
assumere un senso nuovo e, talvolta, imprevedibile. Nel suo intervento introduttivo a questa sezione di lavori, Gerardo Guccini ha proposto l’esempio di George
Sand, figura eclettica dell’Ottocento che dedicò la sua azione culturale
all’esplorazione delle varie forme di creatività orale, da quelle legate al mondo
dell’infanzia a quelle riconducibili alle tradizioni popolari e, non ultime, a quelle
1 Lorenzo Mango, La scrittura scenica. Un codice e le sue pratiche nel teatro del Novecento, Bulzoni,
Roma, 2003, p. 15.
2 Cfr. Konstantin Stanislavskij, La mia vita nell'arte, Einaudi, Torino, 1963.
3 Mango, La scrittura scenica, cit., p. 21.
198
Carla Russo
teatrali. Formulando un modello attoriale che prevedeva la completa compenetrazione tra personaggio e interprete e confacendosi ad esso, la Sand-romanziera abbraccia una pratica compositiva che parte da un sentimento realmente provato e da
lì crea trame e personaggi immaginari. Le analogie tra i processi di ‘scrittura’ del
romanziere e dell’attore intuiti da Sand diventano profetici di quanto avverrà nel
secolo a venire, in particolar modo in Italia dall’avvento delle neoavanguardie in
poi.
Sulle scene, così come nei testi teatrali contemporanei, i personaggi perdono il
loro statuto unicamente mimetico e si fanno ‘voci’ in grado di contenere porzioni
di racconto diegetiche. Viene portato avanti e declinato attraverso soluzioni
drammaturgiche e sceniche innovative il discorso di epicizzazione del dramma
postulato da Brecht, il cui teatro è stato epifenomeno del processo di superamento
delle forme del dramma moderno che Szondi individua in nuce già in autori precedenti (Ibsen, Cechov, Strindberg, Maeterlinck, Hauptmann). A tal proposito, Silvia
De Min, nel suo contributo dal titolo Una voce che contiene tante voci, ci pone la questione dell’oralità intesa come ‘io scenico’, voce parlante (monologante e/o dialogica) all’interno del tessuto drammaturgico e della sua funzione nell’ambito dei meccanismi della narrazione. Tale ‘voce’ può contenere drammaturgie complesse, in
cui il racconto non si dà in modo lineare, ma diventa una successione e sovrapposizione di testimonianze e slanci emotivi, come accade, ad esempio, nella riscrittura
e riduzione per voce sola dell’Orestea di Eschilo curata da Peppino Mazzotta e Igor
Esposito dal titolo Radio Argo, in cui è la voce di un radiocronista a sostituire quella
del coro classico e a supportare l’azione dell’unico attore in scena. Un altro esempio riportato da De Min è la funzione del doppiaggio prestato alla scena, in cui la
presenza di una sola voce può produrre l’effetto sonoro di un cantastorie, come
accade con Eduardo e la sua registrazione delle voci de La Tempesta per la versione
marionettistica dei Fratelli Colla, o può arrivare a distruggere la narrazione, come
nella messinscena de Il Mago di Oz dei ravennati Fanny & Alexander.
L’idea di amplificare una ‘voce’ che altrimenti andrebbe persa racchiude il senso del teatro verbatim, una forma di teatro documentario a cui è dedicato
l’intervento di Vera Cantoni. Ad affermarlo è Robin Soans, attore e autore tra i
principali esponenti del teatro verbatim, il quale sostiene che grazie all’operazione
drammaturgica, basata sul reperimento e l’organizzazione scenica delle fonti (documenti, interviste,…), e all’operazione attorica che mette in pratica il tipico straniamento brechtiano, fatti politici, di cronaca e sociali possano essere restituiti attraverso diversi punti di vista, attraverso ‘più voci’. In tal caso, la scrittura scenica
supera una nuova frontiera in cui la parola recitata nasce dall’elaborazione di una
precedente espressione diretta con l’intento di renderla teatrale, pur mantenendo
intatta la sua veridicità di fondo: la fabula scompare nella cronaca del fatto narrato.
Di tutt’altra natura è la funzione della ‘voce’ nel caso preso in esame da Maria
Cristina Zerbino. Il suo intervento, infatti, dal titolo Pulci e pidocchi: il gioco dei pro-
Costruzione dell’oralità e costruzione della scena
199
nomi sulla scena plautina, tra oralità e scrittura, è una riflessione sul continuum oralitàscrittura nelle commedie di Plauto a partire da un’analisi dei deittici, dei pronomi
personali in particolare, definiti da Zerbino ‘pidocchi del pensiero’: chi sarà quel
’tu’ a cui si rivolge il personaggio? Un grattacapo non da poco, che solo l’atto della
parola è in grado di sciogliere. Solo quando si realizza sulla scena, la lingua del
dramma perde quell’incompletezza comunicativa e i suoi deittici sono finalmente
associati a volti, oggetti e luoghi specifici. Nei testi antichi privi di didascalie,
l’analisi del gioco dei pronomi dà indicazioni rilevanti, secondo Zerbino, sulla loro
dimensione orale e performativa: in essi è riprodotta la dinamica del ‘parlato’ in
cui ‘io’ e ‘tu’ sono necessari, sempre presenti.
Con un salto tematico e temporale, Luigia Tessitore, nel suo contributo Cantastorie da cabaret: attualizzazione del Bänkelsang nel cabaret tedesco degli anni ’20, ci
riporta al secolo appena trascorso e ci mostra come differenti istanze estetiche del
cabaret tedesco di primo Novecento, nato sulla scia del cabaret francese di fine
Ottocento, riconducano alle potenzialità espressive della forma orale. Il cabaret
tedesco cui allude Tessitore è basato sulla riattualizzazione di canti da fiera della
tradizione attraverso l’adozione di espedienti scenici che mutano a seconda degli
esecutori. Wedekind, ad esempio, utilizza lo schema della Rollengedicht, la poesia in
ruoli, in cui il poeta–cantastorie si eclissa per lasciare spazio al personaggio, oltre
ad amplificare l’effetto di straniamento giocando sul contrasto tra il tono della storia narrata e il ritmo di esecuzione. Mehring, attivo negli stessi anni presso il cabaret Wilde Bühne di Berlino, trae dagli esperimenti dadaisti l’uso dissacrante
dell’ironia e lo applica al genere Moritat, basato sul racconto di crimini efferati. Dal
canto suo, Brecht, anch’egli attivo presso il Wilde Bühne, opta per un’oralità ‘guidata’ dal medium della scrittura o della figurazione (uso di cartelli) combinata ad una
narrazione in terza persona, sommando così una componente mimetica ad una
immaginifica e producendo straniamento.
Un nuovo scenario sull’uso dell’oralità ci è offerto dal poeta Muzaffar alNawwab, nato nel 1934 a Baghdad e tuttora vivente e operante, come evidenzia
Fatima Sai nella sua relazione Il corpo del poeta. Oralità secondaria nella poesia araba
contemporanea: Muzaffar al-Nawwab. Dopo essersi dedicato alla composizione scritta,
il poeta sceglie la via dell’oralità come unica via di fuga per aggirare controlli e
censure e permettere la diffusione di verità scomode: sparisce il ‘corpo scritto’ e
resta il ‘corpo’ di Muzaffar, la poesia ritorna al suo statuto originario di flatus vocis
e la voce del poeta, fisica e metaforica, diventa frontiera di resistenza poetica e
politica. Un ritorno all’oralità necessario, che recupera la pratica della lettura pubblica e dà vita ad una ‘performance nella performance’ grazie alla possibilità, da
parte del pubblico partecipante, di poter liberamente registrare l’evento attraverso
l’ausilio delle nuove tecnologie (audio e video) e metterlo in circolazione in un
modo altrettanto libero e inarrestabile.
200
Carla Russo
Ancora, attraverso l’esempio del “TeatroNatura” di Sista Bramini, Maia Giacobbe Borelli nel suo Non c’è niente di più simile ad un fiume che un racconto: la voce
della natura nelle narrazioni di Sista Bramini registra la tendenza attuale verso il recupero del ‘luogo’ all’interno della narrazione teatrale. A lungo occultato dalla presenza del racconto dettato dal dispositivo scenico, e quindi artificiale, il ‘luogo’
torna a far sentire la sua ‘voce’: diventa uno dei personaggi e il racconto è rinarrato
e riscritto in funzione del contesto spazio-temporale. I luoghi naturali si offrono
quale spazio ideale per accogliere i miti della nostra cultura, luoghi primitivi in cui
‘mettersi in ascolto’ dei suoni e dei silenzi, luoghi in cui il teatro ritorna al senso
profondo delle origini e diventa esperienza condivisa di una realtà che travalica i
limiti dell’ordinarietà.
Emma Dante, invece, sulla quale mi soffermo nel mio intervento Costruzione
dell’oralità scenica nell’operazione teatrale di Emma Dante, elabora un personale linguaggio scenico in cui i meccanismi della narrazione sono affidati prevalentemente
agli elementi scenici. Sono l’attore, fatto di corpo e voce, gli oggetti di scena e la
musica, intesa come successione di suoni ma anche di silenzi, a ‘farsi racconto’, a
suggerire ‘storie’. Come Anna Barsotti suggerisce riprendendo una definizione di
Eduardo De Filippo,4 anche gli spettatori diventano parte attiva di tale scrittura,
sono ‘il personaggio in più’, che con la sua presenza “reale e performativa”5 esplicata soprattutto attraverso l’atto del guardare, attiva, determina e rende mutevole
l’agire degli attori sul palcoscenico.
Il concetto di ‘oralità’, soprattutto se applicato alla materia teatrale, deflagra in
una miriade di declinazioni possibili, di cui questa terza sezione di lavori ha cercato, seppur in minima parte, di dar conto. Oggi che i confini tra ‘cosa è’ e ‘cosa non
è’ teatro si sono sempre più assottigliati quasi fino a scomparire, la questione
dell’identità teatrale è quanto mai aperta e contesa. Sottolinea De Marinis:
Nel cercare di restituire a questo mezzo espressivo comunicativo, ormai a rischio di
obsolescenza, un senso, un valore, una necessità, i protagonisti della scena novecentesca [e, oggi, quelli post-novecenteschi, lascia intendere De Marinis, n.d.r.] hanno
tutti imboccato, sia pure in modi differenti e con diversa radicalità, delle vie che,
nel/per rigenerarla, sottoponevano la forma spettacolo, e quindi il teatro nel suo
complesso, a sollecitazioni formidabili e a interrogazioni spietate, in forza delle quali
non di rado l’abbandono del teatro stesso o, almeno, la fuoriuscita dal teatrospettacolo sono apparsi come conseguenze logiche, inevitabili.6
4 Cfr. Anna Barsotti, La lingua teatrale di Emma Dante. mPalermu, Carnezzeria, Vita mia, Edizioni
ETS, Pisa, 2009, p. 139.
5 Ibid.
6 Marco De Marinis, Il teatro dopo l’età d’oro, Bulzoni Editore, Roma, 2013, p. 13.
GERARDO GUCCINI
DAL NARRATORE/BAMBINO ALL'AUTORE/PERFORMER.
APERTURE PROBLEMATICHE SU NARRAZIONE E MEMORIA
A PARTIRE DALL'HISTOIRE DE MA VIE DI GEORGE SAND
Incominciamo con un'immagine. Siamo in una stanza spoglia, ma decorosa. Il
focolare è acceso. Nell'ambiente si notano subito quattro sedie con gli schienali
posti gli uni contro gli altri in modo da formare una specie di celletta quadrangolare; al centro di questo spazio protetto, uno scaldino spento dovrebbe fungere da
sgabello o da cuscino. Al momento però la bambina di tre o quattro anni che si
trova fra le sedie non ci si sta sedendo, ma ci monta sopra in piedi. In posizione
eretta, poggia i gomiti sugli schienali e, molto coscienziosamente, sfila la paglia
dell'imbottitura. Nella stanza ci sono anche due giovani donne. La madre è seduta
vicino, ma non la guarda; tutta presa dalle faccende domestiche, ricama o cuce. La
zia, invece, è evidentemente incuriosita dalla piccola. Sembra sul punto di dirle
qualcosa. Inseriamo anche l'audio. La bambina parla in continuazione con una
vocina sottile sottile. Osservando le sue mani e la concentrazione con cui segue la
loro opera distruttiva, potremmo credere che non stia pensando ad altro. Ma la
voce ci avverte che non è così. Non si riesce a capire cosa dica. La bambina non
parla a nessuna delle donne presenti. Anzi, al momento, il parlare non è per lei
un'occupazione primaria, bensì il riflesso d'un agire meno evidente ed intimo che,
divenuta adulta, chiamerà ‘composizione’: “componevo ad alta voce degli interminabili racconti che mia madre chiamava i miei romanzi”.1 La bambina non si
preoccupa di far capire le storie che le passano per la testa. Tuttavia, a tendere l'orecchio, si percepiscono alcune espressioni che tornano in continuazione: “buona
fata”, “buon principe”, “bella principessa”. Ogni tanto, l'improvvisata vicenda
viene bloccata dalla ripetizione d'una stessa azione. Allora, la zia segnala l'impasse
alla bambina con espressioni scherzose: “Ebbene, Aurora, il tuo principe non è
ancora uscito dalla foresta? E la tua principessa quando finirà di mettersi il vestito
con lo strascico e la corona in testa?”. Aurora sembra non udirla. A intervenire, è
piuttosto la madre che, solo apparentemente indifferente, non gradisce queste interruzione: “Lasciala tranquilla […], riesco a lavorare rilassata solo quando comincia i suoi romanzi fra quattro sedie”. La madre non cerca di capire queste interminabili storie, ma si lascia cullare dal suono del racconto. D'altra parte, non la sua
attenzione, ma la sua presenza è necessaria alla bambina, che, una volta adulta,
ricorderà di aver potuto ritrovare giorno dopo giorno il filo della narrazione grazie
1 George Sand, Histoire de ma vie (1855), Paris, Éditions Stock, 1985, p. 27. Alla stessa fonte sono
riferite anche le successive citazioni dell'episodio.
202
Gerardo Guccini
all'empatia senza contatti apparenti fra lei e la madre: “Ciò che c'era di curioso, era
la durata di queste storie e una sorta di seguito, poiché io ne riprendevo il filo là
dove era stato interrotto il giorno precedente. Forse mia madre ascoltando meccanicamente e come involontariamente queste lunghe divagazioni, m'aiutava a sua
insaputa a ritrovarmici”.
La bambina, Aurore Dupin, sarà, col nome di George Sand, una delle voci più
ascoltate e discusse dell'Ottocento. Il brano dei Mémoires che abbiamo appena ricordato non è solo un delizioso idillio infantile, ma rientra a pieno titolo nella multiforme azione culturale dell'autrice, che si dedicò con continuità e passione alla
conoscenza, alla conservazione e al rinnovamento di varie forme di creatività orale:
popolari, teatrali, legate al mondo dell'infanzia. Il suo interesse per l'argomento
non era certo isolato. Fra i valori della cultura romantica vi erano le tradizioni del
popolo, le sue forme narrative e musicali, il mito del poeta improvvisatore incarnato, in particolare, dalla Corinne (1807) di Madame de Staël e quello del “buon selvaggio” lanciato, il secolo prima, da Jean-Jacques Rousseau che, individuando
nella civiltà un elemento di corruttela, aveva insegnato a considerare le espressioni
orali o cantate più prossime alla felice armonia del mondo naturale che non quelle
letterarie e destinate alla stampa. Peculiare della sola George Sand, è, invece, l'aver
intrecciato alla trattazione letteraria della creatività orale indagini dislocate fra
ricerche sul campo, oltre ad empiriche e sperimentali verifiche volte a cogliere i
principi della composizione estemporanea. Si trattava di esperienze mediate, in un
caso, dalla frequentazione dei narratori popolari del nativo Berry, nell'altro, dalla
pratica dell'improvvisazione scenica assiduamente svolta, a partire dal 1846, assieme a parenti, artisti e attori professionisti, durante i soggiorni nel castello di
Nohant.2 Alcuni dati chiariranno la portata di questi interessi calati nel vissuto.
Al linguaggio e alle tradizioni del Berry, George Sand dedica romanzi e racconti
d'argomento campestre che fecero scuola; fra questi, la Palude del diavolo (1846)
inquadra nell'ambito festivo che le è proprio, la narrazione minuziosamente riportata, d'un raccontatore popolare. Più circoscritti gli interventi della romanziera
sull'inventiva dei “poeti proletari”, ai quali suggerisce di comporre “canzoni per
ogni mestiere”: argomento per cui dovrebbero avere, a differenza dei letterati, “l'ispirazione e la simpatia”3 necessarie. Di particolare importanza è il filone dedicato
alle improvvisazioni teatrali, che comprende romanzi come Il Castello delle Désertes
(1851) e L'Uomo di neve (1859), numerosi canovacci (fra cui ricordiamo almeno il
trittico molieriano: Lelio, Marielle, Molière), articoli quali Il Teatro e l'Attore (1858) e Il
2 Cfr. Debra Linowitz Wentz, Les Profils du Théâtre de Nohant de George Sand, Éditionns A.-G. Nizet,
Paris, 1978. Per i dettagliati riferimenti metodologici e bibliografici, cfr. Anche Roberto Cuppone, CDA.
Il mito della Commedia dell'Arte nell'Ottocento francese, Bulzoni, Roma, 1999, con particolare riferimento ai
paragrafi dedicati al “Teatro di Nohant, primo laboratorio teatrale europeo”, pp. 128-147.
3 Cfr. la lettera di George Sand riportata dal poeta muratore Charles Poncy nella Préface a La Chanson
de Chaque Métier, Comon, Libraire-Éditeur, Paris, 1850, pp. VI-IX.
Dal narratore/bambino all'autore/performer. Aperture problematiche su narrazione …
203
Teatro delle marionette di Nohant (1876) e un saggio storico sulla ‘comédie françaiseitalienne’ che introduce il celebre Masques et bouffons (1860), con cui il figlio della
romanziera, Maurice Sand, rilanciò l'attenzione per la Commedia dell'Arte. Il genere fiabesco è presente sia nelle riflessioni che nell'opera letteraria di George Sand,
dove le fiabe edite rielaborano narrazioni orali destinate alle nipotine (Aurore e
Gabrielle Sand); ma è soprattutto nella Storia della mia vita (1855) che i rapporti fra
bambino, immaginario e narrazione si fanno documento e segno di conoscenze più
generali, venendo calati in una fitta trama di ricordi che descrivono, forse oltrepassando gli intenti dell'autrice, il graduale aprirsi della “ragione nascente”.4
Per decine e decine di pagine, George Sand descrive e commenta immagini ed
episodi del suo passato più lontano, narrando l'evolversi della mente infantile e del
linguaggio. Questa parte del racconto biografico – affatto preponderante nell'economia dell'opera – si articola in due fasi disposte attorno alla traumatica morte del
padre, l'ufficiale napoleonico Maurice Dupin, a seguito d'una caduta da cavallo.
Dopo quel momento (1808), contesto dei ricordi sarà il castello familiare di Nohant,
sul cui sfondo si muovono la nonna materna, la madre, il fratellastro, inservienti e
figli di contadini. Prima, invece, c'è il modesto appartamento parigino di via Grange-Batelière – teatro dei “romanzi fra le sedie” –; ci sono i paesaggi spagnoli, attraversati per raggiungere il padre, distaccato come attendente presso il generale Murat; c'è il sontuoso alloggio di Madrid, che dà su una piazza silenziosa e deserta a
causa dell'occupazione. Dato importante: Aurore Dupin nasce nel 1804, quindi gli
episodi della prima fase hanno per fonte primaria i ricordi di una bambina di duetre-quattro anni d'età. Scrupolosa ricercatrice del proprio passato, George Sand
segnala le immagini sicuramente serbate, quelle confuse, quelle indotte dai racconti
dei parenti e quelle forse ricostruite a seguito di conoscenze ed esperienze ulteriori.
Il 21 febbraio del 1869, tornando a riflettere, ora in veste di nonna, sulla misteriosa mente dei bambini che “pensano senza comprendere”,5 George Sand chiese
all'amico Gustave Flaubert se, a suo parere, era meglio esaltare o reprimere la loro
naturale sensibilità. La risposta dello scrittore aggancia la comprensione del pensiero infantile alla conoscenza antropologica dell'essere umano e, a sorpresa, indica
quale più importante testo di riferimento sulla questione proprio la Storia della mia
vita della stessa Sand:
Voi mi dite delle cose ben vere sulla inscienza dei bambini. Colui che leggerà con precisione in questi piccoli cervelli vi troverà le stesse radici del genio umano, l'origine
degli Dei, l'energia che produce più tardi le azioni, ecc. Un negro che parla al suo
idolo e un bambino alla sua bambola mi sembrano vicini l'uno all'altro.
Sand, Histoire de ma vie, cit., p. 43.
George Sand, “Lettera a Flaubert, 21 febbraio 1869”, in Gustave Flaubert, George Sand, Correspondance, texte édité, préfacé et annoté par Alphonse Jacobs, Flammarion, Paris, 1981, pp. 217-218.
4
5
204
Gerardo Guccini
Il bambino e il barbaro (il primitivo) non distinguono il reale dal fantastico. Ricordo
nettamente che a cinque o sei anni volevo “inviare il mio cuore” a una bambina di cui
ero innamorato (intendo il mio cuore materiale!). Lo vedevo in mezzo alla paglia, in
un corbello, un corbello da ostriche!
Ma nessuno è andato più lontano di voi in queste analisi. Ci sono nella Storia della mia
vita delle pagine sopra questi argomenti, che sono d'una profondità smisurata. Quello che dico è vero, poiché gli spiriti più lontani dal vostro sono restati sbalorditi di
fronte ad esse.6
L'autobiografia della Sand indicava, come Flaubert vide con precisione, la possibilità d'una scienza che indagasse la formazione del linguaggio ‘leggendo’ gli
sviluppi della mente infantile.7 Le competenze psicologiche, che consentirono alla
scrittrice di intrecciare ai fatti oggettivi dell'infanzia la ricostruzione delle peripezie
interiori di se stessa bambina, sono probabilmente dovute, da un lato, all'interesse
per le dinamiche dell'oralità e della creazione estemporanea, dall'altro, al procedere irriflesso e sonnambolico del suo processo compositivo. A differenza del letterato Flaubert, che trovava la misura musicale delle frasi ripetendole fra sé all'infinito,
George Sand esperiva l'autonoma oralità della mente, osservandone l'inesauribile
capacità d'improvvisare discorsi, dialoghi e descrizioni. Con aria istupidita ed
“ebete”, estranea a quanto le succedeva intorno, George Sand ascoltava e trascriveva in tempo reale le enunciazioni verbali del pensiero. Come la piccola Aurore
Dupin, si immergeva in stati percettivi alterati che rispecchiavano, ancor più che i
contenuti emozionali dell'immaginazione, un suo modo d'essere. Anche un letterato infaticabile e fecondissimo come Théophile Gautier, osservando a Nohant il
procedere della scrittrice, noterà scandalizzato la continuità senza pause del suo
lavoro letterario. Dice ai fratelli de Goncourt, che ne riportano il racconto nel Journal in data 14 settembre 1863:
Non può sedersi in una stanza senza che spuntino fuori delle penne, dell'inchiostro
blu, della carta da sigarette, del tabacco turco e della carta da lettere rigata. E ne sforna di pagine! Infatti ricomincia a mezzanotte e continua fino alle quattro... Insomma
sapete cosa le è successo? Una cosa mostruosa! Un giorno ha terminato un romanzo
all'una del mattino […]. E ne ricominciò subito un altro. Scrivere in lei è una funzione
dell'organismo.8
6 Gustave Flaubert, “Lettera a George Sand, 23-24 febbraio 1869”, in Flaubert - Sand, Correspondance,
cit., pp. 218-220, in part. p. 219.
7 L'autobiografia di George Sand non viene citata dagli studi di Piaget e Vygotskij sulla formazione
del linguaggio nel bambino. Tuttavia le corrispondenze fra quest'opera letteraria e le conoscenze
acquisite dalla pedagogia novecentesca sono impressionanti. In particolare, la composizione dei
romanzi fra le sedie presenta le caratteristiche del “monologo collettivo”. Cfr. Jean Piaget, Il linguaggio e
il pensiero del fanciullo, Giunti Barbèra, Firenze, 1983, pp. 17-18.
8 Edmond de Goncourt, Jules de Goncourt, Diario. Memorie di vita letteraria 1851-1896. Scelta,
traduzione e introduzione di Mario Lavagetto, Garzanti, Milano, 1992, p. 106.
Dal narratore/bambino all'autore/performer. Aperture problematiche su narrazione …
205
Nelle sue prime opere letterarie George Sand attribuì il particolare ‘ascolto’, con
cui il romanziere coglie e trascrive quanto il linguaggio produce in lui, a una sorta
di condizione onirica e sonnambolica. Scrive nella Storia di un sognatore (1831):
Nessuno più di me sa gustare le dolcezze di quel sonno magnetico che chiamano
'sonnambulismo', benché questo termine non esprima che una sola delle sua qualità.
Questa condizione dell'anima e del corpo è stata forse troppo poco osservata fino ad
oggi, ed io mi propongo di analizzare ogni giorno ciò che accade nel mio sonno per
portarvi forse, miei cari amici, a scoperte importanti sulla natura e la sede dell'anima.9
Poi, però, con la pratica dell'improvvisazione, l'analisi degli stati onirici si integrò alla sperimentazione scenica dei rapporti fra vissuto e finzione, memoria e
immaginazione. “Se – come si legge nell'Homme de neige – non è la ragione che governa l'uomo, ma è l'immaginazione, è il sogno”, e “il sogno è l'arte, la poesia, la
pittura, la musica, il teatro”,10 ne consegue che il teatro, opera collettiva per eccellenza, consente di sperimentare su basi oggettive le dinamiche oniriche, pervenendo, come dice Stella, un personaggio del Castello delle Désertes, “allo sviluppo sintetico […] delle nostre facoltà artistiche”.11
Il modello attoriale formulato da George Sand può apparire romanticamente
ingenuo. La scrittrice, lontanissima dall'attore freddo e distaccato di Diderot, vuole
infatti che fra il personaggio e i sentimenti reali dell'interprete vi sia una compenetrazione tanto stretta da escludere la rappresentazione di ciò che non si prova. Attraverso il gioco recitativo, scrive, emergono “i sentimenti segreti degli attori”.12
Tale dinamica non corrispondeva per nulla all'improvvisazione praticata degli
antichi comici, maestri nell'arte di sedimentare e montare ampi repertori corporei e
verbali.
Ma ciò che qui interessa appurare non sono tanto le pertinenze storiografiche
dei criteri recitativi sperimentati da George Sand, quanto le loro intersezioni con
l'opera della scrittrice che, pur evitando di mescolare arte e vita al modo dei dandy
o dei romantici esaltati, coltivò nel vivere le sorgenti umane del proprio essere
artista e, quindi, in primissimo luogo, l'estemporaneo prodursi del linguaggio. In
quest'ambito le corrispondenze fra pratica scenica e scrittura appaiono evidenti e
strettissime. Affinché il pensiero potesse ‘dettarle’ il testo d'un romanzo, George
Sand doveva infatti scegliere argomenti che contemplassero sentimenti provati o
avvertibili come propri. “La gente si sbaglia di molto ‒ avverte introducendo Lu9 Cit. in Angela Cerinotti, “Incontro con George Sand”, in George Sand, Il crepuscolo delle fate. Fiaba
sul fanciullo, il sentimento, la vita, Red Edizioni, Como, 1987, p. 13.
10 George Sand, L'Homme de neige, II, M. Lévy Paris, Paris, 1858-1861, p. 286.
11 George Sand, Il Castello delle Désertes, a cura di Gerardo Guccini, Ubulibri, Milano, 1990, p. 125.
12 Jean Rousset, “Le comédien et son personnage de Don Juan à Saint Genest”, Preuves, 201, 1967,
pp. 17-23, in part. p. 17.
206
Gerardo Guccini
crézia Floriani (1853) ‒ se crede che sia possibile fare di un personaggio reale un tipo
da romanzo”. Quindi, prosegue: “Ciò che è possibile fare è l'analisi di un sentimento. Perché questo abbia un senso all'intelligenza, passando attraverso il prisma
dell'immaginazione, bisogna dunque creare i personaggi per il sentimento che si
vuole descrivere, e non il sentimento per i personaggi”.13 Per George Sandromanziera come per George Sand-teatrante i sentimenti non sono triviali garanzie
d'efficacia, che basti sfiorare e mettere in opera per toccare il cuore a spettatori e a
lettori. Le loro verità interiori vengono infatti innestate a identità e trame immaginarie attivando, durante il gioco teatrale, l'oralità dell'attore e, durante la composizione, l'affabulazione mentale dell'autore. Confermando il rapporto di circolarità
fra improvvisazione scenica e scrittura, George si impossessò in quanto autrice del
vissuto teatrale sedimentato dalle improvvisazioni di Nohant ricavandone, con Il
Castello delle Désertes, vicende avventurose e scritte, al solito, “in una specie di stato
di sonnambulismo”.14
La poetica letteraria della Sand si riprodusse al livello delle esperienze sceniche,
venendone però tanto intimamente coinvolta in un gioco di rispecchiamenti e confronti con i compagni d'arte e la dimensione attoriale, da uscirne, al contempo,
confermata e trasformata. Non più solo una poetica funzionale all'opera, ma anche
un pensiero aperto che, del teatro, raccoglieva il continuo divenire, l'identificazione
con la vita e la capacità di animare relazioni interpersonali e avventurosi viaggi
nell'io. Al livello dell'utopia sociale, George Sand immaginava una pratica scenica
capillarmente diffusa e condotta, non più da corporazioni di professionisti, ma da
“tutte le persone di spirito capaci di rappresentare”,15 mentre, al livello degli statuti
artistici, avvertiva come autore e attore potessero contrarsi in un'unica identità che,
di fatto, compendiava le due dimensioni della scrittrice: la grande sonnambula
letteraria, presente fin dai “romanzi fra le sedie”, e il premier rôle marqué del Teatro
di Nohant.16 Scrive George Sand in un articolo del 1858, ma pubblicato postumo
nel 1904 col titolo Il Teatro e l'Attore:
Io non pretendo di dire che gli attori siano generalmente superiori agli scrittori che
lavorano per loro. […] Dico soprattutto che il teatro non sarà completo che quando le
due professioni non ne faranno che una; vale a dire quando l'uomo capace di creare
un bel ruolo potrà crearlo veramente, ispirandosi alle sue proprie emozioni e trovanGeorge Sand, Lucrézia Floriani, Éditions de la Sphère, Paris, 1981, p. 9.
Cfr. la lettera inviata da George Sand al libraio Hertzel il 12 maggio 1847, cit. in Joseph-Marc Bailbé, “Le théâtre et la vie dans Le Château des Désertes”, Revue d'Histoire Littéraire de la France, 4, 1979, pp.
600-612, in part. p. 602.
15 Cfr. Sand, L'Homme de neige, cit., p. 291: “Il Teatro si concilierà con la vita il giorno in cui sarà gratuito e in cui tutte le persone di spirito capaci di rappresentare si faranno, per amore dell'arte, raccontatori e commedianti a un momento dato, qualunque sia la loro professione”.
16 George Sand, “Lettera a Augustine Bertholdi, 24 febbraio 1851”, in Wladimir Karénine, George
Sand, IV, Plons, Paris, 1926, p. 273.
13
14
Dal narratore/bambino all'autore/performer. Aperture problematiche su narrazione …
207
do in lui stesso l'espressione giusta e immediata della situazione drammatica. Mi si
dirà che questa espressione sublime viene agli attori di genio nel silenzio delle loro
celle, e che più d'uno che sa trovare la parola giusta, il vero grido del cuore, sarebbe
incapace di trovare questa parola e di esalare questo grido sulla scena. Questo è vero
al giorno d'oggi, ma non lo sarà per sempre. Le nostre facoltà sono incomplete, la nostra educazione ci dirige verso le specializzazioni, e, inoltre, i nostri pregiudizi ci trattengono. […] Ma arriverà un'epoca di grandi sviluppi in cui gli Shakespeare dell'avvenire saranno i più grandi attori del loro secolo.17
Nel mondo letterario e teatrale di George Sand, il processo dello scrittore e
quello dell'attore presentano strette analogie: entrambi raccordano l'immaginazione fantastica alla rappresentazione di sentimenti avvertiti come propri; entrambi si
rivolgono ad un ascoltatore presente o immaginato. “Quando comincio un libro –
scrive George Sand nella dedica di Adriani a Madame Albert Bignon – ho bisogno
di cercare l'approvazione del pensiero che me lo detta in un cuore amico, non importunandolo con il mio progetto, ma pensando a lui e contemplando, per così dire,
l'anima che so meglio disposta a entrare nel mio sentimento”.18 Ma, mentre nel caso
dell'autore, il flusso dell'improvvisazione mentale si concreta in segni verbali che,
solo venendo fissati e quindi letti, espanderanno nuovamente le pulsioni e gli intenti che li hanno suscitati, in quello dell'attore-improvvisatore, la parola nasce
come segno agito e componente performativa. L'autore ‘ascolta’ la performance del
pensiero, che ‘detta’ il testo; l'attore, invece, fa ‘vedere’ le parole pensate, rappresentando chi le pronuncia. Ipotizzare, nel teatro del futuro, l'avvento di grandi
attori/autori drammatici significava, dunque, voler immettere nel prodursi mentale
del linguaggio l'identità fonico-corporea dei protagonisti scenici.
Le due arti del comporre – l'improvvisazione sonnambolica e quella concretamente agita nello spazio scenico – definiscono, nel pensiero di George Sand, una
dialettica temporaneamente ostacolata dal sistema di specializzazioni della civiltà
borghese, ma destinata a evolversi. Il Novecento, paradossale ‘luogo’ della sperimentazione utopica, conferma generosamente questa previsione, presentando, in
corrispondenza e a seguito della svolta degli anni Sessanta, numerosi autori/performer fra loro diversissimi: Bene, Fo, Scabia, Leo de Berardinis, Moscato,
Ruccello, Cuticchio, Curino, Baliani, Paolini, Montanari, Scimone, Enia, Celestini.
Tutti italiani. Più recentemente, la stessa compenetrazione di funzioni è emersa
anche in Francia con Olivier Py e Wajdi Mouawad. È tuttavia indubbio che proprio
nel nostro paese performance e scrittura si siano incontrate e intrecciate più che
altrove. Perché? Seguendo le idee di George Sand possiamo individuare, alle radici
del caso italiano, due probabili cause. Da un lato, le tipologie attoriali che non si
George Sand, Le Théâtre et l'Acteur (1858), in Oeuvres autobiographiques, II, Gallimard, Paris, 1971,
pp. 1239-1244, in part. pp. 1243-1244.
18 George Sand, A Madame Albert Bignon, in Adriani, Michel-Lévy fréres, Paris, 1863, p. I. Il corsivo è
mio.
17
208
Gerardo Guccini
sottomettono alla drammaturgia scritta, ma compongono testi orali da adattare e
rivedere ad ogni nuova enunciazione e corrispondono alla particolare ‘psicologia’
del popolo italiano.19 Dall'altro, come si dice nel brano citato, la compenetrazione
delle funzioni implica la rimozione delle specializzazioni. Sottrazione che per l'appunto struttura, forse ancor più delle avanguardie e delle ondate generazionali,
l'innovazione italiana dagli anni Sessanta ad oggi. Mentre in altri paesi europei le
trasformazioni dei linguaggi hanno essenzialmente riguardato autori e registi,
coinvolgendo solo di riflesso gli attori, in Italia la crisi sistemica del teatro ha consegnato i processi di svolta, non tanto a ruoli creativi sanciti dalla prassi ma, come
diceva Meldolesi, pratiche d'arte ‘individualizzate’ e nate dalla concretezza del fare
teatro. A queste conviene rivolgersi finché il fenomeno è ancora propulsivo, trascegliendo dal passato percorsi ed opere, che, come fanno le esperienze e gli scritti di
George Sand, dialoghino con i processi in atto.
George Sand, “Préface”, in Maurice Sand, Masques et bouffons, Michel-Lévy frères, Paris, 1860, p.
VI : “La storia della Commedia dell'Arte, vale a dire dell'improvvisazione teatrale, non appartiene
soltanto alla storia dell'arte; appartiene soprattutto a quella della psicologia di due nazioni: l'Italia dove
è nata, e la Francia che l'ha accolta [...]”.
19
CARLA RUSSO
COSTRUZIONE DELL’ORALITÀ
NELL’OPERAZIONE TEATRALE DI EMMA DANTE
Il teatro di Emma Dante “è un teatro che pretende l’evento scenico, si realizza
compiutamente e al meglio nello spazio visivo e sonoro dello spettacolo“.1 Nel
corso degli anni, la regista ha sviluppato una personale pratica scenica che ha
l’intento di costruire ‘racconti’ attraverso la lingua della scena e che individua il
suo ‘centro’ nel momento laboratoriale, per poi completarsi nell’atto performativo
vero e proprio. L’operazione teatrale di Emma Dante ci riconduce alla nozione di
‘testo spettacolare’ che, secondo la semiotica teatrale, “sta ad indicare la valenza
testuale, vale a dire di un insieme di segni semanticamente direzionato, del fatto
rappresentativo”.2 È interessante notare come Gerardo Guccini paragoni la biografia di Emma Dante agli schemi dei ‘romanzi d’artista’ composti fra la fine dell’800 e
i primi anni del ‘900, suddividendola in quattro fasi “che ne collocano
l’apparizione alle soglie dell’invenzione teatrale”.3 Nello specifico, è opportuno
soffermarsi sulla quarta fase, la più delicata e importante, dove si esplicita la volontà della regista di esistere facendo teatro,4 che Guccini suddivide in due scansioni,
corrispondenti ai mutamenti intervenuti a livello registico. In un primo momento,
Emma Dante realizza spettacoli tratti da testi narrativi o da drammi, rielaborati da
lei stessa o da terzi, poi a partire da mPalermu (2001) inizia a far scaturire dal lavoro
della Compagnia non solo lo spettacolo, ma il dramma stesso. La regista matura la
convinzione secondo la quale l’obiettivo a cui tendere sia la fondazione di un teatro
“che rapporti produttore e prodotto, esterno e interno dello spazio scenico, dimensione individuale e contesto sociale… vale a dire una visione formalizzata del
mondo”.5 La regista si confronta e si scontra con la sua città, Palermo, che si rivela
attraverso i corpi e il linguaggio degli attori: “il mondo esterno viene infatti incluso
in processi che non si propongono di riprodurlo esteticamente, ma di ricavarne
realtà ulteriori, dove palpitante e continua è la dialettica fra forme oggettive della
1 Anna Barsotti, La lingua teatrale di Emma Dante. mPalermu, Carnezzeria, Vita mia, Edizioni ETS,
Pisa, 2009, p. 5.
2 Lorenzo Mango, La scrittura scenica. Un codice e le sue pratiche nel teatro del Novecento, Bulzoni,
Roma, 2003, p. 21.
3 Gerardo Guccini, “L’ambiente svelato. Dramma, attore e spazio nel teatro di Emma Dante”, in
Andrea Porcheddu (a cura di), Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, Editrice ZONA, Civitella in Val di
Chiana, 2006, p. 110.
4 Ivi, pp. 109-126.
5 Ivi, p. 113. Continua Guccini: “Tecnicamente, questo passaggio implica il rafforzamento della
dimensione creativa dell’attore e l’estensione delle funzioni drammatiche della regista, che assume fra
le proprie responsabilità sia la definizione dell’argomento che la composizione del testo”.
210
Carla Russo
vita e le soggettività dei teatranti”.6 Il teatro di Emma Dante, da mPalermu in poi, si
colloca sulla scia del teatro d’innovazione che, a partire dagli anni ‘80, ha iniziato a
intrecciare scrittura scenica e scrittura testuale nel quadro della storia o di situazioni ambientali.7 Per Emma Dante ‘fare teatro’ significa tentare di rispondere ad una
‘urgenza’ comunicativa, al bisogno impellente di dire ‘quella cosa’ e non un’altra in
quel preciso momento storico e sociale e di farlo con e attraverso la scena, utilizzando tout court il linguaggio teatrale fatto di attori, oggetti, musica. Pertanto, la
regista ‘scrive’ le sue storie (ed in seguito le racconta) attraverso le unità fonematiche della scena. E lì dove sia presente un testo di partenza,8 esso è riscritto ‒ potremmo dire ‘ricodificato’ ‒ attraverso il linguaggio teatrale.
Una pratica nata dalla sua pregressa esperienza d’attrice, durante la quale determinante è stato l’incontro con due maestri: Cesare Ronconi e Gabriele Vacis. Di
entrambi, Emma Dante ha fatto propri metodi e spunti di lavoro, che ha rielaborato
attraverso la sua idea di teatro e la sua identità culturale intrisa di ‘sicilitudine’.
Il punto di partenza è costituito dal lavoro con gli attori. Si inizia con una fase
laboratoriale preliminare in cui ‘si testano’ gli attori per verificare se siano adatti al
tipo di lavoro a cui si ha intenzione di sottoporli. È attraverso i laboratori che la
regista trova, quotidianamente, la ‘strada da seguire’ e i ‘compagni di viaggio’.
Dopo aver compiuto una prima ‘scrematura’, gli attori superstiti reputati idonei
accedono alla fase laboratoriale vera e propria. A questo punto la regista propone
loro una tematica o una suggestione intorno alla quale far partire una serie
d’improvvisazioni:9 “C’è un progetto, chiaramente, non è casuale tutto quello che
facciamo; …. ha a che fare non con una trama … ma con una discontinuità che è
tipica della vita …. Per cui sono storie che in realtà non hanno delle vere e proprie
trame, sono condizioni dell’anima, sono situazioni, sono accadimenti, sono facce…”.10
6 Ivi, p. 115. In un’intervista rilasciata da Emma Dante a Laura Landolfi si conferma il medesimo
concetto: “I miei lavori partono da spunti realistici per poi diventare visionari, esplorare condizioni
dell’anima”. Cfr. Laura Landolfi (a cura di), “Palermo. La mia è una città da romanzo”, in D (inserto di
Repubblica), 22 novembre 2008.
7 “Dal lavoro congiunto degli attori e del regista/drammaturgo sono dunque scaturiti spettacoli e
repertori dai forti contenuti drammatici”, afferma Guccini, come i lavori di Alfonso Santagata, quelli del
“Teatro de Los Andes”, di “Teatro Settimo”, di Leo De Berardinis, di Marco Baliani, di Ascanio Celestini
e Gaetano Ventriglia. Pur se diversissime sotto il profilo dei linguaggi e delle tematiche, si tratta di
opere che utilizzano modalità compositive strettamente analoghe: “scaturiscono da movimenti
processuali che presuppongono il contatto diretto con il pubblico” e che perciò si riferiscono “a criteri di
ricezione immediatamente condivisibili e popolari” (cfr. Guccini, “L’ambiente svelato. Dramma, attore e
spazio nel teatro di Emma Dante”, cit., pp. 115-116).
8 Come nel caso di Medea, tratto dal testo di Euripide, o de La scimia, tratto da Le due zitelle di
Tommaso Landolfi, entrambi spettacoli del 2004.
9 Ad esempio, in vista dell’allestimento di Le pulle (2009), l’idea di partenza era di condurre un
lavoro sul ‘femminile’ e sulle bambole.
10
Renzo Francabandera, Emma Dante: intervista integrale, Napoli, febbraio 2009,
<http://www.klteatro.it> (07/10).
Costruzione dell’oralità nell’operazione teatrale di Emma Dante
211
Il lavoro che Emma Dante richiede agli attori si muove seguendo tre direttrici
simultanee: il rifiuto di psicologismi e di sovrastrutture e la purificazione da ogni
forma di giudizio; lo stupore che solo i bambini sanno raggiungere; la bestialità,
intesa non soltanto come ricerca della propria istintualità, ma anche come l’intento
di partire da ciò che è necessario, eliminando il superfluo e compiendo una pulizia
estrema in ogni gesto e in ogni sguardo.11 Questo lavoro è condotto attraverso una
serie di esercizi, tra cui la ‘schiera’, un esercizio appreso da Emma Dante durante la
sua esperienza con Gabriele Vacis, attraverso il quale si costruisce il personaggio, il
suo modo di camminare, di guardare, di parlare; esercizio che la regista ha modificato per l’occorrenza. 12 Ecco le sue parole:
Ho rotto la schiera. Ovvero non gliela faccio fare più come me l’ha insegnata Gabriele! La faccio a modo mio, in un modo che ha a che fare con degli incroci strani… La
scena diventa una specie di griglia, di linee che si intersecano. …. La schiera è diventata una sorta di labirinto, in cui ci sono strade diverse. Prima ce n’era solo una: una
strada dritta, e si poteva andare avanti e indietro. Io ho cercato il labirinto, ho cercato
di far perdere l’orientamento agli attori.13
E da questi intricati labirinti emergono, a poco a poco, uno dopo l’altro, i ‘fantasmini’, ossia quelle entità che ‘vengono fuori’ da ogni attore quando entra in contatto “con questo famoso ‘altrove’, che poi è la scena”, afferma la regista, e così
“per una strana commistione di elementi, per una strana alchimia, tutto coincide: il
tempo, lo spazio, la battuta”14 e prendono vita i personaggi che popoleranno i suoi
‘mondi teatrali’: Mimmo, Nonna Citta, Giammarco, Zia Lucia e Rosalia di mPalermu, e poi Nina, Paride, Toruccio e Ignazio di Carnezzeria; la Madre, Gaspare, Uccio
e Chicco di Vita mia; Gaetano e Salvatore di Mishelle di Sant’Oliva; Rosi, Sara, Moira,
Stellina e Ata di Le pulle.
Ogni spettacolo si produce per autogenesi. Durante le improvvisazioni, la regista annota situazioni e battute che, giorno dopo giorno, concorrono a comporre il
testo scenico. Manuela Lo Sicco, attrice storica della compagnia, dichiara di non
aver mai avuto un copione vero e proprio e di come, piuttosto, la regista ‘scriva
addosso’ agli attori il copione che ha in mente, cercando in tutti i modi di fargli
‘vomitare’ le parole dopo averle fatte entrare nelle loro vene e nei loro muscoli.15 Il
11 Cfr. Linda Dalisi, Messa ”in scena” della mafia. Cani di bancata: il metodo maieutico di Emma Dante,
Dante & Descartes Editore, Napoli, 2009, p. 73.
12 Cfr Andrea Porcheddu e Patrizia Bologna, “La strada scomoda del teatro. Intervista con Emma
Dante”, in Porcheddu (a cura di), Palermo dentro, cit., p. 36. L’esercizio di Vacis prevede che gli attori,
schierati, compiano dodici passi avanti e dodici passi indietro, mantenendo un ritmo costante e
procedendo all’unisono.
13 Ibid.
14 Porcheddu e Bologna, “La strada scomoda del teatro”, cit., p. 53.
15 Manuela Lo Sicco, “Giocare a nascondino in un campo minato”, in Porcheddu (a cura di), Palermo
dentro, cit., pp. 174-175.
212
Carla Russo
testo prodotto è oggetto, a sua volta, di una continua rielaborazione determinata
dalle improvvisazioni successive, dai suggerimenti degli stessi attori, dagli ‘incidenti’ illuminanti che muovono il racconto verso percorsi imprevisti.16
Dunque è la lingua della scena a offrire spunti, a dettare storie e modi di raccontarle.
È il caso degli oggetti di scena, che spesso e volentieri hanno offerto ad Emma
Dante e ai suoi ‘occasione di racconto’. “Per me, gli oggetti, in scena, sono vivi come sono vivi gli attori: gli oggetti sono attori importanti ‒ dichiara, e ‒ se una cosa
è viva, non possiamo prevedere come si comporterà”.17 Anche gli oggetti, dunque,
hanno una loro imprevedibilità scenica, possono essere messi lì, quasi per caso e,
sempre per caso, entrare a far parte del gioco teatrale, come il grosso bidone pieno
d’acqua che ha dato vita alla scena del ‘miracolo dell’acqua’ in mPalermu. Come
racconta la regista, durante la scena della ‘piccola abbuffata’, Giammarco (Sabino
Civilleri) mangia diversi pasticcini con voracità (pasticcini che, durante le prove,
venivano sostituiti con dei ‘mottini’ - piccole brioches): “Mi ricordo quando Sabino
mi chiese l’acqua perché non riusciva più a ingoiare e io presi il bidone che avevamo lì. Non c’era acqua in quel posto e con quel bidone è nata la scena dell’acqua di
mPalermu”.18 Nello spettacolo Le pulle, gli oggetti sono disseminati qua e là e fungono da connettori per le scene che si susseguono o diventano protagonisti nelle
scene corali. Essi prendono vita attraverso l’interazione con gli attori, come nelle
scene del maquillage o della svestizione. Ma ci sono momenti in cui gli oggetti arrivano a ‘dialogare tra loro’, come accade nell’imponente calare delle vele, a suon di
musica e a scena vuota, verso l’epilogo della pièce.
Una parte importante della scrittura scenica è determinata dal codice gestuale
messo in atto dagli attori. Azioni reiterate, come il movimento frenetico e ripetitivo
delle fate e delle pulle, oppure come la scena della vestizione, che apre mPaermu, o
il ballo della pancia di Nina in Carnezzeria. Azioni che, nella loro progressione in
scena, diventano innaturali, talvolta grottesche, superando il limite della semplice
rappresentazione mimetica. È un teatro molto fisico, quello di Emma Dante, dove il
corpo degli attori si offre al pubblico e al racconto senza sconti. Assistiamo a scontri violenti, dove i corpi si fronteggiano fino allo spasimo, si agitano in frenetiche
giravolte e insistite camminate. Questa sfrontatezza nel porsi in scena e davanti al
pubblico è confermata dal modo in cui vengono indirizzati gli sguardi. L’intento di
Emma Dante è di parlare vis-à-vis con i suoi interlocutori, senza filtri, di non temere
il giudizio, ma allo stesso tempo di renderli attivi e partecipi, parte integrante di
ciò che sta per accadere. È per questo che la prospettiva degli spettacoli è e deve
16 Il continuo lavoro di rimaneggiamento operato sul testo è dimostrato da un attento studio di
Anna Barsotti sulla lingua teatrale di Emma Dante, nato dal confronto tra i testi editi e quelli inediti
(Barsotti, La lingua teatrale di Emma Dante, cit.).
17 Porcheddu e Bologna, “La strada scomoda del teatro”, cit., p. 64.
18 Ivi, p. 56.
Costruzione dell’oralità nell’operazione teatrale di Emma Dante
213
essere frontale: la ribalta come ‘confine’, oltre il quale c’è forse il mondo, e il rapporto con l’altrove, con la gente diversa, con un pubblico che guarda, spia e giudica.19
Il gioco col pubblico è evidente ne Le pulle, dove la stessa Dante fa da registaattrice-demiurga che introduce gli spettatori nell’universo scenico, svelando (materialmente, aprendo le vele che percorrono il palcoscenico) le identità e le storie dei
personaggi.
Alla luce di quanto detto finora, è indubbio che i suoi spettacoli siano strettamente connessi al contesto di rappresentazione (sala, spettatori) e che le singole
performance abbiano in sé un carattere di irripetibilità (cambio sala, cambio spettatori). Ma, soprattutto, è evidente che gli spettacoli non possano prescindere da un
rapporto di profonda empatia col pubblico che, nel suo caso, diventa un’ulteriore
unità semantica della scrittura scenica. Riducendo notevolmente la distanza tra
attori e spettatori, s’instaura un tipo di comunicazione diretta e di continuo scambio, una comunicazione soprattutto non verbale che si avvale del linguaggio del
corpo (gesti, movimenti, mimica, sguardi). Il pubblico è ‘invaso’ da stimoli sonori e
visivi che lo involgono nello spettacolo. Stimoli sonori che sono sia di natura musicale vera e propria sia di natura ‘umana’, ossia prodotta dai corpi degli attori e/o
dalla loro interazione con gli oggetti di scena.
La costruzione del personaggio e la struttura della messa in scena nel teatro di
Emma Dante sono principalmente una questione di ritmo: tutto nasce da lì e, affinché il ritmo sia il motore di tutto, la musica è presente fin dalle prime improvvisazioni. E l’attore, una volta recepito e fatto proprio questo ritmo, può anche fare a
meno della musica:
La musica è sempre stata predominante, importante, soprattutto nel momento in cui
veniva tolta. …. Nasce sempre molto come spunto, come impulso, come indicazione,
come portatrice di atmosfere per gli attori per lavorare, per improvvisare e poi,
quando gli attori sono in grado di produrre la musica da soli, la musica gli viene negata. …. In realtà questa musica serve ed è servita a far sentire molto il silenzio, lo
scricchiolio delle ossa degli attori, come diceva Artaud, e gli ingranaggi della scena e
soprattutto la pausa tra una nota e l’altra, che è la cosa più interessante.20
Una lezione che deve ancora a Gabriele Vacis, come dichiara lei stessa, che le ha
insegnato ad ascoltare il silenzio e ad usare il rumore prodotto dagli ingranaggi
della scena, di cui fanno parte anche le ossa degli attori che ‘scricchiolano’: “Mi
insegnò che il corpo poteva parlare, che faceva un rumore e che il rumore poteva
essere un canto”.21 Dunque, musica prodotta dagli scricchiolii delle ossa, dai corpi
che si toccano o che impattano violentemente tra di loro o col palcoscenico, ma
Cfr. Barsotti, La lingua teatrale di Emma Dante, cit., pp. 139-140.
Francabandera, Emma Dante: intervista integrale, cit. (corsivo mio).
21 Porcheddu e Bologna, “La strada scomoda del teatro”, cit., p. 35.
19
20
214
Carla Russo
anche musica prodotta dal silenzio, così caro alla regista. E musica composta per
gli spettacoli, sottoponendo i musicisti di turno ai medesimi stimoli, suggestioni,
situazioni, urgenze a cui la regista sottopone i suoi attori.22
L’uscita dall’isola, la Sicilia, l’approdo verso il mondo dell’altrove e il ritorno
nella terra natia hanno determinato sia le ricerche linguistiche che estetiche di
Emma Dante, la quale, nei suoi spettacoli, fa un uso insistito del siciliano: “Sto
cercando una lingua …. questo dialetto mi spiazza, mi sorprende, perché è una
lingua aperta alle contaminazioni e alle impurità, elastica e viva, tanto che alcune
parole sono intraducibili in italiano”.23 La lingua parlata dagli attori (un misto di
italiano, siciliano e di napoletano) e dalla ‘scena’ è strettamente connessa agli archetipi della cultura siciliana di cui la regista e i suoi lavori sono intrisi: le processioni religiose (Carnezzeria), i rituali mafiosi (Cani di bancata), il matriarcato (Vita
mia). E si riallaccia anche al mito attraverso un’originale rielaborazione della Medea
di Euripide, un allestimento internazionale dell’Alcesti e una ‘intervista impossibile’ al dio del mare, Polifemo.
Nel caso della Medea,24 molti elementi hanno influenzato il lavoro della regista e
l’esito dello spettacolo. Innanzitutto il rapporto conflittuale instauratosi con i due
attori esterni alla compagnia (Iaia Forte e Tommaso Ragno) che ha fatto sì che la
Dante decidesse di tagliare il testo, dandogli una struttura completamente diversa
rispetto all’originale nel tentativo di non ‘tradire’ Euripide. E difatti non lo tradisce,
piuttosto compie “uno spostamento di punto di vista, di sguardo”.25 Il raggio
d’attenzione parte dal personaggio di Medea per estendersi alla città di Corinto.
L’azione drammaturgica si svolge all’interno di una Corinto stracciona costituita
da una porta-chiesa sormontata da una croce e da cinque elementi-parete destinati
via via a trasformarsi in abitazioni, confessionale, sala parto, trono del potere civile
e religioso, parete domestica da dove si spia la realtà esterna in un gioco di luci e
ombre. Il lavoro, diviso in due tempi, ha il suo epicentro ideale in una sala parto,
luogo simbolico per l’inizio della vita e per l’inizio dello spettacolo, dove Medea è
pronta a partorire la sua tragedia. Il secondo tempo ci proietta nell’atmosfera delle
case meridionali, che diventano chiese, confessionali, attraverso il movimento delle
pareti mobili, fatte di finestre e grate, che si chiudono infine in cerchio a formare
22 Ad esempio, per l’allestimento de Le pulle, il compositore Gianluca Porcu era spesso presente ai
laboratori e alle prove proprio per lasciarsi ‘attraversare’ dalle stesse suggestioni e poterle tradurre
adeguatamente in musica.
23 Porcheddu e Bologna, “La strada scomoda del teatro”, cit., pp. 66-67.
24 Medea da Euripide, adattamento e regia di Emma Dante, con Iaia Forte, Tommaso Ragno, Gaetano
Colella, Francesco Villano, Luigi Di Gangi, Stefano Miglio, Alessio Piazza, Antonio Puccia; musiche
composte ed eseguite dai fratelli Mancuso; scene di Fabrizio Lupo; luci di Tommaso Rossi; produzione
“Teatro Stabile Mercadante di Napoli” in collaborazione con “Amat – Associazione Marchigiana
Attività Teatrali”. Il debutto si è tenuto a Napoli, il 28 gennaio 2004, presso il “Teatro Mercadante”. Lo
spettacolo è stato poi riallestito nell’estate del 2013 in una veste nuova.
25 Porcheddu e Bologna, “La strada scomoda del teatro”, cit., p. 72.
Costruzione dell’oralità nell’operazione teatrale di Emma Dante
215
nuovamente una rudimentale sala parto, dove avviene il parto di Medea e, simbolicamente, delle donne di Corinto.
Corinto è “un paese di sole che nasconde un deserto: il deserto è pieno di sole e
non c’è mai acqua” ‒ spiega la regista ‒ “un paese sterile e Medea per me era la
speranza, quella donna barbara era tutto ciò che poteva salvare il paese”.26 La Corinto di Emma Dante è “un paese abitato soltanto da un popolo maschile inadatto a
contenere e a sviluppare il seme”27 e dunque sterile. La sterilità di Corinto è legata
al suo essere totalmente dominata dalla sete di potere. Giasone, dunque, si fa re di
una città sterile e il vero delitto con cui Medea punirà Corinto sarà la negazione
della sopravvivenza, uccidendo gli unici figli che la città potesse sperare di generare. Medea rappresenta per Corinto l’acqua, elemento atto ad irrigare la terra arida
per renderla nuovamente fertile. L’acqua, elemento ossessivo e ricorrente in tutto
lo spettacolo, sigla il finale con la sua ‘presenza’ nella suggestiva scena dei vestitini
stesi ad asciugare.
Un’insolita novità drammaturgica è l’idea di rappresentare Medea incinta. La
Medea di Euripide e del mito è già madre e la scelta della regista siciliana è mirata
ad evidenziare la centralità dell’eroina in quanto donna fertile, capace di decidere
sulle sorti di una stirpe che, senza di lei, è destinata a scomparire.
Il coro, che nel testo di Euripide è affidato alle donne corinzie, è interpretato da
un gruppo di attori di sesso maschile, in modo da rappresentare gli abitanti della
città, popolata da soli uomini. Questa scelta sottolinea l’incapacità di procreare
insita sia nella città che in chi la popola. È proprio attraverso l’elemento-uomo che
si esplica una poetica al femminile, segnata dalla “tragicità del bisogno di maternità e di affetto”.28 Una scelta che, in realtà, rimanda agli allestimenti classici della
tragedia, in cui non era contemplata la presenza di donne in scena e i ruoli femminili venivano interpretati da uomini. Anche se solo leggermente travestiti da donne
(alcuni attori hanno il viso ricoperto da vistose barbe), sono impegnati costantemente in una serie di attività femminili: ricamano corredini, simulano il travaglio,
cullano i bambini, stendono il bucato. Recitano in siciliano, esibendo una straordinaria corporeità, e il testo è completamente riscritto. Al contrario, Medea parla
italiano, come anche Giasone e Creonte, e la sua parte rimane fedele al dettato euripideo. Grazie alle discrepanze linguistiche, si accentua il contrasto tra il grottesco
coro di donne incatenate alla propria persiana-parete e al proprio dialetto e Medea,
straniera in terra straniera.
Ivi, p. 71.
Cfr. Emma Dante, note di regia di Medea, <http://www.emmadante.it> (07/10).
28 Andrea Porcheddu, “La tribù tragica di Emma Dante”, in Porcheddu (a cura di), Palermo dentro,
cit., p. 107.
26
27
216
Carla Russo
Il 28 maggio 2007 debutta a Lucerna al “Luzerner Theater” l’Alkestis, libero
adattamento da Euripide, la cui regia è affidata alla Dante.29 È una nuova occasione
per la regista di confrontarsi col mito dopo l’esperienza di Medea e, ancora una
volta, un mito dalle fattezze femminili, raccontato dal prediletto Euripide. Com’è
noto, si tratta della storia di una donna e del suo sacrificio per un uomo che la lascia consegnarsi alla morte. Ancora un coro di donne, stavolta vestite di nero, nel
mezzo di un arcaico rito carnevalesco. Qui la festa “si confonde col funerale e il
cadavere si festeggia imbandendo la tavola con aragoste e fiori” come già era avvenuto in Carnezzeria.30 Ancora una volta viene toccato l’argomento della morte,
ma “stavolta la morte non la si raggira con il vestito rosso di Vita mia e Alcesti torna in vita come nel disegno euripideo ma vecchia di quarant’anni”: questo è il
prezzo da pagare per aver vinto l’ineluttabile.31
Pochi ma essenziali gli elementi di questa ‘non-scenografia’, per parafrasare la
Cardone: un imponente tavolo rotondo, una Madonna bambina, fiori e cibo. Si
tratta di ‘cose’ messe lì per essere usate e di cui abusare, nella maniera eccessiva
che sempre caratterizza gli spettacoli di Emma Dante.
Il testo si complica ulteriormente attraverso l’incontro-scontro di tedesco e dialetti italiani (siciliano e napoletano). Determinante è l’uso della musica, che spazia
da Mozart ai Chemical Brothers, accompagnando alla perfezione ogni momento
del dramma. Il gioco linguistico, musicale e attoriale fonde sacro e profano, comico
e tragico, consegnando al pubblico tedesco una versione della tragedia euripidea
del tutto fuori dai canoni della tradizione.
Medea e l’Alcesti permettono alla regista di confrontarsi con un classico e, per di
più, con una tragedia. È un’occasione per riflettere sul senso del tragico e di definire cosa sia per lei la tragedia:
Per me la tragedia è qualcosa di ‘antico’, che ha a che fare con un’antichità, con tutte
le generazioni, con la vita e con l’umanità…E soprattutto la tragedia ha a che fare con
il ridere nel pianto. È come una barzelletta che viene detta ad un funerale per
sdrammatizzare …. La tragedia è qualcosa che ha a che fare con la quotidianità, con
un evento straordinario che capita magari quando ti stai mangiando i maccheroni.
Per questo dico che è qualcosa di antico: perché è sempre stato così, non esiste una
29 La riscrittura e la drammaturgia sono curate da Kurt Steinmann e Anke Zimmerman. Per
l’occasione, viene allestito un cast internazionale e della Sud Costa Occidentale partecipano Sabino
Civilleri e Carmine Maringola, gli interpreti di Eracle e Thanatos, che disputano comicamente attraverso
la loro lingua madre. Alcesti è una tragedia a lieto fine, come preannuncia Apollo nel prologo, una sorta
di fiaba. Essa veniva rappresentata alla fine della tetralogia tragica euripidea, composta da Le Cretesi,
Alcmeone a Psofide e Telefo, per risollevare l’animo degli spettatori, incupito dagli eventi tragici (cfr.
Euripide, Alcesti-Eraclidi, trad. it. N. Ruscello, Mondadori, Milano, 1995).
30 Flavia Cardone, “Parla tedesco l’Alkestis di Emma Dante”, Hystrio, 30.3, 2007, p. 61.
31 Ibid.
Costruzione dell’oralità nell’operazione teatrale di Emma Dante
217
tragedia moderna. La tragedia tocca l’essere primitivo, primordiale, non è attualizzabile, è qualcosa di un altro tempo.32
Nel 2008 Emma Dante è impegnata nel progetto Interviste impossibili.33 Per
l’occasione, la regista sceglie come oggetto d’indagine Polifemo, il mitologico gigante monoculare reso celebre dal IX canto de l’Odissea di Omero e dal dramma
satiresco Il Ciclope di Euripide. Il perché di tale scelta lo si evince ascoltando
l’intervista. In scena Emma Dante, nel ruolo di se stessa, e Salvatore D’Onofrio nel
ruolo di Polifemo.34 L’intervista si apre con una battuta di Emma: “È permesso?
Posso entrare?”.35 Siamo nella spelonca in cui abita il ciclope che, interpellato insistentemente dall’intervistatrice, risponde con improperi intimando di essere lasciato in pace. Poi si entra nel vivo della questione ed Emma gli domanda se sia possibile rivolgergli qualche domanda a quattr’occhi. In tal modo scopriamo che il motivo della ‘scelta’ del personaggio mitico risiede nella diversità di Polifemo: interrogandolo, Emma spera di capire qualcosa in più di se stessa e comprendere a fondo il motivo che l’ha spinta a incontrarlo. Riflettendo, Polifemo le ricorda un altro
‘essere’, dotato di un terzo occhio, grazie al quale godere di una visione particolare
della realtà: Carmelo Bene.
Emma nota che Polifemo si esprime con un vistoso accento napoletano e gli
domanda perché, viste le sue origini siciliane. E qui il gigante le fa notare come la
Storia sia “imperfetta, chiéna ‘e sbagli”36 e come questi errori l’abbiamo consegnato
alla Storia come un siciliano.37
Tuttavia Emma gli ricorda che non si può cambiare né la storia né il mito che si
è creato negli anni, quindi Polifemo continuerà a restare siciliano, così come lo ha
descritto anche Enea nel III libro dell’Eneide virgiliana. Ed ecco scatenarsi l’ira di
Polifemo che fa agitare il Vesuvio e fa fuoriuscire vapori dal cratere. Si rinnova la
maledizione-invocazione (pronunciata in siciliano) di Polifemo rivolta a suo padre
Poseidone contro Ulisse, che da vero eroe ebbe il coraggio di rivelare la propria
identità.
Porcheddu e Bologna, “La strada scomoda del teatro”, cit., p. 73.
Interviste impossibili, regia di Gabriele Vacis e scenografie di Roberto Tarasco, Auditorium "Parco
della Musica", Roma, aprile 2008. Il gioco è stato il medesimo di quasi quarant’anni prima: si è chiesto
ad una nuova schiera di autori di scegliere un personaggio storico, mitologico, letterario o immaginario
cercando di identificare non un nome qualsiasi, ma il ‘loro’ personaggio a cui porre delle domande.
34 I due attori sono dotati ciascuno di un leggio, unici elementi scenici oltre alle immagini proiettate
alle loro spalle, raffiguranti Polifemo così come l’arte, nei secoli, lo ha consegnato alla Storia (un
mosaico, un disegno, …).
35 Il video dell’intervista di Emma Dante a Polifemo, registrato durante la serata del 28 aprile 2008, è
visibile su <http://www.airots.it> (09/13). Da tale ripresa sono estrapolate le battute citate di seguito.
36 “imperfetta, piena di sbagli”.
37 Polifemo, più avanti, esclama: “Signò, v’aggia deludere, ‘o saccio, ma io so’ sempe state ‘e
rimpetto ai Campi Flegrei” (“Signora, devo deludervi, lo so, ma io ho sempre abitato di fronte ai Campi
Flegrei”), rivelando le sue origini partenopee.
32
33
218
Carla Russo
Le parole di Polifemo sono accompagnate da una musica dolce di sottofondo:
una voce femminile canta, poi la tensione cresce, scandita dal suono ritmico di un
tamburo. Il linguaggio di Polifemo si mescola, passando repentinamente dal napoletano al siciliano, in una sorta di ibridazione del personaggio e del mito stesso.
Polifemo racconta l’episodio che lo vide coinvolto con Ulisse, fino al tranello con
cui l’eroe omerico lo accecò. Il vulcano tuona e si scopre che quella che si credeva
fosse una spelonca è in realtà la testa del gigante: Emma è entrata dal suo occhio
andato distrutto e la pietra posta all’ingresso è la mezza palpebra bruciacchiata.
Attraverso la sua operazione teatrale, Emma Dante è ‘entrata’ letteralmente nel
mito per carpirne il suo senso profondo e restituirlo a noi spettatori, epurato da
ogni forma di contaminazione sedimentata nel tempo che ne impediva una visione
‘pura'. Polifemo esclama: “Signò, io sono orbo, ma veco ‘o stesso tutte cose. …. Che
‘o veco a ffà o mare? Lo conosco a memoria comme è fatto, m’abbasta! …. Il mio
unico occhio, come quello delle bestie, fissava tutte le cose da un unico punto di
vita: chillo d’o bbene”.
È uno sguardo puro, pulito, privo di giudizio e di sovrastrutture, lo stesso
sguardo con cui Emma Dante guarda la realtà che racconta attraverso il suo teatro
e che chiede di avere anche ai suoi attori. Il suo intento non è di ‘fare cronaca’, né
di esprimere giudizi in merito agli argomenti trattati, ma piuttosto di rispondere a
delle urgenze che sente dentro di sé, di raccontare storie necessarie, con lo sguardo
pulito di un bambino, che “sgrana gli occhi e vede. È capace di vedere anche
l’orrore, magari senza giudicarlo; questa è la cosa interessante, no? Dell’infanzia. Il
tuo giudizio è bandito e quindi è puro, è sincero”.38
38
Francabandera, Emma Dante: intervista integrale, cit.
SILVIA DE MIN
UNA VOCE CHE CONTIENE TANTE VOCI
Quale effetto produce, in scena, una voce sola che contiene tante voci?
Quasi d'istinto viene da pensare a un effetto narrativo, anche soltanto per
l'evidente rottura del meccanismo dialogico mimetico: l'elemento teorico cardine è
la gestione dei molteplici punti di vista da parte dello sguardo del singolo,
questione narratologica che, nel linguaggio teatrale, viene ad intersecarsi con le
possibilità della visione. Ma per capire cosa qui si intenda per 'effetto narrativo' a
teatro, converrà riflettere attorno ad alcuni nodi teorici.
La voce che contiene più voci distribuisce i materiali drammaturgici su almeno
due livelli, che potrebbero corrispondere alle categorie di ‘modo’ e ‘voce’ individuate da Gérard Genette in Figure III.1 Se il ‘modo’ risponde alla domanda 'chi
vede?', ossia 'qual è il personaggio il cui punto di vista orienta la prospettiva narrativa?', alla ‘voce’ Genette fa corrispondere la domanda 'chi parla?'. È chiaro che tra
le due possibilità non sempre c'è corrispondenza: colui che vede non è necessariamente colui che parla, ma può accadere per esempio che chi parla sia un narratore
esterno che assume il punto di vista di un personaggio.
Le voci sole in scena, che non danno luogo a un'azione monologante di stampo
mimetico, ma che riproducono drammaturgie complesse, sfruttano proprio le possibilità modali e vocali dei processi narrativi per distribuire parole e azioni drammatiche nelle possibilità del linguaggio e della visione teatrale. I meccanismi della
narrazione vengono recuperati non soltanto quando la voce si misura con racconti
nati in forma scritta e poi adattati per la trasposizione orale, ma anche ‒ cosa che
qui interessa particolarmente ‒ quando essa assorbe e contiene da una parte porzioni dialogiche pensate per più voci, dall'altra i riferimenti didascalici.
In quale rapporto si pone la voce che contiene più voci con la voce monologante? È forse la prima una possibile declinazione della seconda? Alla questione, che
pure porterebbe lontano, conviene fare breve cenno. Claudio Meldolesi, dopo aver
definito le nuove forme di scrittura per la scena come forme prive di personaggi e
dialoghi reali, diceva:
Il monologo è la matrice della drammaturgia contemporanea. Può essere trasposto in
dialoghi, anche molto fitti, ma resta un momento di testimonianza dell'autore … Tutte le poetiche del Novecento si declinano sul monologo ... Il monologo è la scrittura
1
Gérard Genette, Figure III. Discorso del racconto, Einaudi, Torino, 2006.
220
Silvia de Min
più prossima all'autore, il dramma è un monologo dell'autore le cui articolazioni sono affidate a questo o a quel personaggio.2
La riflessione si aprirebbe quindi alla potenziale 'polivocalità' che in scena può
concretizzarsi tanto nella distribuzione dialogica a più voci, quanto nella voce sola:
quello che è certo è che la mente dell'autore è in grado di ospitare il sovraffollamento vocale, un'oralità complessa e multiforme che ritroverebbe la coesione originaria proprio nella forma performativa monologante.3 Benveniste, con estrema
chiarezza, sosteneva che il monologo si pone come variante di un dialogo che lo
struttura almeno a livello mentale: “Le ‘monologue’ procède bien de l'énonciation.
Il doit être posé, malgré l'apparence, comme une variété du dialogue, structure
fondamentale. Le ‘monologue’ est un dialogue intériorisé, formulé en 'langage
intérieur', entre un moi locuteur et un moi écouteur”.4
L'io scenico presupporrebbe quindi un contesto comunicativo che può essere
pensato a più voci. Dal monologo si arriva con un solo passo al monologo interiore
e ci sono senz'altro alcune caratteristiche delle drammaturgie complesse contenute
nella voce sola che andrebbero valutate senza perdere di vista questa grande categoria. Non ultimo il fatto che la voce sola in scena tenda sempre più a farsi carico
non tanto di uno sviluppo drammatico coeso, di un'azione drammatica che si sviluppa dall'inizio alla fine attraverso le relazioni tra i personaggi, quanto di una
sovrapposizione vocale che non necessariamente segue il filo logico della coerenza
narrativa (si parlerà in seguito di de-narrativizzazione). Dujardin, concludendo la
sua ricognizione sullo statuto del monologo interiore nei romanzi, apriva al teatro
con le parole che seguono e che torneranno utili nelle conclusioni:
Ci si può chiedere se, dopo aver occupato un tale posto nel romanzo, il monologo interiore non sia stato chiamato a entrare anche nel teatro o, per meglio dire, a rinnovarlo. Niente impedisce di immaginare, durante un dialogo, una serie di monologhi
'dissimulati' che sarebbero diversi dai monologhi 'dissimulati' di Racine per il fatto
che, invece di essere la traduzione razionalizzata del pensiero del personaggio, lo
esprimerebbero anteriormente alla sua organizzazione logica, cioè allo stato nascente
e nella sua apparente immediatezza – in altri termini, in cui il personaggio lascerebbe
parlare così come sono, durante il dialogo, le voci aggrovigliate del suo cuore.5
Ma andiamo un po' oltre. Si è detto, qualche riga sopra, che la voce che contiene
drammaturgie complesse può farsi carico non solo degli scambi dialogici, ma an2 Teatro Aperto (a cura di), Il teatro nascosto nel romanzo. Atti del convegno Walkie-Talkie 2004, Il
principe costante, Milano, 2005, p. 31.
3 Alcuni spunti molto interessanti a questo proposito si trovano nel numero monografico “L’autore
come performer” in Gerardo Guccini, Nicoletta Lupia (a cura di), Prove di drammaturgia, 18.1, Titivillus
Edizioni, Corazzano (Pi), 2013.
4 Émile Benveniste, “L'appariel formel de l'énonciation”, Langages, 17, 1970, pp. 12-18. Qui p. 16.
5 Eduard Dujardin, Il monologo interiore, Pratiche Editrice, Parma, 1991, p. 84.
Una voce che contiene tante voci
221
che dei riferimenti didascalici. Gerardo Guccini, in una riflessione sulle didascalie
teatrali, scrive a proposito dell'Orestea di Eschilo:
Nella parte iniziale della terza tragedia figura il dialogo fra Clitemestra e le Erinni,
che contiene le più articolate didascalie esplicite del teatro greco. Non è assolutamente detto che queste indicazioni di suono – mugolio, mugolio, gemito, gemito, stridulo
mugolio ripetuto – siano state scritte da Eschilo, anzi è quasi certo che siano opera di
un trascrittore. (….) Quali elementi della drammaturgia eschilea hanno fatto sì che il
trascrittore sentisse il bisogno di integrare le didascalie implicite del testo con un seguito di didascalie esplicite? (….) Inserendo con funzione di battuta un seguito di didascalie esplicite, il trascrittore riporta, dunque, alla rasserenante formula del dialogo
questa alternanza di espressioni linguistiche e gemiti animali. …. La didascalia del
tardo trascrittore bizantino ripristina la forma dialogica. E cioè legge “come se” fosse
un dialogo.6
L'idea di una forma dialogica rassicurante è interessante se applicata proprio
agli esiti moderni di cui ci stiamo occupando: la complessità drammaturgica e, in
alcuni passaggi, la necessaria mediazione narrativa fanno sì che la voce che contiene tante voci e tanti modi (prospettive e distanze) si ponga come rassicurante sopravvivenza di complessità drammatica, quasi a bilanciare l'egolatria performativa
fine se stessa.
Proprio dell'Orestea c'è stata una recente riscrittura e riduzione per voce sola:
Radio Argo, di Peppino Mazzotta (attore e regista dello spettacolo) e Igor Esposito
(autore del riadattamento). In scena c'è un unico attore per sei personaggi e una
voce radiofonica che fa da collante narrativo tra i diversi episodi: i giochi teatrali
con la 'voce' (chi parla) e il 'modo' (chi vede) diventano possibilità contemporanee
di contenere il serial tragico. Le singole soggettività costruiscono non tanto un racconto lineare, ma porzioni di esso, testimonianze e slanci emotivi intersecati e sovrapposti. Lo spettacolo potrebbe essere un radiodramma: è la voce del radiocronista che calibra i tempi, riannoda e commenta le situazioni, accompagna gli spettatori/ascoltatori nelle vicende che scaturiscono dai suoi raccordi narrativi e che danno voce diretta a protagonisti antichi ‒ privati di un certo fatalismo e caricati piuttosto di quell'individualismo contemporaneo che forse è il nuovo volto della tragedia. La radio popolare diventa, dunque, specchio contemporaneo del coro classico.
La voce del radiocronista contiene tutte le voci ed è possibile immaginare che sia il
suo racconto, la sua voce appunto, ad evocare discorsi che si fanno in scena carne,
corpo e interpretazione di fantasmi, vittime e assassini, di potere e di ribellione.
Per concludere questa prima parte prevalentemente teorica, va fatto un altro riferimento a due categorie che Genette descrive in Palinsesti, la 'vocalizzazione' e la
6 Gerardo Guccini, “Tre insegnamenti didascalici: Eschilo, Sardou, Beckett”, Ampio raggio. Esperienze
d'arte e di politica, 4, 2012, pp. 55-73. Qui pp. 60-61.
222
Silvia de Min
'devocalizzazione',7 per spiegare le quali, nel concreto uso drammaturgico, converrà rifarsi a un paio di esempi: il celebre Koholhaas di Marco Baliani e Piazza d'Italia,
ancora di Baliani, tratto dal romanzo di Tabucchi, due spettacoli molto diversi tra
loro, fosse anche soltanto per la presenza dell'attore solo in scena nel primo e per la
'compagnia recitante' nel secondo.
In Koholaas Baliani non mette sempre in bocca ai personaggi parole in forma di
dialogo diretto, eppure il suo testo, nella veste grafica, risulta distribuito tra i vari
personaggi. Tale scansione non ha a che fare con l'assunzione in voce diretta (cioè
del personaggio che dice ‘io’), ma sembra essere fatta in base alla focalizzazione
che l'attore assume nel raccontare i vari passaggi della storia: la narrazione rimane
in terza persona, ma il narratore si posiziona idealmente, di volta in volta, alle spalle del personaggio di cui sta parlando, assumendone il punto di vista.
Che tipo di operazione fa invece Baliani sul romanzo di Tabucchi per renderlo
rappresentabile a teatro? Il romanzo racconta le vicende di tre generazioni di una
famiglia di un borgo toscano, dalle imprese garibaldine alle due guerre mondiali,
fino agli anni '60. Baliani mette in scena un teatro di narrazione corale, in cui tutti i
personaggi raccontano le proprie vicende in forma diegetica, senza quasi mai
scambiare battute di dialogo con gli altri personaggi sulla scena e tenendo lo
sguardo rivolto al pubblico.
Baliani rimane aderente al romanzo, ma lo destruttura vocalmente, affidando ai
personaggi coinvolti nella vicenda le diverse parti: egli opera sul testo effettuando
una 'vocalizzazione', ossia un “passaggio dalla terza alla prima persona”.8 Parafrasando Genette, questa 'trasposizione vocale' non viene fatta coincidere con una
'trasposizione modale', ossia con un evidente cambio di focalizzazione: l'impressione è di trovarsi dinnanzi a personaggi che dicono 'io', ma che forniscono le informazioni come se ciascuno di loro fosse un narratore onnisciente, quasi ci fosse
un'unica voce ideale (quella di Tabucchi) capace di contenerle tutte. Si tratta quindi
di un'operazione uguale e contraria rispetto a quelle di cui stiamo tentando di dare
qualche lettura. È intuitivo che la ‘devocalizzazione’ sia, rispetto a quello visto, il
passaggio inverso, dalla prima alla terza persona.
La voce sola in scena, quando contiene drammaturgie complesse, terrà quindi
continuamente conto di possibilità modali e possibilità vocali, di vocalizzazione e
devocalizzazione.
Esulando per un momento dalle voci sole, destano un certo interesse le parole
che Ronconi usa per descrivere lo stato degli attori nel momento in cui hanno a che
fare con del materiale narrativo, quando cioè porzioni di racconto (diegetiche)
vengono assunte dal discorso dei personaggi, che sempre più, nelle scene contemporanee, perdono il loro statuto completamente mimetico e diventano voci in gra7
8
Gérard Genette, Palinsesti: la letteratura al secondo grado, Einaudi, Torino, 1997.
Ivi, p. 348.
Una voce che contiene tante voci
223
do di contenere porzioni di racconto su di sé. Ronconi chiama stato di ‘bilocazione’
quell'oscillazione tra narrazione e azione ‒ a tutti gli effetti un'oscillazione tra due
tempi ‒ in cui si trova l'attore:
Le prospettive e le condizioni del percorso sono differenti sia da quelle del teatro di
estraneazione che da quelle del teatro di immedesimazione. Non è una semplice
oscillazione tra la prima e la terza persona. È la necessità di controllare con continuità, durante lo spettacolo, i propri meccanismi percettivi e quelli del pubblico, in virtù
di questa bilocazione. L'attore è tenuto ad avere una soglia di attenzione e una vigilanza estremamente alte perché sa che è impossibile proporre allo spettatore un'identificazione con “due persone” contemporaneamente presenti.9
Senza richiamare il celebre Pasticciaccio, tutto evidentemente giocato su questi
piani, è interessante vedere questo tipo di lavoro nel recente rapporto con l'opera
di Spregelburg, un'opera tra l'altro dai molti punti di contatto con la pratica narrativa, fosse solo per la gestione di intrecci e per il montaggio non lineare degli episodi. Ne Il panico, per esempio, Ronconi, almeno in un paio di passaggi, fa uscire
l'attore dal personaggio e lo rende narratore del personaggio stesso in terza persona, mettendogli in bocca il materiale narrativo già pronto nel testo: le didascalie. A
questo punto è quasi ovvio che questo stato di bilocazione, di oscillazione tra mimesi e diegesi e tra stati temporali diversi, si ritrovi nelle voci sole che contengono
drammaturgie complesse.
Passando ora all'analisi di alcuni casi concreti, si proporrà, per comodità, una
bipartizione: si prendono un paio di possibili declinazioni di un fenomeno evidentemente più complesso e vario.
La voce che contiene più voci può esprimersi, in primo luogo, attraverso la tecnica del doppiaggio: la pratica del 'narratore che fa le voci' imitandole è prassi antica, ma i due spettacoli a cui qui si farà cenno, in tempi recenti, sono ricorsi a questa
tecnica con implicazioni narrative (o de-narrativizzanti) interessanti.
Eduardo De Filippo registrò la propria voce per La tempesta shakespeariana da
lui tradotta in napoletano e poi messa in scena con le marionette dei Colla, in occasione della Biennale di Venezia del 1985. Scriveva Eduardo:
Ho cercato di essere il più possibile fedele al testo […], ma non sempre ci sono riuscito. Talvolta, specie nelle scene comiche, l'attore in me si ribellava a giochi di parole
ormai privi di significato e allora li ho cambiati; altre volte ho sentito il bisogno di
aggiungere alcuni versi per spiegare meglio a me stesso e al pubblico qualche concetto o per far risaltare il grande amore protettivo di Prospero per Miranda. [...] Ariele
conserva il suo carattere sbarazzino e poetico, ma mi è venuto naturale farlo comportare, di tanto in tanto, come uno scugnizzo furbo e burlone. Quanto al linguaggio,
9
Teatro Aperto, Il teatro nascosto nel romanzo, cit., p. 92.
224
Silvia de Min
come ispirazione ho usato il napoletano seicentesco, ma come può scriverlo un uomo
che vive oggi.10
Nella traduzione vi è dunque una forte istanza autoriale e, soprattutto, attoriale.
Nella registrazione, la voce di Eduardo fa tutte le voci (tranne la voce femminile di
Miranda che è di Imma Piro), usa sfumature e intenzioni, ma mai storpiature, varia
ma non si sottrae al riconoscimento, accogliendo piuttosto lo spettatore nel suo
straordinario impasto vocale. Recuperando le categorie precedentemente illustrate
si potrebbe dire che siamo dinnanzi a una voce che contiene molti modi (posizionandosi alle spalle dei personaggi, ma rimanendo se stessa). L'effetto sonoro è
proprio quello di un cantastorie, un aedo che la contemporaneità ha registrato:
l'affascinante mondo favoloso della Tempesta, i motivi da romance, trovano con
Eduardo la dimensione popolare del racconto orale.
Con il secondo esempio siamo dinnanzi a un esito quasi opposto, che pure si
ispira alla tecnica del doppiaggio e che prevede l'assunzione vocale, da parte di un
unico attore, di tutte le voci: Him, un lavoro dei ravennati Fanny&Alexander, parte
del progetto dedicato a Il mago di Oz. L'attore Marco Cavalcoli, solo in scena nei
panni del piccolo Hitler di Cattelan, doppia il film Il mago di Oz (Fleming, 1939) che
scorre alle sue spalle: il mago di Oz viene pensato dalla compagnia come l'attore
per eccellenza, l'usurpatore di tutti i ruoli, non a caso nei panni di Hitler. L'attore,
che recita in un gramelot americano-inglese, è abbandonato a ritmi, a tempi, al rumorismo del film. Dal sito della compagnia si legge:
La comicità scaturisce proprio dall’impossibilità di poter doppiare effettivamente tutto e quindi dalla necessità di selezionare, volta a volta, le parti e i punti a cui dare voce. È come se il piccolo dittatore-direttore fosse 'parlato' dal film. Egli adatta ai propri
toni una differente modalità per ognuno dei personaggi e degli eventi del film, in
un'esilarante miscela performativa che da un lato esalta il susseguirsi della narrazione del film, dei colpi di scena, delle battute, mentre dall'altro vi aggiunge la vitalità
che è caratteristica dei modi e dei ritmi propri del teatro.11
In questo spettacolo quindi l'idea della voce che contiene tutte le voci ha un risvolto non solo estetico, ma diventa anche una sorta di denuncia artistica: l'attore
onnivoro domina la narrazione, anche quella più pura, la mastica e la distrugge,
portando a compimento quanto Benjamin diceva nel 1936: “l'arte del narrare volge
al tramonto perché il lato epico della verità, la saggezza, vien meno”.12 Il filo del
discorso subisce un processo di denarrativizzazione nel momento in cui viene inglobato dalla vocalità.
10 William Shakespeare, La tempesta, traduzione in napoletano di Eduardo De Filippo, Einaudi,
Torino, 1984, pp. 186-187.
11 <http://www.fannyalexander.org/archivio/archivio.it/him_home.htm> (01/2014).
12 Walter Benjamin, Il narratore: considerazioni sull'opera di Nikolaj Leskov, in Id., Angelus Novus: saggi e
frammenti, Einaudi, Torino, 1995, p. 251.
Una voce che contiene tante voci
225
Se Eduardo prestava quindi la sua voce a tutti i personaggi, enfatizzando la
presenza attoriale nel potenziale vocale, al contrario, la bulimia vocale di Him
schiaccia l'attore Cavalcoli che di fatto presta alla scena il proprio corpo e la propria voce, rendendosi quanto mai vicino a una marionetta.
Due esiti dunque estremi che pure possiamo affiancare riscontrando il medesimo principio nell'uso della voce sola; tra l'altro, sia in Him che nella Tempesta, assistiamo a una separazione netta tra la voce e l'immagine: come dire che il potenziamento dell'apparato vocale tende normalmente ad esprimersi in realizzazioni che
propongono una separazione netta tra vocale e visuale.
A questo proposito una seconda strada che il teatro contemporaneo percorre ha
a che fare con la voce sola in scena che costruisce drammaturgia proprio nel rapporto voce-figura.
La cosa appare evidente in tutto il teatro di marionette o burattini, ma la Semplicità ingannata di Marta Cuscunà propone soprattutto un nuovo modo per il teatro
di narrazione. Ad ispirare la giovane autrice e attrice friulana è una storia di monacazione forzata, dove la vitalità di una mente femminile (quella di Arcangela Tarabotti) e l'intelligente solidarietà tra donne diventano fermento di Resistenza nella
seconda metà del Seicento. I materiali di partenza sono quindi legati a una storia
locale che diventa perno narrativo e simbolo di un messaggio politico. Lo spettacolo procede per cellule narrative che si dispongono una dopo l'altra, affiancando
molteplici possibilità del racconto: il montaggio della Cuscunà prevede parti diegetiche e porzioni di assunzione drammatica pura, mescolando la storia passata con
modi e linguaggi profondamente contemporanei. La seconda parte dello spettacolo
è tutta costruita con assunzioni di voce da parte delle cosiddette pupazze: sei burattini basculanti, sei monache, che l'attrice fa parlare con sei sfumature di voce
diverse. La vitalità e gli scambi dialogici tra i pupazzi sono un momento di eccezionale moltiplicazione vocale: esempio perfetto di drammaturgia complessa contenuta nella voce sola, per una proposta che è un passo oltre il teatro di narrazione,
con le possibilità del teatro di figura.
Per la Cuscunà il lavoro di scrittura e di composizione è un lavoro di accumulo,
di esercizi di stile capaci di creare situazioni sulla base di alcuni protocolli: le situazioni nascono dalla necessità di non cadere nella narrazione pura, a suo avviso non
sufficientemente efficace per contenere informazioni; i protocolli sono quelli di José
Sanchis Sinisterra, maestro della Cuscunà, che fornisce modelli drammaturgici per
la gestione del materiale narrativo, funzionanti in modo quasi scientifico. Le possibilità linguistiche vengono codificate negli stili narrativi che si sottraggono al filo
del racconto e che, nella voce, si esprimono con libertà di accumulo e sovrapposizione.
Avviandoci alla conclusione, converrà riprendere quanto si è detto all'inizio:
una drammaturgia complessa assunta dalla voce sola in scena produce un 'effetto
narrativo' (tanto che molti degli spettacoli a cui qui si è fatto cenno, una volta eti-
226
Silvia de Min
chettati come ‘teatro di narrazione’, sembrano perdere completamente interesse). È
giusto parlare di 'effetto' e non di narrazione perché proprio l'oralità della scena ha
spinto verso drammaturgie che, pur utilizzando forme della narrazione, non hanno
certo come primo obiettivo la costruzione di una narrazione coesa. La complessità
vocale è mimetica del procedere orale della mente, capace di contenere quelle che
Dujardin ha chiamato “le voci aggrovigliate del cuore”.13 Ecco perché la voce che
contiene tante voci presuppone una scrittura performativa, una testualità pensata,
non solo nel suono ma anche nel montaggio, per essere detta ad alta voce.14 La
questione è più ampia e si pone sul crinale degli studi tra narrativa e drammaturgia, nonché di un dominio dell'oralità nelle pratiche di scrittura contemporanea.
Scrive a tal proposito Gabriele Frasca:
La 'civiltà della scrittura' non è, contrapposta all'oralità, una 'cultura del silenzio'
quanto piuttosto della 'voce disincarnata', e le sue fasi si caratterizzano in relazione a
quanto risuoni anche all'esterno, o mormori solo all'interno, tale voce. Da questo
punto di vista, buona parte dei media elettrici più che richiamare un'oralità performativa rappresenta in verità una forma di scrittura intensamente vocalizzata.15
In un contesto in cui si parla di oralità, si concluderà qui con un ancoraggio alla
scrittura, chiamando in causa un autore che riuscì a contenere nella sua opera,
narrativa e teatrale, molte delle dinamiche di cui si è parlato: Samuel Beckett. Si
proporrà qui un solo esempio della sua scrittura performativa: quello che segue è
l'inizio di Company (1979), una delle prose brevi più tarde che compongono la cosiddetta 'seconda trilogia':
Giunge una voce a qualcuno nel buio. S'immagini.
A qualcuno sul dorso nel buio. Ciò glielo comprova la pressione sulle parti posteriori
e il modo in cui muta il buio quando serra gli occhi e quando di nuovo li riapre. Solo
una minima parte di quanto viene detto può essere verificata. Per esempio, quando
sente, Tu sei sul dorso nel buio. Allora non può che riconoscere la verità di quanto
viene detto. Ma di gran lunga la maggior parte di quanto detto non può essere verificata. Come per esempio quando sente, Tu vedesti la luce quel tale e quel tal altro
giorno. A volte le due si combinano come per esempio, Tu vedesti la luce quel tale e
quel tal altro giorno e adesso sei sul dorso nel buio. Magari un trucco così che l'incontrovertibilità dell'una guadagni credito all'altra. Eccola dunque la proposizione. A
qualcuno sul dorso nel buio una voce racconta di un passato. Con qualche occasionale allusione a un presente e più raramente a un futuro come per esempio, Tu finirai
così come ora sei. E in un altro buio o nello stesso un altro a escogitare il tutto per
compagnia. Via lasciamolo perdere.
Dujardin, Il monologo interiore, cit., p. 84.
Roland Barthes parlava proprio di “scrittura ad alta voce”, da includere in un'ipotetica estetica del
piacere testuale. Cfr. Roland Barthes, Variazioni sulla scrittura seguite da Id., Il piacere del testo, Einaudi,
Torino, 1999.
15 Gabriele Frasca, La lettera che muore. La “letteratura” nel reticolo mediale, Meltemi, Roma, 2005, p. 63,
n. 11.
13
14
Una voce che contiene tante voci
227
Contraddistingue la voce l'impiego della seconda persona. Quello della terza quell'altro canchero. Potesse parlare quello a cui e di cui parla la voce ci sarebbe una prima.
Ma non può. Non lo farà. Non puoi. Non lo farai.16
La situazione descritta è chiaramente performativa, già dalla prima indicazione
didascalica che, come per tutto il testo, dobbiamo immaginare sia detta ad alta
voce: l'unica voce che sentiamo porta su di sé una stratificazione pronominale e, in
altri passaggi del testo, porzioni di discorso che sembrano appartenere a terzi.
Aprire qui il discorso su Beckett porterebbe troppo lontano, ma è da una scrittura
come la sua, capace di contaminare i generi drammatico-narrativo, che può essere
interessante ricostruire un percorso che porta alle possibilità della scena contemporanea.
È abbastanza chiaro che la prima caratteristica di una scrittura performativa,
una scrittura che chiede di essere vocalizzata, chiude il cerchio con l'argomento di
questo contributo: si tratta infatti della scrittura di una voce che contiene tante voci.
Il cortocircuito tra oralità e scrittura è stato innescato e da qui si potrà ripartire.
16
Samuel Beckett, In nessun modo ancora, Einaudi, Torino, 2008, pp. 3-4.
228
Silvia de Min
VERA CANTONI
TESTUALMENTE: L’ELABORAZIONE DRAMMATURGICA
DELLE FONTI NEL TEATRO VERBATIM
Per sua natura il teatro, in quanto arte i cui ‘materiali’ sono esseri umani in carne e ossa, fonde realtà e finzione e questo legame, stretto e ambiguo, è stato indicato quasi costantemente come un aspetto sostanziale della sua forza nonché della
sua pericolosità. Nel Novecento tale liaison dangereuse ha acquisito ulteriore complessità con il moltiplicarsi di forme di teatro documentario, in cui la rappresentazione dell’attualità o della storia si basa sull’accurata raccolta di testimonianze e
dati. Tale lavoro di indagine dà all’opera che ne deriva un particolare potere di
persuasione e per questo ha caratterizzato la produzione di drammaturghi che
ambivano a influire sulla realtà.
Il teatro documentario ha poi visto una considerevole espansione a partire dagli
anni Novanta,1 nel contesto di un più ampio interesse per la funzione testimoniale
dell’arte. Infatti un’evoluzione tecnologica che permette sia la creazione di sempre
più ingannevoli realtà virtuali sia la diffusione immediata e capillare di notizie
spesso in contraddizione fra di loro ha messo in luce i limiti della distinzione vero/falso. Ciò ha stimolato da un lato un diffuso bisogno di verità, ineludibile al
punto di accogliere paradossalmente l’artificio dei reality show, dall’altro il proliferare di opere d’arte imperniate, tematicamente e formalmente, su questa ambigua
opposizione, oltre a un rinnovato interesse per generi prima considerati marginali
come il documentario cinematografico.2
Sulla scena londinese questo orientamento si è espresso in particolare con la diffusione del teatro verbatim, caratterizzato, come suggerisce il termine, dal riportare
testualmente le parole delle sue fonti: una specificità che all’apparenza restringe
fortemente il campo d’azione degli autori, ma invece è stata declinata in forme
molto varie, dimostrando che testi di questo tipo, pur non prevedendo una scrittura nel senso abituale, richiedono un fondamentale intervento drammaturgico per
portare in scena discorsi concepiti con altri scopi.
1 Cfr. il numero monografico “Teatro e informazione”, in Gerardo Guccini (a cura di), Prove di
drammaturgia, 14.1, Titivillus Edizioni, Corazzano (Pi), 2008, che comprende anche un’introduzione al
teatro verbatim (Delia Giubeli, “Verbatim Theatre. Nuova voce della scena politica inglese”, pp. 32-35) e
una riflessione sul ruolo che l’intervista acquista in questo genere di drammaturgia (Tara McAllisterViel, “Passato e futuro del Verbatim Theatre”, pp. 36-37).
2 Per un’analisi sintetica di questa tendenza cfr. Ursula Canton, Biographical Theatre: Re-Presenting
Real People?, Palgrave Macmillan, Basingstoke (UK), 2011, pp. 2-3; per una più dettagliata discussione
del rapporto fra teatralità e realtà nel ventunesimo secolo, cfr. Janelle Reinelt, “Towards a Poetics of
Theatre and Public Events: In the Case of Stephen Lawrence”, TDR, 50.3, 2006, pp. 69-87.
230
Vera Cantoni
Oltre che a livello quantitativo,3 il fenomeno del teatro verbatim appare quindi
significativo sul piano teorico, giacché rappresenta una nuova frontiera della scrittura scenica, in cui la parola recitata nasce dall’elaborazione di una precedente
espressione diretta, generalmente anch’essa orale.
Le fonti
I temi del teatro verbatim sono sostanzialmente di impegno civile, legati ora alla
politica internazionale (Srebrenica di Nicolas Kent, 1996; The Arab-Israeli Cookbook di
Robin Soans, 2004) e soprattutto a vari aspetti della cosiddetta guerra al terrorismo
(Justifying War di Richard Norton-Taylor, 2003; Rendition Monologues di Christine
Bacon, 2008), ora a problemi sociali, per esempio il razzismo istituzionale (The Colour of Justice di Richard Norton-Taylor, 1999), la povertà (Broke di Christine Bacon,
2009) o le difficoltà di una comunità multietnica (Mixed Up North di Robin Soans,
2009).
I testi evocano prospettive sia pubbliche che private, dando voce a personaggi
che sono al tempo stesso individui, portatori di un proprio vissuto, e figure rappresentative di una determinata condizione (per esempio in On a Clear Day You Can
See Dover, scritto da Sonja Linden nel 2010, Hussein è un individuo, ma anche un
esempio di richiedente asilo); oppure affiancano alle testimonianze dei diretti interessati quelle di chi ha affrontato la stessa questione sul piano professionale (come
lo psicologo in Talking to Terrorists di Robin Soans, 2005).
I discorsi riportati possono avere in effetti le provenienze più diverse, dalle dichiarazioni ufficiali di figure politiche alle confidenze di emarginati sconosciuti.
Fra le molte distinzioni possibili, due appaiono specialmente significative: la fonte
può derivare da un contesto pubblico o privato e può avere avuto in origine
un’altra funzione oppure essere stata creata ad hoc. Entrambe le differenze influiscono sul rapporto fra la parola e la sua messa in scena. Benché le diverse possibilità costituiscano all’apparenza un continuum di crescente distanza fra la situazione
in cui i discorsi sono nati e quella drammatica a cui approdano, esse formano piuttosto un quadrato di combinazioni:
FONTI
preesistenti
ad hoc
pubbliche
conferenze stampa, verbali
inchiesta ufficiosa
private
diari, lettere
colloqui
3
Si contano più di 50 drammi verbatim di rilievo negli ultimi venti anni.
Testualmente: l’elaborazione drammaturgica delle fonti nel teatro verbatim
231
Il caso più semplice è costituito dall’uso di documenti di pubblico dominio e dichiarazioni ufficiali, prodotti dunque in vista di una diffusione e spesso nel contesto di una sorta di performance, sebbene non teatrale, come una conferenza stampa
o un dibattito parlamentare. Particolarmente frequentati sono i verbali giudiziari,4
che offrono al tempo stesso garanzie di affidabilità e un’efficacia drammatica testimoniata dal successo delle trame processuali anche nei generi di finzione. In
generale si tratta comunque di discorsi in origine orali, magari preparati per
un’occasione ufficiale, ma sempre pronunciati da qualcuno prima di essere trascritti: solo molto raramente vengono citati testi non destinati alla resa vocale, come
saggi, leggi o statistiche, e quando accade essi risultano solitamente mediati dalle
parole di un personaggio che li riporta, talvolta non testualmente.
Di segno opposto è l’altra procedura abituale nelle ricerche su cui si basa
un’opera verbatim: gli autori spesso intervistano direttamente i protagonisti delle
vicende che intendono narrare, raccogliendone dunque le testimonianze in un contesto privato e con la finalità dichiarata di portarle in scena. Si viene così a creare
un rapporto molto delicato, in quanto dai colloqui avrà inizio la trasformazione
della persona interpellata in personaggio. La stessa metamorfosi interessa tutti i
soggetti di drammi documentari, ma può risultare più netta quando non si tratta di
una figura pubblica; se vengono rappresentate condizioni di sofferenza, può finanche nascere il sospetto che il drammaturgo sfrutti il dolore di un essere umano. Gli
autori di teatro verbatim si mostrano generalmente sensibili alla questione e cercano
di non imporsi agli interlocutori, che hanno sempre la possibilità di decidere consapevolmente se raccontare o no la propria storia, e talvolta, soprattutto quando
l’argomento è delicato, il diritto di approvare il testo o chiederne il cambiamento.
Come ha sottolineato Robin Soans, che in Life after Scandal (2007) riporta le parole di vittime della cosiddetta gogna mediatica, molti dei soggetti di questi testi
sono al contrario contenti di poter esprimere il proprio punto di vista.5 In effetti,
per Soans il senso del teatro verbatim sta nell’amplificare una voce che altrimenti
andrebbe persa, nel far sì che sia ascoltata, prima dal drammaturgo e poi, con la
mediazione dell’attore, dal pubblico.6
Tornando alla rudimentale tassonomia proposta sopra, My Name Is Rachel Corrie
di Alan Rickman e Katharine Viner (2005), tratto da lettere e diari dell’attivista
americana uccisa da un bulldozer israeliano, è forse l’unico caso di testo basato su
4 Il riferimento ineludibile, per i testi basati su atti processuali ancor più che per tutto il teatro
documentario del secondo Novecento, è L’istruttoria di Peter Weiss (Die Ermittlung, 1965), la cui
distanza dal teatro verbatim è peraltro indicata già nel sottotitolo Oratorio in undici canti: l’ambizione di
riportare testualmente le parole dei testimoni appare contrapporsi alla forma poetica per cui opta il
drammaturgo tedesco.
5 Will Hammond e Dan Steward (a cura di), Verbatim Verbatim. Contemporary Documentary Theatre,
Oberon Books, London, 2008, pp. 37-38. Una riflessione analoga è offerta da Alecky Blythe, ivi, pp. 82-84.
6 Ivi, p. 32.
232
Vera Cantoni
testimonianze già esistenti non destinate a una dimensione pubblica. La difficoltà
di reperire materiali simili non sembra tale da spiegare lo scarso uso che ne è stato
fatto; si può invece ipotizzare che documenti analoghi siano stati scartati, ove era
disponibile un’alternativa, per ragioni estetiche. Una caratteristica formale che
accomuna le fonti private preesistenti è il fatto di essere scritte, giacché le conversazioni non vengono normalmente registrate, e quindi potrebbe essere la mancanza della vitalità propria del discorso orale a renderle meno adatte a essere inserite
testualmente in un’opera drammatica.
La quarta combinazione, che prevede l’esistenza di testimonianze pubbliche
raccolte ad hoc, è a prima vista irrealizzabile, ma ha registrato una significativa
occorrenza. Quando una parte dell’opinione pubblica britannica, che trovò espressione anche sulla stampa, mise in dubbio la correttezza dell’operato di Tony Blair
riguardo all’intervento militare in Iraq, non c’erano gli estremi per un’inchiesta
giudiziaria, ma la direzione artistica del “Tricycle Theatre”, che aveva già raccolto
notevoli successi con drammi processuali verbatim (Half the Picture, 1994; The Colour
of Justice, 1999; Justifying War, 2003; Bloody Sunday, 2006), decise che il teatro poteva
creare il dibattito di cui evidentemente molti sentivano il bisogno. Degli avvocati
furono incaricati di sostenere l’accusa e la difesa; con loro furono stilati elenchi di
persone informate dei fatti e quelle che diedero la loro disponibilità furono interrogate come in un tribunale: Called to Account. The Indictment of Anthony Charles Lynton Blair for the Crime of Aggression against Iraq - A Hearing (2007) è costituito dalle
dichiarazioni iniziali dei due legali, dalle testimonianze degli intervistati e dalle
arringhe conclusive, come in un procedimento penale ufficioso e senza verdetto.
Gli autori
Come è in parte già emerso dalle osservazioni precedenti, la creazione di un
dramma verbatim si articola in due momenti distinti: i documenti che ne costituiscono la materia vengono prima raccolti e successivamente elaborati. La fase di
ricerca può non essere opera di chi curerà la drammaturgia, ma di collaboratori o
degli attori stessi. Spesso l’intera compagnia si impegna nell’indagine per poi discuterne i risultati, affidando infine la redazione del testo a uno scrittore, ma facendo tesoro della conoscenza più personale e approfondita dei temi che tutti hanno così acquisito.7
Per quanto riguarda gli autori drammatici, molti provengono da altre esperienze professionali in ambito teatrale, come il regista Nicolas Kent o l’attore Robin
Soans, o dal giornalismo, come Richard Norton-Taylor, ma anche drammaturghi
già affermati come David Hare hanno scelto di sperimentare questa tecnica. La
7 È questo per esempio il modus operandi della compagnia “Out Of Joint”, con cui hanno collaborato
David Hare e Robin Soans.
Testualmente: l’elaborazione drammaturgica delle fonti nel teatro verbatim
233
complessità della creazione di un testo verbatim è confermata dal fatto che persone
con competenze diverse hanno collaborato fruttuosamente a questo scopo, per
esempio Richard Norton-Taylor e il drammaturgo John McGrath per Half the Picture, la giornalista Victoria Brittain e la romanziera Gillian Slovo per Guantanamo
(2004), l’attore Alan Rickman e la giornalista Katharine Viner per My Name Is Rachel Corrie, la drammaturga Sonja Linden e l’attrice Christine Bacon per Asylum
Dialogues (2008).
Spesso locandine, programmi di sala e testi pubblicati manifestano la peculiarità del lavoro drammaturgico verbatim con locuzioni diverse dalla semplice preposizione “by” e dal vago “written by”. Optando per “created by”, per esempio, il
“National Theatre” presenta Home come genericamente opera di Nadia Fall;
l’espressione “devised by” invece designa specificamente il contributo di Nicolas
Kent a Called to Account, in quanto indica chi ha concepito il dispositivo da cui nasce una performance, in questo caso l’inchiesta ufficiosa; il sito della compagnia
“ice&fire” definisce Close to Home (2012) “scripted by” Annecy Hayes, quasi si trattasse dell’adattamento da un altro genere letterario. La locuzione più frequente,
usata con costanza dal “Tricycle Theatre”, è “edited by”, diverse accezioni della
quale sembrano appropriate per il teatro verbatim, dalla più blanda, a indicare una
revisione editoriale, passando per un’operazione di taglio e cucito verbale, fino alla
più forte, come in un vero e proprio montaggio.
Questa varietà terminologica corrisponde all’ampia gamma di interventi che gli
autori possono operare sulle parole delle loro fonti. Già la correzione grammaticale
è oggetto di riflessioni e scelte di poetica: spesso costruzioni erronee, anacoluti,
ripetizioni e riempitivi non verbali sono mantenuti in funzione espressiva, a rappresentare l’idioletto di un personaggio o il suo stato emotivo, ma possono essere
eliminati per evitare un risultato troppo ostico all’ascolto. Per salvaguardare la
chiarezza o la fluidità di un passaggio molti artisti ritengono lecito anche esplicitare dei nessi logici.8 Nel caso di frasi lasciate in sospeso, talvolta la conclusione implicita è posta tra parentesi onde permettere agli attori di riprodurre l’intonazione
che la suggeriva in origine.
Pressoché unanime è l’uso di comporre e intrecciare i materiali, che vivacizza e
arricchisce il testo affiancando punti di vista opposti su una stessa questione o mettendo in luce parallelismi inaspettati. Come in un ejzenstejniano montaggio delle
attrazioni, questi avvicinamenti suggeriscono una determinata lettura delle testimonianze, ma non sono generalmente sentiti come un’ingerenza dell’autore, di cui
al contrario sembrano costituire il campo d’azione specifico.
Molto più dibattuto è l’accostamento in uno stesso dramma di scene verbatim e
d’invenzione. Per esempio David Hare ha sostenuto sul piano teorico, oltre che
sfruttato nella pratica, la possibilità di integrare discorsi pubblici riportati testual8
Cfr. per esempio Robin Soans, in Hammond e Steward, Verbatim Verbatim, cit., pp. 41-42.
234
Vera Cantoni
mente con dialoghi ‘a tu per tu’ cui nessuno può avere assistito, come la passeggiata solitaria di Bush e Blair in Stuff Happens (2004),9 mentre Nicolas Kent ha esplicitamente contestato questa associazione di materiale documentario e non, perché la
trova poco corretta nei confronti degli spettatori, cui vengono così presentate fianco a fianco parole che hanno uno statuto profondamente diverso.10
Al di là di queste divergenze, sono largamente condivise da una parte
l’aspirazione a una fondamentale onestà nei confronti del pubblico e dall’altra la
consapevolezza che non ci può essere una rappresentazione, né giornalistica né tanto
meno artistica, oggettiva. Il solo, inevitabile, fatto di includere certi discorsi e non
altri costituisce un intervento significativo, per non parlare delle connessioni create
dall’avvicinare fra loro affermazioni distinte e più in generale della ricontestualizzazione cui le testimonianze sono ineluttabilmente sottoposte portandole in scena.11 La
correttezza degli scrittori si manifesta allora essenzialmente nel far sempre sentire i
diversi punti di vista possibili, senza tacitarne nessuno, e nel non nascondere, anzi,
mettere in rilievo il processo artistico cui i materiali raccolti sono stati sottoposti.
David Edgar ha visto nella ricorrente dimensione metateatrale un limite di questa drammaturgia.12 Invece per Stephen Bottoms la costante consapevolezza da
parte di autori e pubblico che l’opera è comunque un artefatto e non un documento
è un tratto essenziale della trasparenza su cui si fonda l’etica del genere verbatim.13
Amelia Kritzer ha sottolineato in questo senso la frequente presenza dell’autore fra
i personaggi (per esempio in The Power of Yes di David Hare, 2009, non a caso sottotitolato A Dramatist Seeks to Understand the Financial Crisis, o in All the Right People
Come Here di Alecky Blythe, 2005), o come un ‘tu’ a cui gli intervistati si rivolgono
(come in The Permanent Way di David Hare, 2003, o in Home di Nadia Fall, 2013). 14
Gli spettacoli
Anche nella messa in scena la franchezza di un’elaborazione che non si nasconde nel naturalismo, ma al contrario mette in luce la distanza che la separa dalla
Ivi, p. 63.
Ivi, pp. 152-153.
11 David Lane ha osservato che nel caso di interviste realizzate appositamente già la fase di ricerca è
influenzata dalle scelte di chi pone le domande (David Lane, “Verbatim Theatre - The Rise of a Political
Voice”, in Id., Contemporary British Drama, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2010, p. 67). Anche i
materiali archiviati o registrati sono del resto il risultato di una selezione, come ha rilevato Carol Martin
in “Bodies of Evidence”, TDR, 50.3, 2006, p. 10.
12 David Edgar, “Current Problems in British Playwriting”, Estudis escènics: quaderns de l’Institut del
Teatre, 39-40, 2013, <http://www.raco.cat/index.php/EstudisEscenics/article/view/266875/354496>
(07/13), pp. 14-17.
13 Stephen Bottoms, “Putting the Document into Documentary: An Unwelcome Corrective?”, TDR,
50.3, 2006, pp. 56-68.
14 Amelia H. Kritzer, Political Theatre in Post-Thatcher Britain: New Writing, 1995-2005, Palgrave Macmillan, Basingstoke (UK), 2008, pp. 176-177.
9
10
Testualmente: l’elaborazione drammaturgica delle fonti nel teatro verbatim
235
realtà è stata spesso scelta per evitare che le rappresentazioni verbatim sembrassero
costituire dei veri e propri documenti. Come sottolineato da Amelia Kritzer, infatti,
la ripetizione testuale di un discorso può essere variamente deformata da tono,
espressione, gesti o azioni di chi lo interpreta; lo spettacolo non può annullare gli
effetti della mediazione artistica da cui nasce, ma li può evidenziare, così da non
creare una verità illusoria.15
Può essere vista in questa prospettiva la pratica della compagnia “ice&fire” di
chiedere agli attori di leggere, anziché di recitare a memoria, il testo, che in questo
modo è tendenzialmente sempre meno interpretato. Più estrema è la tecnica della
‘recorded delivery’ di Alecky Blythe: le testimonianze registrate vengono montate
ma non trascritte, bensì mantenute in formato audio; l’attore che deve impersonare
una figura ne sente la voce in cuffia e cerca di riprodurne il più precisamente possibile non solo le parole, ma anche toni, ritmi e volumi.16 Questo genere di dispositivo scenico, di cui gli spettatori vengono messi a conoscenza facendo ascoltare
anche a loro la registrazione durante le prime battute della performance, porta da
un lato a dei ritratti vocali molto aderenti ai soggetti, dall’altro a una recitazione
straniata, perché gli attori non hanno la possibilità di fare propri i ruoli.
Una diversa ambiguità è originata dalle discrepanze fra personaggi e interpreti.
La somiglianza, infatti, uniformemente ricercata sul piano dell’espressione verbale,
è invece talvolta trascurata o perfino rifiutata per quanto riguarda l’aspetto fisico e
le caratteristiche anagrafiche, con l’effetto di sottolineare la distanza fra realtà e
rappresentazione, ma anche di enfatizzare indirettamente i tratti del soggetto che
vengono contraddetti dalla sua resa scenica: se Alecky Blythe afferma che il contrasto fra ciò che gli attori dicono e il loro aspetto sovverte gli stereotipi e mette in
discussione i preconcetti del pubblico,17 un pregiudizio dalle radici profonde può
essere al contrario rafforzato dalla percezione condivisa che un discorso strida
perché messo in bocca a un certo parlante.
Significative differenze fra la dimensione visiva e quella auditiva si notano non
solo nella recitazione ma più complessivamente nella messa in scena del teatro
verbatim. Spesso gli allestimenti prevedono uno spazio pressoché vuoto, astratto
(scelta costante della compagnia “ice&fire”), oppure una scena fissa che rimanda
metonimicamente a un ambiente comune quotidiano (una sala di ritrovo della casa
di accoglienza di Home, National Theatre, 2013; la stanza in cui le prostitute si rilassano in The Girlfriend Experience di Alecky Blythe, Recorded Delivery, 2008), mentre
la colonna sonora riproduce realisticamente dei rumori o include momenti musicali. Le testimonianze stesse sono state trasformate in brani cantati. Home, per esemIvi, pp. 156-157.
Tale pratica è stata ispirata dal metodo utilizzato in prova dall’americana Anna Deavere Smith,
che nel suo celebre Fires in the Mirror (1993) dava voce a un’intera comunità, i cui variegati modi di
esprimersi aveva imparato appunto ripetendone le registrazioni man mano che le sentiva.
17 Hammond e Steward, Verbatim Verbatim, cit., p. 98.
15
16
236
Vera Cantoni
pio, prevede non solo un’esibizione canora proposta originariamente da uno degli
intervistati, ma anche un personaggio che si esprime esclusivamente con il beatboxing e un canto, composto da alcune frasi chiave del testo, eseguito dall’intero cast.
Si registrano anche due casi di vero e proprio teatro musicale verbatim: Waiting di
Victoria Brittain (2010) e London Road di Alecky Blythe (2011). Questo diverso trattamento di immagini e suoni risponde però a uno stesso principio, in quanto sia le
scene fisse e povere che la presenza di numeri musicali tendono ancora una volta a
sottolineare l’artificio teatrale e la sua distanza dalla realtà cui peraltro rimanda.
Gli spettatori
Un’altra caratteristica spicca con costanza nel teatro verbatim, sia a livello
drammaturgico sia negli allestimenti: la centralità degli spettatori, spesso immediatamente manifestata dall’illuminazione, che non prevede il tradizionale buio in
sala. L’importanza del pubblico come interlocutore tanto degli scrittori quanto
degli attori è del resto sottolineata nelle riflessioni teoriche degli artisti stessi,18 che
ne evidenziano la partecipazione sia sul piano dei sentimenti sia su quello intellettuale. Da un lato, infatti, constatano l’empatia suscitata dall’ascoltare le parole di
persone reali, animate dal calore della quotidianità, dall’altro non nascondono il
desiderio, nel dar corpo a questo genere di teatro impegnato, di influire sulla società non tanto scatenando emozioni quanto piuttosto informando.
La simpatia umana appare in effetti solo limitatamente sfruttata dagli autori di
teatro verbatim, essenzialmente per catturare l’attenzione e per superare la potenziale aridità di dati e riferimenti puntuali, mentre nel complesso la scrittura si rivolge brechtianamente alla razionalità degli spettatori, cercando di chiarire i termini di un problema piuttosto che di diffondere una sensazione. Ai molti elementi
stranianti già presentati si può accostare qui un ulteriore aspetto formale che fa
appello al giudizio di chi ascolta: il finale aperto. Pur costruendo, con il montaggio
delle testimonianze, un arco narrativo che presenta e sviluppa un conflitto secondo
uno schema drammaturgico classico, la maggior parte dei testi verbatim non porta
infatti a un’altrettanto canonica risoluzione. Emblematico è in questo senso Called
to Account, che si chiude dopo le arringhe dell’accusa e della difesa, senza verdetto,
perché i giurati sono gli spettatori, che dovranno autonomamente valutare informazioni e ragionamenti, giungendo eventualmente a una conclusione. Nel caso
dell’inchiesta ufficiosa realizzata dal “Tricycle Theatre” il ruolo di giuria è attribuito al pubblico anche sul piano della rappresentazione, ma questa metafora può
illustrare più in generale il compito che il teatro verbatim attribuisce agli spettatori.
La loro partecipazione è inoltre sollecitata al di là dello spettacolo, come testimonia
18 Si vedano, ad esempio, le dichiarazioni di Robin Soans, Max Stafford-Clark e Nicolas Kent, in
Hammond e Steward, Verbatim Verbatim, cit., rispettivamente alle pp. 21, 66-67, 156.
Testualmente: l’elaborazione drammaturgica delle fonti nel teatro verbatim
237
il fatto che quasi tutte queste produzioni rimandano a ulteriori sviluppi, attraverso
i numerosi dibattiti dopo le performance o per mezzo dei riferimenti documentari
puntualmente riportati da pubblicazioni e siti web.
Se una tale continuazione delle ricerche suggerisce un passaggio di testimone
dagli autori agli spettatori, un’analoga affinità è spesso riscontrabile anche
all’interno del testo, quando i personaggi si rivolgono al pubblico con una seconda
persona che in origine si riferiva chiaramente a chi conduceva le interviste. In un
passo di Home la presenza di un ‘tu’ si fa particolarmente concreta quando
un’attrice prepara il tè per la persona a cui sta parlando; che questo interlocutore,
prima dell’elaborazione drammaturgica, fosse l’autrice risulta poi evidente nel
momento in cui le vengono chiesti dei biglietti per lo spettacolo.
In conclusione, il rapporto fra i diversi ruoli di testimone, scrittore, interprete e
spettatore nel teatro verbatim può esserne considerato un tratto caratteristico. Come
si è visto, infatti, sia gli autori del testo che gli attori mantengono una chiara distanza formale dalle fonti cui attingono i loro materiali e simmetricamente il pubblico è invitato a riflettere su questa realtà piuttosto che a identificarvisi, mentre
una peculiare sovrapposizione si verifica tra drammaturghi e spettatori, che condividono la funzione di prestare un orecchio critico alle parole dei testimoni.
238
Vera Cantoni
MARIA CRISTINA ZERBINO
PULCI E PIDOCCHI: I PRONOMI PERSONALI
SULLA SCENA PLAUTINA TRA ORALITÀ E SCRITTURA
Premessa: pidocchi e pulci
Lo studio che segue propone una riflessione sul continuum oralità-scrittura nelle
commedie di Plauto a partire da un’analisi del gioco dei deittici in generale, e dei
pronomi personali in particolare, nei testi del drammaturgo latino. Due citazioni,
tratte da testi che con l’oralità non hanno nulla a che vedere, permettono a mio
avviso di introdurre sinteticamente il discorso sui pronomi personali, condensando
riflessioni di tipo linguistico e semiotico:
«Ah! il mondo delle idee! che bel mondo!... ah! l’io, io... tra i mandorli in fiore... poi tra
le pere, e le Battistine, e il Giuseppe!... l’io, l’io... Il più lurido di tutti i pronomi!...». ....
«... E perché diavolo? Che le hanno fatto di male i pronomi? Quando uno pensa un
qualchecosa deve pur dire: io penso ....
«... I think; già: but I’m ill of thinking...» mormorò il figlio. «... I pronomi! Sono i pidocchi del pensiero. Quando il pensiero ha i pidocchi, si gratta, come tutti quelli che
hanno i pidocchi... e nelle unghie, allora... ci ritrova i pronomi: i pronomi di persona...».1
I hate “I” because when I write, “I love him,” or “I am afraid of being confined by
him,” the “I” is a character I am inventing who/which in some sense drains life from
me ME into artifice and enclosedness. The “I” of “I love him” written down is nauseating. The real “I” is the first I of “I hate I” - the watcher- though only until I write
that, once I have noticed that, that I who hates “I” is a real I, it becomes in its turn an
artificial I, and the one who notices that that “I” was artificial too becomes “real”
(what is real) and so ad infinitum, like great fleas with lesser fleas upon their backs to
bite ’em. Is the lesson, don’t write? It is certainly, don’t write “I”.2
Pidocchi del pensiero, espressione di una soggettività malata nella metafora di
Gadda, grandi pulci che portano sulle spalle pulci più piccole che le mordono
nell’immagine di Byatt in cui i pronomi di prima persona si sdoppiano e, in una
lingua a soggetto obbligatorio come l’inglese,3 si moltiplicano in un abissale cre-
Carlo E. Gadda, La cognizione del dolore, Garzanti, Milano, 2007, pp. 635-636.
Antonia S. Byatt, Babel Tower, Vintage, London, 2003, p. 382.
3 La frequenza dei pronomi soggetto è molto più alta in inglese, lingua a soggetto obbligatorio, che
in italiano, lingua a soggetto nullo, o a pro-drop totale, in cui l’espressione è dettata per lo più da
esigenze comunicative e espressive. Cfr. Bernard Comrie, Universali del linguaggio e tipologia linguistica, Il
Mulino, Bologna, 1983 e Paolo Ramat, Linguistica tipologica, Il Mulino, Bologna, 1984.
1
2
240
Maria Cristina Zerbino
scendo di mediatezza e artificialità: in entrambi i passi citati i pronomi personali
sono rappresentati come entità di tipo ‘parassitario’.
Ma che segni sono questi che, se osservati al microscopio paradossale
dell’indagine teorica, appaiono come fastidiosi e dispensabili parassiti e che invece
nella lingua in azione abbondano, mostrando di funzionare perfettamente? Si tratta
di elementi legati all’esercizio del linguaggio – il livello del discorso che li contiene
è quello pragmatico in cui i segni sono messi in relazione con coloro che se ne servono4 – e rappresentano una categoria complessa in quanto la loro referenzialità e
la loro esistenza linguistica si danno solo nell’atto di parola che li proferisce. Possono essere considerati segni ‘vuoti’ che diventano ‘pieni’ una volta che il parlante
li assume nel proprio discorso,5 segni ibridi che combinano le funzioni peirciane di
simbolo (associato all’oggetto rappresentato secondo una regola convenzionale) e
di indice (che si trova in una relazione esistenziale con l’oggetto che rappresenta).6
Sono i pronomi di prima e seconda persona a definire l’ambito della soggettività e
della coscienza di sé, che si fa attraverso il linguaggio in un tempo eternamente
presente.7
L’affollarsi e il moltiplicarsi su piani diversi dei pronomi-pulci, così come descritti da Byatt, mi sembra un’immagine efficace per introdurre una riflessione sul
gioco dei pronomi nel testo drammatico e sulla scena. L’immagine rende in modo
icastico due caratteristiche che i semiologi del teatro definiscono ‘opacità’ e ‘autoriflessività del segno teatrale’. Il deittico mostra prima di tutto se stesso: è posto,
come tutti gli oggetti scenici, tra metaforiche virgolette perché il pubblico possa
“inferire da esso la presenza di un altro membro della stessa classe di oggetti nel
mondo drammatico rappresentato”.8 Se osserviamo il gioco dei pronomi nel noto
schema della comunicazione teatrale elaborato da Segre, è evidente una molteplicità di piani e di livelli in cui, a una comunicazione di tipo orizzontale ‒ che è quella
che avviene all’interno del testo drammatico tra un io-personaggio e un tupersonaggio (costitutivamente interscambiabili) ‒ si affiancano sia una comunicazione verticale, tra un io-emittente-autore e un tu-destinatario-pubblico, sia una
comunicazione obliqua (quella che Segre definisce “fuga di notizie”), in cui iopersonaggio si rivolge direttamente a tu-pubblico.9 Per rimanere nella metafora, è
evidente che le pulci non sono tutte uguali.
4 Charles W. Morris, Foundations of the Theory of Signs, University of Chicago Press, Chicago, 1938.
Cfr. anche Émile Benveniste, “La nature des pronoms” (1956), ora in Émile Benveniste, Problemi di
linguistica generale, Feltrinelli, Milano, 1994, p. 302.
5 Benveniste, Problemi, cit., p. 304.
6 “Simboli-indice” li definisce Roman Jakobson, Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano, 1994,
p. 152.
7 Benveniste Problemi, cit., pp. 306-315.
8 Keir Elam, Semiotica del teatro, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 15 ss.
9 Cesare Segre, Teatro e Romanzo, Einaudi, Torino, 1984, pp. 5 e 11.
Pulci e pidocchi: i pronomi personali sulla scena plautina tra oralità e scrittura
241
La complicazione, a ben guardare, non finisce qui se si considera, oltre al testo
teatrale, anche il testo spettacolare. L’io personaggio non è un’entità (o un’identità)
reale ma è incarnato da un attore il cui dire “io” è un ‘re-citare’, compimento di un
atto performativo ambiguo che costituisce una rottura tra la parola e la realtà; è
una denegazione per cui il reale presente sulla scena è sempre rinviato alla sua
negazione (“è là ma non è vero”). L’illusione risulta così raddoppiata.10 Il pronome,
nel suo spessore di simbolo-indice, può essere visto come il segnale che innesca la
consapevolezza degli spettatori, il cui piacere nasce forse anche dalla possibilità di
leggere in quel segno una pluralità di soggetti: il personaggio, l’attore che lo impersona (e che comunica in forma obliqua con gli spettatori), ma anche il poeta,
emittente del messaggio verticale rivolto al pubblico.
Quale oralità nella scrittura teatrale? Lingua della vicinanza e lingua della distanza
La deissi è un costituente specifico della lingua del dramma, in cui un io si rivolge a un tu in un ‘qui e ora’.11 L’attualità del discorso drammatico risiede proprio nelle espressioni indicali: il testo è incompleto fino a quando non si realizza
sulla scena e i deittici ne rappresentano l’incompletezza ma anche la rappresentabilità, fornendo indicazioni fondamentali per la realizzazione della comunicazione
scenica. Il testo scritto è un tessuto strappato, troué,12 per usare la bella immagine di
Anne Ubersfeld: dai buchi del textus si affaccia una realtà extratestuale che è quella
delle possibili messe in scena.
La presenza di espressioni indicali, che si richiamano all’attualità della comunicazione, caratterizza la lingua del testo teatrale non tanto come lingua parlata, che è
inattingibile quando si ha a che fare con testi scritti di una lingua morta, quanto piuttosto come lingua della vicinanza, caratterizzata da elementi come il dialogo, il libero
scambio, la familiarità col partner, l’interazione face to face, la libera scelta dei temi, la
spontaneità.13 La lingua della scrittura teatrale è inevitabilmente ‘bagnata’ di oralità e
non può che fare i conti con una parola destinata ad essere detta e ascoltata, ma non
letta. D’altra parte la storia del teatro mostra come la ricerca di una dimensione orale,
soprattutto in culture in cui la scrittura è il medium privilegiato, dipenda dalla sensiAnne Ubersfeld, Leggere lo spettacolo, Carocci, Roma, 1996, p. 178.
Elam, Semiotica, cit., p. 142.
12 Anne Ubersfeld, Lire le Théatre, Éditions sociales, Paris, 1977, p. 24. Il testo è parzialmente tradotto
in Ubersfeld, Leggere lo spettacolo, cit.
13 La definizione è di Peter Koch, Wulf Oesterreicher, “Sprache der Nähe – Sprache der Distanz.
Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte”,
Romanistisches Jahrbuch, 36, 1985, pp. 22-23. Il testo sottolinea il continuum tra oralità e scrittura nelle sue
varie possibilità comunicative, come uno spazio multidimensionale tra i due estremi della Sprache der
Nähe e della Sprache der Distanz. Hans Haffter, Untersuchungen zur altlateinischen Dichtersprache,
Weidmann, Zürich, 1932, aveva già osservato che la lingua di Terenzio si configura a tratti come una
Distanzsprache che tende a limitare i riferimenti alla concretezza della situazione scenica.
10
11
242
Maria Cristina Zerbino
bilità dell’autore, oltre che dai gusti del pubblico e dalle pratiche consolidate di
un’epoca. La lingua del testo drammatico è anche, evidentemente, Sprache der Distanz,
lingua della distanza, in quanto discorso artistico elaborato e costruito nell’assenza
dell’interlocutore, che è caratterizzato da elementi quali la mancanza di interazione,
l’estraneità del partner, la separazione nel tempo e nello spazio, la fissità dei temi.
L’analisi del gioco dei pronomi all’interno del testo teatrale, in particolare di quello antico che non prevede didascalie esterne, può dare a mio avviso indicazioni rilevanti sulla dimensione più specificamente orale e comunicativa, sulla prossemica dei
personaggi e sulle possibili dinamiche visive e sceniche nonché sull’evolversi delle
relazioni tra i personaggi. Inoltre un’indagine sulla frequenza di pronomi-soggetto
espressi, che risulta maggiore nei testi legati alla modalità discorsiva, può dare indicazioni non solo su quanto testi diversi possano dirsi vicini alla espressività del parlato,14 ma anche sul loro rapporto con la dimensione scenica. Come osserva Benveniste: “È possibile immaginare un testo linguistico di notevole ampiezza ‒ un trattato
scientifico ad esempio ‒ dove io e tu non compaiano neppure una volta; sarebbe al
contrario difficile concepire un testo parlato, anche breve, in cui essi non siano usati”.15 Ma anche sulla scena l’uso dei pronomi soggetto può variare a seconda delle
scelte del drammaturgo: un confronto tra le commedie di Plauto e Terenzio, da un
lato, e le tragedie di Seneca, dall’altro, lo mostra con chiarezza:
Tabella 1. Frequenza pronome ego in Plauto Terenzio e Seneca.
Autore
Plauto
Terenzio
Seneca
Totale versi
21275
6074
8677
Occorrenze ego
2348
492
42
Frequenza
ogni 9 vv.
ogni 12 vv.
ogni 206 vv.
Tabella 2. Frequenza pronome tu in Plauto Terenzio e Seneca.
Autore
Plauto
Terenzio
Seneca
Totale versi
21275
6074
8677
Occorrenze tu
1518
347
92
Frequenza
ogni 14 vv.
ogni 17 vv.
ogni 94 vv.
14 Johan B. Hofmann, La lingua d’uso latina, Pàtron, Bologna, 20033, § 95. Leonard R. Palmer, The Latin
Language, Faber and Faber, London, 19613, pp. 74-75. Sulla possibilità di studiare la Umgangssprache di
una lingua morta si veda Heinz Happ, “Die lateinische Umgangssprache und die Kunstsprache des
Plautus”, Glotta, 45, 1967, pp. 66 ss. La Umgangssprache combina vari fattori tra cui l’elemento affettivo e
quello convenzionale o banale ma, nella sua conservatività, presenta anche tratti di registro alto. Qui si
ometteranno i riferimenti alla lingua parlata e si preferirà parlare di modalità discorsiva, richiamandosi
alla nozione di discours precisata da Benveniste nel suo “Structure des relations de personne dans le
verbe” (1946), ora in Benveniste, Problemi, cit., pp. 269-282.
15 “La nature des pronoms” ora in Benveniste, Problemi, cit., p. 302.
Pulci e pidocchi: i pronomi personali sulla scena plautina tra oralità e scrittura
243
Il paragone ha evidentemente solo un valore indicativo, data la difformità dei
testi a confronto sia dal punto di vista tipologico (commedia e tragedia hanno stili
completamente diversi e un diverso rapporto con la dimensione colloquiale) che da
quello cronologico.16 Tuttavia è innegabile che le cifre evidenziate rispecchiano usi
e funzioni del pronome decisamente diversi. I numeri evidenziano anche differenze tra l’impiego del pronome di prima e quello di seconda persona. Le occorrenze
di ego sono decisamente maggiori rispetto a quelle di tu nelle ventuno commedie
plautine e in quelle di Terenzio: la differenza è dovuta in parte al fatto che, mentre
ego compare espresso sia nei dialoghi che nei monologhi, tu si trova piuttosto raramente nei monologhi e la sua espressione è limitata alle parti dialogate. In Seneca
la situazione è rovesciata: tu si trova impiegato più del doppio delle volte rispetto a
ego. Se l’ellissi del pronome di prima persona appare generalizzata, l’appello al
destinatario risulta a volte indispensabile.
In latino, e in generale nelle lingue che ne ammettono l’omissione, i pronomisoggetto si trovano più spesso espressi nei testi discorsivi poiché nel dialogo la
persistenza del tema è più labile e il contatto tra emittente e destinatario (che continuamente si scambiano i ruoli) è maggiore. A questo si aggiunge la funzione centrale che i pronomi, in quanto espressioni indicali, assumono all’interno del testo
drammatico. La frequenza dei pronomi-soggetto è quindi un segnale che dà indicazioni sulla dimensione colloquiale e performativa di un testo e che si riflette, ad
esempio, in una diversa distribuzione dei pronomi all’interno dei monologhi e
all’interno dei dialoghi.
La scarsità di deittici personali caratterizza la lingua delle tragedie di Seneca
come Sprache der Distanz o, volendo richiamare le categorie elaborate da Nencioni,
di una forma di ‘parlato scritto’,17 mentre la lingua di Plauto e quella di Terenzio
presentano, anche se in gradi diversi, le caratteristiche di una Sprache der Nähe, più
legata alla dimensione dialogica e performativa.
Se dal punto di vista mediale le commedie plautine appartengono al polo della
scrittura, da quello concettuale sono pienamente inserite nel fenomeno estremamente variegato dell’oralità, in cui si mescolano una pluralità di procedimenti linguistici e di stili che vanno dall’espressione ‘spontanea’ ‒ o dall’imitazione di que-
16 La discontinuità del materiale conservato non permette di evidenziare un’evoluzione nel tempo
tra testi tipologicamente simili, ad esempio quelli comici. In generale, manca per il latino uno studio
dello sviluppo dell’espressione del pronome personale sia in senso diacronico che all’interno di diversi
tipi di testo, come è stato invece messo a punto per la lingua italiana da Massimo Palermo, L’espressione
del pronome personale soggetto nella storia dell’italiano, Bulzoni, Roma, 1997.
17 Giovanni Nencioni, “Parlato-parlato, parlato-scritto, parlato-recitato” (1976), in Giovanni
Nencioni, Di scritto e di parlato. Discorsi linguistici, Zanichelli, Bologna, 1983, pp. 126-179, considera la
lingua teatrale una categoria di “parlato-recitato”, a sua volta specificazione del “parlato-scritto”, ma
che si distingue nettamente dal parlato spontaneo o “parlato-parlato”.
244
Maria Cristina Zerbino
sta ‒ a testi accuratamente elaborati.18 Nello spazio e nel tempo della commedia
plautina agiscono ‒ contemporaneamente e in una molteplicità di piani ‒ una Sprache der Nähe e una Sprache der Distanz. Oralità e scrittura operano in sinergia: sono
concetti misti e impuri. Se l’oralità non è poi così orale come sembra, allo stesso
modo la scrittura in teatro cambia di segno: si pensi alla scrittura scenica che fa
evidentemente riferimento alla dimensione fisica dei movimenti degli attori sul
palco e non a un fenomeno letterario.19
In questa prospettiva è interessante studiare quali siano gli elementi caratteristici della lingua teatrale plautina come ‘lingua della vicinanza’ e quali i segnali che
fanno intendere questa ‘vicinanza’ in una dimensione fisica. L’attualità del discorso
drammatico risiede proprio nelle espressioni indicali che costituiscono
“l’immanenza dello spettacolo in seno al testo”20 e forniscono indicazioni fondamentali per la realizzazione della comunicazione scenica.
I pronomi sulla scena: “io chi?” o il paradosso della prima persona
Che ruolo giocano i pronomi sulla scena plautina? La funzione principale sembra essere quella didascalica che fornisce indicazioni sulle relazioni e sulla prossemica dei personaggi. Non è raro trovare passi in cui, ad esempio, il pronome soggetto di seconda persona è impiegato per specificare a quale dei personaggi che si
trovano in scena ci si rivolge. Ma in Plauto traspare anche una consapevolezza più
raffinata delle implicazioni sceniche determinate dall’uso dei pronomi, intesi come
segni vuoti che diventano pieni quando il parlante se ne appropria. In alcuni casi,
partendo da quelle che possono sembrare semplici facezie o giochi linguistici in un
testo scritto, è possibile ricostruire una dinamica visiva e scenica ben precisa che
solo nell’oralità e sulla scena trova la sua compiutezza.
Così ad esempio, nel Truculentus (vv. 253 ss.), sembra possibile ravvisare una
giocosa riflessione sulla ambiguità del pronome come simbolo-indice. Astafia, serva della cortigiana Fronesio, bussa alla porta della casa del rozzo ma munifico
cliente Strabace, non senza timore di essere maltrattata dal di lui servus violentissimus il quale, puntualmente, si affaccia alla porta richiamato dai colpi e dalle grida.
Ne segue uno scambio vivace in cui incomprensioni e motti di spirito si succedono
a ritmo serrato. Si tratta del primo ingresso in scena dello schiavo eponimo della
18 Koch e Oesterreicher, Sprache der Nähe – Sprache der Distanz, cit., p. 30. Nella oralità concettuale
‘elaborata’ sono presenti elementi di oralità primaria quali la progressività della forma, l’esecuzione
parlata, l’interazione tra attore e pubblico.
19 Cfr. Giuseppe Bartolucci, Teatro-corpo, teatro-immagine. (Per una materialità della scrittura scenica),
Marsilio, Padova, 1970. In Plauto è possibile trovare traccia di una sensibilità su questi temi e di una
riflessione sul fenomeno della scrittura come strumento potente di comunicazione a distanza ma anche
mezzo ambiguo che si presta al fraintendimento: si pensi all’espediente drammaturgico della lettera che
compare in diverse commedie.
20 Segre, Teatro e romanzo, cit., p. 10.
Pulci e pidocchi: i pronomi personali sulla scena plautina tra oralità e scrittura
245
commedia, Truculento, le cui uniche due apparizioni (vv. 256-321 e 669-698) delineano, più che un personaggio a tutto tondo, un ruolo che si presta a un efficace
‘cameo’.21 Il personaggio combina un’estrema rozzezza di modi con una competenza linguistica approssimativa che lo porta a fraintendere quello che gli viene
detto e a infilare uno strafalcione dopo l’altro, guadagnandogli l’appellativo di
“Mrs. Malaprop della commedia latina”.22
Il passo è giocato sulla routine del bussare alla porta, ampiamente sfruttata dai
poeti comici a partire da Aristofane ed evitata invece in tragedia forse proprio per le
sue connotazioni farsesche.23 Al convenzionale “chi è?” dello ianitor segue uno scambio all’apparenza banale, che si conclude tuttavia in modo niente affatto consueto:
AS.
sed fores, quicquid est futurum, feriam.
ecquis huic tutelam ianuae gerit? ecquis intus est?
TR. quis illic est qui tam proterue nostras aedis arietat?
AS. ego sum; respice ad me. TR. quid ‘ego’? nonne ‘ego’ uideor tibi?
quid tibi ad hasce accessio aedis est prope aut pultatio?24
La risposta di Astafia “sono io, guardami” non basta: la conversazione prosegue
e prende una piega che sembrerebbe filosofica se non fosse del tutto comica. La
domanda di Truculento quid ‘ego’? ha una funzione metalinguistica: l’oggetto, posto tra più o meno metaforiche virgolette grazie all’impiego di quid, è specificamente linguistico. L’incomprensione si basa sull’inanità del pronome che, in quanto
simbolo che si richiama al codice, non dà indicazioni sull’identità del parlante, ma
lo identifica soltanto come tale. Il servo plautino sembra dare voce a quello che è
stato definito il ‘paradosso della prima persona’: a rigore Astafia, dicendo “sono
io”, non comunica nulla della propria identità, ma solo il significato linguistico del
21 È suggestiva l’ipotesi che Plauto potesse aver riservato per sé queste due brevi scene, un po’ come
facevano Alfred Hitchcock o Orson Welles nei loro film. Sui personaggi impersonati da Plauto cfr. C.W.
Marshall, The Stagecraft and Performance of Roman Comedy, Cambridge University Press, Cambridge,
2006, p. 134.
22 Wallace M. Lindsay, “Leo’s Plautus”, Classical Review, 10, 1896, p. 334. Mrs Malaprop (da mal à
propos) è il personaggio della commedia di Richard Sheridan The Rivals (1775), che dice illegible invece di
eligible, affluence invece di influence, delusion invece di allusion, tutte paronimie o, per l’appunto,
‘malapropismi’.
23 Cfr. George E. Duckworth, The Nature of Roman Comedy. A Study in Popular Entertainment, Princeton University Press, Princeton, 1952, p. 117; Oliver Taplin, Greek Tragedy in Action, University of California Press, Berkeley, 1978, p. 105; K.B. Frost, Exit and Entrances in Menander, Oxford University Press,
Oxford, 1988, p. 9; Marshall, The Stagecraft, cit., p. 192.
24 “AS. Ma busserò alla porta, vada come vada. Che c’è qualcuno a guardia di questa porta? C’è
qualcuno dentro? TR. Chi è che prende a cornate la nostra porta con tanta prepotenza? AS. Sono io,
guardami. TR. ‘Io’ chi? Io non ti sembro forse ‘io’? Che è ‘sta bussazione? Chi ti dà permesso di accessione
in questa casa?” (Truc. 255-257). Testo latino di Walter Hofmann, Plautus, Truculentus, Wissenschaftliche Buchgesellschaf, Darmstadt, 2001, p. 155. Trad. mia in cui ho cercato di evidenziare due probabili
neologismi plautini nelle parole accessio e pultatio. Cfr. André Maniet, “’Frapper à la porte’ en latin
préclassique. Notes morpho-sémantiques sur ‘pello’ et ses dérivés”, Latomus, 25, 1966, pp. 33-36.
246
Maria Cristina Zerbino
pronome, cioè “colei che parla in questo momento”.25 La comica ostilità di Truculento è rappresentata sulla scena dalla mancanza di contatto, dal rifiuto di entrare
in relazione ‒ una relazione prima di tutto visiva ‒ con l’ancilla. Ma il vero Witz è
contenuto nelle parole che seguono: “nonne ‘ego’ videor tibi?” La battuta è attribuita
ad Astafia dalla maggior parte degli editori moderni ma il gioco è, a mio avviso,
decisamente più interessante se la domanda viene messa in bocca a Truculento26
che, in questo modo, si appropria del segno ‘vuoto’ mostrandone l’incompletezza e
l’ambiguità semiotica. Ego non denomina nessuna persona, non significa nulla se
non è inteso come un deittico e dunque messo in relazione con un volto (anche
quello di una maschera) o con un nome.
Un confronto con uno scambio simile in Menandro può essere illuminante per
mostrare quanto Plauto estremizzi un gioco già presente nei modelli greci. Si tratta
di un passo del Dyskolos in cui avviene il riconoscimento tra l’adulescens Sostrato e
il suo servo Geta:
ΣΩ.
[π]αῖ Γέτα
ΓΕ.ἐμὲ τίς; ΣΩ. ἐγώ. ΓΕ. σὺ δ’εἶ τίς; ΣΩ. οὐχ [ὁρᾷ]ς; ΣΩ. ὁρῶ·
τρόφιμος.27
Pur non essendo una scena in cui entra in gioco l’azione del bussare, anche il dialogo tra l’adulescens Sostrato e il suo servo si svolge accanto a una porta, quella del santuario di Pan da cui Geta è uscito accecato dal fumo del sacrificio, dettaglio che fornisce
sia il motivo della sua entrata in scena che quello del mancato riconoscimento. Anche
questa scena è giocata su una dinamica visiva: il pronome ἐγώ non basta a Geta per
individuare il suo interlocutore, ma è necessario che il servo veda chi ha davanti: il
verbo ὁράω compare due volte nello stesso verso. La fenomenologia del vedere sulla
scena greca e su quella romana – si sa – non ha niente di realistico ed è puramente
dettata dalla convenzione e il mancato riconoscimento, con i suoi possibili spunti umoristici, diviene presto un cliché comico spesso fine a se stesso.28
25 Benveniste, Problemi, cit., p. 314. Sul paradosso della prima persona cfr. François Récanati, “Singular Thought: In Defence of Acquaintance”, in Robin Jeshion (a cura di), New Essays on Singular Thought,
Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 161. Un pensiero espresso alla prima persona è problematico
in quanto il pronome ‘io’ comunica sempre il suo significato convenzionale e non il suo contenuto; esso
contiene l’esperienza che il parlante ha di se stesso, che resta privato e dunque incomunicabile. Per
uscire dal paradosso è necessario intendere il significato non come corrispondenza o rispecchiamento
del mondo ma, pragmaticamente, come uso.
26 L’attribuzione all’ancilla è proposta da Schoell e seguita dalla maggior parte degli editori. La
domanda è attribuita a Truculentus da Friedrich Leo, Plauti Comoediae, Weidmann, Berolini 1895 e,
recentemente, da Hofmann, Truculentus, cit., p. 155.
27 “SO. Geta, ragazzo. GE. Chi mi chiama? SO. Io. GE. E tu chi sei? SO. Non mi vedi? GE. Ti vedo, padrone” (Men. Dysk. 551-552). Testo greco di Eric W. Handley, The Dyskolos of Menander, Bristol Classical,
London, 1992. Traduzione mia.
28 Cfr. Anne M. Dale, “Seen and Unseen on the Greek Stage: a Study in Scenic Conventions”, in A.
M. Dale, T. B. L. Webster, E. G. Turner, Collected Papers of A. M. Dale, Cambridge University Press, Lon-
Pulci e pidocchi: i pronomi personali sulla scena plautina tra oralità e scrittura
247
Il gioco, accennato in Menandro, viene prolungato in Plauto: mentre Geta riconosce l’interlocutore come un ‘tu’ di cui ignora però l’identità, il servo di Plauto
può vedere ma evidentemente non guarda e si ferma prima, al livello delle parole.
Il gioco di sguardi mancati ha un immediato effetto comico e la domanda “chi è
io?” insinua un dubbio tutto teatrale. In quella che Ubersfeld definirebbe una “fenditura della recitazione”, il teatro esibisce sé stesso “affermando la divisione della
scena e della finzione, della voce dell’attore e di quella del personaggio, dell’Io-1 e
dell’Io-2, non riconciliabili ma presenti insieme nella stessa voce”.29
Sulla scena plautina si svolge un paradossale dramma pronominale. Più avanti
è ancora un pronome, il dativo tibi che non a caso è ripetuto nel verso successivo, a
denotare un cambiamento per cui il servo entra decisamente in una relazione discorsiva, e forse visiva, con l’interlocutrice: il personaggio può dire ‘io’ perché ha
di fronte un ‘tu’ che lo individua come tale. La domanda successiva di Truculento
ha un destinatario preciso: Quid tibi ad hasce accessio aedis est prope aut pultatio? Si
passa da un quis, che per di più si trova illic, a un interlocutore reale riconosciuto
come un tu che è prope: il dialogo può cominciare. Dal punto di vista scenico la
pausa costituita dal gioco sul pronome ha implicazioni prossemiche e suggerisce
una possibile sequenza di movimenti per cui i due personaggi arrivano progressivamente a guardarsi e dunque a vedersi.
Attraverso le incomprensioni di Truculento Plauto mette in scena la lingua e in
particolare la lingua teatrale, in cui tanta importanza ha la deissi personale come
indice di “orientamenti performativi”.30 Se “ego sum” è una dichiarazione di esistenza come personaggio, l’uso del pronome ha in certa misura la stessa funzione
convenzionale di un travestimento; è un segno che il lettore o lo spettatore sono
invitati a riconoscere proprio dove non funziona, dove l’efficacia dell’identificazione viene messa in discussione dalla domanda: quid ego? Si evidenzia così una
possibile funzione scenica oltre che linguistica dei pronomi personali che, se da un
lato dà forza all’ipotesi che il loro impiego nella langue teatrale plautina non sia
casuale ma abbia uno specifico valore performativo, dall’altro rivela che le osservazioni sull’uso dei pronomi possono contribuire alla riflessione su temi come
l’immedesimazione, il ruolo e l’identità.
Se il teatro non è, in definitiva, che un discorso sull’identità e sulla relazione,
sulla possibilità di essere se stessi e insieme essere un altro, il ‘gioco dei pronomi’ è
probabilmente uno dei modi principali in cui si declina tale discorso.
don, 1969, pp. 119-129. Vi sono vari livelli del ‘vedere’: cosa vedono i personaggi, cosa gli attori, cosa il
pubblico? William Beare (The Roman Stage. A Short History of Latin Drama in the Time of the Republic,
Methuen, London, 1968) osserva che i personaggi vedono quello che il drammaturgo vuole che vedano.
29 Ubersfeld, Leggere lo spettacolo, cit., pp. 45-46.
30 Cfr. Alessandro Serpieri et al.,”Toward a Segmentation of the Dramatic Text”, Poetics Today, 2,
1981, pp. 163-200 in cui il testo drammatico è visto come una progressione dinamica di atti linguistici
analizzabili in una serie di segmenti deittico-performativi.
248
Maria Cristina Zerbino
Il parassita e la civetta: un racconto breve come un lampo
In sede conclusiva, e non solo per amore di Ringkomposition, vorrei tornare a
parlare di parassiti, non tanto di pulci e pidocchi quanto di un parassita plautino, il
Penicolo dei Menaechmi, o meglio di una sua battuta che forse permette un aggancio al tema della trasposizione scenica del racconto orale.
Ai vv. 647-653, il parassita e la matrona accusano Menecmo di aver sottratto il
mantello della donna:
Ma. palla, inquam, periit domo.
MEN. quis eam surrupuit? MA. pol istuc ille scit qui illam abstulit
MEN. quis is homo est? MA. Menaechmus quidam. MEN. edepol factum nequiter.
quis is Menechmust? MA. tu istic, inquam. MEN. egone? MA. tu. MEN. quis arguit?
MA. egomet. PE. et ego; atque huic amicae detulisti Erotio.
MEN. egon dedi? MA. tu, tu istic, inquam. PE. uin adferri noctuam,
quae ‘tu tu’ usque dicat tibi? nam nos nos defessi sumus.31
I Menaechmi sono una commedia degli errori, ma in questo caso le accuse a
Menecmo sono giuste, non c’è equivoco: ad aver preso la palla alla moglie per regalarla alla sua amante è stato proprio Menecmo. Ma questi non si riconosce nel Menaechmus quidam; anzi chiede quis is Menaechmust? e, se non fossimo certi che il
personaggio ignora l’arrivo in città del fratello gemello, potremmo credere che
sfrutti a suo vantaggio la confusione generata dalla sua presenza.
Si tratta di un passo ad altissima densità deittica tutto costruito intorno alla battuta finale che, giocando sul segno-suono del pronome di seconda persona, lo mette in relazione col verso della civetta (tu-tu, da cui il verbo tutubare). Si tratta, molto
probabilmente, di una invenzione di Plauto che non dipende da un eventuale originale greco. Il tipo di civetta cui si fa riferimento, la γλαῦξ, che corrisponde alla
noctua latina, è detta τυτώ, a imitazione del verso ‘tu tu’. Tuttavia in greco il gioco
di parole con il pronome di seconda persona è impossibile, almeno in attico, dove il
pronome è σύ.32 È, questa, la prima attestazione in latino del termine noctua, connesso alla vita notturna della civetta.33 In generale l’uccello è associato alla morte34
e anche alla magia e alla stregoneria, se ad esso si può affiancare ‒ come sembra ‒
31 “MA. Manca un mantello da casa. ME. E chi l’ha preso? MA. Beh, questo lo sa chi l’ha preso. ME. E
chi è? MA. Un certo Menecmo. MEN. È una carognata, quant’è vero Iddio. E chi è questo Menecmo? MA.
Proprio tu lì. ME. Io? MA. Tu. MEN. E chi lo dice? MA. Lo dico io. PE. E io. E l’hai portato qui alla tua
amica Erozio. MEN. Io gliel’ho dato? MA. Tu tu lì, ti dico. PE. Vuoi che ti porti una civetta che ti dica ‘tu
tu’ in continuazione? Perché ‘noi noi’ ormai siamo stufi”. Testo latino di A. S. Gratwick, Titus Maccius
Plautus, Menaechmi, Cambridge University Press, Cambridge, 1993. Traduzione mia.
32 Gratwick, Menaechmi, cit., p. 201. In dorico il pronome è τύ e in beotico τού.
33 Cfr. Varro, L. L. 5, 76. Il termine è usato solo qui da Plauto; in Curc. 191 si trova l’aggettivo
noctuinus.
34 Plinio, in N. H. 10, 34 la chiama avis funebris.
Pulci e pidocchi: i pronomi personali sulla scena plautina tra oralità e scrittura
249
la misteriosa strix.35 Il suo verso lugubre, simile a quello del gufo, bubo, è visto come presagio di tempesta o di sventura e associato al lamento delle anime dei morti.36 Gli studi sul folklore greco e latino degli uccelli testimoniano di diverse tradizioni, superstizioni e aneddoti riferiti all’animale.37 Così il volo, il grido e il posarsi
della civetta sono considerati presagi di cattiva salute38 e, in particolare, la sua apparizione durante il giorno. Uno scongiuro tramandato da Festo recita così in relazione alla strix: † στρίγγ’ ἀποπέμπειν νυκτίβοαν, τὰν στρίγγ’ ἀπὸ λαῶν † ὄρνιν
ἀνωνύμιον ὠκυπόρους ἐπὶ νῆας.39 Lo scongiuro è interessante perché ci testimonia la credenza che un grido notturno porti sfortuna e debba essere allontanato. In
realtà il corrispettivo della noctua latina è piuttosto la γλαῦξ cui fa riferimento un
frammento di Menandro: ἂν γλαῦξ ἀναχράγη δεδοίκαμεν, in un passo in cui un
personaggio enumera i mali che l’uomo causa a se stesso con la sua superstizione,
in aggiunta a quelli che la natura gli procura.40 Il grido della civetta, come lo starnuto, i sogni e le visioni, è oggetto di superstizione.
La battuta di Penicolo, dunque, non è poi così innocente: il richiamo alla civetta
ha implicazioni oltremodo sgradevoli e uin adferri noctuam? è una proposta velatamente minacciosa, visto che di solito ci si preoccupa di mandare via l’animale.
Il riferimento di Penicolo al verso della noctua, ricco di suggestioni e significati nella
sua icastica brevità, è per così dire un racconto condensato in poche sillabe: il tu-tu
della civetta è contemporaneamente suono e segno, allocuzione e lugubre minaccia41
35 Plin. N. H. 11, 232. Sui vari tipi di civette nel mondo antico cfr. Cfr. August F. von Pauly, Georg
Wissowa, Paulys Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, J.B. Metzlersche
Verlagsbuchandlung, Stuttgart, 1931, VI, s.v. “Eule”, pp. 1064-1071 e Pauly-Wissowa, Paulys
Realencyclopadie, cit., Zweite Reihe (R-Z), VII, s.v. “Striges”, pp. 356-363. Cfr. anche Hubert Cancik,
Helmuth Schneider, Manfred Landfester, Christine F. Salazar, Brill's New Pauly Encyclopädia of the Ancient World, Brill, Leiden Boston, 2007, vol. 10, s.v. “Owl”, pp. 307-310. L’associazione delle striges o
strigae con le streghe sarebbe tutta latina: cfr. John C. Lawson, Modern Greek Folklore and Ancient Greek
Religion: a Study in Survivals, Cambridge University Press, Cambridge, 1910, pp. 180-184. Sul nome,
connesso a stringo più che a strido, cfr. Rosa Ronzitti, “L’etimologia di latino strix tra indoeuropeistica e
romanistica”, Romance Philology, 63, 2009, pp. 183-193.
36 Virg. Georg. 1, 403; Ov. Met. 5, 549: venturi nuntia luctus; Plin. N. H. 18, 362.
37 Ernest Ingersoll, Birds in Legends, Fable and Folklore, Longmans, Green and Co., Toronto, 1923, pp.
180-190.
38 Cfr. lo scongiuro apotropaico γλαῦξ ἴπταται “la civetta vola” citato da Carl Sylvio Köhler, Das
Tierleben im Sprichwort der Griechen und Römer. Nach Quellen und Stellen in Parallele mit dem deutschen
Sprichwort, Commissions-Verlag von L. Fernau, Leipzig, 1881, pp. 42 ss.
39 “Che vada via la strige che grida di notte, la strige dalle genti, uccello innominabile sulle navi
veloci”, cfr. Wallace M. Lindsay, Sexti Pompei Festi, De uerborum significatu quae supersunt cum Pauli
epitome, B.G. Teubner, Lipsiae, 1913, p. 414, ll.17-31, e p. 415. Lo scongiuro è riportato nell’epitome di
Paolo Diacono a Festo che, secondo l’integrazione di Müller seguito da Lindsay, citerebbe Verrio che a
sua volta riporta il detto greco. Cfr. Ronzitti, “L’etimologia...”, cit., p. 185.
40 Menandro, Fr. 620 Koerte 1959 (= 534 K), v. 11. “Abbiamo paura quando la civetta grida”. A
quanto ho potuto vedere si tratta dell’unica attestazione del termine in Menandro.
41 Diverso il tu tu puramente fonico e allitterante del personaggio di Nottola, ne Lo schiavetto di
Gianbattista Andreini del 1612, atto I scena I, che, distribuendo soldi e camicie agli scrocconi che lo
seguono, li apostrofa così: “Portamele qua. To’ tu! Tu, ancor tu! Vien qua tu! Tu! Fatti innanzi! Tu
250
Maria Cristina Zerbino
che, rivolta a Menecmo, doveva essere particolarmente azzeccata. Nell’Oneirocritica di
Apollodoro si trova infatti una interpretazione secondo la quale sognare una civetta,
come altri animali notturni, sarebbe un riferimento a adulteri o ladri:42 l’animale che
dice tu-tu rappresenta esattamente ciò di cui la matrona e il parassita accusano Menecmo. La battuta è a mio avviso un esempio di come il racconto orale, o alcune delle
sue caratteristiche, possano essere trasposti sulla scena. In un processo di tipo metonimico, il respiro ampio della narrazione, permesso al racconto orale, viene qui compresso nel motto finale: della storia resta l’eco evocatore che basta per ricordarla tutta o, a
buon bisogno, per immaginarne una nuova. Non sapremo mai se Plauto avesse in
mente una storia o se la inventasse in quel momento, ma è suggestivo pensare che
sotto quel tu-tu potesse esserci un aneddoto, magari divertente come la storia del povero Bobby Hall:
More than fifty years ago, a local ‘character’, named Robert Hall, was returning home
through the woods late one night and lost his way. ‘Man lost!’ shouted the frightened
traveller. ‘Whoo! whoo!’ cried the owl. ‘Bobby Hall; lost in the Three Mile Bottom!’
replied the man. This went on for hours. The story reached the ears of the townspeople, and ‘Bobby Hall’ was famous ever after.43
Anche qui il verso della civetta viene semantizzato e il suono diventa segno linguistico, parola detta, anche se involontaria, che risponde a una richiesta e, a sua
volta, pone una domanda. L’oralità del teatro è quella del discorso, di un io che si
rivolge al tu, ma nel tempo ritmato dalle esigenze dell’azione il racconto orale può
trovare il suo spazio che, breve un lampo, basta da solo a illuminare e a farsi notare
“come la civetta quando di giorno compare”.44
prendi questa! Tu questa, tu questa, tu pure questa, questa e così ancor tu! Tu, benché picciolo, to’
questa, ci farai duo fazzoletti ancora! E così ancor tu di quest’altra”. Cfr. Laura Falavolti (a cura di),
Commedie dei comici dell'arte, UTET, Torino, 1982. Il segno assume qui un valore fonosimbolico
nell’imitazione del verso animalesco. A proposito di civette e di tradizioni popolari, è interessante il
raffronto con il personaggio del folklore tedesco Till Eulenspiegel nel cui nome si trovano associati la
civetta e lo specchio che, in un certo senso come il pronome tu, rimanda l’immagine dell’interlocutore.
Su una rilettura teatrale recente del personaggio si veda la relazione di Gabriella Sgambati, “Till
Eulenspiegel di Tawada Yoko: tra magie e straniamenti linguistici”, infra, pp. 123-132.
42 Cfr. Artemidorus, Oneirocritica, Text, Translation and Commentary by Daniel E. Harris-Mc Coy,
Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 348-349.
43 Charles Swainson, Provincial Names and Folk-Lore of British Birds, Trübner and Co., London, 1885, p. 130.
44 William Shakespeare, Henry VI, parte Terza, Atto V, sc. IV. La frase si trova in epigrafe a Leonardo
Sciascia, Il giorno della civetta, Einaudi, Torino, 1967. Il grido della civetta risuona spesso in Shakespeare,
si pensi a Macbeth, atto II, scena II, in cui, nel momento dell’assassinio del re, lady Macbeth esclama: “It
was the owl that shriek’d, the fatal bellman, / Which gives the stern'st good-night. He is about it”.
Anche qui un racconto si condensa in pochi tratti: la civetta è paragonata al guardiano notturno che
suona la campana per chiamare il prigioniero alla forca e ricordare a tutti gli altri la prossimità della
morte. Del resto, come ricorda John Donne: “never send to know for whom the bells tolls; it tolls for
thee”.
LUIGIA TESSITORE
CANTASTORIE DA CABARET: ATTUALIZZAZIONE DEL BÄNKELSANG
NEL CABARET TEDESCO DEGLI ANNI ’20
L’etimologia della parola “cabaret”, proposta dal volume etimologico del dizionario “Duden”, è sufficiente per cogliere la natura molteplice di questa forma
d’arte, così difficile da sussumere in una categoria omogenea:
Das Fremdwort, das auch in der Bedeutung ‘(drehbare) mit kleinen Fächern versehene Platte für Speisen‘ gebräuchlich ist, wurde Ende des 19. Jahrhunderts aus frz.
Cabaret „Kleinkunst(bühne); Restaurant; Satz Gläser mit Flasche“ entlehnt. Das französische Wort seinerseits stammt aus mittelniederländisch cabret (Nebenform von
cambret, cameret), das zu dem unter Kammer behandelten Wort gehört und eigentlich „Kämmerchen“ bedeutet.1
L’etimo, che riecheggia quello della satira latina, rimanda a un piatto da portata
per pietanze diverse, alludendo fin da subito all’idea della pluralità e della coesistenza del diverso, concetto che ritorna in qualsiasi tentativo di enucleare l’essenza
di cabaret.2
Volendo tentare una sommaria definizione di questa singolare forma d’arte, risulta lampante la sua componente drammatica, fatta di azione scenica, danza, movimento. Tuttavia codesti aspetti performativi non esauriscono in toto l’essenza del
cabaret. Fin dalla sua formulazione originaria e nel suo sviluppo nel primo ventennio del Novecento il cabaret è anche e soprattutto oralità; oralità del canto e
della parola raccontata e declamata. È solo in questa compresenza mediale, in questa cornice polimorfa di parola, musica e performance che si può comprendere
adeguatamente il ruolo trainante svolto da generi popolari come chanson e ballate
nel repertorio programmatico del cabaret.
Fin dal capostipite parigino, il leggendario “Chat Noir” aperto a Montmartre
nel 1881, il cabaret mostra il suo volto ibrido, variegato, innovativo. Nel piccolo
locale sorto al numero ottantuno di Boulevard Rochechouart, nel quartiere degli
artisti parigini, si offriva un intrattenimento di vario genere che spaziava dalla
declamazione di versi a spettacoli di ombre cinesi, senza escludere intermezzi teatrali veri e propri. Tuttavia in questo diversificato programma una posizione del
1 Günther Drosdowski (a cura di), Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache, Band 7, Dudenverlag, Mannheim, 2001.
2 Per le teorie sul cabaret si rimanda in ambito tedescofono alla lettura dei tre principali contributi
sul tema: Jürgen Henningsen, Theorie des Kabaretts, Henn, Düsseldorf-Benrath, 1967; Michael Fleischer,
Eine Theorie des Kabaretts, Brockmeyer, Bochum, 1989 e Benedikt Vogel, Fiktionskulisse – Poetik und Geschichte des Kabaretts, Mentis Vlg., Paderborn, 1993.
252
Luigia Tessitore
tutto peculiare era ricoperta dall’esecuzione di chanson, destinate a diventare simbolo del cabaret artistique di fine secolo.
La chanson è un genere profondamente radicato nella cultura francese a tal
punto che, secondo lo scrittore Boris Vian, “Wer in Frankreich ein Gedicht schreibt,
schreibt ein Chanson. Wer in Frankreich ein Chanson schreibt, schreibt ein Gedicht”.3
Nata come canto di guerra, composta per celebrare le vittorie dei Merovingi e la
successiva nascita del loro regno, la chanson si sviluppa nei secoli come racconto in
musica, trasposizione in versi e melodia del quotidiano, della realtà storica e politica del tempo, un vero e proprio “specchio della quotidianità”, adottando la definizione dello studioso Reinhardt Hippen.4
Lo sguardo impietoso, critico, disincantato della chanson, dalle origini fino alle
derive del cabaret parigino, legittima la definizione di Heinrich Mann che ribattezzò tali componimenti “Lieder der Empörung,5 ovverosia “canti dello sdegno”,
strumenti eterei e incisivi al tempo stesso, usati fin dall’antichità per veicolare
l’indignazione di una qualsivoglia collettività rispetto a una sovrastruttura opprimente. Ed effettivamente a questo scopo precipuo si prestano le chanson, che nei
secoli declinano variamente la collera del popolo francese. Gli esempi in questo
senso sono molteplici: dalle violente invettive anticlericali e antiaristocratiche di
Francois Villon nel Quattrocento alle canzoni parodistiche indirizzate a Richelieu e
Mazzarino durante l’assolutismo, ai canti che i rivoluzionari intonavano ai piedi
della ghigliottina durante la rivoluzione del 1789.6
La critica parodistica ai costumi corrotti delle classi nobiliari costituisce il tratto
più vistoso del genere ma non ne esaurisce il ricco ventaglio di possibilità tematiche. In questo senso è esemplare l’affermazione del commediografo francese Maurice Donnay che a proposito delle chanson scrive: “Si cantano chanson di ogni tipo:
scandalose, ironiche, delicate, naturalistiche, idealistiche, ciniche, liriche, nebulose,
maschiliste, repubblicane, reazionarie – tutto fuorché chanson noiose”.7
Una prerogativa, questa, quanto mai valida nel cabaret di fin de siècle, che nasceva principalmente come un luogo d’intrattenimento, per quanto ‘intellettuale’
volesse definirsi. Le chanson di questo periodo, pur smorzando notevolmente i
toni accesi e violenti del passato, conservano inalterato lo sguardo critico sulla
realtà circostante. Uno sguardo che, cinico e disincantato, si posa sulle periferie
3 Reinhard Hippen, Das Kabarettchanson. Typen, Themen, Temperamente, Pendo Verlag, Zürich, 1986,
p. 10.
4 Ibid.
5 Heinrich Mann, Verteidigung der Kultur, Claassen, Hamburg, 1960, pp. 473-474.
6 Il percorso storico-culturale della chanson è tracciato approfonditamente in Heinz Greul, Bretter,
die die Zeit bedeuten. Die Kulturgeschichte des Kabaretts, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1967.
7 Pierre Barbier, France Vernillat, Histoire de France par les chansons, Gallimard, Paris, 1961, p. 76
(Traduzione mia).
Cantastorie da cabaret: attualizzazione del Bänkelsang nel cabaret tedesco degli anni ’20
253
degradate e malsane della metropoli, abitate da delinquenti, prostitute e derelitti,
protagonisti delle chanson portati in scena da Aristide Bruant o Yvette Guilbert, tra
gli interpreti più noti del cabaret artistique di fine secolo.
Senza la tradizione della chanson francese non si potrebbe comprendere la nascita e l’evoluzione del cabaret in area tedescofona. L’esperimento di Rodolphe
Salis e la diffusione di numerosi altri cabaret in Francia contribuirono a esportare il
nuovo genere fuori dai confini nazionali. Il modello dello “Chat Noir” rappresentò
una premessa imprescindibile per il primo esempio di cabaret letterario tedesco, il
“Buntes Theater”, inaugurato a Berlino nel 1899. Rinominato “Überbrettl”,8 il cabaret condivideva con il capostipite parigino il medesimo atteggiamento intellettualistico, ma d’altra parte radicalizzava l’intento programmatico di farsi portatore di
un sensazionale rinnovamento delle arti.
Il suo fondatore, lo scrittore e attore Ernst von Wolzogen, intendeva raccogliere
la sfida lanciata dal personaggio letterario Stilpe, il bohemien protagonista
dell’omonimo romanzo di Otto Julius Bierbaum9 che sognava di imprimere alla
propria epoca una sospirata e necessaria rivoluzione artistica e culturale, coniugando sapientemente arte e intrattenimento attraverso ‘Momus’, un teatro di varietà d’impronta letteraria. Nei suoi sogni di gloria, Stilpe vagheggiava: "Die Renaissance aller Künste und des ganzen Lebens vom Tingeltangel her! […] Wir werden
eine neue Kultur herbeitanzen! […] Lustig und lustig werden wir diese infame,
moralklapprige Welt wieder machen, lustig und himmlisch frech!". 10
Nelle intenzioni del suo iniziatore, il “Buntes Theater” avrebbe dovuto acquisire una propria, distintiva specificità, evitando di diventare una semplice imitazione
del suo progenitore parigino. Per evidenziare questa separazione, quindi, il ‘Barone del Brettl’, come veniva denominato Wolzogen, decise di fondare il suo cabaret,
invece che in un comune ristorante, in una piccola sala teatrale dotata anche di un
palco, di attori professionisti e di uno certo spazio per l’orchestra.
Come per lo “Chat Noir”, anche nel “Buntes Theater” berlinese la chanson assume ben presto un ruolo trainante nel caleidoscopico repertorio offerto da questa
nuova forma d’intrattenimento. Il modello francese, reso famoso dalle iconiche
performance di Bruant e Guilbert, costituisce, di fatto, una base irrinunciabile per
poeti e interpreti del nascente cabaret tedesco i quali, tuttavia, guardano con rinnovato interesse anche al proprio passato letterario, recuperando generi popolari
che sembrano rispondere con insperata prontezza alle esigenze performative di
questa nuova arte. Fonti d’inspirazione divennero quindi la Volksballade, che aveva
8 Le suggestioni vitalistiche di Nietzsche, irrinunciabile “padre spirituale” degli intellettuali
dell’epoca, sono facilmente rintracciabili. Il nome Überbrettl, chiaro calco da Übermensch, allude alla
volontà di superare il comune Brettl, il chiassoso e spesso triviale spettacolo di varietà diffusosi in
Germania dagli anni novanta dell’Ottocento.
9 Otto Julius Bierbaum, Stilpe. Ein Roman aus der Froschperspektive, Schuster und Löffler, Berlin, 1897.
10 Ivi, p. 359.
254
Luigia Tessitore
già incontrato un cospicuo interesse letterario grazie allo studio sul genere condotto da Herder,11 il Bänkelsang e il Moritat.
Il Bänkelsang è un genere sviluppatosi tra il XVII e il XVIII secolo. Il termine deriva da Bank, la pedana sulla quale si esibivano i cantastorie durante i mercati e le
fiere, attirando così l’attenzione degli astanti e inducendoli a comprare la propria
merce, generalmente dei libricini che recavano le storie appena raccontate. Spesso
il cantastorie o Bänkelsänger si avvaleva anche del supporto d’immagini (Schild) per
illustrare adeguatamente la storia da lui cantata, creando un variegato complesso
di segni che combinava sapientemente immagini, parole e musica, tale da poter
definire il Bänkelsang un vero e proprio “audio-visuelles Medium” in embrione.12
La finalità intrinseca del genere era principalmente di natura commerciale: è
spiegato così lo stile di questi componimenti, fondato su descrizioni lunghe e dettagliate che preferivano un’aggettivazione caricata ‒ se non addirittura eccessiva ‒
atta a marcare il carattere sensazionale delle storie narrate e a sopperire alle loro
esili trame. Il repertorio tematico del genere è particolarmente vario: per lo più
venivano trattati casi giudiziari e processi, storie d’amore, calamità naturali e curiosità mondane. Pur nella loro intrinseca eterogeneità, questi temi rispondevano a
un’unica, principale prerogativa: l’attualità. Chiaramente si tratta di un concetto di
attualità del tutto relativo, come puntualizza a questo proposito lo studioso Leander Petzoldt nel suo volume sul Bänkelsang:
In einer Zeit, die noch keine Massenmedien in unserem Sinne kannte und in der sozialer Konnex nur zu einem geringen Teil durch Druckwerke, Flugblätter, häufiger
jedoch nur durch die persönliche Kontaktnahme einer Gewährsperson ermöglicht
wurde, konnte der Begriff Aktualität nur relative Gültigkeit besitzen. Aktuell war alles, was der Masse fremd und unbekannt sein musste und was aus dem Alltagsleben
herausragte.13
All’interno della grande varietà di temi, in particolare, le storie incentrate su delitti efferati e su criminali senza scrupoli finirono col tempo per acquisire una propria autonomia di genere e, tramandate con il nome di Moritat, costituirono un
sottogenere dalla categoria Bänkelsang. Il dizionario bilingue “Langenscheidt” riporta il termine Moritat come intraducibile, fornendo in alternativa la definizione:
“Ballata dei cantastorie da fiera che narra un fatto di sangue”. L’etimologia del
termine risulta infatti piuttosto oscura: secondo Petzoldt potrebbe ricondurre al
termine “Mordtat”, “assassinio”, oppure alla parola latina moritates (in francese
11 Johann Gottfried Herder, Auszug aus einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker in
Bernhard Suphan (a cura di), Herders Sämmtliche Werke, Bd. V, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin,
1891.
12 Leander Petzoldt, Bänkelsang. Vom historischen Bänkelsang zum literarischen Chanson, J.B. Metzlerische Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1974, p. 65.
13 Ivi, p. 10.
Cantastorie da cabaret: attualizzazione del Bänkelsang nel cabaret tedesco degli anni ’20
255
moralitée) in riferimento a quel genere di narrazione culminante in un insegnamento didascalico o morale.
Nel riadattamento cabarettistico dei succitati generi tale aspetto fu volutamente
obliato, privilegiando piuttosto il contrasto grottesco tra la tragicità della vicenda
narrata e l’atteggiamento quasi sornione del cantastorie. Contrariamente alla tradizione popolare cui si rifaceva, la chanson improntata al Moritat, nella scena cabarettistica degli anni ’20, non prevedeva alcun intento moralizzatore né tantomeno il
ripristino dello status quo attraverso la punizione del criminale. Al contrario, essa
eludeva ogni rassicurazione mirando piuttosto a rilevare la brutalità e il degrado
della moderna metropoli del dopoguerra.
I componimenti da fiera, declinati nelle plurime accezioni tipiche del genere,
esercitavano, proprio per la loro duttilità, un indiscusso fascino tra gli artisti del
cabaret tanto da costituire uno specifico filone per il repertorio cabarettistico tedesco di primo Novecento. La natura performativa di Bänkelsang e Moritat, infatti, si
adattava perfettamente alla forma ibrida e in fieri del cabaret che, pur riprendendo
una forma lirica di impianto tradizionale, la rinnovava nel repertorio tematico e
nella performance. I molteplici artisti che si misurarono con l’attualizzazione di
queste forme, infatti, marcarono ulteriormente la tendenza per il macabro, tipica
del Moritat, ottenendo inediti effetti comici attraverso la parodia di situazioni e
personaggi, altrimenti patetici o addirittura tragici.
I versi di Frank Wedekind, Walter Mehring e Bertolt Brecht, presentati
nell’analisi che segue, sono da considerarsi esemplificativi del percorso di riadattamento del canto da fiera nel cabaret tedesco di primo Novecento. Esiti di differenti istanze estetiche, essi sono tuttavia accumunati dall’interesse a sfruttare le
potenzialità espressive di una forma orale, proveniente dalla tradizione, adattata
nell’inedita e moderna cornice del cabaret. Se da un lato Wedekind si fa iniziatore
di questa tendenza, consegnando alla tradizione l’immagine del cantastorie moderno, distaccato enunciatore della storia e indifferente alla sua brutalità, dall’altro
Mehring e Brecht adattano il modello riportato in auge da Wedekind a nuove suggestioni. Il primo fa ricorso a un’ironia surreale, desunta dal Dadaismo, mentre il
secondo inserisce il modello del Bänkelsang tradizionale nella poetica dello straniamento.
Tuttavia, il percorso di ri-attualizzazione del canto da fiera nel cabaret del primo Novecento comincia imprescindibilmente da Frank Wedekind, uno dei maggiori protagonisti del cabaret letterario Die Elf Scharfrichter, fondato a Monaco nel
1901 con una propensione alla critica sociale e politica più marcata rispetto
all’Überbrettl berlinese. Tenendo ben presente la tradizione del Bänkelsang e del
Moritat, Wedekind canta ballate di seduzione e di sangue con l’impietoso distacco e
la cinica monotonia del cantastorie moderno. I fatti di crimini e delitti, tanto ricorrenti nel Bänkelsang tardo medievale, sono recuperati e caricati di una componente
consapevolmente più macabra, che stride tuttavia con il contegno neutrale e quasi
256
Luigia Tessitore
prosaico dell’interprete. Ne è un esempio Der Tantenmörder,14 ballata che Wedekind
portò in scena sul palco del cabaret monacense nel 1902, rifacendosi chiaramente ai
diversi topoi del Bänkelsang tradizionale,15 adattati al nuovo contesto storicoculturale. In linea con la tradizione popolare, ritroviamo anche alla base del Moritat
wedekindiano un fatto di sangue: un giovane uccide la vecchia zia dopo che
quest’ultima lo sorprende a rubare il ricco bottino di denaro e gioielli che lei avidamente nascondeva in casa.
Ich hab meine Tante geschlachtet,
Meine Tante war alt und schwach;
Ich hatte bei ihr übernachtet
Und grub in den Kisten-Kasten nach.16
Differentemente dalla maggioranza dei Moritat tradizionali, in cui la storia era
raccontata da una voce esterna ai fatti, in questo componimento Wedekind adotta lo
schema della Rollengedicht, la poesia in ruoli, altra creatura ibrida tra testo e performance, in cui il poeta-cantastorie si eclissa per lasciare spazio al personaggio. In questo caso è l’assassino a prendere direttamente la parola, facendosi carico di una confessione che, nel suo tono piatto e distaccato, produce un inconfondibile senso di
straniamento. A rinvigorire tale affetto contribuisce, inoltre, l’evidente contrasto tra il
tenore delittuoso della storia, accentuato dal linguaggio brutalmente visivo
dell’omicida,17 e il ritmo cadenzato, quasi cantilenante, della strofa, reso evidente
dall’uso della rima alternata (“geschlachtet”/”übernachtet”; “schwach”/”nach”).
Su questo modello s’innesta, poi, un altro motivo ricorrente del Bänkelsang, lo
Hinrichtungslied, il “canto dell’esecuzione”, in cui è l’assassino a prendere la parola.
Nel componimento wedekindiano, tuttavia, non assistiamo alla confessione di un
assassino penitente e schiacciato dal peso del proprio crimine. L’omicida, dopo
aver raccontato con ingenua e agghiacciante spietatezza il delitto di cui si è macchiato, si rivolge nell’ultima strofa al giudice, cercando nella sua gioventù
un’attenuante alla colpa commessa:
Ich hab meine Tante geschlachtet,
Meine Tante war alt und schwach;
14 Frank Wedekind, Manfred Hahn (a cura di), Ich hab meine Tante geschlachtet: Lautenlieder und
"Simplicissimus"-Gedichte, Lagen, München, 1967, p. 71.
15 Karl Riha, Moritat, Song, Bänkelsang. Die moderne Ballade, Sachse&Pohl, Göttingen, 1965 e Petzoldt,
Bänkelsang, cit., pp. 67 e ss.
16 Frank Wedekind, Ich hab meine Tante geschlachtet…, cit., vv. 1-4. “La zia ho massacrato / Mia zia era
vecchia e stanca / la notte da lei avevo passato / e rovistavo nella sua cassapanca” (traduzione mia).
17 Si consideri a questo proposito la scelta del verbo usato per descrivere l’omicidio: piuttosto che
adoperare verbi semanticamente “neutri”quali ermorden o umbringen (uccidere), il poeta opta invece per
schlachten che letteralmente significa ‘macellare’, conferendo, così, una qualità decisamente più brutale
alla confessione dell’io narrante.
Cantastorie da cabaret: attualizzazione del Bänkelsang nel cabaret tedesco degli anni ’20
257
Ihr aber, o Richter, ihr trachtet
Meiner blühenden Jugend-Jugend nach.18
A dispetto delle connotazioni brutali e violente, la storia narrata rivela una comicità inaspettata grazie all’uso sapiente dell’ironia, in grado di abbassare notevolmente la carica tragica della vicenda e contribuendo alla creazione di un umorismo nero e decisamente macabro.
L’attualizzazione di Bänkelsang e Moritat, portata al successo da Wedekind, prospera felicemente sulla scena del cabaret tedesco anche negli anni successivi. A
Berlino, che tra il 1919 e il 1924 diventa sede d’innumerevoli cabaret, famosi per
annoverare nelle proprie file i poeti e gli interpreti più in vista del tempo, opera, tra
gli altri, Walter Mehring, poeta vicino all’avanguardia storica, che trae dagli esperimenti Dada l’uso dissacrante dell’ironia facendone il tratto peculiare della sua
produzione per il cabaret. Ne è un esempio, la chanson Die Kartenhexe,19 che riprende la tradizione del genere Moritat, colorando di un’ironia corrosiva il racconto di un efferato crimine di sangue. Abbandonate le forme più sperimentali della
sua poesia, in questa chanson Mehring ricorre a una struttura chiaramente tradizionale, composta di nove strofe di quattro versi a rima baciata, che si confà meglio
all’andamento narrativo della lirica. Nelle brevi strofe della chanson si dispiega la
storia di una cartomante di Mulackstraße, dalle dubbie facoltà divinatorie ma dal
sicuro talento per la truffa, che fu rapinata e uccisa dalla strabica Elli e dal suo fidanzato-complice Tommy, entrambi poi condannati a morte per il delitto. Come
nel componimento di Wedekind, anche il finale di questo Moritat metropolitano
non lascia spazio ad alcun lieto fine; al contrario, nell’ultima strofa viene anticipato
il destino comune che attende tutti i protagonisti della chanson. La bocca
dell’Inferno è pronta ad accoglierli tutti: assassini, assassinata, giudice e boia.
Das Recht nahm den gewohnten Lauf.
Die Hölle nahm sie alle auf:
Das Paar selbdritt –
Richter, Henker, Hexe –
Alle sechse!20
Diversamente dall’impianto tradizionale del Moritat, che culmina con la punizione dei malvagi e l’insegnamento morale finale, il verdetto capitale dei due assassini non ristabilisce un ordine idilliaco del mondo che è impossibile a realizzarsi
in una realtà metropolitana dominata dall’inganno, dall’arrivismo, dalla violenza.
18 Frank Wedekind, Ich hab meine Tante geschlachtet…, cit., vv. 17-20. “Mia zia ho massacrato / Mia zia era
vecchia e stanca / Ma, vostro onore,voi abbiate a cuore / la mia bella gioventù in fiore.” (Traduzione mia).
19 Walter Mehring, Das Ketzerbrevier: ein Kabarettprogramm, K. Wolff, München, 1921, p. 93.
20 Ivi, vv. 33-37. “La giustizia fece il suo corso / L’inferno li accolse tutti / La coppia - in tre - /
Giudice, boia, maga / tutti e sei!“ (Traduzione mia).
258
Luigia Tessitore
Nel cabaret Wilde Bühne, dove Mehring ricopriva il ruolo di autore principale e
co-direttore, ogni settimana si dedicava una serata alla scoperta dei nuovi talenti.
Fu proprio durante una di queste serate, nel gennaio 1922, che si esibì anche il giovane Bertolt Brecht, portando in scena due chanson.21 Di queste, la Legende vom
toten Soldaten22 è una ballata satirica che racconta della follia dei generali tedeschi
che, di fronte alla sconfitta imminente, decidono di adoperare i cadaveri dei soldati
morti al fronte per rinforzare il reggimento ormai decimato. Prima di esibirsi, Brecht aveva apposto ai lati del palcoscenico una copia dei versi che si accingeva a
cantare. Questo espediente potrebbe essere interpretato come l’attualizzazione
dello Schild nel Bänkelsang tradizionale, in cui le immagini delle scene salienti della
storia supportava la narrazione del cantastorie e guidava la comprensione del
pubblico. Parallelamente nell’intento di Brecht, la presenza visiva dei versi durante
l’esibizione avrebbe dovuto coadiuvare l’interiorizzazione del messaggio senza
lasciar spazio a fraintendimenti da parte del pubblico.23
La canzone, di chiaro intento pacifista e antimilitarista, non fu accolta benevolmente, al contrario gli astanti reagirono con tale indignazione da costringere a far
calare anzitempo il sipario sull’esibizione del giovane drammaturgo. La chanson,
bistrattata dal pubblico del cabaret, trovò poi una sua più confacente collocazione
nel dramma Trommeln in der Nacht, pubblicato nel 1922.
La seconda chanson con cui si esibì Brecht nella sua fugace incursione nel cabaret è intitolata Apfelböck oder die Lilie auf dem Felde24 e appare molto più vicina allo
stile del Moritat wedekindiano. L’influenza di Wedekind sulla produzione letteraria del giovane Brecht è acclarata e ancora più manifesta nelle altre liriche che si
rifanno chiaramente al Bänkelsang. Tuttavia Brecht pare radicalizzare alcuni elementi dello stile del maestro Wedekind. L’atteggiamento di distacco quasi sardonico del cantastorie, già riscontrato nella ballata di Wedekind, in Brecht si priva di
ogni compiacenza o ironia. Al contrario, la posizione acritica e neutrale del narratore sembra essere anticipatrice della tecnica dello straniamento.
Straniante è, inoltre, lo sfalsamento tra finzione letteraria e verità storica percepibile fin dalla trama della ballata. Diversamente dagli esempi finora citati, alla
base della chanson brechtiana vi è, per la prima volta, un fatto di cronaca: il sedicenne Joseph Apfelböck, che diventa Jakob nella lirica di Brecht, si macchiò
dell’uccisione dei genitori a Monaco nel 1906. Fatta eccezione per l’andamento
21 Helga Bemmann, Berliner Musenkinder-Memoiren. Eine heitere Chronik von 1900 – 1930, Lied der Zeit
Musikverlag, Berlin, 1987.
22 Bertolt Brecht, Poesie 1918 – 1933. Traduzioni di Emilio Castellani e Roberto Fertoniani, Einaudi,
Torino, 1968, p. 204.
23 Gerald Alan Fetz, The Political Chanson in German Literature from Wedekind to Brecht, UMI
Dissertation Information Service, Ann Arbor, 1973.
24 Brecht, Poesie, cit., p. 12.
Cantastorie da cabaret: attualizzazione del Bänkelsang nel cabaret tedesco degli anni ’20
259
melodico dei versi, conferito dalla struttura strofica a rima alternata, fin dalla prima strofa traspare una lucida, quasi giornalistica, esattezza:
Im milden Lichte Jakob Apfelböck
Erschlug den Vater und die Mutter sein
Und schloß sie beide in den Wäscheschrank
Und blieb im Hause übrig, er allein.25
Differentemente dal componimento di Wedekind, nella ballata brechtiana siamo di fronte a una narrazione in terza persona, che risponde più fedelmente
all’impianto originale del Bänkelsang in cui è il cantastorie e non il personaggio a
presentare il racconto. Il Tantenmörder di Wedekind voleva essere una parodia del
genere Bänkelsang, in grado di creare uno slittamento comico attraverso lo stridente
contrasto tra brutalità della storia narrata e distacco performativo del cantastorie.
In Brecht, invece, è recuperata quasi fedelmente la funzione originaria del genere:
racconto informativo, quasi giornalistico, di un evento sensazionale e fuori
dall’ordinario.
Anche in questo caso, come nei componimenti prima analizzati, è assente ogni
intento moralizzatore, che è invece presente nella formulazione tradizionale del
genere, destinata a una società dotata di un sistema di valori rigidamente strutturato. Nel primo ventennio del Novecento, secolo sopravvissuto a fatica all’orrore del
primo conflitto mondiale, è elusa infatti qualsivoglia rassicurazione sul ripristino
di un fantomatico status quo. Il cantastorie Brecht, avvertendo la necessità di veicolare una consapevolezza sociale e politica nel suo uditorio, denuncia una violenza
cieca e senza scopo, che risulta per questo ancora più agghiacciante, gelida e sorda,
come la risposta di Jakob sul perché del suo delitto:
Und als sie einstens in dem Schrank ihn sahn,
Stand Jakob Apfelböck im milden Licht.
Und als sie fragten: Warum er's getan,
Sprach Jakob Apfelböck: "Ich weiß es nicht.26
Qui lo straniamento non è un esito comico del conflitto tra parola e performance, ma il risultato di una specifica linea operativa. Differentemente dai suoi predecessori, infatti, Brecht conferisce al sistema polisemico desunto dal Bänkelsang fatto
di parola, gesto e musica, una componente immaginifica e mimetica in grado di
produrre una Verfremdung, un vero straniamento nel pubblico.
25 Brecht, Poesie, cit., p. 12, vv. 1-4. “In mite luce Jakob Apfelböck / ammazzò suo padre e sua madre
/ li chiuse tutt’e due nel guardaroba / E restò nella casa, solo lui.”
26 Ivi, vv. 33-36. “E quando una volta nell’armadio guardarono / in mite luce stava Jakob Apfelböck.
/ E quando gli chiesero perché l’avesse fatto / Jakob Apfelböck rispose: non lo so.”
260
Luigia Tessitore
Dall’analisi tracciata finora emerge che, pur nella sostanziale eterogeneità di intenti, Wedekind, Mehring e Brecht sembrano riconoscere nella forma del canto da
fiera, nella sua inedita compresenza di differenti registri mediali, un precedente
niente affatto trascurabile nell’universo variegato del cabaret di primo Novecento,
che afferma con forza il potere immortale dell’affabulazione orale, per quanto ibridata e potenziata dalla componente drammatica e musicale.
FATIMA SAI
IL CORPO DEL POETA.
ORALITÀ SECONDARIA NELLA POESIA ARABA CONTEMPORANEA:
MUZAFFAR AL-NAWWAB
Scrive Adriana Cavarero nel suo A più voci. Filosofia dell’espressione vocale: “C’è
un campo della parola dove la sovranità del linguaggio si arrende a quella della
voce. Si tratta, ovviamente, della poesia”. E aggiunge: “Ogni voce, viene certamente da una persona, unica irripetibile, come ogni persona”.1
Sullo stesso tema Alessandro Portelli scrive:
Nel linguaggio della critica letteraria ‘voce’ è oggi un temine tecnico che indica la peculiarità dello stile di un poeta o più in generale di un autore. […] Tale uso è interessante soprattutto per il suo rimando a un’unicità vocalica che resta sottintesa e all’un
tempo, viene stravolta e destituita del suo registro sonoro. […] Il fatto che non esistano due voci umane assolutamente identiche fa sì che in letteratura ‘voce’ divenga
equivalente generale di differenza espressiva perdendo ogni riferimento all’oralità.2
L'unicità del profilo dell’autore che qui presentiamo risiede non solo nel suo stile unico e personalissimo, ma è legata alla unicità carnale della sua voce e della
macchina-corpo che la produce e riproduce; è connessa alla sua ‘persona’ in senso
fisico ed etimologico. L’interesse che ha per noi la sua opera, infatti, è strettamente
connesso alla forma grazie alla quale i suoi testi hanno potuto circolare nei Paesi
arabi, afflitti dalle durissime restrizioni della censura.
Muzaffar al-Nawwab, nato nel 1934 a Baghdad e ancora vivente e operante,
comincia a scrivere molto giovane e pubblica presto due antologie. Nel 1963 viene
incarcerato per la sua affiliazione al partito comunista che nel frattempo era stato
messo al bando. In carcere scriverà uno dei suoi testi ancora oggi più noti,
L’innocenza, in cui racconta della terribile condizione dei detenuti politici che venivano rimessi in libertà senza un motivo apparente per far credere a chi stava dentro e fuori dal carcere che avessero confessato. La loro vita quindi era distrutta,
insieme a ogni forma di solidarietà della comunità, con una pratica che aveva il
deliberato intento di frantumare la coesione dell’opposizione politica.3 Era
senz’altro la prima volta in cui si parlava pubblicamente di questo argomento, ben
noto a tutti, ma che continuava ad essere tabù. Oltre che per l’inedito attacco al
regime, questo testo è importante per il modo in cui dal carcere esce e si diffonde.
Adriana Cavarero, A più voci. Filosofia dell’espressione vocale, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 16.
Alessandro Portelli, Il testo e la voce, Manifestolibri, Roma, 1992, p. 29.
3 A causa di questo testo (che è in realtà un testo doppio, composto di due parti distinte: L’innocenza
della madre – L’innocenza della sorella) al-Nawwab riceverà un aumento della pena detentiva.
1
2
262
Fatima Sai
Perché si diffonde sulle bocche dei compagni di detenzione di al-Nawwab, che
l’avevano imparato a memoria e una volta fuori l’hanno ripetuto in una catena da
allora non si è più interrotta.4
Questa strategia di aggiramento del controllo e della censura, dunque, porterà
al-Nawwab ad una scelta di vita e di pratica poetica radicale: deciderà di non pubblicare quasi più per iscritto.5 Se la carta stampata può essere fermata e costituire
anche motivo di condanna a morte, allora la poesia può ripartire dal suo grado
zero ed essere flatus vocis. Sparisce il corpo del reato e resta il corpo. Il suo corpo, la
sua viva voce diventano la frontiera della resistenza poetica e politica, recuperando
e rielaborando l’antichissima tradizione orale araba, una pratica che almeno dal
sesto secolo, da Suq ‘Ukaz ad oggi, ha continuato a permanere in forme diverse,
dalle più popolari alle più colte in ogni epoca.6
Le vicende biografiche di al-Nawwab si intrecciano con quelle tormentate
dell’Iraq negli anni che hanno seguito la nascita della repubblica, fino alle alterne
fasi che l’hanno visto condannato alla clandestinità e infine all’esilio, durato più di
40 anni. Solo nel 2011 Muzaffar al-Nawwab è riuscito a rivedere il suo Paese dopo
lunghe peregrinazioni, scritture, studi, lotte politiche e reading poetici tenuti in
gran parte del mondo.
4 Salaam Yousef, “Oppression and Defiance in the Poetry of Muzaffar al-Nawwab”, Alif-Journal of
Comparative Poetics, Human Rights and People’s Rights in Literature and the Humanities, 13, American University in Cairo Press, 1993.
5 Il corpus delle opere a stampa rilasciate dall’autore si compone di quattro raccolte in totale, due in
fusha, arabo standard, e due in ‘ammiyya, nella variante regionale (nello specifico quella dell’Iraq
meridionale, pur non essendo la sua variante natìa). Tuttavia, la produzione a lui attribuita e circolante
tramite diversi altri canali di diffusione è indubbiamente più vasta.
6 Con il nome di “Suq ‘Uzaz” è conosciuto un noto festival di poesia che si teneva annualmente nei
pressi della Mecca preislamica e che vedeva radunarsi poeti e cantori di tutte le tribù dell’Arabia, per
contendere nella loro arte esibendosi dinanzi ad un folto pubblico. La questione dell’oralità nella poesia
araba classica è da sempre stata considerata come elemento fondamentale nella composizione della
forme tradizionali dei poemi e come consustanziale della loro struttura narrativa. Tuttavia è solo a
partire dagli anni settanta del Novecento che si è iniziato a comprendere appieno le implicazioni di
questa affermazione. Nel suo saggio Oral Composition in pre-Islamic Poetry, James T. Monroe comincia ad
applicare sistematicamente la teoria della formularità di Milman Parry e Albert Lord per analizzare il
corpus della poesia araba preislamica, iniziando così un filone di studi che ha permesso di evidenziare
l’importanza dell’elemento orale della poesia colta in tutte le epoche e di gettare luce su alcuni fenomeni
popolari affatto marginali, che resistono praticamente in tutte le aree arabofone. (Cfr. James T. Monroe,
“Oral composition in pre-Islamic poetry”, Journal of Arabic Literature, 3.1, 1972, p. 1-53).
Ulteriori riferimenti a riguardo si possono trovare in: Thomas Herzog, “Orality and the Tradition of
Arabic Epic Storytelling,” in Karl Reich (a cura di), Medieval Oral Literature, De Gruyter, New York Berlin, 2012; Julie Scott Meisami, Structure and Meaning in Medieval Arabic and Persian Poetry, Routledge
Curson, London, 2003; Suzanne Pinckney Stetkevych, The Mute Immortals Speak: Pre-Islamic Poetry and
the Poetics of Ritual, Cornell Universtity Press, New York, 1993 e Id., The Poetics of Islamic Legitimacy: Myth, Gender, and Ceremony in the Classical Arabic Ode, Indiana University Press, Bloomington, 2002;
Michael Zwettler, The Oral Tradition of Classical Arabic Poetry, its Character and Implications, Ohio State
University Press, Columbus, 1978.
Il corpo del poeta. Oralità secondaria nella poesia araba contemporanea …
263
Pur con tutte le limitazioni alla mobilità e i rischi per la sua sicurezza personale,
al-Nawwab, infatti, non ha mai interrotto la pratica della lettura pubblica, andando
direttamente incontro al suo pubblico. Decine di suoi reading poetici si sono tenuti
in Medio Oriente, nel Nord Africa, in molti Paesi europei, negli Stati Uniti. E
ovunque gli eventi erano affollatissimi ed estremamente partecipati, sia che si
svolgessero in contesti di grande ufficialità che in piena clandestinità.
Quello di Muzaffar al-Nawwab, dunque, può essere pienamente definito come
fenomeno di oralità secondaria: la fase della composizione è scritta, mentre la pubblicazione e la diffusione avvengono per auralità.
Zumthor delinea un principio di classificazione di fenomeni di oralità in tre categorie, sulla base della loro relazione con la tradizione:
- Oralità a ritmo lungo – ovvero in piena continuità con la tradizione (sopravvivenza
o reliquia).
- Fenomeni frutto di accelerazione (regionale o universale, che si producono cioè sotto l’impatto di un avvenimento che sconvolge l’immaginazione o la coscienza della
comunità).
- Rottura (sopravviene nel momento in cui il cambiamento delle condizioni
dell’esistenza tocca un punto critico e investe valori sentiti come essenziali). 7
Nel caso di Muzaffar al-Nawwab non possiamo indicare come esclusivamente
pertinente nessuna di queste alternative, perché sono tutte vere, dal punto di vista
performativo, letterario e linguistico. La sua azione, come abbiamo visto, rientra in
una pratica che, pur presentandosi in forme diverse, non si è mai interrotta nel
mondo arabo. Il contenuto e la forma dei suoi testi si agganciano alla tradizione
letteraria più alta per l’uso di temi, stilemi e lemmi, ma le sue opere sono direttamente connesse anche alla contemporaneità, all’accelerazione storica che ha subìto
il mondo arabo negli ultimi decenni e che ha imposto alla vita culturale rapidi
cambiamenti. Le guerre, ad esempio, – non solo quelle arabo-israeliane ‒ hanno
modificato l’immaginario culturale di riferimento e il repertorio retorico, determinando anche un’impennata nell’uso delle forme dialettali come lingue letterarie.
Infine l’opera di al-Nawwab può essere letta anche come reazione ai rivolgimenti storici legati alle influenze del neocolonialismo, che hanno messo in pericolo
la continuità delle forme culturali tradizionali e in molti casi la stessa solidità linguistica. Ed è proprio questa rottura che il poeta denuncia e cerca di colmare con il
suo monito politico, il suo richiamo alla memoria storica e alla fedeltà alla lingua.
Nei suoi versi, nel suo modo di porgerli, nel suo ‘essere l’opera’, si ritrova tutta
la complessa relazione con una tradizione che è in parte da salvare e in parte da
ricostruire.
7
Paul Zumthor, La presenza della voce, introduzione alla poesia orale, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 81.
264
Fatima Sai
Da questo breve estratto dall’incipit di una delle sue opere più note, si possono
subito individuare alcuni degli elementi tipici della poesia orale. Il titolo del componimento è Abdullah il terrorista, un lunghissimo e amaro poema sullo stereotipo
internazionale dell’arabo. Abdullah, l’uomo qualunque, l’uomo medio, è per tutti,
ovunque e sempre un terrorista, immagine alla quale farebbe bene ad aderire una
buona volta, e “compiere un lavoro prima di cena” come dice al-Nawwab incitando il suo protagonista.
La notte e Abdullah sono parenti.
La grappa fredda, il fuoco, la tristezza dei giorni e Abdullah sono parenti.
Capisce di onde,
e preferisco chi costruisce due remi e non ha bastimenti.
Lotta, le ciglia in avanti,
malgrado schiere di eroi, lui, sposta pareti.
È genero del fuoco dei giorni.
Mi piaci Abdullah per te stesso adirato,
con te stesso arrabbiato.
Il tuo mitra celebra il suo summit da solo e sul loro summit mettici le suole.
Schiaffeggiali Abdullah con la suola delle scarpe
ché la storia ha generato serpenti.
Cala su loro la cerniera dei tuoi calzoni
e avrai calato loro le braghe,
e una delibera che apre le cosce
e sedute a porte chiuse e altre cose senza precedenti.
Apri il fuoco col tuo fucile da guerra Abdullah
apri così la loro seduta, nemici e parenti.8
Il poema continua per oltre settecento versi, costituendo una sorta di saga epica
di un contro-eroe. Ogni volta, nelle sue performance, come da tradizione, l’autore
decide al momento se leggerlo tutto o selezionarne delle parti, anche su richiesta
degli astanti.
Ma oltre ai reading, in cui la poesia si trasmette direttamente ai partecipanti in
un’esperienza unica e irripetibile, sono state le registrazioni audio prima, audiovideo in seguito, a diffondere la voce poetica di al-Nawwab nei più lontani angoli
del mondo arabo. Chiunque partecipasse a questi eventi poteva liberamente produrre delle registrazioni samizdat9 su qualunque supporto e immetterli poi, liberamente, in una circolazione fluida e inarrestabile.
8 Muzaffar al-Nawwab, Al-a’mal al-shi’riyya al-kamila, Dar Qanbar, London, 1996. Si tratta di una
pubblicazione non licenziata dall’autore. Per questa traduzione ‒ realizzata da chi scrive ‒ si è
confrontato il “testo” con altre versioni, disponibili in registrazione dalla voce dell’autore, e altre ancora
trascritte da terzi fra cui gli estratti pubblicati nel saggio di Carol Bardenstein, “Stirring Worlds:
Traditions and Subversions in the Poetry of Muzaffar al-Nawwab”, Arab Studies Quarterly, 4, 1997.
9 Cioè “autoprodotte”. Si è voluto utilizzare questo termine russo, che ha definito il fenomeno di
diffusione clandestina di scritti censurati dalle autorità sovietiche, per ampliare l’orizzonte
Il corpo del poeta. Oralità secondaria nella poesia araba contemporanea …
265
Nel 1974, convinto da alcuni amici di una nota casa editrice, al-Nawwab pubblica finalmente una nuova raccolta stampata, ma corredata di due audiocassette
su cui ha inciso la lettura delle sue opere. In tal modo, quindi, pur concedendosi ai
mezzi tradizionali della letteratura, al-Nawwab conferma ancora una volta il primato della voce, dell’esecuzione e del suono sulla scrittura, per la loro natura di
riverbero, estremo residuo corporeo. La vera forza delle sue parole ‒ violenti attacchi politici o inebrianti lamenti amorosi che siano ‒ sta in quell’essenza impalpabile, in quel soffio di fiato, in quella grana unica al mondo, da tutti riconoscibile, con
cui continua la sua programmatica azione rivoluzionaria, uccidendo, o azzerando
la metafisica della letteratura.
La sua è una precisa scelta politica e filosofica: la poesia si dà dove c’è corpo; si
dà dove i corpi si incontrano e vibrano all’unisono; il corpo è la sede, il mezzo, il
senso primo e ultimo della poesia. E questo corpo è un corpo sociale. Con
l’esecuzione, la poesia può finalmente avere luogo e tempo; può essere, esserci. La
performance scorre irripetibile come la vita, la letteratura diventa vita.
Per dirla con Zumthor: “il testo diventa arte entro un luogo emozionale, manifesto in esecuzione, da cui proviene e a cui tende la totalità delle energie che costituiscono l’opera viva. È dunque l’esecuzione che fa di una comunicazione orale un
oggetto poetico, conferendo ad esso l’identità sociale in virtù della quale viene
percepito e dichiarato tale”.10
Obbligato a stare lontano dalla sua patria, al-Nawwab va verso la sua gente e il
suo pubblico in un moto dettato da un’urgenza umana, politica ed estetica insieme.
Con le letture pubbliche chiama a raccolta la sua comunità, con il preciso intento di
ri-chiamarla al ruolo collettivo, per farla sentire ancora accomunata da principi
linguistici, estetici, politici, esistenziali. In tal modo dà vita a performance ogni
volta uniche, in cui la comunità, in loco o in esilio che sia, si riunisce per celebrare
un autentico rito.
Secondo la teoria delle performance di Richard Schechner, vi sono cinque elementi universali di base identificabili in ogni tipo di rituale:
A special ordering of time
A special value attached to objects
Non productivity in terms of goods
Rules
Special places/ non ordinary places set aside or constructed to perform these events in.11
internazionale di questa pratica. Comune a molte situazioni di oppressione autoritaria, la registrazione
e la diffusione autonoma di testi orali rispecchia un fermento culturale e intellettuale inarrestabile.
10 Zumthor, La presenza della voce, cit., p. 96.
11 Richard Scheckner, Performance Theory, Routledge, London, 1975, p. 8.
266
Fatima Sai
È evidente che questi principi, validi per ogni tipologia di rito in ogni civiltà, si
applicano anche ad una performance poetica, che rientra così fra le attività umane
extra-ordinarie e dunque appartenenti all’ordine del rituale. Queste attività si svolgono in un tempo e un luogo extra-ordinari e precisi; il tempo in esse impiegato è
materialmente improduttivo e la performance è interamente gestita da regole non
scritte di comportamento.
La poesia diventa dunque lo spazio extraordinario della società; è lo spazio della ritualizzazione. Può dirsi però azione sociale e collettiva solo nella condivisione
delle regole che la sottraggono all’ordinarietà di spazio e tempo, aprendosi alla
dépense.12
Ma ancora più nello specifico Schechner fornisce un altra combinazione di elementi che può chiarire ancora meglio in quale spazio interpretativo sia possibile
situare la poesia orale:13
Self assertive
“I” +
Social
“We” + / -
Play
Self-trascendent
“Other” -
Games, Sports, Theatre
Ritual
by
Rules establish frames: “Do”
(freedom), Don’t
Rules given by authority
Pleasure principle, Eros,
id, private world, assimilation
Balance between pleasure
and reality principles, ego,
accommodation
Reality principle, Thanatos,
Superego
Rules
player
established
Gli elementi di questo schema sono disposti in modo da oscillare fra due poli in
cui ‘+’ è il gioco14 e ‘–’ è il rituale.
Anche in questo caso la poesia orale, come praticata da Muzaffar al-Nawwab,
copre l’intero arco delle possibilità: da una parte i testi rispondono a regole fissate
dallo stesso autore, dall’altra la lettura in pubblico li fa diventare senz’altro parte di
un gioco sociale, che segue le convenzioni della comunicazione pubblica degli incontri. Le composizioni poetiche, infine, rientrano anche nell’ordine del rituale, in
quanto rispondono alle regole dettate dall’autorità della tradizione letteraria.
12 “Dispendio improduttivo”. Il termine è coniato da Bataille per riferirsi a tutti i fenomeni di
“dispersione”, “spreco”, “dono ritualizzato”, “sacrificio”. Cfr. Georges Bataille, La parte maledetta,
Bollati Boringhieri, Torino, 1992.
13 Schechner, Performance Theory, cit., p. 17.
14 Gioco inteso come momenti ludici personali privati, come quelli dei bambini, senza regole fisse, o
con regole che il giocatore fissa sul momento la cui validità svanisce con la fine di quello stesso
momento.
Il corpo del poeta. Oralità secondaria nella poesia araba contemporanea …
267
Come ogni rituale poi, la poesia serve a riconfermare il concetto stesso di comunità, perché la àncora al suo fondamento linguistico, secondo la teoria di Durkheim.15
Con Muzaffar al-Nawwab, tuttavia, questa riconferma non è altro che un gioco
acrobatico tra gli elementi di innovazione e di infrazione delle regole del canone e
tra un godimento compiaciuto della tradizione, “un godimento corporeo del canto
della carne e della pulsione ritmica da cui sgorga”.16
La sua performance è un atto totale. Ne costituiscono parte integrante: intonazione, timbro, velocità, articolazione, ritmo, registro, pause, gestualità, sguardo,
improvvisazione, interazione con altri soggetti presenti, l’interazione con gli oggetti di scena (acqua o qualunque altre bevanda / microfono / fogli) e, non ultima,
l’interazione con il pubblico. Le reazioni degli uditori, infatti, entrano attivamente
nei dati dell’esperienza totale che vive chi prende parte a questa celebrazione collettiva, in cui il poeta diventa medium col suo corpo.
La recitazione di al-Nawwab non è un monologo, bensì un assolo, cioè una esecuzione che, tuttavia, contrariamente all’apparenza, il performer non può assolutamente fare da solo. Nella musica araba, molto simile al jazz in questo, la struttura
tipica della performance è un magma sonoro armonizzato in un maqam, una tonalità ‒ un mood ‒ dal quale ciclicamente emerge la voce di un singolo strumento o
cantante per volta, che si esibisce nel suo assolo e che trova eco nel tappeto sonoro
che infine lo riassorbirà. Così la voce di al-Nawwab emerge nel continuum vocalico
della comunità per prendere parola, sulla storia e sulla vita, e per trovare la risonanza nel feedback dei suoi ascoltatori.
Ancora secondo Zumthor:
Ogni cultura possiede un suo sistema passionale, le cui configurazioni di base possono essere colte, in tratti semantici più o meno dispersi, ma specifici, in ogni testo che
essa produce. Il testo poetico orale sembra essere quello in cui questi tratti sono più
fitti. È perciò che la poesia orale dà a volte l’impressione di aderire più strettamente
del racconto a ciò che, a un livello profondo, l’esistenza collettiva ha di più ripetitivo,
di qui una ridondanza particolare, e una minore varietà di temi.17
Il tema più ricorrente che si mette in scena in questo rituale collettivo è la storia
araba, la storia dei secoli dello splendore, ma soprattutto la storia contemporanea.
La funzione del rituale, dunque, è proprio quella di elaborare gli accadimenti storici più prossimi e brucianti, quelli verso cui più facilmente si tende ad essere ciechi,
tracciando i contorni di un’identità in divenire, nutrendo e decostruendo a un
tempo il mito dell’arabismo, in una sorta di grande poetry jam, in cui ciascuno diventa memoria vivente.
Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, Meltemi, Milano,2005.
Cavarero, A più voci, cit., p. 21.
17 Zumthor, La presenza della voce, cit., p. 52.
15
16
268
Fatima Sai
MAIA GIACOBBE BORELLI
NON C’È NIENTE DI PIÙ SIMILE AD UN FIUME CHE UN RACCONTO:
LA VOCE DELLA NATURA NELLE NARRAZIONI DI SISTA BRAMINI
C’è un paesaggio interiore, una geografia dell’anima; ne cerchiamo
gli elementi per tutta la vita.
Chi è tanto fortunato da incontrarlo, scivola come l’acqua sopra
un sasso, fino ai suoi fluidi contorni, ed è a casa.
Josephine Hart, Il danno.
Dentro ad un edificio teatrale, sulle assi di un palcoscenico, il raccontarsi reale
del luogo dove si svolge effettivamente lo spettacolo non è quasi mai contemplato,
anzi è spesso classificato come disturbo all’attenzione dello spettatore che si deve
concentrare invece sulle azioni e sulle parole dell’attore. Il palcoscenico, concepito
come una sorta di scatola-contenitore trasparente, viene riempito durante gli spettacoli da sonorità e visioni che aprono la mente a un altrove che porta a immaginare insieme agli altri, nella ‘virtualità’ del teatro, uscendo da quel luogo fisico. Fabrizio Cruciani ha esaltato la qualità evocativa, artificiale, dello spazio teatrale: “Lo
spazio non è soltanto una qualità della realtà fisica quanto piuttosto una struttura
storica dell’esperienza; lo spazio artificiale del teatro è una convenzione culturale
che diventa elemento attivo dell’espressione artistica, sia nel suo costruire visione,
sia nel suo determinarsi come ambiente: un luogo dei possibili espressivi”.1
Non era così alle origini, la scelta dei luoghi di rappresentazione aveva, un
tempo, un suo preciso significato e senso. Poi la scena teatrale moderna, con le sue
pareti nere o con i suoi fondali, ha cercato di escludere alla visione, o forse è meglio
dire all’attenzione, il luogo in cui si svolgeva effettivamente l’azione, in favore di
una narrazione costruita in modo artificiale dal dispositivo scenico per lasciare
spazio al campo infinito delle possibilità.
Solo recentemente assistiamo al recupero del luogo di spettacolo all’interno della narrazione teatrale, luogo che ricomincia ad avere una sua parte nella composizione drammaturgica quando il racconto che si vuole ‘mettere in scena’ viene rinarrato e riscritto in funzione del contesto spazio-temporale in cui ci si trova ad
agire, e la realtà ‘virtuale’ prende le mosse dalla realtà concreta. Fuori dai teatri, si
scelgono spazi in funzione del loro carattere e della loro storia, della loro qualità
acustica ed evocativa. Il luogo in cui si svolge uno spettacolo diviene uno degli
elementi del racconto, sia per il riverbero che lo spazio provoca nel performer, sia
per le sonorità che il luogo stesso produce e aggiunge alla performance. Così il
1
Fabrizio Cruciani, Lo spazio del teatro, Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 4.
270
Maia Giacobbe Borelli
luogo fa sentire la sua voce a chi lo sa ascoltare, si impone con il suo silenzio, o al
contrario con il suo rumore. Diventa uno dei personaggi.
Un teatro che mette al centro i luoghi naturali è quello proposto da “O Thiasos
TeatroNatura”, la compagnia guidata da Sista Bramini, che convoca negli spazi
aperti dei parchi e delle campagne italiane i suoi spettatori. Narra i miti fondanti
della nostra cultura occidentale, storie spesso derivate dalle Metamorfosi di Ovidio:
“Demetra e Persefone”, “Miti d’acqua”, “Miti di stelle”, ma anche “Numa e la fondazione di Roma” o storie di santi, come “La leggenda di San Giuliano” (Premio
Teatri del Sacro 2011).2 Spesso in questi spazi poco antropizzati, riserve e parchi
naturali, luoghi cosiddetti ‘primitivi’, noi spettatori, convocati in orari insoliti,
all’alba o al tramonto, in quei varchi temporali dati dal passaggio dalla luce al buio
o viceversa, troviamo il modo di guardarci intorno. Ci ritroviamo in ambienti dove
miti e vicende umane si confondono e si rispecchiano. Per la prima volta dopo
tanto tempo, dopo il tempo della nostra infanzia, siamo colpiti dalla presenza degli
altri esseri, e percepiamo i suoni degli animali, delle acque o del vento. Facciamo
silenzio e ci mettiamo in ascolto.
Grande è il valore del silenzio degli uomini quando si trovano in uno spazio naturale, perché solo così possono ascoltare suoni leggeri, impercettibili, che sono
stati a lungo trascurati. Proprio attraverso il silenzio, oltre che con la parola, la
comunità riunita ritrova quella qualità di ascolto che permette di tornare al senso
profondo di un teatro delle origini, dove l’evento teatrale è il luogo di
un’esperienza condivisa che può modificare lo stato di coscienza.
Dice Mariangela Gualtieri, commentando la perdita di occasioni per il silenzio
nella vita dell’uomo:
Io penso che l’arte dell’attore sia ‘arte del silenzio’ per lo meno nella stessa misura in
cui è arte del dire la parola. Un attore che non sia esperto di silenzio è attore a metà.
E quel suo silenzio fra le parole, così diverso da quello della pagina scritta, si tende in
un intreccio col silenzio del pubblico presente. Insieme, i due silenzi, creano a volte
un tappeto di ascolto che non esito a definire ispirato, un ascolto così teso che agisce
sul respiro degli astanti, quasi togliendo peso ai luoghi, ai corpi, al mondo. Allora nasce un tempo festivo e il teatro ripiomba nel luogo tremendo e luminoso della propria origine.3
Come un teatro così diverso che ha scelto di agire fuori dagli spazi antropizzati,
riempiendo il racconto di silenzio e ascolto del luogo, con obiettivi che sembrano
travalicare la sola esperienza teatrale, può stimolare la nostra riflessione sulla narrazione orale?
2 Informazioni sul lavoro e sulle pubblicazioni di Sista Bramini e della Compagnia “O Thiasos
TeatroNatura” al sito <http://www.thiasos.it> (01/14).
3 Mariangela Gualtieri, “Quel baratro fra scritto e orale” in Valentina Valentini (a cura di),
Drammaturgie sonore. Teatri del secondo Novecento, Bulzoni, Roma, 2012, p. 149.
Non c’è niente di più simile ad un fiume che un racconto …
271
Ascoltare un mito: una voce in bilico sui limiti del reale
Il racconto di un mito permette di incontrare, in bilico sui limiti del reale, le
grandi forze della natura e di dilatare, attraverso la narrazione orale, la presenza
del vivente al di là del tempo e dello spazio. Il mito può contenere la parola che
ben si accorda con la presenza del teatro nei luoghi naturali perché nella narrazione del mito l’intreccio tra i silenzi e il suono della voce è lo strumento che evoca un
mondo simile al sogno, condiviso da tutti quelli che ascoltano. Un ritorno
all’indietro, un tuffo nella memoria delle nostre comuni origini storico-culturali,
evocate dal tessuto sonoro di una phoné che vede insieme animali e umani. È
un’esperienza di realtà non ordinaria, dove tutto si rovescia: il familiare può diventare estraneo e la dimensione fantastica si rivela subito familiare, grazie alla possibilità immaginativa racchiusa nella natura umana che riconosce tutte le realtà come
fondamentalmente metaforiche e mitiche.4 Immaginare insieme è la forza
dell’esperienza teatrale proposta dalla musicalità ed energia verticale, incantatoria,
presente nelle parole tramandate del mito.
Molti spettacoli di Sista Bramini sono proposti in orari e luoghi insoliti, per
esempio “Demetra e Persefone”, visto a Centeno (Vt) il 1 luglio 2012 alle luci
dell’alba, in occasione del ventennale della Compagnia.5 Durante l’evento sentiamo, insieme alle parole del mito, i suoni del luogo, gli uccelli, il fiume, il vento,
proprio quando l’attrice descrive il passaggio degli eroi nel mondo insidioso di una
foresta, lì dove si aggirano sperduti cercando la strada per un ritorno a casa. Sista
dice: “Al cacciatore poteva capitare di sentire le voci...”, proprio mentre noi siamo
testimoni di un mondo vocale composito che si apre intorno a noi.
In una conversazione che abbiamo avuto è emersa l’importanza del dialogo tra il
coro-canto, che l’ambiente naturale fornisce con i suoi suoni, e la voce di lei stessa
che narra, in un duettare reso ancora più valido dalla metrica del testo antico, rispettata fedelmente nella narrazione, in modo tale da sviluppare una tecnica precisa per
esaltare la musicalità delle parole. La metrica le permette di introdurre parole desuete per le descrizioni, accompagnate da parole più semplici per le azioni, cucite insieme da un preciso tempo-ritmo suggerito dalla musicalità del verso. Una narrazione
semplice, costellata di parole che portano fuori dall’attualità, che creano un flusso di
coscienza aiutando l’inconscio a entrare in contatto con il luogo naturale. Il mito per
lei rimanda a un mondo di suoni e visioni, che sente e vede effettivamente intorno a
lei. Non è un testo che racconta un’esperienza antica, bensì la possibilità di rivivere
Cfr. la nozione del ‘fare anima’ in James Hillman, Gli animali del sogno, Cortina, Milano, 1991.
Di questo spettacolo esiste una registrazione sonora, effettuata in altro luogo, ai Laghi d’Orta il 5
luglio 2009 all’alba.
4
5
272
Maia Giacobbe Borelli
nel presente l’emozione dell’esperienza stessa, attraverso precise parole che rievocano quelle ‘forze pure’, di cui parlava Antonin Artaud.6 Sostiene Bramini:
La parola è lo strumento evocatore che io non abbandono. Lo essenzializzo e lo confronto con il tempo-ritmo vivente, perché l’azione rivive dentro di me nella profondità di uno spazio immaginale. Io sono il tramite di un tempo lontano, come lo sono i
pupari, cerco di raccontare il mito con le parole della tradizione, mantenendo una relazione diretta con il pubblico che è la chiave del racconto.7
Lucia Amara, studiando i rapporti tra metro, corpo e voce, rileva che è proprio
il rispetto dello schema metrico nella dizione di un testo antico a permettere di
ricomporre nella bocca del narratore quel canto che svela l’origine corporea e sonora delle parole, facendolo emergere: “Se si parte dall’assunto che la scansione metrica è uno dei luoghi in cui si sviluppa una vera e propria prassi della voce, la
metrica diviene, allora, pratica o ‘forma’ dell’emissione”.8 Il corpo rientra in possesso dell’azione proprio attraverso l’emissione della voce, tecnicamente costruita e
controllata dalla metrica del testo del mito. Canta il mito attraverso un sapiente uso
della voce, che rispetta la forma ritmica delle parole antiche.
“Siamo solo canali svuotati e preparati a far scorrere qualcosa del mito
dall’interno all’esterno e viceversa”, confessa Sista.9
Il racconto pone la domanda antica nello spazio presente; si può rispondere con
un altro racconto che il mito suggerisce in quel momento preciso nel luogo naturale. Il mito rimanda a immagini e suoni che riecheggiano nel presente. Ma è anche
l’orecchio dello spettatore a essere messo in causa come interlocutore diretto e organo compositore di piani sonori diversi.
“Non vi racconterò ...” ripete con insistenza Sista Bramini procedendo nel racconto,
mentre accenna, allude, avvolge i suoi spettatori con fiumi di parole con le quali, invece, rievoca e racconta. Un’onda di suoni che trasforma il mito in una chiave per aprire
l’orecchio all’ascolto della natura stessa. Paradossalmente, il punto di rottura tra la
natura e il mito è percepibile solo guardandone la continuità. La narrazione è un processo di sedimento della parola che va creando contiguità, grazie alla configurazione di
6 Antonin Artaud, “Articolo del luglio 1934”, Id., Œuvres, Gallimard, Parigi, 2004, p. 479: “Tutti i
Grandi Miti del Passato dissimulano delle forze pure. Essi non sono stati inventati che per far durare e
manifestare queste forze”.
7 Conversazione fra Sista Bramini e Maia Giacobbe Borelli, registrata il 6 giugno 2013 a Roma, inedita. Per
un approfondimento sul lavoro di ascolto e ambientazione necessari in uno spettacolo di “O Thiasos
TeatroNatura” nel luogo naturale, cfr. Sista Bramini e Francesco Galli, Un teatro nel paesaggio, Titivillus, Pisa,
2007.
8 Lucia Amara, “Metro, corpo, voce. Annotazioni per uno studio sulla metrica nel teatro del primo
Novecento”, in Valentini (a cura di), Drammaturgie sonore. Teatri del secondo Novecento, cit., p. 257.
9 Sista Bramini, “O Thiasos TeatroNatura nei 10 anni di Naturalmente arte”, in Tomaso Colombo e Lorenza Zambon (a cura di), Teatro e Natura, Naturalmente arte, Marco Valerio, Torino, 2011, pp. 43-53; qui p. 52.
Non c’è niente di più simile ad un fiume che un racconto …
273
intrecci e relazioni che esauriscono il discorso anche senza svelarlo in tutte le sue componenti, lasciando alcune zone oscure che lo spettatore rielabora per suo conto.
Ascoltare la voce della natura: quando il fiume si racconta
Che cosa sono diventati per noi gli spazi naturali, perché è intrigante usarli come
luoghi di narrazione, frequentarli e farli effettivamente diventare spazi di teatro,
seppur temporanei? Forse perché permettono di interrogarci su molte questioni,
forse perché “I teatri che agiscono in ambiente naturale sono interessati a tutto ciò
che alla globalizzazione resiste, sono interessati alla cultura del vivente nel suo radicamento in territori molto diversi l’uno dall’altro per storia, per geografia, per memoria”, interviene Roberta Gandolfi. “Città e campagna – continua ‒ non sono solo
più questione di residenza, di pubblico, di generi e registri espressivi, di modi di
produzione, ma diventano esse stesse tema della ricerca teatrale: il teatro diventa lo
strumento privilegiato di una interrogazione sul ‘senso del luogo’”.10
Sista Bramini è convinta dell’importanza di questa interrogazione per mettere
in evidenza le dimensioni spazio-temporali che vi si sono sedimentate nel tempo,
un’interrogazione cioè delle ‘forze pure’ che si sprigionano nel contatto con il suo
genius loci e nell’ascolto di quel luogo:
Il genius loci si risveglia quando entriamo in contatto con quelle caratteristiche originarie di un luogo che la sua storia ha trasformato, ma che permangono come impronta sotterranea e vitale, si risveglia quando percepiamo il patto di amicizia che ha legato
in modo speciale quel luogo e le persone che l’hanno vissuto e trasformato. Ma il risvegliarsi del genius loci non è solo il riconoscimento del legame con un passato di cui
scoprire le tracce ancora visibili, bensì una forza che ci àncora al presente e ci ispira
nella visione del futuro, è la qualità di un impulso creativo che può sprigionarsi in
noi con il contatto e l’ascolto di quel luogo.11
Il contatto con le presenze, immaginali o reali, che andiamo a incontrare in un
luogo, ben si rapporta con le parole ascoltate perché il mito non è solo un racconto
condiviso, il mito riaccade ogni volta nell’ascolto del luogo in cui esso si svolge.
Allora, si chiede Sista, “come imparare a stare nell’ascolto di quel fiume, quel bosco, quell’albero secolare, quell’orizzonte al punto da entrare in relazione, attraverso di esso, con una dimensione ancora più profonda in grado di nutrire la psiche e
farla respirare in ritmi e spazi più vasti?”.12 Spesso in questi spazi ci sentiamo os10 Roberta Gandolfi, “Agire il paesaggio. Teatri, pensieri, politiche del ‘luogo’”, in Franco Acquaviva
e Roberta Gandolfi (a cura di), Ricerche di s/confine. Oggetti e pratiche artistico/culturali, Dipartimento dei
Beni Culturali e dello Spettacolo dell’Università di Parma, 2013, p. 72. Testo disponibile online al link
<http://dspace-unipr.cilea.it/bitstream/ 1889/2282/1/GANDOLFI-dilatare.pdf> (01/14).
11 Bramini, “O Thiasos TeatroNatura nei 10 anni di Naturalmente arte”, cit., p. 53.
12 Sista Bramini, “Il TeatroNatura una forma d’arte per un presente sostenibile” in Alice Benessia (a
cura di), Per un presente sostenibile, Donzelli, Roma, 2014 (in c.d.s.).
274
Maia Giacobbe Borelli
servati da chi in quel luogo abita, presenze che siamo andati a disturbare e con le
quali non siamo più in grado di rapportarci.
“In altre parole, se l’arte teatrale è dedita primariamente, nella bella formulazione di Bertolt Brecht, a raffigurare ‘le forme della convivenza umana’, i teatri in
ambiente naturale ‒ i teatri protesi verso l’aperto, il paesaggio, la natura ‒ dilatano
il loro oggetto ed estendono la presenza del vivente oltre l’umano, verso il creato.”13 Piante e animali sembra vogliano essere ascoltati e guardati per proporsi
come soggetti attivi dell’incontro. Allora, come rieducare l’udito di noi spettatori,
non più avvezzi ai luoghi naturali? Come accogliere questo tipo di oralità che la
natura rivolge a noi in una lingua perlopiù sconosciuta e oscura?
L’antropologia non ha smesso di confrontarsi al problema del rapporto di continuità e discontinuità tra natura e cultura. In apparenza, in effetti, l’integrazione
dell’uomo nella natura è una sorta di ossimoro, dato che la natura si caratterizza
per l’assenza dell’uomo, e l’uomo evoluto si caratterizza per essere quello che,
unico tra le specie animali, ha saputo superare il ‘naturale’ in lui passando dai suoni al linguaggio. Questa antinomia ci pare suggestiva dato che rende manifesta
un’aporia del pensiero moderno suggerendo nello stesso tempo una via per sfuggirne. La natura è per noi il regno del primitivo, dell’umano precivilizzato,
dell’arcadia spensierata, lo sfondo sul quale l’umanità pone i suoi miraggi, i suoi
sogni e le sue utopie, lo strumento per convincere l’uomo che non ci sono alternative possibili al nostro sistema di vita, altri modi di vivere nel mondo. Una separazione tra il mondo reale, quello urbanizzato, e un mondo ideale ‒ che non può più
esistere ‒ e che la natura ci rimanda come possibilità irrealizzabile. Così, nel pensiero moderno gli animali sono esseri puramente materiali che non possono partecipare di quella sostanza che è l’anima, che non hanno, come diceva Artaud, il
‘soffio’.14 Corrado Bologna riassume bene i termini della questione:
La voce dell’animale, come tutto il pensiero dell’Occidente ribadisce, è ‘voce della natura’. L’irruzione della ‘voce della coscienza’ è violenta, impone l’interruzione e la
frattura, articola il grido confuso per dargli senso e forma nel linguaggio ‘fatto di parole’ che solo, consente la com-passione, il rapporto con l’altro (con l‘esterno,
nell’esterno): che, solo, garantisce dunque la socialità.15
Gandolfi, “Agire il paesaggio. Teatri, pensieri, politiche del ‘luogo’”, cit., p. 73.
Sulla nozione di ‘soffio’ (souffle) in Artaud, cfr. Marco De Marinis, “Geroglifici del soffio: poesiaattore-voce fra Artaud e Decroux nel Novecento teatrale”, in Id., Teatri di voce, «Culture teatrali», 20,
Quaderni del Battello Ebbro, Porretta Terme (Bo), 2011, pp. 11-38; Lucia Amara, “Sostanza sonora e
vocazione performativa nelle glossolalie di Artaud”, in Teatri di voce, cit., pp. 39-70; Evelyne Grossman,
“Quitter la lettre écrite”, in A. Artaud, Cahier, Ivry, janvier 1948, Gallimard, Paris, 2006, pp. 9-18; Maia
Giacobbe Borelli, “Antonin Artaud e il passaggio dei corpi in teatro”, in Maia Giacobbe Borelli (a cura
di), Out of Order. Quel che resta del corpo nello spettacolo contemporaneo, Bulzoni, Roma, 2012, pp. 15-61.
15 Corrado Bologna, “Flatus voci. Metafisica e antropologia della voce”, citato in Amara e Di Matteo,
Teatri di voce, cit., p. 277.
13
14
Non c’è niente di più simile ad un fiume che un racconto …
275
A questo punto di vista non cessiamo di aderire spontaneamente quando ammettiamo che gli umani si distinguono dai non umani grazie alla loro coscienza,
soggettività, capacità di significare, padronanza del simbolico, e per il linguaggio
verbale che permette a queste facoltà di esprimersi. Nel linguaggio distinguiamo
fortemente le nostre parole dai suoni animali. “Quando emettono la loro sonorità”
‒ dice Mario Bettini analizzando i diversi vocaboli con cui si designano le vocalità
delle creature animate che non sono uomini ‒ “gli animali compiono più o meno la
stessa azione compiuta dagli umani – ma umani non sono, la qual cosa significa in
primo luogo che essi non possiedono linguaggio e non articolano parole”.16 Queste
linee di separazione linguistiche distinguono a priori l’animato dall’inanimato, il
solido dall’immateriale, i regni della natura e quelli del linguaggio, il suono senziente dagli altri suoni ‘naturali’ e, tra questi, gli uomini che vivono secondo le
leggi della ragione da quelli che credono nel sovrannaturale. Il linguaggio,
l’antropologia e il pensiero occidentale tutto, si sono fatti strada in un continuo
separare e dividere. Scrive ancora Bettini che “nelle raccolte lessicografiche greche,
quelle che sembrano risalire a Zenodoto, per designare la vocalità degli animali si
fa generalmente ricorso alla parola phoné”. E così continua:
Si tratta in effetti dello stesso termine usato da Aristotele per designare le sonorità
emesse dagli animali dotati di laringe e di polmoni: egli distingue infatti fra il semplice psóphos (suono), prodotto dagli esseri privi di tali organi, la phoné, emessa dagli
animali che invece ne sono provvisti, e la diálektos, il linguaggio articolato, che prevede il possesso della lingua ed è proprio degli esseri umani.17
Postulando una distribuzione universale di umani e non-umani in due domini
ontologici separati, siamo poco attrezzati all’analisi di tutti questi sistemi di comprensione del mondo nei quali è assente una distinzione formale tra natura e cultura. Ma la natura non è in tutti i popoli una sfera di realtà autonoma come per noi.
Insomma, per riprendere un’acuta immagine di Alfred North Whitehead,18 ci accorgiamo di quanto sia pretestuosa la nostra superiorità al mondo naturale, dato
che i bordi che delimitano i confini tra cultura e natura sono sempre confusi. Sarebbe opportuno tracciare una cartografia di questi legami, richiamarci alle collettività ibride ‒ quelle società che vivono immersi tra gli altri viventi ‒ per le quali,
come avevano notato più di un secolo fa Sir Walter Baldwin Spencer e Francis James Gillen studiando i nativi australiani, un uomo osserva l’essere che gli serve da
16 Mario Bettini, “Voci. Antropologia sonora del mondo antico”, citato in Amara e Di Matteo, Teatri
di voce, cit., p. 290.
17 Ibid.
18 Alfred North Whitehead, filosofo della natura, ha scritto, tra gli altri, An Inquiry Concerning the
Principles of Natural Knowledge (1919), The Concept of Nature (1920), Nature and Life (1934, in italiano
Natura e vita, Mimesis, Milano, 2012).
276
Maia Giacobbe Borelli
totem considerandolo come lo stesso di sé. Senza operare cesure ma in assoluta
interdipendenza tra la sua cultura e la sua natura.19
La questione è quella della “demarcazione”, mi conferma Sista Bramini chiedendosi se non dovrebbe il teatro frequentare, ponendosi in ascolto, proprio l’area
di 'confusione' di cui parla Whitehead, per “ammorbidire” attraverso un'intensificazione della sensibilità quei punti secchi (rinsecchiti) di “demarcazione” tra natura e cultura.20
Anche Roberta Gandolfi evidenzia questa funzione connettiva del teatro che si
svolge in spazi naturali, tra la matericità del vivente e l’umana sensibilità simbolica
che si esprime metaforizzandola. Nella doppia chiave, metaforica e materica, questo tipo di spettacolo permette di intensificare la percezione dell’ambiente circostante:
Non solo il dispositivo spazio-temporale del cerchio di attenzione, ma anche tutti gli
altri registri espressivi utilizzati, come il racconto, il canto, la musica, l’immaginario
poetico e la perfomance attorica, sono orientati a questo connettere l’azione simbolica
con il paesaggio e l’ambiente circostante. Risuona fortemente in alcune esperienze (O
Thiasos TeatroNatura) la sensibilità simbolista verso la percezione sinestetica del reale; ci si muove comunque oggi, generalmente, oltre la ricerca di un suggestivo sfondo
per l’azione teatrale, e invece verso una intensificazione percettiva dell’ambiente, a
un doppio livello: nella sua metaforicità ma anche nella sua matericità.21
Specchio di noi e del nostro comune percorso culturale dovremmo considerare
quei luoghi naturali nei quali gli spettacoli di Sista Bramini ci invitano a tornare,
per considerare il mondo naturale come partner ‘vivo’22 e ascoltare gli esseri che vi
abitano. Arrivare a una dimensione di reciprocità, a un’attitudine di maggior ascolto che ci permetta di essere di nuovo in grado di accettare questi esseri per riconoscerli come nostri interlocutori e compagni di strada, anch’essi testimoni insieme a
noi dell’evento che andiamo realizzando, non per mero furore ecologista ma “perché il teatro, come la parola, ha bisogno che lo si lasci libero”.23
Così tra il suono di un fiume e il procedere di un racconto non ci sarà per noi
più alcuna differenza e sarà il fiume stesso a narrarci la sua storia e noi ad ascoltare
la sua voce portata dalle acque.
19 Cfr. Baldwin Spencer e Francis James Gillen, The Native Tribes of Central Australia, McMillan, London, 1899. I due antropologi si sono occupati della spiritualità totemica dei popoli dell’Australia
Centrale, influenzando con le loro teorie sia le ricerche di Emile Durkheim per Le forme elementari della
vita religiosa (1912), sia Sigmund Freud nell’elaborazione di Totem e tabu (1913). Notizie sulle loro
ricerche e un ampio archivio dei materiali etnografici da loro collezionati è consultabile a
<http://spencerandgillen.net/spencerandgillen> (01/14).
20 Corrispondenza del 20 gennaio 2014, inedita, fra Sista Bramini e Maia Giacobbe Borelli.
21 Gandolfi, “Agire il paesaggio. Teatri, pensieri, politiche del ‘luogo’”, cit., p. 75.
22 Cfr. Sista Bramini, “Il mondo naturale visto come partner vivo”, Teatri delle diversità, 21, 2002.
23 Antonin Artaud, “Quatrième lettre, Paris, 28 mai 1933”, in Œuvre, cit., p. 577, mia traduzione. Cfr.
anche Id., “Lettere sul linguaggio”, in Il Teatro e il suo doppio con altri scritti teatrali, Einaudi, Torino, 1968.
Non c’è niente di più simile ad un fiume che un racconto …
Sezione IV
277
278
Maia Giacobbe Borelli
ANGELA ALBANESE
Introduzione
TEATRALIZZAZIONE DI VICENDE STORICHE
ATTRAVERSO LA LORO NARRAZIONE ORALE
Mi piace pensare che il teatro possa farsi arca.
A patto che sia in grado di accogliere al suo interno
diversità a rischio scomparsa.
L’arca non è un luogo dell’armonia.
Oppure un luogo in cui le differenze si appianano.
L’arca è una stalla dove ognuno urla il suo verso distinto.
Pietro Floridia, Teatro in viaggio
“Manca un’inchiesta, manca un racconto di una tragedia … manca chi dà eco alle urla, manca chi riscrive storie, chi trova colpevoli, chi fa cronaca…, questi vuoti
colmati dal teatro, dalla letteratura, rimandano a tutta l’estensione del vuoto colmato. Verità è ciò che più mi ossessiona […] trovare gli strumenti per metterla a
fuoco, trovare il punto di vista che non renda semplice ciò che è complesso, ma che
lo renda visibile e leggibile”.1
Queste riflessioni di Roberto Saviano tratte dal suo La bellezza e l’inferno, diventato nel 2009 un monologo teatrale da lui stesso interpretato, ci portano al cuore
della questione che la quarta sezione del convegno si è proposta di indagare, vale a
dire le dinamiche di adattamento che intervengono nella trasposizione scenica di
storie di identità collettive e individuali, di eventi socio-culturali, di momenti storici divenuti esemplari o paradigmatici. Il materiale rielaborato dai drammaturghi è
spesso ripreso da narrazioni orali, acquisite in modo diretto attraverso interviste o
testimonianze, oppure per via indiretta attraverso la mediazione di testi giornalistici, di saggistica o narrativa. Proprio attingendo a questo tipo di fonti, il teatro,
specie negli ultimi decenni e anche sulla scorta dell’influenza esercitata dall’intensa
esperienza del “teatro di narrazione” degli anni novanta, è riuscito a colmare vuoti
d’informazione, vuoti di storia politica e sociale, facendosi portavoce della coscienza civile e identitaria, supplendo alle categorie istituzionalmente incaricate di fare
luce sulle contraddizioni sociali e politiche della contemporaneità, assumendo su
di sé il compito di recuperare una memoria comune fatta di tradizioni e di miti e di
dipanare trame storiche, vicende comunitarie, singole sequenze dell’oggi o di un
passato a noi prossimo. Diverse esperienze teatrali contemporanee sono riuscite a
1
Roberto Saviano, La bellezza e l’inferno, Mondadori, Milano, 2009, pp. 50-51.
280
Angela Albanese
recuperare tasselli rimossi dalla coscienza storica del paese, pur mantenendo, almeno nelle più autentiche e riuscite espressioni artistiche, l’originaria vocazione
del teatro ad aprire contraddizioni,2 a non limitarsi a riflettere la realtà ma a metterla in causa, senza confondersi o competere con la cronaca o con l’attualità. Non è
superfluo qui soffermarsi un poco sui due termini, “attuale” e “contemporaneo”,
che forse con leggerezza riteniamo sinonimi e che invece, specie in relazione al
fatto artistico, potremmo pensare persino come l’uno il contrario dell’altro.
L’attuale – ha ben rilevato Gabriele Vacis in un’intervista rilasciata a margine della
messa in scena del suo Supplici a Portopalo del 2009 ‒ è qualcosa che sta solo in un
tempo, è il tempo in un determinato momento, mentre il contemporaneo è il tempo
in ogni momento, “è qualcosa che sta sempre con il tempo in tutti i tempi”;3 se
l’attuale muore con il tempo, il contemporaneo è in ogni momento del tempo e in
ogni momento il suo pensiero produce senso. La parola “attualità” è dunque parola del giornalismo, della televisione, è parola che consente una intelligibilità immediata dell’evento, ma ne logora e distrugge la memoria, ne annulla la distanza,
racconta l’evento in modo ansimante. Le parole dell’attualità, del giornalismo,
della cronaca tendono a normalizzare, a ridimensionare, a rendere ordinarie esperienze sociali, culturali, antropologiche e storiche che invece il teatro, luogo privilegiato di dilatazione del tempo e di decantazione dell’esperienza, sa fissare e rendere straordinarie, extra-ordinarie. Ha scritto Roland Barthes in un passaggio del
suo Il brusio della lingua, che “La parola informativa… è così strettamente mescolata
all’evento, all’opacità stessa del suo presente… da esserne il senso immediato e
consustanziale, il suo modo per accedere a un’intelligibilità istantanea”,4 che è come dire che l’informazione rimane tale, attuale e condannata ad essere dimenticata
se non è fissata e messa in rapporto alla narrazione. Chiarisce ancora Barthes nello
studio sul teatro brechtiano, anch’esso contenuto in Il brusio della lingua: “l’arte
critica è quella che apre una crisi: che lacera, squarcia la coltre, produce fessure
nell’incrostazione dei linguaggi, interrompe e diluisce l’avvelenamento della logosfera; è un’arte epica che rende discontinui i tessuti discorsivi, che distanzia la rappresentazione senza annullarla”.5 Il teatro è capace appunto di squarciare la coltre
e di insinuarsi nelle zone d’ombra della logosfera, recuperando la sua autentica
radice etimologica di theàomai, ossia l’essere luogo e tempo privilegiato di “visione” di ciò che non è criticamente percepibile nell’immediato della vita vissuta. Il
teatro è civile e necessario non tanto, o non solo, per i contenuti politici o i messagCfr. Massimo Marino, “L’informazione contro il teatro. Il caso di Sul concetto di volto nel Figlio di
Dio a Milano”, Culture teatrali, 22, 2013, p. 29.
3 Gabriele Vacis, “Supplici nel nostro presente: comprendere la contemporaneità”, Engramma. La
tradizione classica nella memoria occidentale, 78, marzo 2010.
(http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=442).
4 Roland Barthes, Il brusio della lingua, tr. it. B. Bellotto, Einaudi, Torino, 1988, p. 161.
5 Ivi, p. 226.
2
Teatralizzazione di vicende storiche attraverso la loro narrazione orale
281
gi ideologici che veicola,6 ma perché sa assumere la giusta distanza dalla logosfera,
perché non con “dirette spiegazioni sociologiche”, ma “per via drammatica” ed
estetica permette “dei preziosi ‘avvicinamenti’ al reale”.7
I contributi che compongono questa quarta e ultima sezione del volume non si
sono limitati a sondare le diverse implicazioni del rapporto fra oralità e sue rielaborazioni drammaturgiche, come era negli intenti delle giornate di convegno, ma
hanno saputo anche, con sfumature differenti e passando in rassegna alcune esperienze teatrali contemporanee, dare testimonianza di questa diversità consustanziale del teatro rispetto ad altri codici comunicativi: della sua intrinseca vocazione
a farci fermare, rallentare, a farci riappropriare di ciò che produce senso, a consentire l’esercizio di una tensione, essendo il tempo del teatro un tempo che dilata, un
tempo dell’attenzione. Scrive Gabriele Vacis che il teatro è appunto uno strumento
per produrre tempo. E proprio con l’intervento di Vacis, che si distende intenzionalmente non nella forma di saggio accademico ma in quella di preziosa testimonianza teatrale, si apre quest’ultima sezione. È bello rinvenire fra le righe di una
scrittura appassionata e personalissima, che privilegia il racconto esperienziale e la
testimonianza diretta rispetto all’esposizione di principi e di modelli teorici, le
linee guida che contraddistinguono la poetica teatrale di Vacis, drammaturgo e
regista, uomo di scena oltre che di libro.8 Prima fra tutte quella “drammaturgia
dell’attenzione”— ossia lo sforzo costante di “stare in attenzione”, di ascoltare e
vedere la realtà che sta intorno per creare azioni comuni — che ha motivato e continua a dare fondamento al suo operare artistico.
Con il saggio di Davide Aliberti dal titolo The Ladino Players: dalla narrazione orale alla performance nel teatro sefardita statunitense, il teatro oltre ad essere modo per
produrre tempo diventa anche strumento per produrre spazio e identità. Dopo
aver inquadrato storicamente il fenomeno della diaspora delle comunità sefardite,
ossia delle comunità ebraiche che fino al 1492 avevano abitato la penisola iberica, e
attraverso un’analisi dettagliata delle origini e della parabola del teatro sefardita in
particolare statunitense nato agli inizi del XX secolo, Aliberti arriva a dare conto
dell’importante esperienza dei Ladino Players, compagnia amatoriale sefardita attiva a New York dal 1994 fino al 2004, che ha indirizzato la sua attività drammaturgica al recupero linguistico, culturale e identitario di queste comunità attraverso la
messa in scena di opere nell’originaria lingua giudeo-spagnola, unico elemento che
faticosamente è sopravvissuto nei secoli a preservarne l’identità.
6 Cfr. Marco De Marinis, “Dal teatro politico alla politica teatrale”, in Stefano Casi e Lena Di Gioia (a
cura di), Passione e ideologia. Il teatro (è) politico, Editoria & Spettacolo, Spoleto, 2012, pp. 15-32.
7 Claudio Meldolesi, “Forme dilatate del dolore”, Teatro e Storia, 33, 2012, p. 368.
8 È persino superfluo ormai il riferimento al ben noto volume di Ferdinando Taviani, Uomini di
scena, uomini di libro. Introduzione alla letteratura teatrale italiana del Novecento, Il Mulino, Bologna, 1995.
282
Angela Albanese
Anche Daniela Allocca, autrice del saggio (r)Esistenze sonore. La traduzione
dell’invisibile in Schwarze Jungfrauen e Schattenstimmen di Feridun Zaimoğlu e Günter Senkel, testimonia di un altro importante momento di recupero di un’identità
comunitaria veicolato da un codice linguistico. Questa volta l’identità collettiva si
identifica nella Kanak Sprak, nella lingua “canaca”, termine dispregiativo con cui in
Germania sono stigmatizzati gli stranieri, specialmente gli immigrati turcotedeschi, e che di fatto è il gergo impiegato da chi sta ai margini della società, dagli
outsiders, vagabondi, disoccupati, tossici, omosessuali, prostitute etc. Sono questi i
protagonisti e le “fonti” orali di due monologhi, Schwarze Jungfrauen/Vergini Nere e
Schattenstimmen/Voci dall’ombra, di Feridun Zaimoğlu oggetto dell’analisi di Allocca. La studiosa entra nell’officina dello scrittore e drammaturgo, egli stesso figlio di
emigrati turchi in Germania, per analizzare il processo di registrazione di queste
voci dissonanti e marginali, a cui è restituita dignità, e della loro traduzione in
forma drammaturgica.
L’ultimo contributo di Raffaella Di Tizio, dal titolo Lavoravo all’Omsa: dalla cronaca al teatro, pensando a Brecht, rappresenta un ulteriore esempio di quella “drammaturgia dell’attenzione” teorizzata da Vacis. Di Tizio si sofferma sullo spettacolo
Lavoravo all’Omsa del Teatro Due Mondi di Faenza, che intreccia le trame e i personaggi di una precedente produzione della compagnia, Santa Giovanna dei Macelli
del 2005, con le storie delle operaie del calzificio di Faenza, licenziate nel 2010 a
seguito della decisione dell’azienda di delocalizzare in Serbia la produzione per
aumentarne i profitti. Lo spettacolo, esito di un laboratorio che ha coinvolto molte
delle operaie licenziate e che ha visto in scena una di loro a raccontare in prima
persona la propria vicenda, ha preso dunque le mosse, denunciandolo, da un fatto
di cronaca, di attualità; tuttavia, come ben scrive Di Tizio, “contraddicendo il tempo rapido della cronaca”, della notizia, della parola informativa, lo spettacolo è
stato davvero capace di dilatare il tempo della storia e di amplificarne le voci coinvolte.
Una delle cose più difficili per gli esseri umani, ha scritto Mariangela Gualtieri,
è “quella di farsi vuoti e attenti. Parlo di un’attenzione plenaria, vertiginosa, la
stessa dei neonati, quella che ci ha fatto imparare a camminare, a parlare, a fare
tutto ciò di cui siamo capaci”.9 Il teatro esige questo tipo di vuoto e di attenzione,
questa capacità di ascolto e di visione, che è condizione indispensabile per riuscire
a sentire le voci e le storie del mondo.
9
Mariangela Gualtieri, “Poeta che parla”, Prove di drammaturgia, 1, 2013, pp. 36-37.
GABRIELE VACIS
LA DRAMMATURGIA DELL’ATTENZIONE
Divido in due parti il mio racconto e infine vi parlerò brevemente di Nadia.
Nella prima parte vi leggo l’introduzione alla nuova edizione de Il racconto del
Vajont, che non è ancora in libreria ma lo sarà tra poco. La fascetta sul libro dice:
1963-2013. Cinquant’anni dopo. Un grande libro per non dimenticare con due saggi inediti degli autori. Leggo qui il mio:
Sono passati quindici anni dalla prima uscita di questo libro, e più di venti da quando abbiamo cominciato a pensare alla tragedia del Vajont. Quello che è successo in
tutto questo tempo mi ha aiutato a capire qualcosa proprio sul tempo.
Vent’anni fa stava finendo il millennio. Nella cultura dell’epoca prevalevano due atteggiamenti opposti: prepariamoci alla fine espiando le nostre colpe; oppure: godiamoci il tempo che ci rimane. Era qualcosa che avevano dovuto conoscere già alla fine
del primo millennio, quando si pensava che allo scoccare della mezzanotte del novecentonovantanove sarebbe finito il mondo. Questa volta c’era l’aggravante del mille
non più mille. Ogni nuovo libro, ogni nuovo spettacolo, ogni nuova opera d’arte si
annunciava come il gesto ultimo di un’umanità esausta. Gli intellettuali di spicco davano per compiuta la fine del romanzo, la fine del teatro, la morte dell’arte in genere.
Dio era morto da un pezzo e uno storico americano, nel 1992, pensò che era arrivato
il momento di sancire la fine della storia.
Quindi, quello che si vedeva vent’anni fa erano grandi spettacoli espiatori, che affondavano le radici nei rituali del pianto e della morte. Mentre sull’altro versante si
imponevano orge di nonsenso effimero e giocoso.
Il teatro ha tre fonti: il rito, il gioco, la narrazione. Il rito e il gioco, declinati in mille
poetiche, erano all’origine di ogni proclama finale. In questo quadro la terza fonte del
teatro sembrava dimenticata o, piuttosto, inutile.
La narrazione è affermazione del tempo. Se il tempo sta per finire cosa t’importa di
affermarlo? La narrazione è conferma del passato e del futuro. Se sei convinto di non
avere futuro, perché dovresti confermarlo? E se non hai un futuro, che te ne importa
del passato? E se la storia è finita cosa ti rimane da raccontare?...
Per la nostra generazione, cresciuta al cospetto di grandi creatori di riti finali e di giochi mortali, che possibilità c’erano? Ci rendevamo ben conto delle tragedie che testimoniavano i nostri padri. Ci scorrevano davanti agli occhi le loro visioni potenti di
un’umanità offesa da Auschwitz, da Hiroshima, dai gulag. Nutrivamo grande rispetto per la loro angoscia: avevano tutte le ragioni di coltivarla e celebrarla. Certo, era
un po’ frustrante essere giovani mentre tutto, intorno, stava per finire. Per fortuna
c’erano anche ‘padri’ come Peter Brook e Dario Fo, che continuavano a tessere grandi
racconti, che per noi erano scialuppe di salvataggio nell’oceano del senso.
Infatti, già da qualche anno, un po’ clandestinamente, avevamo cominciato a frugare
tra le macerie del Novecento. Quello che si trovava erano frammenti, schegge di costruzioni precedenti, che però, reincollate da nuove tecnologie come la televisione,
come Internet, sembravano sagomare semplici forme di racconto. Nel teatro, in particolare, quello che sembrava riemergere era la trascurata terza fonte: la narrazione.
284
Gabriele Vacis
La realtà si frammentava. Però scoprivamo che questi frammenti di realtà, riaccostati
come nei puzzle, producevano narrazioni, storie... Tempo. Sperimentavamo con sorpresa che non era vero che il tempo era finito. Oppure sì, magari era finito, però nulla
vietava di fabbricarne di nuovo. E una possibilità di produrre tempo era raccontare il
passato per costruirsi un futuro. Era dalla fine degli anni Settanta che provavamo a
costruirci un futuro, nonostante la fine della storia. Il racconto del Vajont fu uno degli
episodi che vent’anni fa attestarono la riconquista del tempo.
Prima c’era il «teatro di parola», che esigeva l’estrema, estenuata considerazione di ogni
vocabolo: che ogni parola, in teatro, sia pronunciata come fosse l’ultima! Così si affermavano spettacoli monumentali, in cui le parole fioccavano come macigni. Ci volevano
intervalli lunghi tra l’una e l’altra perché si depositassero nell’anima dello spettatore.
Quando ti travolgeva la parola successiva non avevi già più memoria di quella precedente: era paradossale, ma il peso della parola annullava il ‘discorso’, che si compone
nella relazione tra le parole. Il teatro di parola, costringendo all’isolamento, alla solitudine ogni singolo lemma, dilatava il tempo fino a dissolverlo. Per contro, c’erano grandi artisti che innalzavano canti meravigliosi fatti di parole dilaniate, straziate.
L’andamento tonale, la modulazione virtuosistica. Il suono aveva la meglio sul senso.
L’esito era conforme: entrambe le tendenze testimoniavano la perdita di significato del
testo, che annunciava la catastrofe finale: mille non più mille.
Tutto il nostro lavoro precedente al racconto del Vajont si era sviluppato in una ‘fucina’ che era il Laboratorio Teatro Settimo. I nostri spettacoli rincorrevano la ricomposizione del tempo. Non cercavamo più le profondità abissali di ogni parola, non ci
interessava più solo il loro suono. Esploravamo i legami tra le parole. C’interessava
molto il suono delle parole, il loro ‘canto’, ma perché serviva a riverberarne il senso.
Il nostro non era più teatro di parola, ma ‘teatro di discorso’.
Negli anni in cui pensavamo al racconto del Vajont si affermava anche ‘la televisione
di parola’. Per certi versi sembrava il contrario del teatro di parola, ma a ben vedere
l’obiettivo era lo stesso: celebrare la decomposizione del senso attraverso il dissolvimento del tempo. La ‘televisione di parola’ erano fluviali talk show in cui si ‘chiacchierava’ all’infinito. Il vuoto pneumatico creato dalla massa specifica della parola
teatrale si traduceva, in televisione, in un profluvio di vaniloqui che invece sottraeva
peso al discorso, fino ad annullarlo.
Credo che il successo, anche televisivo, del Racconto del Vajont, nascesse dalla sorpresa di una parola in equilibrio tra il senso e il suono. Il che generava un ‘discorso’ immediatamente comprensibile. Ma dove la comprensione non era tolleranza indulgente
e la comprensibilità non era facile accesso che banalizza. La comprensione per noi
aveva un gusto arcaico, come il suono di lingue dimenticate. In genere riesce molto
più facile capire piuttosto che comprendere: è così che assorbiamo le onnipresenti
immagini pubblicitarie, così guardiamo distrattamente televisori, computer, iPhone e
iPad. Comprendere era qualcosa come spalancare le fauci fino a farsi scricchiolare i
tendini. Vedere fino a distinguere le congiunzioni di una realtà che sembrava sbriciolarsi davanti ai nostri occhi. Ascoltare fino a sentire molte voci contemporaneamente:
quelle che venivano da lontano, dalla televisione, dal Web, ma anche quella che arriva dalle persone che ci sono accanto... Quella che viene da altri tempi, dal passato o
dal futuro, ma anche quella parola che viene pronunciata qui, adesso.
Credo che nei quindici anni dalla pubblicazione di questo libro, la narrazione abbia
cominciato ad affermarsi come strumento per produrre tempo, e quindi realtà. Che è
poi un gesto antico come il mondo. Qualche volta, soprattutto nelle parole di certi
politici che intendono la narrazione come fabbricazione di verità a proprio uso e con-
La drammaturgia dell’attenzione
285
sumo, si ha addirittura l’impressione di un abuso della pratica narrativa. E in effetti
quando la narrativa sia slegata dalla comprensione può produrre esiti inquietanti.
Ma alla fine credo che la pratica del narrare significhi riconciliarsi con il tempo, con il
succedersi delle generazioni. L’unica possibilità per uscire dalle secche della contrapposizione tra cogliere l’attimo e coltivare la memoria o progettare il futuro. Forse
riconciliarsi con il tempo si- gnifica semplicemente ‘stare’, coltivarne la consapevolezza.1
Ecco, finisce così il pezzo che ho scritto per questa nuova edizione del Racconto
del Vajont. Poi, per il mio intervento di oggi, mi ero preparato una scaletta. Però,
come spesso accade quando incontro Gerardo Guccini, lui mi sconvolge tutto il
percorso e, quindi, l’ho riformulato. Allora: permettetemi prima di tutto di ringraziare Gerardo, perché spesso mi dice quello che sto facendo. Voi siete ricercatori,
siete dottorandi, beh, credo che questo sia proprio il ruolo di chi studia: dire a chi
fa che cosa sta facendo. È molto utile. Naturalmente bisogna saperci fare, bisogna
essere molto bravi. Il professor Guccini è uno dei pochi che riesce a spiegarmi cosa
sto facendo. Cioè, io vado avanti su quello che faccio ‒ non è che mi fermo a pensarci sopra ‒ però poi lui arriva e mi dice: “Guarda che stai facendo questo”. Ecco.
Il suo discorso su George Sand mi ha colpito perché mi spiega quello che sto facendo, soprattutto quando dice che gli Shakespeare dell’avvenire saranno i grandi
attori. È come se George Sand, con più di un secolo di anticipo avesse intuito Dario
Fo. E infatti, guarda caso, più di un secolo dopo, Dario Fo ha vinto il premio Nobel
per la letteratura. E credo che possiamo concordare sul fatto che il premio non è
stato dato alla scrittura letteraria di Fo, ma alla sua ‘narrazione’, che comprende
tutto lui stesso: il suo corpo e la sua voce. C’è una coincidenza divertente nel Premio Nobel a Dario Fo. Glielo hanno dato il giorno in cui è andato in onda Il Racconto del Vajont. Quella sera, durante la diretta televisiva, abbiamo dovuto inserire in
fretta e furia un omaggio a quello che abbiamo sempre considerato un maestro. Per
me questa coincidenza ha un senso molto preciso: conferma idealmente quello che
cercavo di dirvi nell’introduzione al libro che vi ho appena letto: significa che in
quel momento, nel 1997, si stava conquistando una certa idea di ‘tempo’, una sua
riscoperta, e quindi la riconsiderazione della possibilità del succedersi delle generazioni.
La seconda parte del mio intervento vorrei allora impiegarla per raccontarvi
quello che sto facendo adesso. Il racconto del Vajont era un ponte gettato tra la mia
generazione e quella dei nostri padri. Con il lavoro che vi racconterò cerco di gettare un ponte con la generazione dei nostri figli.
Da un po’ di tempo nutro una sensazione di disagio di fronte alla gran parte del
teatro che vedo, ma anche di fronte alla gran parte del cinema, perché li trovo
1 Gabriele Vacis, Il racconto e la consapevolezza del tempo, in Marco Paolini e Gabriele Vacis, Il Racconto
del Vajont, Garzanti, Milano, 2013, pp. 13-16.
286
Gabriele Vacis
sempre ‘troppo scritti’. Trovo sempre tutto troppo scritto. Gerardo Guccini, citando
di nuovo George Sand mi ha aiutato a comprendere questa sensazione: è quando la
scrittrice francese dice che “un giorno, tutte le persone che saranno in grado di
recitare, reciteranno”. Ecco: credo che sia arrivato quel giorno. Oggi sono molte di
più le persone che ‘fanno’ teatro di quelle che ‘vanno’ a teatro. Sembra un paradosso, ma se contate i gruppi spontanei, le filodrammatiche, i gruppi scolastici, ma
soprattutto l’utilizzo che del teatro fanno le aziende o i reading che si moltiplicano
ovunque, insomma la cosa non è paradossale, è semplice realtà. Succede anche per
la scrittura, per la fotografia, per il cinema. Con i nostri iPhone produciamo continuamente immagini e video, molti dei quali non godranno mai della grazia di uno
sguardo. Ecco, credo che il gesto successivo alla narrazione debba fare i conti con
tutto questo. Perciò vi racconto un progetto che ho fatto negli ultimi due anni e che
si chiama Cerchiamo bellezza. Questo progetto ha già generato uno spettacolo: La
bellezza salvata dai ragazzini.2
Nel corso di un anno e mezzo abbiamo incontrato circa un migliaio di ragazzini.
Li abbiamo cercati nelle scuole di Vercelli, Novara, Alessandria e della periferia di
Torino. Poi abbiamo capito che molti ragazzi a scuola non ci vanno, quindi abbiamo coinvolto organizzazioni di diverso tipo: da oratori salesiani ad associazioni
che si prendono cura di adolescenti che tentano il suicidio e tutti i luoghi di aggregazione che abbiamo trovato. Abbiamo fatto incontri ovunque: aule universitarie e
piccole scuole di teatro e di danza, centri sociali e radio locali. Durante gli incontri
convocavamo i ragazzi il sabato pomeriggio in biblioteche, palestre o teatri. Il sabato pomeriggio c’erano dei laboratori che abbiamo finito per chiamare “rave teatrali”. Cosa si faceva in questi rave? Se dovessi sintetizzarlo in tre parole direi che
‘stavamo in attenzione’. Da molti anni sviluppo un esercizio che si chiama “Schiera”. Consiste nel creare azioni comuni. Dal semplice camminare al costruire situazioni, danze, canti. L’importante è che i partecipanti ascoltino e vedano la realtà
che li circonda. Abbiamo fatto un video che racconta il percorso di cui vi sto parlando, riguarda Vercelli, da quando siamo arrivati a quando abbiamo conquistato
il Teatro Comunale.3
Poi percorsi simili li abbiamo fatti, come dicevo, ad Alessandria, a Novara e nella periferia torinese. Dei mille ragazzi che abbiamo incontrato, alcuni ce li siamo
portati dietro per tanto tempo, altri sono venuti lì un giorno e poi non sono più
tornati. Ma credo che in fin dei conti tutti quanti si siano portati a casa qualcosa.
I rave teatrali comprendevano anche delle interviste realizzate su un set cinematografico ‘portatile’. Durante i colloqui sul set facevamo domande ‘narrative’. Non
chiedevamo opinioni, niente domande tipo: “cosa pensi della bellezza?”. Facevamo
domande che esigevano delle storie come risposta: “qual è stato il momento più
2
3
Il video che annuncia il progetto è disponibile al link http://vimeo.com/95878692 (07/14).
Disponibile on line al sito https://www.youtube.com/watch?v=7NxtinFOEs4 (07/14).
La drammaturgia dell’attenzione
287
bello della tua vita?”, “Qual è il posto più bello del mondo, quello in cui sei stato e
quello in cui vorresti andare?”.4 Alla fine abbiamo fatto lo spettacolo. Io, sulla scorta di esperienze precedenti, avevo in mente un lavoro con una ventina di ragazzi,
invece ne abbiamo messi in scena cinquantotto. Non abbiamo fatto selezioni. Semplicemente, nel corso del tempo, abbiamo progressivamente alzato l’asticella. Quelli che hanno voluto ci hanno seguiti. Per esempio: lo spettacolo ha debuttato il 9
aprile del 2013, e quindi le prove hanno occupato tutte le loro vacanze di Pasqua.
Le prove dello spettacolo erano alle Fonderie Limone, che è una vecchia fabbrica
trasformata in teatro vicino a Moncalieri. È una delle sedi del Teatro Stabile di Torino. I ragazzi che venivano da Vercelli, da Alessandria, da Novara, da lontano,
abitavano nella foresteria delle Fonderie Limone. Capite che per un ragazzino di
sedici o diciassette anni sacrificare le proprie vacanze di Pasqua per provare uno
spettacolo è un atto di coraggio non indifferente. I coraggiosi sono arrivati fino alla
fine e sono andati in scena. Lo spettacolo era in abbonamento nella stagione del
Teatro Stabile ed ha fatto l’esaurito per una settimana di repliche. Voglio dire: hanno fatto una cosa vera, non un saggio o una recita scolastica. E per me non si è trattato di una ‘concessione’ all’animazione. Per me, oggi, questo lavoro, è la realizzazione più concreta di una poetica.
Vi parlo brevemente della drammaturgia dello spettacolo. L’abbiamo composta
attingendo prevalentemente alla pagina Facebook <https://www.facebook.com/
pages/Cerchiamo-Bellezza/286871954754837?fref=ts>. Per diversi mesi abbiamo
chiesto ai ragazzi di postare sulla pagina Facebook, ogni giorno, il loro momento di
bellezza. Un momento di bellezza al giorno! I testi che i ragazzi hanno scritto sulla
pagina Facebook sono diventati il testo dello spettacolo. Il compito era: la bellezza
di oggi. E sono uscite cose così:
Sul treno. Seduta di fronte a me una ragazza teneva sulle ginocchia “Cime tempestose”. Le ho chiesto se potevo leggerne la prefazione. Lei: “Certo”. Quando ho finito le
ho allungato il libro, ma lei mi ha guardato, mi ha sorriso e ha detto: “Se ti va puoi
leggerlo finché scendiamo”.
La bellezza è la vigilia di qualcosa.
Mio nonno ha potato il pesco e mi ha portato un po’ di rami pieni di piccole gemme
rosse. Le ho messe in un vaso d’acqua e le gemme sono già diventate grandi e rosa.
Domani sbocceranno.
Scegliti un buon prato e osserva le stagioni finché capirai dove mettere i piedi, come
metterli e l’importanza di non calpestarlo, il buon prato. Abbiamo bisogno di passi
più leggeri per avere ancora e sempre sedici anni.
4 Le risposte ottenute si possono ascoltare on line ai seguenti link: <https://vimeo.com/95879196>
(07/14); <https://vimeo.com/95879351; https://vimeo.com/95878803; https://vimeo.com/95878898> (07/14).
288
Gabriele Vacis
Oggi la professoressa ha letto queste parole: “Esiste un punto nell’oceano dove tutte
le correnti si incontrano e l’acqua si ferma. Bisogna aspettare di imboccare una corrente per essere portati via”. Sono io quel punto fermo nell’oceano. Non vedo l’ora di
essere trascinata via.
Mia mamma è proprio bella.
Mi sono addormentato sul divano, scoperto. Mi sono risvegliato coperto, e in casa
c’era solo papà.
La mia bellezza di oggi è in stazione, quando Niky, decifrandoci il tabellone degli
orari, ha sentenziato: “Torino PS significa Torino post scriptum”. E noi ci abbiamo
creduto.
Questa notte, sentendo ridere Sabrina. Niente di particolare, è successo tante altre
volte.
Il momento più bello di oggi: una donna tenta di dare ai suoi allievi il vigore di fare
qualcosa come se fosse l’ultima cosa che fa prima di morire. Brava prof!
Sullo spazio scenico de La bellezza salvata dai ragazzini campeggiava un grande
schermo su cui venivano proiettati i colloqui raccolti sul set portatile. Alla fine
dello spettacolo, sullo schermo, appariva questa scritta: “la bellezza va protetta
dalle nostre stesse grida di gioia”.
Insomma, quello che abbiamo fatto con questo lavoro è mettere in pratica una
sorta di “drammaturgia dell’attenzione” che credo assomigli all’idea di George
Sand quando dice che un giorno tutti quelli che saranno in grado di recitare reciteranno. Specie se penso che in francese recitare si dice jouer. L’esercizio da cui siamo
partiti, la “Schiera” è lo strumento più adatto. Ho cercato spesso di definire la
Schiera, mi aiutava una delle città invisibili di Italo Calvino, Marozia, oppure la
pagina della madeleine di Proust. Uno dei ragazzi che facevano lo spettacolo, un
giorno, sulla pagina Facebook, ha spiegato così quello che facevamo: “hai mai
guardato la neve? Scende calma, scende tutta insieme. Ogni fiocco si prende cura
di quello vicino per non lasciare spazi vuoti. Nessun fiocco di neve guida un altro
fiocco di neve. Tutti insieme sanno cosa fare”. Questo è quello che sto cercando di
fare da anni con la Schiera: lui l’ha detto così. E mi sembra più efficace di Calvino e
Proust.
E per finire vi dico qualcosa su Nadia. Anche questo mi è stato suggerito dalle
parole del professor Guccini sul flusso di coscienza. Nel giugno scorso ho lavorato a
Milano con undici disabili, psichici e fisici. Alcuni erano tranquilli e disciplinati. Di
altri, non avevi mai la minima idea di quello che avrebbero detto e fatto l’attimo
successivo. Uno di queste si chiama Nadia. Nadia è alta un metro e trenta, magra
come un chiodo. Gli psichiatri dicono che ha il morbo di Basedow associato ad una
sindrome psicorganica. Parla forbitamente. Usa termini come “corroborante, incan-
La drammaturgia dell’attenzione
289
tevole, seducente”. Solo che li ripete all’infinito. Per esempio: “Gabriele, Gabriele,
Gabriele, Gabriele, mi offri qualche cosa di amaro? Qualche cosa di amaro, qualche
cosa di amaro, amaro, amaro, amaro… Un caffè, un caffè, un caffè, una buona,
ottima, aromatica, corroborante tazzina di caffè, ma amaro, amaro, veramente,
veramente, veramente, veramente, veramente, veramente amaro…”.
Nadia è una che può tacere per tutto un pomeriggio o non smettere un attimo
di parlare. Colleziona rossetti. Non lo mette spesso, il rossetto, ma chiede a chiunque di portargliene un paio, specificando la gradazione di colore. Può raccattare in
un giorno anche venti o trenta rossetti. Incontra una signora e le dice: “Che bel
rossetto, che colore incantevole, incantevole, incantevole, che bel colore incantevole… Un colore veramente, veramente, veramente, veramente seducente, veramente
affascinante, affascinante, af-fa-sci-nan-te, te, te, te… Ce l’hai qui il rossetto? Ce
l’hai qui?... Me lo regali?”. E le signore glielo regalano.
Lei, Nadia, un giorno ha fatto una cosa pazzesca. Ha dispiegato un flusso di coscienza di mezz’ora, e noi siamo rimasti secchi a guardarla e ad ascoltarla. Parlava
con una proprietà di linguaggio che comportava l’uso di espressioni come “non
posso assumere carboidrati perché voglio un pancino veramente piatto, un affascinante, seducente, provocante pancino veramente piatto, veramente, veramente,
veramente pi-at-to, tto, tto!…”. Usava metafore e metonimie, ossimori come “la
mia casa, la mia casa, la mia casa, la mia nuova vecchissima casa, la mia nuovissima vecchissima casetta… la mia amata, amatissima casa, la mia amata odiatissima
casa…”.
Di fronte a Nadia che faceva fluire la propria coscienza ho ripensato a quanto ci
ho lavorato sul flusso di coscienza. A quanti flussi di coscienza abbiamo provato a
scrivere con Marco Paolini, con Laura Curino, con Lella Costa, con Arianna Scommegna. Il finale dell’Ulisse di Joyce è sempre stato un’ossessione per me. Ho cercato di metterlo in scena non so quante volte. E Céline, che cercava di scrivere come i
pensieri che ti scorrono in testa… Ecco: di fronte a Nadia che parlava scompariva
tutto. Non c’era scrittura dietro alla sua presenza. Tutto quello che avevo fatto fino
a quel momento, tutto quello a cui potevo pensare diventava, irrimediabilmente,
‘troppo scritto’.
Vi ho detto del Racconto del Vajont, de La bellezza salvata dai ragazzini e di Nadia,
perché il mio percorso è partito dalla narrazione, dove ritrovavo un rapporto con il
tempo nel suo fluire. Mi interessava ‘produrre tempo’: ero convinto che tutto il
tempo non raccontato è tempo sciupato. Per questo ci volevano attori/autori consapevoli della propria presenza in scena: Dario Fo era il modello. Produrre tempo è
sempre bello e necessario. Però quello che mi affascina veramente adesso, veramente, ve-ra-men-te, te, te, è “stare dentro al tempo”. E per questo ci vogliono persone reali, che siano esse stesse tempo.
290
Gabriele Vacis
DAVIDE ALIBERTI
THE LADINO PLAYERS:
DALLA NARRAZIONE ORALE ALLA PERFORMANCE
NEL TEATRO SEFARDITA STATUNITENSE
Premessa
I Ladino Players sono stati una compagnia teatrale attiva tra il 1994 e il 2004 nel
Lower East Side di New York, che ha dedicato i suoi dieci anni di attività alla riscoperta e alla trasmissione della lingua e dell’identità sefardita. ‘Ladino’ è il nome
con cui negli Stati Uniti e in Israele è conosciuta la lingua giudeo-spagnola, un
termine che deriva dal verbo enladinar, “tradurre in latino”, che nella Spagna del
XV secolo stava a indicare un particolare processo di traduzione dei testi sacri della
cultura ebraica. Il ladino era di fatto una lingua utilizzata unicamente per le traduzioni, nelle quali ciò che variava era unicamente il lessico, trasposto in spagnolo,
mentre restava del tutto invariata la struttura sintattica dell’originale ebraico,
creando così una sorta di lingua calco, come l’ha definita Vidal Sephiha,1 molto
diversa dalla lingua parlata, quotidianamente conosciuta col nome di giudeospagnolo o judezmo. La compagnia, fondata dallo studioso sefardita David Fintz
Altabé, era composta da ebrei sefarditi e ashkenaziti provenienti da contesti differenti e con differenti livelli di comprensione del giudeo-spagnolo; nonostante ciò, è
stata questa la lingua nella quale hanno scritto e interpretato tutte le opere.
Come tutte le compagnie teatrali sefardite, anche i Ladino Players sono sempre
rimasti una compagnia amatoriale, con l’unica differenza che la loro attività non si
è mai limitata soltanto all’intrattenimento, ma si è concentrata su una più incisiva
operazione culturale di recupero e diffusione della cultura giudeo-spagnola,2 attraverso una pratica teatrale mirata a rendere il pubblico parte attiva nel processo di
rivalorizzazione e modernizzazione della lingua e fargli prendere coscienza della
propria identità. Ci si soffermerà qui su alcuni frammenti di un’opera dei Ladino
Players intitolata Prezentando una Meghilah para Muestros diyas, tentando di metterne in luce, attraverso l’analisi del particolare uso della lingua e delle strategie performative adottate, l’importante progetto di recupero identitario, linguistico e culturale, sempre sotteso al lavoro della compagnia. Prima, però, sembra opportuna
una breve ricognizione storica del teatro sefardita.
1 Haim Vidal Sephiha, Le Ladino: (judéo-espagnol calque): structure et évolution d'une langue liturgique,
Association Vidas Largas, Paris, 1979.
2 Aviva Ben-Ur, Sephardic Jews in America, New York U.P., New York and London, 2009.
292
Davide Aliberti
Origini del teatro sefardita
La diaspora sefardita ha origine dall'espulsione degli ebrei dalla Spagna nel
1492, un evento che costringe centinaia di famiglie a stabilirsi nelle principali città
del Mediterraneo, dove la loro lingua e la loro cultura continuano a evolversi a
stretto contatto con le lingue e le culture locali. Il giudeo-spagnolo diviene così una
lingua composta da frammenti di altre lingue, una mixture o jargon3 che intorno al
XIX secolo arriva ad affermarsi come lingua letteraria e culturale di tutte le comunità dell’area mediterranea. Le origini del teatro sefardita sono riconducibili proprio a questo periodo quando, tra il 1860 e il 1870, nelle città ottomane di Edirne,
Istanbul e Izmir vengono messe in scena le prime opere in giudeo-spagnolo, consistenti in brevi drammi di carattere religioso provenienti dalla tradizione orale.4
Solo a partire dal 1880, con l’apertura del teatro di Salonicco, inizia a prendere
forma una vera e propria tradizione teatrale sefardita, un processo lento che si
consolida agli inizi del XX secolo grazie all’attività delle scuole dell’”Alliance Israelite Universelle” (AIU), che contribuiscono a trasformare le piccole comunità ortodosse disseminate su tutto il territorio ottomano in gruppi etnici pluralistici interamente proiettati nella cultura europea moderna.5 Tra le opere di maggiore successo in questo periodo si annoverano El tyempo del 1882, un adattamento
dell’Esther di Jean Racine, e Istoriya de Han Benyamin del 1884, una versione in giudeo-spagnolo de l’Avare di Molière, tradotta e adattata dal celebre David Joseph
Hassid. Quest’ultima, in generale, ricalca l’originale francese, con l’unica differenza
che Hassid sposta l’ambientazione da Parigi a Salonicco e cambia il nome dei personaggi trasformando Valère in Enriko, Mariane in Matilde e Anselme nel sinyor
Eduardo,6 e creando in tal modo maggiore empatia con un pubblico che non sarebbe mai riuscito a identificarsi in un gentiluomo parigino. Gli adattamenti di Hassid
riscuotono così tanto consenso che i sefarditi arrivano a conoscere alla perfezione le
opere di Molière, pur senza avere alcuna conoscenza dei nomi dei suoi personaggi
originari. In questo modo si contribuisce alla diffusione della cultura francese, rinforzando al tempo stesso l’identità giudeo-spagnola. Nel 1886 va in scena a Salonicco il Sefer Milhama Beshalom, un classico dell'ebraismo ashkenazita scritto da
Haim Abraham Katz nel 1797.7 Diversamente dall’originale in cui il razionalismo e
l’intellettualismo riflettevano le forti influenze dell’Haskalah (l’illuminismo ebraiHaim Vidal Sephiha, Le Judéo-Espagnol, Entente, Paris, 1986, p. 77.
Elena Romero, "El teatro entre los sefardíes orientales", Sefarad, 29, 1969, pp. 178-212.
5 Aron Rodrigue, French Jews, Turkish Jews: The Alliance Israélite Universelle and the Politics of Jewish
Schooling in Turkey, 1860-1925, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1990, pp. 80-90.
6 Olga Borovaya, Modern Ladino Culture: Press, Belles Lettres, and Theatre in the Late Ottoman Empire,
Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 2011.
7 David Bunis, "Associational Strategies in Ottoman Jewish Society in the Nineteenth and Twentieth
Centuries", in Avigdor Levy (a cura di), The Jews of the Ottoman Empire, The Darwin Press, Princeton,
1994, pp. 457-484.
3
4
The Ladino Players: dalla narrazione orale alla performance…
293
co), la versione giudeo-spagnola è immersa in un’atmosfera mistica, malinconica e
seducente.8 Il pubblico di queste prime rappresentazioni è composto da membri
dell’emergente borghesia sefardita formatisi nelle scuole dell’AIU e, solo a partire
dagli inizi del XX secolo, comincia a diversificarsi includendo anche altre fasce
della popolazione. Nello stesso periodo il teatro sefardita si avvicina a tematiche di
interesse più squisitamente sociale,9 come nell’opera in cinque atti intitolata Los
males de la colada che descrive in modo minuzioso la vita nel quartiere ebraico di
Salonicco con tutte le sue abitudini, i detti e i proverbi che ne caratterizzano la quotidianità.10 Tra il 1920 e il 1930 l’attività teatrale si intensifica notevolmente, diventando strumento di propaganda e di educazione politica, come nel caso della
Resurrección di Tolstoj, allestita nel 1919 dalla compagnia teatrale della Federazione
Socialista, e dell’adattamento dell’Esther di Racine scritto dall’attivista Betar
Shlomo Reuvain.11
Oltre che a Salonicco, i sefarditi conducono un’intensa attività teatrale anche in
altre città dell’Impero Ottomano come Rodi, Drama, Xanthi e Kastoria, dove il 18
novembre 1917 ha luogo un grande spettacolo a sostegno delle numerose vittime
dell’incendio che aveva colpito Salonicco al principio dell’estate dello stesso anno.12
Sempre a Kastoria, nel 1932, riscuote un notevole successo El medico malgrado, tratto
dalla commedia di Molière Le Médecin malgré lui e messo in scena dall’”Association
of Young Jews” in occasione del “Tu Bishvat”. Questa compagnia acquisisce negli
anni una fama sempre maggiore, riuscendo in breve tempo ad aprire un grande
club comprendente una libreria, un punto di ristoro e un teatro che rimane aperto
fino al 1937, anno in cui la compagnia si scioglie e la maggior parte dei membri si
trasferisce in Palestina dove fonda la “Greek-Jewish Agricultural Cooperative Settlement Moshav Tsur Moshe”.13
Il teatro sefardita negli Stati Uniti
Con la caduta dell’Impero Ottomano nel 1922 e il propagarsi dei movimenti nazionalisti in tutta l’area balcanica, molti sefarditi emigrano negli Stati Uniti andando a costituire una delle prime e più popolose comunità nordamericane, quella del
Lower East Side di New York, più comunemente conosciuta come la ‘Kolonia’. Si
8 Alicia Barouch, "The Parallelism between Milhama Beshalom and the Yiddish Popular Theatre", in
Issacher Ben-Ami (a cura di), The Sephardi and Oriental Jewish Heritage Studies, The Magnes Press, Jerusalem, 1982, pp. 277-285.
9 Michael Molho, Literatura Sefardita de Oriente, Instituto Arias Montano, Madrid, 1960.
10 Elena Romero, El teatro de los sefardíes orientales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Madrid, 1979.
11 Ibid.
12 Romero, El teatro de los sefardíes orientales, cit.
13 Yosef Eliyahu, Memories of the History of the Jewish Community of Castoria in the Twentieth
Century, Moshav Tsur Moshe, Israel, 1983.
294
Davide Aliberti
tratta di una vera e propria enclave sefardita nel cuore della città, che con gli anni
arriva a ospitare circa ventimila ebrei di lingua giudeo-spagnola, molti dei quali
svolgono un’intensa attività teatrale attraverso i “Sephardic Drama Clubs”. Queste
piccole associazioni di attivisti arrivano ad attrarre fino a duemila spettatori, organizzando spettacoli teatrali spesso seguiti da balli che si protraggono fino alle prime ore del mattino. Tali avvenimenti sono stati sin da subito seguiti con grande
interesse dalla stampa sefardita che, allo stato attuale, costituisce l’unica testimonianza su gran parte di questi spettacoli.
Una delle prime rappresentazioni allestite nella Kolonia è stata Ahashverosh i
Ester, organizzata da “La Sosietá Hesed VeEmet de Kastorialís” nella primavera
del 1911 e riproposta nel 1916 da “La Sosietá Ahavat Shalom de Monastir”. L’opera
è stata ampiamente elogiata da Maurice S. Nessim, direttore del quotidiano socialista in giudeo-spagnolo El Progreso, in una lunga recensione in cui apprezzava, fra
le altre cose, l’interpretazione di Adele Confino nel ruolo di Esther. La prima tragedia di Shakespeare tradotta e adattata in giudeo-spagnolo è stata invece Romeo i
Julieta, portata in scena dalla “Young Men Sephardim Association” nel 1916 e recensita sempre da El Progreso in un articolo in cui venivano celebrate Miss Ester
Assael nel ruolo di Giulietta e le toccanti interpretazioni di Regina Taragano e Rica
Medini. Nel 1922 il quotidiano La Luz giudica un successo sensazionale l’opera
Amor i Dezespero o La Arleziana, una tragedia in cinque atti allestita dalla “Sosiedad
de Karidad de Ozer Dalim”, che vanta il più grande numero di spettatori della
storia della Kolonia. L’attrice che ha raggiunto il più alto livello di celebrità nel
teatro sefardita statunitense è stata senza dubbio Esther Cohen, la cui attività teatrale nel corso degli anni ‘30 viene documentata dall’unico quotidiano in giudeospagnolo, La Vara, edito tra il 1922 e il 1948 nel Lower East Side e dunque ancora in
attività in quel periodo. In seguito alla seconda guerra mondiale le rappresentazioni teatrali diminuiscono notevolmente fino quasi a scomparire. Tra le poche associazioni rimaste, solo la “Sisterhood Congregation of VeShalom” di Atlanta allestisce qualche rappresentazione tra il 1958 e il 1973, mantenendo tracce di giudeospagnolo unicamente nei canti. Questo rapido declino è dovuto alla progressiva
perdita di prestigio della lingua giudeo-spagnola e al sempre più scarso interesse
che le nuove generazioni hanno riservato alla cultura sefardita.14
Prezentando un Megilah para Muestros Diyas
Dalla prima metà degli anni ’90 fino agli inizi del XXI secolo il teatro sefardita
statunitense vive un periodo di rinascita grazie all’attività dei Ladino Players. La
loro prima produzione è Ester A-Malká, un'opera del Purim portata in scena nella
14 Tracy K. Harris, Death of a language: the history of Judeo-Spanish, Newark University of Delaware
Press, Newark, 1994.
The Ladino Players: dalla narrazione orale alla performance…
295
primavera e nell'estate del 1995, seguita l’anno successivo da Prezentando una
Meghilah para Muestros diyas e da Merekiyas de Orchard Street, dramma basato sulle
tensioni tra gli ideali delle vecchie e nuove generazioni di immigrati sefarditi a
New York. Tra le altre opere di successo si annoverano Forsyth Street del 1997, basata sull’esperienza di emigrante di David F. Altabé nel Lower East Side, Aviya der
Ser del 2002 e Panorama Sefaradi del 2003, ricavate da una selezione di racconti degli
autori sefarditi contemporanei Matilda Koén-Sarano e David M. Bunis. La compagnia si rifà molto al teatro sefardita statunitense degli inizi del XX secolo, utilizzando quasi esclusivamente la lingua giudeo-spagnola e mantenendo una stretta
relazione con lo spazio urbano circostante, sia per quanto riguarda le tematiche
trattate (l’esperienza degli immigrati sefarditi nella Kolonia), sia in relazione ai
luoghi rievocati (Forsyth Street, Orchard Street, i confini urbani dell’antica Kolonia
sefardita).
Prezentando una Meghilah para Muestros diyas risulta essere una delle opere che
meglio rappresentano l’impegno dei Ladino Players nella riscoperta e diffusione
della lingua e dell’identità sefardita, un processo attraverso il quale attori e pubblico collaborano attivamente alla riscrittura e modernizzazione di un testo tradizionale. L’opera è una rivisitazione della storia di Ester, una donna ebrea che va in
sposa al re di Persia riuscendo così a sventare la congiura ordita dal primo ministro
del re contro la sua comunità. I Ladino Players dividono la rappresentazione in tre
atti, ambientandola nella Social Hall di una sinagoga in cui si sta preparando una
rappresentazione della storia di Ester in occasione del Purim. La narrazione assume dunque sin dal principio una struttura metateatrale, caratterizzata da due vicende sovrapposte: quella della regina Ester e quella dell’allestimento della sua
storia nella New York del XX secolo. Nella scena d'apertura il Rabbino si rivolge
direttamente al pubblico dicendo: “Vozotros tambien devesh uzar la lengua antes
de ke se vos olvide por entero”15 (“Anche voi dovete usare la lingua prima che la
dimentichiate completamente”), e da quel momento in poi l’intera rappresentazione si svolge in giudeo-spagnolo, costringendo così il pubblico a comprendere una
lingua che non parla da anni o che non ha mai parlato, pur essendo in qualche
modo parte del suo bagaglio culturale. L’affermazione del Rabbino genera sorpresa e sgomento non solo fra gli spettatori, ma anche fra gli stessi attori che cominciano a pretendere delle spiegazioni. La risposta del Rabbino non lascia spazio a
repliche, dal momento che – sostiene ‒ tutti loro dovrebbero già conoscere la storia
della regina Ester, essendo parte della memoria collettiva della diaspora; riguardo
poi alle presunta inaccessibilità della lingua, continua il Rabbino, la maggior parte
degli spettatori ha studiato spagnolo a scuola o inteso parlare giudeo-spagnolo
almeno una volta nella vita, così da essere perfettamente in grado di seguire la
narrazione.
15
Altabe David, Prezentando una Megilah para Muestros Dyias, unpublished, 1996, p. 2.
296
Davide Aliberti
Il pubblico è dunque obbligato a comprendere il giudeo-spagnolo, una lingua
che nel corso della rappresentazione è sottoposta, così come l’intera opera, a un
processo di modernizzazione a cui prendono parte anche gli spettatori. In una delle scene iniziali, ad esempio, Ester sfila davanti al re che, impressionato dalla sua
bellezza, decide di sposarla immediatamente. Il primo ministro Aman però, intenzionato a presentare sua figlia al re, cerca insistentemente di dissuaderlo dallo sposare Ester. Il re a quel punto, infastidito da tanta insistenza, esclama “No me sekes
mas el kulo”16 (“non rompermi più le scatole”), provocando l’ilarità del pubblico e
la sorpresa degli attori che, interrompendo immediatamente la rappresentazione,
affermano che la parola “kulo” non è presente nel testo originale e che l’attore che
interpreta re Assuero sta improvvisando. Il presidente della compagnia decide
allora di chiedere consiglio al Rabbino, il quale, considerata la reazione positiva del
pubblico, afferma di non avere nulla in contrario all’utilizzo della parola “kulo”. In
questo modo, gli attori dimostrano di utilizzare il testo come qualcosa di vivo,
flessibile e adattabile, modificandolo nel corso della rappresentazione in base alle
reazioni degli spettatori. Un processo di riscrittura che coinvolge dunque anche i
personaggi, risultanti del tutto diversi da quelli descritti nel testo originale: il re, ad
esempio, descritto nel libro di Ester come uomo freddo e distaccato, nella versione
di Altabé è figura molto più sensibile e umana, tanto che nella quarta scena dice a
Ester: “yo me siento tan asolado sin ti...”17 (“mi sento così solo senza di te”). Il parere del pubblico su queste continue modifiche al testo originale, quando non richiesto esplicitamente, è ottenuto con differenti stratagemmi, come quando uno degli
attori si rivolge agli spettatori esclamando con complicità: “aunken no aprese en la
Megilah, me esté gustando”18 (“anche se non c'è nella Megilah, mi sta piacendo”), e
attendendo la loro reazione. In tal modo il pubblico partecipa al processo di modernizzazione dell’opera, lasciandosi catturare dalla lingua e sforzandosi di comprenderla.
A differenza del “Ghetto Theatre” che si concentra sulla nostalgia per la patria
perduta,19 il teatro dei Ladino Players si basa sulla memoria collettiva della diaspora. Per questa ragione, la storia che si decide di mettere in scena è un classico del
Purim, una storia conosciuta da tutti i membri della diaspora ebraica, il cui testo
viene costantemente rielaborato attraverso l’uso del giudeo-spagnolo che, in un
primo momento, crea un effetto straniante sul pubblico, per poi indurlo invece al
ragionamento attivo, al desiderio di comprendere la lingua per poter partecipare
Ivi, p. 11.
Ivi, p. 8.
18 Ibid.
19 Jacqueline Lo e Helen Gilbert, "Towards a Topography of Cross-cultural Praxis”, The Drama Review, 46.3, 2002, pp. 31-53.
16
17
The Ladino Players: dalla narrazione orale alla performance…
297
allo svolgersi degli eventi.20 Come si è visto, gli attori cercano inoltre di favorire la
partecipazione del pubblico non immedesimandosi mai completamente nei personaggi, bensì mantenendosi a una certa distanza per poterne analizzare criticamente
il comportamento e la lingua. L’intero spettacolo diventa così un colloquio aperto
con il pubblico, un dialogo costante che mira a renderlo cosciente e desideroso di
contribuire al recupero della lingua giudeo-spagnola e alla modernizzazione
dell’opera.
Marvin Carlson afferma che i drammaturghi creano le proprie opere in funzione di un contesto specifico:21 luogo e destinatario diventano quindi elementi essenziali nella produzione e ricezione dell’opera. Le comunità diasporiche però avvertono lo spazio in maniera differente a causa del loro continuo processo di dislocazione: ogni specifico luogo diventa così una tappa del viaggio e, allo stesso tempo,
una tappa di un continuo processo di ibridazione culturale, fatto di guadagni e di
perdite. Nella trasposizione scenica di un’opera tradizionale in un contesto diasporico, come nel caso analizzato di Prezentando un Megilah para Muestros Diyas, la
riscrittura e la modernizzazione diventano processi necessari affinché l’opera si
adatti a un’identità che si evolve costantemente nella diaspora. Nel caso dei sefarditi, l’elemento sul quale si poggia l’identità è la lingua, una lingua che si è evoluta
globalmente nel corso della diaspora mescolandosi ad altre lingue, ma rimanendo
sempre la lingua intima delle comunità sefardite. Il giudeo-spagnolo rappresenta
dunque l’identità sefardita, un’identità che nel corso del XX secolo si è affievolita
progressivamente fino quasi a scomparire. I Ladino Players, avvertendo l’urgenza
e la necessità di risvegliare nella memoria culturale dei sefarditi del Lower East
Side le ultime tracce rimaste di quest’identità, rinarrano la storia di Ester con la
collaborazione del pubblico, utilizzando il giudeo-spagnolo come elemento di coesione. Come scrive Diana Taylor: “People participate in the production and reproduction of knowledge by 'being there', being part of the transmission".22 La memoria culturale può di fatto essere riconfigurata attraverso la pratica corporea, attraverso la partecipazione e la collaborazione attiva tra gli attori e il pubblico: ne è
esempio paradigmatico proprio il finale di Prezentando un Megilah para Muestros
Diyas in cui uno degli attori esclama: “Por ke no les demandamos a todas las
mujeres … ke suvan al tabló a prezentarsen al rey”23 (“Perché non chiediamo a
tutte le donne … di salire sul palco e presentarsi al re”), invitando così il pubblico a
prendere parte alla danza tradizionale della corte persiana.
20 Bertold Brecht, Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic,a cura di J. Willett, Eyre Methuen,
London, 1964.
21 Marvin Carlson, Speaking in Tongues: Language at Play in the Theatre, University of Michigan Press,
Ann Arbor, 2006.
22 Diana Taylor, The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas, Duke University Press, London, 2003, p. 20.
23 Altabé, Prezentando una Megilah, cit., p. 10.
298
Davide Aliberti
Conclusioni
La lingua, come afferma Benardete, è la cosa più preziosa che i sefarditi hanno
conservato nel corso della diaspora24 ed essa, per le comunità statunitensi con le
loro numerose micro-identità25 (sefarditi turchi, sefarditi greci, ecc.), può costituire
un elemento di straordinaria coesione. Prezentando una Megilah para Muestros Diyas
si sviluppa infatti attraverso due narrazioni sovrapposte che, grazie all’uso del
giudeo-spagnolo, fondono attori e pubblico, tradizione e modernità. Ciò che spinge i Ladino Players a rinarrare un classico del Purim in giudeo-spagnolo è la necessità di valorizzare una lingua e un’identità sotto minaccia. La compagnia di Altabé
si assume così il compito di educare il pubblico, di renderlo consapevole che utilizzare il giudeo-spagnolo significa riscoprire la propria identità, salvaguardare la
propria specificità linguistica e culturale davanti all’egemonia della cultura dominante. La scelta di utilizzare il teatro come mezzo di trasmissione è data quindi
dall’urgenza di questo compito. L’oralità in questo caso diventa fondamentale
essendo il mezzo di trasmissione di una identità che è linguistica ed è culturale:
essere sefardita significa parlare giudeo-spagnolo. Quella dei Ladino Players è
stata dunque un’esperienza singolare nel panorama teatrale contemporaneo,
un’esperienza incentrata principalmente sull’uso di una lingua in pericolo di estinzione, imposta allo spettatore con il fine di garantirne la sopravvivenza.
24 Mair José Benardete, Hispanic Culture and Character of the Sephardic Jews, Sepher-Hermon Press,
New York, 1982.
25 Ben-Ur, Sephardic Jews in America, cit.
DANIELA ALLOCCA
(R)ESISTENZE SONORE
LA TRADUZIONE DELL’INVISIBILE IN SCHWARZE JUNGFRAUEN E
SCHATTENSTIMMEN DI FERIDUN ZAIMOĞLU E GÜNTER SENKEL
Nel 1995 Feridun Zaimoğlu pubblica Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft.1 La parola canaco veniva usata dai colonizzatori per indicare gli abitanti
autoctoni di Nuova Caledonia, ignari del fatto che canaco significa semplicemente
“uomo”. L'uso dispregiativo di questo termine si ripropone in Germania nei confronti dei turchi tedeschi2 e viene trasformato con Kanak Sprak in un appellativo da
utilizzare con orgoglio. Sia per le tematiche trattate che per la ritmica, questa lingua ha le sue radici nelle sonorità urbane, in particolare nel rap e nell'hip hop:3
“Längst haben sie einen Untergrund-Kodex entwickelt und sprechen einen eigenen
Jargon: die ›Kanak-Sprak‹, eine Art Creol oder Rotwelsch mit geheimen Codes und
Zeichen. Ihr Reden ist dem Free-Style-Sermon im Rap verwandt […]”.4
La lingua canaca è un sotto-codice, una lingua creola, gergo dei vagabondi, un
sermo free-style e la società che parla canaco è composta da rapper, ‘breaker’, transessuali, disoccupati, tossici, rivoluzionari, persone in cerca di asilo politico a cui
viene chiesto “Come si vive da canaco in Germania?”.5 La logica di inversione operata nel testo, per cui essere ‘canachi’ diventa motivo di orgoglio, è la stessa utiliz1
Feridun Zaimoğlu, Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft, Rotbuch Verlag, Hamburg,
1995.
2 “In the original contemporary German context the term Kanake is an ethnic slur form the same
league of racist epithets as 'Bimbo', 'Fidschi' and 'Kümmerl'”: cfr. Feridun Zaimoğlu, “Here Only the
Kanake Has the Say”, in Liesbeth Minnaard (a cura di), New Germans, New Ducht, Literary Interventions,
Amsterdam University Press, Amsterdam, 2008, p. 145.
3 Cfr. Sabine von Dirke, “Hip-Hop Made in Germany. From Old School to Kanaksta Movement”, in
Anges C. Mueller (a cura di), German Pop Culture. How “American” Is It?, University of Michigan, Michigan, 2004, <http://www.press.umich.edu/pdf/0472113844-ch6.pdf> (08/13). L'autrice sostiene che in
Germania si tratti di un movimento con una cifra transnazionale che lo differenzia da quello americano
(pp. 105-106). Si veda anche Julia Abel “Erzählte Identität. Mündlisches Erzählen in der neuerem
Deutsche ‘Migrantenliteratur” in Klaus-Michal Bogdal (a cura di) Der Deutschunterricht. Erzählern. Teorie
und
Praxis,
Friedrich
Verlag
Hannover,
2005,
pp.
20-30,
<http://www.unibamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/split_lehrstuehle/didaktik_deutsch/Daten/Material_BrendelPerpina/Erzaehlen/JuliaAbel-ErzaehlteIdentitaet.PDF>; Reinhard Sauer, “Kanak Sprak”: sprachliche
und soziokulturelle Feridun Zaimoğlu”, in Antonella Gargano e Hans-Georg Grüning (a cura di),
Confini e spazi liminari nella cultura tedesca/Grenzen und Grenzräume in der deutschen Sprache und Literatur,
EUM – Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2008, pp. 219-233; Nicoletta Gagliardi, “Nicht nur
Kanak Sprak: la lingua mista dei giovani tedeschi e i suoi riferimenti massmediatici”, in Maria Voghera
(a cura di), Testi e linguaggi, 2, 2008, pp. 130-148, <http://elea.unisa.it:8080/jspui/handle/10556/565 >
(08/13).
4 Zaimoğlu, Kanak Sprak, cit., p. 13.
5 Ivi, p. 9.
300
Daniela Allocca
zata dagli afroamericani per affermare la forza della differenza.6 Canaco diventa
così un termine-etichetta con cui si identificano anche appartenenti ad altre minoranze presenti in Germania. “Ich türkisch, du jugoslwisch…Wir sind alle Kanake,
wir sind ein Volk, ok?” (“Io turco, tu jugoslavo. siamo tutti canachi, siamo un popolo, ok?”), dice Ertan Ongun, spacciatore di eroina turco-tedesco nel film Kanak Attak (2000),7 tratto da Abschaum (1997),8 secondo romanzo di Zaimoğlu. I canachi
riconoscono una forma di comunità in queste storie, una forma di appartenenza
che nasce proprio dal tessuto sonoro di questa scrittura, si identificano in quella
che ‒ per dirla con Schäfer ‒ chiameremo comunità acustica:9 “Die Wortgewalt des
Kanaken drückt sich aus in einem herausgepreßten, kurzatmigen und hybriden
Gestammel ohne Punkt und Komma, mit willkürlichgesetzten Pausen und improvisierten Wendungen”.10
Questa è la lingua che Zaimoğlu registra e ‘traduce’ nelle sue opere, così anche
per le interviste che compongono Koppfstoff (1998), libro che fa da contraltare femminile alle voci maschili di Kanak Sprak.11 Zaimoğlu parla in modo ironico di ‘protocolli’ da cui poi vengono tratte le sue scritture;12 l'uso della registrazione assume
una forma più consapevole in due opere teatrali, composte da monologhi ricavati
da interviste, entrambe firmate dal collaudato duo Zaimoğlu/Senkel.13
Per Schwarze Jungfrauen/Vergini Nere sono state raccolte 30 interviste a giovani
donne musulmane in Germania, da cui sono stati ricavati 10 monologhi.14 Va in
6 Secondo Maria Stehle ci sarebbe una diversità solo nell'audience in quanto gli afroamericani si
rivolgono agli afromericani stessi mentre Zaimoğlou avrebbe in testa un uditorio tedesco. Maria Stehle,
“Ghettos and Feridun Zaimoglu's Textscapes of the 1990s”, in Id., Ghetto Voices in Contemporary German
Culture. Textscapes, Filmscapes, Soundscapes, Camden House, Rochester - New York, 2012, p. 36.
7 Kanak Attak, regia di Lars Becker, sceneggiatura a cura di Lars Becker e Bernhard Wutka,
Germania, 2000; è anche il nome di un movimento nato nel 1998 <www.kanak-attak.de > (08/13).
8 Feridun Zaimoğlu, Abschaum – Die wahre Geschichte von Ertan Ongun (1997), trad. it. A. Orsi,
Schiuma. Il romanzo della «feccia» turca, Einaudi, Torino, 1999.
9 Murray R. Schäfer, The soundscape. Our sonic environnement and the Tourning of the world, Vermont,
Destiny Book, 1993, trad. it. N. Ala, Il paesaggio sonoro. Un libro di storia, di musica, di ecologia, Lim, Lucca,
1998.
10 “La forza della lingua canaca si esprime attraverso un balbettino ibrido e compresso, a fiato corto,
senza punti né virgole, con pause arbitrarie e svolte improvvise”: cfr. Zaimoğlu, Kanak Sprak, cit., p. 13.
Le traduzioni sono mie ove non indicato altrimenti.
11 Feridun Zaimoğlu, Koppfstoff- Kanaka Sprak am Rande der Gesellschaft, Rotbuch Verlag, Hamburg,
1998.
12 La parola ‘protocolli’ usata tra virgolette dallo stesso autore è ambigua, in quanto vuole affermare
sia l'autenticità del materiale raccolto sia il lavoro di riscrittura. A riguardo si veda: Leslie A. Adelson,
The Turkish Turn in Contemporary German Literature: Toward a New Critical Grammar of Migration, Palgrave
Macmillan, New York - Basingstoke, 2005, in particolare il capitolo “Genocide and Taboo”.
13 Senkel è risaputamente uno dei migliori, se non il miglior amico di Zaimoğlu. A riguardo si veda:
Mein Leben, Bayerische Rundfunk, 28.02.2013 <http://www.youtube.com/watch?v=AR7rER2Ljpg >
(01/14). Il duo ha prodotto inoltre: Othello (2003), Lulù live (2006) Romeo und Julia (2006).
14 Ferdiun Zaimoğlu, Günter Senkel, “Schwarze Jungfrauen”, Theater Heute, 5, Der Theater Verlag
Friedrich, Berlin, 2006.
(r)Esistenze sonore …
301
scena per la prima volta il 17 maggio 2006 per la regia di Neco Çelik15 presso lo
“Hebbel am Ufer” (HAU) a Berlino. La seconda scrittura è Schattenstimmen/Voci
dall’ombra per cui sono stati intervistati immigrati sans-papiers in diverse città europee, e dalle interviste sono stati ricavati nove monologhi.16 La prima di quest'opera
si tiene il 20 aprile del 2008 presso lo “Schauspiel Köln”, mentre qui ci occuperemo
della rappresentazione per la regia di Nurkan Erpulat e la drammaturgia di Karen
Witthuhn, ospitata a novembre dello stesso anno nel Postmigrantisches Theater Festival: Dogland, a cura di Shermin Langhoff, presso il ”Ballhaus Naunystrasse” a Berlino.17
Havelock, riflettendo sull'uso del registratore nel lavoro degli antropologi, sottolinea quanto proprio questa situazione possa influenzare il linguaggio utilizzato,18 mentre Goody la definisce una situazione liminale alla performance in quanto
l'intervistato non è costretto a dettare ma può seguire il flusso della narrazione.19
Il rapporto con l'oralità è strettamente connesso con il materiale di partenza e
con il processo a cui esso è sottoposto. Il documento sonoro in queste opere diventa
il testo di partenza e non una scrittura. In “Theater Heute” (2008), Zaimoğlu spiega
che, una volta raccolto il materiale, indossa le cuffie e riascolta le interviste dettando il tutto a Günter Senkel, che ha il compito di metterlo al computer, dal momento
che Zaimoğlu non possiede un computer; si passa poi a una rielaborazione per
dare musicalità al testo, il tutto a partire dal materiale di cui si dispone, un vero e
proprio montaggio o, meglio, una coreografia che lascia che sia il corpo delle parole, il loro suono ad autorganizzarsi.20 “Wir haben mit unseren Mündern ihre Melo-
15 Neco Çelik, nato nel 1972 a Berlino da genitori turchi immigrati come Gastarbeiter, è educatore e
regista per il cinema e il teatro. Prima di arrivare al cinema faceva parte della scena dei graffiti.
16 Ferdiun Zaimoğlu, Günter Senkel, “Schattenstimmen”, Theater Heute, 7, Der Theater Verlag Friedrich, Berlin, 2008. Alcuni monologhi sono stati tradotti in italiano da Elisa Ricci e richiedibili online nella
sezione “Theaterbiliothek” del “Goethe Institut”. Questo testo, inoltre, è stato oggetto di un progetto
ideato e curato da me e dalla dott.ssa Ricci, a cui si sono aggiunti nella moderazione dei laboratori
Davide Francesca e Francesca Pedullà. Il progetto, dal titolo Performing Translation/ Voci dall’ombra, è
stato promosso dal “Goethe Institut Genua”, sostenuto dal Comune di Genova e ospitato al 16°
“Festival Internazionale della Poesia di Genova”, 2010,
< http://www.lerotte.net/download/article/articolo-156.pdf> (01/14).
17 La curatela di Shermin Langhoff è stata determinante per lo sviluppo di queste produzioni. Cfr.
Artur Pleka, Stefan Tiggesar, ”Migration Dichten und Deuten. Ein Gespräch zwischen Shermin
Langhoff, Tuçay Kulaoğlu und Barbara Kastner im August 2010”, in Id. (a cura di), Das Drama nach dem
Drama. Verwandlungen dramatischer Formen in Deutschland seit 1945, Transcript, Bielefeld, 2011, pp. 399408.
18 Eric A. Havelock, The muse learns to write, Yale University Press, New Haven - London, 1986.
19 Jack Goody, The Interface between the Written and the Oral, Cambridge University Press, Cambridge,
1987.
20 “Si tratta di sentire come il principio del suono organizzi il testo e, al contempo, disorganizzi la
pretesa del linguaggio di controllare tutto il processo della significazione.” Adriana Cavarero, A più
voci. Filosofia dell'espressione vocale, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 147.
302
Daniela Allocca
dien gepfiffen”,21 affermano i due autori con un'espressione che ben rende questo
processo di ‘traduzione’, riorganizzazione del materiale.
In “Theater Heute” (2006) per Vergini Nere si parla di opera semidocumentaria a
suggerire una non autenticità di queste voci.22 Zaimoğlu afferma: “Als Abmachung, galt dass ich ihren Hass, ihre Wut und ihre Lebensbeichten in meine Form
und Kunstsprache übersetzen darf. Die Inhalte habe ich unverändert gelassen”.23
Le interviste vengono 'tradotte' nella lingua artistica, ma il tutto risponde alla
richiesta di queste donne di essere raccontate.24 Raccontandosi danno voce a donne
musulmane radicali che non hanno alcuna crisi di identità, parlano del loro rapporto con il sesso che contempla una idea di verginità non corrispondente alla castità,
come fa notare Katrin Sieg, quanto alla capacità di essere inviolabili.25 La cosa importante, come afferma il regista Neco Çelik, è che quest'opera sia riuscita a far
arrivare in maniera diretta e chiara allo spettatore questo mondo così complicato.26
Una differenza che può essere ravvisata con i primi esempi di teatro documentario
sta nel fatto che le interviste sono un materiale privato che resta anonimo, e non
documenti pubblici; inoltre i monologhi sono numerati e i personaggi al massimo
hanno un appellativo che li identifica. Nel caso di Vergini Nere, i monologhi sono
montati in modo tale che le storie si intreccino tra loro, le attrici hanno tutte un
unico costume che neutralizza la loro identità e supera anche lo stereotipo di genere in quanto appaiono quasi asessuate,27 mentre in opere come Die Ermittlung/ L'istruttoria di Peter Weiss, considerato un modello del teatro documentario, i diciotto
accusati mantengono il nome reale, mentre i nove testimoni sono anonimi. É evidente che è la materia stessa che determina questi cambiamenti. Ricordiamo inoltre
che il titolo completo dell'opera di Weiss è Die Ermittlung. Oratorium im 11 Gesän21 “Abbiamo fischiettato la loro melodia con la nostra bocca”, Zaimoğlu, “Schwarze Jungfrauen”,
cit., p. 47.
22 Il discorso sull’autenticità riguarda il teatro documentario in generale ma è proprio
nell’autonomia della forma artistica rispetto ai documenti che si delinea una differenza con altre forme
teatrali che pure si basano su documenti storici. Cfr. Brian Barton, Das Dokumentartheater, Metzler
Verlag, Stuttgart, 1987.
23 “Come pattuito potevo tradurre il loro odio e la loro rabbia e le loro confessioni (di vita) nella mia
forma, nella mia lingua artistica. Il contenuto l'ho lasciato inalterato”: cfr. Feridun Zaimoğlu in Hülya
Gürler, Gottgefällig, knallhart und sexy- Die Schwarzen Jundfrauen verschonen nichts und niemand,
25.03.2010,
<http://www.migazin.de/2010/03/25/gottgefallig-knallhart-und-sexy-die-schwarzenjungfrauen-verschonen-nichts-und-niemanden/2/> (08/13).
24 Eva Behrendt, “Zumutung gegen Vermutung. Über Feridun Zaimoglus und Günter Senkels semidokumetarische Monloge ‘Schwarze Jungfrauen’ und ihre Urauffürung am Hau Berlin”, Theater
Heute, 5, 2008, p. 41.
25 A tal proposito si veda Katrin Sieg, “Black Virgin: Sexuality and the Democratic Body in Europe”,
New German Critique, 109, 2010, pp. 147-185.
26 Zaimoğlu, “Schwarze Jungfrauen”, cit., p. 44.
27 Per una descrizione più dettagliata della messa in scena si veda: Maha el Hissy, “Heilig, profan,
diffamiert. Zur Konstruktion weiblicher muslimischer Identität in Feridun Zaimoğlu und Günter Senkel”, in Getürkte Türken. Karnevaleske Stilmittel im Theater, Kabarett und Film deutsch-türkischer Künstlerinnen und Künstler, Transcript Verlag, Bielefeld, 2012, pp. 110-144.
(r)Esistenze sonore …
303
gen/L'istruttoria. Oratorio in 11 canti.28 L'intento dell'autore era creare un oratorio
civile avviando processi di memoria comune, da fondare proprio a partire dalla
condivisione orale: ‘enunciare’ e ‘denunciare’ si equivalgono.29 L'idea di comunità
è di fatti collegata a un orizzonte acustico comune. Se in Weiss l'uomo è il prodotto
degli apparati tecnici ‒ scienza, politica, sociologia30 ‒ questi dispositivi agiscono
anche nella creazione delle identità di neomusulmane e migranti illegali, che non si
accordano però alla visione normalizzante ma, come in Kanak Sprak, stonano, sono
voci che escono fuori dal coro.
Mononog drei
Ja und was is'n dabei zu Gott zu finden das ist für mich kein Problem und die andren
Pilzmaden die ich zu Gesicht bekomm die Tetrapackfressen die Arschritzenfressen
die hier rumlaufen was soll ich mir n Kopf machen was die wolln. Illegale Poronohasen sind das die Fraun fackln nicht lange und ficken. Illegale Pornonutte fickt aus
dem Stand sobald die Klappe klack und nach dem Fick ist vor dem Fick das gilt auch
für die bürgherlichen Fraun die machen nur viel Gedönis um nix wollen doch auch
nur Männer auftreiben und dann legen sie sich hin und reißen die Vagina auf und
wenn der Mann fertig is tut er ihr n Gefallen im realen Leben in der Berufswelt.31
La vergine nera numero 3 vomita la sua rabbia contro le occidentali: sia
prostitute che ‘borghesi’ per lei non sono altro che Pornohase /pornoconigliette.
La parlata di queste neomuslmane viene riprodotta nella scrittura attraverso la
grafia per simulare la fluidità e l’irruenza dell'eloquio, trascrivendone elisioni,
sincopi e apocopi. Altri elementi tipici della lingua parlata sono i connettori fàtici,
l'anacoluto e le ellissi, come nel caso del pronome personale che dovrebbe essere
sempre espresso e invece viene a mancare.32 “Ziehe den Kopf ein, schaue nur
28
Peter Weiss, Die Ermittlung. Oratorium im 11 Gesängen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main,
2006.
29 L'Istruttoria venne rappresentata per la prima volta contemporaneamente in quindici teatri il 19
ottobre del 1965.
30 Cfr. Erika Sallock, Peter Weiss' Die Ermittlung. Zur Struktur des Dokumentartheaters, Athenäum Verlag, Frankfurt am Main, 1972.
31 “E allora è così difficile arrivare a Dio per me non è un problema e quegli altri vermi che mi
ritrovo in faccia quei mangia-tetrapack, leccaculi che stanno qua in giro perché mi dovrei preoccupare
di che vogliono loro. Pornoleprotte ecco cosa sono le donne non si fanno scrupoli e fottono e fottono.
Pornoputtana illegale fotte sul posto appena il gioco gira e dopo il fottere è il prima del fottere e questo
vale anche per le borghesi che fanno solo un gran chiasso per niente ma vogliono solo accalappiare
degli uomini e poi si coricano e aprono le gambe e quando l'uomo ha finito lui le fa dei favori nella vita
reale nel mondo del lavoro”. Zaimğlu, Schwarze, cit., p. 3. La traduzione di alcuni monologhi a cura
della dott.ssa Elisa Ricci è richiedibile sul sito del Goethe Institut nella sezione “Theaterbibliothek”, di
cui si è presa visione, ma in parte qui modificata.
32 Già in Kanak Sprak si verificava una simulazione dell'oralità nella scrittura, letta sempre in chiave
di una ripresa degli stili del rap. Cfr. Annette Seck, “Pop is ne fatale Orgie”, in Arnd Beise (a cura di),
Peter Weiss Jahrbuch für Literatur, Kunst und Politik im 20. und 21. Jahrhundert, Röhrig Univesitätsverlag,
St. Ingbert, 2007, pp. 103-118.
304
Daniela Allocca
geradeaus, ziehe weiter und weiter, bis ich aus dem Viertel hinaus bin”33 invece di
“Ich ziehe den Kopf ein, ich schaue nur geradeaus, ich ziehe weiter [...]”. Altro tratto
caratteristico è l'uso di allitterazioni e ripetizioni che creano dei giochi di parole dati
dall'associazione dei suoni. Tutto confluisce in un ritmo della lingua che investe il
lettore come nelle rap slam battles. La ripetizione, la ridondanza fanno parte del
codice rap, ma anche in generale del registro del racconto orale.34 Tracce di oralità
evidenti sono anche l'uso/creazione di appellativi per i personaggi. In Vergini Nere
abbiamo “Pilzmaden/virus”, “Pornohase/porno conigliette”, “Porononutte/porno
puttane”;
“Nasenspraysüchtiger/dipendente
da
spray
da
naso”;
“Nasensprayfreund/amico da spray da naso”; “Nasensprayjunkie/tossico da spray da
naso”; in Voci dall'ombra troviamo “Minuspunk/punk minorato” che diventa
“Minuskmarok/marocchino minorato” o anche “die Schweinischer/sporcaccione”. La
voce del singolo intervistato viene mescolata a quella degli altri e ritessuta dai due
autori andando a creare una polifonia che ben ‘traduce’ l’ibridità di questi
personaggi.
Il processo di produzione di queste scritture è direttamente connesso con il
tema trattato, ovvero l'autenticità negata a questi personaggi. Così anche per
l'opera potremmo chiederci: chi è l'autore, chi compone veramente l'opera? E
questi personaggi quanto sono autentici? L'autenticità delle storie del testo sta
forse proprio in questa restituzione della vocalità. “La vocalità è la storicità di una
voce, il suo uso” afferma Zumthor.35 Il testo scritto rappresenta una fase di queste
storie, uno stato in cui esse si trovano, queste sono storie e suoni che appartengono
alla moltitudine, alla comunità acustica e vengono 'usate' per testimoniare e
condividere proprio i disagi creati da un sistema che ritiene autentico solo ciò che è
documentabile con la scrittura. Dove finiscono i diritti del corpo, i diritti della
voce? In Voci dall'ombra abbiamo una denuncia ancora più esplicita di questo
sistema. Nel primo monologo, un uomo di colore si prostituisce a insaputa della
moglie ed è per questo doppiamente invisibile: prima per il colore della pelle, poi
per l'impossibilità di parlare del suo stato. “Gut, bei ihr sagen die Leute: Ist
Frau./Bei mir sagen die Leute: Ist Schwarz, das reicht.”36 E in seguito, proprio la
persona che lo paga per le sue prestazioni gli dice: “Du bist doppelt angeschissen,
sagt er,/ du bist doppelt Schwarz: einaml die Hautfarbe und dann die Existenz.”37
33 “Infilo la testa (nel cappuccio), guardo solo avanti, vado oltre e oltre, finché non sono fuori dal
quartiere.” Zaimoğlu, Schattenstimmen, cit., p. 4.
34 Cfr. Walter Ong, Oralità e scrittura. La tecnologia della parola, Il Mulino, Bologna, 1986, pp. 68-70.
35 Paul Zumthor, La presenza della voce, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 7.
36 “Di lei le persone dicono: è donna, di me le persone dicono è nero e questo basta”. Zaimoğlu,
“Schattenstimmen”, cit., p. 3.
37 “Sei doppiamente sfigato, dice, sei due volte nero: una volta per il colore della pelle e poi per
l'esistenza”. Ivi, p. 4.
(r)Esistenze sonore …
305
Nel monologo due, troviamo Minusmarok, il lavapiatti, che si sente un fantasma e
viene visto solo come uomo-oggetto:
Ich bin ein Gespenst... /Sieben Tage die Woche bin ich im Einsatz, meine Hände sehen aus als würden sie ein Wasserleiche gehören./Die Perso-Sau denkt: Minusmarok? Das ist n Penishalter. Was heißt das? Das heißt, dass sie in mir nur n Penis sieht,
un der Rest des Körpers ist nur so ne Art Handyhalter, aber eben nicht fürn Handy,
sondern der andere Scheiß völlig egal [...].38
Nel quarto monologo incontriamo una ragazza slava che si prostituisce e anche
questa condizione la porta a un duplice annullamento. Vivere nell'illegalità senza
poter affermare la propria presenza, generando una forma di alienazione dal corpo
come forma di difesa dal vissuto: “Mein Geschäft? Primabett. Fläche. Ich liege auf
der Fläche, ich bin eine Fläche, der Mann liegt auf mir, er ist eine Fläche. Drei
Dimensionen machen mich verrücht, und den anderen Mädchen ergeht es nicht
anders”.39 Solo la bidimensionalità ha spazio in queste vite. Dare voce a queste
storie significa restituire loro una tridimensionalità propria del corpo in tutta la sua
crudeltà. Nel discorso/logos del sistema ritorna l'eterno rimosso: la voce-corpo.
Il regista Nukan Erpulat realizza questa condizione cercando degli attori adatti
fisicamente ai personaggi dei monologhi (l'africano, la donna slava, il marocchino),
ma scambiando le loro storie. Gli spettatori vengono divisi in quattro gruppi e,
camminando attraverso il Ballhaus, incontrano i quattro personaggi che raccontano
storie diverse da quelle che il loro corpo suggerisce. Vernesa Berba recita in una
stanza illuminata dalla sola luce che riesce ad attivare pedalando e racconta la
storia di un pusher africano che cerca di non impazzire in una vita in cui deve
sempre correre. Un attore di colore, Aloysius Itoka, impersona un marocchino,
Minusmarok il lavapiatti, mentre Murat Seven racconta la storia della prostituta
esteuropea in una stanza piena di farfalle vive, lei odia le donne borghesi, mentre
Michael Wenzlaff è l'uomo di colore che si prostituisce a insaputa della moglie in
una stanza-dormitorio completamente buia, dove possiamo ascoltare solo la sua
voce in posizione distesa su dei letti. La disseminazione della voce è una
caratteristica tipica del Postdramatisches Theater teorizzato da Hans Thies Lehmann:
parola e voce diventano spesso soggetto della messa in scena.40 Questa scelta
38 “Sono un fantasma.../sette giorni a settimana sono occupato, le mie mani mi sembrano come se
appartenessero a un cadavere annegato.../ La maiala persiana (così chiama il suo capo) pensa: Minusmarok? É solo un poggiapene. Cosa? Significa che lei in me vede solo un pene e il resto del corpo è
solo come una sorta di poggia cellulare, solo non per un cellulare, ma per l'altra merda, uguale [...]”.
Ibid.
39 “Il mio lavoro: lettomeraviglia. Superficie. Sto sulla superficie, sono una superficie, l'uomo sta su
di me, è una superficie. Tre dimensioni mi fanno impazzire e per le altre ragazze non funziona
diversamente”. Ivi, p. 8.
40 Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main, 1999, p.
276.
306
Daniela Allocca
traduce però forse la condizione stessa dei migranti illegali. Nella vita quotidiana
essi vengono privati proprio della possibilità di essere presenti, di presentarsi, sich
vorstellen in tedesco, che letteralmente significa qualcosa che ha luogo davanti ai
nostri occhi, un verbo che nella sua forma non riflessiva significa immaginare, forse
a suggerire quanto la capacità di rappresentazione sia legata alla presenza e renda
possibile la comunità.41 Questi personaggi sono invece intrappolati in un limbo
indefinito in cui la loro storia non aderisce al corpo, ma risuona improvvisamente
nello spazio come ‘corpo sonoro’; Sparti, che usa questo termine parlando del
rapporto tra oralità e jazz, ricorda che improvviso è una parola che “rimanda a ciò
che non si può vedere (in anticipo), e proprio l'imprevisto rappresenta il tabù
dominante in una cultura videocentrica”.42 Queste voci sono l'imprevisto nel
sistema, l''osceno'.
L'effetto di straniamento dato dalla scelta registica genera un ascolto più
attento: lo spettatore è costretto a prestare la massima attenzione alla voce, il corpo
di questi attori diventa corpo sonoro, medium di storie e la voce riacquista potere.
Parola che incanta è inoltre quella della protagonista del monologo numero nove
che chiude Voci dall'ombra. Si tratta di una zingara che afferma di non saper né
leggere né scrivere, ma usa la voce/parola per ammaliare, bestemmiare, lanciare
ingiurie. È una voce-arma, e per questo lei non parla mai ad alta voce, i verbi che
segnalano il suo eloquio indicano un sussurrare, bisbigliare, forse proprio perché
consapevole della forza della voce usa la voce in modo 'razionale'. Il monologo si
chiude non a caso con un gioco di parole, una formula magica, creata grazie a un
cambio vocalico, cambi di consonanti e permutazioni, formula che viene
pronunciata dalla zingara per attirarsi la buona sorte e la ricchezza: “Geld Gold
Glück. Glück Gold Geld. Gold Geld Glück”.43 Non ci è dato sapere se la formula
abbia funzionato, ma la 'magia' di questi monologhi sta nella restituzione di voce ai
soggetti marginali. Il teatro riesce così a creare spazi di resistenza44 in cui anche
queste storie vengono incluse e partecipano alla creazione di una comunità a
venire.45
41 Benedict Anderson, Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (1983),
Verso, London–New York, 2003.
42 Davide Sparti, Il corpo sonoro. Oralità e scrittura nel Jazz, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 156.
43 “Soldi, oro, fortuna/Fortuna, oro, soldi/oro, soldi, fortuna.” Zaimoğlu, “Schattenstimmen”, cit., p.
19.
44
Pieter Verstraete, “Contested Spaces of Acoustic Community”, Post-Migrant Theatre,
<http://ipc.sabanciuniv.edu/en/wp-content/uploads/2012/10/Pieter-Verstraete-ATMM-Paper-ContestedSpaces.pdf >(09/13).
45 Giorgio Agamben, La comunità che viene, Bollati Boringhieri, Torino, 2001.
RAFFAELLA DI TIZIO
LAVORAVO ALL’OMSA:
DALLA CRONACA AL TEATRO, PENSANDO A BRECHT
Una delle domande alla base di questo convegno è perché una storia sia rinarrata attraverso il teatro. Vorrei portare l'esempio di un recente spettacolo del
“Teatro Due Mondi”, ben sapendo che quello che rischia di sfuggire ad una ricostruzione critica è precisamente l'essenza, la forza misteriosa di un evento scenico.
Lavoravo all'Omsa1 ha debuttato il 3 maggio 2013, come parte del progetto “Teatro e Comunità” curato da Cristina Valenti e Giada Russo, presso il centro “La Soffitta” del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. In scena ci sono cinque attori con completi rossi, camicie bianche e cravatte nere: sono i licenziati della
fabbrica “Omsa” di Faenza, ma a tratti diventano parte di un altro mondo: sono gli
operai di Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht che lamentano le loro condizioni, sono Mauler l'industriale e Giovanna l'idealista che predica la mansuetudine,
ma alla fine reciterà salmodiando la necessità della lotta. Con loro c'è Angela Cavalli, operaia: racconta la storia di un lavoro perso non per via della crisi, ma per
una scelta di strategia aziendale; mostra i gesti che faceva ogni giorno per produrre
calze; spiega come l'apertura dello stabilimento, negli anni trenta del Novecento,
avesse significato l'emancipazione per molte donne della sua città e ripercorre le
tappe della battaglia (persa) contro la delocalizzazione.
“Così finisce la storia: nel silenzio, che è il grande sacco dove finiscono tutte le
storie” ‒ dice l'attore Renato Valmori dopo aver abbandonato il ruolo di Mauler ‒
“Ecco perché ne parliamo. Ecco perché parliamo. Perché non sparisca nel sacco”.
In piedi di fronte al pubblico, attori e operaia si uniscono in un inno: “quando
tutto ti sembra perduto” ‒ cantano ‒ “leva in alto la voce e la rabbia”.
Circostanze
Introducendo un volume sulla Santa Giovanna dei Macelli di Strehler (del 1970),
Arturo Lazzari sottolineava “quel molto di occasionale e di condizionato che ogni
scelta nel lavoro teatrale comporta”:2 pur nella coerenza dei percorsi e delle ricerche, alle origini di uno spettacolo c'è spesso un incontro che avviene nelle giuste
circostanze e tra le giuste persone. Per il Teatro Due Mondi, nato a Faenza nel 1979,
1 Con Monica Camporesi, Angela Cavalli, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Andrea
Valdinocci, Renato Valmori; regia di Alberto Grilli; drammaturgia di Gigi Bertoni; musiche originali e
direzione musicale di Antonella Talamonti.
2 Arturo Lazzari (a cura di), Giorgio Strehler. Santa Giovanna dei Macelli di Brecht, Bertani Editore,
Verona, 1974, p. 9.
308
Raffaella Di Tizio
si è trattato innanzitutto di ascoltare quello che stava oggi accadendo nella propria
città: nel 2010 davanti alla storica fabbrica “Omsa” stazionava un picchetto permanente di operai, in protesta per un licenziamento avvenuto via fax e per la scelta
della “Golden Lady Spa” di delocalizzare in Serbia le sedi di produzione.
In un momento in cui la lotta perdeva di forza e di visibilità, una ventina di
operaie legate alla Cgil, insieme ad attori e volontari, ha risposto all'invito del
gruppo teatrale e preso parte ad una settimana di laboratorio sul tema del diritto al
lavoro.3 Guidavano il seminario Hervée de Lafond e Jacques Livchine del “Théâtre
de l'Unité”, che dagli anni Sessanta organizzano azioni di strada – le “Brigate d'intervento teatrale” ‒ dove i protagonisti non sono attori ma persone accomunate da
una stessa urgenza di comunicazione.4 Le “Brigate Teatrali Omsa” dovevano “rendere visibili le operaie in modo scanzonato, poetico, per nulla sindacale o politico”:5 erano fatte di azioni semplici, pensate per coinvolgere più persone possibili;
condotte poi dal regista del Teatro Due Mondi Alberto Grilli, hanno invaso le strade di molte città, servendo di sostegno alla lotta operaia.6
Lavoravo all'Omsa è in parte una prosecuzione di questo percorso, ma la sua è
anche un'altra storia, con radici più lontane. Nel 2005 il Teatro Due Mondi aveva
messo in scena Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht.7 Alcune recensioni definivano allora il testo come “sicuramente datato”,8 altre continuavano a vedervi
piuttosto una “sconcertante e quasi profetica attualità”.9 Fatto è che nella Heilige
Johanna der Schlachthöfe, scritto a ridosso del crollo di Wall Street del 1929, Brecht
prendeva in esame “un nodo di problemi concretamente vivo e drammatico, ben
presente alla coscienza del pubblico o del lettore”.10 Nel dramma si parla del 'Sistema' economico che aveva portato alla crisi “con parole chiare ed esplicite, con
3 “Al lavoro! Il teatro, la musica e altre azioni a sostegno di un diritto”, Faenza, 12-19 settembre
2010. Cfr. Alberto Grilli, “Il teatro di ogni giorno. Lettera per l'apertura di una Casa del Teatro”, Teatro e
Storia, 33, 2012.
4 “La brigade d'intervention théâtrale ou B.I.T. pratique un théâtre d'intervention et se fait fort
d'inventer sur n'importe quel sujet une courte forme en quelques jours ou en quelques heures si une
urgence se présente”. Da <http://www.theatredelunite.com/> (01/14).
5 Sono parole di Hervée de Lafond tratte dal documentario di Lisa Tormena Licenziata!, Sunset,
Faenza, 2011.
6 Oggi 120 delle operaie licenziate lavorano nello stabilimento riconvertito a divanificio, vittoria non
estranea alla visibilità ottenuta tramite le azioni teatrali. Cfr. Giada Russo, “Brigate Teatrali Omsa. Il
teatro come informazione, memoria, lotta”, Ateatro, 139, 14 maggio 2012.
7 Regia Alberto Grilli, con Beatrice Cevolani, Stefano Grandi, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria
Regosa, Delia Trice, Renato Valmori; musicista in scena Alessandro Valentini; scene, costumi e oggetti
di scena Maria Donata Papadia; musiche originali e direzione musicale di Antonella Talamonti; luci di
Marcello D'Agostino, riduzione e adattamento del testo di Gigi Bertoni; produzione ERT Emilia
Romagna Teatro Fondazione – Teatro Due Mondi.
8 Massimo Marino parla su L'Unità del 2 febbraio 2005 di “un lavoro dal fortissimo taglio politico,
sicuramente datato, che il Teatro Due Mondi rende coinvolgente ed attuale”.
9 Sandro Bassi, “Brividi ai Due Mondi”, Sette sere, 3 dicembre 2005.
10 Paolo Chiarini, Bertolt Brecht, Laterza, Bari, 1967, p. 218.
Lavoravo all’Omsa: dalla cronaca al teatro, pensando a Brecht
309
una favola illuminante che è la trasposizione drammatico-poetica di un capitolo
dell'economia politica marxista, il capitolo sulle crisi cicliche”.11 Com'è noto, la
messa in luce dei meccanismi economici avviene attraverso il percorso di Giovanna
Dark, attivista dell'Esercito della Salvezza, che fallisce nel suo tentativo di mediare
tra industriali della carne e operai. Passata dalla parte dei lavoratori, per non aver
consegnato una lettera che le è stata affidata Giovanna contribuisce al fallimento di
uno sciopero generale e alla riconquista dell'ordine. In punto di morte afferma che
“solo la violenza può servire dove regna la violenza, e solo uomini, dove ci sono
uomini, possono dare aiuto”,12 ma le sue ultime parole sono soffocate dagli inni
della sua ex organizzazione religiosa, che la santifica come “combattente e martire”.13
Santa Giovanna dei Macelli del Teatro Due Mondi era un allestimento ricco per
scenografia e costumi, come per partiture vocali e fisiche. Era uno spettacolo dal
ritmo serrato, che comunicava anche tramite i contrasti dei colori (luci virate sul
rosso, e il rosso dei grembiuli e dei guanti spessi degli operai, il nero dell'Esercito
della Salvezza, il bianco dei capitalisti), dei canti (ispirati o tratti dalla tradizione
religiosa o da quella di lotta operaia) e degli atteggiamenti fisici (operai sempre
piegati verso il terreno, industriali dalle schiene dritte e dagli alti cilindri). Gli spettatori, seduti sui due lati lunghi dello spazio, alla fine venivano fatti spostare per
assistere in file ordinate alla canonizzazione di Giovanna, innalzata accanto al magnate della carne in scatola Pierpont Mauler. All'interno di questo mondo grottesco, titoli di giornale contemporanei ingigantiti sulla scenografia, o gridati nel corso della rappresentazione, servivano a non far dimenticare contesto e luogo presente: l'Italia del crack “Parmalat”, l'Italia che scivolava verso la crisi, e un mondo
sempre pieno di contrasti economici.14
Nel 2012, dopo l'esperienza delle Brigate Teatrali, è nata l'idea di far rivivere
questo spettacolo attraverso l'incontro con una tematica presente e specifica. Il
risultato non è più una parabola generale che sveli i meccanismi dell'economia: lo
sguardo è concentrato su una singola storia, il racconto di uno specifico punto di
vista. Brecht, con un occhio ai drammi di Shaw, prendeva la Pulzella d'Orléans di
Schiller per portarla nel suo tempo, quello della crisi di Wall Street del 1929. Il Teatro Due Mondi riprende la propria Giovanna Dark per portarla in un nuovo presente, per farle ascoltare la storia di altri operai: non più come sottotenente dell'Esercito della Salvezza, ma come attivista di un moderno sindacato.
Lazzari, Giorgio Strehler. Santa Giovanna.., cit., pp. 10-11.
Bertolt Brecht, Santa Giovanna dei macelli, Einaudi, Torino, 1963, p. 121.
13 Ibid.
14 Per un'analisi di questo spettacolo cfr. Cristina Valenti, “Santa Giovanna dei macelli. L'opera
brechtiana ripresa e realizzata dal Teatro Due Mondi di Faenza”, A. Rivista Anarchica, 37.326, 2007.
11
12
310
Raffaella Di Tizio
Un preciso punto di vista
SLIFT L'essenziale è questo: da che parte è lei, caro signore? Al di qua o al di là della
barricata?
SNYDER I Cappelli Neri sono al di sopra della mischia, signor Slift. E dunque, al di
qua.15
Lo spettatore di Lavoravo all'Omsa non si trova immerso in un'atmosfera cupa e
densa, ma siede in una sala perfettamente illuminata, priva di scenografia, di fronte ad attori che indossano le divise rosse delle Brigate teatrali. I titoli di giornale
non sono più uno sfondo ma hanno preso il centro della scena: davanti a noi c'è l'ex
operaia Omsa Angela Cavalli, interprete di se stessa. È la sua voce, l'unica sostenuta da un microfono, a raccontarci la storia della chiusura dello stabilimento industriale faentino. È il suo punto di vista ad essere messo in scena.
Scrive in proposito Gigi Bertoni, drammaturgo del Teatro Due Mondi:
Per me che scrivo è indispensabile individuare un punto di vista dal quale far correre
il racconto. E ho scelto il punto di vista collettivo dell'operaio. E per essere più precisi, delle operaie che mi hanno aiutato a scrivere il testo. E di molte delle loro compagne che con loro hanno vissuto la lotta contro la chiusura dell'Omsa.16
Nello spettacolo si parla quindi di come gli operai abbiano vissuto i mesi di protesta, di cosa volesse dire nelle loro vite il lavoro in fabbrica, del modo in cui l'accordo tra sindacati, azienda e ministero è stato siglato. Si racconta anche delle Brigate teatrali, di cui in più punti vengono ripetute azioni e parole. Lo sguardo scelto
è “frutto di un percorso in cui si sono seguite ansie paure delusioni di chi partecipava a una lotta che si sapeva persa in partenza, e i loro problemi quotidiani, le
loro motivazioni”.17 Per questo la complessa struttura di Santa Giovanna dei macelli
non può restare in primo piano, ma solo apparire a tratti per scompaginare, dare
spessore e riflessi inattesi alla vicenda dell'Omsa.
Nello spettacolo del 2005 Cristina Valenti vedeva la capacità di trovare “i corrispettivi del teatro brechtiano e delle sue intenzioni negli esiti e nelle modalità del
lavoro pluridecennale” dei Due Mondi “sulla scrittura scenica, la drammaturgia
attorica, il canto e i parlati intonati”;18 in Lavoravo all'Omsa, dove le parole di Brecht
non sono al primo posto, la vicinanza alle sue intenzioni è però forse ancora più
chiaramente visibile. Mi riferisco a quanto si legge nel suo Breviario di estetica teatrale (1948), dove si sostiene che la scelta di una posizione “al di fuori del teatro” è
Brecht, Santa Giovanna, cit., p. 62.
Gigi Bertoni, I Cappelli Neri e il sindacato, <http://www.teatroduemondi.it/it/lavoravo
%20all'omsa/indexitlavoravo.html> (16/01). Al testo hanno collaborato Anna Benericetti e Angela
Cavalli.
17 Conversazione con Gigi Bertoni, Faenza, 17 settembre 2013.
18 Valenti, Santa Giovanna dei macelli, cit.
15
16
Lavoravo all’Omsa: dalla cronaca al teatro, pensando a Brecht
311
“un elemento precipuo dell'arte drammatica”, partendo dal principio che “Per
l'arte (...) essere ‘apartitica’ non significa altro che essere ‘del partito dominante’”.19
Il Teatro Due Mondi ha incontrato Brecht nel corso di una ricerca teatrale che ha
scelto di porre la sua ragion d'essere al di fuori della scena, e che in scena vuole
“servire ad una presa di coscienza” e non fare mistero del proprio “sguardo sulla
vita”.20 È facile quindi vedere nel suo lavoro qualcosa che ricordi la definizione del
teatro epico (del 1931), forma in cui le sensazioni “vengono spinte fino alla consapevolezza” e lo spettatore “viene posto di fronte a qualcosa” e costretto “a decisioni, a una visione generale”.21
Il voler raccontare nel modo più chiaro possibile la storia dell'Omsa ha quindi
condizionato la scelta dei frammenti di Santa Giovanna, modificati in parte per l'inserimento nel nuovo contesto (ma spesso senza dover cambiar molto perché le
parole di Brecht potessero riferirsi al presente).22 Giovanna, approdata dalla crisi
del 1929 a quella contemporanea, tenta ancora una volta senza successo di mediare
tra le parti in lotta. Il suo percorso di conoscenza non si può però più definire un
viaggio “verso gli abissi”:23 gli operai che incontra non appaiono grottescamente
deformati da fame e sfruttamento, e Pierpont Mauler (l'unico degli industriali brechtiani a restare, se si esclude una breve apparizione di Slift) sembra aver perso la
sua faccia sanguinaria.24 Non rappresenta più tanto l'aspetto cinico del capitalismo,
con i suoi – veri o simulati ‒ rimorsi di coscienza, quanto un imprenditore moderno, un generico membro di categoria così come può venir visto da una certa prospettiva: quella di chi subisce scelte altrui senza aver voce in capitolo.
La concretizzazione fisica delle differenze tra operai e padroni è dunque scomparsa: i primi sono ricondotti ad una fisicità animalesca solo in un breve momento,
Bertolt Brecht, Scritti teatrali, Einaudi, Torino, 2001, p. 137.
Conversazione con Alberto Grilli, Faenza, 17 settembre 2013. Di Brecht come direzione aperta di
ricerca parlano i saggi di Paolo Chiarini e Massimo Castri in Adelio Ferrero (a cura di), Brecht oggi,
Longanesi, Milano, 1977.
21 Bertolt Brecht, “Il teatro moderno è il teatro epico”, in Scritti teatrali, cit., p. 30.
22 Si va dagli accenni alla crisi moderna (qui in corsivo) inseriti nelle battute di Brecht, come quando
Giovanna afferma: “E io che pensavo: se aiuto i padroni avrò aiutato anche gli operai. Se si salvano le
banche, queste sosterranno lo sviluppo, la produzione sul territorio. Com'ero sciocca: è chiaro che chi vuole
aiutare i poveri deve aiutarli a difendersi da voi” (Brecht, Santa Giovanna, cit., p. 64), alla semplice
sostituzione della parola “carne” con “calze”, per passare dal racconto dei mercati di Chicago di Brecht
a quello della delocalizzazione dell'Omsa.
23 Brecht, Santa Giovanna, cit., pp. 32 e 74.
24 Nella Jungfrau von Orléans di Schiller, seguendo la tradizione secondo cui “Giovanna, che è alla
ricerca del re, lo riconosce subito benché i suoi cortigiani la mettano alla prova cercando d'ingannarla
sulla sua identità” (Frederic Ewen, Bertolt Brecht. La vita, l'opera, i tempi, Feltrinelli, Milano, 2005, pp. 228229), re Carlo viene riconosciuto per virtù divina (“Tu non hai mai visto il mio volto prima d'ora. Come
fai a sapere chi sono?” chiede il re a Giovanna, che risponde: “Io ti vidi dove Dio solamente può
vedere”). In maniera più prosaica, la Giovanna Dark di Brecht individua l'industriale Mauler per
l'aspetto del suo volto: “Giovanna: (va verso Mauler) Lei è Mauler! / Mauler: Non sono io. / (...)
Giovanna: Sì, è lei. / Mauler: Come mai mi conosci? / Giovanna: Perché sei quello che ha la faccia più
sanguinaria”. Ibid.
19
20
312
Raffaella Di Tizio
quando mimano di bere, come neonati che succhiano il latte, le raccomandazioni
alla mansuetudine dei Cappelli Neri. E questi ultimi non si presentano più come “i
soldati del Signore”,25 ma come un sindacato che vuole riportare tra i lavoratori,
prima della religione, “l'ordine” e “l'ubbidienza”.26
Alla fine dello spettacolo, dopo il suo monologo Giovanna non viene innalzata
come santa, ma va a sdraiarsi in terra insieme alle operaie, ripetendo l'azione delle
Brigate che vedeva tutti i partecipanti stendersi in una lunga fila, in piazza o per
strada, in silenzio. Le sue ultime parole ‒ dove si parla di “lotta” e non di “violenza”, com'era in Brecht, ad evitare fraintendimenti in uno spettacolo che vuol parlare in modo aperto e diretto ‒ non vengono coperte dagli inni religiosi dei Cappelli
Neri.
È stato scritto che Lavoravo all'Omsa “è vero stile Agit-Prop, a metà tra teatro e
propaganda politica”:27 il richiamo è agli anni '70, quando il teatro d'impegno sociale godeva di più vasto consenso. Diversamente da allora, l'accostamento tra
fabbriche e teatro oggi è tutt'altro che scontato, e insieme alla scelta di mostrare
senza maschere la propria motivazione etica, in uno spettacolo ricco di canti popolari e di lotta, contribuisce a dare la sensazione che vi sia tra spettatori e scena una
sorta di anacronismo, nonostante si stia parlando di un preciso momento del contemporaneo.
Lavoravo all'Omsa ha un impatto scenico estremamente semplice: pensato per
essere una sorta di recital, non ha disegno luci né scenografia. Oltre al microfono,
gli oggetti sono solo cinque barili rossi: arrivano da Santa Giovanna, dove erano i
barili di carne in scatola delle fabbriche di Mauler e Cridle. I costumi vengono dalle
Brigate Teatrali, le partiture fisiche e le parole da entrambi gli spettacoli. Ma mentre nelle Brigate e in Santa Giovanna il pubblico circondava la scena, itinerante per le
strade o in sala, qui tutto si svolge frontalmente e sempre chi parla è rivolto agli
spettatori. L'idea alla base del lavoro era infatti quella di comporre “un oratorio dal
movimento controllato”:28 anche se ciò che resta delle partiture fisiche perdendo in
dilatazione acquista in potenza, rifiutando di restare semplicemente di sfondo, il
significato è affidato soprattutto alle parole e ai canti. Questi sono frutto di un altro
Brecht, Santa Giovanna, cit., p. 17.
Il monologo con cui Giovanna si presenta in scena, “alla testa di una squadra d'assalto di Cappelli
Neri”, in Brecht comincia così: “In tetri tempi di sanguinoso smarrimento, / ordinato disordine, /
pianificato arbitrio, / disumana umanità, / quando non vogliono più cessare, nelle nostre città, le
agitazioni; / in un mondo che è simile a un macello, / spinti da voci di minacciose violenze, / perché la
rude violenza del popolo miope non / spezzi le sue stesse macchine, non / calpesti il suo propri pane, /
vogliamo qui riportare / Iddio” (Ivi, scena II, pp. 15 e 16). Nello spettacolo del Teatro Due Mondi
Giovanna, accompagnata da altre due donne del sindacato, conclude lo stesso brano affermando:
“vogliamo qui riportare l'ordine, l'ubbidienza e Dio”, e spiega agli operai ai quali sta distribuendo del
cibo: “Ci teniamo molto ad avere la vostra approvazione, il vostro ‘sì’ incondizionato”.
27 Agnese Doria, “Contro l'indifferenza usando il teatro: tornano le lavoratrici dell'Omsa”, L'Unità,
Bologna, 1 maggio 2013.
28 Conversazione con Gigi Bertoni, cit.
25
26
Lavoravo all’Omsa: dalla cronaca al teatro, pensando a Brecht
313
incontro del Teatro Due Mondi, quello avvenuto nel 2001 con la cantante e musicista della “Scuola di canto popolare” del Testaccio Antonella Talamonti (allieva e
poi collaboratrice di Giovanna Marini). È lei a curare il lavoro vocale del gruppo,
iniziato con gli spettacoli di strada, confluito in Santa Giovanna e vero protagonista
di Lavoravo all'Omsa. Qui le voci degli attori riempiono la scena dall'inizio alla fine,
a volte invadendo interamente lo spazio, a volte sostenendo e accompagnando i
toni più semplici utilizzati da Angela Cavalli.
Le Brigate Teatrali e Santa Giovanna si traducono nei diversi modi di narrare presenti in Lavoravo all'Omsa, dove si incontrano il linguaggio dei personaggi brechtiani e le parole quotidiane (in una scena anche il dialetto romagnolo) scelte per
raccontare la storia della fabbrica faentina. Eppure questa compresenza di due
mondi lontani non mina la forza dello spettacolo, creando piuttosto una differenza
di potenziale che ne arricchisce senso e complessità.
Se a raccontare sono 'non-attori'
La storia delle operaie della fabbrica Omsa di Faenza si è tradotta prima nelle
Brigate Teatrali, poi in un racconto in forma di favola portato nelle case dalle stesse
protagoniste, all'interno di una versione speciale dello spettacolo Amnesie di Stefano Vercelli (2011).29 Lavoravo all'Omsa è l'ultimo frutto di questo percorso. Qui si
alternano il racconto piano e semplice di Angela Cavalli e i canti, i dialoghi, i recitativi, le parole scandite e ritmiche degli attori; ci sono due diversi livelli di formalizzazione, due registri linguistici e due modi di narrare, ma entrambi raggiungono
il pubblico con la stessa forza.
Eppure in scena abbiamo una storia di cronaca, e una testimone di se stessa, insieme a un gruppo di attori affiatato che ha costruito il suo artigianato teatrale con
oltre trent'anni di lavoro comune. Cosa permette di funzionare a questo insieme di
attori e 'non-attori'?
Il regista dei Due Mondi, Alberto Grilli, ha risposto spiegando che
Tutte le tecniche che studiamo e pratichiamo come gruppo servono a raggiungere
uno scopo: la presenza scenica.
Gli attori studiano e si formano per arrivare a questo obiettivo.
Su cosa possono contare i non-attori per essere ‘presenti scenicamente’?
Sulla voglia di esserci, sulla motivazione profonda che li ha portati, spesso per caso, a
incontrare il teatro. Questo è quello che hanno in comune: la profondità della motivazione e il fatto che il loro obiettivo non è essere attore.
Sono qui … per rivendicare il diritto di testimoniare un pensiero, o un'emozione. O la
mia vita.
29
Cfr. <http://www.teatroduemondi.it/omsa.html> (25/01).
314
Raffaella Di Tizio
Questa motivazione profonda, questo atto di testimonianza in prima persona, dona
presenza scenica. Crea le condizioni perché affiori la verità della vita pur nella finzione.30
Così i non-attori finiscono per funzionare in scena quanto gli attori esperti, che
per arrivare al loro livello di verità hanno fatto un percorso di assimilazione e superamento della tecnica. Sono l'urgenza di narrare, il bisogno di testimoniare, a
rendere viva la loro presenza.
Anche prima di queste iniziative, che hanno contribuito a tenere viva l'attenzione sul caso della fabbrica faentina, la vertenza operaia ha avuto una sua visibilità.
Eppure oggi Angela Cavalli racconta di aver trovato soltanto nel teatro la possibilità di raccontare davvero la propria storia, di dire quello che per lei era indispensabile dire. Racconti che a prima vista danno la sensazione di essere meno mediati,
come quello televisivo, finivano col distorcere dettagli dell'esperienza senza metterne a fuoco il punto centrale, quello che per lei scottava. Di fronte a una battaglia
persa, davanti ad una vertenza in cui “nessuno ha ascoltato gli operai”, il teatro è
stato il modo più concreto di “esprimere il dissenso”, di dare forma alla “necessità
di esprimere il proprio punto di vista”.31
C'è una netta differenza tra l'essere visibile e narrare, tra essere oggetto o soggetto di una dinamica comunicativa. La televisione espone, il teatro può proteggere, costruendo il suo discorso con la necessaria lentezza, contraddicendo il tempo
rapido della cronaca. Per il Teatro Due Mondi lavorare con non-attori si è tradotto
nella possibilità di trovare un nuovo senso alla necessaria “relazione tra il teatro e
la vita”.32 Per Angela Cavalli continuare a recitare in Lavoravo all'Omsa è soprattutto un modo concreto “di portare avanti la vertenza”,33 di non lasciare che ogni cosa
“sparisca nel sacco” del silenzio.
L'apparente semplicità di Lavoravo all'Omsa lascia spazio al pensiero: gli spettatori non possono non scegliere a loro volta una posizione di fronte agli eventi narrati; il canto che alla fine ascoltano è un inno che li invita a non rinunciare ad immaginare altre migliori conclusioni possibili.
Grilli, “Il teatro di ogni giorno”, cit., p. 27.
Conversazione con Angela Cavalli, Faenza, 19 settembre 2013.
32 Conversazione con Alberto Grilli, Faenza, 17 settembre 2013.
33 Conversazione con Angela Cavalli, cit.
30
31
INDICE DEGLI AUTORI
Angela Albanese (Università di Modena e Reggio Emilia)
Davide Aliberti (Università di Napoli “L’Orientale”)
Daniela Allocca (Università di Napoli “L’Orientale”)
Maria Arpaia (Università di Napoli “L’Orientale”)
Maia Giacobbe Borelli (Università di Roma “La Sapienza”)
Chiara Maria Buglioni (Università di Milano)
Vera Cantoni (Università di Pavia)
Alessandro Cimino (Università di Napoli “L’Orientale”)
Enza Dammiano (Università di Napoli “L’Orientale”)
Stefano De Matteis (Università di Salerno)
Silvia De Min (Università di Venezia “Ca’ Foscari”)
Raffaella Di Tizio (Università dell’Aquila)
Vincenza Di Vita (Università di Messina)
Anna Livia Frassetto (Università di Sassari)
Massimo Fusillo (Università dell’Aquila)
Maddalena Giovannelli (Università di Milano)
Gerardo Guccini (Università di Bologna)
Dario Migliardi (Università di Napoli “Federico II”)
Dora Rusciano (Università Roma Tre)
Carla Russo (Università di Napoli “L’Orientale”)
Fatima Sai (Università di Napoli “L’Orientale”)
Gabriella Sgambati (Università di Napoli “L’Orientale”)
Irene Starace (Università di Granada)
Luigia Tessitore (Università di Napoli “L’Orientale”)
Gabriele Vacis
Anna Vinciguerra (Università di Napoli “L’Orientale”)
Antonella Zapparrata (Università di Napoli “L’Orientale”)
Maria Cristina Zerbino (Università di Roma “La Sapienza”)
308
Raffaella Di Tizio