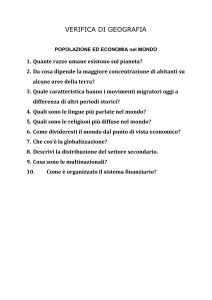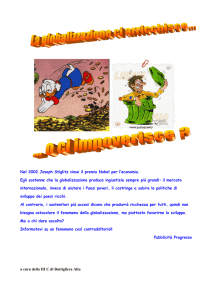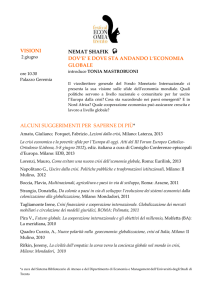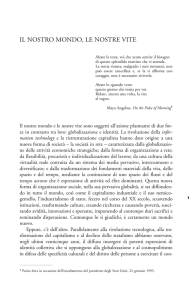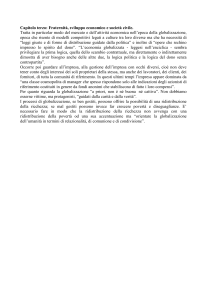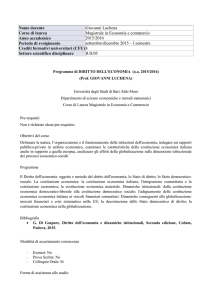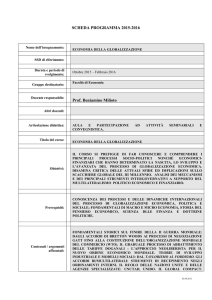APPUNTI SULLA GLOBALIZZAZIONE
LE N
per le aziende
Il mercato diventa mondiale, la forza lavoro multiculturale, i clienti appartengono a paesi diversi, i luoghi di produzione si spargono per l’intero pianeta
Romano Trabucchi
el maggio scorso il termine
“globalizzazione” ha compiuto vent’anni. È stato coniato
nel 1983 da Theodore Levitt,
teorico e docente di marketing della Harvard Business School. Con i suoi articoli
e libri, Levitt sostenne, allora, che era
giunto per le imprese il momento di imporre al mondo intero gli stessi consumi,
utilizzando le nuove tecnologie della comunicazione per pubblicizzare i loro
prodotti o servizi e per organizzarne la
produzione. Quando il “villaggio” diventa “globale”, affermava, riecheggiando
Marshall McLuhan, anche produzione e
consumi devono diventare “globali”, con
il grande vantaggio per le imprese di realizzare immense economie di scala e giganteschi profitti.
La globalizzazione crea, dunque, alle imprese nuove sfide: il mercato diventa mondiale, la forza lavoro diviene multiculturale, i clienti appartengono a paesi diversi, i
luoghi di produzione si spargono per l’in-
il giornale del dirigente
N
6
6
Romano Trabucchi, dopo aver operato, come dirigente, in due grandi imprese dei settori terziario e della comunicazione (con responsabilità nell’area risorse umane), ha diretto la
Casa Editrice Etas Libri. È stato partner fondatore di due aziende di consulenza (Micom e Isso) e consigliere di amministrazione della multinazionale della consulenza Watson Wyatt Isso. È stato docente di “gestione del personale” presso la Scuola di direzione aziendale
(SDA) dell’Università Bocconi. È autore di pubblicazioni di management e presso l’editore
Franco Angeli dirige una Collana di management. Collabora a periodici e riviste. È membro del comitato scientifico del Cfmt.
tero pianeta. La funzione marketing si potenzia e si specializza verso l’estero. Per citare un solo dato: nel 1965 meno del 4%
delle posizioni di lavoro delle imprese
americane era legato al commercio estero
e alle esportazioni, mentre nel 2000 quella percentuale era salita al 25%1.
La “piazza” del mercato diventa il mondo.
È possibile produrre o fornire servizi dappertutto e in contemporanea. Un prodotto come un film, tipica espressione del
nuovo capitalismo culturale (Rifkin), viene contemporaneamente lanciato in tutto
il mondo. “Il Re Leone della Walt Disney,
un film di grandissimo successo, uscì contemporaneamente in 500 paesi. Quasi 200
articoli ispirati al film sono stati creati su
licenza e commercializzati, per capitalizzare sull’immagine del Re Leone. Un anno dopo l’uscita del film, ne venne presentata la versione teatrale a Broadway.
All’uscita del teatro, gli spettatori dovevano passare attraverso un negozio, allestito nel foyer, in cui si vendevano i gadget
del Re Leone”2.Per non parlare del gigantesco battage pubblicitario per l’ultimo libro di Harry Potter, per il quale le librerie
di tutto il mondo, da Londra a Hong
Kong, da Johannesburg all’Australia, sono state aperte anche di notte e dove le stazioni ferroviarie di alcuni paesi hanno ricreato il treno a vapore di cui si parla nel
racconto. E se è facilmente comprensibile che questo avvenga per film e programmi di intrattenimento, in realtà avviene anche per il lancio a livello mondiale di ogni genere di prodotti.
La concorrenza si inasprisce: diventa ipercompetizione. Sfida di tutti contro tutti.
1
2
H. C. Weizmann, J. K. Weizmann, Gestione delle risorse
umane e valore dell’impresa, Franco Angeli, Milano,
2001, pag. 37
R. Normann, Ridisegnare l’impresa, Etas, Milano, pag. 89
UOVE SFIDE
Non solo, si allarga l’arena competitiva che
non è più limitata da confini geografici, si
accorcia anche l’orizzonte temporale della strategia e delle operazioni aziendali.
Per le imprese aumentano l’esigenza di
muoversi liberamente per cogliere le opportunità economiche (flessibilità) e il bisogno di ridurre i costi, spesso con licenziamenti di massa che accrescono il valore delle loro azioni. Imprese e dirigenti so-
no sempre più condizionati dalle valutazioni dei mercati e degli intermediari finanziari globali. La competitività fra le imprese diventa il comandamento supremo
cui tutto deve essere subordinato.
La struttura dell’intera organizzazione
aziendale viene ripensata. Come abbiamo indicato nel primo articolo (vedi n.
1-2/2003), le imprese tendono a farsi leggere. Di fronte al turbolento orizzonte
globale hanno bisogno di “leggerezza” e
di grande rapidità di azione. Nell’era industriale si puntava sulla solidità: sul capitale fisico, sull’importanza degli edifici, dei macchinari, delle materie prime.
lavoro possono notevolmente variare.
Aziende di informatica della Silicon Valley producono software in India. Quello
che si progetta a Los Angeles può essere
prodotto in Canada, venduto in Europa e
fatturato in qualche paese del sud-est asiatico (ha detto scherzosamente una volta
Alessandro Baricco che la globalizzazione
è quello “scanzonato collage” per cui a
Bangkok è possibile mangiare lo stesso
hamburger che fanno in Connecticut,
confezionato in una scatoletta fabbricata
in Perù e commercializzato da una ditta a
capitale misto franco-giapponese). Le
TLC rendono possibile questa estrema
La parola globalizzazione è ormai entrata nel linguaggio comune. Ma, come spesso accade, il termine viene usato in modo generico e si presta agli slogan più disparati, quasi sempre vuoti di contenuto. Insomma, la globalizzazione viene mitizzata o demonizzata, ma
quasi mai ci si sofferma a cercare di capirne le implicazioni, le opportunità, i rischi. Questo
è il terzo articolo con cui Romano Trabucchi affronta alcuni di questi aspetti. Lo fa in modo aperto, problematico, senza nessuna pretesa di sistematicità, cui del resto un tema ancora così controverso nemmeno si presta
flessibilità spaziale, temporale e organizzativa. Il computer che collega istantaneamente tutti i punti del globo, favorisce
questa organizzazione e rafforza le interdipendenze tra tutti gli operatori locali.
In questo contesto si moltiplicano le ristrutturazioni, le alleanze strategiche, le
fusioni, le incorporazioni, le compartecipazioni (nel 1998 furono portati a termine 23.962 accordi di fusione in tutto il
mondo per un valore di 2,4 trilioni di dollari e un incremento di quasi 5 volte rispetto al 1991)3. Cambiano, perciò, continuamente i confini fra l’impresa e il suo
ambiente competitivo. Sorgono filiere o
costellazioni di imprese collegate da rapporti produttivi o di mercato, spesso senza accordi societari, ma con semplici
joint venture; alleanze necessarie per appropriarsi di competenze che diversamente sarebbero accessibili in modo più
costoso e possono essere un mezzo per
ridurre la libertà di manovra di un concorrente attuale o potenziale. Anche i
rapporti fra le diverse imprese e organizzazioni si fanno leggeri e flessibili.
3
The Economist, 9 gennaio 1999
7
6
il giornale del dirigente
Si puntava su strutture gerarchico-piramidali. Oggi conta il capitale immateriale costituito dalle conoscenze,
dall’immaginazione, dalle informazioni, dalle competenze. Conta la velocità
di azione e di reazione. Contano le relazioni. Conta il capitale umano. Le aziende cominciano ad apprezzare le competenze più della disponibilità delle persone, e questo ha una serie di conseguenze sul rapporto contrattuale del lavoratore con l’impresa e sul modo di concepire la sua vita professionale.
Finisce il fordismo come filosofia organizzativa in base alla quale l’impresa è
qualcosa di monolitico, solidamente radicata in un luogo, sede di lavoro per tutti i suoi operatori. Con la nuova filosofia
postfordista l’impresa diventa una rete in
cui le diverse funzioni possono avere localizzazioni diffeUn film come Il Re Leone, con tutte
renti; in cui viene
le operazioni di merchandising ad esso
collegate, secondo Rifkin è il tipico
spezzata la catena
esempio del nuovo capitalismo culturale del valore; in cui
l’esternalizzazione delle attività non primarie consente ad essa di concentrarsi
sull’area strategica nella quale possiede
le competenze distintive; in cui i tempi di
APPUNTI
SULLA GLOBALIZZAZIONE
È evidente che anche la rigidità tayloristica dell’organizzazione del lavoro viene meno. Il postaylorismo va parallelo al
postfordismo. La struttura organizzativa dell’impresa cambia: abbandona il
carattere gerarchico-piramidale. Anche
l’organizzazione della fabbrica si flessibilizza a tutti i livelli. Si pensi all’impresa estesa (extended entreprise), applicazione che poggia sulla teoria dei frattali. Nella fabbrica frattale i fornitori
(una volta ritenuti rigorosamente
“esterni” all’impresa) producono sul posto i pezzi e i sottosistemi che sono poi
montati just in time sul corpo dell’auto
posizionata sulla linea di montaggio che
scorre ai due lati di un complesso di uffici in vetro, costruiti per facilitare la
collaborazione tra tecnici e operai e lo
scambio di informazioni4. Anche i confini dell’impresa si fanno mobili e incerti. E questo avviene proprio nella
fabbrica automobilistica (paradigma
della “monoliticità” industriale) da cui
era nata la catena di montaggio con le
ferree regole e i tabù dei Ford e dei Taylor. I fornitori entrano nella fabbrica e
concorrono direttamente alla produzione: un buon esempio di questo è stata la
“politica” della qualità totale.
In sintesi, la “nuova” impresa, come abbiamo accennato, è caratterizzata dall’“effetto Odd”: outsourcing (esternalizzazione); delayering (appiattimento della piramide gerarchica); deconstruction (frammentazione della catena del valore).
Anche il lavoro cambia. In questa situazione di grande turbolenza e incertezza
cambiano le sue condizioni e la sua concezione. Non solo non ci sono più i mestieri che si svolgono per tutta la vita ma
il lavoro - come afferma Bauman - “è sovente un’operazione una tantum, l’attività di un bricoleur, mirata a quanto è a
portata di mano e a sua volta ispirata e
limitata da quanto è a portata di mano,
più il risultato di un’occasione presa al
volo che il prodotto di un processo pianificato e programmato”5. Come ha affermato Ulrich Beck, il lavoro viene “flessibilizzato”: viene spezzettato nella sua
dimensione spaziale, temporale e con-
il giornale del dirigente
4
8
6
5
M. Carter, La rinascita di una forza trainante, The European, vol. 3, luglio 1998
Z. Bauman, Modernità liquida, Editori Laterza, 2002,
pag. 159
trattuale. Questo ha implicazioni sui
problemi dell’occupazione, sulle forme
di lavoro e di rapporto contrattuale. Si
realizza una molteplicità di rapporti e di
contratti di lavoro. I nuovi lavori sono
tanti: tanti lavori, altrettanti modelli contrattuali. I giovani, i destinatari dei nuovi contratti, sono stati definiti la “nuova
razza flessibile”. Anche il tempo di lavoro è molto variabile. L’orario pieno quotidiano e per 5 giorni settimanali non è
più la norma.
Quando la produzione diventa per l’impresa un’attività non primaria. La tendenza
alla “leggerezza” ha fatto sì che molte
grandi aziende si siano “liberate” anche
dei processi produttivi, esportandoli in
zone del mondo dove la mano d’opera è
a buon mercato o le condizioni per l’impresa particolarmente favorevoli. La
produzione non è ritenuta un’attività
strategicamente primaria e, quindi, viene appaltata all’esterno (all’estero). Qui
l’outsourcing non ha una ragione specialistica, ma si giustifica con la ricerca,
da parte delle imprese, di un aumento di
deregolamentazione, di libertà imprenditoriale e di massimizzazione degli utili.
Anche l’esternalizzazione della produzione è vista come un aspetto del grande
processo di dematerializzazione. In questa impostazione il marketing diviene la
funzione centrale e decisiva per il destino
dell’impresa, perché si occupa della filosofia della sua immagine e della costruzione del marchio. Il prodotto nasce in
fabbrica, ma ciò che il cliente compra è
il marchio. È il marchio che trasmette valori, mode e costumi e motiva all’acquisto. È il marchio che garantisce la continuità del prodotto e dell’impresa.
L’aspetto rilevante della produzione sono le idee, le immagini, i valori e le conoscenze incorporati nel prodotto e che
il marchio esprime e valorizza.
È, dunque, il marchio, non il prodotto,
l’elemento fondamentale per il successo
dell’impresa. Image is everything. Perciò
il marchio deve rappresentare qualcosa
di perenne. “I macchinari si usurano. Le
auto arrugginiscono. Le persone muoiono. Ma i marchi sopravvivono sempre”,
affermava Hector Liang, presidente di
United Biscuits. In questa impostazione
la strategia aziendale è pienamente legittimata a non considerare “primaria” la
funzione della produzione: e a delocalizzarla in qualche parte del mondo.
Qui il processo di dematerializzazione
sembra aver raggiunto la sua forma integrale. Le multinazionali si svincolano dai
prodotti materiali e la produzione non ha
più quella considerazione che aveva
nell’era industriale; non è più l’orgoglio
degli imprenditori.
È interessante notare come su questo
punto si inserisca la denuncia di alcuni
critici della globalizzazione. La fabbrica
viene “rinnegata”, afferma Naomi Klein,
la teorica dell’antiglobalismo. Nell’era
dei supermarchi i prodotti possono non
essere di ottima qualità; diventano irrilevanti; quello che conta è l’idea, l’identità
culturale del marchio “In questa trasformazione, lenta ma inesorabile, delle priorità aziendali… società che si erano sempre accontentate di ricarichi del 100%
sul prezzo al dettaglio rispetto al prezzo
di produzione, sono andate alla febbrile
ricerca di fabbriche, in qualsiasi parte
del mondo, capaci di realizzare i loro
prodotti a costi minimi per applicare un
ricarico pari quasi al 400%”6.
La contestazione delle multinazionali da
parte del movimento che contesta questa
forma di globalizzazione punta proprio
sul processo di esternalizzazione della
funzione produttiva e degli effetti che
questo ha avuto per la logica delle imprese. No-global va parallelo a No-logo (il
titolo del libro della Klein): due negazioni che sintetizzano la nuova contestazione all’economia globale. La tesi di Levitt,
da noi citata all’inizio, diventa per la
Klein il tentativo di colonizzare il mondo
intero con un’unica cultura consumistica: i marchi delle multinazionali impongono un consumismo di massa dagli effetti devastanti per la qualità della vita
degli uomini.
In realtà, la delocalizzazione della produzione da parte delle multinazionali avviene spesso verso paesi che non hanno
una politica fiscale e, soprattutto, hanno
bassi salari e nessuna legislazione del lavoro. Qui l’esternalizzazione della produzione si sposa, secondo le critiche noglobal, con una nuova forma di “moderno schiavismo”. Certamente, le multinazionali, liberandosi degli stabilimenti, si
liberano anche dei posti di lavoro e, soprattutto, del principio della “responsabilità del produttore” nei confronti della
forza lavoro: un principio che apparte6
N. Klein, No-logo, Baldini & Castoldi, Milano, 2001,
pag. 173
neva alla vecchia società industriale che
faceva della sicurezza del posto del lavoro uno dei suoi punti qualificanti.
La Nike, multinazionale dello sport, è
l’esempio paradigmatico e molto citato
di dove può portare la “leggerezza” delle nuove imprese e la loro tendenza ad
“esternalizzare” ogni funzione aziendale, compresa la produzione. Quando, ad
esempio, si scoprì che nelle fabbriche
Nike in Cambogia lavoravano bambini,
ci fu un grande scandalo. Partirono gli
appelli contro il dumping sociale e a favore di un deciso boicottaggio dei prodotti dell’azienda. Alle Olimpiadi del
2000 a Sydney, il gruppo di pressione
Nikewatch chiese agli atleti di boicottare i prodotti Nike. La multinazionale
Usa per limitare i danni cancellò tutti i
contratti con i fornitori cambogiani e
questo fu, per la Cambogia, una sciagura, perché questo significava mettere
sul lastrico decine di migliaia di operai
cambogiani. È stato a seguito dell’intervento dei sindacati americani che si è
trovata una soluzione per migliorare il
rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro (a cominciare dal divieto del
lavoro minorile).
Oggi la Nike annuncia stabilimenti che
saranno controllati dall’Organizzazione
internazionale del lavoro e aperti ai sindacati. Ecco come la minaccia di un
boicottaggio da parte dei consumatori e
la paura di un danno che avrebbe potuto colpire il cuore dell’impresa, l’immagine del suo marchio, ha mutato l’atteggiamento di una delle maggiori multinazionali.
Il problema è che la sostenibile leggerezza (fisica ed economica) che ha reso possibile l’attuale globalizzazione si scontra
con l’insostenibile pesantezza (etica e sociale) dello sfruttamento delle persone,
della negazione dei diritti umani, dell’ingiustizia sociale. Vedremo prossimamente gli aspetti critici della globalizzazione e quali problemi e soluzioni possano prospettarsi.
Anche le malattie si globalizzano? Con quali conseguenze? Nell’epoca della globalizzazione
riappare la paura millenaristica di
un’infezione totale, come le antiche pestilenze, a causa di un mutante particolarmente virulento, come tanti film di
fantascienza hanno immaginato. Oggi
si parla del rischio di un’influenza planetaria. L’analisi storica ed epidemiologica ha messo, d’altronde, in evidenza
come l’emergere di nuove epidemie è
sempre legato a profonde modificazioni sociali ed ecologiche. E oggi migrazioni di massa, urbanizzazione spinta,
globalizzazione, con la facilità, la velocità e l’estensione del sistema di comunicazioni, aumentano la pericolosità di
queste situazioni. La novità è che il tempo di trasmissione della malattia per i
ritmi veloci di circolazione di cose e persone è divenuto fulmineo a confronto
con epidemie del passato. Basti ricordare che nel ’300 per tornare in Europa
dall’oriente, dove era endemica, la peste
impiegò qualche secolo.
Precauzioni per la SARS. Nell’era
della globalizzazione riappare la
paura atavica dell’infezione totale
Il caso della polmonite atipica (Sars) è
un esempio significativo perché i suoi
effetti si ripercuotevano sul “made in
China”, un paese importante nel processo di globalizzazione.
Si è temuto che, se la malattia fosse
continuata con l’intensità originaria,
avrebbe rischiato di compromettere il
nostro stesso stile di vita, i nostri consumi che utilizzano prodotti o parti di
prodotto che vengono dalla Cina (scarpe, abbigliamento, videogame, microchips e via dicendo). Il 40% delle scarpe Nike, per fare un solo esempio, sono
fabbricate in Cina.
Nella divisione globale del lavoro la Cina
ha un ruolo fondamentale per la produzione dei nostri beni di consumo. Essa,
con la disponibilità del gigantesco serba-
toio di manodopera a costi bassissimi
che si ritrova è, ad esempio, il principale
partner commerciale degli Stati Uniti.
La nuova situazione creata dalla malattia metteva, perciò, in crisi gli approvvigionamenti e i rifornimenti, non solo per
evidenti problemi organizzativi, ma anche perché gettava una luce sinistra sulla possibilità di assumere il coronavirus
dagli oggetti o dalle merci di provenienza asiatica. E, soprattutto, metteva in crisi la catena gerarchica e informativa che
lega le imprese locali alla casa-madre e i
controlli che questa esercita quotidianamente sul loro operato.
Ecco un esempio (in negativo) di quella
interdipendenza degli eventi a livello
mondo, di cui abbiamo parlato. In una
situazione come questa, se esce dal con-
trollo, c’è il rischio che metta in crisi gli
stessi vantaggi dell’economia globale.
In una delle sue corrispondenze dagli
Stati Uniti, Federico Rampini notava come le multinazionali americane abbiano
ipotizzato anche un’“impensabile” retromarcia dalla delocalizzazione per riportare interi pezzi della loro produzione economica vicino a casa, per esempio in
Messico.
E concludeva: “Sarebbe un colpo senza
precedenti alla globalizzazione”7. Un anno e mezzo dopo l’11 settembre, la Sars
attacca di nuovo la stessa infrastruttura
nervosa della globalizzazione e rischia di
metterne in crisi proprio l’elemento caratteristico, la moltiplicazione del commercio mondiale ottenuta grazie alla
cancellazione delle distanze.
7
La Repubblica, 29 aprile 2003
11
6
il giornale del dirigente
APPUNTI
SULLA GLOBALIZZAZIONE