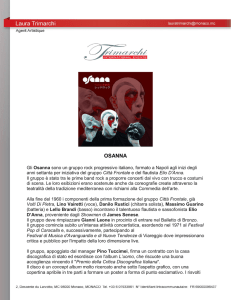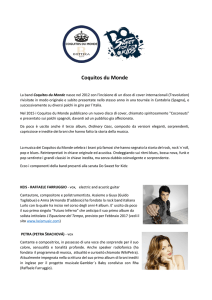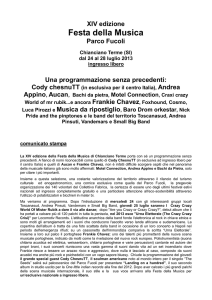digital magazine ottobre 2010
N.72
iosonouncane
democrazia del televoto
blonde redhead
Tremate, tremate
le streghe sono tornate...
SALEM, White Ring, oOoOO, Balam Acab, Modern
Witch, Mater Suspiria Vision...
Orange Juice
Elisa Randazzo // No Guru // Crocodiles // Dargen D'Amico // One Dimensional Man
Turn On
p. 4
Elisa Randazzo
5
No Guru
6
Crocodiles
8
Dargen D'Amico
10
One Dimensional Man
Drop Out
12
Blonde Redhead
20
iosonouncane
28
Tremate, tremate le streghe sono tornate
Recensioni
36
Salem. iosonouncane. BlackAngels...
Rearview Mirror
92
Orange Juice
Rubriche
82
Gimme Some Inches
84
Re-boot
86
China Underground
96
Giant Steps
97
Classic Album
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda.
Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,
in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,
è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Direttore: Edoardo Bridda
Direttore Responsabile: Antonello Comunale
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Coordinamento: Gaspare Caliri
Progetto Grafico
e
Impaginazione: Nicolas Campagnari
Redazione: Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi,
Top of the pop.
Stefano Solventi, Teresa Greco.
Staff: Mauro Crocenzi, Lucia Di Carlo, Desiree Marianini, , Fabrizio Zampighi, Stefano Pifferi, Marco Boscolo,
Gabriele Marino, Teresa Greco, Andrea Napoli, Teresa Greco, Stefano Solventi, Antonio Puglia, Diego Ballani, Luca
Barachetti, Giancarlo Turra, Edoardo Bridda, Gaspare Caliri, Gianni Avella
Festival internazionale | 8° edizione
Bologna, 30 ottobre - 6 novembre 2010
2
www.genderbender.it
Guida
In
spirituale:
copertina:
Adriano Trauber (1966-2004)
iosonouncane
I
n un’epoca in cui chiunque pubblica dischi, è un miracolo imbattersi in chi soppesa la mossa fino a quando non si sente pronto. Elisa Randazzo è siffatta rarità,
un’artista con gli occhi spalancati sul mondo, pronta a
raccogliere ogni barlume di vita e metterlo da parte.
Dopo una gavetta d’eccezione che la avvicina a Lisa
Germano (violinista, arrangiatrice e cantante nell’ultima
formazione dei Red Krayola), ha avvertito il bisogno di
aprire il proprio vaso di Pandora: “E’ stata una delle esperienze musicali più liberatorie della mia vita: avevo deciso di
seguire l’istinto, il desiderio di registrare le canzoni così come
venivano fuori.” Un agire ammirevole nell’era del calcolo
e del distacco, questo mettere in primo piano il vissuto
e ricavarne canzoni intense, sospese - senza hippismo da
cartolina - in certa California (dove la Nostra, dopo un
lungo girovagare, risiede) a cavallo tra ’60 e ’70.
C’è semmai catarsi, evidente sin dalla copertina che raffigura una fotografia in fiamme, metafora di un passato
che lascia il posto al presente; ribadita da una dimensione sonora domestica che indica la genesi meditata ma viscerale: “Nel bel mezzo del divorzio decisi di vendere l’anello
nuziale per pagare studio e mixing. Ho inciso voci e violini a
notte fonda nel mio soggiorno, senza sovraincisioni.” Con la
4
No Guru
Turn On
Turn On
Elisa
Randazzo
—Eli's Coming—
—Milano Original
Playback—
Alla luce di un esordio
promettente, indaghiamo i segreti
di una cantautrice fuori dal
comune
No Guru recita la ragione
sociale, ma non si tratta di
una formazione all'esordio. Al
massimo di un "supergruppo",
come dimostrano i nomi coinvolti
nel progetto.
cura e l’amore di chi si guadagna il pane da stilista (con
la linea “Dusty of California”, ispirata al suo mito Dusty
Springfield) e di chi le note le ha assimilate con il latte
materno, aggiungiamo. I genitori, Victoria e Teddy, vergavano infatti hit per Zombies, Linda Ronstadt e Frank
Sinatra: “La vita famigliare ha ruotato attorno alla musica.
E’ da lì che arriva, anche se il mio approccio è diverso: non
scrivo per conto terzi ma partendo da un luogo e da un’interpretazione personali. Però, quando sono ispirata, lavoro finché
non ottengo qualcosa e anche questo lo devo ai miei, come il
‘costruire’ i brani con gli archi.”
Ecco il segreto della delicatezza dell’insieme, della collaborazione con Bridget St. John e del fantasma di Judee Sill che appare sovente, delle pagine che riportano
alla Joni Mitchell che non è più e alla brillantezza del
miglior Neil Young agreste. Bruises And Butterflies cresce
con gli ascolti e persuade su un cammino già proiettato
nel domani con passo sicuro: “Vedere i miei desideri realizzarsi mi fa stare bene. Non ho rimpianti per me questa è
una cosa molto importante.” Da adulta, la grandezza non
può che attendere dietro l’angolo. Giancarlo Turra
S
iamo in tempi di revivalismo anni Novanta e chi in
quegli anni visse il proprio zenith, torna ora a farsi
sentire. E’ il caso dell’ex Ritmo Tribale Edda, convertitosi a un folk intimo e mutante, degli Afterhours visti
a Sanremo, del nuovo corso dei Massimo Volume, degli Starfuckers di Ordine '91-'96, del citazionismo dei
Vessel targati Gismondi–Nuccini-Reverberi o dei rinati One Dimensional Man. Vecchie conoscenze che a
bordo palco ritrovano nuovi estimatori assieme a quello
zoccolo duro di fans che i Novanta li ha vissuti sul serio. Come hanno dimostrato i concerti affollatissimi dei
Massimo Volume l'anno scorso o più di recente i molti
lettori passati per la nostra recensione di Milano Original Soundtrack – complice la pubblicazione della stessa
sul profilo facebook della band – dei No Guru di Xabier
Iriondo, Andrea Scaglia, Alex Marcheschi, Luca Talia, Bruno Romani e Andrea “Briegel” Filippazzi.
Di loro parliamo in questa sede, ex Ritmo Tribale ed
ex Afterhours (con una punta di Detonazione) tornati come per magia sotto lo stesso tetto. Con in testa
quella Milano sempre più ingorgo (culturale?) e sempre
meno realtà disposta a tirare il freno delle pretese. Eppure è proprio la somma dei fattori a generare i No Guru,
un’unità inscindibile di passato, presente e geografia che
emerge anche dalle considerazioni della band: "Milano e
duemiladieci: questi sono i due elementi essenziali. Sentivamo
il bisogno di tirar fuori l’isterismo della città, lo sferragliare
dei tram, la sensazione di vivere sempre in ritardo. E dunque
tempi spezzati, sax dissonanti, uniti a un ritmo incalzante. Gli
Afterhours, i Ritmo Tribale, gli anni Novanta sono solo note
biografiche. Esistono e fanno parte del nostro bagaglio personale. Ma questo progetto vorrebbe andare oltre."
C’è il rumore nervoso delle no wave a certificare la
svolta stilistica. Una musica in bilico tra cesure intransigenti ed elettricità spigolosa, crescendo e rimbalzi funk,
incentrata su una scrittura che in parte richiama la forma
mentis delle formazioni-madri: “Abbiamo cercato di inserire
ingredienti poco armonici all’interno di una scrittura fondamentalmente pop.Volevamo che il messaggio arrivasse, senza
indugiare in avvitamenti strumentali troppo prolissi. Rispetto
al passato le chitarre sono più acide, non ci sono i bassoni
che tanto piacevano a Briegel, emergono stacchi dissonanti".
Tra le righe tornano in mente i Contortions ma niente
sperimentalismi gratuiti in bella mostra. Al massimo una
solidità invidiabile garantita da musicisti decisi a rimanere ben sintonizzati sul presente. Il loro.
Fabrizio Zampighi
5
Turn On
Crocodiles
—Psycho surfers—
Dieci anni di provocazioni sonore
sfociano in uno degli album pop
più brillanti dell’anno. Dai Plot
ai Crocodiles, la storia del duo
californiano più hyped del momento
C
hissà se i fratelli Reid, nati al sole della California anziché nell’uggia di Glasgow, avrebbero covato quel misto
di alienazione e tensioni urbane che ha fatto dei Jesus And Mary Chain un bignami esistenzialista ad uso e
consumo di generazioni di noisemakers. In questo senso Brandon Welchez e Chriss Rowell sono solo gli ultimi del
lotto. Loro vivono a San Diego, ma l’arte del rumore l’hanno imparata presto, come corollario ad un gusto per la
provocazione che faceva dei loro Plot uno sputo un faccia a chi pensa ancora alla California come la patria di surf,
bellezze siliconiche e muscolosi tipi da spiaggia.
Plot sta per Plot To Blow Up The Eiffel Tower. Una storia breve la loro, articolata in tre album, l’ultimo dei quali,
Saviors & Suckers, giace ancora unreleased in qualche cassetto polveroso. Nacquero dalla fantasia di Welchez e
Rowell, appena conosciutisi a un meeting antifascista tenutosi a San Diego, e per sei anni misero a segno un attacco
sistematico a ogni tipo di prevaricazione culturale.
A prescindere dall’aspetto meramente musicale (il loro era un art punk che incorporava elementi noise e free
6
jazz), a spostare sempre un pò più in alto l’asticella della tollerabilità, fu una via crucis di gigs d’assalto, in cui
la band attuava ogni tipo di provocazione. Fra le altre
cose erano soliti presentarsi sul palco con uniformi che
richiamavano quelle del partito nazista, per poi lasciarsi
andare ad atteggiamenti omoerotici. Una volta, a Salt
Lake City, si sfiorò la rivolta. Welchez ricorda l’episodio
divertito: "Fu una sorta di Stonewall (la rivolta gay del ’69
che prese il nome da un locale del Greenwich Village,
ndr.), stavamo suonando per un branco di palestrati omofobi
che iniziarono a minacciarci dicendo che volevano ucciderci.
Fortunatamente non passarono mai ai fatti".
A settembre del 2006 i Plot annunciavano lo scioglimento tramite il loro MySpace: un comunicato di poche righe che metteva la parola fine al progetto, ma
non all’attività dei due in qualità di catalizzatori delle
tensioni creative che ribollivano ai margini della città.
Welchez, insieme ad altri membri della band, formò i
Prayers (autori di un solo EP per la concittadina Art
Fag). Rowell, preferì dedicarsi alla letteratura. Scrisse
addirittura due libri prima di decidersi a formare i Crocodiles insieme al vecchio compagno.
Rispetto alla band originaria, le influenze del nuovo progetto erano tracciabili quasi geometricamente. I Crocodiles si muovevano in quello spazio cartesiano che
ha sull’asse delle ascisse l’apatia esistenzialista dei Jesus
And Mary Chain e sul quello delle ordinate il pop
isolazionista degli Spacemen 3. Neon Jesus, il singolo
che segnava l’esordio della band, era un grumo pulsante
di energia negativa sepolto sotto scorie di feedback e
detriti punk, talmente convincente da destare l’attenzione dei media e fungere da trampolino di lancio per
l'etichetta creata dallo stesso Walchez, la Zoo Music.
Ma non bastava, perché in un underground californiano
scosso da fremiti creativi, era necessario che qualcuno
si arrogasse l’onere di delineare i riferimenti culturali
verso cui far convergere l’immaginario artistico. Ecco il
senso delle serate intitolate Skull Kontrol, dal nome
del blog curato dagli stessi Crocodiles: si trattava veri
e propri happening, momenti di gestazione della scena
cittadina, che avevano come protagoniste le più eccentriche sensibilità locali. "E' stato bello fino a che è durato
– ricorda oggi Welchez – Erano serate incredibili, in cui si
suonava di tutto, dai Germs a Biggie Smalls. Era qualcosa di
veramente eclettico!".
Ad affiancare i due nell’organizzazione e promozione
delle serate c’era il loro amico Mario Orduno, creatore
della Art Fag, etichetta fra le più attive all’interno del
fall out di sonorità lo-fi, d’oltreoceano. San Diego diventava così la terza punta del triangolo che vedeva Brooklyn (con Woodsist e Captured Tracks) e Chicago
(con la HoZac) agli altri due poli. Seduti al centro della
scena c’erano loro, i Crocodiles, in virtù dell’attesa spasmodica che si respirava per il disco d’esordio. Welchez
e Rowell lo registrarono di straforo nello studio di un
amico produttore, sfruttando i suoi momenti liberi.
Summer Of Hate, esce a metà del 2009: l’impeto anarchico dei Plot è in gran parte ammorbidito, incanalato
in una narcosi psichedelica che pervade tutti i brani. Le
coordinate sono quelle di un noise pop controllato, talvolta nebulizzato in una dilatata trance lisergica, cinico
come il titolo più rappresentativo dell’album, quella I
Wanna Kill il cui chorus "...nothing right, nothing wrong..."
secondo alcuni esprime al meglio l'estetica apatica della
band. "Niente di tutto questo. – affermano i due parlando
di quel brano – Si tratta di una canzone scritta a soggetto.
Non tutto quello che cantiamo va preso alla lettera. Siamo
più attratti dall'aspetto musicale della faccenda. Esteticamente ci piace percorrere la linea di confine fra violenza e
bellezza".
A pubblicare il disco è la Fat Possum, etichetta dai
trascorsi blues punk che sta radicalmente rinfrescando il proprio roster, fino a rendersi protagonista della
nuova stagione indipendente a stelle e strisce. In quelle
miniature di pop drogato, in quella surf music per chi ha
ecceduto con lo Xanax, l’etichetta intravede un potenziale commerciale e decide di investirvi. Occorre però
levigare le asperità di una produzione semiamatoriale e
dotare la band di una serie di input che permetta loro
di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Per questo viene ingaggiato uno dei produttori più hyped del
momento (James Ford del collettivo Simian Mobile
Disco) e allestito uno studio di registrazione nel bel
mezzo del deserto del Mojave, a Joshua Tree: un’abitazione opportunamente riconvertita e imbottita all’inverosimile di ogni tipo di strumento analogico e digitale.
Anticipato dall’omonimo singolo (che vede come side
track una cover dei Dee-Lite!), Sleep Forever è il brillante e caleidoscopico frutto di quelle sessioni. Pervaso
dall’amore per i 60s più sognanti e per la wave più emotiva, il sound dei Crocodiles è un impasto di feedback,
beat elettronici, vocalizzi aerei e colorate cromature
d’organo che esaltano le melodie velvetiane della band.
L’oltraggio nichilista si è tramutato in uno psycho pop
sognante, al punto che il video dell’ultimo singolo Heart
Of Love, mostra un assolato scorcio di California in cui
fanno capolino quelle spiagge su cui oggi, i Crocodiles,
appaiono perfettamente a loro agio.
Diego Ballani
7
Turn On
Dargen
D'Amico
—Prendi per mano
D'Amico—
Prendiamo al volo l'invito di Dargen
e lo prendiamo per mano. Per capirlo,
se la cosa interessa, bisogna entrare
nel suo mondo a suo modo, saper
mettere assieme carne ed esegesi,
poesia e tamarragine.
S
ubito dopo l'uscita della prima parte (primi di giugno) e subito prima dell'uscita della seconda (primi di ottobre),
abbiamo intercettato Dargen per cercare di capire meglio i perché e i percome della direzione - consapevolmente
suicida - definitivamente intrapresa con il progetto su doppio EP digitale D'. Chiacchierata veloce ma densa.
Partiamo da lontanissimo. Più volte hai detto della tua passione per i neomelodici. Qui a Palermo il
fenomeno è di una pervasività incredibile. Ma a Milano, come li hai scoperti? La cosa ti interessa a
livello di immaginario, di estetica, di voci? Chi ti piace?
Il genere neomelodico è dappertutto, è uno stato della mente non una regione d’Italia, tant’è che anche i neomelodici
palermitani cantano in napoletano. Io li ho scoperti prima che si navigasse in rete, era semplicissimo acquistare le musicassette neomelodiche negli autogrill, in tutti gli autogrill, anche nel profondo nord. Amo, ma preferisco comunque
non fare nomi perchè i chiacchieroni non sono benvisti tra i neomelodici.
Conosci Alea, la rapper di Acerra? Sono rimasto colpito anni fa dal suo primo singolo, Ghetto, pezzo
che poi Neffa ha remixato e sul quale ha rappato una strofa (parliamo di tempi già post-Chicopisco).
Era un pezzo con una sua violenza poetica, molto oldskool rap. Anche ad Alea ho chiesto dei neomelodici. Lei apprezza soprattutto i cantanti coi piedi ben piantati nella tradizione, tipo Maria Nazionale
(tra i protagonisti di Gomorra versione Garrone).
Anche a me piacciono quelli ben piantati, anche fisicamente. Non conosco la canzone di Alea, però l’ho sentita nominare più volte. Chiaramente abitando ad Acerra avrà una conoscenza ben più approfondita del genere, conoscenza
che le invidio.
8
Visto che siamo in argomento...Ti piace l'ultimo
Neffa hip hop? Vi lega, tra le altre cose, la stima
che entrambi avete per Emiliano Pepe.
Sì, il Neffa di quel periodo mi piace eccome, come è
naturale che piaccia a chi mastica un minimo di rap. A
Emiliano sono molto legato, ultimamente lo vedo poco,
ma mi fa sempre sbattere ‘o core, lo voglio troppo bene e gli
dedico Facimme Pace di Tony Colombo.
Sempre parlando di cantanti amati nel mondo
hip hop italiano, che mi dici di Diego Mancino?
Conosco il suo ritornello per un pezzo di Fibra [Idee
Stupide; ndr] e mi piace, ma la mia conoscenza si ferma
lì. Mi stai facendo fare una figuraccia, grazie.
Hai detto che a Fabri farebbe bene pubblicare
un disco dalle vendite non multimilionarie. Hai
detto anche che con Controcultura ha probabilmente centrato questo obiettivo. Quanto e
come ti pare diverso dalle sue ultime cose? Il suo
freestyle sul tuo Van Damme e le anticipazioni
che ho sentito da Quorum mi hanno abbastanza
convinto...
Ha più chiare le proprie possibilità, meno angoscia, sa
lavorare su di sé senza attendere che lo facciano i discografici.
Sia tu che lui siete due nomi storici dell'HH underground italiano. Il vostro percorso artistico è
simile e profondamente diverso, come dev'essere. Entrambi avete semplificato l'approccio alla
rima e diminuito il tasso di tecnica rispetto alle
produzioni storiche (penso a Una Minima e penso a Tana2000), a favore di una comunicatività
più asciutta e allo stesso tempo a tinte più forti:
le pose da "Eminem italiano" di Fabri, le tue produzioni che flirtano con l'electro (con quell'uso
così deformante del vocoder, e ancora il rapping
molto meno squadrato, vicino al cantato)... Si
tratta in qualche modo di un adeguamento ai
nostri tempi?
Mi pare improbabile che un artista resti uguale a sé. Immaginati Vasco Rossi che in ogni disco ripropone Albachiara, magari cambiando qualche parola, qualche nota,
ma sempre Albachiara, allora sì che sarebbe giusto incarcerarlo senza appello, l’immobilità è ben peggio del
possesso di cocaina. La cosa che spaventa di più è che
probabilmente i fan farebbero i salti di gioia ascoltando
Albaalba, e l’anno seguente Chiarachiara, e via così fino
al 2012.
In Prendi per mano D'Amico dici "mi riconosco nel
mio disco solo se mi rispecchio nel retro del cd". In
Il Rap per me dicevi: "Il rap per me è dire cose che
non credi su una musica non tua". L'autenticità è
solo una delle maschere possibili?
L’autenticità è relativa. I soldi falsi non sono più falsi di
quelli veri. Ben vengano le maschere, il deodorante è
una maschera, la buona educazione è una maschera.
Nelle tue ultime collaborazioni con Amari e
Crookers, e con questo ultimo eppì in particolare, sembra che tu ti stia costruendo una tua
"poetica tamarra". Mi spiego meglio. "La mia religione è bere una cosa con te" non è una specie
di aggiornamento della poetica montaliana delle
piccole cose al tempo dell'aperitivo, dei cellulari,
del social network eccetera? Penso anche a certe tue dichiarazioni in cui dici che Dio può stare
dappertutto, anche e soprattutto nelle piccole
cose...
Sì, se l’ho detto, non lo nego. Lungi da me però aggiornare la poetica montaliana, più interessante e utile per
me sarebbe se Montale aggiornasse la mia. In realtà le
poetiche si aggiornano automaticamente. Forse, se oggi
Montale fosse qui a Milano e avesse la mia età, sarebbe
un cantautorap come me e magari a quest’ora saremmo
assieme.
Sempre in Bere una cosa, parli di "vita senza tempi morti". Mi ha fatto pensare a Pasolini e ai suoi
discorsi su vita, morte, pianosequenza e montaggio...
A me no, ma rispetto troppo le idee altrui per farti cambiare idea.
La produzione di Malpensandoti ha qualcosa dei
Daft Punk di Make Love. C'è la stessa atmosfera agrodolce, rarefatta, rallentata. Ecco, quando
produci, come produci? Che tecnologia usi, a chi
ti ispiri?
E’ un accostamento che mi fa immenso piacere, come
l’insalata e l’aceto balsamico, ma credo sia fin troppo
sfavorevole per loro. I Daft sono una pietra miliare della
musica contemporanea, hanno prodotto dischi e suoni
che altrimenti non esisterebbero. Io inversamente, produco con pochissima perizia e molto a sensazione, non
sono un musicista, non ho i mezzi per ispirarmi a chi
vorrei. Produco con un vecchio pc e una vecchia versione di Acid Pro.
Ultima cosa. Il tuo rapporto con la Sicilia. Ci ritorni ogni tanto o è solo un ricordo (o una fantasia)?
Ci torno spesso, ci mancherebbe. E' un paradiso in liquidazione.
Gabriele Marino
9
Turn On
One
Dimensional
Man
—A volte ritornano...—
Mai ufficialmente sciolti, ma
nemmeno attivi. Dopo un decennio
di congelamento, torna la seminale
formazione del noise-rock italiano
per una serie di live e un nuovo
disco...
L
a notizia ormai è di dominio pubblico, ma resta sempre di quelle bomba. Gli One Dimensional Man si riformano
per una serie di concerti in cui celebrano, riproponendolo nella sua interezza, You Kill Me, il disco del 2004 che
ne sancì il successo di pubblico e critica. Notizia che sicuramente farà piacere sia ai 30something, sia ai molti fan del
Teatro Degli Orrori. I primi a cavallo dei 2 millenni videro crescere il terzetto veneto, apprezzandone il noise-rock
di stampo newyorchese e i live incendiari; i secondi avranno modo di vedere da dove prende le mosse una delle
macchine da guerra rock più in forma del momento.
Noise-rock di matrice newyorchese, lercio e depravato, imparentato con quella forma bastarda di blues violentata da
Surgery e Pussy Galore, in grado di diffondere il verbo di Scratch Acid e Jesus Lizard, completamente immolato ad
una idea di rock sudata, appassionata, punk senza-essere-punk. Questa potrebbe essere una ideale cartolina dal mondo ODM. In più metteteci un cantante carismatico, musicisti con l’orecchio giusto (vedi alla voce Favero), un forte
10
immaginario letterario e una certa predilezione per la
forma-canzone ed avrete una delle band più considerate e insieme sottovalutate del primigenio panorama
rumoroso italiano.Vederli sul palco, per la prima volta o
come un attesissimo comeback, non sarà male. Il fatto
poi che il terzetto – a supportare Capovilla al basso e
Giulio Ragno Favero alla chitarra troviamo Luca Bottigliero, batterista dei Mesmerico – roderà alcuni brani
nuovi per l’annunciato full-length non fa che aumentare
la voglia di seguirli on stage. Per ora accontentiamoci di
questa chiacchierata con Pierpaolo Capovilla.
Cominciamo con una domanda semplice, scontata e anche un po’ provocatoria: perché? perché
dopo così tanti anni, Pierpaolo?
One Dimensional Man non si sono mai sciolti. Abbiamo
fatto Il Teatro degli Orrori, certo, ma ho sempre detto che One Dimensional Man avrebbero continuato il
loro percorso; ora, è arrivato il momento di rimettere
in moto questa creatura, che mi è costata tanta fatica...
Come mai ti è costato tanta fatica rimettere su
quest’animale da palco che sono ODM?
Fatica? No, nessuna fatica, amico mio. Lo faccio con gioia
ed entusiasmo, come sempre. Io non sto facendo altro
che portare a compimento l'obiettivo che mi ero dato
circa quattro anni fa: due gruppi, tourné tutto l'anno, in
studio di registrazione ci metterò le radici.Voglio vivere
la mia vita fino in fondo, costi quel che costi.
Come è maturata questa decisione, mi riferisco
al successo del Teatro, tantissime date, impegni in studio e in progetti particolari, ma pure
all’“uscita” di Giulio dal Teatro per poi “rientrare” con ODM…
Credo che io e Giulio siamo nel bel mezzo di un sodalizio artistico; lavorare insieme ci procura grandi soddisfazioni.
Come si collocano gli ODM oggi? Voglio dire,
all’epoca eravate dei precursori di un certo suono, ora la scena noise-rock italiana bene o male è
matura, pensa a Lucertulas, Dead Elephant, ecc.
e soprattutto c’è un certo distacco anagrafico
tra noi vecchietti e le nuove leve…
Vecchietti? Distacco anagrafico. Mi rendo conto...Ma
dopo l'inaspettato successo de Il Teatro, riproporre
One Dimensional Man era inevitabile. Se non ora, quando? C'è un pubblico inter-generazionale, che non vede
l'ora di ascoltarci dal vivo. Sarà come dici tu, la scena
ormai è matura, ma qualcosa mi dice che One Dimensional Man possano ritrovare un posto di tutto rilievo.
I prossimi dieci concerti saranno all'insegna del nostro
suono di sempre, ma il nuovo disco sarà invece molto
innovativo.
Dal tuo osservatorio privilegiato – intendo come
distacco anagrafico e come realtà consolidata
del rock italiano – come è la scena noise-rock
italiana attuale?
Esiste una scena noise-rock in Italia? Non lo sapevo.
Di quelli di un tempo – penso a Crunch e Jinx
tanto per far due nomi – ormai non si hanno notizie. Voi invece ritornate. Volete solo riscuotere
il dovuto o al cuor non si comanda e il primo
amore non si scorda mai?
Sono convinto che One Dimensional Man sapranno superare ogni aspettativa. In cuor nostro, l'ambizione più
grande è quella di fare un bel disco.
Perché la scelta è ricaduta su You Kill Me? Perché
fu quello della “svolta” o ci sono altre ragioni?
You Kill Me è il nostro disco più rappresentativo, la scelta è stata naturale.Il live conterrà comunque pezzi da
tutti i dischi, dal primo all'ultimo. Sarà una meraviglia. Ci
saranno inediti. Contiamo di spaccare i timpani all'auditorio, e chissà, fors’anche oltre. All' universo ...
Prima mi accennavi al nuovo disco come qualcosa di innovativo. C’è una attesa piuttosto grande,
perciò vuoi anticiparci qualcosa?
Per ciò che riguarda il nuovo album di One Dimensional
Man, siamo ancora nella fase interlocutoria dello scambio di idee; ma io e Giulio lavoriamo con grande velocità, e abbiamo le idee chiare Il nuovo disco sarà profondamente diverso dai precedenti, molto più attento al
futuro, e molto più "dinamico". I testi non li scrivo io, ma
tutti Rossmore James Campbell, pittore e poeta australiano di Sidney che già collaborò con One Dimensional
Man in "You Kill Me" ("This Man in Me" è un testo suo).
Sarà un disco romantico, seduttivo, ricco di tristezza e
disperazione, di gioia e riscatto.
Questo ottobre sembra proporci grandi ritorni eccellenti …Massimo Volume, prima e ODM,
poi…secondo me è segno della grandezza “avanguardistica” di certi progetti italiani…troppo
avanti per i tempi in cui maturarono…che ne
pensi?
Sono d’accordo. Eravamo in anticipo sui tempi "italici",
ma eravamo in ritardo a livello globale.
Stefano Pifferi
11
Blonde redhead
—Quasi per caso—
Drop Out
Hanno attraversato due decenni.
Hanno uno zoccolo duro di fan
che li segue appassionatamente.
Abbiamo incontrato Amedeo,
Simone e Kazu e ci siamo fatti
raccontare la loro storia...
Testo: Marco Boscolo
12
13
“Non lo so come capiamo quando una canzone è pronta: semplicemente lo sentiamo”. Sta tutto qui il pensiero musicale di Amedeo Pace e dei suoi due compagni di viaggio, il fratello Simone e la giapponese Kazu Makino. Non ci sono
regole precise per la creatività, le canzoni e i suoni si formano piano piano
nell'interplay tra gli strumenti, “quasi per caso, senza che ci siano delle strade già
predefinite”. Ed è un po' difficile da credere mentre assistiamo al concerto bolognese del trio nippo-italiano di base newyorkese. Le canzoni sono eseguite
con una professionalità e una vocazione estetica che non sembra lasciare
alcunché al caso. Ne abbiamo avuto la riprova durante il pomeriggio, quando
siamo venuti qui all'Estragon di Bologna per incontrare i musicisti. Erano solo
le due del pomeriggio e i fratelli Pace erano già impegnatissimi nel loro sound
check. Ogni pelle e ogni effetto della batteria di Simone (combinazione di
tamburi acustici e percussioni elettroniche) è stato provato finché il fonico
non ha trovato il livello che soddisfacesse il batterista. Lo stesso è valso per
le chitarre e le tastiere suonate da Amedeo. Una precisione che sembra voler
affermare che i suoni di qui e ora devono assomigliare all'idea che i Blonde
Redhead hanno in testa, non si sa bene dove, ma bisogna cercarli finché non
si trovano, in un'atmosfera generale che è difficile capire quanto sia fintamente o genuinamente naif.
L'idea di ricerca sonora emerge anche dalle chiacchiere che abbiamo fatto
sul tour bus con Kazu, considerata dallo staff e anche dai fratelli Pace, come
la mente principale dietro a Penny Sparkle, l'ultimo capitolo di una saga indie
che si avvicina senza colpo ferire ai vent'anni di attività. “Sono stata a Stoccolma dove ho lavorato con i produttori (Van Rivers e Subliminal Kid, gli stessi di
Fever Ray, N.d.I.) e lì ho inizialmente scritto una versione di Here Sometimes.
Suonare e lavorare in Svezia mi è piaciuto molto, così ho cominciato a pensare
che avrei voluto realizzare tutto il disco in quel modo e con quell'atmosfera”. In
quel periodo, come ci racconta lui stesso, succede che Amedeo si trovi in Islanda per suonare nel disco di un amico. Così è facile arrivare in Svezia e provare
a mettere il suo tocco sul nuovo pezzo. Meno contento di questa produzione
che Makino conferma essere stata piuttosto importante (“ma era quello di cui
probabilmente avevamo bisogno”) sembra essere Simone, che raggiunto al telefono qualche settimana prima dell'uscita del disco ci ha raccontato che lavorare
a distanza, tra New York e Stoccolma, non è stato così semplice:“abbiamo avuto
da che ridire con la produzione, perché avevamo in mente un'idea di suono e loro
ci hanno invece spinto in un'altra direzione. Abbiamo discusso anche pesantemente,
perché ci era parso che la nostra idea di sound venisse troppo influenzata dalla
produzione”. Alla fine, però, il risultato di questa scissione tra Europa e America,
con Makino di qua e i fratelli Pace di là, sembra aver soddisfatto tutti e tre i
membri della band, perché anche Simone alla fine sottolinea che le idee suoi
suoni date da Van Rivers e Subliminal Kid ha prodotto una dialettica che si è
rivelata produttiva per tutta la band nell'andare a parare in territori più europei
che forse non erano del tutto attesi, in una definitiva ricongiunzione tra i due
continenti, per chi, come i Blonde Redhead ha iniziato una carriera nel solco del
chitarrismo sonico del Lower East Side ed è approdato in casa 4AD.
Delle eventuali influenze del tipico suono dell'etichetta, la stessa di band
atmosferiche ed eteree come i Cocteau Twins e i This Mortal Coil, i
tre preferiscono non parlare. Al telefono, Simone era stato addirittura
categorico:”non me ne frega niente di queste cose. Io penso a suonare e a portare
avanti il lavoro dei Blonde Redhead. Non mi interessano le etichette messe dalla
stampa e non mi interessano nemmeno le influenze che possiamo avere”. Ma
14
concede che durante la lavorazione
del disco si ascoltava Third dei Portishead, la cui influenza fa capolino
anche in alcune parti di batteria sul
nuovo disco, e la musica brasiliana
degli anni Sessanta. “Quando metti su
un disco brasiliano di quegli anni”, racconta Amedeo sul tour bus, “hai immediatamente una sensazione di libertà
che non ha eguali”, ma anche se con un
filo di riluttanza ammette anche lui che
i Portishead sono finiti nel lettore, forse
tre o quattro volte, ma non so se questo
abbia influenzato il sound del disco”.
Makino starnutisce e ha il naso un
po' chiuso di chi sta covando un raffreddore potente, sicuramente colpa
di un autunno bolognese in anticipo e
del condizionatore del bus settato su
temperatura eccessivamente refrigeranti. La sua preoccupazione per la
performance della serata, però, non è
per la voce e il canto, ma per le parti
di tastiera di Amedeo, il quale intanto
se ne sta seduto con una tazza di te
caldo tra le mani cercando di combattere l'umidità. “Nelle nuove canzoni
ci sono ancora delle parti di tastiera che
Amedeo suona con qualche esitazione,
forse perché siamo all'inizio del tour e
le canzoni sono ancora fresche”. Chissà,
forse la preoccupazione deriva anche
dal fatto che normalmente Amedeo
suona di più la chitarra, lo strumento da cui derivava l'impronta sonora
dei primi Blonde Redhead. “Dal vivo
suono molto di più la chitarra”, precisa
lui stesso, “rispetto a quanto non abbia
fatto sul disco. Ma non è del tutto lineare capire in che direzione siamo andati
con il nuovo disco. Il fatto è che di ogni
canzone di Penny Sparkle abbiamo
tre, quattro, a volte cinque versioni differenti”. Forse un giorno sarà il caso
di preparare un bel box di alternate
takes e rarità, un atto di celebrazione che finora la band non si è mai
concessa. E se il modo di comporre è
rimasto lo stesso dall'inizio della carriera, potrebbe anche trattarsi di una
retrospettiva su svariati cd.
Quando i tre appaiono sul palco, l'Estragon è pieno come per le grandi occasioni. Kazu, Simone e Amedeo si presentano in bianco, illuminati da lampade
che ricordano delle lunghe candele. Le presenze confermate dell'organizzazione sono alla fine 1100, in perfetta continuità con le due tappe precedenti
di Milano (800) e Roma (1400). Osservando e mescolandosi con il pubblico si
capisce un po' meglio quale sia la vera abilità che ha tenuto i Blonde Redhead
in linea di galleggiamento per tutti questi anni. I tre hanno sempre saputo
filtrare in una forma originale e personale le istanze che hanno captato con
le loro attentissime antenne musicali, alla faccia di quando sostengono di
non venire influenzati da quello che ascoltano. O forse, nel loro caso, non si
tratta di vere e proprie influenze, ma di una capacità di riplasmare lo zeigeist
di un sound. E lo si intuisce osservando il pubblico, composto soprattutto
da appassionati della prim'ora, da quelli che hanno cominciato a seguirli con
La Mia Vita Violenta del 1995. Il titolo di quest'ultimo a ricordare le radici
italiane dei fratelli Pace (con un omaggio a Pier Paolo Pasolini), mentre la
15
materia sonora che si sviluppa dentro è un art-rock noiseggiante di chiara
matrice americana. Si tratta in realtà del secondo disco (l'esordio, omonimo,
è dello stesso anno), ma è il primo con la formazione a trio definitiva, dopo
l'abbandono di Maki Takahashi, e un disco ancora molto amato dai fan. L'estetica low-fi che lo pervade ha contribuito in maniera determinante a lanciare i
Blonde Redhead nell'empireo degli eroi indie, sostenuti anche dal canto straniante e graffiante della Makino. Gli episodi più riusciti sono probabilmente le
schegge garage (meno di due minuti) di I Am There While You Choke On Me e la
soffusa Young Neil. Alcuni hanno sostenuto che la miscela sonora proposta da
quei Blonde Redhead fosse un indie rock con un'attitudine math.Tutto si può
giustificare, e forse il math rock di quegli anni ha influenzato studenti di arte
e musica quali erano i membri della band all'inizio degli anni '90, ma a noi pare
più onesto pensare che i fratelli Pace e la Makino mettessero la loro perizia
16
strumentale al servizio della loro musica senza apparire nerd, in un'estetica in
bilico tra noise, art, Steve Albini e Thurston Moore.
Difficile comunque incasellarli, anche solo umanamente, in una qualche
categoria. Nemmeno quella di newyorkesi, di abitanti della grande città fatta
di meticciato razziale, di immigrati da ogni parte del mondo, quella città che
accoglie tutti coloro che hanno un minimo di talento (e volte nemmeno
quello) come la loro casa adottiva, una patria dell'animo (artistico). “Io e Simone siamo nati a Milano, mentre Kazu è nata in Giappone”, racconta Amedeo
avvolto dal suo maglione a righe con abbottonatura alla marinara, magari
comperato in una delle sue gite in bici per le boutique di Soho. “A New York
ci siamo soltanto trovati, ma almeno io non è che mi senta particolarmente a casa
in quella città. Mi capita di più di essere a mio completo agio in mezzo alla natura,
in un contatto diretto con lei”. Quasi di un ritorno alla vita selvaggia, nei boschi,
un'idea che ha sempre affascinato gli americani progressisti, da David Thoreau a Christopher MacCandless. Probabilmente sta qui, nella negazione
di alcuna appartenenza una chiave di lettura della prima parte della parabola
Blonde Redhead, di apolidi del suono e dell'estetica. La stessa negazione, si
trattava allora del pop, che contraddistingue il terzo episodio, Fake Can Be
Just As Good del 1997, il primo disco in cui davvero suonano come i Sonic
Youth in tutto e per tutto. I tre se ne fregano di poter essere considerati
degli epigoni e snocciolano otto schegge di rock spigoloso dominato dalle
chitarre abrasive di Amedeo e dal canto di Kazu Makino che a volte sembra
proprio quello di Kim Gordon. Il percorso si fa via via meno spigoloso a partire dal successivo In an Expression of the Inexpressable dell'anno seguente,
mano a mano che la voce della Makino trova una strada propria, tra Bjork
ed Elisabeth Frazer, mantenendo un'attitudine artatamente hippy. Ammorbidimento ancora più evidente nel successivo Melody of Certain Damaged
Lemons, il più accessibile fino a questo momento. Letti in prospettiva con
quello che è avvenuto dopo, possono sembrare preludi dei capovolgimenti
che si sarebbero concretizzati nel giro di pochi anni, quando i Blonde Redhead si accasano alla 4AD.
“Forse sono stati proprio loro dell'etichetta a vedere in noi un sound potenziale
per il loro roster, perché noi” racconta Amedeo mentre Kazu annuisce, “non
ci siamo mai visti come una band con quel tipo di sound. Poi può essere venuto
fuori qualcosa che si colloca in quell'area, ma non è stata una scelta consapevole”.
D'altra parte, la continua ricerca aperta a qualsiasi stimolo non prevede certo che si vada in studio di registrazione con delle idee preconcette in testa.
Ma tant'è che nell'effimera stagione della nu-wave, come veniva definito il
ritorno in auge di sonorità post-punk grazie a Interpol, Editors e compagnia, che anche il nuovo Misery Is A Butterfly è un compendio dell'aria che
tirava allora e che ha tirato per buona parte del decennio. Tramonta il lato
rumorista della band e emerge in tutto e per tutto un pop rock accessibile,
caratterizzato da atmosfere suadenti e dark. Non mancano alcuni momenti
più angolari e più propriamente rock, come per esempio Falling Man, ma sono
increspature in un sound che si sta spostando sempre più verso territori dream. Alle schiera dei santini si aggiungono ora Thom York e per certi versi
anche Arto Lindsay. Se per molti fan ha significato una sterzata inaccettabile,
Misery Is A Butterfly ne ha sicuramente raccolti per strada altri, provenienti
da altri percorsi. Di sicuro il sesto disco ha fotografato meglio di molti altri
un momento nelle vicende musicali del decennio, cogliendo gli aspetti essenziali di un'estetica che era in continuo movimento tra ambiti lontani e diversi.
17
Un'estetica cui ha contribuito anche l'aspetto dei tre musicisti: lo sguardo
liquido di Simone e Amedeo, incorniciato dall'argento che comincia a fare capolino tra i capelli neri e il look preciso; Kazu Makino con un aspetto sempre
da ragazzina, ingenua ma capace di graffiare. Un equilibrio delicato tra sogno
e concretezza, tra caos e ordine.
E dell'ideale lato b di quel disco, ovvero il successivo 23 del 2007, durante
la serata dell'Estragon viene salutata dal pubblico con grande calore Dr. Strangeluv, forse una delle canzoni che meglio di altre possono essere essere indicate come ideale ponte tra i primi e i secondi Blonde Redhead: la chitarra di
Amedeo è protagonista, ma è annegata dentro a un mare di synth che creano
un'atmosfera sospesa ed eterea, la circolarità della melodia è ossessivamente
psichedelica e sorreggono il tutto gli interventi misurati della voce della Makino. In quel disco trovavano spazio anche alcune tentazioni electro-pop, che
però dal vivo vengono messe da parte, in favore delle nuove composizioni,
che sul palco acquistano una consistenza tutta particolare. “La volontà in molte
canzoni di Penny Sparkle”, ci raccontava Simone al telefono da New York,
“era quella di creare uno spazio sonoro arioso e ampio, con pochi elementi che
interagiscono tra di loro, in modo che in quello spazio ci possa succedere qualcosa”.
Come se la materia impalpabile delle dieci tracce avesse bisogno dell'ascoltatore per essere del tutto efficace, come se le canzoni avessero quasi una
vita propria. Una vita spesso determinata da un certo suono e dal mondo
che quel suono evoca. Ma la scelta della strumentazione, di tutte le tastiere
che determinano il sound del disco non è avvenuta con questa logica. “Non
abbiamo scelto di usare una determinata marca di tastiere, per esempio una Casio,
perché ci ricordava la techno” ci racconta Amedeo nel tour bus. “Le tastiere le
abbiamo scelte semplicemente perché dopo averne provate tante, abbiamo trovato
il sound che ci piaceva per le nostre composizioni”. Ancora una volta si ritorna
alla musica come accidente, come causalità che succede e gode di un'esistenza propria, quasi indipendentemente dai musicisti.
Forse proprio per questa inafferrabilità continua della loro musica, del
continuo inseguimento di un sogno che esce dall'interazione tra le diverse
sensibilità dei membri della band, la produzione importante, molto presente
di Van Rivers e Subliminal Kid deve avere avuto un ruolo determinante nel
trovare un ordine tra le tante idee di Makino e soci. Già con 23 era stato
inevitabile parlare del famoso “tocco di classe” di Alan Moulder, uno che
ha messo le mani sulla musica di gente come Depeche Mode, Smashing
Pumpkins e Nine Inch Nails. Allora si era detto che Moulder aveva messo
le chitarre messe in secondo piano per dare spazio alla sua idea, nel complesso più inglese ed europea, fatta di synth e atmosfere retrofuturiste. Oggi, alla
luce di Penny Sparkle (a cui comunque Moulder a prestato i propri servigi
per il missaggio finale: “Ci eravamo trovati bene”, ci aveva raccontato Simone al
telefono), si può dire che quelle sonorità avevano e hanno radici più profonde
all'interno della ricerca dei Blonde Redhead. Soprattutto per Kazu, spesso il
motore primo di molte delle nuove composizioni, che nelle note stampe allegate all'uscita, ha dichiarato di essersi “innamorata della musica come di qualcuno
che si conosce da tanto tempo. Era tutto sospeso in un'atmosfera di sogno, anche se
a volte è stato burrascoso. A volte mi sono sentita come un pastore che cerca di radunare cinque stalloni in un recinto senza riuscirci. Ho avuto l'impressione di essere
un collegamento con tutti, come se io rimanessi ferma mentre gli altri mi ruotavano
costantemente attorno”. Ecco tutta la sensazione di vaghezza che pervade le
sonorità del disco, l'atmosfera eterea, in pieno dream pop da 4AD, checché
18
ne dicano gli stessi protagonisti. Ma
c'è anche una forza, dentro questo
percorso, che fa dichiarare ancora a
Kazu, che “se dovessi tornare indietro
nel tempo, [lo] rifarei esattamente allo
stesso modo”. In queste dichiarazioni
apparentemente sconnesse, che comunque fanno parte del personaggio
e dell'estetica naif del trio, ci pare di
intravvedere una verità. Perché se la
genuina ricerca del proprio suono
non si è mai fermata, per i Blonde
Redhead, così capaci di interpretare di pancia le vicende sonore che li
circondavano di volta in volta, non è
mai davvero arrivato il disco definitivo. Ma forse questo è impossibile
per il loro essere continuamente in
movimento, tra i suoni, tra le derive
del pop, tra questa sponda dell'Atlantico e quella americana, senza appartenere del tutto a niente. Si ha come
l'impressione che se i Blonde Redhead si fermassero, mettendo a fuoco,
cesellando, si perderebbe il delicato
equilibrio che li ha portati fino a qui.
Nel bene e nel male.
Nel frattempo, il concerto
all'Estragon è finito e noi siamo usciti dal locale assieme ai fan. L'aria è
ancora più fresca che nel pomeriggio,
ma fortunatamente non piove più.
Cercando di evitare l pozzanghere,
i fan si riuniscono in capannelli, da
quali captiamo brandelli di conversazione. Tutti sembrano soddisfatti
della performance e della resa sonora dei nuovi brani. Apprezzano anche
l'impatto scenografico delle luci, ma
si chiedono come mai non hanno
suonato quella o quell'altra canzone
di Melody of Certain Damaged
Lemons o di Fake Can Be Just As
Good, dandoci l'impressione che dal
vivo i Blonde Redhead siano almeno
in parte un affare per nostalgici dei
Novanta. Ognuno dei fan sembra
avere una propria idea della band, una
propria personale rifrazione luminosa che sembra scaturire da quel prisma sonoro. Come se non esistesse
una band, ma tanti Blonde Redhead
quanti sono gli ascoltatori e i cambiamenti che hanno attraversato. E tutti
quelli che ancora attraverseranno.
19
iosonouncane
—Democrazia del televoto—
Drop Out
Violento, irrispettoso,
frantumato, lucido. In una parola,
Iosonouncane. Ovvero come
sopravviere a una società in cui
tutto "è una gara, come al solito, tra
bionde e more"
Testo: Fabrizio Zampighi
20
G ente
da aperitivo
Il De Marchi è un bar fuori dal tempo. Almeno
per il sottoscritto. Ci compri delle bottiglie di birra da venti cl a poco più di un euro l’una. Un posto
per studenti, è chiaro, in una città come Bologna
che dagli studenti succhia tutto o quasi per poi
riciclarlo nei salotti “buoni” di Del Bono o Cofferati. Togliendo nel contempo sempre più spazio
proprio a quegli studenti che pagano cara la possibilità di frequentare l'università, in onore a una
concezione di quiete cittadina borghese, univoca
e probabilmente irrealizzabile. Se non ci credete
chiedetelo ai tipi del Locomotiv. Loro ne sanno
qualcosa.
Ma qui si parla d’altro, nello specifico di un
musicista trapiantato nella città felsinea da quasi un decennio: Jacopo Incani. E’ lui che incontriamo tra i tavoli del locale verso sera, per una
chiacchierata informale sul suo esordio ufficiale a
nome Iosonouncane, La macarena su Roma.
Giacca simil-militare, scarpe da ginnastica, sguardo
attento, idee chiare. Un sardo coriaceo, orgoglio21
dopo." Forza lavoro e sfruttamento,
diritti civili e sudore, nell'immaginario di una città – e di una regione,
la Sardegna, la stessa di Berlinguer e
Gramsci – che porta ancora i segni
delle sue origini. Con gli ingressi delle
vecchie miniere abbandonate sparsi
per il paese e le leggende su chi in
quelle miniere è morto a garantire al
luogo un'aura di esoterismo macabro
mica da poco, non bastasse una posizione geografica quantomeno singolare. Nasce qui Incani e la storia del
suo paese la manda immediatamente
a memoria. Come manda a memoria
i primi ascolti giovanili propagandati
dai genitori: i cantautori, i Pink Floyd,
i Beatles e i Rolling Stones. Quando
si dice il DNA.
A dieci anni ci si sposta a Iglesias,
comunità più articolata rispetto alla
piccola Buggerru, dove la musica diventa adolescente e il Nostro incontra i giovani sodali che finiranno per
confluire nei seminali Adharma.
Intanto sono scoccati i Novanta e il
lettore CD ha decisamente cambiato
Pacchetto tematico
Partiamo dall'inizio. Buggerru, re- stile: “A tredici anni ho scoperto gli Oacita la carta di identità. Sardegna Sud- sis. Rimasi proprio folgorato da (What’s
Ovest. Una gola tra il mare e le mon- The Story) Morning Glory?, non so il
tagne su cui si arrampicano un pugno perché. Ho smesso di giocare a calcio e
di case con una storia interessante ho iniziato ad ascoltare anche psichedealle spalle: “Buggerru è stata fondata lia di metà anni Sessanta. Con un amico,
a metà ‘800. I terreni erano della fami- poi, mi divertivo a spezzettare i brani di
glia di Modigliani, che li vendette a una altri e a ricomporli con un registratore a
compagnia francese. Questa compa- quattro piste. In seguito sono arrivati angnia scoprì che sotto le montagne c’era che i Radiohead, i Placebo, i Muse. Tutti
uno dei più grossi giacimenti di piom- gruppi della mia adolescenza”. E' frebo d’Europa e così cominciò a scavare quentando Thom Yorke e compagnia
chiamando operai da tutta la Sardegna che gli Adharma si fanno le ossa. Con
e dall’Europa. Nella valle i francesi co- un misto di Muse e Verdena che mastruirono le abitazioni per gli impiega- turerà in un rock con venature crosti delle miniere e nel giro di vent’anni sover prima e in un indie-rock con
Buggerru divenne una città da diecimila rimandi progressive-funk nella parte
persone, oltre che un centro culturale più importante della carriera. Quelcon aspirazioni europee. Nel 1904 ci la che la band comincia a Bologna, ai
fu una protesta gigantesca dei minatori tempi dell'università: “Con gli Adharma
che si concluse con l'eccidio degli stessi. facevo cose che mi piacevano ma che
Questo evento tragico portò la camera non sentivo proprio mie. In più allora
del lavoro di Milano a indire il primo avevo dei problemi ad accettare la mia
sciopero generale nazionale sei giorni voce. Mi vergognavo molto, sia della voce
samente proletario, i cui natali, come
impareremo di lì a poco, ricoprono
un’importanza notevole nel quadro
complessivo della proposta musicale,
almeno quanto la biografia. Alla fine
dei convenevoli si contano sei bottiglie sul tavolo, abbastanza per decidere di alzarsi, andare a mangiare
qualcosa di veloce e ripiegare verso
casa Incani, ché per l’intervista c'è bisogno di un posto in cui far scorrere
le idee senza filtri esterni. Quattrocento euro al mese per un monolocale dalle dimensioni ridottissime,
all’interno del quale spiccano un paio
di Groovebox, qualche tastierina giocattolo, un’Ephiphone acustica, una
loopstation, una drum machine e un
laptop.Tutto quello che serve per dar
vita alla canzone d’autore dirompente e all'elettronica fosca che ritroviamo all'interno del disco: home made
come l'etica punk impone, professionale come garantito dalle moderne
tecnologie domestiche.
22
23
che dei testi che scrivevo. Quando ho iniziato ad usare il campionatore mi sono
casualmente ritrovato a scrivere come
scrivo ora e a cantare come canto ora.
E’ stato un passaggio molto naturale”. Il
gruppo vorrebbe farsi adottare dalla
Bologna culturalmente più ricettiva,
guadagnare qualche ingaggio e arrivare a incidere un disco. In realtà le
cose si fanno piuttosto complicate
e se da un lato quel disco tanto atteso lo si incide sul serio per Jestrai
(Risvegli EP), dall'altro le dinamiche
interne alla band non reggono il peso
del nuovo contesto: “Eravamo tutti
compagni di liceo, tutti di Iglesias. Quando siamo arrivati nel capoluogo emiliano
credevamo molto ingenuamente che le
cose sarebbero state abbastanza facili
e che qualcuno ci avrebbe notati semplicemente suonando in giro. In realtà il
contrasto tra la vita in Sardegna e la vita
a Bologna ci ha messo in difficoltà. I rapporti si sono fatti più problematici anche
perché in giro a suonare ci andavamo
poco, pur avendo pubblicato un EP con
Jestrai. Nel natale 2007 io mi sono poi
reso conto che avevo mollato l’Università (Dams) senza laurearmi, stavo lavorando in un call center e l’unica cosa
che volevo fare era suonare dal vivo. E
così dopo otto anni ho lasciato il gruppo. In quel momento ho comprato un
campionatore, una chitarra amplificata
e ho cominciato a registrare materiale
per conto mio.”
Rewind. E' il 2004 e ci sono i Liars
a suonare all'Estragon. Incani è lì e
rimane folgorato. Batteria loopata
in diretta, suono violento, attitudine
anarchica, per un gruppo dal fascino
animalesco e certamente sovversivo
rispetto ai canoni del rock più tradizionale. E' la fisicità ritmica e provocatoria della band ad aprirsi un varco
nell'immaginario del Nostro. Nuovi
tasselli da sommare a quel mosaico
che andrà a costituire la base dello
stile musicale di Iosonouncane, assieme ai già citati cantautori (il Lucio
Dalla di Com'è profondo il mare,
24
il Fabrizio De Andrè di Storia di
un impiegato, il Giorgio Gaber di
Polli di allevamento, il Lucio Battisti di Anima latina) e al Syd Barrett dell'adolescenza.Accade un'altra
cosa, sempre nello stesso periodo. Un
Incani allora collaboratore di webzines musicali si invaghisce a tal punto
del Suzuki Bazuki dei Mariposa da
voler intervistare il gruppo di persona, dopo un concerto. Evidente il
significato intrinseco dell'episodio:
da un lato le analogie caratteriali con
l'ensemble di Orvieti, Giusti, Cimino,
Gabrielli, Canè, Fiori, Marchi (surrealismo, rottura degli schemi, creatività underground, matrice ideologica)
garantiscono un'intesa immediata e
un terreno fertile su cui crescere,
dall'altro l'evento stabilisce un ponte con le personalità della band che
gestiscono la Trovarobato (Michele
Orvieti e Gianluca Giusti). A loro Jacopo si rivolgerà – con la mediazione
di Daniele Calandra degli Addamanera – quando verrà il momento di
incidere l'esordio discografico.
Forward. Incani lavora in un call
center, non ha più un gruppo con cui
suonare e continua a trafficare con i
campionatori: “A luglio 2008 mi trasferii alla Bolognina e mi ritrovai a condividere con un amico una casa vecchissima, senza pavimento in bagno e senza
riscaldamento. In quel periodo lavoravo
in zona fiera e così il mio ritmo di vita
era scandito dal lavoro durante il giorno
e dalla stanchezza che mi costringeva
ad andare a dormire alle nove la sera.
Poi mi svegliavo alle quattro della mattina e registravo musica con le cuffie. Così
per un mese. E’ stato in quel periodo che
ho scritto i primi pezzi, partendo dalla
dimensione autobiografica, ma raccontando anche di altri. Per il mio primo disco volevo scrivere canzoni che fossero
in qualche maniera collegate tra loro”.
Una chitarra, degli appunti sparsi e
qualche frammento di suono. Non
esiste un metodo preciso per comporre un brano. Anche perché si fa
musica nei ritagli di tempo, togliendo
ore al sonno, quando l'insoddisfazione per un lavoro frustrante ti lascia
respirare. Basta un titolo o un giro di
chitarra per partire (Il famoso goal di
mano), un beat da tastierina giocattolo o un testo per un cortometraggio
mai andato in porto (La macarena su
Roma). Magari su un loop campionato,
alla ricerca di quell'elettronica in bilico tra Fennesz, Keith Fullerton Whitman e Flying Lotus (Il ciccione) che
giorno dopo giorno acquista sempre
più credito nella tua personale classifica di ascolti. Con un approccio ai
testi visivo, narrativo, ritagliato su un
contrasto continuo tra dettaglio e
campo lungo (Summer On a spiaggia
affollata, Il corpo del reato) e sui soliti noti, in fatto di scrittura: “Alla fine
i miei pilastri sono Syd Barrett e Brian
Wilson. Il primo per l’irregolarità negli
accordi, il secondo per le intelaiature degli arrangiamenti. Oltre a questi, citerei
l’approccio alla voce di Lucio Dalla, che
mi piace moltissimo”.
Prima libera associazione: i Massimo Volume. Nessun punto di
contatto tra il gruppo bolognese e la
parabola di Iosonouncane, né da un
punto di vista strettamente musicale,
né testuale, né generazionale. Eppure
c'è un elemento fondante che unisce
le due esperienze: la biografia. Da una
parte la figura dell'immigrato borderline che finisce sulla pagina scritta e nei
testi di un Emidio Clementi biografo
di sè stesso; dall'altra la sfera personale/lavorativa/esistenziale dell'Incani
che diventa il principale motore di
tutto il progetto. Certo, cambia l'approccio. Nel primo caso si racconta
in maniera lineare, ci si affida a una
musica descrittiva, non è necessario
un processo di interpretazione che
filtri la sovrastruttura; nel secondo è
proprio il punto di vista originale, la
personalità sopra le righe a costituire
un valore aggiunto.
Il modus operandi di Incani è quello
giusto, tanto che nel giro di poco si
25
collezionano sei brani da spedire in
free download (il Primo Pacchetto
Tematico Gratuito) sulla classica
pagina di myspace che nel frattempo
ci si è preoccupati di inaugurare –
con un gioco di parole che riprende
ironicamente il cognome del diretto
interessato – a nome Iosonouncane. Ci si accorge quasi subito che le
musiche deraglianti e i testi fiume in
oggetto hanno bisogno di respirare,
di uscire dalle quattro pareti intonacate di un appartamento e di farsi
ascoltare. Se non su disco – a quello
si arriverà poi -, almeno su un palco.
Anche perché la proposta è malleabile, scostante, fluida, suscettibile di
mille modifiche in corsa, ma soprattutto talmente provocatoria da poter
trarre giovamento da una dimensione live in cui giocare al rialzo. E' così
che nasce la versione delirante del
Teatro Canzone del Gaber naziona26
le a firma Iosonouncane. Come uno
sfogo ubriaco e senza reti di sicurezza, che macini al suo interno i call
center, la frustrazione per un lavoro
sottopagato, la violenza delle ideologie, la rabbia per una coscienza civile
pressoché inesistente: “Suonando certi pezzi mi sono reso conto che alcune
cose che avevo registrato a casa erano
canzoni nate sulla base di un’idea di
canzone alla quale potevo arrivare solo
seguendo determinati passaggi affrontati durante i live. Quando ho cominciato
a suonare molto dal vivo, le due dimensioni si sono toccate influenzandosi a
vicenda. Suonando ho capito quante
cose in più avevo messo nei pezzi in
casa, scrivendo e registrando quando
già facevo i concerti mi sono reso conto
di quali suoni avrei voluto portare dal
vivo e ancora non avevo portato”.Va da
sé che l'approccio scelto è di quelli
senza compromessi. Un coacervo di
urla, saluti romani, macchiette da talk
show, affiancati alla musica e sbattuti
in faccia a chi ascolta. Rappresentazione fedele di noi stessi: supponenti,
provinciali, falsi, ma anche aggressivi,
spaventati dal diverso, ben contenti
di rinchiuderci in forme di socialità
pre-costituite come gli aperitivi. E
quando qualcuno ce lo fa notare, le
reazioni sono tra le più disparate: “In
alcuni casi vedo che il pubblico apprezza
molto, altre volte ho rischiato che i toni
provocatori che uso durante i concerti
non venissero compresi. Di base credo
che le mie esibizioni non siano di facile approccio, vuoi perché musicalmente
non sono accomodante, vuoi perché ogni
tanto c’è anche bisogno di interpretare
quello che si vede e si ascolta. Cogliere l’ironia. Del resto voglio la libertà di
esprimermi, anche a costo di rischiare
qualcosa. Anche se in realtà il problema
dell’interpretazione di quello che faccio
cerco di non pormelo. Quando scrivo La
Macarena su Roma dal punto di vista
di un italiano medio che guarda la tv,
fa zapping e dice io sto bene da solo
ecc…vado a sviscerare quei piccoli incastri quotidiani che mi rendo conto essere
anche i miei. Sarebbe troppo facile muovere una critica verso gli altri senza fare
autocritica.”
Il riferimento alla sfera politica c'è
ed è evidente. Ma è una politica del
sopravvivere, del quotidiano, nascosta
tra gli isterismi ruvidi e declamati che
fanno da carburante a tutto il materiale. Niente di paragonabile, per dire,
alla nostalgia falce e martello degli
Offlaga Disco Pax (seconda libera
associazione) con cui si recupera invece un immaginario, lo si coibenta
attraverso il ricordo personale e lo si
dà in pasto al pubblico. Qui è il teatro
delle miserie quotidiane a prendere
il sopravvento, in un autocritica costante che non si accontenta dell'appartenenza ma vuole andare oltre.
E' al release party dell'ultimo, omonimo, disco dei Mariposa che Jacopo
Incani calca per la prima volta un
palcoscenico importante. Tocca a lui
aprire al Locomotiv per la band bolognese, ma non tutto gira come dovrebbe. Del resto manca l'esperienza, la consuetudine nell'utilizzo delle
macchine, la lucidità per affinare gli
interventi e legarli con i brani o magari solo un occhio critico che possa
suggerire la direzione da prendere.
Da quel momento in poi, tuttavia, le
cose cominciano a funzionare, come
dimostrerà anche un Indipendulo
2009 al M.E.I. affrontato col giusto piglio (“E' andata molto bene. Il pubblico
ha reagito positivamente”)
L' orchestrina
incalzante
E si arriva all'esordio ufficiale. Le
registrazioni sono fissate per luglio
2010 a Bologna presso lo Studio Spaziale e la spina dorsale de La Macarena su Roma è ovviamente il Pri-
mo Pacchetto Tematico Gratuito.
I pezzi già scritti vengono rielaborati
ma non cambiati radicalmente (“In realtà vorrei continuare a registrare i dischi
in casa, per poi andare in studio a mixare e a masterizzare”), se ne aggiungono altri (l'amarissima Il corpo del reato,
la molle Il Ciccione, la scapicollante Il
boogie dei piedi, l'onirica Giugno), si dà
il giusto rilievo a qualche monologo
particolarmente riuscito (I superstiti)
o a qualche campionamento felicemente alieno (Rifacciamoci la bocca coi
cibi buoni di Gusto). Lo scopo è rendere tridimensionale il suono, pur mantenendosi nei paraggi dell'approccio
casalingo che caratterizzava il demo
originale. Alla fine il risultato soddisfa, nell'ottica di una maturità che se
musicalmente è ancora al primo step,
nei testi mostra già una concretezza
invidiabile. Naturale conclusione di
un percorso a tappe che assomiglia
a un romanzo di formazione un po'
incasinato, in cui ogni elemento, alla
fine, va al posto giusto. Tanto che,
arrivato a questo punto, anche il diretto interessato ammette di volersi
fermare un attimo per valutare con
un minimo di distacco quanto fatto e
come evolvere. Tra gli obiettivi, lavorare sull'aspetto musicale con più calma, magari sfruttando il tour che lo
occuperà a tempo pieno da ottobre
2010 (per le date c'è la pagina eventi
di sentire ascoltare).
Rimane il tempo per un ultimo
scambio di battute e ne approfittiamo per chiamare in causa gli Uochi
Toki (terza libera associazione). I
terreni musicali sono evidentemente diversi, ma accidentati allo stesso
modo, in un tripudio di frantumazioni ritmiche, campionamenti, rumore.
E poi in entrambi c'è quell'idea di
scrittura elaborata, maniacale, decisa
a dare ad ogni singola parola il giusto peso: “Gli Uochi Toki mi piacciono
molto. Poi sono un fan sfegatato di Dargen D’amico, anche se nella musica che
ho prodotto fino ad ora non c’è traccia
di questo tipo di influenza. Del resto lo
ascolto solo da un anno. Credo che abbia una profondità enorme, ad esempio
in brani come Moderata Crisi, e mille
livelli di interpretazione. Mi piacerebbe
in qualche maniera collaborare con lui
un giorno…”
27
Tremate, tremate le streghe
son tornate
—Salem, White Ring, oOoOO,
Balam Acab, Modern Witch,
Mater Suspiria Vision, //Tense//,
CREEP—
E
Drop Out
Estetica hauntologica, immaginario
esoterico, synth-pop virato dark e
beat house andati a male. In più
sigle criptiche e occultismo 2.0.
Tutto questo è il witch-house,
l'ennesimo trend del sottobosco.
Testo: Stefano Pifferi
28
ra ovvio che quel fenomeno, più o
meno circoscritto e/o riconoscibile definito hypnagogic-pop o, nelle
sue infinitesimali varianti, glo-fi o
chillwave, mostrasse il lato oscuro e perverso. Quella estetica della ricordanza, fatta di
memorie di memorie e slittamenti sfocati di
significato ha virato il proprio asse portante
al nero dell’incubo horror e della reverie più
angosciosa, trovando paradossalmente nella
stagione del sole e della luce la sua esplosione. È di questi ultimi mesi infatti l’ennesimo,
nuovo trend mediatico proveniente dal più
tetro underground e definito a vario titolo
nel microcosmo online. Tra le più affascinanti, proprio witch-house. Gioco di parole che
rievoca due componenti essenziali in questa
nuova (vecchia) onda: l’occultismo di base e
l’esoterismo etimologico, ma anche, musicalmente, una versione “posseduta”, maledetta
e scarnificata della house.
Palme che si stilizzano in piramidi nere,
geometrie che creano spigoli appuntiti, suoni
che imputridiscono fino a marcire. Incubi semi-horror ed evanescenza ai massimi livelli la
fanno da padroni. Esoterismo e nascondismo
2.0. Chiedere rispettivamente a Tri-Angle e
29
salem
30
Disaro, label di riferimento per il neo(sotto)genere: la prima (titolare è Robin
Carolan del blog 20 Jazz Funk Greats) è un tripudio di grafica ossianica
e grado zero dell’informazione; la seconda, pregnante esempio di deviante
nascondismo nell’era dell’occhio orwelliano ed estetica di riciclo. Label distanti e diverse ma accomunate da una estetica mutante in grado di deviare
le istanze glo-hypna verso lidi disturbanti in cui convivono forme estreme di
hip-hop, wave gotico-esoterica, synth-pop che più robotico e dark non si può
e hauntology oscura.
Tutto intorno una scena, per quanto impalpabile perché legata ai bit del
flusso internettiano, alla versione da sottobosco del myspace (soundcloud
e bandcamp su tutte) e alla delocalizzazione da un vero e proprio centro
geografico, sta piano piano prendendo il sopravvento, finendo anche con l’avventurarsi in circuiti mainstream dell’informazione come Rolling Stone e The
Guardian.
A partecipare a questo sabbath della memoria 80s una serie di band dai
moniker oscuri, inintelligibili, criptici a dir poco, fatti di slash e asterischi, croci
e triangoli, tutto in grafica povera; come se il rifiuto di un nome comprensibile
fosse la nuova frontiera di chi si occulta “anche” agli occhi del sottobosco
indie, rendendo impossibile qualsiasi “googleata”. ▲, †‡†, Gr†ll Gr†ll, oOoOO, //Tense//, Pwin ▲ ▲ Teaks, †NO VIRGIN † e letteralmente una marea di altri, è tutto un florilegio di simbologia e geometrie da iper-ermetismo,
come se nella migliore delle ipotesi i ventenni di oggi avessero scoperto le
infinite possibilità della tastiera. Oppure, nella peggiore, avessero applicato al
sottobosco indie la neolingua adolescenziale da sms/chat.
Inutile parlare di discografia per progetti che vivono quasi esclusivamente online, ma l’immaginario collettivo è un tripudio di geometrie, piramidi,
angoli acuti e sfarfallio di immagini eighties-pop mirabilmente rese da collettivi di video- e film-maker in bassa fedeltà come Mater Suspiria Vision/
Cosmotropia De Xam, Aids-3D e filiazione tutta, in una sorta di ciclo di
Creamaster girato in una discarica post-industriale infestata che riprende il
futuro ipotizzato e sognato negli 80s. Il legame tra musiche e immagini (video
e grafiche) è inscindibile: i collage tardo-adolescenziali delle copertine dei
cd-r o la slow-motion di fotogrammi rubati dal trash televisivo degli ultimi 30
anni si sposano idealmente con il riciclo al negativo di una memoria acquisita
e non vissuta.
Accanto ai nomi meno noti, alcune band più intelligibili si stanno facendo largo. Nomi come Balam Acab, White Ring, Modern Witch, Creep,
Water Borders o i citati oOoOO, dovrebbero essere familiari a chi bighellona per le estremità nascoste del web. Accomunati in una “scena”additata
coi nomi più disparati (drag, haunted house, screwgaze, cave crunk, ghost juke)
tra i quali il più gettonato tra i bloggers è witch-house, offrono uno spaccato
piuttosto vario per sonorità: si va dal dubstep a quello più ambient mefitico,
al dark o ancora alle eteree atmosfere di matrice shoegaze-goth per finire
addirittura al versante ebm-oriented o limitrofo al pagan-folk.
Sonorità diverse accomunate da un senso di imminente minaccia, cavernosi echi, beat sintetici e da un impatto visionario. A far da collante, tanto da
essere riconosciuto come vero e proprio capostipite del genere, è un progetto americano paradossalmente assurto al ruolo di culto su magazine patinati
per ragioni che esulano dal portato musicale: il solito gossip r’n’r fatto di vizi,
droghe pesanti, omosessualità e scandali sui generis.
Salem, questo il nome scelto da tre twenty-something di Traverse City,
31
Michigan, Heather Marlatt, John Holland e Jack Donoghue, con quest’ultimo di base a Chicago. Nome evocativo e d’impatto, ma non secondo
i tre che minimizzano le ragioni della
scelta trincerandosi dietro una ingenuità che puzza di artefatto: Salem
suona bene ed è anche un bel posto,
ci confessa Heather, col sodale John
a farle eco: Lo scegliemmo molto tempo fa e quando un nome suona bene
anche dopo 5 anni è da paura no? Il
riferimento rimanda alla città tristemente famosa per la caccia alle
streghe e la scelta si rivela ideale
per evocare un immaginario di occultismo e irregolarità borderline
che si tramuta musicalmente in un
evanescente e sfocato mix: shoegaze impalpabile, techno minimale,
effimera pomposità blackmetal e
dubstep greve e cavernoso, il tutto
white ring
32
condito con voci ethereal alla 4AD
o mutanti da hip-hop bianco da sobborgo urbano. Proprio il contrasto
tra le suadenti atmosfere oniriche
delle vocals di Heather e il vocione cadenzato su base juke di Jack
(Quando rappa riesce ad abbassare il
ritmo e finisce col somigliare ad uno del
ghetto, dice John) sono il segno più
evidente di un sound che sfugge e
insieme rimiscela influenze e rimandi tra i più distanti. Se esiste un posto in cui possono convivere Oneohtrix Point Never e Burial, Cocteau
Twins e hauntology made in Ghost
Box, quel posto è King Night.
In apparenza fuori contesto, è il
sostrato rap o hip-hop rintracciabile nelle ritmiche cadenzate e obnubilate a sorprendere e a portare a
galla passioni giovanili mai sopite e
esperienze pregresse in ambiti juke e
ghetto-house chicagoana: È l’aspetto
percussivo quello che più mi interessa
nella musica, conferma Jack. Sin da ragazzino ho sempre ascoltato rap e hiphop, soprattutto per le ritmiche, tanto
che da quel punto di vista lo considero
un genere in continua evoluzione. Non
è un caso che gli artisti che più mi influenzano ora sono per lo più producer
rap come Drummaboy, Araabmuzik, dj
Nate. Anche John aveva un progetto
juke-disco, Whore-Ce, col quale si
divertiva a comporre folli canzoni da
discoteca nelle nottate casalinghe a
base di speed. In merito all’importanza del rap/hip-hop per Salem è, però,
piuttosto evasivo nonostante abbia
spesso citato Three 6 Mafia, Twista,
Lil’ Wayne come influenze: Di solito
non mi preoccupo di quale tipo di musica sto ascoltando o dalla quale sono
influenzato, quanto di “cosa” è quella
balam acab
canzone, come suona, la sua melodia e
la sua struttura.
A differenza della iperproduzione
tipica da 2.0, Salem ha una gestazione lenta. Pochi e brevi vagiti sparsi nel
giro di un paio d’anni, da aggiungere ad
una serie di tracce singole o remixate abbandonate nell’impalpabilità del
web o a qualche oscura compilation.
Dopo il cd-r Fuckt su Disaro (some
goth kids get a hold of early Three Six
Mafia, si leggeva online su quella raccolta di pezzi), l’esordio “vero” arriva
nel 2008 col 7 pollici Yes, I Smoke
Crack per Acéphale. Quattro pezzi
di heavenly voices, beat sintetici e
estetica hauntology, seppur ancora
in forma prodromica lanciano il proverbiale campanello d’allarme tra gli
addetti ai lavori.
L’anno scorso la band ha spinto
sull’acceleratore, proponendo un
trittico di uscite, ovviamente tutte
sold out. Water (Merok Recs), OhK
(Big Love) e Frost (Audraglint) sono
un percorso di avvicinamento ad un
sound personale, grazie ad un lavo-
rio anche sugli stessi pezzi (Redlights,
Sweat, OhK tornano spesso in forme
mutanti) che ne ripensa spesso i dettagli lasciando intatta la base di partenza: un synth-goth virato glitchyhop che crea brulle e desolate lande
di gelida pop-music per novelli dark
da cameretta.
Fino a poco tempo fa – dice Heather in merito al culto creatosi attorno a loro – non sapevo ci fosse altra
gente che fa musica simile alla nostra,
ma con questo non voglio dire che abbiamo iniziato noi. Di sicuro non ho nessuna intenzione di far parte di un movimento o di una scena. Se ci sono altre
persone ispirate da ciò che facciamo, ok,
buon per loro. I tre sono però concordi nel considerare la propria musica
non come una semplice evoluzione
al negativo delle istanze hypna-pop
(Heather: non credo che sia l’opposto
di nulla, no), quanto una sorta di personale catarsi su pentagramma: se
John afferma che la propria musica
proviene spesso da un luogo di profonda tristezza, Jack ribatte: Ciò che mi
piace della nostra musica è che copra
un ampio spettro di situazioni di vita e
sentimenti, così che se ci sono momenti
negativi o tristi, c’è anche un forte senso
di speranza e abbandono.
Affermazioni che ci trovano in
parziale disaccordo soprattutto per
il tentativo di smarcarsi dalla neo“scena”. L’humus da cui prende le
mosse tutto il variegato movimento
che abbiamo descritto finora è proprio quello dell’hypnagogic, ossia una
deviata e malata rievocazione degli
80s. Nel fenomeno witch-house però
quell’immaginario è virato al nero,
piegato verso l'incubo e rievocato
spesso e volentieri con l'ausilio di
video e immagini sgranate, in slowmotion, roboticamente reiterate.
Pronto a mostrare l’altra faccia della
medaglia di quello scintillante e illusorio decennio, il suo lato oscuro.
33
Breve geografia
in 10 mosse
witchy
W hite R ing
Duo di Brooklyn formato dal synthetico beat maker Bryan Kurkimilis e dalla novella chanteuse Kendra Malia e tra i
più goth del lotto. Avvolti da un manto brumoso e circondati da simboli runici, i due hanno esordito lo scorso marzo
con un 7 pollici condiviso con i sodali oOooO, edito dalla svedese Emotion. Sul loro lato sguinzagliavano Roses, quattro minuti per bassi molesti, rullanti taglienti, synth apocalittici ed il mesto, confuso cantato di Kendra. Pochi mesi ed
è tempo per un nuovo singolo: Suffocation, il loro pezzo migliore, esce per la canadese Hi-Scores Recording Library
su vinile corto e in digitale con ben cinque remix aggiuntivi, tra cui anche uno ad opera di Mater Suspiria Vision, altro
quotato nome del giro. A fine ottobre il primo tour europeo del gruppo, ovviamente solo in UK. (Andrea Napoli)
o O oo O
Il moniker sotto cui si cela Christopher Dexter Greenspan è tra i più criptici e quindi emblematici della nuova sottocorrente. La prima creatura viene licenziata ad inizio anno da Disaro, etichetta che si è imposta come punto di riferimento per tutta la casa delle streghe. Un cd-r con sei brani tra cui spicca la cover di un vecchio pezzo disco-funk
come Summertime, Summertime dell’italo-americana Nocera, qui riadattato sia nel titolo (NoSummr4U) sia nel sound
che si fa assai prossimo ad un altro tormentone di recente fattura, il glo-fi. Segue il singolo split con i newyorkesi
White Ring di cui abbiamo già detto e ora è di imminente pubblicazione un EP su dodici pollici per Tri Angle che se
porterà a maggiore compimento le tracce fin qui seminate sarà di sicuro una tappa obbligata. (AN)
M ater S uspiria V ision
Una delle realtà più interessanti ed eccentriche del giro, partendo dal nome, passando per le grafiche trash-glam, per
giungere all’incredibile numero di video-clip autoprodotti che affollano la pagina myspace. Autori di una serie sconfinata di micro-uscite su cd-r, cassetta, dvd-r e finanche vhs, sempre tirate in una cinquantina di copie al massimo, il duo
composto da soggetti rispondenti a nomi quali ℑ⊇≥◊≤⊆ℜ e Cosmotropia De Xam è artefice di un sound claustrofobico come pochi. Linee di basso pesanti come macigni, campioni di inquietanti voci infantili ed apocalittiche ritmiche
marziali fanno il paio con grafiche da magazine di moda deturpato e titoli che non si vergognano di abusare di parole
come witch, crack e tutto il nuovo immaginario d’ordinanza. (AN)
//Tense //
L’opera del duo (trio dal vivo) di Houston è quanto di più lontano ci sia da canoni, per altro dettati da pochissimo,
della witch house. La musica dei //Tense// è infatti pura reinterpretazione di quel sound Industrial Dance/EBM che
vent’anni fa fece il successo di una label come Wax Trax!. E allora perché il nome ricorre spesso sulle pagine web dei
soggetti in questione? Semplice, perché ancora un volta è la texana Disaro ad averci messo lo zampino, pubblicando
il cd-r Consume, dopo che la francese Desire aveva già licenziato l’album Memory, prima in CD e da poco anche in
LP, a breve distanza dal nuovo EP Introducing. Per chi avesse poca dimestichezza con la materia, si tratta di un’elettronica smaccatamente anni ’80-’90, connotata da pensanti beat meccanici, voci incalzanti e liquidi giri di synth. La
versione primigenia di quello che oggi va sotto il nome di drag. (AN)
†‡†
Altro nome criptico, altro giro di infiniti remix e pezzi sparsi online. Influenzato in parti uguali da acid-house, 80s new
wave, 90s dance, goth rock, hip-hop, noise, 2nd wave of black metal, geometry (?!), il ragazzetto che si nasconde dietro
l’alternanza di croci e doppie-croci va di ritualità e occultismo come se piovesse. Chiuso nella sua cameretta, col solo
ausilio di pc, qualche filtro e microfoni modificati, †‡† frantuma l’immaginario goth anni ’80 a forza di white noise di
fondo, sinfonico procedere black-metal e iniezioni di ebm marcia e rallentata al massimo suffragando la definizione
di “gothic chillwave” con cui è stato etichettato online. Imminente l’esordio in cd-r sull’immancabile Disaro. (Stefano
Pifferi)
CREEP
Trip-hop e rape-gaze campeggiano sul myspace dei Creep, progetto al femminile formato dalle djs newyorchesi Lauren Flax e Lauren Dillard, ma non c’è molto da fidarsi su chi si nasconda veramente dietro la sigla Creep. Di certo
c’è la musica, che si muove sul versante più sognante, seppur sempre angsty, dell’intera faccenda. Roba limitrofa alla
minimal-techno più ossianica o al synth-pop più esoterico, dilatato e dreaming che si configura a volte come un glitchpop dalle forti tinte dark, altre come una sorta di versione horror dei Cocteau Twins. Titoli come Empty Church o
Jessica King non sfigurerebbero affatto in qualche b-movie horror d’antan. Le ragazze si offrono anche come remixers
(tra gli altri, anche di Memory Tapes) e il prossimo 7” per TriAngle prevede Romy dei The xx alla voce. (SP)
M odern Witch
La sigla Modern Witch è appannaggio di Kristy Foom, Mario Zoots e Kam Khan, trio formato a Denver un paio
di anni fa dai primi due e con all’attivo una cassetta autoprodotta (Comfort Noise del 2009) e un cd-r untitled per
la solita Disaro. Sound eterogeneo che spazia da una sorta di electroclash sedata ad un synth-pop claustrofobico e
mutoide, che sfocia facilmente nella minimal-wave più horror cantata sporadicamente da una Nico ventenne. Tutto
un trionfo di beats, drum-machine dei primordi, synth di seconda o terza mano ossessivamente reiterati. Un tempo
si sarebbe definita cold-wave. (SP)
P win ▲ ▲ Teaks
Se intitoli un pezzo The Secret Hypnagogic Dreams Of Laura Palmer (nello specifico il cd-r split con Hobo Cubes su
Hobo Cult recs) o Beyond The Red Room hai già detto molto, se non tutto, del tuo universo di riferimento. Alla base
delle musiche del geniale moniker c’è una visionarietà filmica lynchana, che slabbra il potenziale horrorifico del glo-fi
notturno in “a night of hypnagogic dementia”, come recita la press. Una manciata di release, quasi tutte in formato
cassetta, come l’appena uscito split a 4 su Mind Magnetic, fanno di Pwin Teaks uno dei nomi “gelidi” di questa nuova
onda. (SP)
G r † ll G r † ll
Voci campionate al ralenti, battuta bassissima e drogata, ritualismo di matrice esoterica e codici alfanumerici a nascondere/confondere ancor di più l’immaginario ebm contorto e sfasato di questo solo-project di cui nulla più della sigla identificativa è dato
sapere. In verità qualcosa si sa, tipo nome e cognome, Martin Noermann, e provenienza, Danimarca, ma non ci metteremmo la
mano sul fuoco. L’unica traccia discografica – il cd-r self-titled su Disaro, tanto per cambiare – evidenzia un retrogusto old-school
industrial tra i più pesanti dell’intero lotto, tra brume Burning Star Core, folate di rumore bianco sempre in modalità riverberate
lo-fi e voci possedute dall’anima venduta al diavolo del black-metal nord-europeo. Scheletriche architetture dark-noise che speriamo escano in forma più definita. (SP)
B alam Acab
Progetto solista dello studente ventenne Alec Koone che, dopo anni di registrazioni noise e drone in cameretta, ha
cominciato a sperimentare incalzando i sample concreti di sempre con nuovi beats rudimentali, arrivando subito ad
attirare l’interesse della neonata, ma già emblematica, Tri Angle. Come già accennato nell’ultimo Gimme Some Inches, See Birds è il primo EP del nostro e imbastisce in sei pezzi scheletriche strutture dubstep, eteree come Mount
Kimbie, astratte suggestioni ambient e sfuocate immagini sonore à la Ducktails. Il 12 pollici spopola tra i network
dell’elettronica corrente tanto da essere momentaneamente sold out e per ora non sono annunciate nuove uscite.
L’headliner sul Myspace di Koone però parla chiaro: “No witches in this house!”. (AN)
34
35
Recensioni
— cd&lp
highlight
AA. VV./Gonjasufi - The Caliph's
Tea Party (Warp Records, Ottobre
2010)
G enere : elettronica / psych
Eravamo molto curiosi di questi remix di A Sufi And
A Killer. E per la peculiarità della voce di Sumach - alla
prova con qualcosa di diverso dallo psych&vintage cucitogli addosso alla perfezione da Gaslamp Killer (e alla
prova essa stessa, come materia prima da manipolare)
- e per la qualità dei nomi coinvolti. In sintesi? Progetto
sontuoso ma poco sostanzioso. Il Sufi-rimaneggiamento
non riesce del tutto, la voce finisce spesso con il cozzare
con le (ri)produzioni e il risultato non suona bene come
potrebbe sulla carta. Scorriamo la tracklist.
La minacciosa liturgia ambient di Mark Pritchard
(Ancestors), il pauperismo vintage di MRR (Holidays) e
il casino psych/terzomondista di Dem Hunger (SuzieQ) sono numeri fuori fuoco. C'è buon mestiere: Bibio
che mantiene il piglio funky dell'originale (Candylane),
l'heavy wonkyzzazione di Jeremiah Jae (Kobwebz), lo
shuffle ossessivo di Bear In Heaven (Love Of Reign), il
ralenti deformante di Oneohtrix Point Never (She's
Gone). Ci sono ottimi il tiratissimo electrofunk-ragga di
Dam Mantle (Ageing), la vera e propria trasfigurazione
di DedN a opera di Broadcast & The Focus Group
(detriti bucolico-psichedelici, arpeggini e pizzicamenti
esotici, harpsichord, percussioni tribali), la rarefazione
dubstep di Shlohmo (Change), il remake di My Only
Friend (b-side off-album di Kobwebz) firmato Hezus,
l'ostinato muro di synth della DedN di agdm. Ecco, sono
proprio le produzioni di quest'ultimo, sempre in coppia
con Gonja, quelle che aspettiamo adesso.
(6.2/10)
Gabriele Marino
Abe Vigoda - Crush (PPM, Settembre
2010)
G enere : wave
I veterani dello Smell, il quartetto di mezzosangue che
ci aveva sorpreso con un caleidoscopio di colori a tinte
forti qual'era Skeleton, torna col nuovo album e ci spiazza
nuovamente.
Se quel disco era un torrido caleidoscopio tropical36
punk, Crush annerisce la tavolozza, tanto è pervaso da
una predominanza di toni tendenti al grigio della wave
più minimale e fredda. Certo, le avvisaglie c'erano state
nel mini Reviver e nell'avvicendamento alla batteria tra il
dimissionario Reggie Guerriero e il nuovo Dane Chadwick, ma sinceramente non ci saremmo aspettati una
sterzata così brusca.
È tutto l'universo di riferimento ad essere cambiato
radicalmente. Synth-pop, cantato di stampo bowieano
(periodo berlinese, per intendersi), florilegio di bassi
cavernosi e ritmi da disco-beat d'antan, atmosfere tra
goth e new romantic, riverberi e delays a dar cupezza e
profondità al suono. Insomma, più che ad un iridescente
e solare frullato punk tropicale, Crush sembra rimandare
alle operazioni di recupero wavey di acts come Xiu Xiu.
Repeating Angel, Throwing Shade o Dream Of My Love non
lasciano adito a dubbi: gli 80s più scuri son lì, non più
dietro l'angolo ma nettamente in primo piano, tanto che
si stenta quasi a riconoscerli.
C'è da chiedersi il senso di una operazione del genere.
Ruffiano annusare dei trend del momento? O libertà creativa spinta ai suoi massimi livelli? Una possibile chiave di
lettura ce la offre una discografia che non ha mai tentato
di replicare una formula acclarata, ma si è sempre spinta
oltre. Certo, mai con una svolta repentina come quella di
Crush. Per ora giudizio sospeso.
(6.9/10)
Stefano Pifferi
Aeroplane - We Can't Fly (Eskimo
Recordings, Ottobre 2010)
G enere : disco O ttanta
Già con l'ultimo Chromeo abbiamo fatto fatica ad arrivare alla fine. Ecco che ci arriva oggi un'altro lavoro
infarcito con quei suoni anni Ottanta retrofuturistici. Il
duo italo belga formato da Stephen Fasano e Vito De
Luca aveva fatto gridare al miracolo nel mix per la rivista
Mixmag di qualche tempo fa. Quel disco suonava fresco
e balearico; ricordate quanto fossero fuori tempo massimo e per questo super attuali?
Oggi tornano esaltati da Pitchfork (che si gasa per il singolo electro reggae funky che dà il nome all'album) e
riportano ancora una volta sul banco del mercato i suoni
Black Angels (The) - Phosphene Dream (Blue Horizon Records,
Settembre 2010)
G enere : P sycho R ock
Dici Black Angels e ti vengono in mente gli altri "Black", quelli che proprio in questi giorni pubblicano
l'atteso Wilderness Heart. Due collettivi di stonati che, oltre a metà del moniker, condividono un amore incondizionato per la psichedelia dei tardi 60s e le pesanti trame lisergiche post sabbathiane. Significativo che i due gruppi si siano dati appuntamento per un'ideale Battle Of the Bands che i Black Mountain
affrontano confidando nella tradizione folk, imbastendo un hard prog pragmatico, grazie al quale riprendono contatto col pianeta Terra.
Dal canto loro gli Angels abbandonano parzialmente i raga circolari del precendente Directions To See
A Ghost, ma finiscono per scolpire un suono austero e marziale che sembra indifferente alle pene terrene. Officiano un rito della cui sacralità sono
stati custodi gruppi come Jefferson Airplane, The 13th Floor Elevators
e Pink Floyd: una celebrazione mistica dell'epopea psichedelica, del suo
potere di immaginare paesaggi maestosi e sconvolgenti. Magari non sempre
caldi e assolati, ma sempre suggestivi e dannatamente reali.
Bad Vibrations apre il disco, ma si pone idealmente al centro dell'intero album:
un'omelia oscura che mette mano all'anima nera del sogno hippy. Alex Mass
vi canta in una sorta di trance sciamanica, con quella che sembra un ideale
punto di incontro fra la vocalità statuaria di Grace Slick e quella emotiva di Neil Young. Il drumming
tribale e gli accordi lividi generano una tensione che si stempera improvvisamente in una cavalcata verso
gli infinti spazi. Si tratta di un brano che funge da modello a tutto quello che verrà in seguito: le infinite
varianti di uno psycho folk elettrico, rimodellato di volta in volta sul simulacro di un beat diafano (Sunday
Afetrnoon), di un deragliante space rock (River Of Blood), di un mantra barrettiano (Yellow Elevator #2) e di
chissà che altro.
Compatto e scuro come un monolite, Phosphene Dream è l'opera di un gruppo che non si limita a
riproporre logori stilemi, ma ha l'ambizione di aggiornare un linguaggio, l'unico che funga da appiglio allo
smottamento del rock dallo panorama odierno. Una musica perennemente in bilico fra trascendenza e
pulsioni ataviche: una dicotomia che mette l'ascoltatore in uno stato di soggezione. Difficile andare oltre
giocando con le stesse carte, problema che loro stessi dovranno affrontare nel momento in cui decideranno di dare un seguito a questo capolavoro.
(7.8/10)
Diego Ballani
anni Ottanta e un po' di progressività che vorrebbe rifare
il buon vecchio Prins Thomas. I rimandi ve li cediamo
volentieri: scoprire da dove han preso i coretti, le chitarrine e le tastierine è solo questione di minuti. La rielaborazione di quegli anni da bere ormai inizia a puzzare di
vecchio. Dopo qualche giro di giostra non ce la facciamo
più ad avere sotto gli occhi le immagini di Spagna, Sandy
Marton e le brutte copie dei Daft Punk di Discovery. Il
mestiere c'è (hanno remixato gente del calibro di Grace
Jones, Friendly Fires e Sebastian Tellier) ma ho (t)tanta
voglia di cambiare.
(5/10)
Marco Braggion
37
Aloe Blacc - Good Things (Stones
Throw, Settembre 2010)
G enere : vintage bl ack
Aloe ci ha folgorato a inizio anno con una canzone speciale, uno di quei pezzi capaci di diventare immediatamente un tormentone e di restare tali senza mai venire
a noia. Parliamo di I Need A Dollar, sigla della serie tv
How To Make It In America. Ha bissato poi qualche mese
dopo con una commovente versione di Femme Fatale dei
Velvet Underground. Insomma, ci ha pompati alla grande
Aloe per questo suo secondo album.
E il disco - prodotto benissimo, con dinamico spirito vintage, dal duo Truth&Soul - è davvero un gioiellino black,
intenso e compostissimo, dominato dalla sua interpretazione generosa e dai ritmi r'n'b del piano, equamente
diviso tra amore familiare, amore erotico e consciousness. Tra popsoul sporcato di ottimismo gospel (la title
track), pathos funkysoul (Take Me Back), sottili rifiniture
di wah-wah (You Make Me Smile), calchi Sixties (Politician,
che sembra mimare Atlantis di Donovan), un valzerino
black (If I), grumoso funky (Hey Brother), cartavelina reggae (Miss Fortune), staffilate funksoul e organo da chiesa
(So Hard).
Aloe ci regala un disco dove mestiere e ispirazione sono
un'unica cosa.
(7/10)
Gabriele Marino
Altar Eagle - Mechanical Gardens
(Type Records, Settembre 2010)
G enere : synth pop / shoegaze
Back in the 80's with Altar Eagle's shoeagaze. Brad Rose
e la moglie Eden Hemming hanno scoperto di avere
un'ulteriore personalità: Mechanical Gardens è un disco
pop, dove niente ricorda anche soltanto vagamente il
noise multiforme di The North Sea o lo psycho folk
di Corsican Paintbrush (l'altro progetto insieme dei
due).
Delicate atmosfere shoegaze coesistono con ritmi techno, dolci melodie dream-pop sono accostate a loop di
pura elettronica: sembra quasi che il duo di Tulsa abbia
rielaborato le influenze musicali degli ultimi trent'anni e
le abbia riversate in piccole citazioni all'interno dei brani. Forse anche per loro lavorare a Mechanical Gardens
è stato un tuffo indietro nel tempo, come suggerisce il
sound che spesso sembra provenire da una vecchia cassetta. Così iniziare con gli Slowdive in Battlegrounds è
dichiarazione d'intenti, d'amore per synth, echi, riverberi e tastiere ondeggianti, che ritroviamo in B'nis B'riht
Girls, colonna sonora di una felicità ideale difficilissima
da raggiungere. Poi s'inserisce la cassa in quattro e un
38
vecchio amore della Hemming, l'indietronica: Spymovie
mette insieme primi My Bloody Valentine e techno
artica, strizzando l'occhio ai Cocteau Twins.
Il dream-pop che si fa dance sognante e metronomica di
Mechanical Gardens è un buon connubio, nonchè un bel
tentativo di destreggiarsi nel mare affollato della synth
wave.
(7/10)
Gemma Ghelardi
Andrea Cola - Blu (A Buzz Supreme,
Ottobre 2010)
G enere : pop d ' autore
L'ex Sunday Morning abbandona il suono homesleepiano del promettente Take These Flowers To Your
Sister e si presenta in prima persona con canzoni in
italiano e indole pop. Gli Aidoru ci mettono strumenti e
marchio associativo, da par suo Andrea Cola aggiunge
ad ogni traccia delle piccole sorprese, per una scrittura
che non cerca stravolgimenti ma vibrazioni dal lato che
non ti aspetti.
Si parte con il canonico pop-rock elettrificato di La mattina presto e l'ottimo lavoro percussivo di Diego Sapignoli su Mangia le fragole. Poi Legno bianco ci lascia
intendere un Rino Gaetano in vena sentimentale coi
Blur a fare da backing band e Se io, tra voi sceglie il passo
analogico smentendo la titolazione endrighiana, opzione
ancor più evidente nella successiva Così lontano in vero
così vicina al Battiato di Patriots..
Tuttavia di Blu piacciono soprattutto il candore maturo
e l'indole soul fuori dal genere, che sono stati le stesse
armi in più di un altro recente esordio in italiano, quello di Marco Iacampo. Come il già Goodmorningboy,
Andrea Cola rivendica in modo puro e diretto il suo
essere al mondo, talvolta con un filo d'ironia discreta
(l'aurea d'antan di Piove a Milano) o un richiamo potente
alla tradizione meno consona (l'ansiogenia rockista alla
Captain Beefheart de Il cuore trema). Ma più spesso
scegliendo di stare con la schiena dritta a guardare un
orizzonte dilatato e onirico, si prenda ad esempio l'emozionante Anna, senti che tamburi.
(6.8/10)
Luca Barachetti
Anika - Anika (Invada, Ottobre
2010)
G enere : dup - post - punk
The first lady of Invada, come da press, arriva all'esordio con un disco di "uneasy easy listening" tanto sorprendente quanto accattivante. Cresciuta e formatasi tra
Berlino e Bristol, di professione giornalista freelance e
promoter musicale per passione, la ragazzetta mette a
frutto tutto il background accumulato in anni di ascolti
sul versante punk, dub e 60s pop e le casuali frequentazioni col salotto buono di casa Invada: mr. Geoff Barrow
(Portishead, ma soprattutto in questo caso Beak>) in
persona si pone, infatti, come mentore in studio della
bionda chanteuse in nome di una sensibilità musicale comune.
Ne esce una versione teutonica di Santogold al ralenti
(Terry) o una specie di what if con Nico calata nel melting
pot dei giorni nostri, condito da disco-punk anemico alla
maniera di una M.I.A. dopo un bong d'erba buona (Yang
Yang, guardatevi il video per un immaginario visivo alla
M.I.A.), P.I.L. cresciuti nei sobborghi di Bristol intorno
alla metà dei 90s (End Of The World), disco-not-disco attualizzato al terzo millennio e post-punk anglosassone al
femminile e in fissa col funk bianco.
Un esordio che non sfigurerebbe al cospetto delle ristampe targate Soul Jazz. Che a pubblicare oltreoceano
sia la Stones Throw non è che l'ulteriore attesto di stima
per questo piccolo gioiellino.
(7/10)
Stefano Pifferi
Antony and the Johnsons - Thank
You For Your Love EP (Secretly
Canadian, Agosto 2010)
G enere : avant pop
Tipico ep-antipasto per ingannare l'attesa dell'album
lungo Swanlights (che poi, cosa ci sarà mai bisogno
d'ingannare...), questo Thank You For Your Love è un
cinque tracce che rimarrà come una virgola nel repertorio di Antony and The Johnsons, congiunzione tra
le solenni volute di The Crying Light e il chissà cosa che a
breve ci verrà rivelato.
Tanto la dinoccolata title track che la ben più mesta My
Lord My Love fanno intuire coloriture errebì riconducibili alle ultime evoluzioni Lambchop. Quanto al resto,
esercizi di stile nelle rarefazioni scentrate di You Are The
Treasure e nelle due cover (Pressing On di Bob Dylan e
Imagine di John Lennon), arrangiamenti parchi e preziosi per una voce sempre più capace di somigliare solo
a se stessa.
(6.4/10)
Stefano Solventi
Antony and the Johnsons Swanlights (Secretly Canadian,
Ottobre 2010)
G enere : avant pop
Sinceramente non mi attendevo molto da Swanlights,
quarto lavoro lungo per Antony and The Johnsons.
Vuoi per il non trascendentale antipasto Thank You
For Your Love EP, e in parte perché era stata annunciata la presenza in scaletta di pezzi già noti, eseguiti più
volte live però mai pubblicati. Sospettavo insomma che
Hagerty inaugurasse già la pratica del raschiamento del
barile, ma gli ascolti hanno fugato ogni timore. Al contrario, c'è da stupirsi che tracce come la sinuosa I'm In
Love o la palpitante Christina's Farm abbiano trovato solo
adesso la consacrazione fonografica. E' un disco più essenziale dei predecessori, gli arrangiamenti del sempre
ottimo Nico Mulhy perseguono una frugalità assieme
delicata e incisiva, il pianoforte e gli archi disegnano scenari bucolici senza sbrodolature, sfrondati da una tensione tiepida, senza requie (come in Ghost).
Lo spiritual moderno che da I'm A Bird Now trovava
solenne trasfigurazione in The Crying Light, rivela qui
un cuore folk le cui radici rimandano alla prima Nico
passando dai Dirty Projectors (The Great White Ocean)
e che non disdegna di confrontarsi con un camerismo
cinematico dagli sviluppi melodici neanche troppo vagamente Morrissey (Salt Silver Oxygen). Forse mai come in
questo disco la voce è sembrata tanto vicina, scoperta,
carnale. Ad altezza d'uomo. Discorso che vale anche per
il contributo di Björk in Fletta (brano risalente alle sessioni di Volta), mentre fa eccezione la title track, dove
su un tappeto di riverberi elettrici Antony imbastisce una
fosca liturgia psych che scomoda fantasmi John Martyn e Tim Buckley. Resta la sensazione di un artista
che ancora sta esplorando i propri limiti e le possibilità,
di un individuo che non smette di porsi domande sulla
vita e sullo stare al mondo, di un'espressione figlia di
questo percorso difficile e meraviglioso. Un procedere
tra incertezze, inquietudini, illuminazioni ed estasi. Che
gli fanno legittimamente sostenere - e splendidamente
cantare: ogni cosa è nuova.
(7.3/10)
Stefano Solventi
Arp (The) - The Soft Wave
(Smalltown, Settembre 2010)
G enere : K raut , cosmic
Alexis Georgopoulos è una vecchia volpe. Già avvistato
negli Alps (III e Le Voyage su Type), e nella tracklist
del Dj Kicks di James Holden, in passato ha inciso per
un'infinità d'etichette: DFA, RVNG INTL, Troubleman
Unlimited, Lo, Rong, Type, Root Strata, Eskimo, Deitch.
Appena sporcato di noise (Alexis si è trasferito di recente nella Grande Mela) e registrato originalmente su nastro per poi esser riversato in tutti i soliti formati, The
Soft Wave è un album dal sound in punta di dita: synth
39
analogici, chitarra, piano e qualche flauto sporadico con
tanto di dichiarazione d'amore a Brian Eno e Robert
Wyatt nell'unica song del lotto, la ballata From a Balcony
Overlooking the Sea.
Gli Arp, secondo l'autore, si occupano di short stories o
filmic vignettes. Di fatto remissano le sinfonie all'ananas
dei primi Kraftwerk fino ad Autobahn. Semplice. Ruffiano se volete. Niente male.
(7/10)
Edoardo Bridda
Autre Ne Veut - Autre Ne Veut (Olde
English Spelling Bee, Settembre
2010)
G enere : pop
Chiudete gli occhi e immaginatevi una puntata d'antan di
Top Of The Pops presa da una vecchia VHS. Fate sfilare
Prince intento a riprendersi da una sbronza (Wake Up),
lo spauracchio di Arthur Russell (Soldier non gli invidia
nulla) e la silhouette di Molly Ringwald, la rossiccia lentigginosa di The Breakfast Club. Otterrete l'ennesimo clash
memorie '80: gli Scritti Politti (quelli di Cupid & Psyche
e Provision) intinti nel meta-pop russelliano e osservati
secondo lo sguardo distorto di Ariel Pink, imbarazzo
(Two Days Of Rain) e cadute inclusi nel prezzo. Alcuni episodi però non sono affatto male: Drama Cum Drama è un
gioiello, mentre il pop di OMG e la stranita ballata Loveline sembrano provenire da un giovane - e alticcio - Green
Gartside. E Green un perché ce l'ha sempre avuto.
(6.3/10)
Gianni Avella
Baby Blue - We Don't Know
(Trovarobato, Settembre 2010)
G enere : blues - indie
E se We Don't Know fosse il disco soul dei Baby Blue?
Un soul scarnificato e in combutta con la psichedelia di
Syd Barrett (Don't ask Me Why), infantile e ripetitivo (Oh
Marie), rumoroso (Shut Up), filtrato da un crooning narcotizzato ma ancora riconoscibile (I Don't Know). Nessun
ripetersi grossolano e fuori fuoco di soluzioni già viste
nell'Ep d'esordio e in Come! insomma, ma un progetto
discografico coerente capace di mantenere un approccio riconoscibile e di rappresentare al tempo stesso
un'interessante variazione sul tema.
A rinfrancare i vecchi estimatori pensano brani pungenti come Earthquake, ma il resto del programma sceglie
coscientemente di lavorare sulla scrittura rallentando i
tempi, lacerando la classica ballad con i consueti isterismi
(Stay A While), perdendosi in un intrico di linee vocali solo
apparentemente abbozzate (Dawn). Fino ad arrivare alla
40
conclusiva Porto Palo, ideale punto di giuntura tra i vecchi
e i nuovi Baby Blue, con la sua forma canzone definita e
vagamente "antoliniana" solcata dal solito blues tagliente.
Se i parametri stilistici della formazione toscana sembrano ormai ampiamente definiti, pare che al loro interno
rimanga ancora un discreto margine di manovra per oltrepassare con stile quei rimandi Blues Explosion/White
Stripes che dagli esordi costituiscono il principale "limite" della proposta dei Baby Blue.
(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
Beautiful - Beautiful (Al-Kemi
Records, Settembre 2010)
G enere : rock
Cristiano Godano, Luca Bergia e Riccardo Tesio
incontrano Gianni Maroccolo e Howie B al Teatro
Petrella di Longiano. Improvvisano in solitaria, registrano,
assemblano. Ne nasce Beautiful, vera e propria band con
al seguito un disco omonimo di dodici tracce fra strumentali e canzoni fatte e finite. I Marlene Kuntz ripassati di
elettronica? Non esattamente, ma nemmeno un qualcosa che si possa definire con precisione. In Pow pow pow
pare quasi di ascoltare i Twilight Singers - e il discorso
vale anche per l'ottima In your eyes. Single too! veleggia vanamente ottantiana e sintetica dalle parti dei Depeche
Mode e non sono due delay e due distorsori a salvarla.
Fatiche gioca su un iniziale rumorismo scuro che anticipa
chitarra e pianoforte crepuscolari, con la prima ad esplodere solitaria e non del tutto a fuoco. White rabbit riesuma
invece il più ovvio fantasma di un Nick Cave benedetto
da David Tibet, mentre una serie di strumentali più o
meno lunghi contenenti un po' di tutto (crescendo post,
noise d'occasione, trucioli d'elettronica assortita) fanno
da inconcludenti neo-Spore o da meri riempitivi.
Non saremo di certo noi a deprecare il tentativo da
parte di musicisti con importanti percorsi alle spalle
di intraprendere direzioni in diagonale per arrivare a
sbocchi imprevisti. Ma qui è tutto fin troppo casuale e
in definitiva inutile. Forse le tante idee sviluppate in sede
d'improvvisazione andavano limate di più (e alcune proprio eliminate). Forse, molto più semplicemente, questi
dream-team di nomi altisonanti che si mettono a fare
musica insieme non funzionano perché mancano di quel
fuoco primigenio che li rende sostanziali oltre il proprio
esserci. Lasciamo ai Beautiful il beneficio di una seconda
chance, e speriamo comunque che il tutto non diventi
- perdonateci la boutade, ma non è nostra la scelta del
moniker - una telenovelas.
(5.2/10)
Luca Barachetti
highlight
Crocodiles - Sleep Forever (Fat Possum, Settembre 2010)
G enere : P sycho pop
Nell'autunno psichedelico del 2010 non potevano mancare che loro. Brandon Welchez e Charles Rowell
sono due noismakers di San Diego, la cui importanza è cruciale nel coacervo di suoni urticanti del nuovo
lo-fi americano, soprattutto in virtù del ruolo di animatori dell'agguerrita
scena californiana, nonché di un passato da terroristi sonici con i Plot To
Blow Up The Eiffel Tower.
I Crocodiles esordivano poco più di un anno fa con quel Summer Of
Hate che, oltre ad essere finito nella mia personale top ten di fine anno,
aggiornava il linguaggio dei Jesus And Mary Chain con il cinismo ruspante
di brani come I Wanna Kill. Con quel lavoro forgiavano psychocanditi di immacolata grana melodica, rivestendoli di fango e detriti.
Oggi ricalibrano le ambizioni upgradando il loro garage pop ipnotico, pulendo e levigando, facendo brillare le chitarre, campendo gli spazi con organi e synth analogici, dando aria
ai brani fino a far spirare una fragrante brezza lisergica. I due, dal canto loro, non ci provano neanche a
nascondere i riferimenti: si va dai soliti fratelli Reid pacificati dalle droghe, agli Spacemen 3 più garage e
meno isolazionisti, fino allo shoegaze dei Telescopes e a tutto quel ronzare di fuzz e melodie malate che
un quarto di secolo fa, in Gran Bretagna, finiva per lambire le classifiche.
Oggi le solite trame vengono imbastite da un gruppo di freaks che, nonostante la provenienza, di sole e
spiagge non sa che farsene. Meglio dedicarsi alle atmosfere ossessive e decadenti di Hollow Hollow Eyes e
Billy Speed, in cui sembra di ascoltare i brani di Pornography sfregiati da un complesso freakbeat. In un
certo senso sta proprio qui la forza dell'album: in quella purezza 60s che percorre tutti i pezzi donandogli
fascino e freschezza.
(7.3/10)
Diego Ballani
Belle And Sebastian - Belle And
Sebastian Write About Love (Rough
Trade, Ottobre 2010)
G enere : pop , soul
"Devi guardare il sogno aldilà degli alberi attraverso le
finestre del tuo salotto". Scrivere d'amore è la capacità
di trovare i colori nel grigio quotidiano, di scovare poesia
nella routine di una vita ordinaria. Stuart Murdoch e i
suoi lo fanno da quattordici anni e, possiamo dirlo, pochi
altri come loro. La formula della longevità dei Belle And
Sebastian sta tutta qui, nel titolo di un ottavo album che
ce li restituisce immancabilmente fedeli a se stessi eppure, nondimeno, rinnovati. In che modo? Tra un ammiccamento glam e una facezia pop, già il precedente The Life
Pursuit aveva segnato la strada, seguito l'anno scorso
dall'ancor più eloquente God Help The Girl, capriccio solista di Stuart ove i vezzi white/northern soul già esibiti a
più riprese in precedenza prendevano del tutto il sopravvento, definendo così il carattere della mossa successiva.
Ecco quindi spiegato il duetto - probabilmente impensabile per gli aficionados della prima ora - con Norah
Jones nella malinconica Little Lou, Ugly Jack, Prophet John:
invero riuscito se ci abituiamo alla nuova immagine dei
Belles come professionisti del soft pop contemporaneo
(un crossover indie-chic à la She & Him, per tirar fuori
un paragone non troppo peregrino). La rinnovata scelta
di Tony Hoffer e dei suoi studi losangelini d'altronde la
dice lunga: irrimediabilmente lontani, lontanissimi i tempi
in cui gli scozzesi erano sinonimo di maldestra ingenuità
adolescenziale, di intimità fieramente provinciale. Chiamatela, se volete, età adulta. Ed è pur vero che di fronte al
sound levigato, pulito e brillante di quest'ultima prova si
potrebbe - a ragione - parlare anche di mestiere, non fosse per una freschezza di scrittura (senz'altro corroborata
dai quattro anni di stop) e una maestria negli arrangiamenti che pochi dubbi lasciano sulla qualità complessiva
del lotto. Oddio, all'altezza di I'm Not Living In The Real
World (rockettino tendente all'irritante di Stevie Jackson)
si soffre un po', ma al cospetto di gemme dall'architettura
sonica perfetta quali I Want The World To Stop (degna erede
di una I Fought In A War, solo molto più cool), I Didn't See
It Coming e la stessa title track (con ospite l'ugola dell'at41
trice brit Carey Mulligan, giusto per restare in mood God
Help The Girl) non si può che far l' - ennesimo - inchino.
(7/10)
Antonio Puglia
Black Heart Procession - Blood
Bunny/Black Rabbit (Temporary
Residence, Ottobre 2010)
G enere : wave cantautorale
Annata ricca di avvenimenti, il 2010 di Pall Jenkins e
Tobias Nathaniel: dopo aver splendidamente riesumato i Three Mile Pilot, quello che è rimasto il nucleo anche dei Black Heart Procession ci propone un mini-CD
generoso nella durata e artisticamente apprezzabile. Tre
nuove tracce di elegante romanticismo - da un'America
che, come quei Tuxedomoon maturi cui il duo somiglia
sempre più, si fonde alla Germania dei primi '70 - convivono con un pugno di remix in una rivelazione sulla
metodologia e lo stile dei Nostri.
Nel senso che è per l'appunto il lavoro sul suono a sottolineare la robustezza della scrittura, sia che si assoldi
Lee "Scratch" Perry per la follia in camere d'eco di
Freeze, si convochi Eluvium a rielaborare Drugs tra glissando ambientali e tasti cameristici o il concittadino Jamuel Saxon la declini in downtempo. Variazioni su temi
e trame che (sommate alle pulsazioni oblique e alle filmiche cupezze ideate da Mr.Tube, alias Jenkins medesimo)
permettono agli inediti di cui sopra di risaltare, passando
dalla squadrata ma eleganteBlank Page al gassoso, malinconico quadrettoThe Orchid attraverso la torbida melodia di una magistrale Devotion. Idee fin troppo valide
e articolate per un semplice "riempitivo" discografico:
anche questa è classe.
(7/10)
Giancarlo Turra
Blastema - Pensieri Illuminati
(2Roads/Halidon, Ottobre 2010)
G enere : M ainstream rock
Disco dalla gestazione travagliata, questo esordio dei
Blastema, che solo oggi viene alla luce, dopo delusioni e disaccordi con alcune etichette e festival italici. La
bella voce di Matteo Casadei (con un nome così...), che
a tratti sembra inseguire gli stilemi di un'icona del rock
targato Italia, come l'Edda dei Ritmo Tribale, traina un
sound in realtà piuttosto lineare, in un incerto equilibrio
tra rock chitarristico di stampo 90s e un rock d'autore circa Scisma, in uno sguardo che sembra guardare
soprattutto al vicino passato. Quando escono da questo schema, con gli accenni ska (Sperma) o il tentativo
disco-pop della titletrack, le cose si muovono meglio e
42
raggiungono risultati non disprezzabili con Canzone da
3 euri, che mette insieme hardcore melodico e anthempop da classifica. Ma sono i testi che spesso scivolano in
sanremismi e xfactorismi facili a costituire l'anello più
debole di una proposta che, nonostante le buone qualità
di fondo, non sembra ancora aver trovato la direzione in
cui muoversi.
(5.7/10)
Marco Boscolo
Brisa Roché - All Right Now
(Discograph, Settembre 2010)
G enere : I ndie
Nata negli Stati Uniti, Brisa Roché risiede da alcuni anni
in Francia, dove pare che abbia trovato la propria patria
d'adozione. Il suono che esce dalle quattordini tracce di
questo suo All Right Now, il terzo album della carriera,
è un amore sconsiderato per la musica degli anni Novanta. Sarà perché dopo essere cresciuta nella Carolina
del Nord, Brisa decide che a sedici anni, lei classe 1976,
doveva vivere nel pieno la scena grunge di Seattle. Dopo
la morte del padre, un po' di progetti emo-pop falliti e un
flirt con il mondo del jazz, Brisa è uno strano miscuglio
di Joni Mitchell da giovane, la Nina Persson che ha reso
grandi i Cardigans e una smodata ammirazione per la
P.J. Harvey di Dry.
Registrato in California, il disco dovrebbe risentire
dell'influenza del dream pop West Coast, ma in realtà si
limita a incalarsi in un sound classico da Novanta, reazionario per la scarsa volontà di rinnovarsi e introverso per
i riferimenti. Come nel caso di tanti ritorni più o meno
manifesti e voluti alla musica dei quegli anni, sul piano
formale non c'è nulla che non vada in queste quattordici
tracce, se si esclude il fatto che se ne potevano tagliare
quattro o cinque senza che cambiasse il senso dell'operazione: sono tutte prodotte, suonate e cantate bene. Il
problema è che a guardarsi solo indietro, senza nemmeno la curiosità di scovare qualche gemma oscura dimenticata, si rischia di scrivere sempre le stesse canzoni.
(6/10)
Marco Boscolo
Carl Barat - Carl Barât (Pias,
Ottobre 2010)
G enere : O rchestral pop
"Se hai lavorato a un'idea che non deve vendere nulla
è
molto più facile. Puoi andarci di cuore. Ho sempre saputo che
quest'album era la verità. Lo sentivo nell'anima". A parlare
è Carl Barat, co leader e autore di due album firmati
Libertines assieme a Pete Doherty, e altrettanti dischi
come leader dei derivativi Dirty Pretty Things. Quel
highlight
Deerhunter - Halcyon Digest (4AD, Settembre 2010)
G enere : P opgaze
Se la nostalgia di un passato più o meno remoto è una delle chiavi di lettura decisive per la musica di questi
anni zero, bisogna però distinguere tra chi si limita a un citazionismo elegante e raffinato seguendo solamente la moda che permette di avere più visibilità (via Pitchfork e altri canali di comunicazione), e chi, invece, plasma la materia della tradizione a proprio piacimento perché l'ha oramai fatta propria e sente che
a quella tradizione potrebbe un giorno aspirare ad appartenere. Alla seconda
categoria appartengono sicuramente Bradford Cox e i suoi Deerhunter,
che ritornano con quello che si rivela il loro disco più coeso e organico,
lasciando da parte le parziali indecisioni di Cryptograms e il rischio della
ripetizione insito in Microcastle. Oggi il "cacciatore di cervi" sembra aver
trovato un equilibrio sonoro che ha portato a un popgaze più fruibile che
mai, sempre però dipinto su di una tela sonora oscura e atmosferica, che per
certi versi deve qualcosa anche all'ambient.
Oltre alla bontà delle composizioni, spicca un lavoro davvero certosino sul
suono delle chitarre che spesso sono sufficienti per dare un'ambientazione precisa a tutto il pezzo. È il
caso, per esempio, della citazione byrdsiana di Memory Boy o dell'eco R.E.M. di Revival. Desire Lines si apre
come un pezzo degli Arcade Fire, i Deerhunter possono essere accostati per la capacità di entrambe le
band di tracciare una proprio strada che unisca il porticciolo protetto dell'indie con il gusto delle masse.
Altrove, invece, si deve faticare un po' di più per entrare nel bosco musicale dei Deerhunter, come nella
stratificata Helicopter che si chiude con un falsetto fragile e intenso di cui non si pensava fosse nelle corde
di Cox, o nella cerebrale Earthquake, che posta a inizio scaletta sembra quasi un manifesto: ritmo blando,
scandito da percussioni parsimoniose, ma secche come colpi di frusta e chitarre ipnotiche. Due dei pezzi
migliori del lotto sono posti, invece, in chiusura: Coronado, uno stomp quasi solare sottolineato da un sax
molto black, e He Would Have Loughed, che ricorda le sonorità del progetto solista di Cox (Atlas Sound),
salvo trasformarsi progressivamente in qualcosa di completamente diverso, quando il ritmo rallenta e ci
si sposta in paesaggi dream.
Un disco apparentemente semplice per l'immediatezza che contraddistingue la maggior parte degli episodi, ma in realtà ricavato da una stratificazione di idee e suoni che lo fa crescere ad ogni ascolto. La dimostrazione che semplice e semplicistico non sono sinonimi.
(7.5/10)
Marco Boscolo
Barat che il 31 marzo scorso, al Boogaloo, dichiarava che
lui e Pete erano "pronti ad incidere nuove canzoni", quando era chiaro al mondo che tornare a scrivere assieme
era più un desiderio suo che non del flaccido compagno
oramai legato, sia in tour che in studio, ai più fortunati
Babyshambles.
Rispetto alla fortune dell'amico, Barat fin'ora non ha fatto una gran carriera. Con la band rifaceva i Libertines
in un giochetto di cui si è presto stufato (e il pubblico prima di lui). In solo si era fatto battere sul tempo
dall'amico che aveva confezionato, nel marzo del 2009,
un buon lavoro a nome Peter Doherty (scritto con la
erre finale) la cui formula era proprio identica a quella
che aveva in mente lui.
Curiosamente Carl, all'epoca in cui uscì Grace/Wastelands, bisbigliava alla stampa di aver pronte delle canzoni, al piano, esattamente l'opposto rispetto allo stuolo di
fiati e ottoni dispiegato dal Dohery "a teatro"; in quello
stesso periodo, smentiva voci sulla reunion Libertines
che di lì a poco avrebbe spinto più di ogni altro.
Non voleva presentarsi davanti ai compagni a mani vuote e Carl Barât è qualcosa in più della risposta al disco
di Pete. Anzi, è un buon album, sfarzoso, pomposo, disneyano, strutturato secondo una serie di canzoni che
sono poi classici canovacci da Tin Pan Alley, cantati in
un crooning da innamorato abbandonato. Classici sor43
retti da una scrittura che c'è e non scimmiotta, come
suggerirebbero i chronicles da punk-rocker. Lo stile poi
è cristallino, diciamo pure maccartneyiano. L'altra faccia
dei Libertines in versione orchestrata mantiene, dunque,
le coordinate vaudeville e serenade, portandosi appresso tutte le idee melodiche all'avant spettacolo. Tanto che
in questa sede il trentenne, per la prima volta, mostra al
mondo che può essere un cantautore emancipato e che
forse la strada e le buone maniere gliel'hanno indicate i
Divine Comedy.
Dietro alle splendida The Fall Troviamo Neil Hannon in
persona, mentre l'altro ospite azzeccato è quell' Andrew
Wyatt (Miike Snow) co-responsabile delle orchestrazioni (The Magus, Je Regrette, Je Regrette, What Have I
Done e la finale Ode To A Girl).
(7/10)
Edoardo Bridda
Charlatans (The) - Who We Touch
(Cooking Vinyl UK, Settembre 2010)
G enere : P op , rock
Dietro a quel cesto di capelli tinti, Tim Burgess è un po'
come Ian McCulloch: non vuole arrendersi all'età, certi
patetici romanticismi proprio non li vuole abbandonare,
ma è ancora in grado di scrivere delle canzoni fresche e
convincenti in ottimi arrangiamenti pop-psych.
Who We Touch esce corredato da un secondo ciddì di alt takes e b sides che forse è chiedere troppo
all'ascoltatore, eppure, portando pazienza per un singolo
deboluccio come My Foolish Pride (un bubblegum teenager simil Lemonheads) ed episodi del peggior Noel
Gallagher come Your Pure Soul, è da considerarsi un
lavoro riuscito.
Ancora una volta la specialità e la forza risiedono nella song bucolica, un formato che funziona sempre, sia
quando Tim lo taglia con i riffoni punk presi di peso dai
Sex Pistols (l'indie rock di Love Is Ending), sia quando lo
immerge in brume synth e passo d'uomo (Smash The System) o in salse più americane (When I Wonder). Perdonandogli altri peccati come gli slanci al cielo di Intimacy o
porcate '80 come Trust In Deside, l'effetto incanto per il
motorik di Sincery (altro momento rockista non convenzionale della faccenda) e per la progressione pop-prog
lennon-pinkfloydiana di Oh! è assicurata.
Con Who We Touch il marchio Charlatans arriva degnamente all'undicesimo album in vent'anni di carriera.
(6.7/10)
Edoardo Bridda
44
Chromeo - Business Casual (!K7,
Ottobre 2010)
G enere : disco 80
I due giovani di Montreal ritornano sul luogo del delitto
Ottanta e provano a portarsi di nuovo sull'hot spot del
gotha synth pop mondiale. Con l'aiuto di Philippe Zdar
(mezzo Cassius) al mixing tentano di bissare le promesse che avevano fatto con il mix sul DJ Kicks di qualche
tempo fa, ma la loro proposta, anche se viaggia attraverso tutti i territori della decade da bere, non convince
fino in fondo.
Ci vanno sì di electro funk (Hot Mess), di vocoderato
ammiccante (I'm Not Contagious), di ricordi camp progressivi moroderiani (Night By Night), di assoli di chitarra
e di altri trucchetti (tra cui il bellissimo featuring di Solange Knowlesin When The Night Falls), ma sembrano più
due impegati che devono portare a casa il pezzo che due
che si divertono. E questo cuore di plastica dopo un po'
rivela la sua artificialità dedicata - come dice il titolo esclusivamente al business.
Fancy Footwork è solo un bel ricordo. Peccato. Ci stiamo
iniziando a stancare del retrofuturismo spicciolo e da qui
in poi siamo sempre più consci di meritarci qualcosa di
più dell'ennesimo clone di Discovery. Perfetto per qualche negozio di abbigliamento, qualche sfilata o qualche
festina in appartamenti chimici. Buona la resa globale, ma
il prodotto resta alla lunga prescindibile. Sufficienza tirata per i funksters sciccosi P-Thugg e Dave 1.
(6/10)
Marco Braggion
Cibelle - Las Vênus Resort Palace
Hotel (Crammed Discs, Luglio 2010)
G enere : futurexotica
Si rivoltino pure le placche tettoniche, finisca questo derelitto pianeta, c'incenerisca e sommerga: rimarrà sempre un nightclub dove mettere in scena quel che resta del
sogno. Alla fine del mondo, ed oltre. Così Cibelle torna,
quattro anni dopo lo stupendo The Shine of Dried
Electric Leaves, ad immaginare una realtà parallela
dove certe guizzanti ossessioni sonore (le sue) dettano le coordinate. Stavolta il turbillon electro-jazz-bossafolk-psych-exotica l'ha spinta ad ipotizzare un concept
dove, in uno scenario futuro tra l'apocalittico ed il balzano, tal Sonja Khalecallon tiene banco al Las Vênus Resort
Palace Hotel assieme alla sua band, i fidi Los Stroboscopious Luminous. La loro missione è intrattenere i reduci
dalla catastrofe pasturandone l'immaginario col lenitivo
della musica (e del palcoscenico), una combinazione di
dramma e understatement che conduce non certo a
caso verso atmosfere jamesbondiane: vedi la melmosità
Shirley Bassey di Braid My Hair e la deliziosa cover di
Underneath The Mango Three (dalla soundtrack - appunto
- di Agente 007: licenza di uccidere, anno 1962).
Ben venga poi certo romanticismo giocoso, tipo quello
onirico e clownesco di Melting The Ice, oppure capace di
squadernare serica pensosità (Sad Piano), senza con ciò
rinunciare alla fregola di scozzare idiomi, aromi e chimere come nel forrò edulcorato di Frankenstein, nello
psycho-cha-cha-cha di Escute Bem e nel cibermambo di
Man From Mars. La componente ludica, in questo iperpost-decamerone, è un segnale portante, come testimonia la presenza di It's Not Easy Being Green, pezzo portato
al successo dalla rana Kerimit del Muppet's Show e qui
virata in languido doo-wop acustico. E cosa dire di Lightworks, che dell'originale di Raymond Scott (musicista
elettronico attivo già nei fifties) ripropone il piglio infarcendolo di delirio, acideria tex-mex e piña colada.
Cibelle, insomma, conferma di voler prendere molto sul
serio l'arte di non prendersi sul serio. Il risultato è un (altro) album-cocktail che sembra aver azzeccato il giusto
dosaggio tra gioco, raffinatezza e profondità. (7.3/10)
Stefano Solventi
Clientele (The) - Minotaur EP
(Pointy, Agosto 2010)
G enere : psych pop
Siano benvenuti mini album come questi - e ne fioccano, ultimamente - perché rivelano una sbrigliatezza impossibile ai lavori lunghi e in ragione di ciò ci raccontano lo stato delle cose con chiarezza spesso inaudita.
Dei Clientele, ad esempio, sapevamo l'indole ambigua,
quel dolciastro dimenarsi tra caligini e assenzio, tra sere
fradicie di spleen e pomeriggi sonnacchiosi. Sembrano
(sono?) degli inguaribili bohemienne, ostinamamente (e
ostentatamente) ricercati con le loro trame languide e
flou, ma anche d'altro canto dei neo-psichedelici insidiosi, contagiati dal germe acido che sprezza le confortevoli
traiettorie della consuetudine.
Duplici e quindi mostruosi, inafferrabili alieni della radio
accanto, una linea tracciata in obliquo tra le malinconie
febbrili di Jekill e lo scostante vitalismo di Hide. Capirete quanto mi sembri azzeccato quindi un titolo come
Minotaur, palpitazioni cameristiche a battezzare una scaletta di sussulti deliziosamente autunnali (Strange Town,
Nothing Here Is What It Seems), guizzi d'asprigna luce pop
(Jerry, Paul Verlaine) ed affezioni sperimentali (il talkin' su
sfondo electro-noise di The Green Man). Degna di nota
- per quello stare in bilico tra carezza e deviazione - è
la cover di As The World Rises And Falls, pezzo pescato dai
sixties a firma dei losangelini The West Coast Pop Art
Experimental Band, che chiarisce altresì a quali radici
i Nostri amino restare aggrappati. Per il 2011 è atteso il
nuovo album Haunted Melody: altro titolo programmatico? (7/10)
Stefano Solventi
Clinic - Bubblegum (Domino,
Ottobre 2010)
G enere : pop
Qualche anno fa, in occasione dell'ultimo album a sigla
Clinic, ovvero Do It del 2008, ci domandavamo se alla
fin fine la band di Jonathan Hartley, Ade Blackburn, Brian
Campbell e Carl Turner non continuasse a riproporre
pedissequamente lo stesso disco. La risposta non sembra arrivare nemmeno da questo nuovo capitolo della
loro avventura discografica, il sesto dal 1999. Le coordinate principali rimangono sempre quelle dell'art punk,
ora declinato più sul versante pop, stile Howard Devoto, altre rimanendo più fedele alla linea che porta ai Fall.
Se l'impianto sonoro di base rimane sempre lo stesso,
bisogna però dire che qui i Clinic hanno cercato l'ispirazione in tantissimi luoghi diversi della musica, tanto che
accanto alla coesione estetica fa capolino una varietà che
ci fa dire che ogni canzone sia un unicum a se stante. Vi
si ritrovano spoken-word presi a prestito dai Cream di
Wheels of Fire (Radiostory), strumentali ispaneggianti (Un Astronauta En Cielo), lo stomp-blues di Forever, la
ballad quasi emo di Baby, il folk di Freemason Waltz (che
centri la massoneria?) e le sfumature caraibico-brasiliane
di Milk and Honey. Il problema di Hartley e soci non è
tanto scrivere canzoni godibili, quanto riuscire un giorno
a scriverne una che rimanga impressa più del tempo che
passa nel lettore.
(6.5/10)
Marco Boscolo
Colya - 54 e non sentirli (Music
Valley, Giugno 2010)
G enere : rock italiano
I fiorentini Colya s'impossessano della magniloquenza
Muse senza provare quel minimo colpo di coda assolutamente vitale in simili situazioni. E così 54 e non sentirli pare una raccolta di outtakes da Black Holes and
Revelations, con il trio ad imbastire tracce dal passo
sicuro e granitico, distese sulle quadrature della batteria
e gli inevitabili saliscendi vocali del già Canemorto Antonio Nardi alla chitarra e al violino.
Cosa servirebbe? Probabilmente una canzone rotonda e
ispirata come quella Laura che nel 2005 li vide esordire
in un promettente ep, oppure una produzione meno ag45
ghindata di festoni sonici ad inseguire col fiatone i primi
Marlene Kuntz. Qua e là un certo sentore Radiohead pre-Kid A non aiuta, e nemmeno la rilettura di Vivere
una favola di Vasco Rossi che pare restituire il favore al
rocker di Zocca intento a scoprire l'avanguardia verseggiando in italiano Creep.
Non si esce vivi dagli anni novanta per dirla parafrasando
l'Agnelli. O forse non si esce vivi e basta.
(5.2/10)
Luca Barachetti
Corin Tucker - 1,000 Years (Kill
Rock Stars, Ottobre 2010)
G enere : indie folk - rock
Non fosse bastata la musica, delle Sleater Kinney serbiamo ottima opinione anche per l'essersi ritirate imbattute all'apice della carriera. Prerogativa dei più grandi,
la scelta del "momento giusto" per sparire e altrettanto
quello dell'ipotetico ritorno, che s'avrebbe da fare solo
con qualcosa di rilevante da dire. Regola che vale per
Corin Tucker, la quale - dopo un periodo trascorso a godersi le gioie della famiglia - riappare con relativa, omonima band dalla Portland dove tutto è iniziato, recando
undici brani di folk-rock virato indie, cioè devoto ai '60
però ricco di mosse che lo allontanano dal puro revival e
in ciò simile a certe cartoline inviateci più di un ventennio fa da Barbara Manning.
Penna tuttora brillante, la maturità restituisce un approccio più posato ma senza forzature, evidente nel gusto per il dettaglio "di peso" che fece grande The Woods
e nell'urgenza espressiva, felicemente adattata alla nuova
fase dell'esistenza; che emerge chiara dal caracollare dylaniano ma inquieto della title track e dalla gemma introspettiva di chiusura Miles Away. Nel mezzo, una solida
varietà di sfacciate citazioni Byrds (Riley) e ticchettanti nervature da Slits senza reggae (Half A World Away),
di momenti tesi eppure leggiadri (It's Always Summer) e
scorribande robuste (Big Goodbye), di impennate (Handed Love, Pulling Pieces) e riflessioni (Dragon). Esattamente
quello che t'aspetti da un'artista coscienziosa: bello avere
certezze, ogni tanto.
(7/10)
Giancarlo Turra
David Wrench / Black Sheep Spades & Hoes & Plows. Songs Of
Insurrection, Defiance & Rebellion
(Invada, Agosto 2010)
G enere : neo - folk
L'ombra lunga dei Current 93 più bucolicamente ossianici si stende sul terzo album di David Wrench, dall'espli46
cito sottotitolo Songs Of Insurrection, Defiance & Rebellion.
L'albino e ieratico produttore, pianista e cantautore gallese, sotto l'ala del mentore Julian Cope (che insieme
a Fat Paul e Michael Sullivan del giro Black Sheep contribuisce alla causa), unisce una lunga una composizione
inedita a quattro mani a 3 radicali rielaborazioni di folk
tradizionali britannici di stampo insurrezionale.
Lunghe tracce di neo-folk che assumono toni crepuscolari e contorni malinconico-decadenti alla Tibet, con una
strumentazione all'osso (mellotron, wurlitzer e poco altro) a sorreggere la profonda e grave voce di Wrench.
Scelta ideale per esaltare il cuore tematico del disco, i
traditional ruotanti intorno a canzoni anarchiche, riottose, brucianti e disperate che narrano di minatori inglesi
di fine '800 (The Blackleg Miner) o gridi libertari poi repressi nel sangue (A Radical Song).
Dark e controverse ballads lasciate ai margini dai revivalisti folk moderni, come ammette Wrench stesso nell'accluso, corposo booklet con testi e introduzioni ai pezzi,
e che rappresentano soltanto il primo passo di una seria
ricerca sulle origini della musica folk più oscura e ribelle.
Vera e propria etnomusicologia della rivolta.
(7/10)
Stefano Pifferi
Dreamend - So I Hate Myself, Bite
by Bite (Graveface, Ottobre 2010)
G enere : F olk pop
Dreamend in realtà è semplicemente il moniker dietro
il quale si nasconde Ryan Graveface, patron anche
dell'etichetta, specializzata in piccole produzioni in edizioni limitate. La sua musica è un viaggio nell'America
delle ghost town minerarie, magari al tramonto, quando
gli spirti della notte cominciano a prepararsi per uscire
dai loro rifugi diurni. Ne esce un folk-pop fortemente
psichedelico, incentrato sulla reiterazione di semplici
pattern e pochi versi (si veda l'iniziale Pink Clouds In The
Woods, i cui oltre sei minuti determinano l'atmosfera sognante di tutto il disco).
Altre volte si trovano inserti d'elettronica e voci corali
che gli inglesi amerebbero semplicemente definire come
haunting (An Admission). Per il resto, siamo di fronte a un
lavoro sulla coralità che ricorda ora i R.E.M. di Automatic For The People (Magnesium Light) ora i Calexico
(Pieces). So I Hate Myself, Bite By Bite nel suo complesso è un disco piacevole, capace di mettere l'ascoltatore nel mood dell'autore, ma con quale canzone non del
tutto all'altezza (sembrano bozzetti o poco più), passa via
senza che ne rimangano troppe tracce nelle orecchie.
(6/10)
Marco Boscolo
highlight
Drivan - Disko (Smalltown Supersound, Agosto 2010)
G enere : indie , lo fi pop
Dietro al progetto Drivan troviamo una vecchia conoscenza di SA, Kim Hiorthøy, tuttofare a casa
Smalltown e anche grafico, illustratore, film maker e non ultimo musicista. Un personaggio chiave nello
scacchiere della post-IDM scandinava e l'autore di almeno un paio di gioielli - Hei e Melke - di quella che
all'epoca è stata definita anche col termine di folk-tronica. Kim lavora con
suoni concreti, piano e chitarra. Ama i ritmi di casa Warp ma è capace di passare da un breakbeat a una cassa in 4 (o un levare) con la stessa disinvoltura
dei Mouse On Mars. La sua arte riede comunque nel ricreare ambienti raccolti e campestri in uno streaming di ricordi e purezza attraverso particolari
microfonazioni che, a seconda delle finalità, impoveriscono e/o vivificano la
fonte sonora (non a caso è autore di un album di soli field recording, For
The Ladies).
Disko, ottenuto grazie alla collaborazione di tre performer conosciute durante una piece di teatro danza, è di fatto il suo primo album pop. Ci troviamo una buona varietà di arrangiamenti che ne ripercorrono i loop più caratteristici e le canzoni, sognanti e intimiste, cantate dalle ragazze
con una punta di infantilismo e in lingua svedese, chiudono idealmente il cerchio di una ricerca decennale
sulla narrazione folk contemporanea.
Kim il norvegese si è rinnovato arricchendo la palette con una buona dose di tradizioni svedesi. La sua
musica ne esce uguale e diversa. Molto attenta ai particolari sonici e con buon senso melodico. Fascinosissima la dizione svedese di Lisa Östberg, Louise Peterhoff e Kristiina Viiala, protagoniste di buone canzoni:
il downtempo funk di Lat det Va, il dream folk elettronico à la Type Records di Inget Mer Sen, l'hip hop di
Shamshalam, Shimshilim, il ragga folk con campionamenti da vita dei campi di Kampa fino al classico mood
nordico tra cassa e minimalismi al piano di Det Gor Ingenting. Da avere.
(7.3/10)
Edoardo Bridda
Edda - In orbita ep (Niegazowana,
Settembre 2010)
G enere : canzone d ' autore
Un anno fa Semper Biot ce lo ridava vivo e in salute
dopo un periodo difficile tra tossicodipendenza e inciampi esistenziali assortiti. In orbita festeggia invece
il primo anniversario del ritorno, un ep registrato lo
scorso marzo negli studi di Radio Capodistria riguardante l'Edda dal vivo, laddove l'ex Ritmo Tribale si presenta ancora più nudo di quanto non lo sia stato in un
disco d'esordio che era di culto già prima di essere
pubblicato.
Dei cinque brani in scaletta quattro sono presi proprio
da quel lavoro ma vengono riformulati per un organico
ridotto (vitale il lavoro di Sebastiano De Gennaro fra
percussioni ed elettronica), il quinto è una rilettura di Suprema di Moltheni che è pleonastico definire intensa.
L'ep si trova solo sul sito dell'etichetta e ai concerti ma
conviene appropriarsene: disadatto alle strutture trop-
po rigide, Edda sul palco modifica le proprie liriche in
itinere, ve ne aggiunge di altri (qui frammenti di Ancora
tu di Battisti e A tratti dei C.S.I.) e canta il tutto con
una spontaneità senza filtri che ha un qualcosa di ancestrale e intimo allo stesso tempo. Nudo appunto, ma
nell'irripetibilità del momento, quando conta soprattutto
ardere.
(6.8/10)
Luca Barachetti
Edwyn Collins - Losing Sleep
(Heavenly, Ottobre 2010)
G enere : pop , northern soul
Perdere il sonno, perdere la dignità. Chiedersi quale sia
il proprio ruolo, il proprio senso. Sopravvivere a un ictus non è esattamente una passeggiata, e Edwyn Collins
sceglie di raccontarcelo in maniera diretta, cruda, senza
troppi fronzoli. Punk, potremmo persino dire. Losing Sleep è l'album che fino a cinque anni fa, quando si trovava
47
semiparalizzato su un letto d'ospedale, mr. Orange Juice non avrebbe mai sperato di poter fare. Ecco quindi
dodici che più che canzoni sono poco controllate schegge di vita, sparate in velocità senza troppo curarsi della
forma - sì, quella forma e pulizia che nel bene o nel male
aveva segnato tutta la sua produzione post-Postcard.
Un ritorno alla ruvida urgenza naif degli esordi?
Nient'affatto, piuttosto la risposta a un'esigenza di immediatezza, derivata anche da limitazioni oggettive: la
riabilitazione motoria non è ancora completa e quindi il
re di Scozia ha soltanto cantato (per come gli è concesso, e purtroppo si sente) su un mucchietto di composizioni co-scritte - o meglio, devotamente regalate - da
una serie di amici vecchi e nuovi: dall'antico compare
Roddy Frame ai pischellini yankee Drums (la loro In
Your Arms è una delle cose migliori), dall'onnipresente
Johnny Marr ai suoi temporanei bandmates Cribs (la
più che mai Buzzcocks-iana What Is My Role), dagli
allievi primi della classe Kapranos / McCarthy (anche
se di Franz Ferdinand, in Do It Again, ci sono giusto i
cori) a Romeo Stodart dei Magic Numbers. Va detto,
dello smalto del precedente Home Again (del 2007, ma
realizzato prima della malattia) resta pochino, e quindi
non è propriamente un "bel" disco Losing Sleep. Ma ha
un suo senso. Vuoi come affettuoso tributo a una leggenda (ancora!) vivente, vuoi come necessaria catarsi.
Lo prendiamo come un - amabilmente prescindibile "bentornato".
(6/10)
Antonio Puglia
El Guincho - Pop Negro (Young
Turks, Settembre 2010)
G enere : strawberry jam
E' incredibile come Pop Negro sia segno dei tempi, di
questi tempi subito stanchi. In tre anni e tre album, siamo già passati dalla novità alla senescenza, dal contagio
diffuso alla pandemia alla "metastasi" (di uno stile e di
un modo di fare musica). E la cifra stilistica di Pablo appare qui supercaricata, superfetata, a un passo dall'autoparodia. La conoscenza del dato tecnico e di quello
linguistico non si discutono, ed è proprio questo che
sorprende, perché con la sua voce monotona, sempre
tirata, e la sua produzione coloratissima e impastata
Pablo non riesce proprio ad aggiungere nulla a quel
mondo - immaginario & suoni - indie Duemila di cui voracemente si nutre e che va dagli storici(zzati) Animal
Collective - a tratti si sfiora il plagio ideologico - fino
alle ultime propaggini glo/chill come ultimissima moda
di finto-bricolage ed esotismo terzomondista. Trentacinque minuti e nove pezzi tutti uguali, tutta la stessa
48
marmellata, con quelle tastierine vintage, quelle percussioncine, quelle chitarrine funky, quei ritmi spastici ed
esagitati (wonkypop?), quelle massicce solarizzazioni
calypso/caraibiche.
(5/10)
Gabriele Marino
EL-B - Dirty EP (Night Audio, Maggio
2010)
G enere : dubstep
Lewis Beadle è uno dei riconosciuti prime mover di quello UK garage che andava diventando dubstep, nonché
una delle pochissime persone citate da Burial nelle sue
pochissime dichiarazioni pubbliche (l'altro nome fisso è
ovviamente A Guy Called Gerald). Dirty è un EP di
sgranchimento con dentro quattro pezzi di media lunghezza, molta aria di post-techno e in evidenza la derivazione d'n'b, con un minimalismo in toni di grigio a base di
globuli dub e rullante step (l'ottusissima Dirty Dirty). Tre
pezzi davvero molto buoni, alta maniera, ma poi il brano
conclusivo lascia l'amaro in bocca, con quelle brutte tastieracce HHdancefloor e la brutta performance di Rolla
Mc.
(6.4/10)
Gabriele Marino
Elf Power - Elf Power (Orange
Twin, Ottobre 2010)
G enere : psych pop
"Dedicated to Vic Chesnutt. We love you Vic". Non
poteva mancare all'interno di questo disco la dedica
all'amico scomparso tragicamente, che gli Elf Power di
Andrew Rieger avevano accompagnato nel 2008 nel lo-fi
pop di Dark Developments.
Il gruppo di Athens, Georgia, presente nel collettivo
Elephant Six e tra i fondatori della label Orange Twin,
conta oramai una considerevole e apprezzata carriera
lunga ben 16 anni, spesa tra power e psych pop. Tornano
con un album omonimo, che si presenta come una sorta
di summa della loro carriera; c'è il loro pop scintillante,
nelle sue versioni psych e power, c'è il folk, il rock e in
sintesi, tutto quello che l'indie rock di razza riesce a produrre nelle sue innumerevoli incarnazioni.
In questo comeback ritroviamo le melodie ipnotiche ma
non il consueto ritmo ipercinetico, che qui è calato, a
favore di una compattezza e maggiori momenti di riflessione, una sorta di versione "adulta" della loro musica.
Magari il prossimo lavoro ci smentirà clamorosamente
chissà. Per ora ci piace questa metamorfosi.
(7.2/10)
Teresa Greco
EMA - Little Sketches On Tape
(Night People, Agosto 2010)
G enere : impro
Neanche il tempo di mettere la parola fine all'esperienza
Gowns col lungo, straziante brano dwld-only Stand &
Encounter, che Erika Anderson, metà cuore del progetto
condiviso con Ezra Buchla, si ripresenta. La spilungona
azzera il passato e crea dal nulla EMA, moniker/acronimo
che la aiuta a esorcizzare il trauma post-Gowns, presentandosi al mondo con una breve tape rilasciata sulla label
dell'ex Raccoo-oo-oon Shawn Reed.
Little Sketches On Tape è il titolo emblematico per
una serie di piccoli bozzetti notturni, dark e introspettivi,
inconclusi e struggenti per solo voce, piano e chitarra. Il
tutto condito da tape collage e rumori sparsi che risuonano di un feeling intimista, privato e sofferto: segno di
una sensibilità - e di una voce, c'è da dirlo - fuori dal comune, capace di agire a 360° tra cantautorato off, weird
music e impro di classe.
Le brevi composizioni dell'album sono state inoltre messe a disposizione di artisti, dilettanti e meno, invitati a
tratteggiare immagini partendo dalle suggestioni scaturite dall'ascolto della mezzora scarsa del disco.
L'ennesima dimostrazione del cortocircuito tra arte e
musica che sembra segnare questi anni '00 e un buon
surrogato per difendersi dalla nostalgia per la dipartita
dei Gowns.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Emanuele Bocci - Un po' Gabbiano
(Ottobre 2010)
G enere : C abaret
Dopo l'esperienza con Le Voci del Vicolo, Emanuele Bocci torna sulla scena musicale con il suo primo album da
solista. Divertentismo da cabaret: questo il genere che
predilige nelle dodici tracce di Un po' gabbiano. Bocci
si rifà allo stereotipo del cantautore toscano dall'ironia
scanzonata ma ragionata.
Fra giochi di parole e "grulli" livornesi (Paolo Ruffini
come special guest in Non ci sono più parcheggi), Emanuele cala le sue canzoni in scenari di quotidiana e futile
routine. In episodi sciocchi come Sono un automa e nelle
canzoni più "serie" (Dove era il bosco, Il musicista) l'imbarazzo assale l'ascoltatore per una scrittura priva fattura.
Stornelli alla Baccini da osteria di vicolo genovese (Gli
sfollati) ed incursioni in territorio ispanico a base di tarallucci e vino (Nunca mais) non convincono proprio, ne
divertono .
Al polo nord potrebbe essere la nuova hit di Canale3 Toscana o il pezzo forte della sagra del tortello. La voce
di Emanuele poco si presta all'espressività richiesta in
questo genere musicale; resta pulita, ordinata, senza vezzi
ne giochi e, più di ogni latra cosa, manca di una scrittura
briosa e simpatica. Questo disco dovrebbe risultare divertente, peccato non lo sia.
(5/10)
Giulio Bartolomei
Emiliana Torrini - Rarities (One
Little Indian, Settembre 2010)
G enere : P op , dance
Me and Armini terzo lavoro dell'islandese di stanza
a Londra Emiliana Torrini non aveva convinto. C'erano
degli eccessi di produzione, la scrittura non sempre reggeva la distanza, eppure i problemi non erano legati al
formato quanto alle finalità.
Perdendo l'aura magica dei primi due lavori, la trentenne
si trovava a diversificare gli arrangiamenti non approdando, in realtà, da nessuna parte se non ad un formato
piuttosto prevedibile e abusato. Questa doppia compila destinata ai completisti (e ai
lounge selector) ci dà modo di riscoprire alcuni inediti
del passato remoto di Emiliana come la Sugarcubesiana Weird Friendless Kid (splendida) ma soprattutto di
risentire i primi singoli della chanteuse in una quantità
disorientante di versioni tra dancefloor, r'n'b, hip hop,
chamber e teatro.
L'immagine che ci ritorna dell'Islanda di Love In The
Time Of Science (Easy, To Be Free e Baby Blue) è di
una terra - e lo sapevamo - molto legata al mainstream
americano e ai suoni soul, house, 2 step bristol-londinesi. Emiliana non si è mai voluta incasellare come
artista alt. snob, e questi "auto-featuring" ne rivelano
l'anima da performer versatile e sensuale. Sono praticamente tutte ottime le produzioni da party e after
party e i remix per mano di Rae and Christina, Toe
Johansson, Dreemhouse e Dillion and Dickens.
(7/10)
Edoardo Bridda
Emmablu - Eden (Slang Records,
Ottobre 2010)
G enere : rock
Il binario è di quelli senza nemmeno una curva. E porta
dritto dritto ai Led Zeppelin, ai Deep Purple, al rock
sudista degli Allman Brothers (Southern) e, per certi
versi, al nostrano progressive. Un hard-psych-prog tutto
organi, chitarre elettriche, batterie sincopate rubato ai
Sessanta/Settanta più elettrici ma senza eccessi gratuiti
che facciano storcere il naso o grettezze da cover band.
Pur rimanendo confinati in un'autostrada per il paradiso
49
highlight
Iosonouncane - La macarena su Roma (Trovarobato, Ottobre
2010)
G enere : elettro - cantautorato
Jacopo Incani è il frutto della sua biografia. Una biografia da loopstation, campionata su più livelli, in cui si
mescolano infanzia da cantautore, adolescenza barrettiana e attualità da discepolo di Flying Lotus. Ascolti
che trovano spazio in uno scantinato della Bologna meno allineata tra un
laptop e una chitarra acustica, con i vicini che scalpitano per le urla e una
rabbia sgraziata, poetica, profonda, a reggere il gioco.
C'è il Gaber lucido e spietato di Io se fossi Dio nelle corde di questo sardo
sotto i trenta trapiantato in Emilia, disperso in uno zapping di ghezziana
memoria e condito con gli scarti della TV spazzatura, attualizzato da un'elettronica sporca e omaggiato da testi provocatori e taglienti. Insomma difficilmente decifrabile ma necessario, per mettere a nudo il vivere squallido di
un'Italia da alberghetto a ore in bilico tra call center e precarietà, razzismo e
disparità sociale. Vi si da voce dall'interno, senza attenzione per le buone maniere o rispetto per la sensibilità retorica di chi nel disastro quotidiano ha trovato un proprio spazio vitale. Perché quando la tragedia
della realtà sgomita per emergere e tu ci sei dentro fino al collo, non puoi far altro che raccontarla per
com'è: surreale, cinica, violenta.
Quel che accade in una Summer On A spiaggia affollata, con i vacanzieri che esultano per i barconi naufragati dei clandestini (Una folla selvaggia che invoca a gran voce / la versione in carne ed ossa delle morti viste in
tv / poi finalmente il barcone affollato ribalta e comincia ad affondare / gli ombrelloni si gonfiano di un boato di
gioia e di saluti per chi da casa è rimasto a guardare) o in una title track in cui si sparano sentenze dal divano
di casa (Ma cosa fanno questi? Come vivono questi? Sanno solo fare figli / Disgrazie e figli /schifezze e figli / Ah!
Non siamo mica noi i pazzi / sono loro che devono starsene a casa / come faccio io / così si risolve / ah beh certo,
magari anch'io faccio schifo / certo ma qui dentro / dentro casa mia / nessuno mi vede), in una Torino pausa pranzo stile Thyssenkrupp piena di illustri ipocrisie (sulle panche donate da qualche imprenditore / la democrazia
siede in veste ufficiale / e il suo plotone di testimoni / saponette alla mano / ripassa il commiato per gli ultimi tra i
cittadini) o in una La macarena su Roma in cui la diretta TV diventa vita reale (Il trentanove, il mio portone / lo
riconosco è il mio portone / sono sotto casa mia / cosa faccio? Vado anch'io?/ Che cosa devo fare? / Devo scendere
devo andare? / no! È partito il televoto / oggi voto / oggi scelgo / oggi partecipo / oggi decido io).
Nessuna retorica, nessun nichilismo da generazione zero, nessuna pretesa di rappresentare qualcosa o
qualcuno, se non il diretto interessato. Un'individualità in bilico tra tragedie reali (Il corpo del reato), scenari
onirici disciolti in stile Dalì (Il ciccione), autobiografia (Il sesto stato) e improbabili macchiette calcistiche (Il
famoso goal di mano) ma capace di generare uno dei migliori esordi dell'anno.
(7.6/10)
Fabrizio Zampighi
di cui si conoscono già limiti di velocità e destinazione,
gli Emmablu riescono a suonare freschi e convincenti,
come del resto aveva già rilevato anche il buon Stefano
Solventi su queste stesse pagine ai tempi dell'esordio del
gruppo. A dimostrazione del fatto che Le Vibrazioni
sono solo la punta dell'iceberg di un revivalismo Seven50
ties "all'italiana" dato per spacciato in più di un'occasione
ma mai ufficialmente morto.
(6.7/10)
Fabrizio Zampighi
Eugene Chadbourne/Arbe Garbe
- The Great Prova (CPSR, Giugno
2010)
G enere : folk
Loro calcano da quindici anni i palchi italiani proponendo
un folk-punk urticante e nomade, multilingue - dilaletto compreso - e danzereccio; lui è una figura di spicco dell'underground statunitense, banjoista e chitarrista
d'avanguardia influenzato dal free e già collaboratore di
John Zorn, Violent Femmes, Jello Biafra, Camper Van Bethoven. Insieme hanno suonato durante un breve tour
all'inizio del 2010 e The Great Prova è il risultato di questa
collaborazione.
Registrato in presa diretta il ventisette febbraio, il disco
ha il pregio di andare oltre le solite schermaglie folk, e
se da un lato media come da copione tra balcani, ritmi
in levare e regionalismi, dall'altro può fregiarsi di una freschezza inedita garantita dal repertorio scelto - i brani
di entrambi -, da certe iniezioni di rockabilly e country
slabbrato (Ollie's Playhouse) e in generale da un'attitudine sperimentale quantomeno anomala per questi lidi.
Insomma, si balla ma si apprezzano anche gli spigoli rumorosi di Why Kids Go To School, i banjo briosi di The
Old Piano e Down The Drain, i Primus virati Messico di
Women Against Pornography.Tanto che per una volta quasi
ci si dimentica che si tratta di un disco live.
(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Fabio Orsi - Random Shades Of Day
(Privileged To Fail, Agosto 2010)
G enere : drone
Il dubbio principale è su dove incasellare questo Random
Shades Of Day, dato che dei tre cd che costituiscono il
packaging, i primi 2 sono di materiale unreleased o ormai da tempo out-of-print e il terzo, che intitola l'intera
operazione, a tutti gli effetti il nuovo album del musicista
tarantino-berlinese. Andando con ordine Orsi non si limita a riproporre alcuni dei suoi lavori migliori come i 3"
South Of Me (Foxglove, 2006) o Faded On The Blowing Of
Winter (Akoustic Disease, 2007), per forza di cose penalizzati dall'essere in edizione limitata, ma riesuma anche
tracce unreleased o molto rare come lo split 7" lathe cut
con l'amico Valerio Cosi. Trance music, drone, field recordings, rimandi etnomusicologi alla Lomax, personale
concezione di psichedelia si alternano tra allucinazioni e
slanci visionari dimostrando come anche il laboratorio
privato di Orsi sia degno di nota.
Nel terzo disco, il più nuovo anche cronologicamente, il
tarantino da fondo alle sue tendenze dilatatorie diluendo la title track in 4 movimenti all'insegna di un droning
fluttuante, ascensionale e di una sorta di "concept" sullo
scorrere della giornata. In alcuni passaggi il suono elaborato da Orsi è immobile, quasi estatico (Part I) o ancestrale come una slow motion sulla nascita del pianeta
(Part II), altre più minaccioso e oscuro come una colonna
sonora dei primordi (Part III), ma resta sempre fortemente evocativo, per quanto sfumato e scontornato dal
contesto a cui fa riferimento (qualunque esso sia). È ambient, è droning, è psichedelia e molto altro, ma sempre
a suo modo. Essenzialmente, però, è ottima musica che
dimostra per l'ennesima volta lo spessore e la sensibilità
di un ottimo musicista.
(7.3/10)
Stefano Pifferi
Fabri Fibra - Controcultura
(Universal, Settembre 2010)
G enere : hardcore rap
A fine anni Novanta, Fabrizio Tarducci aka Fabri Fibra
aka Sfiber/Fibroga, da Senigallia, era il nome su cui puntare nell'underground HH italiano. Voce nasale e impastata, immaginario slackerdepresso, rime funamboliche tra
slang e nonsense, un primo disco solista - generazionale,
Turbe Giovanili (2002) - patrocinato dalle basi di un Neffa
già lontano dalla scena. Poi la rottura con il produttore
della crew delle origini, Lato, e l'addio all'underground
con la svolta Eminemiana del marcissimo Mister Simpatia, sulla Vibra Records di Bassi Maestro. Due anni di
pausa e di messa a punto - e di crisi personale (droghe
comprese) - e arriva il Tradimento dell'omonimo passaggio alla major Universal, un cambio di rotta in senso bruttamente commerciale segnato dalle basi dell'ex Sottotono
Big Fish e da una radicale semplificazione del rappato.
Arrivano il clamore mediatico e il successo di massa,
grazie a mosse efficaci come i video-tormentone e in
generale i testi cattivi - a base di moralismo e insulti - dei
pezzi. Fibra diventa un personaggio, un guru, l'idolo dei
ragazzini, il bersaglio delle mamme e dei tg. La scena si
divide tra odio e rispetto. Passano tre anni e si bissa, anzi
si getta il carico, con Bugiardo.
L'interlocutorio Chi vuol essere Fabri Fibra? dello scorso anno è il segnale della stanchezza dell'uomo come
personaggio sovraesposto, superintervistato, anomalia
dentro il sistema eccetera. E' arrivato il momento del
rilancio. Fibra canta su Festa dei Crookers, in coppia con
Dargen D'Amico (altro nome di culto dei Novanta
reinventatosi nei Duemila con un percorso parallelo e
diverso), ma si va sempre più ridisegnando come "artista impegnato": conduce una trasmissione su Mtv in cui
"mostra la vita di giovani che vivono situazioni disagiate e
socialmente critiche, perlopiù stranieri o meridionali", si di51
highlight
Massimo Volume - Cattive Abitudini (La Tempesta Dischi, Ottobre
2010)
G enere : rock
Saranno pure cattive, ma suonassero tutte come questi 11 pezzi, alle abitudini dei rinati Massimo Volume
ci adatteremmo senza nessun problema. Sono passati ormai una decina d'anni da Club Privè e dalla colonna
sonora di Almost Blue, ma non ce se ne accorge nemmeno: appena Cattive
Abitudini comincia a girare a regime scatta il vortice spazio-temporale e i
Massimo Volume di oggi solleticano il palato come i Massimo Volume di allora. Inutile cercare in questo disco innovazioni o svolte sconvolgenti: il ritorno
più atteso del decennio vive delle solite, tese, vibranti canzoni da leggere che
azzerano lo iato già dai primi incroci delle chitarre di Egle Sommacal e Stefano Pilia. Basta quello per essere catapultati all'indietro. Stanze, 1993. Almeno
un paio di vite fa. Stessa emozione e stessa sorpresa.
La voce di Clementi è, al solito, un magnete che attanaglia subito l'ascoltatore
con le sue storie di ritorni e solitudini, maestri neanche tanto nascosti e esistenzialismo (mai) spicciolo. E
un rivolo d'autobiografismo collettivo nell'iniziale Robert Lowell, metà amaro, metà rassicurante, insieme ci
commuove e ci angoscia. Per la forza di parole solo in apparenza semplici e il timore di vedere di nuovo
svanire dalle mani questo gioiello di letteratura fatta musica. O viceversa. Perché di musica nei dischi dei
bolognesi ce n'è sempre stata molta. E ora, non ce ne voglia il passato, ce n'è ancora di migliore. Se del
ruolo di Mimì tocca giocoforza parlare in altri termini, i restanti tre sembrano un corpo unico, solido e
maturo. Il drumming di una Vittoria Burattini mai sopra le righe ma perennemente attenta e puntuale; le
chitarre dei compagni di mille reading, poi, sono forse la nota migliore, musicalmente parlando, del comeback. Dialoghi serrati o contrappunti lievi e impercettibili, elettricità o sottofondo, l'intarsio è sempre di
grandissima classe.
Mai ci saremmo aspettati un ritorno del genere. Lo avevamo sperato, questo sì. Ma stavolta i quattro sono
andati oltre ogni previsione rilasciando un album fresco e classico, che suona come i Massimo Volume che
ci saremmo aspettati ma che ci stupisce ad ogni nota, ad ogni parola.
(8/10)
Stefano Pifferi
chiara fan di Marco Travaglio, aderisce con entusiasmo
al Woodstock a cinque stelle di Beppe Grillo.
Ad anticipare Controcultura, esce Quorum, web album in free download con dieci pezzi veloci dove accanto al solito carosello anti-italico e agli ormai rodati
tocchi eminemiani - anche nelle basi - Fibra riscopre finalmente il piacere delle strofe. Fa autoanalisi nella title
track, più lucidamente del solito: "Ho un piede nel successo e l'altro nella fossa [...] Incastri che per te non hanno un
senso, era dieci anni fa [...] Faccio un ragionamento, faccio
un peggioramento e vendo per magia. Su in regia, non capite,
era tutta una strategia, a casa mia scrivo in camice bianco
come in farmacia".
Controcultura segue questa scia e va subito detto che
moltissime strofe spaccano e spaccano anche un casino,
con un recupero pieno del gusto della rima e del gioco
di parole. Parata infinita di produttori (Fish, Marco Zan52
girolami, Crookers e tanti altri) e basi meno tamarre
e più grimey del solito. I contenuti sono sempre quelli:
individualismo, schizofrenia, tristezza generazionale, società di plastica, televisione, la scena, nomi e cognomi
(Noemi Letizia, Marco Carta), delitti di cronaca. Su tutto
però, magari non per quantità ma per efficacia, vince il
lato autoriflessivo, quello più interessante adesso che il
Fibra moralista è definitivamente uscito allo scoperto,
si veda il pezzo con ospite Dargen, quasi un mea culpa:
"Non ricordo più quando eravamo bravi [...] Tanto l'originalità prima o poi la perdiamo tutti [...] noi che facevamo belle
lettere, belle rime Fabri, ora che fanno schifo facciamoci almeno le letterine"; "Sono un insensibile, come un insensitivo
che prende i soldi alle persone che stanno male. Anche io
faccio così, con le mie canzoni anche se ne prendo pochi [...]
ed è una bellissima insensazione essere qui in questo disco
di Fabri che sarà quello che venderà meno in assoluto". Dice
Fabri: "M'hanno creato a tavolino come un robot di plastica
[...] che all'improvviso rompe i giocattoli e fa un casino".
Oltre tutto, oltre l'incazzatura, le parolacce, l'impegno,
le belle strofe, i brutti incisi cantati, le basi ampiamente migliorabili, la sensazione del capolinea. E' un mezzo
homecoming? Con queste carte sul tavolo non sappiamo
proprio come e quando finirà la partita...
(6/10)
Gabriele Marino
Father Murphy - No Room For The
Weak (Boring Machines, Ottobre
2010)
G enere : wave
Battezzato come una frase tratta da Day Of The Lords dei
Joy Division e concluso da una scarnificata ed esangue versione di There Is A War di Leonard Cohen. Con
queste credenziali, il nuovo mini dei Father Murphy non
può sottrarsi alla tetra caligine che sembra riempirne
l'universo e che ha ormai definitivamente azzerato gli
squarci di luce dei primi passi.
Una musica che più che torturata è tormentata, inquieta,
travagliata, mossa da demoni difficili da comprendere se
non attraverso un percorso laterale e atemporale tra
estremi musicali e non solo: roba che tiri in ballo indifferentemente le musiche nascoste della New York fine '70
e l'immaginario visionario jorodowskiano, il misticismo
pagano e morboso e le apocalissi Swansiane, il neo-folk
di mr. Tibet o la new-wave più tetra e goticheggiante.
Ma non è questione di rimandi diretti, quanto di affinità
elettive che i tre adepti della chiesa del reverendo Murphy sono in grado di plasmare e restituire un sound personale, intimo, sentito e sofferto. Che si tratti di lunghe
indagini neo-drone-folk-rock come in We Now Pray With
Two Hands,We Now Pray With True Anger o lugubri e morbose esaltazioni dell'automortificazione (You Got Worry),
l'oscurità la fa da padrona. In maniera però elegantissima
e convincente. L'ennesimo grande passo.
(7.2/10)
affronta la materia. Deferenza frutto - ne siamo sicuri
- più di un affetto sincero piuttosto che di un tentativo
grossolano di plagiare uno stile. Eppure la musica funziona, anche perché l'Andreani non se la cava affatto male
nel trasporre in note la storia dei due partigiani della
52esima Brigata Garibaldi che fa da concept al disco.
Liriche profonde, approccio appassionato e un libercolo allegato con un intervento di Marino Severini dei
Gang, per un'opera che non smuoverà forse le montagne, ma possiede certamente una sua dignità.
(6.3/10)
Fabrizio Zampighi
Fops - Yeth Yeth Yeth (Monotreme,
Settembre 2010)
G enere : wave pop
Altro non attendevano che di ritagliarsi un po' di spazio
per mischiare con calma i rispettivi talenti, Dee Kesler
e Chadwick Donald Bidwell, il primo cantante nei Thee
More Shallows e l'altro autore nei Ral Partha Vogelbacher, band per così dire apparentate operanti in quel
di San Francisco. E così son nati i Fops, un chimismo
talmente effervescente da aver sprigionato nel giro di
poche sessioni non uno ma due album, il qui presente
Yeth Yeth Yeth e quel Priest In Them Caves già annunciato per l'inizio 2011.
Siamo dalle parti di un cantautorato krauto in fatamorgana wave, tastieroni caliginosi e vibratili come dei New
Order raggelati Kraftwerk (Ghost Town Hall) o strattonati Julian Cope (Yellow Jacket Corpse). Una specie di
calore differito Cluster condisce ogni traccia, da quelle
con una punta di Xtc nelle melodie (Black Boar, Scandinavian Preppie) a quelle che gettano una strizzatina d'occhio ai Wire meno esagitati (Glass Blower), e persino
nell'inattesa processione psych di Maple Mountain. Uno
sguardo retrò che pennella il presente.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Filippo Andreani - La storia
sbagliata (, Settembre 2010)
G enere : C antautore
Francesco Bearzatti Tinissima
4tet - X (suite for Malcolm) (Parco
della Musica Records, Settembre
2010)
G enere : avant jazz
Fabrizio De André, Massimo Bubola e Ivano Fossati, ovvero LA canzone d'autore. Per il suo esordio il
comasco Filippo Andreani sceglie coscientemente di
ricalcare in maniera didascalica la lezione dei maestri, registrando tredici episodi in bilico tra folk, testi impegnati
e melodia. L'aderenza ai modelli è a tratti quasi imbarazzante, tanta è la rispettosa deferenza con cui il Nostro
Torna il Tinissima 4tet di Francesco Bearzatti, band allestita in occasione del disco-omaggio a Tina Modotti.
L'occasione è una suite dedicata a Malcolm X, altro personaggio che ha cavalcato la Storia a pelo, subendone
tutte le conseguenze ma lasciando una traccia da cui è
impossibile prescindere. Le tappe della sua vita offrono
lo spunto a dieci episodi più una "digressione" in quel
Stefano Pifferi
53
di Kinshasa a celebrare l'epica impresa di Muhammad
Alì, che quasi dieci anni dopo l'assassinio di Malcolm sorta di formidabile nemesi - ne portò simbolicamente
a compimento l'utopia. La scaletta si dipana quindi tra
felpati post-bop, febbri free, trepidazioni blues (dal neanche troppo vago afflato Charles Mingus), spasmi funk,
solennità hip-hop (la funerea amarezza di Epilogue, per la
voce di Napoleon Maddox) e persino ibridi dance come
la guizzante Cotton Club.
Un autentico viaggio insomma nell'immaginario sonico
nero che ha accompagnato - anche solo idealmente - la
formidabile e controversa vicenda del cosiddetto "Detroit Red". Di Bearzatti apprezziamo la scrittura (molto
belle soprattutto la solenne Conversion e l'orientaleggiante Hajj), ma ancor più la propensione ad alternare
le trame di sax (ma anche clarinetto e xaphoon) con un
accorto ricorso all'elettronica (sentitevi A New Leader),
ingredienti che assieme allo stile frenetico di Giovanni
Falzone - e ai suoi "human effects" come margini selvatici
della tromba - ravvivano continuamente il sound, lo iniettano di imprevedibile e contemporaneità. Con due front
man così, spalleggiati da una sezione ritmica dinamica e
versatile, la presa sonica è garantita, in grado di superare
d'amblé la maggiore difficoltà insita in un progetto del
genere, ovvero determinarne l'urgenza, la necessità prima espressiva che "storica".
Il jazz non è certo obsoleto quando sa mettersi in gioco
con tanto entusiasmo, coraggio ed intensità. (7.4/10)
Stefano Solventi
Frankie Rose And The Outs
- Frankie Rose And The Outs
(Memphis Industries, Settembre
2010)
G enere : garage - gaze
Frankie Rose non è certo una sconosciuta; basta dire
che è stata (soprattutto) batterista di Crystal Stilts,
Vivian Girls e Dum Dum Girls per capire la portata
della sua figura - certamente centrale, per le esperienze
che ha attraversato, ognuna a suo modo significativa, nei
nostri anni.
Nella nuova compagine Frankie (come con le Vivian impegnata alle pelli, alla chitarra, e alle corde vocali) fa tesoro del suo curriculum, battendo il ferro caldo che aveva
contraddistinto le tre band menzionate, piene di efficacia
genericamente garagista. Frankie Rose And The Outs
viaggia anzitutto sulle possibilità di resa e scrittura efficace di canzoni scanzonate garage-psichedeliche, in un
terreno che tocca morbidezza shoegaze e piccole pillole acide Sessanta (la Count Five-iana Must Be Nice,
54
Don't Thread). Il combo lavora non certo sui riferimenti
maturi del genere dei My Bloody Valentine, quanto
sul presupposto dello shoegaze delle origini, quello dei
primi Jesus And Mary Chain (vedi Girlfriend Island, veloce esercizio preso senza troppe titubanze dal manuale Psychocandy - o, se vogliamo, dalla raccolta Barbed
Wire Kisses). Ci ricorda una volta in più come come gli
zuccherini dei Chain fossero auto-ascritti nel solco della
psichedelia Sixties (la finale Save Me, ballata a cavallo con
Galaxy 500).
Soprattutto la tecnica comprende però fresche revolverate Nuggets in tema garage (Don't Tread), qualche reminiscenza Vaselines, così come, curiosamente ma non
troppo, avvicinamenti alle versioni più americane di Syd
Barrett (That's What People Told Me), e quindi (la consecuzione è prevedibile ma piacevole) sovrapposizioni coi
nostrani Jennifer Gentle (Candy).
Sarebbe stato semplice, per Rose, procedere con gli automatismi del genere, e diventare prescindibile. Eppure,
così come per le formazioni di cui ha fatto parte, conferma la tenuta di un metodo di rispolverare che si limita a
fare ciò che sa fare, senza episodi che abbassino il livello:
essere freschi, saper scrivere canzoni.
(7/10)
Gaspare Caliri
Gerardo Balestrieri - Canzoni
al crocicchio (L'Alternativa,
Settembre 2010)
G enere : etno swing
Gerardo Balestrieri è un talento. Nel segno della nota
propensione apolide e generosa, si disimpegna tra swing
e tarantella, bosforo e latinoamerica, blues e chanson.
Incroci e incontri vissuti con naturalezza disarmante, con
la competenza di chi ha dovuto riparare mille motori
lungo la strada e non c'è ingranaggio di cui non sappia
l'incastro.A questo punto però bisogna metterci un però.
Perché questo secondo vero album d'inediti oltre un decennio dopo I nasi buffi e la scrittura musicale considerato che Un turco napoletano a Venezia vedeva in scaletta solo riletture di brani tradizionali - non
convince del tutto. Sembra mancare il sale del vissuto,
sia pure in guisa di trasfigurazione teatrale (guitta e blasé
alla Paolo Conte, che resta tra i riferimenti principali,
oppure in punta di delirio à la Vinicio Capossela, che
invece non c'entra molto).
Forse il problema è che non sai bene dove finisca la calligrafia e inizi il mestiere, un mestiere capace di giocare
carte spettacolari (vi basti la taranta-country-swing di
Canzone ingiuriosa) ma in qualche modo più incline alla
forma (la graziosa Rouen, la frenetica Ormai non provo
più gaiezze, la disillusa Canzone al crocicchio) che non
all'espressione. Come dire: è più posa che poesia. Sensazione che non cessa neanche con l'avvincente psychballad tzigana di Kegame, con la milonga turcomanna di
Camera con vista o con quella Casa che prende in prestito
il malanimo enigmatico di De André, salvo poi sparagliare
tutto con palpitante frenesia balcanica. Uno spettacolo
d'arte varia senz'altro gradevole, ovvero avvincente, ma
non troppo coinvolgente. Spero d'essermi spiegato.
(6.2/10)
Stefano Solventi
Goldmund - Famous Places (Leaf,
Ottobre 2010)
G enere : piano , soundtrack
Il 2010 sembra l'anno di Keith Kenniff. Il ragazzo di Portland ha preso moglie e qualcosa nella sua vita è cambiato
negli ultimi mesi: ha inaugurato ben due nuovi progetti
e un'etichetta discografica che porranno definitivamente fine alla dicotomia che lo ha sempre contraddistinto,
ovvero Helios e Goldmund. Tra la fine di quest'anno e
l'inizio del prossimo assisteremo alla nascita sia dei Mint
Julep, dediti all'indie rock/shoegaze (band che lo vedrà
accanto alla compagna), sia un altro progetto, Meadows,
che si occuperà di musica per bambini. Le due formazioni hanno già un bel po' di materiale pronto e wikipedia
ci dà i titoli degli album: Save Your Season e The Littlest Star, entrambi previsti per 2011.
Sono avventure molto diverse da quelle del tutto complementari intraprese fin'ora dal poliedrico musicista, e
la prova del tre sotto il nickname Goldmund sembra
dunque un momentaneo addio alle vesti di compositore e storico di colonne sonore, e non un nuovo tassello. Dopo Courduroy Road e The Malady of Elegance,
l'ex studente della Berklee College of Music esplora perciò un'americanità che ha i contorni della definitiva cifra
stilistica. Famous Places parla di luoghi che significano,
o hanno significato, qualcosa per lui, ambienti armonici
che descrivono contemporaneamente luoghi, situazioni
e ricordi.
Collaborando con registi indipendenti e componendo
musiche per spot pubblicitari, Kenniff è diventato maestro nel disegnare con la mente le strategie della telecamera e con i tasti imprimere i colori e le prospettive, nel sottolineare sfumature e sensazioni con i piccoli
interventi elettronici e ambient. L'album rappresenta
pertanto una perfetta colonna sonora per un pamphlet
stellestrisce, fortunatamente lontano dalle finte smancerie e dagli struggimenti hollywoodiani o dall'orgoglio
nazionale dell'ultimo Van Dyke Parks. Goldmund è indissolubilmente legato al cinema ne-
oclassico, e i maligni malignino sulla frustrazione di un
musicista che voleva fare il regista. La sua è musica intelligente, fuori dal tempo e che sul tempo riesce a narrare,
ma soprattutto un ascolto prezioso che svela nuovi segreti e particolari ascolto dopo ascolto. Sarà un addio?
(7.1/10)
Gemma Ghelardi
Grey History - Lucifer Over
Disneyland (Radical Matters,
Agosto 2010)
G enere : power - noise
Due celebri figure dell'avanguardia italiana si nascondono
dietro Grey History, sigla che, oltre a rinsaldarne l'amicizia, sposta oltre i paletti delle ormai quasi decennali
collaborazioni. Fabio Orsi e Gianluca Becuzzi, loro i
protagonisti, si muovono stavolta non più sulla scultura
di suoni (l'ottimo So Far con (etre) su Porter) o sul versante più synth-pop della wave/post-punk, vedi i recenti
album a firma Noise Trade Company.
La scelta ricade su un ambito musicale di matrice grey
area, con una particolare predilezione per i momenti più
harsh e white noise dell'area più estrema di industriale
ed electro. Power electronics violenta e nondimeno sarcastica, industrial-noise primigenio e humor nerissimo
col suo immaginario (s)fatto di mickey mouse nazisti e
disneyland luciferine: Boyd Rice benedice dagli inferi,
Albin Der Blutharsch Julius se la ride, Whitehouse fa
da mentore in lontananza e Maurizio Bianchi controlla nelle retrovie, ma la mano dei due - in particolare del
background giovanile becuzziano - si nota eccome.
Il declamare acido di A Cheap Holiday in Siberia svetta su
tutto il resto, col suo sincopato incedere ebm unito a
folate di gelida harsh, ma in generale tra droning imbastarditi (Armed Struggle Is Not Terrorism), vecchia e cara
scuola industrial for the iron youth (God To Them All The
Rest Of Us), ambient imputridita e fastidiosissima (East
Carers Commando), di carne (umana) al fuoco ce n'è. E
sempre di ottima qualità.
A garantirne, se si avessero ancora dubbi, è la Radical
Matters, che si propone come al solito con grande eleganza e materiali poveri, inscatolando il cd in una copertina da 7" curata in ogni dettaglio.
(7/10)
Stefano Pifferi
55
Half-handed Cloud - As Stowaways
in Cabinets of Surf, We Liveout in Our Members a Kind of
Rebirth (Asthmatic Kitty Records,
Settembre 2010)
G enere : schizo - folkpop
Si legge dalle note: John Ringhofer ha registrato il nuovo lavoro di Half-Handed Cloud, Stowaways (abbreviazione di As Stowaways in Cabinets of Surf,
We Live-out in Our Members a Kind of Rebirth),
mentre faceva il custode di una chiesa di Berkeley, grazie alla sua tape machine portatile. Sembra fili tutto con
il passato dei cinque album di John, culminato nella raccoltona Cut Me Down & Count My Rings. Probabilmente
il grosso dei fan rimarrà lo stesso, ma non certo quelli
più affezionati all'obliquità a cui Ringhofer aveva abituato.
La sua musica ha sempre avuto la peculiarità di voler
rincorrere gli appunti che scappano, che se non te li
segni sono perduti. In Stowaways ciò contrasta con la
tradizione iper-storicizzata, e condivisa, di alcuni inni
americani del diciannovesimo secolo, espressamente
citati nelle lyrics. Eppure Half-Handed Cloud lascia
qualche pezzo sulla strada, finendo col risultare - per
così dire - deficitario nella principale caratteristica della produzione precedente: essere memorabile e memorizzabile, avvicinando l'unicità, nella confusione lirica e
melodica del sound espresso.
John ha sicuramente guadagnato in spirito sornione alla
Kevin Ayers (The Sea Has No Face, I'm Over The Need
To Bail), tutto sommato sorridente se ci pensiamo - ma
come il Gatto del Cheshire carrolliano. I bozzetti della mezza mano funzionano ancora (Splashdowns Hold
The Hymnal Together); HHC si mima clandestino, ma pur
sempre entro la cornice del folk singer che non rinnega
la provenienza (Out on the Ice, We Face Our Hearts) e
la linearità, all'uopo (Divers Divers). Stowaways è un
flusso di venticinque pezzi che ricorda gli esperimenti cantautoriali scanzonati - o de-canzonati (Concentric
Groups of Mirrored Loops) - di Harry Nilsson o della
giovialità para-cameristica di VanDyke Parks. Ringhofer non rinuncia all'arrangiamento "sovrascritto", che
include piano, ottoni, piccoli circuiti (Brooks Embracing
Burdens).
Ma, in definitiva, lo scarto maggiore è quel suono ripulito,
come fosse un vaudeville in chiaro, senza l'idea di carrozzone itinerante. Fa eccezione qualche solito frammento
lasciato galleggiare (Guy With Driftwood Skin), complici i
fiati e la schizofrenia dei vecchi tempi, che accalcava e
continua in questo caso ad accumulare felicemente temi
in rapidissima successione. E questo forse è l'Half-Han56
ded Cloud che vediamo meglio e vedremmo bene nei
prossimi capitoli ringhoferiani.
(7/10)
Gaspare Caliri
Helmet - Seeing Eye Dog (Work
Song, Settembre 2010)
G enere : noise - rock
Suona irrimediabilmente datato il nuovo album della
noise-legend Helmet, ma almeno non tocca i livelli imbarazzanti dei dischi post-reunion Size Matters (2004) e
Monocrome (2006).
Scordatevi la disturbante abrasività chitarristica di Strap
It On (1991) e lo squadrato e chirurgico procedere noise
di Meantime (1992). Quegli Helmet sono morti praticamente allora, al momento di trasformarsi in un ingranaggio mainstream con le devianze accessibilmente pop di
Betty (1994) e, peggio ancora, con l'inconcludenza di Aftertaste (1997), definitiva pietra sulla carriera del combo
newyorchese. Il ritorno non è che sia stato dei migliori,
con cambi di formazione che catalizzano ancor di più
il peso della formazione sull'ego del chitarrista e unico
superstite Page Hamilton, ma tant'è. Di reunion inutili ne
abbiamo viste e ne vedremo moltissime.
Tornando a Seeing Eye Dog, di frecce al proprio arco ne
ha, soprattutto nel dittico iniziale So Long e la title track:
due songs compatte, furiose e condite di chitarre al vetriolo che fanno sperare in un ritorno ai tempi d'oro.
Poi però il disco comincia a fossilizzarsi su una sorta
di noise-pop in the vein of Foo Fighters e affini virato
metal (Welcome To Algiers o la sinceramente orribile And
Your Bird Can Sing): si lascia da parte la carica sovversiva e/o disturbante in favore di un rifferama potente ma
prevedibile e scontato, spesso banale. La scrittura poi è
visibilmente catchy, tanto che verrebbe da definirla pop
se non si trattasse degli Helmet.
Tecnicamente ottimo e perfettamente prodotto, Seeing
Eye Dog è un passo avanti rispetto agli album dei 2000s
ma è pur sempre un rammarico per chi ha apprezzato
l'impatto violento e visionario dei primi Helmet.
(6.4/10)
Stefano Pifferi
High Wolf - Ascension (Not Not
Fun, Settembre 2010)
G enere : tropical - psych
Approda finalmente sulle spiagge Not Not Fun, il francese High Wolf e ci saremmo meravigliati del contrario.
L'etica e l'estetica della one-man band d'oltralpe, oltre
che il suono e l'attitudine, portavano alla etichetta di
Britt e Amanda sin dai rigurgiti psych dei cd-r autopro-
dotti col marchio Winged Sun. Assonanze e affinità tra
marchi e sigle molto più vicine di quanto la geografia
faccia pensare, certificate prima dalla tape Animal Totem
e ora da questo esordio in vinile lungo Ascension. Come
da titolo, un lungo trip in 5 canzoni fatto di foreste tropicali e effluvi post-psych creati col supporto di strumentazione desueta (tablas su tutte, ma anche synth
analogici) e spirito girovago (il nostro è reduce da un
mega-trip in India e zone limitrofe alla ricerca di field
recordings e ispirazione). Roba che spappola il cervello
e sposta la percezione, creando "quarti mondi" insieme
immaginari e reali a disposizione di sensibilità inclini
all'ascolto.
In particolare, Meeting Of The Three Seas e Fire In My Bones si fanno apprezzare per il loro taglio trance-inducing,
fatto di flutti di droning rituale e tribalismo acceso, ma è
l'intero assemblaggio che fa di High Wolf uno dei modelli
di riferimento della nuova psych "tropicale". A ruota, altri
dischi in solo (Shangri L.A. per la giapponese Moamoo) o
in combutta con spiriti affini (Neil Campbell a.k.a. Astral
Social Club nel progetto Iibiis Rouge) stanno lì a dimostrare lo spessore del freak francese.
(7/10)
Stefano Pifferi
Jack Sparrow - Circadian
(Tectonic, Ottobre 2010)
G enere : techstep organico
Dopo Cyrus, Pinch e 2562 arriva il quarto moschettiere
in casa Tectonic, la label di techstep gestita dal maghetto
liquido di Underwater Dancehall. Jack Sparrow è il ragazzo
di Leeds che atterra sulla label di Bristol e importa il suo
mondo spezzato, technoide, magico, alienato, fumoso e
drogato di osmotica biologia erditata dagli O.R.B.: le voci
ambient e i pigolii dei uccellini, quelle cose che hanno
fatto incetta di fan nelle lande e nei prati inglesi poi trasferitisi a Goa.
Il paragone può sembrare peregrino, ma l'escapismo
di questa linea di dubstep tutta concentrata sul taglio di un glitch che ricorda il d'n'b pulito della Moving
Shadow e di quei loschi figuri insabbiati nella diaspora
fine anni Novanta della jungle, emerge con un sogno
visionario che si rifà all'immaginario biotech e che sta
in piedi senza scimmiottare nessuna 'scena' o tendenza à la page.
Con l'aiuto dell'amico produttore Ruckspin e con le
belle vocals di Indi Kaur (che aveva già collaborato con
Pinch), il pirata del techstep si porta su un livello creativo
che non ha nulla da invidiare ai suoi compagni di scuderia. Il ritmo circadiano che ci impone con questa ora di
ritmo va ascoltato dall'inizio alla fine. Una meditazione
technoide che varia tra tribalismi ragga e punte di jungle
glaciale a 160bpm. Sopra la media.
(7.3/10)
Marco Braggion
James Blackshaw - All Is Falling
(Young God, Settembre 2010)
G enere : folk elegiaco
Fin dall'esordio risalente al 2004 non passa anno nel quale James Blackshaw non pubblichi uno o più lavori. Per
il 2010 è la volta di All Is Falling, titolo animato da uno
spirito apocalitticamente elegiaco sull'onda della partecipazione agli ultimi due dischi dei Current 93 di David
Tibet, con tanto di marchiatura Young God al seguito.
Il compositore inglese nasce come fingerpicker puro,
incidendo nel 2006 O True Believers - che ad oggi rimane il suo capolavoro, nonché uno dei dischi più importanti del nuova generazione post Basho-Fahey - e
rimane tale almeno fino al 2008, quando con Litany of
Echoes allarga al pianoforte e agli archi il proprio interesse compositivo. Da lì la svolta dichiarata ufficialmente con il successivo The Glass Bead Game dell'anno
scorso: fra l'influenza dei raga e quella del minimalismo
più canonico Blackshaw sceglie la seconda, concentrandosi su una scrittura che pur non essendo mai priva di
una buona dose di virtuosismi prova la zampata emozionale sul gioco di ripetizione-variazione tipico di tutto il
filone nymaniano.
All Is Falling riprende i presupposti del suo predecessore e li allarga, ribadendo l'intenzione compositiva prima che performativa di Blackshaw e collegandolo pure
a riferimenti ad oggi quasi del tutto inediti. Così lungo le
nove parti di cui è composto il disco scorrono, accanto
ai classici climax albeggianti di marchio Nyman (Part 2
per chitarra e archi) e a qualche calligrafia pianistica di
troppo (Part 1), echi sinistri e sensibilmente psicotici alla
David Maranha (Part 8) ma anche lunghe narrazioni
cinematiche come dei Six Organs Of Admittance
dediti all'evocazione cameristica (Part 7) e addirittura
uno scampolo percussivo (eseguito dallo stesso titolare)
in Part 6.
Il tutto è complessivamente omogeneo, al punto che
non appare per nulla casuale la scelta di dare alle singole
tracce una numerazione in parti. Nonostante ciò il miglior Blackshaw continua a rimanere quello folkeggiante e chitarristico del sopra citato capolavoro. Conforta
però trovarlo oggi in trasformazione, lontano da qualsiasi stagnazione interlocutoria ed immerso in un discorso
sicuramente destinato ad evolvere ancora.
(6.9/10)
Luca Barachetti
57
highlight
Non Voglio Che Clara - Dei cani (Sleeping Star, Ottobre 2010)
G enere : canzone d ' autore
Forse siamo al punto di non ritorno, meglio di così non si può fare. Anche a fronte di quello spirito di
continuo recupero di ogni cosa - per cambiarne e contaminarne un parte o poco più - che è stata la cifra
degli anni zero e di quest'appendice duemiladieci chissà quanto lunga ancora. Al ripristino di un certo
cantautorato italico pre-settanta, rivisto con sensibilità neo-romantica e ascolti posteriori, i Non Voglio
Che Clara hanno dato uno dei maggiori contributi. Qualitativi più che quantitativi, con soli due dischi dal
2004 ad oggi, di cui almeno uno (l'esordio Hotel Tivoli del 2004) fondamentale per capire quello sguardo
all'indietro dato da una parte sostanziosa del songwriting indipendente sulla
produzione dei vari Tenco, Bindi, Paoli, Modugno e Ciampi pure.
I nomi, ognuno con le proprie peculiarità e le proprie distanze da quella stagione, li conoscete: Grazian, Baustelle, Benvegnù, lo stesso Morgan prima che
venisse divorato, e via dicendo. Ma è naturale che siano i bellunesi capitanati
da Fabio De Min a firmare il disco definitivo a riguardo. Dei cani ripete
esattamente quanto fatto negli anni dai nomi citati e dagli stessi Clara. Ma
con più lucidità, molteplicità d'influenze, eppure omogeneità del risultato. La
produzione di Giulio Ragno Favero che compie l'operazione opposta a
quella messa a punto per l'ultima magnifica uscita dei Valentina Dorme - là pulizia, spigoli, durezza; qui
immersione in una soluzione orchestrale che non compete solamente agli archi ma coinvolge chitarre,
organi, fiati, addirittura la voce. E poi la scrittura di De Min, il diario di uno o più amori finiti insieme ad
una stagione inevitabilmente di passaggio (Gli anni dell'università), dove la prima persona non è una questione meramente grammaticale ma diventa il taglio emotivo di un racconto che mescola nostalgia, rabbia,
malinconia, (livide) speranze.
Si parte con La mareggiata del '66, titolo alla De Gregori, indole spectoriana calibrata il giusto rispetto ai
Baustelle su major, liriche da brivido che vorresti sentirle cantate da quella Patty Pravo d'allora. Poi Il
tuo carattere e il mio, che con le sue schegge d'elettronica e le vertebre di post-rock crepuscolare a tenere
alto il brivido pensi sia la traccia con i Port Royal ospiti e invece no, è la successiva, Le guerre, primo dei
due episodi chiaramente imparentate al beat (l'altro è Secoli, che mischia pure Brian Wilson e Flaming
Lips). Più in là, poi, è la già citata Gli anni dell'università a stanare l'ascoltatore: il testo nella seconda parte
è puro Paolo Conte ipermalinconico ma in ectoplasmi vocali alla Morricone e chitarre baluginanti
come insegne che si spegneranno a breve. Tutti momenti di pari e inaudita intensità mentre il resto tiene
la tensione al giusto grado e piazza i Non Voglio Che Clara nelle posizione alte di un'ipotetica classifica del
neo cantautorato italiano. Nettamente staccati dagli ultimi Baustelle - dai quali non hanno fortunatamente
preso lo spleen d'apocalisse citazionista - ma ad inseguire la progettualità intellettuale de I moralisti degli
Amor Fou. Nati e cresciuti già oltre quel bianco e nero fin troppo vintagistico sul quale i Non Voglio Che
Clara completano ora il loro sorpasso.
(7.5/10)
Luca Barachetti
Junip - Fields (City Slang, Ottobre
2010)
G enere : psych folk
Esistono dai primi anni zero, ma esordiscono in lungo
solo oggi gli svedesi Junip, trio capitanato dal chitarrista e cantante di origini argentine José Gonzàlez, al
cui successo come solista (due album molto venduti, soprattutto in UK) si deve questo slittamento decennale.
58
Meglio tardi che mai, perché le undici tracce di Fields
sono davvero gradevoli per non dire intriganti: folk psych
in tiepida guazza elettronica, dolcezze lisergiche servite
con flemma da maggiordomi pusher, il piglio sottilmente
robotico ad innescare la seduzione ossessiva di raga placidi, la vena che d'un tratto s'imbizzarrisce in un galoppo
irrequieto.
Gioca a loro favore e non potrebbe essere altrimenti il
canto lunare di Gonzàles, che ci ricorda in qualche modo
le più morbide escursioni della Beta Band, così come
non sembra peregrino segnalare elementi di paragone
con George Harrison ed il più assorto John Martyn.
(7/10)
Stefano Solventi
K-X-P - K-X-P (Smalltown
Supersound, Agosto 2010)
G enere : K raut , synth rock
Abbiamo giusto intuito con gli Arp di The Soft Wave
che la nuova ondata di corrieri cosmici non disdegna
qualche pennellata d'attitudine noise newyorchese. E se
dici NY e metti sul lettore l'attacco di Pockets arrivi direttamente sul lato rockista della faccenda, magari immaginando le mani (e le braccia) di Martin Rev dimenarsi
sul synth. Dietro alla criptica sigla si nasconde tuttavia
ben altro: salvo la summenzionata traccia e il traino di
18 Hours (Of Love) (adorata dalla cricca Optimo) non
troviamo un ego à la Alan Vega a mettere a ferro e fuoco il mix sonico bensì tre disciplinati finnici professanti
una rigida disciplina lisergica nello stile impersonale degli
Add N To X (Labirynth). Proprio come i tre britannici
dell'acclamato Avant Hard, anche qui: niente chitarre
e niente canzoni, ma calcolati motirik Neu! e acidi controllatissimi a base di Can, Spacemen 3 e This Heat.
La mente dietro al progetto non è l'ultimo venuto: Timo
Kaukolampi, ex Op:l Bastards e The Lefthanded, noto ai
più come produttore della divetta Ottanta di casa Smalltown Annie, è dal 2006 che anelava l'idea di una personale versione degli Lcd Soundsystem. Le macchine e
lo studio dove far convergere rock, dance e synth-delia
anni '70 non gli sono mancati ma chiedergli - come han
auspicato molti addetti - il capolavoro, dopo quasi un lustro di riferimenti e referenti prossimi, era decisamente
troppo.
L'uomo, più umilmente, riesce a imbastire un'esaltante
sintesi sonica con dei momenti all'altezza del mito e altre
cose di buon mestiere (Aibal Dub, la Vangelis-iana New
World) tutti trip da godersi sotto un palco invece del
solito salotto fumoso. Non è poco a dir il vero.
(7/10)
Edoardo Bridda
Kelley Stoltz - To Dreamers (Sub
Pop, Ottobre 2010)
G enere : P op psych
Li abbiamo recensiti più che positivamente con il precedente Circular Sounds ma è probabile che il nome
di Kelley Stoltz dica poco o nulla ai lettori di SA. Nel
variopinto rooster della rinata Sub Pop, il suo è uno dei
nomi meno hyped, schiacciato tra corazzate indipendenti
come Male Bonding, Dum Dum Girls e Avi Buffalo. Perdersi questo suo ultimo lavoro sarebbe però, anche questa volta, un peccato. Significherebbe farsi mancare uno sguardo obliquo e smaliziato su un tema trito
come quello della melodia lisergica di ascendenza 60s.
Stoltz ne da un'interpretazione fresca, che fagocita elementi di modernariato pop (le sfuriate di fuzz, le fughe
psych, gli "aah" e "oooh" a profusione, le chitarre al contrario) e li trasfigura grazie alla lente distorcente della
produzione DIY.
E' facile intravedervi una lunga gavetta a base di home
recording e cut & paste sonoro, tuttavia la sua è una
concezione opulenta della canzone che lo porta a stipare spectorianamente ogni idea nelle poche tracce a
disposizione.
To Dreamers è ricco di trovate ritmico-melodiche,
racchiuso fra gli estremi costituiti dalla alambiccata
costruzione wilsoniana di Baby I've Got News For You, e
dall'ispirata poesia di August, sorta di incontro/scontro
fra la malinconia asciutta di Nick Drake e gli svolazzi
psichedelici di Syd Barrett. Basterebbe poi ascoltare
una versione acustica di I Don't Get That, per goderne
della fine grana melodica e appurare le doti di Stoltz in
qualità di sofisticato artigiano pop.
E' l'ottavo album per questo menestrello del Michigan,
attivo sin dal '99 a riorganizzare i propri 60s in piccole
visioni ad uso e consumo dei sognatori moderni.
(7/10)
Diego Ballani
Killing Joke - Absolute Dissent
(Spinefarm, Settembre 2010)
G enere : wave , hard
Averlo visto al Primavera Sound del 2006 pitturato
come un Kiss dimenarsi come un vecchio animale da
palcoscenico non mi ha certo colpito positivamente.
Tutto quel grandguignolismo a base di horror e pose
grottesche non era proprio il massimo anzi, pareva una
regressione bella e buona dei presupposti post-punk dai
quali il festival barcellonese era partito. Del resto, non vi
era dubbio che lo spettacolo di Jaz Coleman e dei suoi
compagni di un tempo Killing Joke aveva qualcosa di perversamente attrattivo. Youth, il produttore e bassista,
Geordie Walker con i ritrovati riff granitici - spesso raddoppiati da tastieroni messianici - formulavano un mix
mutante, nu metallico e assieme synth-etico con il quale
finivi per fraternizzare. Absolute Dissent lo ripropone in studio con nuovi brani che sembrano una risposta
goth-wave all'ultimo Klaxons o una versione malata del
59
gospel-soul dei Depeche Mode (tirati in ballo nel singolo European Super State).
Con quella lama di dramma e farsa, evo hard rock e
sintetiche nu metal, i vecchi KJ, orfani del bassista Paul
Raven (deceduto nel 2007) e tornati in formazione originale, suonano sempre truzzi e beceri trovando un viatico nella contemporaneità macinando sapientemente
l'abecedario di riferimenti storici di cui sono capaci: bassi
cadaverici Big Black, sincopi Melvins (This World Hell),
persino pose Motorhead (End Game) e un tantino di
romanticismo asciutto di casa Sheffield (Honour The Fire)
condito di citazionismi Pil (Ghosts On Ladbroke Grove su
basi dub).
Coleman e compagni mostrano di saper rielaborare idee
e influenze proprio come fecero gli Wire di Send, dei
quali recuperano la monoliticità; rivendicano l'evo barbaro che venne prima dei Muse ricordando a Bellamy
e co. che sono i coglioni e la tecnologia l'unico binomio
possibile. Nella loro brutalità calcolata, non c'è che dar
loro ragione.
(6.8/10)
Edoardo Bridda
Lele Battista - Nuove Esperienze
sul Vuoto (Mescal, Settembre 2010)
G enere : cantautorato
La citazione da Pascal incastonata in fondo al booklet
indica l'intenzione meditativa di questo secondo lavoro
da solista dell'ex La Sintesi. Le dodici canzoni di Nuove Esperienze sul Vuoto scelgono infatti il lato interiore
dell'esperienza umana, preferendo però le tonalità soffuse
ad un più prevedibile colore scuro e guadagnando così in
(sottile) imprevedibilità. Piace dunque questo Lele Battista più calibrato rispetto al precedente Le Ombre,
ancora una volta in bilico tra Franco Battiato e David
Sylvian ma con una maggiore consapevolezza di scrittura. Le trame elettroniche usufruiscono di un lavoro di
artigianato che punta ad un suono capace di riempire i
luoghi di ascolto come le menti. Il punto di partenza è
Brilliant Trees, quello di arrivo forse Blemish.Tuttavia
di strada ce n'è ancora tanta da fare, fermo restando
che il nostro quando prova la sviata in combutta con
Mauro Ermanno Giovanardi (il crescendo un pizzico coldplayano di Attento) trova il momento migliore di
un disco da odorare e poi assaggiare lentamente. Come
quei vini non eccellenti ma che diventano buoni se gli si
concede tempo e attenzione.
(6.8/10)
Luca Barachetti
60
Locrian - The Crystal World
(Utech, Novembre 2010)
G enere : D rone
Ci avevano lasciati appena 6 mesi fa con l'esperienza
multi-collaborativa di Territories, ora tornano con The
Crystal World, nome mutuato da un racconto di J.G.
Ballard. E se anche in questo album figura un nuovo nome
oltre al duo originale André Foisy/Terence Hannum, il lavoro di Steven Hess (On, Pan American, Ural Humbo) alle prese con elettronica e percussioni, sembra più
quello di un terzo elemento che di una comparsa.
Facile intuire che questa scelta sia servita a intensificare
e addensare l'output sonico della band, di nuovo sotto
l'ombrello di quello stesso drone annerito che caratterizzava l'esordio in studio Drenched Lands. Niente più
doppie casse o chitarre in tremolo ma di nuovo lunghi
feedback e synth con sustain infiniti, heavy metal mutato
drone che non abbandona i suoi contatti con il genere
originario. Ci sono ancora parti di chitarre che suonano
come tali e non si è perduto del tutto il concetto di canzone à la Neurosis e Sunn O))), due band con le quali
i chicagoani potrebbero iniziare a competere, sia per la
cura dei suoni, sia per la forte componente evocativa.
The Crystal World è la riprova di come la band sappia
muoversi con naturalezza lungo più direzioni e strumenti non proprio ortodossi per il genere. I cori angoscianti
di At Night's End, il piano di Obsidian Facades o la chitarra
acustica e gli archi di Elevation And Depths suonano perfettamente a loro agio tra rumori ed urla lancinanti.
La versione in cd contiene inoltre un secondo disco, non
presente nel futuro vinile, una traccia unica delle evoluzioni lentissime che presenta nel modo meno compromissorio possibile quello che è il suono di questi ultimi
Locrian.
(7.2/10)
Leonardo Amico
Lonesome Southern Comfort
Company (The) - Charles The Bold
(On the Camper, Settembre 2010)
G enere : folk rock
Lui è John Robbiani, svizzero, ma si appresta a scuoterci
l'immaginario col nome di The Lonesome Southern
Comfort Company. E' recidivo. Lo ha già fatto prima
come chitarrista dei Far From The Madding Crowd,
poi appunto con questo progetto in solitario, pur aiutato dai vecchi compagni di viaggio (tra cui i compagni di
etichetta Peter Kernel), previo un album omonimo ad
agosto 2008. Quindici le tracce del debutto, altrettante nel presente sophomore Charles The Bold. Solita
la vena folk-rock con qualche inevitabile strappo psych,
highlight
Phantom Band (The) - The Wants (Chemikal Underground Records,
Ottobre 2010)
G enere : neo - wave
Buonissimo segno quando un gruppo odierno mette in difficoltà e spinge a
citare tanti e tra loro diversi nomi per spiegarlo in qualche maniera. Sono
dei bei tipi, questi scozzesi in giro da un lustro - alle spalle alcuni singoli e un
altro album (l'interessante però acerbo Checkmate Savage edito lo scorso
anno) - e scappano dalle mani come anguille appena pescate. Sono insetti
che non c'è verso di mettere in una teca, e allo scopo ne devi consultare
di enciclopedie. Sulle prime resti perplesso, poi ti persuadi che, alla luce di
un'attualità colma di pallidi imitatori, sei al cospetto di un lusso.
Rispetto all'esordio, ricavato da una serie di jam, The Wants è passo avanti
d'eccezione che ha preteso sei mesi per rivelare la concretezza della proposta, un fiume dal moto impetuoso e dai tanti affluenti che fa pensare a dei Long Fin Killie (degli Stereolab) formatisi un decennio
dopo, a dei Liars col cuore di panna invece che di zolfo; guardandosi attorno, a una versione depurata da
intellettualismi e compiacimento di These New Puritans e Dirty Projectors. Senza la freddezza dei
primi e la dispersività dei secondi, poggiando su un sentire misterioso e arcano e sulla possibilità - che
ognuno ha ma pochi sfruttano - di ascoltare e rielaborare tutto lo scibile rock.
Senza che i modelli scelti soffochino lo stile, emerge un vibrante sincretismo nella voce sospesa tra Ian
McCulloch e David Sylvian (finendo talvolta dalle parti di Eugene Edwards, come nella fenomenale
Into The Corn); nelle cadenze motorik e in arrangiamenti arguti e stratificati, da Associates del Duemila
(Goodnight Arrow); nella penna che dipana con naturalezza pop, epica, ombre. Tre quarti d'ora abbondanti
di sorprese, insomma, dove i Japan si alleano con i primi Eurythmics (O) e ballate sfociano in cavalcate
kraut (The One Of One), dove il toccante folk Come Away In The Dark coabita con gli LCD Soundsystem
europeisti di Mr. Natural.
Per tacere del resto, maturità sinuosa e insieme spigolosa che intreccia tecnologia umanista e nervi scoperti, romanticismo e disillusione, memorie e aspirazioni. Il futuro, ipotesi sempre più complessa da pensare e progettare in modo credibile, passa anche da qui.
(8/10)
Giancarlo Turra
per un rosario di ballate capaci d'imporsi con naturalezza disarmante, come pianticelle sbocciate tra la strada
e il deserto, concimate ad amarezza Willard Grant
Conspiracy e trepidazione Okkervil River, custodite
con lo sguardo lungo e grave dei Johnny Cash e dei
Cormac McCarthy. Infine raccolte con gesto naturale e
servite in purezza acustica o in un bruciante intingolo
elettrico (vedi il fortunale à la Crazy Horse in Tom,
Dad & Mom).
Il segreto è non staccare mai il piede dal pedale dell'intensità, certo. Così da definire un ambito narrativo coeso
e per certi versi impenetrabile, senza scampo, allestendo una vicenda nella quale si celebrino ancora una volta
i topos della solitudine sullo sfondo della frontiera, col
mantice dei violini ed il gracidio dell'organo ad imbastire
un conforto effimero. Che il folk-rock fosse una cate-
goria apolide già lo sapevamo. Nella voce, negli scenari,
nei ciondolamenti melodici di Robbiani vive l'ennesima
conturbante epifania.
(7.3/10)
Stefano Solventi
Love Amongst Ruin - Love Amongst
Ruin (Ancient B, Agosto 2010)
G enere : R ock
Dopo i Boo Radleys e i K-Klass, il batterista - e jingle
maker a tempo perso - Steve Hewitt lasciava i Placebo.
Era il 2007. Oggi lo troviamo a capo di una band, Love
Amongst Ruin, ragione sociale dall'immaginario assimilabile a quello degli ex compagni, ma con alcune differenze
sostanziali.
Priva degli attacchi emo-zionali di Molko, la linea Hewitt
61
highlight
Salem - King Night (Iamsound, Settembre 2010)
G enere : witch
Tremate, tremate, le streghe son tornate. In realtà non son tornate affatto, dato che si manifestano solo
ora sul formato lungo dopo aver creato un hype della madonna con una manciata di vinili piccoli e qualche
sparso remix diluiti temporalmente in un arco di tempo che oggigiorno assomiglia ad ere geologiche e
geograficamente per etichette che definire del sottobosco è già un eufemismo.
Sia come sia, di questo trio misto (John Holland, Heather Marlatt e Jack Donoghue, questi i protagonisti) stanziato tra il Michigan e l'immancabile New
York si parla già da molto tempo nella rete di forum e blog che agitano l'underground mondiale sempre alla ricerca della nuova sensazione. Mai come
stavolta però, la sensazione è che oltre l'hype di rito, qualcosa di tangibile ci
sia eccome.
Se si prende il nome dalla città delle streghe per antonomasia della cultura
americana, poi è naturale che i suoni prodotti vengano di conseguenza, elevando i Salem a band di riferimento della nascente scena "witch", versante oscuro, tenebroso, ossianico e esoterico dell'hypnagogic/
glo-fi. Per rimanere a coordinate spicciole e ben identificabili, King Night è un tetro miscuglio di ambientazioni angelico/mefistofeliche, beats cavernosi che tanto devono alle scarne trame dell'hip-hop così come
alla densa gravità del dubstep o del juke chicagoano, delays e riverberi shoegaze che si fanno voragini (gli
Oneohtrix Point Never remiscelati a dovere), eteree vocals femminili alternate a vocioni da rapper
coatto, pulsioni minimal techno trash già anticipate dai ceroni bianchi dei Crystal Castles e goth-rock
d'ordinanza. Un calderone di ingredienti magici per chi è stanco di palme e tramonti sfocati, droghe leggere e sfumati immaginari 80s: King Night inizia con una pomposità black metal che perpetua l'ufficio del rito
satanico in pentacolo, Asia è l'immaginario ballardiano post-Burial, Frost il richiamo sensuale ambient delle
sirene stregate dal ricordo Dead Can Dance, Sick è il bbreaking per una nuova possibilità di alt-hop,
Release Da Boar il noise che i Sonic Youth non si permettono più. E via così, un colpo di grazia ai poseurs
da cameretta che mantiene comunque un'aura poshy deviata sul 666 tanto osannato dal metallo nero.
Qui c'è l'incubo, la decadenza degli yuppies presi a male, la polaroid sfocata e notturna dell'hypnagogic, il
lato oscuro che invece di rifarsi al mainstream guarda alla Morte Nera e ne rielabora il senso strafacendosi
di crack (come recita il loro primo EP Yes I Smoke Crack). Qui ci sono le streghe. Qui c'è la paura. E noi
diamo loro il benvenuto.
(7.3/10)
Stefano Pifferi, Marco Braggion
si fonda ora su un rock atmosferico dal cantato cool. La
resa sonoica è rigorosamente live, gli hook melodici decisamente anni '90. Tra gli arrangiamenti troviamo ricami
psych, archi (Bring Me Down), hard rock losangelini (Blood & Earth), trame à la Massimo Volume (Truth, Heaven
& Hell) e un po' di quel gusto cyber/nu firmato Marylin
Manson (Home).
E' un lavoro masterizzato con tutti i crismi possibili, la
batteria possiede un gran bel suono, ma dei L.A.R. ne
facciamo tranquillamente a meno.
(5/10)
Edoardo Bridda
62
Lugano Fell - SLICE REPAIR
(Baskaru)
Primo compito per recensire Slice Repair (primo album regolarmente licenziato di Lugano Fell, dopo
un cdr d’esordio) è – come sempre – sfuggire all’ineffabile. Il lavoro di James Taylor ci dà il pretesto per
segnalare - una volta di più - un metodo che ha segnato (o seguito) il passaggio dal post-rock all’elettronica avant, scivolando dolcemente nell’elettroacustica.
Le reminiscenze ci sono tutte, a partire dalla prevedibile
eco in lontananza di Labradford / Pan American (Slope), che portava già a metà Novanta (in Labradford, per
esempio) sotto gli occhi di tutti le potenzialità dell’ibridazione. Slice Repair non è però un fossile creato in
laboratorio. Nasce con un brano di dilatazioni ambientali
quasi cosmiche ma di provenienza compositiva minimalista (Bleaker), si muove su terreni già citati ma – almeno in un’occasione (47 Easy 47), prima della conclusione - riesce anche ad affrontare, con saggia profondità
di visione, due mondi che si guardano: quello di Alvin
Curran (c’è musica elettronica vivissima, popolata da
un bell’intarsio artigianale di voci, in Preform Naple) e
quello del glitch. Certo non si tratta di universi estranei,
è vero, ma neanche troppo spesso messi a confronto.
Non è però un caso, con tutta probabilità, che ciò che
riesce meglio a Taylor e alla ragione sociale Lugano Fell è
una versione butterata, glitchata ma ugualmente intensa
delle suite di David Pajo / Papa M (Two Hundred Clocks
And A Metre). È il recente passato che torna, forse. Ma ciò
che promuoviamo è la capacità di rimescolamento che
non suona per nulla passatista – né cerca di far finta che
il cordone ombelicale sia ancora attaccato.
(6.5/10)
Gaspare Caliri
Mark McGuire - Living With
Yourself (Mego, Ottobre 2010)
G enere : psych
Naturale che, a furia di parlare di hypnagogic, memorie
di memorie e estetica della ricordanza, qualcuno finisse
con l'architettarci un intero album. Se poi quel qualcuno
è il chitarrista degli Emeralds, una delle band elette da
Keenan a rappresentanti dell'immaginario hypna-pop, allora la faccenda assume connotati interessanti.
Oltre a muoversi in compagnia di John Elliott e Steve
Hauschildt, McGuire è autore di una carriera sotterranea fatta di infinite produzioni in proprio tra cd-r e tapes
per label altrettanto oscure come la personale Wagon, la
Arbor o la Pizza Night. Psichedelia dronica e sperimentazioni meditative di chitarra, di cui si consiglia vivamente il recupero per lo meno dell'ottimo Guitar Meditations II e della ristampa Tidings/Amethyst Waves, su
Weird Forest.
Per l'autoproclamato esordio ufficiale, Mark McGuire
concepisce il proprio personale manifesto, accantonando
le scorie radioattive che contrassegnano la sua carriera
in solo. Armato come al solito di sola chitarra (acustica
e elettrica), il nostro incentra la riflessione sul proprio
passato personale. Amicizie, legami famigliari, ricordi d'infanzia e questioni affini vengono scandagliate e rielaborate
con un mood malinconico e nostalgico, tramutato musicalmente in lunghi strumentali di chitarra in punta di dita,
ipotetici metà strada tra degli Emeralds "rurali" e certi
movimenti faheyani, rotti di tanto in tanto da qualche tape
sample vocale d'antan (protagonista, tra gli altri, anche McGuire stesso da bambino, registrato dal padre).
Living With Yourself è un concentrato vario e cangiante
di delicata e soffusa psichedelia intimista, capace in alcuni passaggi di sfiorare la stasi, in altri di abbandonarsi
a bucolici quadretti pastorali, in altri ancora a mostrare
dirompenti crescendo fino a trovare rare punte esplosive. La dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che la bontà
dell'esperienza Emeralds risiede nel valore creativo dei
propri protagonisti.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Mark Ronson - Record Collection
(Columbia Records, Settembre
2010)
G enere : popmuzik
Mark Ronson tenta il rilancio in grande stile. Si chiude
in studio con uomini fidati, chiama a raccolta tanti ospiti
diversi, jamma, registra, taglia e cuce (e canta anche). Il
risultato è esattamente quello che voleva lui, senti due
note e capisci subito il clash di elementi pop classici (coretti e melodie zuccherate anni Sessanta, tanto soul) e di
skills produttive nu & now (quindi con gli occhi puntati
indietro sugli anni Ottanta).Titolo, copertina e testo della title track non sono certo casuali e il disco è un continuo ammiccare al limite del plagio, una parata di cliché
quasi irritante, tra tastierine e tastieracce, rullanti super
popcorn e urletti vari.
Se Mark azzecca featurer e motivetto guida, la cosa funziona e funziona benissimo (il singolo Bang Bang con QTip; una Somebody To Love Me che cavalca l'onda melodica di Day'n'Nite e vede un'intensa interpretazione di
Boy George; una Glass Mountain Trust dove il desaparecido D'Angelo ci dà davvero dentro, fa a cazzotti con la
brutta base e vince lui). Altrimenti ci si ferma a robette
insulse (in primis, gli inutili intermezzi strumentali; non
scordiamoci poi che mezza tracklist la canta la Pipettes
Rose Elinor Dougall, e qualcosa vorrà pur dire) o si finisce per sprecare alcune buone possibilità (le comparsate
di Ghostface Killah e di sua maestà Duran Duran
Simon Le Bon).
Per quanto sicuramente appassionato, Record Collection è
troppo scopertamente un giochetto produttivo - neppure troppo chirurgico nel puntare al cuore nu-pop - per
convincerci del tutto. Per quanto vivificato da qualche
numero azzeccatissimo, sa davvero troppo di già sentito.
Eccolo Ronson: tra Phil Spector e Paris Hilton.
(6/10)
Gabriele Marino
63
Mavis Staples - You Are Not Alone
(ANTI-, Settembre 2010)
G enere : bl ack
Si dice che col passare del tempo si diventi più saggi, ma
come la metti con chi era già saggio in gioventù? Mavis Staples fa musica da sessanta anni, da che con babbo
"Pops" e relativa famiglia portò il gospel fuori dalla tradizione senza rinnegarla e annodandola a rock, country
e mondanità black con maestria insuperata, tale da azzerare i parametri coi quali "giudichi" un album. Non bastasse il passato, ecco un presente favoloso felicemente
sostenuto dall'esemplare Anti, tappe un We'll Never Turn
Back che - prodotto da Ry Cooder onorando un debito
da signore - inaugurava nel 2007 un rapporto rafforzato
da premi, onorificenze e dal fumigante Live: Hope At The
Hideout.
Nulla di meglio, a questo punto, che mutare nella continuità chiedendo al saggio fan Jeff Tweedy di produrre
il terzo lavoro e sceglierne i brani, pescando tra classici,
ricordi di famiglia (firmate da papà, Downward Road e You
Don't Knock) e offrendo un paio di originali (il sublime
country "con anima" You Are Not Alone, la sinuosa e polemica title-track). Per cucire un abito di foggia atemporale dagli arrangiamenti essenziali e comunque curatissimi, scintillio commovente (Losing You: Randy Newman
l'autore, degna del dylaniano Oh Mercy la resa) oppure
gioioso (We're Gonna Make It e la sua The Band da
acquasantiera; il crepitante funk Last Train di Allen Toussaint) quando non entrambe le cose assieme (il John
Fogerty di Wrote A Song For Everyone traslocato in John
Wensley Harding; I Belong To The Band sottratta al Rev.
Gary Davis e posta in chiusura a Moondance).
Quando arrivano la trascendenza del medley Too Close
To Heaven/I'm On My Way To Heaven Anyhow e la limpida
Wonderful Saviour, hai di fronte tutta l'inarrivabile dignità
di musica e interprete. La quale voleva "fare un disco nel
quale ogni canzone avesse un significato e desse un motivo
per alzarsi la mattina." C'è riuscita.
(7.4/10)
Giancarlo Turra
Melody Fall - Into The Flash (Nun
Flower, Settembre 2010)
G enere : E mo power pop
A volte succede che i percorsi che le band prendono
non siano per nulla lineari. Prendete questi Melody Fall,
ovvero i nostranissimi Fabrizio Panebianco (voce, chitarra e piano), Marco Ferro (batteria), Pier Andrea Palumbo (basso e cori), Davide Pica (chitarra e voce). Questo
che ci ritroviamo tra le mani non è un esordio, perché
i quattro torinesi hanno alle spalle tre dischi pubblicati
64
in Giappone, l'ultimo dei quali licenziato addirittura dalla
Universal, la major più major di tutte. Si vede che nel
Paese del Sol Levante la formula punk-power-pop venata
di emo non ha mai smesso di funzionare. Perché Into
The Flesh ricorda da vicino le sonorità di gruppi come
i Weezer e le espressioni più piacione Green Day.
A tratti si infila nelle composizioni una reminiscenza
hard-core, come se i nostri avessero mandato a memoria i dischi dei Pennywise negli anni '90, ma guardando
le loro foto viene il dubbio che fossero troppo giovani. Il
risultato dell'operazione, che vede l'interessamento delle alte sfere della discografia italiana e francese, oltre a
quella giapponese, che è rimasta evidentemente fedele,
sono 43 minuti adatti all'airplay radiofonico con ottime
potenzialità commerciali. Ascolteremo queste undici
canzoni mentre facciamo la cyclette, ma difficilmente ce
ne ricorderemo qualcuna.
(6/10)
Marco Boscolo
Mice Parade - What It Means To Be
Left-Handed (Fat Cat, Settembre
2010)
G enere : I ndie rock , etno
What It Means To Be Left-Handed è ben il settimo album
targato Mice Parade, un marchio di qualità e indefinitezza, d'artigianato sincero e confini variabili. Per essere
precisi, quello di Mr. Adam Pierce è un suono casa dove
di volta in volta soggiornano diverse persone e nazionalità. E la casa, capirete, non è mai la stessa. Il viaggio è
sempre di quelli che vanno dall'esteriore all'interiore in
un profluvio di sapori, tutti esotici, volendo anche anacronisticamente etnici. Dall'Africa al Brasile, dal mediterraneo all'Islanda, nella musica di questa perla del catalogo
Fat Cat si sono intrecciate metriche jazz, folk, pop e non
ultimo indie(folk)rock, (non?) genere cui Pierce s'è avvicinato più compiutamente nell'ultimo Mice Parade e
che qui quadra dentro una personalissima poetica.
C'è infatti sempre stata una contraddittoria indefinitezza
melodica in tutti i lavori della sua generazione, cresciuta
a pane e post-rock chicagoano: un aspetto che è stato
affrontato di petto da pochissimi (Will Oldham) e che
ha portato tutti gli altri, lui compreso, verso una continua ricerca di luoghi e situazioni soniche, sempre più
lontani. A Hawk And A Hacksaw, HiM, e Mice Parade hanno intrapreso carriere all'insegna di un appassionante suono trans-etnico, ma se i primi hanno trovato
casa immergendosi completamente in tradizioni lontane
dall'occidente, e i secondi sono approdati a un più freddo
approccio Tortoise-iano, Pierce sceglie l'uscio di casa
trovando nel naturale indie-rock ascoltato da adolescen-
te (la cover degli ottimi Lemonheads di Mallo Cup) la
miglior ispirazione per una manciata di brevi song tra le
sue migliori (Even, Tokyo Late Night, Fortune Of Folly, Couches & Carpets). E, sotto la rinnovata ispirazione, anche i
momenti più tipicamente miceparadeiani acquistano una
compattezza e una chiarezza di visione inedite (il misto
di folk Múm e mediterraneo di Do Your Eyes See Sparks è
splendido, idem il minimalismo e il piano classicheggiante
di Old Hat).
Segno che la maturità è finalmente qui, per giunta con
tutta l'immediatezza della gioventù.
(7.1/10)
Edoardo Bridda
Morlocks - Play Chess (Fargo,
Settembre 2010)
G enere : G arage rock
La seconda vita dei Morlocks, la seminale garage band di
Leighton Koizumi, è ormai un dato di fatto. Easy Listening For The Underachiever si è dimostrato qualcosa di più di una semplice rimpatriata, in quelle tracce
c'era un grido di disperata vitalità da parte di chi, per
sua natura, non sa stare senza succhiare linfa dalle radici
stesse del rock.
Radici che sono oggetto di un album tributo che si beve
tutto di un fiato. Morlocks Play Chess è, infatti, un felice
gioco di parole con cui la band suggella il proprio omaggio alla Chess Records e a una serie di brani simbolo su
cui sono costruite le fondamenta del rock, monumenti
blues e rythm'n'blues insuonabili da chiunque non voglia
apparire come l'ultima delle cover band intenta a concedere i bis in un infimo bar di provincia.
Affrontare pezzi come Boom Boom di John Lee Hooker, evitando l'odioso effetto karaoke è possibile solo se
quegli accordi li si è vissuti da sempre. Su questo aspetto
ogni dubbio è stato fugato dalle ultime esibizioni estive
dei Morlocks, che hanno mostrato una band compatta e
affiatata, feroce e lasciva al punto giusto.
Koizumi, dal canto suo, maneggia la materia con l'abilità
di un prestigiatore. Sfodera tutta la sua arte di garage rocker di lungo corso, rendendo dannatamente sexy I'm A
Man di Bo Diddley, interpretando con tono delinquenziale Killing Floor di Howling' Wolf e trasformando You
Can Never Tell di Chuck Berry in uno shake assatanato.
L'adrenalina scorre a fiumi, lo stile viene dispensato a
profusione e tutto fila liscio dalla prima all'ultima traccia.
L'unico appunto è da farsi ad una produzione moderna,
forse troppo moderna, con bassi pompati, batteria tronituante e chitarre brillanti, laddove il genere richiederebbe un sound filologico che i fan ricercano come una
boccata d'aria fresca nel mare delle super produzioni
odierne.
Sono dettagli, naturalmente, critiche benevole di chi ai
Morlocks vuole bene da sempre e attende con impazienza il prossimo album d'inediti.
(6.5/10)
Diego Ballani
Neil Jendon - Male Fantasies (Land
Of Decay, Giugno 2010)
G enere : A mbient - N oise
Un passato da chitarrista più o meno rock, dapprima in
territori indie-mainstream con i Catherine e in seguito
con le nebbie indie degli Zelienople di casa Type, da
qualche anno Neil Jendon sembra essersi convertito
alla religione delle manopole e bottoni, firmando dischi
di ambient analogico vicino alle riproposizioni cosmiche
di Carlos Giffoni, Expo '70 o Pulse Emitter. I due
lati del nastro scorrono senza strappi e rotture e con
la totale assenza di parti percussive. La ricetta del chicagoano consiste in lunghi sustain modulati LFO come
spazi desolati, che una tecnologia deturpata fatta di filtri
gracchianti trasportano in ambientazioni di industrie dismesse, e paesaggi urbani abbandonati. E in questo deve
trovarsi quella sensibilità comune che ha portato André
Foisy (Locrian) a pubblicarlo per la sua Land Of Decay
e a dichiararsi suo appassionato ammiratore. 40 minuti
di musica, più come evocazioni di scenari possibili che
per lasciarsi catapultare la testa nell'outer-space.
(6.8/10)
Leonardo Amico
Neil Young - Le Noise (Reprise,
Settembre 2010)
G enere : folk rock
Facile ma arguta l'allusione del titolo al produttore Daniel Lanois, vero e proprio co-starring di questo lavoro,
milionesimo titolo nella carriera infinita di Young. L'arguzia sta appunto nel celare dietro al calembour l'importanza del rumore - questo significa "le noise" in francese
- per l'arte passata, attuale e forse futura del canadese.
Rumore fido compagno ma duro da addomesticare, da
plasmare, indocile alla disciplina delle forme, ruggito di
pancia della bestia elettrica che non dorme mai. Il suono
(acustico o elettrico) per Neil è sempre stato (anche)
rumore. Quel suo stile così spigoloso e malfermo (tanto
come strumentista che come cantante) è qualcosa di più
che tecnica scadente e altro ancora da una calligrafia, è
il segno stesso di un livello espressivo che come un filo
rosso ha attraversato l'ultraquarantennale repertorio.
In questo senso, Le Noise mi sembra, almeno come idea
65
di base, un disco importante. Perché se non è la prima
volta che Young si confronta da par suo con questo
aspetto (soprattutto con Arc e con la soundtrack di
Dead Man, ma in questa chiave possono essere letti
anche gli "azzardi" stilistici di Trans e Re-ac-tor ed
il banco di prova acustico di Unplugged), è inedito
l'affidarsi ad un produttore di tale livello. Il quale ha
nel background tra le altre cose il precedente di Oh
Mercy, l'album che recuperò una controversa ma tutto
sommato riuscita profondità al suono di Bob Dylan.
Lecito quindi ipotizzare che questo disco sia nato con
lo scopo preciso di approfondire la questione: verificare la possibilità di un rumore strutturato come suono
nell'arte younghiana. Neil Young si presenta così in perfetta solitudine con otto canzoni nuove (o seminuove), impregnate di quella stessa brusca apprensione - o
"impegno" se preferite - che pervade gli ultimi lavori, in
molti casi purtroppo all'insegna di un "cotto e mangiato" pressapochista che non rende giustizia né all'autore
né all'ascoltatore (va un po' meglio con l'acustica Love
An War e con quella Hitchhiker già proposta da qualche
anno nei concerti).
Le chitarre e la voce finiscono riorganizzate nella dimensione sonica di Lanois, in quel dominio plastico di riverberi e delay e dinamiche mercuriali, la spazialità scolpita
in un non-luogo terrigno e digitale, un mondo insomma
d'inquietudine ingegneristica, il mistero più patinato che
c'è. Se è discreto l'intervento nei due episodi a spina
staccata, negli altri casi immaginatevi la grana scabra à
la Sedan Delivery sterilizzata e messa sotto una gelatina
tremula. Il risultato è affascinante solo sulla carta, nella
realtà suona piuttosto improbabile. Otto cavoli a merenda con un loro non meglio definito e neanche indispensabile perché.
(5.5/10)
biata rispetto al passato, visto che con Nuvole notturne siamo definitivamente dalle parti di un cantautorato
malinconico/onirico che mescola chitarre acustiche, basi
elettroniche e la produzione "allentata" di Paolo Messere. Quest'ultima rintracciabile in qualche accenno a
certe rilassatezze post-rock eteree e per nulla fuori luogo, a cui si aggiungono crescendo elettrici sorprendenti
(Eco), richiami Tunng (I ciliegi) e un tessuto strumentale
sostenuto da contrabbasso, synth, pianoforte, Farfisa e
armonium. Il risultato non dispiace affatto, anche se una
certa uniformità nelle intenzioni impedisce di isolare
momenti veramente memorabili.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Luca Barachetti
Nihil Est - Nuvole notturne
(Seahorse Recordings, Ottobre
2010)
G enere : elettro - cantautorato
Verrebbe quasi da dire che i milanesi Nihil Est abbiano
seguito il consiglio che davamo loro ai tempi dell'omonimo demo. Quando ne parlavamo come di una band
capace di mostrare una buona originalità negli episodi
cantati in italiano - "un italiano lattiginoso che diresti colto dal giardinetto più recondito (e serioso) dei Mariposa,
concimato a Bruno Lauzi e Robert Wyatt" - e meno
predisposta a un'inglese ordinario sospeso tra miriadi di
influenze.
La ricetta del gruppo sembra tuttavia leggermente cam66
Fabrizio Zampighi
Numero 6 - Extended Play 2010
(Autoprodotto, Settembre 2010)
G enere : indie pop
Bentornato a chi non se n'era mai andato, come i Numero 6. Attivissimi tra ep con collaborazioni di rilievo
(Bonnie "Prince" Billy a ricantare Da piccolissimi pezzi
nell'ep di due anni fa) e recenti dischi letterari in combutta con Enrico Brizzi, arrivano ora con questo ep
che anticipa l'uscita del nuovo disco sulla lunga distanza,
prevista per novembre (titolo I love you fortissimo).
Extended Play 2010 ripropone i genovesi per quello
che sono, ovvero una delle migliori compagini indie-pop
della penisola. Qui fra retrogusti funkeggianti (Pronto per
l'inverno) e pop matematico che emette rifrazioni chitarristiche (Semplice) confermano la devozione a Ivan
Graziani come a Battisti (di cui vi è forse un omaggio
ne Il regno dei no). Già queste tracce non sbagliano un
colpo, tuttavia l'effetto è del tipo "le cartucce migliori
non le abbiamo ancora sparate".Vedremo.
(6.8/10)
Okamotonoriaki - Telescope (munest, Agosto 2010)
G enere : I dm , ambient
In un percorso IDM che unisce smalti di classica, folk,
pop, jazz, techno sotto la lente accorta e domestica da
tipico artista audiovisuale giapponese, Okamotonoriaki
Noriaki è figlio sia dei mondi sonici del primo Takagi
Masakatsu sia delle sonorità elettroacustiche della City
Centre Offices.
Disponibile in 400 copie, Telescope è il settimo album del
catalogo della giovane label mü-nest, un piccolo gioiello
che unisce momenti ambientali/cinematici a episodi ritmati riconducibili a certi Tortoise esotici (Lighthouse) o
alle ritmiche di un Jon Hopkins. Ed è un album elegante.
highlight
Somnambulist (The) - Moda Borderline (Acid Cobra, Agosto 2010)
G enere : art rock
Marco Bianciardi è un tipo difficilmente prevedibile. Lo lasciammo due anni orsono alle prese col debutto
degli Hotel Ambiente, progetto che sanciva il suo distacco dagli Elton Junk e che lo vedeva abbandonare la batteria per un sorprendentemente efficace ruolo di front-man (chitarra e voce). Oggi il ragazzo
venuto dal Chianti e volato a Berlino via Bologna, cambia ancora le carte in
tavola presentandosi con un nuovo trio. Assieme a lui nei Somnambulist
troviamo il violinista Rafael Bord - curriculum stratificato tra soundtrack e
punk chanson - ed il batterista avant-jazz Marcello Busato. Risultato? Otto
tracce romantiche e insidiose, veementi e cupe, d'una ricercatezza assieme
meditata e selvaggia.
Interni berlinesi scossi da tremori Afghan Whigs (sentitevi 80s Violence), il
violino come ferite infette, il dark side dei dEUS (l'ottima Don't You Want To
Devour This War?), le sgarbate arguzie noise della chitarra, una certa teatralità
gothic-stoner (la title track), le sottigliezze impetuose e frastagliate del drumming (notevole il lavoro in
Quinto mistero della gioia), poi tutto un parafernalia di theremin, vibrafono, sample, sax, piano... Occhio poi
all'opening track Red Carpet, impeto indie tra i migliori uditi negli ultimi tempi. Moda Borderline è un disco che ti prende e ti porta via, come disse quel tale. Un viaggio stordente tra visioni d'inferno quotidiano
che si porta dentro una specie di luce. E già altre canzoni pronte a sbucar fuori.
(7.5/10)
Stefano Solventi
Pieno di vividi dettagli. Molto vicino ai modi di un Brian
Eno per il modo in cui sono accostati droni, strumenti
acustici e effetti (Mauna Kea). Trovatelo. Non ve ne pentirete.
(7.1/10)
Edoardo Bridda
Orchestral Manoeuvres in the
Dark - History of Modern (100%
Records, Settembre 2010)
G enere : synth pop
Se non ora quando? Sembra essere questa lo spirito con il
quale gli Orchestral Manoeuvres in the Dark hanno
messo in pista il loro undicesimo album ufficiale, il primo
dalla metà degli anni Novanta, quando, al contrario, era
prematuro un vero e proprio revival delle sonorità sintetiche targate anni Ottanta. Oggi che i tempi sembrano
fin troppo maturi, Andy McCluskey e Paul Humphreys tornano in pista e pare che il tempo si sia fermato
all'anno di grazia 1986: electro, disco-pop ed infatuazioni
kraute per l'esaltazione del modernismo.
Ma se è impossibile che mai tornino a scrivere una Enola
Gay, loro più grande successo e uno dei singoli più famosi
di tutti gli anni Ottanta, non ci si può nemmeno accon-
tentare di suonare oggi come allora, senza nessuna maturazione, senza nessun contatto con il contemporaneo.
Perché queste tredici tracce paiono avanzi di magazzino
di un'epoca di cui oggi vediamo nettamente l'influenza
buttate nella mischia solo per raccogliere quanto più sia
possibile. Nulla che non sia dignitoso, ma nulla che attragga l'attenzione per ritornare ad ascoltare alcuna delle
tredici tracce.
Si salva qualche melodia azzeccata (New Babies: New Toys,
Sister Marie Says) e il tributo ai Kraftwerk degli oltre
otto minuti di Right Side?. Per il resto meglio recuperare
il disco omonimo dell'80, Organisation e Architecture
and Morality, veri gioiellini di artigianato pop infarciti di
intuizioni e fascinazioni tecnologiche.
(5.5/10)
Marco Boscolo
Outrageous Cherry - Seemingly
Solid Reality (Alive Naturalsound
Records, Settembre 2010)
G enere : P sycho pop
Quella che il sottoscritto porta avanti con gli Outrageous Cherry è la storia di una passione iniziata una decina d'anni fa e mai completamente sopita, scattata quan67
do per la prima volta ascoltai l'attacco di Georgie, Don't
You Know, brano che apriva lo splendido Out There In The
Dark. La cosa che imparai ad amare di Matthew Smith e
soci è il fatto che non si limitino a comporre canzoni, ma
mettano in scena piccole utopie 60s: quadretti ideali in
cui Ray Davies, Lou Reed e Syd Barrett partecipano
a party psichedelici su meravigliose spiagge californiane,
con Stones e Byrds a fare da sottofondo. Insomma, il
meglio tutto insieme.
Naturalmente la deriva oleografica è qualcosa di più di
un semplice rischio; gli OC sono riusciti ad evitarla grazie
ad un suono riconoscibile sin dal primo ascolto. Un personalissimo wall of sound a base di riff muscolari disciolti
nell'acido, wah wah e fuzz a piede libero impiastricciati in melodiose filastrocche neo hippy, che Smith canta
con voce ultra riverberata. Negli anni questa formula ha
vissuto di minimi aggiustamenti, che li ha visti passare
da uno psycho rock cosmico ad un power pop dall'alto
tasso lisergico a cui aggiungere a piacimento piccoli ma
significativi elementi, che siano fiati o curiose pose glam.
Da un paio di album a questa parte, però, Smith è entrato in una sorta di stallo. Dal precedente Universal
Malcontents i brani si assestano su un minimo comune
denominatore che li rende sempre meno degni d'attenzione. Mentre su quell'album qualche pezzo ancora si
salvava, qui si fatica a trovare canzoni che non vadano
oltre il consunto tema merseybeat, le solite filastrocche
narcotiche condite con slogan flower power cantati in
maniera sempre meno convinta.
Una fase passeggera? Speriamo. Intanto il sei politico se
lo guadagnano con lo strumentale cosmico della title
track e il garage rock pugnace di Self-Made Monster, oltre che per la stima che ancora riponiamo in Matthew
Smith. Per il futuro, però, attendiamo il colpo di reni che
rinfocoli l'antica passione.
(6/10)
Diego Ballani
Parched - ARC (RareNoise)
Parched, la nuova creatura di Eraldo Bernocchi,
strutturata insieme a Davide Tiso, è riassumibile in una
sola formula: dilatazioni per chitarra. La prassi dipende
dalle possibilità compositive di una tecnica – che vede la
seicorde assoluta protagonista, amplificata in ambiente
- che prevede Tiso alle prese con strutture armoniche
e arpeggi, Bernocchi alla chitarra preparata e all’elettronica.
Arc è un album di post-rock quasi ambientale fatto
di umori scuri ma mai radicali, abbastanza teso ma per
nulla massimalista. Un prodotto capace di momenti di
sospensione forse troppo prolungati ((Mute)ant – Hill),
68
ma anche di interessanti evoluzioni sul tema di ricerca
su cui spesso si è impegnato David Pajo, almeno alla
fine dei Novanta. No One In The Playground si dipana e ci
trascina nelle linee di sviluppo minimaliste – ma profondamente post-rock, per estrazione – e trova un momento di messa in movimento di una distensione pervasiva.
L’essenza del disco è la dilatazione, appunto. Il tocco di
chitarra che serve a procrastinare un mood, un pensiero.
Come una rilassatissima gambata di rana di un nuotatore
nel mare più piatto, che ha l’obiettivo di ridare slancio,
ma lieve, all’andatura, a mantenere un moto quasi impercettibile (A Melting Chair). Il mare si trasforma in piscina quando si arriva a fondo vasca, e bisogna riprendere
il passo. E qui arriva l’inserto delle elettroniche (Invisible Wires), del tutto funzionali allo strumento principe
dell’album e agli obiettivi dello stesso. E tutto non può
che finire (Landscapes And Days Eternally Gone) con l’uscita dall’acqua, con le ossidazioni dell’aria, e dell’universo
anno 2010, a cui non è facile presentare un disco con
queste caratteristiche senza mandare a noia. Obiettivo
superato.
(6.5/10)
Gaspare Caliri
Peter Broderick - How They Are
(Bella Union, Settembre 2010)
G enere : songwriting / minimal
Prima o poi anche i migliori sono costretti a rallentare,
se non addirittura a fermarsi. E proprio in questi momenti i migliori si distinguono: si adattano e cambiano i
piani. Prendete quel prolifico compositore che è Peter
Broderick: pensava a un 2009 passato di corsa, lavorando al successore di Home e girando in tour sia da solo
che con i danesi Efterklang. Poi un ginocchio operato
che non vuole rimettersi lo costringe a una pausa forzata, il polistrumentista si ritira in Oregon e, non potendo
più giocare con i suoni, si reinventa a giocare con pensieri e parole.
Il risultato è How they are, un album delicato e malinconico, pervaso da una tristezza sottile che prende
d'inverno, quando la pioggia scivola sui vetri e ti ritrovi
a osservare il mondo esterno attraverso un vetro di cinismo e nostalgia (o attraverso una linea laterale, come
canta, a cappella, nell'introduzione). Ai toni intimisti di Sideline seguono When i'm out, in cui note del pianoforte
si rincorrono nel silenzio di una stanza, e la drammatica Pulling the rain, dove soltanto il registratore osa far
sentire la propria presenza, ogni tanto, sbattendo sulla
cassa del piano. Il fluire di emozioni continua con Human eyeballs on toast, ironica riflessione sull'uomo e sul
desiderio di vedere le facce a friggere in padella (every
time i see a man, i dream about his face in frying pan), fino
a raggiungere il momento più evocativo con la minimale
Guilt's tune, in cui pianoforte e chitarra accompagnano
l'americano a toccare le corde dell'Arthur Russell di
Another Thought.
Con How They Are Broderick ci regala un album
semplice, senza effetti o elettronica, che rappresenta la
sua umanità prima ancora che la sua personalità artistica
e che trova nell'essenzialità il mezzo per trasmettere una
parte importante di sè.
(7.2/10)
Gemma Ghelardi
Piccola Bottega Baltazar - Ladro
di rose (Azzurra Music, Giugno
2010)
G enere : canzone d ' autore
Forse quelli della Piccola Bottega Baltazar l'hanno
capito che la canzone d'autore, quella classica, di tante
parole e Premi Tenco, non basta più. Loro che da lì provengono, nutriti da un immaginario fatto di De André
(a cui hanno dedicato addirittura un disco tributo), Endrigo, Lauzi, ma anche di tante letture (quel Buzzati
che spunta più spesso di quanto non s'immagini), forse
hanno intuito l'esigenza di un passo in avanti, o meglio
di lato, verso musiche altre parimenti nutritive. E così
l'affidarsi al produttore e compositore Carlo Carcano
(Donà, Bluvertigo, Morgan) per questo quarto lavoro è
la risposta ad un atrofizzarsi sempre in agguato per chi,
partendo da una tradizione immensa, ne ricalca i passi
con poche possibilità di rinnovamento.
Ladro di rose parte dal folk acustico tra la Francia e
l'Inghilterra e vi innesta metronomie pop di chiara nobiltà, rumorismi, palpiti teatrali, perfino synth cosmologici e
granuli di musica concreta. Le canzoni raccontano di ciò
che quotidianamente succede dentro e fuori i muri delle
nostre case, ricordandosi però che non bastano i muri a
creare un dentro e un fuori quando al contrario tutto è
collegato e quindi davvero reale.
La Bottega scrive testi che non hanno una parola fuori
posto, evitano la retorica da comizio e pure quell'intimismo ermetico che è la versione letteraria del "non
so suonare, allora faccio musica sperimentale". E invece,
seppur nello spazio d'interstizio di una canzone, sperimentano davvero - sul linguaggio, sulla possibilità di una
narrazione cantautorale classica ma nuova - quando raccontano una storia di ordinaria rassegnazione italiana in
L'ombra del Caliburo e un'altra di sempiterno impantanamento in Ossigeno («riportami su / in un paese che non
sia truccato / che non sia in ostaggio / che abbia più fiato»).
Oppure quando avviano un crescendo coldplayano per il
drammatico mal d'amore di Stefania dorme vestita, zenith
del disco insieme ad una Strologo metà in dialetto veneto metà in italiano che distribuisce versi come staffilate
(«Riva aprile coi so fiori, / coi poeti e i cantautori. / Tuti i scrive
e tutti i sona: semo un popolo de mona»).
Avessero accorciato di un quattro-cinque brani una tracklist che in quindici tracce raggiunge l'ora di musica ed
inevitabilmente accatasta episodi interlocutori saremmo
qui a parlare di un capolavoro. Tuttavia Ladro di rose è
un disco buono, molto buono. E che soprattutto ci lascia
speranzosi.
(7/10)
Luca Barachetti
Piet Mondrian - Misantropicana
(Urtovox, Settembre 2010)
G enere : pop apocalittico
I Piet Mondrian sfilano lo spleen atomico-vacanziero di Tropicana del Gruppo Italiano e vi aggiungono
un'iniezione di sano odio nei confronti dell'umanità tutta. E Misantropicana, esordio su Urtovox dopo un
convincente demo autoprodotto (Ci diamo allo sperimentale?, 2008), suona come dei Baustelle ridotti
all'osso due minuti prima o due minuti dopo l'apocalisse
nucleare. La voce maschile e quella femminile di Michele Baldini e Caterina Polidori vanno spesso all'unisono
come dei Francesco e Rachele in spleen gainsbourghiano ma ripassati Kurt Vonnegut. Ovvero quella risata a
denti stretti, quell'indolenza depressiva ma non depressa,
quel cinismo da lingua senza peli contro l'era delle Tina
Cipollari elette a modello comunicativo dominante. Il
tutto rimpastato in una sequela di richiami cercati dal
duo e portati in dote dal crescente Wassilij Kropotkin (Samuel Katarro) che cura gli arrangiamenti: un
kazoo da Conte rincitrullito in Boogie Woogie, un funk
stilizzato alla Offlaga Disco Pax con spurghi elettrici
nell'incisiva title-track, qualche synth alchemico nelle liriche eccellenti di Ho votato Lega, un paio di sgomitate da
poliziottesco zona Calibro 35 in Credo che per natura,
e ad aleggiare pure la fascinazione di un Lucio Battisti
per intenditori.
Eppure sulle tredici tracce qualcosa risulta a noia, sarà
l'eccessiva lunghezza di un disco che ripete il modello
base (bozzetto folk chitarristico povero di accordi) cercandone infinite varianti. Certo è che i Piet Mondrian
hanno già una carta d'identità loro e si fanno amare, perché odiano e non stanno bene.
(7.1/10)
Luca Barachetti
69
Poison Arrows - Newfound
Resolution (File 13, Settembre
2010)
G enere : post math
Le "nuove risoluzioni" offerte dal comeback dei Poison
Arrows non è che siano così nuove, ma di sicuro spostano
l'asse del sound della band di Chicago. Anzi, superband, sarebbe il termine più esatto visto che tra membri - Patrick
Morris (basso, ex Don Caballero), Justin Sinkovich (chitarra, ex Atombombpocketnife) e Adam Reach (batteria)
- e ospiti vari - Pall Jenkins (Black Heart Procession,
Three Mile Pilot), Brian Case (90 Day Men, Disappears) e Mia Clarke (Electrelane) tra i più rappresentativi
- la congrega è di quelle che non passa inosservata.
Alla base post- e math-rock virata spacey che caratterizzava First Class, And Forever, il combo chicagoano aggiunge
una sterzata non da poco sempre sul versante vintageanalogico (loops, keyboards, synth) che ne dilata i contorni e offre una buona via di fuga alla risacca di genere.
I toni sono sempre contenuti e mai sopra le righe, con
relativa mancanza di picchi clamorosi: alcuni momenti
(Inadmissible Architecture, For Lack Of An AK) rinverdiscono i fasti di June Of 44 et similia mixati con la concezione del suono aperto e robotico dei Trans Am, mentre
altri (Flawed Acumen) sembrano mostrare un sentiero
percorribile nell'amalgama del sound vintage-analogico
sul corpo morto del fu post. Inoltre il gioco in studio di
registrazione aggiunge e stratifica la strumentazione a
disposizione del progetto compattando ancor di più la
proposta del trio, senza mai eccedere né dare l'impressione di un artificio fine a se stesso. Rinnoviamo perciò
il giudizio espresso per il debutto: non eccelsi ma per lo
meno piacevolmente avventurosi.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Prince Rama - Shadow Temple (Paw
tracks, Settembre 2010)
G enere : now - age
Gli ultimi affilati alla Paw Tracks sono questi Prince
Rama, trio misto cresciuto in una comune Hare Krishna, formatosi in una scuola d'arte in quel di Boston e
infine - dopo aver ricevuto "il sussurro di Prince Rama
nei propri orecchi" - riciclatosi in band per le vie creative
di New York, versante Animal Collective et similia.
Nulla nel terzo album dei bostoniani Taraka Larson (voce,
chitarra, tastiere, synth, drum machine, percussioni), Nimai Larson (voce, batteria) e Michael Collins (voce, synth,
drum machine, percussioni) - autodefinitisi a ragione
now-age - va per il verso giusto: psycho-freakerie a più
non posso si alternano a vociare irrequieto da mantra
70
inacidito, tambureggiare insistito a ohm andati alla deriva,
manipolazioni digitali ad ancestrale musica corale. Non
mancano nemmeno i campanellini mentre registrazioni
e produzione - opera di Avey Tare, Josh Deakin e Rusty
Santos - hanno avuto luogo tra vecchie chiese sconsacrate e la casa del nipote di Kurt Vonnegut (!!!).
Insomma, nulla che si discosti dalla moderna fascinazione
per i rituali orientali fatti di raga e free-folk, mix di tecnomodernerie e ataviche tradizioni ma con un apprezzabile
sguardo strabico: un occhio strizza ai krauti più frikkettoni
mentre l'altro ripassa le coordinate dell'America più weird.
E il terzo? Beh, il terzo è socchiuso in meditazione, no?
A far la differenza rispetto al canone di genere c'è che
i tre, tra canti collettivi, invocazioni in sanscrito e adattamenti da canti indiani, sembrano crederci davvero e il
tutto non suona come la solita pagliacciata ad uso e consumo degli hypers di mezzo mondo. Staremo a vedere.
(7/10)
Stefano Pifferi
Redroomdreamers - Roosters On
The Rubbish (Happy/Mopy, Ottobre
2010)
G enere : indie rock
Anni spesi a fare indie come Growing Ocean, apprezzato trio attivo nel napoletano lungo i perigliosi Novanta,
quindi i colpi delle "alterne vicende" che prima spensero
il progetto e poi, ben più tragicamente, la vita del bassista
Inigo Grasso. Correva il 2008. Fu allora che Alessio e Dario, batterista il primo e chitarrista-cantante il secondo,
decisero di dare vita ai Redroomdreamers, trovando
nel polistrumentista Simone una versatile terza gamba.
L'attualità ci offre il primo disco firmato dalla nuova entità, nel quale l'avventatezza tipica degli esordi s'impasta
alla densità dell'esperienza. Soprattutto la prima parte
di questo Roosters On The Rubbish testimonia una
forza notevole, sintonizzata da qualche parte tra il cantautorato alternativo degli American Music Club ed
il post grunge dei Pearl Jam altezza Yield, permettendosi altresì di mischiare fragranze Beck e Belle And
Sebastian (nella sorprendente The Dog). Nel teorico
lato B le trame si fanno più pensose perdendoci in immediatezza, però non smetti di avvertire un senso di necessità ed il calore disteso di chi non ha nulla da dimostrare. La voce di Dario, in bilico tra l'arguta limpidezza
d'un Al Stewart e l'intensità bluesy di Ben Ottewell,
accompagna le melodie al loro più vivido compimento.
Un inizio davvero niente male per la neonata etichetta
Happy/Mopy Records .
(7.2/10)
Stefano Solventi
highlight
Twin Sister - Vampires With Dreaming Kids / Color Your Life
(Domino, Ottobre 2010)
G enere : D ream , folk
Sono in giro da un paio d'anni e il digi distribuito ora da self riassume una prima parte di carriera raccogliendo due eppì usciti rispettivamente nel novembre del 2008 e lo scorso marzo. A pubblicarli è Domino,
etichetta che sulle nuove leve del pop indipendente c'ha un discreto fiuto e
che con il presente quintetto proveniente da Long Island non sbaglia affatto.
Essendo giovanissimi e praticamente a digiuno da studi di registrazione, i
cinque hanno tutte le ambizioni, le folgorazioni e qualche difetto del caso.
Relegati i confini labili e a una cifra stilistica ancora un po' ondivaga, le compensazioni ripagano, e con gli interessi: un preciso afflato melodico e la misura dello spazio sono già scintille per il perfetto mix di mistero, confidenze
pop e incanto indie a tutto tondo.
A colpire nel segno è il canto di Andrea Estella, tra l'art pop dai retrogusti folk del primo eppì Vampires
With Dreaming Kids, e le atmosfere che dai Broadcast (Milk And Honey) portano ai Beach House (Lady
Daydream) dell'altro medio metraggio Color Your Life.Attorno: spazi sempre aperti e coperti a dovere, smalti sostanzialmente psych bucolici pieni di varianti: qualche tocco library (Galaxy Plateau), un incantevole
motorik (The Other Side Of Your Face), glo (All Around And Away), polveri di stelle, angoli twee e, per non farsi
mancare nulla, ralenti indie '90 (i Pavement di Ginger).
L'ondata fine Ottanta di 4AD che abbiamo già incontrato, dall'underground più profondo ai Blonde
Redhead, arriva certamente anche qui ma diversamente dalle ortodossie del caso, i ragazzi ci mettono
la continuità e la misura. Da Devendra e My Brightest Diamond ai Cocteau Twins (e compagnia dream)
passando per la endless summer californiana, c'è un limbo dove tutto è possibile e qualche volta è davvero
fantastico.
(7.3/10)
Edoardo Bridda
Robert Owens - Art (Compost
Records, Ottobre 2010)
G enere : soul house
Uno che attraversato la storia dell'house sempre in piedi
non può che essere una grande voce. Perché la house è
soul e il soul è voce. Owens (ricordate l'inno Can You Feel
It?) è uno che ci vede giusto e presenta questo doppio
monstre così "in qualsiasi posto dove suono, la parte vocale
è la cosa che viene fuori di più. La musica è un ciclo. Nel giro
minimal, la gente vuole solo sentire il beat, perché è fatta di
droga. Ma noi siamo tornati per guardare ancora una volta
alla sensibilità. Le persone hanno bisogno di fare comunità,
di vivere l'uno vicino all'altro. Quando la gente esce vuole
scambiare una parola con chi trova per strada. Specialmente
nel tempo di Facebook, Twitter, etc. la gente vuole emozioni
e devozione".
Due dischi che presentano un ricordo di house impiantato nella sua voce, marchio di fabbrica altissimo di un
qualcosa che può esistere solo in altri mondi. Owens è
un personaggio che ti capita di sentire poche volte in un
decennio. Uno che fa arte e lo sa può essere solamente
venerato. Che siano ad ascoltarlo gli impasticcati della
techno, o i nostalgici della balearica, quello che viene
espresso qui è emozione. Puro distillato soul. Non si può
rimanere indifferenti alla voce di un uomo così. Dall'inizio alla fine un groove che ti avvolge e che non ti lascia
mai. Blackness e quadratura perfetta del cerchio smooth
nel primo disco e del ritmo nel secondo. Imprescindibile
al di là di ogni catalogazione Owens si affida al vecchio
amico Larry Heard (dei Fingers Inc.) e alle nuove leve
Atjazz, Beanfield e Show-B e sbanca. Old school makes
art again.
(7.4/10)
Marco Braggion
71
Ruggine - Estrazione Matematica
Di Cellule (Escape From Today,
Agosto 2010)
G enere : noise - rock
Lo avevamo anticipato tempo fa, al momento di indagare la scena del Canalese Noise e ora è qui in tutto il
suo splendore. Estrazione Matematica Di Cellule, esordio
lungo per il quartetto a doppio-basso Ruggine, arriva
confezionato in uno splendido digipack e avvolto in una
costante tensione che avevamo imparato ad apprezzare
all'epoca dell'omonimo ep.
Riesumando i Massimo Volume (sensazioni che crescono
/ frasi che mi portano indietro nel tempo) Simone Rossi
urla disperato e a noi sale un groppo in gola. Sembra di
ascoltare Stanze, eppure il suono è rallentato, inspessito,
aspro e vibrante: è una gara di resistenza di stampo posthc come se ne poteva sentire e apprezzare nella prima
metà dei 90s. In più, il quartetto della provincia Granda
mostra capacità di sintesi e elaborazione di generi addizionando il suono di slanci noise, cupo livore di stampo
quasi industrial e stranianti aperture melodiche.
Il segreto sta nella sezione ritmica: l'interplay tra i due
bassi di Paolo Scalabrino e Francesco Rossi e la batteriamonstre di Davide Olivero (un pachiderma tanto mobile
quanto denso) su cui si liberano la chitarra angolare e
la voce scartavetrata di Simone Rossi. Una voce (e dei
testi) su cui riflettere. Una band (e un suono) che aspettavamo da tempo.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Ryan Bingham - Junky Star (Lost
Highway Records, Settembre 2010)
G enere : A mericana
Impressiona di Ryan George Bingham la rapidità con la
quale è divenuto una "sicurezza" e, ugualmente, quanta
vita vissuta per davvero emerge dalla grana rugginosa e
dolente delle sue corde vocali. Quasi che la sua statura autoriale sia stata scolpita negli anni trascorsi da una
casa a un rodeo, finché qualcosa non si è messo in moto
e un po' di radici le ha lasciate giustamente attecchire.
Ora che persino il cinema lo ringrazia per una The Weary
Kind che, inclusa in "Crazy Heart" ha fruttato un Oscar a
lui e al curatore della colonna sonora T-Bone Burnett,
ci potrebbe essere di che preoccuparsi.
Invece no, lui prosegue dritto per la sua strada e addirittura fa meglio che in Roadhouse Sun nel replicare a Mescalito, istillando la certezza di poter offrire, a tempo debito, una versione prossima ventura di quel Capolavoro
con altra maturità anagrafica. Che quella artistica non sia
in discussione lo sottolinea questa terza raccolta di can72
zoni che testimonia l'alternarsi tra gli Stones più bucolici (Depression) e uno Springsteen sudista (Yesterday's
Blues, Lay My Head On The Rail) mentre Steve Earle
benedice i passi più sinceri e la novità è una "presenza"
dylaniana più marcata (l'armonica di The Poet, Direction Of
The Wind e la sua inedita vis polemica).
Quando la scuola texana inaugurata da Townes Van
Zandt applaude il commiato, intessuto delle meravigliose luci ed ombre gettate su Self-Righteous Wall e All
Choked Up Again, noti la puntualità della produzione, merito sempre di Burnett, e l'assenza delle lievi sbandate
presenti sul secondo album. Ulteriori segni di una crescita che non conosce soste e regala conferme con una
disinvoltura rara.
(7.6/10)
dell'attenzione e ogni minimo rumore segue una dinamica propria, come se fosse parte di un'orchestra in cui
tutto, dalla natura alla vibrazioni, ha un suo posto.
Il risultato è un disco romantico, che immerge l'ascoltatore in una dimensione in cui natura e uomo si mischiano e si completano, dove non è più possibile stabilire la
differenza fra l'uno e l'altro e si può finalmente cogliere
quella vibrazione universale che le campane tibetane di
Seasons cercano di propagare fra ricordi e luoghi.
(7.3/10)
Giancarlo Turra
Già costellata di decine di uscite in tutti i formati, dai più
minoritari ai classici CD, la vasta discografia di Dan Johansson in arte Sewer Election continua ad arricchirsi.
A distanza assai ravvicinata dall'album Vidöppna Sår su
Pan e dal singolo Kvävd per la milanese A Dear Girl Called Wendy, ecco un nuovo LP, questa volta targato RTB.
Non del tutto nuovo, ad essere precisi, poiché Bristning
è la riedizione in vinile di una cassetta rilasciata nel 2008
per la tape label Klorofyll Kassetter, il cui materiale viene
oggi saggiamente riproposto e leggermente ampliato.
Seasons (pre-din) - Your Eyes The
Stars and Your Hands The Sea (Type
Records, Settembre 2009)
G enere : ambient
Era inevitabile che nel momento in cui Seasons avesse
deciso di sospendere per un momento le sue splendide self releases, si sarebbe lasciato convincere dalla Type
Records: e non solo perchè ha collaborato sia con Richard Skelton che con John Xela Twells, ma perché
Type è l'etichetta forse più adatta a cogliere la bellezza
dell'ambient evocativo di Seasons. Agli ascoltatori appassionati del misterioso inglese forse un po' dispiacerà
non essere più i soli ad avere una copia fatta a mano di
Your Eyes The Stars and Your hands The Sea, copia che si erano impegnati ad ottenere, visto che nel giro
di poche ore le uscite della Thy-records vanno sold-out.
Ma la versione in vinile uscita su Type non è una semplice
ristampa bensì una rivisitazione, un riflettere sugli stessi
pensieri a distanza di tempo, con uno sguardo diverso.
Come ogni lavoro di Seasons, anche questo disco è
estremamente personale: quasi un percorso interiore,
dove ogni luogo registrato (dai boschi agli edifici abbandonati) ha un significato per il musicista, che ne assorbe
la vibrazione riproponendola in una vivida visione auditiva. Ai suoni catturati naturalmente sovrappone poi altri
livelli, che rappresentano l'intervento umano: strumenti
a corda e singing bawls, principalmente. I layer però non
vengono percepiti come due cose distinte, ma come un
fluire: i rumori quotidiani, pur essendo riconoscibili, arrivano diversi, come immersi nella nebbia, filtrati da un
mondo interiore oscuro e complicato. Il procedimento
è simile a quello di Skelton, ma se lì il suono sembra
quasi un dono ai fantasmi che abitano i ruderi registrati,
in Seasons la visione è più filmica: il suono è al centro
Gemma Ghelardi
Sewer Election - Bristning
(Release The Bats, Luglio 2010)
G enere : H arsh N oise
Il suono Johansson è ben noto: loop di nastri registrati,
rovinosi suoni di metalli raccattati in chissà quale discarica, assalti al rumore bianco che si alternano ad angosciosi
silenzi asfittici, registrazioni analogiche che immortalano
paesaggi astratti di malattia, perversione, sofferenza e annichilimento. L'immancabile celebrazione di una disfatta
umana e emotiva affidata a due lunghi brani anonimi.
Trovare delle specificità per cui Bristning spicchi tra i numerosi lavori precedenti è compito arduo che lasciamo
ai fanatici del noise più duro; ma se cercate sgomento
in musica fatevi avanti: la fogna di Dan è pronta a fagocitarvi.
(6.8/10)
Andrea Napoli
Soho What - The First Impression
Last (Sometimes, Agosto 2010)
G enere : free - wave
Piccoli Larsen Lombriki crescono. Dietro il moniker
Soho What si nasconde infatti il progetto nato dalla mente deviata di Rudi Van Mad, che del collettivo avant-rock
è (era?) chitarrista, tra le altre cose. In questo debutto
"in solitaria", in cui cioè tutta la faccenda e i collaboratori
(il grosso viene sempre dal giro LL) ruota intorno al suddetto chitarrista/cantante, si da fondo alla commistione
73
di generi della casa madre, ma mantenendo in nuce una
sorta di dipendenza dalla forma canzone e dalla strutturazione interna dei pezzi.
La wave più deragliante e free, il rock più destrutturato
e noise, la pop music più infantile e deturpata, l'electro
più dark e sperimentale convivono in un guazzabuglio
di suoni che sfuggono in ogni direzione e che prediligono - nomen omen - un approccio improvvisativo e da
first take. Basterebbe leggere l'elenco delle influenza
lasciato sul myspace (da Snakefinger al sadomaso, dai
Residents a Contorsions, Stooges e Neu, da Devo
e Beefheart ai fumetti della Marvel) per comprendere
come il suono della band, una volta ricoperto da un
manto di lucida follia snowdoniana, sia realmente inclassificabile. Energico, trascinante, deragliante, The First
Impression Last è non a caso finito tra i preferiti di quel
pazzo di Julian Cope. La sensazione però è che resti
un divertissement tra amici.
(6.7/10)
Stefano Pifferi
Solar Bears - She Was Coloured
In (Planet Mu Records, Settembre
2010)
G enere : A mbient , indie
L'IDM non è morta. Si è rinnovata abbeverandosi alla
sorgente: vecchi synth, dischi krauti e colonne sonore
dei Settanta. Questi i nuovi oggetti del desiderio dei sognatori da cameretta e questo il trend a tutto campo che
coinvolge, da un lustro oramai, vaste fette di sommerso
sonico al di qua come al di là dell'Atlantico.
Una rielaborazione dei Boards Of Canada in chiave
Germania '70 potrebbe essere il perfetto esempio per
comprendere la formula dei Solar Bears, due ragazzi irlandesi che hanno recentemente portato a casa di Mike
Paradinas un suono che mescola abilmente elementi
rock (chitarra, batteria, piano) e sintetici (synth, drum
machine) in chiave ambient, soundtrack, new age e attitudini tardo prog.
Le buone maniere John Kowalski e Rian Trench, le hanno imparate alla Pulse Sound Engineering School. Con
macchine e strumenti si muovono di buon artigianato
(Forest Of Fountains, Children Of The Times tirano in ballo
il dittico Kraftwerk-Daft Punk, in Twin Stars rimodellano sapientemente Vangelis, Klaus Schulze e i Tangerine
Dream con fare da minimalisti IDM), e già qualche brivido arriva dal lato più rockista della faccenda (She Was
Coloured In) o da episodi meno formali (il funk liquido
in salsa chamber prog Primary Colours A the Back Of The
Mind, la post-chill di Neon Colony).
Una buona proposta per chi è ancora a secco di sonorità
74
'70. Ancora un po' di pazienza per coloro che vorrebbero una maggiore disinvoltura e emancipazione.
(6.7/10)
Edoardo Bridda
Stereolab - Not Music (Duophonic,
Ottobre 2010)
G enere : pop retrofuturista
Sembra giunta l'ora di chiudere per il Laboratorio, anche
se l'ufficialità parla di una semplice messa "a temporaneo riposo". Anticonvenzionalità per anticonvenzionalità,
i Nostri non se la cavano con un inutile best of e rispolverano tredici tracce delle sessioni che nel 2008 fruttarono Chemical Chords. Lavoro dignitoso che si assestava
viepiù sulla formula geniale che aveva in precedenza sposato art e pop, krautrock e chanson arguta con mano lieve
e ferma. Senza negarsi nulla quanto a sperimentazione
e allargando il campo dell'ispirazione a Os Mutantes,
United States Of America e Mouse On Mars, in
testa un'idea di intellettualismo ironico e sferzante che
scriveva regole proprie allorché citava a destra e a manca.
Perfetta per l'epoca che la vide svilupparsi rigogliosa, la
creatura di Tim Gane e Laetitia Sadier (attiva anche con gli apprezzabili Monade, prossima al debutto
solista) ha smesso di stupire all'inizio del nuovo secolo,
nondimeno conservandosi in buona forma: mai un'uscita
inutile in una produzione copiosa e nemmeno qui si viene meno. Seppur in tono minore, il saluto è il consueto
campionario di memorie trasfigurate e movenze falsamente "easy" mai autocompiaciute, apici una Leleklato
Sugar d'elaborata delicatezza e un remix di Silver Sands in
fenomenale transito da Düsseldorf a Detroit e ritorno, il
saltellare sereno di Two Finger Symphony e la malinconia
circolare che avvolge Delugeoisie. Al pari del valzerino Aelita e dei Neu! apocrifi di Pop Molecules, bellezza priva di
rughe che non pensa al domani.
(6.8/10)
Giancarlo Turra
Sufjan Stevens - The Age Of Adz
(Asthmatic Kitty Records, Ottobre
2010)
G enere : avant pop folk
Dopo un lustro nel quale ci ha concesso solo lavori interlocutori, apprezzabili sì ma di sponda, Sufjan Stevens torna in sella alla bestiolina autorale. E la trova
comprensibilmente vogliosa, carica. Però cambiata. C'è
un'inquietudine nuova al lavoro nel petto, un tumulto intimo sebbene destinato - come è naturale - ad irradiarsi
collettivo. Come prima conseguenza, il mega-concept
highlight
Walkmen (The) - Lisbon (Bella Union, Ottobre 2010)
G enere : swamp indie
Iniziarono nel 2002 come una sorta di prequel garage degli Strokes, per farla semplice e breve. Per i
newyorkesi Walkman i consensi arrivarono consistenti, ma il pieno l'avrebbero fatto col ben più meditato
quinto album You & Me. Due anni più tardi arriva il qui presente Lisbon, destinato ad alzare ulteriormente l'asticella. Fin dai primi solchi si susseguono chiari i segnali: l'arpeggio è
un trillo morbidamente ostinato, il drumming un rombo basale, quanto alla
voce, eh, è una voce di quelle che non potrebbero fare a meno di se stesse:
un graffiarsi presente di graffi passati, una generosità ferita e bramosa. Semplici le melodie, rivolte ai fifties del country-folk che va trasformandosi nel
formidabile ibrido errebì con tutte le oscillazioni doo-wop e swamp pop (e
che più avanti rimbalzerà garage e surf), rutilante e accorato, in bilico consapevole sulla propria natura effimera.
S'incendiano le chitarre, certo, come nel singolo Angela Surf City, con quelle
espettorazioni che se mantengono genuinità lo devono alla ricetta che su tutto spande il suo aroma: suonare come chi ha siglato la pace coi demoni malgrado la terra continui a bruciare sotto ai piedi, malgrado
il fragore del sangue nelle vene. Una maturità ancora inquieta, dove l'innocenza è un fantasma celebrato
però mai rimpianto: questo il "luogo" che i Walkman si sono scelti, dal quale ti porgono con garbo febbrile
la sarabanda dei sentimenti (la splendidamente tesa Blue As Your Blood), il valzer dei propositi (l'infiammabile
Victory), l'errebì dell'età perduta (Juveniles). Quel luogo probabilmente esiste davvero, o almeno a loro è
sembrato così nei due viaggi che li hanno portati in Portogallo: ecco spiegato il titolo della canzone che
battezza l'album, ballatina col cuore in ambasce dai riverberi esotici, il momento più intenso in scaletta
assieme a quella Stranded che s'inventa una brass band d'accompagnamento per la processione di un'anima
triste. Agli antipodi, una Woe Is Me dalla disarmante, limpida, ossessiva vivacità.
E' musica questa che gioca a carte scoperte con un mistero impenetrabile. Riguarda il motivo stesso per
cui siamo ancora qui ad investire tempo, energia, emozioni nel rock'n'roll. (7.5/10)
Stefano Solventi
dedicato agli stati dell'Unione sembra al momento accantonato. Le coordinate della nuova mappa convergono
quindi su Sufjan stesso, la cui tomentosa e feconda maturità ha già fruttato il sedicente ep - in realtà un album
bello e buono - All Delighted People, uscito poche
settimane fa. Adesso, come ampiamente annunciato, arriva The Age Of Adz. Non senza colpi di scena.
E' come se Sufjan tentasse di edulcorare l'irrequietezza
spostandosi senza posa tra scenografie spettacolari, o - se preferite - come se avesse ingoiato la pasticca (metaforica) che regala il conforto di visioni psych, electro
e dream pop sbalzate e contemporanee. Un tuffo nelle proprie (e anche un po' improprie, massì) possibiità,
in una dimensione profonda ma esuberante, sfaccettata
fino allo sconcerto ed incontenibilmente empatica. La
tavolozza sonica disegna scenari palpabili, a tratti sembra
di stare dentro ad un dipinto vivo, di galleggiare sulla
carnosa radianza di linee e colori. I riferimenti artistici,
del resto, sono espliciti: il titolo stesso del disco rimanda
all'opera di Royal Robertson, pittore della Louisiana classe 1930, morto nel '97, schizofrenico, sedicente profeta,
abitato (lui e i suoi lavori) da allucinazioni futuristiche per
non dire sci-fi. Qualcosa di quest'ultime abita le undici
tracce in scaletta: una mischia balzana di elementi popular per attivare codici di stupore, d'insolito meraviglioso,
il filo nero dell'angoscia nel patchwork ipercromatico.
Sufjan pennella con estro sfrenato, si precipita da una
visione all'altra, da una dimensione all'altra, ammicca
l'iperdadaismo post-psych dei Flaming Lips, l'ipnoromanticismo panico dei Sigur Rós, il freak pop bucolico e corale (Animal Collective in testa), non si
fa mancare ipotesi electro-funk dal calore accorato
Radiohead (si veda la coda di I Want To Be Well). E in
questo esercizio d'insopprimibile versatilità non scor75
da di aprire breccie sul cuore gospel-folk-pop della sua
ispirazione, come porzioni di tela lasciate senza colore
dove scorgi il disegno, una sottotraccia che riconduce
alle lezioni Paul Simon, Brian Wilson e Van Dyke
Parks. E' un sostrato irrinunciabile e scoperto, che in
qualche modo tiene in piedi tutto il formidabile baraccone. E' il perno della giostra.
In questo continuo allontanarsi e rannicchiarsi in se stesso, nel carosello degli azzardi che s'infiammano ed evaporano come sogni, mille volte Sufjan rischia di perdersi,
di cadere, di sbagliare la svolta (quell'orribile autotune in
mezzo alla fluviale Impossible Soul...), ma un attimo dopo
ti ritrovi commosso o sbalordito o semplicemente divertito. Capisci che è lo spettacolo d'arte varia di chi in
qualche modo sta cercando di fare chiarezza, di fulminare
i fantasmi, di affacciarsi sul burrone. The Age Of Adz è
un'opera eccessiva, imperfetta, forse velleitaria. Ma racconta il caos emotivo di questi anni come poche altre.
Nel modo giusto.
(7.4/10)
da offrire a queste sonorità, ma noi non siamo tentati di
dare voti alla carriera.
(6.3/10)
Marco Boscolo
Suuns - Zeroes QC (Secretly
Canadian, Ottobre 2010)
G enere : art rock
Da bravi figli dell'età dell'onniscienza, i Suuns da Montreal esordiscono proponendo un linguaggio composito, per il quale la calligrafia è questione di ingredienti e
dosaggio, tutto un riarticolare forme, modi e mood che
significa anche - soprattutto - innescare riverberi spaziotemporali. Nello specifico, Zeroes QC mette in fila una
scaletta a base di kraut e post wave, electro-dark e artrock, scomodando con acume memorie Clinic, Wire,
Suicide, Can, più una spolverata di Chrome e persino
un pizzico di Polvo. Motoristici o semplicemente seriali,
atmosferici e insidiosi, eclettici fin sull'orlo dello sconcerto, i quattro canadesi risultano divertenti da ascoltare.
Stefano Solventi Ogni traccia nasconde una sorpresa, come se a scozzare
le carte fosse il caos ma col raziocinio che gli punta la
pistola alla schiena.
Superchunk - Majesty Shredding
Va a finire che l'ambaradan funziona. Malgrado la veloci(Merge, Settembre 2010)
tà, gli scambi a tradimento e le pendenze a scapaccione,
G enere : emo power pop
Difficile parlare male di una band come i Superchunk, non avverti neanche per un attimo il rischio di deragliare.
sia per il rispetto a una carriera comunque più che di- Anzi, c'è come un senso di coerenza lucida.Tutto ciò pregnitosa nel micromondo del power pop mondiale, sia suppone una capacità di calcolo da post-nerd del rock
perché il leader Mac McCaughan e Laura Ballance hanno che affascinano più per la loro natura di fenomeni confondato la Merge Records che ci ha regalato Arcade temporanei che non per quello che sono o saranno in
Fire, l'ennesima buonissima prova dei Teenage Fan- grado di esprimere.
club o il ritorno di Tracy Thorn. Gente così ti viene da (6.7/10)
ammirarla e basta.
Stefano Solventi
Musicalmente non avevano più detto nulla dal 2001, dopo
undici anni di carriera e otto album. Anche dal titolo, He- Swahili Blonde - Man Meat
re's To Shutting Up, era un disco che aveva del commiato, (Manimal Vinyl, Ottobre 2010)
dell'addio alle scene. Ma sarà per il ritorno in pista anche G enere : neo - wave
di altri gruppi storici della scena emo/power pop come i Uno che di star fermo non ne vuol sapere, John FruGet Up Kids (in tour lo scorso anno con un passaggio sciante: definitivamente (?) uscito dal gruppo, mentre
anche in Italia), sarà perché i piccoli emuli come i We cura la propria prolifica carriera solista si è unito a questo
Are Scientists sono in gran forma, sia quel che sia nel progetto, concepito a L.A. da Nicole Turley (già cantan2010 questi signori del pop da singalong, dell'hook facile te e batterista di tali WEAVE!) guardando al post-punk
decidono di ritornare con undici nuovi brani.
in buona compagnia (sono della partita Laena MyersNon c'è nulla che non vada in questi quaranta e passa Ionita, Stella Mozgawa e Michael Quinn; addirittura
minuti di chitarrismo pop radiofonico e colorato, ma John Taylor dei Duran Duran presta il basso al framsembra che dal 1990 ad oggi non sia cambiato nulla. Ma- mentato wave-funk Tigress Ritual). Pratica che di questi
jesty Shredding potrebbe essere stato inciso in qualsia- tempi ha esaurito la spinta propulsiva, per quanto qui si
si momento tra il capolavoro No Pocky for Kitty e Come usi l'accortezza di guardare a formazioni scarsamente
Pick Me Up: stesse soluzioni melodiche, stessi intrecci di imitate capendo come di cloni di Wire e Joy Division
chitarre e voci, stessi riferimenti giovanilistici. Qualcuno se ne abbiamo piene le tasche.
apprezzerà, e probabilmente il mercato ha molto spazio Sette brani in poco più di mezz'ora consacrati a impasta76
re felicemente la lezione di Raincoats (il folk maltrattato in chiave urbana), Slits (le voci isteriche, l'impasto
sonoro organizzato secondo tecniche dub) e Rip, Rig &
Panic (certo jungle-jazz a bagno nel funk in allegra confusione). Ne deriva una festa ebbra di ritmo su tappeti
di percussioni, batterie "umane" e non e bassi scivolosi,
attraversata in orizzontale da tastiere kraute e chitarre
pungenti, violini e qualche colpo di genio (la sensazionale
Red Money un outtake di Cut se l'avessero prodotto Brian
Eno e Robert Fripp).
Benedetta inoltre da un gusto melodico obliquo però robusto (esemplare la black mutante di Le Mampatee), che
- come per le Rings - necessita di una frequentazione
assidua e attenta per rivelarsi appieno. Vigoroso e meno
fedele alla linea di quel che potrebbe apparire, Man Meat
si perderà nel magma produttivo attuale per venire riscoperto nel 2020, quando potrete dire: "io c'ero".
(7.3/10)
Giancarlo Turra
Swans - My Father Will Guide Me
Up A Rope To The Sky (Young God,
Settembre 2010)
G enere : heavy rock
Michael Gira aveva voglia di provare di nuovo quel taglio
di chitarra e quel senso così marziale e primitvo di essere
"heavy". Era stato molto chiaro quando un paio di anni
fa ci disse che aveva voglia ancora una volta di suonare
"pesante". Gli Swans come trademark quindi. Tanto ieri
quanto oggi,che se ne dissotterra il cadavere con un disco, una compagine, un tour nuovo e un risultato ancora
una volta diverso da tutto quello che c'è stato in precedenza. In questo senso, l'ultimo parto degli Angels Of
Light, We Are Him, era già programmaticamente coordinato su quest'idea, quella cioè di reinventarsi di nuovo
una ferocia, un'aggressività, un ruggito di chitarra nero antracite. Non un ritorno alle origini però. Niente catastrofi
come in Filth e Cop, quanto una sapiente miscela di
tutto quanto è venuto dopo Children Of God, fino alla
chiusura avantgarde delle colonne sonore per chiechi.
Che alla fine il prodotto finale della reunion suoni come
un perfetto ibrido tra Swans e Angels Of Light dice molto
sulle capacità attuali di questo "grande vecchio". My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky ne esce
fuori con un generale senso di incompiutezza, come se
si girasse sempre intorno ad un'idea senza mai centrarla
in pieno. Alla fine tanto il suono, quanto la struttura dei
brani ne risente, ma tutto viene salvato in calcio d'angolo,
perché si avverte lontano un miglio che ci si trova nelle
mani di un professionista. Uno che l'ha sempre saputa
lunga e anche questa volta si era parato alla grande, met-
tendo le mani avanti mentre dichiarava che i nostalgici dei
bei tempi andati sarebbero stati delusi, perché qui nessuna operazione amarcord avera ragion d'essere. E alla
fine, anche nella line-up, questi nuovi Swans targati anni
zero, hanno davvero poco da spartire con quelli di ieri.
Solo Norman Westberg e Christoph Hahn possono dirsi
ex-membri a tutti gli effetti, mentre il resto viene dagli
Angels Of Light: Phil Puleo, Thor Harris e Chris Pravdica
già in Flux Information Sciences.
Si capisce quindi come il disco suoni come un torrente guadato per metà, senza troppa convinzione, ma con
qualche slancio, qui e li, della vecchia energià. L'apertura
tre le campane di No Words / No Thoughts restituisce subito un'aria da tardi Swans, con la chitarra di Westberg che riporta indietro le lancette a The Great Annihilator. Il canovaccio del lavoro si evolve quindi in maniera
abbastanza prevedibile. Da un lato i brani "heavy rock",
spesso innestati, come quasi tutti, su solide spalle bluesy.
E' il caso delle tracce più in odore di Swans, come My
Birth, la marcetta apocalittica di Inside Madelaine o la marziale Eden Prison. L'altro corpus di brani è invece completamente legato agli Angels Of Light: Reeling The Liars In,
Jim, Little Mouth, ballad tese e introverse. L'eccezione di
You Fucking People Make Me Sick, che vede un inacidito
Devendra Banhart in veste di hobbit sotto acido, cerca di allinearsi alle costruzioni astratte di Soundtrack
For The Blind, ma il risultato è davvero pessimo e sconclusionato. Alla fine un disco che non aggiunge nulla, né a
noi, né a Michael Gira che però, d'altro canto, vedrà bene
di far fruttare di nuovo il nome Swans con il nuovo tour
mondiale.
(6/10)
Antonello Comunale
Teho Teardo - Soundtrack Work
2004 - 2008 (Expanding Records,
Agosto 2010)
G enere : A mbient / minimal
Seguire le vicende artistiche di Teho Teardo significa essere condannati a rincorrere. E spesso ci si ritrova con il
fiato corto. Musicista, compositore, sonorizzatore, sound
designer, ma anche conduttore radiofonico, produttore e
arrangiatore. Non bastasse tutto ciò a far venire un bel
mal di testa, ci pensa la varietà del suo lavoro come musicista. Dopo esperimenti in proprio già nella prima metà
degli anni Ottanta, nel decennio successivo Teardo acquista una certa visibilità sulla scena internazionale grazie al
lavoro nei Meathead, band dedita a un rock industriale
innervato di sperimentazione, lavora a Birmingham, New
York, in compagnia di Lydia Lunch e remixa brani di
Placebo, Girls Against Boys tra gli altri.
77
Ma è negli anni zero che l'attività di Teardo diventa meno
sotterranea e raggiunge anche il pubblico del cinema
d'autore italiano: sue sono le musiche originali di Denti
di Gabriele Salvatores (2000) e Lavorare con lentezza
di Guido Chiesa (2004). In particolare, le composizioni
per quest'ultimo film sono contenute in quest'antologia
che raccoglie il lavoro cinematografico dal 2004 al 2008
e ci aiuta a fare ordine. Vi ritroviamo le splendide atmosfere ambientali e vagamente disturbanti dei brani composti per La ragazza del lago, l'esordio di Malaioli e un
piccolo caso nel 2007, e quelli per il più famoso Il Divo
di Paolo Sorrentino (2008). Completano la raccolta le
musiche originali per Il passato è una terra straniera
e per L'amico di Famiglia.
A supporto del lavoro alle chitarre, al piano, la rhodes e
all'elettronica dello stesso Teardo, c'è un vero ensemble
di archi che conferisce ai brani una profondità che va
oltre il commento delle immagini per cui erano inizialmente pensati. Le sue composizioni atmosferiche sono
sempre costellate di particolari che a volte disturbano
(positivamente), altre volte fanno alzare un sopracciglio
di stupore. E se la musica di Teardo ha interessato un maestro del soundtrack come Ennio Morricone, che lo ha
definito un protagonista della ricerca "dell'originale attraverso un'economia di materiali e una forma personale di
minimalismo", questa raccolta è un'ottima occasione per
cominciare a conoscerlo.
(7/10)
Me). Terror è il produttore grime&dintorni dal tocco più
elegante attualmente in circolazione.
(7/10)
Gabriele Marino
Thermals (The) - Personal Life (Kill
Rock Stars, Settembre 2010)
G enere : A lt . R ock
Sarò sincero, ero partito con l'idea di stroncarlo questo disco. Non perché odi i Thermals, anzi. E' che quando segui
un gruppo dagli inizi e quello che più ti colpisce di lui è
la sapienza con cui incrocia violente scariche punk con la
verbosità polemica di un Bob Dylan, ti fa male vederlo raggiungere una maturità che è quasi sempre sinonomo di ponderazione, inevitabili restringimenti di orizzonti e inconsulti
rallentamenti di ritmo. Più spesso di autentica noia.
I Thermals in questo senso hanno fatto il più tipico dei
percorsi e dopo album brucianti come More Parts Per
Million e Fucking A, hanno dapprima iniziato a intravedere il potenziale commerciale della propria musica,
andando alla ricerca dell'anthem che conciliasse la loro
passione politica con i passaggi su MTV; dal precedente
Now We Can See, poi, hanno iniziato ad assumere la
posa dei veterani in disarmo, relegando ai margini l'urgenza che ci aveva fatto innamorare loro.
Personal Life, com'era inevitabile, completa la svolta.
Archiviata l'incazzatura dell'era Bush, i Thermals si concentrano sui dilemmi personali, finanche amorosi. MusiMarco Boscolo calmente seguono le linee guida di un alt rock di stampo
90s, che nei palinsesti americani ha da tempo rimpiazzato
il ruolo dell'AOR. Il loro, tuttavia, è un power pop dissoTerror Danjah - Power Grid
nante, dalle corpose linee di basso, che nei momenti più
(Planet Mu Records, Luglio 2010)
obliqui fa propria la lezione dei Pixies e che, per certi
G enere : dubstep
In attesa dell'album di debutto vero e proprio, Unde- versi, ricorda il modo in cui i Replacements piegavano
niable, in uscita a novembre, Terror Danjah mette sul la tradizione blue collar ai dettami del punk.
piatto un EP tagliato con il cesello, mezz'ora di pura clas- Dal punto di vista squisitamente melodico contiene alse produttiva. Il suo horror step strumentale è raffinatissi- cuni dei brani più compiuti dei Thermals: Not Like Any
mo, uno stile non solo perfettamente modellato, scolpito Other Feeling e Power Lies sono mid tempo accorati, che
in un continuo appagante esercizio di microspasmi, ma conquistano l'ascoltatore senza neanche irretirlo con un
soprattutto immediatamente riconoscibile. L'uomo cura chorus vero e proprio. Non mancano neppure gli anthem
tutte le componenti della sua musica, timbri, melodie e a presa rapida, anche se ora (è il caso di Your Love Is So
Strong) il furore a cui si accompagnano è più misurato e
struttura dei brani, e il risultato è eccellente.
Otto titoli perfettamente autodescrittivi: rimbalzi e gio- l'indignazione è assente.
chini alla Ikonika (Space Traveller), breaks e assalti di archi, Va dato loro atto di essere maturati senza invecchiare,
come nel suo stile ninjesco (Menace), pulsazioni spastiche di aver pefezionato con conivnzione una formula magari
annegate nel flow (Pulse), torcimenti (Twisted), studi di non più fresca, ma sempre personale ed avvincente. Perasciugamento dub (title track), luccicanti rullanti dubstep sonal Life, in questo senso, è una raccolta di pop song
(Uptown Lane), atmosfera sinistra, due tocchi di piano su chitarristiche potenti, emotive e (quasi mai) scontate.
una base più che secca disidratata (programmaticamente, Apprezzarle, ve l'assicuro, non equivale ad accontentarsi.
Horror Story), addirittura ritorno allo UK garage via dan- (6.5/10)
cehouse/tribal in un'altalena di sfarfallii di tastiera (Ride 4
Diego Ballani
78
Tricky - Mixed Race (Domino,
Settembre 2010)
G enere : tricky mesh
spettatamente shoegaze o il noise in sbornia free della
title track.
Tra i crediti, oltre al padrone di casa - titolare anche
Nona prova per l'ex vocalist dei Massive Attack e san- della Acid Cobra -, troviamo James Johnston (Gallon
tone del trip-hop. Uscito dalle paludi di uno stallo mid-00, Drunk, Lydia Lunch Big Sexy Noise), Stéphane Pigneul
oggi dopo il buon Knowle West Boy, l'uomo si ritira a Parigi (Object, Heligoland) e il nostro Alessio Gioffredi (Die ingaggia una serie di ospiti che gli consentono ancora latazione), a tirare le fila di un disco affascinante che voruna volta di esprimere il suo meticciato sonico. Nel grup- rebbe rappresentare un concept sulla confusione nei rappo dei featurers troviamo al debutto su disco la cantante porti umani ai tempi dei social network.
italo-irlandese Franky Riley, che l'ha accompagnato nei (7/10)
tour degli ultimi due anni e che sostituisce degnamente
Fabrizio Zampighi
Martina Topley Bird, il vocalist giamaicano Terry Lynn,
Bobby Gillespie dei Primal Scream, il liutista e cantan- Underworld - Barking (Cooking
te Hakim Hamadouche e per finire pure il fratello Marlon Vinyl UK, Settembre 2010)
Thaws.
G enere : dance
Il disco salta di palo in frasca in maniera soffusa, come solo A sentire quel disco di collaborazioni dell'anno scorso
Tricky sa fare, esponendo la forma canzone alla sua vo- (Athens), per non parlare delle dichiarazioni anti ellepì
ciona sussurrata e cavernosa, quasi come un Tom Waits di un anno fa o degli sbandierati feat. di Paul Van Dyk
postmoderno. Si va quindi dal remix dei Daft Punk di (e soprattutto Appleblim), pensavamo che Rick Smith
Technologic in chiave bbreak (Kingston Logic) a ricordi del e Karl Hyde potessero tornare in campo con qualche
trip-hop di Maxinquaye con il dialogo tra l'uomo e la ra- idea in più, magari contaminando il dancefloor con jazz,
gazza (Early Bird, Ghetto Stars), dalla cazzatina araba che cantautorato made in Brian Eno (con il quale hanno
fa tanto mesh di Hakim, al blues marcio e lo-fi di Come collaborato recentemente) e sonorità now on (dubstep
To Me, dai i ricordi electro di Time To Dance all'ardkore ovviamente).
Novanta dei Prodigy (Bristol To London).
Non se ne parla. Barking punterà certamente a una glasMixed Race inaugura una fase nuova, rilassata e consape- sa gospel-OGM Eno-assistita, eppure gli hook melodici, e
vole di assestarsi su una buona media compositiva sen- più in generale l'abecedario di loghi comuni pop innestati
za strafare. Come i buoni vini si gustano meglio dopo nello stomachevole menù trance dance UK, sono davvequalche anno dall'imbottigliamento, così questo disco ci ro senza appello.
fa capire che solo oggi Tricky è un'artista consapevole al E' tutto fermo al '96. Un sound ultra commerciale tar100% delle sue capacità, senza troppi patemi o doman- gato Novanta buono per qualche palestra o lezione di
de filosofiche sul futuro del pianeta. L'uomo ci narra da spinning (Always Loved A Film). Se se ne esce si punta alla
una prospettiva personale come si possa cantare ancora ballad (una patetica Louisiana) o all'ambient cuscinetto (gli
col germe del trip hop in testa in un contesto che non Orb in fotocopiatrice di Simple Peal), mentre attorno si
è più pre-millenaristico. Peccato che lo faccia solo per configurano una debole drum'n'bass - data papabile per
mezz'ora.
il revival - come singolo (Scribble), tristi episodi goth-pop
(7/10)
con matematico rise-up da pasticca (Between Stars) e paMarco Braggion sticci eurodisco sui quali è meglio soprassedere proprio
(Diamond Jigsaw).
Perlomeno il precedente Oblivion With Bells si adoUlan Bator - Tohu-Bohu (Acid
perava a tenere alto il blasone di una prestigiosa casata,
Cobra, Ottobre 2010)
Barking, invece, punta a speculare sull'immaginario NoG enere : noise - psichedelia
A sei anni di distanza dal loro ultimo disco - Rodeo Mas- vanta più sputtanato e pertanto si merita il peggio: che
sacre - tornano gli Ulan Bator di Amaury Cambuzat, giornalisti additino comodamente gli Underworld come
con un'opera strutturata, musicalmente ricercatissima e quelli di Born Slippy che cercano di rimanere a galla.
come di consueto trasversale. Post-rock solo in superfi- (5/10)
cie - soprattutto nelle geometrie allentate -, visto che in
Marco Braggion, Edoardo Bridda
realtà il materiale registrato è di quelli consapevolmente
in bilico tra generi e approcci diversi. Come dimostrano
le stratificazioni elettriche di brani come Speakerine o le
atmosfere invernali di Régicide, una Ding Dingue Dong ina79
Venetian Snares - My So-Called Life
(Planet Mu Records, Settembre
2010)
G enere : ' ard - break - core
Come al solito Aaron fa ciò che vuole, e questa sua libertà può portare ad alti e bassi di cui sappiamo bene.
Questo disco è presentato dallo stesso Snares nella pagina ufficiale come la prima uscita di una nuova etichetta,
la Timesig (sempre nel roaster Planet Mu). Le tracce del
lavoro sono state "composte nel giro di uno/massimo
due giorni", e questa urgenza si esplica in una "collezione
di piccole storie".
Ed è un diario allucinato che parte dalla base del breakbeat (il quasi plagio di Come To Daddy nell'opener Cadaverous) per poi rimestare tutti i trick del breakcore di cui è
vate sin dalla notte dei tempi.
Oltre ai ritmi, visto che siamo in piena moda da campionamento '92, troviamo vocine in elio e campioni da
film di serie B (vedi il la retrofilia di Zomby richiamata
in Aaron 2 e Who Wants Cake?) spinte pesissime sui bassi
post-jungle (Ultraviolent Junglist) e accenni melodici, anche quelli tipici del nostro, che ricordano il suo album
del 2005 Rossz Csillag Allat Szuletett (Goodbye9/
Hello10).
Per addetti ma anche per chi c'ha il senso dell'umorismo
breakkato.
(6.8/10)
Marco Braggion
VeryShortShorts - Background
Music For Bank Robberies (Bar La
Muerte, Settembre 2010)
G enere : avant rock
Uno degli inconvenienti più piacevoli circa i Veryshortshorts capita quando provate a cercarli sul
vostro motore di ricerca preferito: guardate che razza di immagini vengono fuori. Ti viene quasi il dubbio
che l'abbiano fatto apposta. Tuttavia è ben altro l'immaginario di riferimento di questo trio italo-francese (Stefan Manca al piano, Stefano Roveda al violino
e Jeremy Thòma alla batteria) stanziato a Berlino. Le
quindici composizioni strumentali del loro esordio
Background Music For Bank Robberies sono un
curioso ed efficace miscuglio di tracotanza rock, estro
improv e languori cameristici.
Ne risultano brevi allestimenti sonori come soundtrack
di sequenze ora romantiche e ora malsane, spesso trafelate e talvolta fragorose.
Mitteleuropa e adrenalina, frenesia e lirismo, una pienezza sonora che fa perno sul drumming robusto ribattuto
dalla puntualità anarchica (e subdolamente pensosa) del
80
piano, mentre il violino fa il diavolo a quattro tra il soave
ed il mercuriale. Buon disco, band interessante.
(7.1/10)
Stefano Solventi
Weezer - Hurley (Epitaph,
Settembre 2010)
G enere : A lt rock
Da un pò di anni a questa parte, ogni volta che i Weezer
si presentano con un nuovo lavoro, scatta in me una curiosità malsana che mi porta a chiedermi se riusciranno a
cadere più in basso rispetto all'album precedente. Devo
dire che fino ad ora non mi hanno mai deluso, inanellando una portentosa serie di scivoloni verso il fondo
culminata con l'ultimo Raditude.
Al cospetto di quella Fossa delle Marianne artistica, questo Hurley non poteva che mostrare segni di ripresa.
Naturalmente non si esce dal paradigma del college rock
infantile, che nella fattispecie ha i suoi picchi di demenza
nelle lyrics di Smart Girls; questa volta però Cuomo e
compagni si ricordano di essere stati una fucina di riffoni
post grunge, e corroborano i nuovi brani con un chitarrismo potente che rimanda proprio agli esordi, purtroppo
al netto della produzione di Rick Ocasek, che fece dell'album blu un bel bigino pop.
Il nuovo corso, è sancito dalla firma del contratto con la
Epitaph, che non sarà più una seconda casa per giovani
skaters come accadde a metà degli anni 90, ma è pur
sempre vicina al target naturale dei Weezer. Ai geeks
e teenagers odierni i californiani offrono il pop al testosterone di Ruling Me e Where's My Sex (con un chorus
oh-so-90s che farà la felicità dei vecchi fan), le virate malinconiche di Memories, ma poi appesantiscono tutto con
l'anthem ultra epico di Trainwrecks e, in generale, con melodie volatili e un pop bidimensionale che fa a pugni con
la ritrovata etica indie.
Alla fine, con tutta la buona volontà, non si riesce ad arrivare alla sufficienza. E dire che (l'oscena) copertina con
il faccione di Hurley, aveva ben disposto un fan di Lost
come il sottoscritto.
(5.5/10)
Diego Ballani
Wolf + Lamb - Love Someone (Wolf
+ Lamb Music, Giugno 2010)
G enere : deephouse
Dopo una serie di produzioni sciolte pubblicate prevalentemente sul solo formato digitale, ecco l'album di Zev
Eisenberg e Gadi Mizrahi, nomi caldi dell'underground
dance newyorkese. La loro formula è tutt'altro che nuova, ma decisamente graziata da un tocco personale.
L'incipit Lynchiano, rumori ambientali e radio scassata
che manda una vecchia musichetta inopportunamente
allegra, seguito dal lento definirsi di un loop deephouse
umbratile (Just For Now) inquadra perfettamente la loro
musica. Dieci brani lunghi, monotoni e monocromi, una
deep sinistra e illanguidita, animata da variazioni di tono
minime ma sensibili, che la fanno ora electropop (Shoeshine Boogie), ora disco/garage (Love Someone), stilizzatamente tribal (Want Your Money), algidamente latin (I Know
You're Living), jazzata (e desolata, Monster Love), Cobblestone Jazziana (Must Be Brooklynn), addirittura Depeche Modeiana (Therapist). Pochissimi elementi giocati
molto bene, stile e atmosfera. (7.2/10)
Gabriele Marino
Wolf People - Steeple
(Jagjaguwar, Ottobre 2010)
G enere : '70 s rock
Chissà quale batterio s'è infiltrato negli uffici della Jagjaguwar, se da tre annetti pure colà hanno preso a farsi
paladini del ritorno all'hard rock e a talune pomposità
progressive. Lo dimostrano i campioni di vendite Black
Mountain e il relativo spin-off Lightning Dust, compagni di palco di questo quartetto britannico ora all'esordio
"vero", dopo una raccolta di singoli e lo sguardo in ogni
caso rivolto ai seventies. Sai che novità di questi tempi, e
anche se mica tutti si chiamano Pontiak, anche qui ci si
è recati a registrare in una casa di campagna: sostituite
Virginia con Galles, e il gioco è quasi fatto.
Si spiegano così l'imbarazzante flauto e i riff prelevati da
Aqualung diTiny Circle e il frequente ricorso a un tentennare tra Led Zeppelin, Free e decine d'altri nomi meno
noti (tranne i pieni e vuoti di Silbury Sands e il convulso
magma Cromlech, il resto si riduce però a puro mestiere).
Vale infatti a poco l'abilità esecutiva se non l'accompagnano attitudine sincretica o una penna che faccia la differenza: i Wolf People si raccontano mediocri e felici passatisti,
una tantum capaci d'infilare la vibrante ballata folk Banks
of Sweet Dundee Pt. 1 dentro una parata di svigoriti luoghi
comuni. Non bastava nel 1973, figuriamoci adesso.
(5.5/10)
Giancarlo Turra
Women - Public Strain
(Jagjaguwar, Agosto 2010)
G enere : pop storto
Sorprende un pizzico meno del debutto Women ma resta
una spanna sopra la media, Public Strain. Merito della
capacità di Patrick Flegel (voce/chitarra), Matt Flegel (basso/voce), Chris Reimer (chitarra/voce) e Michael Wallace
(batteria) di rendere incatalogabili le proprie musiche,
disorientando l'ascoltatore con un mix di pop e noise,
melodie sixties e Velvet, spolverate di Polvo, coralità
solare e profondità weird.
La matassa è sempre la stessa e pure l'amico Chad VanGaalen al mixer - e ospite qua e là - è ancora lui. Di
diverso c'è un alone di latente oscurità, un rinchiudersi
a riccio nelle melodie vocali e una rilassatezza da postparty a limare gli scatti del debutto. Disco difficile Public
Strain: densissimo, stratificato, tendente al nero e non di
facile impatto. Il quartetto giostra col pop sommergendolo di rumore, allenta la tensione strumentale aggrumando
l'impatto emotivo, regolarizza gli arzigogoli mantenendo
una totale libertà nelle strutture dei singoli pezzi.
Particolare da non dimenticare, è infine il fattore canzone. Gli Women ne fanno di compiute e sensate, in pratica
classiche perle dell'universo "storto" degli ultimi 30 anni.
Gliene diamo atto.
(7/10)
Stefano Pifferi
Yann Tiersen - Dust Lane (Mute,
Ottobre 2010)
G enere : pop orchestrale
Piace l'artista che al sesto album ancora avverte la necessità di mettersi in discussione: segno che a muoverne le
scelte c'è un vissuto che impedisce di pubblicare dischi
con atteggiamento impiegatizio. Nello specifico, lungo i
due anni trascorsi a preparare Dust Lane Yann ha perduto
la madre e un caro amico, incupendo un lavoro iniziato in acustica solitudine e poi arricchito di sintetizzatori
vintage, archi e cori con l'aiuto in fase produttiva di Ken
Thomas (Sigur Rós, Dave Gahan). Arduo affermare
se sia da imputare a costui o al musicista bretone l'esito,
teatro interlocutorio dove tortuosità compositive e arrangiamenti sopra le righe spesso soffocano la magia.
La quale torna solo in un'ombrosa Chapter 19,chanson
preziosa dell'ospite Matt Elliott e, in misura minore,
nella filastrocca pop Fuck Me (da gogna però il testo:
"Fuck me, fuck me... make me come again") e nel David
Axelrod apocrifo della title-track. Altrove ci si smarrisce dentro romanticismi ai confini del prog (Dark Stuff)
e inutili lungaggini (Till The End), in belle idee risolte male
(Ashes) e discreti inchini agli ultimi Flaming Lips (Palestine, Amy). Il futuro dirà se si tratta di un momentaneo
appannamento o del sofferto cambio di pelle: per ora,
l'unica certezza resta la novità negativa di una grandeur a
briglia troppo sciolta.
(6.5/10)
Giancarlo Turra
81
Gimme Some
Inches #9
Nuovo giro a colpi di vinile tra witchhouse e hypnagogic-pop, free-madness
e pop-sixties. Protagonisti Talibam!, Aucan, Spectrals, Burial Hex and many,
many more...
Vi stavate preoccupando dell’assenza dei Talibam! dalla scena musicale? Il mese scorso non avevate
trovato nemmeno una release del
duo newyorchese? Tranquilli, questo
mese i nostri preferiti tornano non
con uno bensì con due 7”. Cosmoplitude è il primo 45 giri made in
ESP-Disk della storia, è ultra-sexy
come l'immagine di copertina ed è
pervaso dalla solita attitudine free,
cosmica, trascendente e appassionata che abbiamo imparato ad apprezzare. L’altro invece è uno split italico:
a produrre è la trimurti del rumore
meridionale Ammagar, Musica Per
Organi Caldi e Lemmings, mentre
a condividere i solchi del vinile troviamo i partenopei Ne Travaillez
Jamais. Se il duo Shea/Mottel va di
consueto free-form in presa diretta
(registrato live al Cellar Theory di
Napoli) che ne mostra scelleratezza
e eclettismo, il trio nostrano offre
Una Domenica In Campagna river82
berata e sfuggente in mille direzioni,
potente e insieme screziata cavalcata free-form.
Per americani che vengono da
noi a registrare e pubblicare, ecco
un percorso inverso. Per realizzare il loro primo 7” i bresciani Aucan attraversano l’oceano e se ne
vanno nel lontano Sol Levante. È
la Stiffslack a stampare lo split coi
Talking Dead Goats da Osaka.
Their side for home, our side for the
club, suggeriscono i tre bresciani e
l’ascolto di Crisis, in versione dub
remix ce li fa apprezzare per quella
forma mutante di combo quale sono.
Cangianti e acidi come il vinile giallo
del 7”. Già segnalato su queste pagine, Louis Jones aka Spectrals si sta
facendo un nome a furia di dischetti
in vinile. Ora, se non andiamo errati,
è la volta del primo vinile lungo, fantasiosamente chiamato Spectrals
Extended Play: 7 tracce per Moshi
Moshi che – seppur includano il 7”
Peppermint uscito per il singles
club della label inglese a fine settembre – sono tutte inedite e mixano
il bedroom pop sixties oriented che
caratterizzava le prime releases con
un piglio più r’n’r, sempre dei sessanta. Produzione semiprofessionale e impasto di Diana Ross & The
Supremes e The Isley Brothers alla
maniera di Phil Spector. Da tenere
d’occhio.
A sorprenderci questo mese
però è Daniel Lopatin, noto come
Oneohtrix Point Never che per
Mego da alle stampe un 7” che per
nomi e suggestioni è un vero e proprio gioiello. Seduto al piano e accompagnato dalla voce di Antony
fornisce una versione di Returnal,
già presente sul self titled, che è a
dir poco strappalacrime. Il lato B è
un’altra perla, visto che a remixare lo
stesso pezzo è addirittura Fennesz,
invero piuttosto fedele alla versione
ufficiale, inebetita da qualche folata
di uggiosa manipolazione digitale e
da cascate di synth in overdrive.
Proseguiamo con un mea culpa:
non aver segnalato per tempo il
nuovo EP dei //Tense//, band texana
di EBM fedele alla linea con all’attivo
già un cd-r su Disaro e un album su
Desire. Proprio quest’ultima qualche
mese fa ha infatti rilasciato Introducing, mini di sei pezzi in cui, più che
presentarsi, il combo di Houston
ricalca le coordinate, per altro già
chiare, tracciate sull’LP Memory.
Edito in due versioni, CD e cassetta, l’EP riproduce i vecchi dettami di
funk robotico e meccanici electro
beats da dancefloor ambigua come
solo Front 242 e D.A.F. sapevano
fare. Per gli appassionati un bel tuffo nel passato. Nei Peasi Bassi, dopo
la compilation su doppio LP Kamp
Holland, torna Enfant Terrible con
una nuova uscita sempre su vinile.
Dans è il primo 12 pollici delle Kim
Ki O, duo di ragazze di Istanbul dedito ad una wave dai toni soft per
basso, elettroniche e voci femminili. Nei sei pezzi che compongono il
mini-lp le due giovani amiche danno
fondo a quello che sanno fare meglio: pezzi brevi senza essere stringati, melodici senza eccessiva ruffianeria, astratti senza perdere di vista
l’efficacia delle strutture pop. In rete
è possibile vedere il video di Herkes
Evine da un fotogramma del quale è
stata ricavata la copertina del disco.
Le premesse per un full-lenght d’interesse ci sono tutte.
Chi invece non riesce a stare
con la mani in mano è Clay Ruby,
in arte Burial Hex, uno dei nomi
più apprezzati del vasto sottomondo noise-drone che ritorna con una
folta schiera di nuove pubblicazioni.
La prima è il 12” one-sided licenziato dalla nostrana Holidays. Hunger
consta di due tracce omonime su di
un unico lato vinilico in cui l’uomo
del Wisconsin mette a fuoco una
nuova incarnazione della sua poliedrica creatura. Alla consuete atmosfere astrali il nostro aggiunge ora
un beat di cassa, mai udito prima, che
proietta un’immagine da soundtrack
da film horror anni ’70 à la Goblin.
Spontaneo il parallelo con From
The Grave di Umberto, disco di
cui parlammo (bene) qualche mese
or sono. Una nuova declinazione
che trova un secondo sbocco anche
nell’imminente 7 pollici per Release
The Bats, The Tower, che vanta un
groove se possibile ancora più accattivante. A breve anche un nuovissimo 12 pollici tirato in solo centoventi copie dall’italiana Urashima dal
nome programmatico: From The Rites Of Lazarus. Già in circolazione
invece l’lp Vedic Hymns, split con i
sodali Knit Her, in cui campeggia
l’eccellente Storm Clouds. Chiudiamo
con una segnalazione tutta italiana.
Dopo la pubblicazione di Capputtini'i LignueSatàn,l’ubiqua Shit Music
For Shit People torna con un nuovo
7 pollici, ancora in trecento copie
e confezionato in carta da parati
serigrafata, ormai tratto distintivo
della label. Questa volta è il turno
dei Two Bit Dezperados, quartetto sardo-brasiliano con membri
di Love Boat e Rippers, che rilascia
quattro pezzi di fuzz-garage da toni
ora pop (Devil In Me) ora vagamente
psichedelici (O-Yes). L'artwork di Sylvie P (aka Guillaume dei Feeling Of
Love) arricchisce con gusto questa
succulenta uscita che farete bene a
fare vostra.
Stefano Pifferi, Andrea Napoli
83
Re-Boot
#8
Full immersion di primo autunno
sotto una pioggia fitta di demo, autoproduzioni e affini. Il Belpaese del rock
emergente - almeno lui - non conosce
recessione.
C'è del marcio nella cosiddetta Padania, e i Maciste ci sguazzano come
un ranocchio nello stagno. E' un quintetto "con bombetta", sorta di uniforme
clownesca che sottolinea il piglio balzano d'una proposta che è invece tanto
lucida quanto proteiforme: immaginatevi un Tom Waits colto dalla taranta
balcanica e da una febbre garage-weird,
tipo Jon Spencer frastornato Kusturica, con tutto un afrore old-psych a
scaldare la zuppa gitana. Debutto omonimo (Devil's Ruin Records, 7.2/10)
che ci racconta il teatrino - perché di
teatrino si tratta - con dovizia di particolari, con foga entusiasta, ghignante e
liberatoria.
Passiamo quindi ai siciliani Old Polaroid, che tornano a due anni dall'ep
Man Who Hate Women di cui apprezzammo la centrifuga post-pop balzana e
appassionata, torbida e visionaria. Stavolta ci provano con un album tutto intero, Why Do The Ducks Fly In Flocks?
84
Un mese di ascolti
emergenti italiani
(Moi Mercenaire Dischi, 7.3/10), senza
affatto accusare il fiato corto della lunga distanza. Per (F)rancesco Cipriano
e compagni (tra cui Enzo Cimino, già
Mariposa) eclettismo è la parola d'ordine: canzoni pescate dal baule pieno di
tutto alla rinfusa, fragranze stagionate e
stordenti, ritratti audaci, ammennicoli
esotici, specchi ossidati e foto sbiadite
(polaroid, magari) restituite a vita nuova
e contemporanea. Ne esce misticanza
psych e languori bucolico-melò, una traiettoria storta e dolciastra attraverso le
nebbioline dell'irrequietezza. Una promessa mantenuta.
I Motel 20099 sono quattro ragazzi da Sesto San Giovanni, due chitarre, il
basso, la batteria. Formazione standard
per un rock ruspante che rimanda più
o meno direttamente allo sguardo verso l'America degli eighties pre-Ligabue.
Nel loro Romanticismo dalla periferia per giovani teppisti (autoprodotto,
6.0/10) per fortuna non ci sono machismi da indiani padani e steverogersband,
semmai un estro paisley un po' ingenuo
e inevitabilmente "italianizzato", appena contagiato da vibrioni cantautorali
come dei nipotini ad altezza di marciapiede di Massimo Bubola. Un plauso
all'entusiasmo, se non altro.
Tutt'altra roba, ovvero un'urgenza
wave di riporto nelle cinque tracce di
EP (Anomolo Records, 6.8/10), questo il
laconico titolo con cui debuttano i Drama Emperor da Macerata. Elettronica
ed elettricità affilate con la pietra abrasiva dell'allarme, le voci distorte come
il guazzabuglio emotivo che sovrintende
la loro disamina del contemporaneo. Un
po' Joy Division, un pizzico di P.I.L. e
Bauhaus, particelle Primal Scream
più un estro febbrile da cuginetti del
Teatro degli orrori. Con siffatte coordinate non è semplice proporre soluzioni inedite, ma intensità e convinzione
compensano più che abbastanza. Sembra di ascoltare il Bennato di
Sono solo canzonette e invece si tratta di un giovane musicista siciliano con
la fissa del tono sbracato. L'Erba cattiva (Barbienojarecords, 6.9/10) è un
po' un esordio ufficiale per Carmelo
Amenta – due Ep alle spalle – e raccoglie un campionario di suoni in bilico tra
canzone d'autore, blues e rock. Poche
idee ma buone, condite da una leggerezza negli arrangiamenti che stupisce per
sobrietà ed efficacia. Quanto emerge da
una Non è niente cantata sottovoce o dal
Bennato di cui si diceva in apertura postato nel divertissement in levare di A Volte, dal Tom Waits notturno e ubriaco
di Hombre o dalle inquietudini caveiane
tra chitarre elettriche e piano di Strade.
Melodia e qualche spigolo, in free download sul MySpace dell'artista.
Altra declinazione piuttosto riuscita
tra rock, pop e canzone seria – questa
volta si cita il Battisti più soul, oltre alla
scuola melodico-cantautorale nostrana degli anni Settanta – è quella che si
ascolta in Bugie per Asini (Theatralia,
6.9/10) di Bimbo, al secolo, Simone
Soldani più tutta una serie di musicisti
prestati al synth, alla chitarra elettrica, al
rhodes e alla batteria. Tra rimandi Coldplay su ballad in stile America anni
Cinquanta (Non ho voglia di fare niente)
e falsi plagi del Lucio nazionale (una
Mille parole che gioca con l' Anna del
cantautore di Poggio Bustone, una Figlio
epidurale che ricorda vagamente Il tempo di morire) si collezionano dieci brani
godibilissimi, il cui vero valore aggiunto
sembra essere la produzione (Simone
Soldani,Valerio Fantozzi, Ivan Rossi).
Ci troviamo in Friuli dove il progetto the Storylines nasce quattro anni fa,
a Piancavallo, nelle montagne che guar-
dano la città di Pordenone. Il loro June
Leaves (Megaphone, 6.8/10) è un disco
lieve fatto di atmosfere soffuse e delicate, che riesce a coniugare elettronica e
analogica, con guizzi folk e pop, il tutto
per un cantautorato dal sapore piuttosto homemade, che ci ha ricordato in più
di un momento le prime cose di Beck.
Suoni molto umanizzati i loro, al di là dei
mezzi usati da parte del gruppo, per un
disco che ci ha colpito per l'espressività e una certa compiutezza estetica. Li
aspettiamo alla prossima uscita allora.
E rimaniamo ancora nella stessa regione questo mese, con la cantautrice
franco-friulana Priska e il suo secondo
lavoro Eppure ti vedo ancora (Nota,
7.1/10). Album tra italiano, francese e
furlan, per musica di ispirazione classica
e chamber pop, che fa della malinconia
dark il suo punto forte. Dilatazione e
atmosfere, rarefazione e raffinatezza
caratterizzano in positivo quest’album,
dove l’espressività è sempre contenuta
ma viene comunque fuori con un bel
piglio. Un’uscita che ne conferma il talento. Brava.
Fabrizio Zampighi, Teresa Greco,
Stefano Solventi
85
China underground#0
fare da tramite. Una traiettoria da aggiustare e da approfondire nel tempo,
che però è doveroso percorrere per cominciare a osservare più da vicino un
popolo di cui dovremo abituarci a sentiLa Cina è vicina? Sì, no, per certi versi. re parlare sempre più spesso nei prosTitoli di giornali, servizi televisivi. Miracoli simi anni. Un modo per familiarizzare
economici e prodotti di qualità scadente, con uno spirito artistico che più ci vivi
dittatura e violazione dei diritti umani, il a contatto e più sembra uguale e difascino del dragone. Poi pensi un attimo verso dal nostro. Certo, per fare musica
e capisci che queste immagini-stereotipi si usano sempre chitarre, bassi e batpotrebbero anche non esaurire la com- terie, e le emozioni sono quelle comuni
plessità di un paese. Ti capita di viverci a tutti gli uomini, ma nell’attitudine si
per qualche anno e ti rendi conto che muove qualcosa di diverso. È per quela Cina, come qualunque altro luogo, è sto che intraprendiamo questo viaggio,
più eterogenea di come te la presen- 11 puntate con cui iniziare a osservare
tano i media. Vedi una tradizione forte la realtà artistica indipendente cinese,
e una modernità in via di costruzione, con divagazioni artistico-cinematografiil che significa che c’è un modo tutto che ma con la musica sempre al cencinese di vivere la contemporaneità. Al tro, nelle sue diverse forme e nei suoi
di là dell’ideologia e dello sviluppo eco- soggetti: chi la fa, chi la ascolta e chi la
nomico. E poi c’è la cultura cinese, di produce. Si parte oggi, con una prima
cui non sappiamo nulla perché da noi puntata sulle indie-labeltargate Cina.
non fa notizia, su cui molti cinesi sono Mi sono chiesto cosa avrei potudisposti a investire le proprie passioni e
la propria vita al prezzo di rifiutare vie to scrivere pur essendomi perso una
puntata della storia. E che puntata:
più facili di sopravvivenza.
China Underground non sarà una Tian’an Men.
Cina: musica, cinema e arte. Non
rubrica che vuole spiegare la musica e
l’arte cinese, ma un primo tentativo di è solo una questione di tecnica e taComincia la collaborazione di SA con
il sito China Files. Comincia l'esplorazione del mercato indie potenzialmente
più grande del mondo...
86
lento, c’è qualcosa che scorre dentro
mentre si imbraccia uno strumento
e si versano parole su un microfono
o su una pellicola. C’è lo spirito di
un’epoca e l’identità di un posto. Non
è una buona premessa per uno che
non può certo dire di essere nato
nel posto e nel decennio giusto, per
uno che Woodstock, Hendrix, l’hard
rock, il punk, il dark e via dicendo li
ha potuti solo studiare. O al massimo
immaginare e rimodellare. Sì, vabbè
nel ’94 c’erano i Nirvana ma erano
così americani che lo spirito grunge
lo abbiamo potuto solo imitare.
Gianni Maroccolo in un’intervista di qualche anno fa rifletteva sul
significato del rock. Lo immaginava
come un’indole e come un modo
di rapportarsi alla vita, ancor prima
che come una forma musicale. Per la
cultura alternativa cinese è lo stesso:
in Cina la musica rock nasce come
musica underground che incarna un
certo spirito, un movimento d’animo
che iniziò a covare nei giovani in un
momento epocale della storia cinese.
Era la Cina degli anni ottanta e del
post-maoismo, quella che rinasceva
sulle rovine lasciate dalla Rivoluzione
Culturale. La Cina aperta all’esterno
e al mercato; povera ma che voleva
diventare ricca; convinta di sé, ma
che guardava, imitava e sognava un
Occidente-mito. Individualismo, libertà, malessere generazionale.
Ma anche il non avere nulla. Nei
campus universitari si viveva con
poco e l’individualismo era anche la
risposta di chi era abbandonato a
un futuro difficile da immaginare, fra
tante parole e ideali che arrivavano
da fuori senza però essere davvero
riconoscibili per una massa di giovani
emarginata dai cambiamenti sociali.
Nuovi colori nei vestiti, arte e utopia
giovanile per sperimentare. Capelli
lunghi, sigarette e birre consumate
senza sosta ai margini dell’Università
di Pechino per sfogare. E, nonostante tutto, valori sociali e morali duri
a morire. Le proteste di Tian’an Men
furono un po’ un simbolo, o un punto
di rottura di tutto questo, e la musica che uscì fuori negli anni che le
precedettero fu lo specchio fedele di
un modo di essere e di una speranza,
prima di ogni altra cosa.
Pechino, 1986. Un ragazzo di 25
anni sale sul palco di un festival musicale e intona le note di Nothing To My
Name. Canta un ideale lontano anni
luce dai pezzi dell’epoca. Allude a un
mondo avido di cambiamenti, rifiuta
l’omologazione, parla di sé aprendosi
a sentimenti scomodi per il regime.
Oggi non so quanti ragazzi cinesi che
amano la musica alternativa mi direbbero che ascoltano e che si emozionano con Nothing To My name di Cui
Jian. Ma è un pezzo che è storia, è la
fedele fotografia di un’epoca. E anche
se non parlava di democrazia o libertà di stampa è divenuto una delle colonne sonore degli studenti che occuparono Piazza Tian’an Men prima
della repressione. Perché incarnava
un’indole e la cantava a squarciagola
affinché potesse essere condivisa. Era
l’alba del rock cinese. Tutti lo sanno
e per questo rispettano Cui Jian e il
valore di quel pezzo.
Pechino, 1993. E’ l’anno di Beijing
Bastards, il primo film indipendente
cinese. Iniziato senza una sceneggiatura vera. Per girarlo - senza soldi - ci
sono voluti 12 mesi e la sua uscita
è valsa la censura e l’allontanamento
dall’industria cinematografica del regista Zhang Yuan. Beijing Bastards è
la storia del proprietario di un locale
del circuito undergroundpechinese
alla ricerca della ragazza che ha messo incinta ed è scomparsa. E’ anche
la storia di un gruppo che non riesce
ad esibirsi davanti a un pubblico. E
quella di uno scrittore che prova a
vendere le sue creazioni e quella di
un pittore a caccia di un truffatore.
Tra gli attori, ancora lui, Cui Jian, nei
panni del leader della band. I protagonisti si sovrappongono in ricerche
che divengono un vagabondaggio
senza meta. Questa volta sono passati 4 anni da Tian’an Men e i sogni
sono già seppelliti sotto una coltre di
silenzio.
In quegli anni la Cina pianificava la
sua riabilitazione internazionale, dopo
che le immagini di un uomo disarmato davanti ad una fila di carri armati
avevano fatto il giro del mondo. Preparava i suoi PIL a doppia cifra, ma ci
sarebbe voluto un decennio per avere di nuovo il rispetto dell’Occidente
e non con la democrazia ma con i
soldi. Era una Cina diversa da quella
cantata da Cui Jian, o forse no, era la
stessa Cina, solo più smarrita, dopo
aver ripudiato il governo e la fine di
un sogno forse non compreso neanche dagli stessi studenti. Smarrita per
i cambiamenti che si intravedevano
all’orizzonte: giovani marginalizzati
dall’ingresso nel mercato, come quelli che prendono forma nelle prime
pellicole di Jia Zhangke, una delle
voci più autorevoli del cinema cinese
di fine anni Novanta e dei nostri anni
Zero.
Intorno prendevano forma i primi
progetti rock. Emergeva una fedeltà
alle attitudini anglo-americane, che
si incontrava con la tradizione folk
del Nord-ovest cinese, di cui veniva
ripreso lo stile del cantato urlato e
dissonante. Dai Black Panther mosse
i primi passi Dou Wei, oggi capofila
della musica cinese d’avanguardia e
sperimentale; nei Mayday compariva He Yong, chitarrista considerato
tra i padri del punk cinese; le Cobra
tessevano una formula new-wave al
femminile, mentre i Tang Dynasty
preparavano A Dream Returns To Tang
Dynasty, un album destinato a divenire una pietra miliare dell’hard-rock
cinese.
Xindu, 2010. La seconda edizione
dello Zebra Music Festival apre i battenti. Nella prima delle tre giornate di
musica e intrattenimento accorrono
50.000 persone. Musica pop e alternativa, persino alcune vecchie glorie
degli anni Novanta. Tre palchi, di cui
il principale non ha nulla da invidiare
ai migliori mega-eventi d’oltreoceano. Grandi sponsor e grandi ingranaggi commerciali; l’area che ospita
e divulga le iniziative di alcune ONG
locali stride con il megaschermo del
palco principale, che nei momenti di
pausa manda messaggi pubblicitari
alternati a video stile MTV. Una macchina organizzativa lontana anni luce
dai primi festival che mossero i passi
alla fine degli anni novanta, guidati dal
MIDI festival di Pechino.
Gli anni Novanta sono stati una
transizione importante per la musica
cinese: la circolazione dei primi cd,
l’apertura di pub e l’esibizione live
nella capitale hanno aiutato lo sviluppo di una scena, mentre la ricezione
di nuove forme musicali, ispirate al
metal, al punk e al grunge si sono riflesse nell’ampliamento della geografia musicale oltre Pechino. Nel 1993
apriva i battenti la MIDI School, con
un corso di tre anni per aspiranti musicisti rock. Il ricambio generazionale
era assicurato e una maggiore competenza tecnica diventava negli anni
87
sempre più alla portata di tutti. La seconda metà del decennio fu accompagnata dall’arrivo del new metal, del
rap e del post-punk.
La Cina è cambiata. C’è da chiedersi se con l’aumento della band e la
crescita dell’ambiente qualcosa di originario sia andato perdendosi in termini di autenticità per acquisire però
qualcos’altro. I progetti effimeri sono
aumentati, ma ugualmente sono cresciuti anche i contenuti dei prodotti
di valore. Oggi la Cina è meno naive e se l’indole degli anni Ottanta è
oggi ormai difficilmente riconoscibile, c’è maggiore consapevolezza della propria posizione e della propria
funzione artistica. Mentre la musica
alternativa ci ha guadagnato in nuovi suoni, sperimentazioni e persino
tournée all’estero viste come forme
di apprendistato.
La Cina è cambiata. Si muove in
modo disordinato attorno a un’industria discografica tutt’altro che tangibile, a un pubblico ancora molto ristretto e a limiti più o meno sensibili
per la creatività artistica. L’internazionalizzazione è divenuta una realtà del
nuovo millennio anche per la musica:
alcune bandhanno firmato contratti
con label occidentali, internet è divenuto il primo veicolo di promozione,
mentre una serie di addetti ai lavori
è sbarcata in Cina, chi per investire e
chi per contribuire alla nascita della
musica alternativa cinese, con nuovi
locali, con etichette indipendenti, con
attività di talent-scout.
Nuove scene musicali hanno preso piede, in grado di mettere insieme
competenza tecniche, forme musicali
contaminate e sensibilità cantautoriale. Su tutte il neo-folk cinese (Xin minyao), ma anche progetti singoli dotati
di ben altro spessore e personalità
rispetto alle primissima scena musicale metal e punk, improntata ancora
all’imitazione di modelli stranieri. Le
barriere del regime esistono ancora
oggi, ma somigliano al contorno di
88
uno spazio che al suo interno lascia
una libertà di movimento sufficiente
a creare un fermento, in cui la voglia
di chi fa la musica, chi la produce e
chi crea spazi per ospitarla convergono per creare una scena che ha in
Pechino il suo epicentro naturale.
Per chi è lontano come noi c’è
tanto da capire e osservare. C’è da
riconoscere un percorso a tratti anche snaturato. Oggi gli artisti musicali
sono mille miglia lontano dall’indole
del primo rock cinese; ma in pochi ti
diranno di non apprezzare Cui Jian,
se non altro per quello che ha significato. C’è un filo che parte dalla cultura post-maoista e arriva fino ad oggi,
passando per Tian’an Men e per lo
sviluppo di una super potenza economica. Di fianco, il mercato globale
e l’Occidente maestro e raffronto
costante, con le sue forme musicali e
le sue competenze più specializzate
sul piano strettamente tecnico.
C’è anche chi dice che la musica
non ha frontiere e permette incontri tra persone che parlano lingue
diverse e distanti. Basta imbracciare
uno strumento e iniziare a suonare
davanti al pubblico di studenti fuori
sede e di giovani cinesi all’interno di
un piccolo locale di un qualsiasi hutong di Pechino per rendersene conto.
* China Files [www.china-files.
com] è un’agenzia di stampa composta
da giornalisti, videomaker, fotoreporter e
sinologi di diverse nazionalità. Sfruttando il valore aggiunto della presenza sul
territorio cinese, si propone di ascoltare,
osservare e raccontare la Cina contemporanea nella sua complessità, troppo
spesso ridotta a interpretazioni in bianco e nero.
Mauro Crocenzi
China underground#1
chiarezza legale. Secondo: la confusione di una moltitudine di percorsi
individuali uniti dall’amore per la musica ma sostanzialmente privi di coordinamento e pianificazione. Come
“In Cina non c’è un mercato di mu- dire: non esiste un mercato indie, ma
sica indipendente”. È questo un ritor- c’è un sacco di musica alternativa, che
nello che ci si ritrova a sentire spesso piaccia o meno, di qualità o prodotta
nei circuiti musicali dell’underground in casa, ma pur sempre indipendente.
pechinese. È un problema di band Questa musica esce dalle sale prove,
di qualità, in una scena musicale an- arriva nei locali, sui palchi dei festival
cora molto giovane. E di pubblico, e anche su compact disc e sui (poin una società che ha ancora altre chissimi) siti o riviste specializzati;
priorità rispetto alla musica alterna- sempre grazie a individui che spesso
tiva. Ma anche di acquisto: pirateria senza alcuna esperienza ma con una
e produzione a basso costo sono gran voglia di fare mandano avanti
due problemi storici dello sviluppo una macchina, in equilibrio tra pasdi un’industria professionale made in sione e carenze di mezzi, con la priChina. Per l’esistenza di un mercato ma a compensare la seconda.
Non è un caso che qui in Cina ci
musicale indipendente non basta un
numero di band o di festival musicali sia una consapevolezza molto minocostantemente in crescita; un merca- re - rispetto alla nostra Italia - della
to gira intorno al coordinamento di distinzione tra mercato delle major e
diversi soggetti fino a legare chi fa la mercato indie. Perché qui di distinziomusica a chi la ascolta. Dalla produ- ne ne fanno un’altra: tra industria dizione alla promozione, dal negozian- scografica (con un mercato esistente,
grandi somme a disposizione, grande
te all’acquirente.
Riflettere sull’argomento con gli utenza e poca creatività) e musica
addetti ai lavori cinesi spinge a due underground (senza un vero mercaconclusioni su tutte. Primo: la confu- to, con pochi finanziamenti e molta
sione di un ambiente in cui manca- creatività). In mezzo, c’è qualcosa di
no figure professionali specializzate, diverso, con una forma ancora apmezzi economici, distinzioni nette e prossimativa ma che ci ricorda la
Modern Sky, Pilot Records, 13 Moth,
Areadeath, Miniless. Le indie label tra
auto-organizzazione, localismo e slanci
industriali...
Il mercato della musica
indipendente in Cina
scena delle indie-label americane.
Sarà per invidia o per ignoranza,
sarà per quel vecchio e irrisolvibile
conflitto tra il vendersi e la fedeltà alla
linea, ma negli ambienti maggiormente alternativi non si fa che un gran
parlare di nomi come la Modern Sky
Records, la regina delle indie-label targate Cina.
Fondata nel 1997, la Modern Sky
ha fatto da madrina a nomi molto caldi della scena nazionale alternativa,
come Re-TROS, New Pants e PK-14,
con un catalogo che oggi si avvicina
alle 100 pubblicazioni dall’inizio delle
attività. Emerso come nucleo originario, oggi quello musicale è solo uno
dei tanti settori in cui opera l’impresa
madre, la Modern Sky Entertainment,
con specializzazioni che vanno, tra
l’altro, dal campo letterario a quello
cinematografico e al design. Musicalmente parlando, esiste persino una
divisione dell’azienda, la M2, che si
impegna nella gestione dell’immagine
delle band.
I festival patrocinati dalla Modern
Sky sono tra i più popolari in Cina.
Negli ultimi anni gli appuntamenti
live del Modern Sky Festival e dello
Strawberry Music Festival sono riusciti a guadagnarsi la partecipazione
di artisti di calibro internazionale,
89
come Xiu Xiu e International Noise
Conspiracy. La sezione discografica
della Modern Sky Entertainment è
radicata sul territorio, con tre sottoetichette specializzate divise per generi (rock-underground, world music
ed elettronica) e agganci sempre più
saldi con l’occidente, si veda la partnership con la multinazionale EMI e la
licenza per la distribuzione di gruppi
importanti come Radiohead, Mogwai,
Bauhaus ed Echo & the Bunnymen.
All’interno del panorama discografico indie esistono anche altri modelli di successo, come quello della
Pilot Records, attiva nell’organizzazione di concerti di caratura internazionale (Peaches e The Secret Machines, giusto per citare i due eventi più
recenti) e produttrice di gruppi cinesi
con un buon seguito (AK-47 e Ziyo).
O come la 13 Month, fortemente
legata alla promozione della cultura
live in Cina e allo sviluppo della scena
folk-rock cinese. È con quest’ultima
che incide Xie Tianxiao, la figura
forse più rappresentativa del rock cinese dell’ultimo decennio.
S celte
di vita e di passione
Realtà ben avviate come quella
della Modern Sky Records, della Pilot
Records e della 13 Month restano
però una stretta minoranza nella scena musicale alternativa cinese, che è
tuttora molto legata all’iniziativa dei
singoli e frammentata in un mosaico
di collettivi poco allineati all’industria
musicale. In questo quadro, Pechino
mantiene tradizionalmente il ruolo di
centro gravitazionale, cuore culturale
di una Cina divisa tra l’affarismo delle città costiere e le metropoli industriali nell’entroterra.
La storia di Wang Xiao è a suo
modo molto lineare. Il punto di partenza della sua esperienza è stato un
sito internet, aperto nel 1997, quando il web cinese ancora non era il
mezzo di supporto principale per la
promozione. E da una passione per
90
l’heavy metal condivisa in una scena
musicale allora ristrettissima, dove
i principali soggetti si conoscevano
tutti. Solo due anni dopo, Wang Xiao
era già coinvolto nella pubblicazione
di un paio di riviste specializzate. Poi
per lui l’arrivo a Pechino e un progetto discografico che prende piede
tra il 2003 e il 2004 con la nascita
dell’etichetta metal Areadeath.
Per risparmiare si cercano tutti gli
espedienti possibili e così promozione gratuita e richieste morigerate
da parte dei gruppi che entrano nel
progetto permettono di dare respiro
all’investimento iniziale. La strategia
è quella di produrre (a basso costo)
in Cina e rivendere all’estero, in un
mercato già sviluppato.
L’esperienza della Miniless ricorda invece la storia di una vera e propria etichetta di culto. Fondata nel
2006 da Yang Chang, Han Han e
Li Xiaoliang, la label è tra le poche
concentrate sulla scena musicale del
Sud-Est della Cina, Shanghai e dintorni. Quando gli chiediamo di “promozione” e di “obiettivi”, Han Han
storce il naso e preferisce parlare
di “diffusione” e “percorso”. Per lui
l’esigenza principale non è la vendita o l’affermazione della Miniless nel
mercato musicale in quanto azienda.
Le cinque persone che collaborano
oggi con l’etichetta hanno tutte un
altro lavoro e l’impegno che spendono nella musica è quello di “scoprire
nuove realtà di valore per dare loro
una voce”. Una piattaforma dove
ognuno mette quello che ha, al servizio della creazione artistica musicale.
Del resto Han Han viene da Hefei, uno dei tantissimi centri urbani
cinesi con una popolazione di milioni
di abitanti ma completamente priva
di qualsiasi spessore culturale. La sua
idea di etichetta discografica parte
da un’esperienza di condivisione. Tra
persone legate a progetti musicali affini e unite nel volere che questo suono sia cinese, perché troppi
gruppi della scena cinese degli anni
’80-’90 sono finiti su un palco solo
per le loro qualità di poser, per essere delle mere imitazioni di rockstar
straniere. Le band che operano nella
Miniless variano nello stile, dal noise
allo shoegaze, dal post-rock all’elettronica, ma condividono lo stesso
approccio alla musica, basato su un
certo tasso di preparazione tecnica e
su un atteggiamento live teso e nervoso (piuttosto che sfrontato, come
era invece per i colleghi dei decenni
precedenti).
Ci sono poi esperienze ancora
più ristrette, veri e propri collettivi
autonomi completamente staccati
dal mercato. È il caso della Nojiji,
etichetta attiva dal 2004 in uno dei
tanti distretti dell’immensa periferia
pechinese, un riferimento attivo per
i musicisti “delocalizzati” di una metropoli delle dimensioni di Pechino.
Il collettivo prescinde da ogni considerazione economico-commerciale
e si basa sull’auto-finanziamento, a
supporto di un’attività creativa diversificata tra letteratura, musica, cinema, eventi. Fulcro del progetto è un
concetto di cultura underground che
muove dalla cultura beat americana
fino a congiungersi con la filosofia
buddhista cinese. Lo scenario abituale è quello dello “Small Buddha’s
Saying Club”, spazio dove convergono le iniziative principali, ma il nome
dell’etichetta ricorre anche in occasione di performance in spazi alternativi e di esibizioni estemporanee,
il tutto all’insegna di un sound noise-sperimentale sporcato da segnali
elettronici.
La
sfida della produzione
di musica underground
cinese
Progetti come quelli della Areadeath, della Miniless e della Nojiji non
mirano ad investimenti di successo,
ma sono dettati da ideali che devono
far fronte a carenze basilari, su tut-
te quella di investimenti e di figure
tecnico-professionali. La mancanza di
soldi ostacola lo sviluppo di una scena musicale di valore e a risentirne è
soprattutto la qualità del suono, limitata dalla sostanziale assenza di figure non solo provviste di competenze
tecniche e di esperienza, ma anche in
grado di consigliare le band sul suono da adottare.
Un’altra sfida con cui confrontarsi
è quella della vita breve delle band.
Un processo tipo è quello che vede
sciogliersi un gruppo subito dopo il
periodo universitario per far fronte
alla realtà lavorativa, che può portare un ragazzo anche a migliaia di
chilometri di distanza dalla città di
origine. La mancanza di continuità
nei progetti può limitare la volontà
di un produttore di investire sulla
musica cinese ed indirizzarlo verso il
mercato straniero. Tutto ciò costringe un’etichetta a vivere in continua
trasformazione. Spesso persino quello delle tournée diviene un impegno
organizzativo troppo complesso in
un paese come la Cina, dove, oltre
alla mancanza di locali in cui esibirsi,
gli spostamenti risultano assai difficoltosi per via delle grandi distanze.
A questi problemi si aggiungono
quelli con cui l’industria discografica
è costretta a confrontarsi su scala
mondiale: crisi del mercato, download, Internet. La maggioranza delle
label underground è stata fondata
nell’ultimo decennio da giovani cinesi cresciuti nell’era di Internet. Il che
porta ad una comprensione generalizzata del meccanismo dello sharing
musicale. La vendita online è allora il
modo più comune per fronteggiare la
crisi, eliminando la maggior parte dei
costi, mentre si tende a diversificare
le attività e ridurre la produzione di
cd.
Ma anche in questo caso il mercato cinese è molto particolare. Il costo di un cd si aggira mediamente sui
3-4 euro a copia, essendo registrato
a costi bassissimi e con una produzione scadente. L’andamento dei
prezzi si è stabilizzato negli anni ’80
con l’arrivo di materiale discografico
di scarto uscito dai circuiti internazionali e reintrodotto a prezzi molto
bassi in quello cinese. Da allora fino ai
giorni nostri gran parte della produzione musicale occidentale è rimasta
su prezzi bassissimi per il diffondersi
della pirateria. Il che oggi limita quei
produttori cinesi che vorrebbero migliorare la qualità delle registrazioni
nella musica indipendente, ma che si
troverebbero a non operare più nei
prezzi di mercato.
Oltretutto il pubblico “alternativo” cinese per definizione non
è orientato all’acquisto di cd: né di
band straniere, estranee all’esperienza culturale cinese, né di quelle nazionali, ampiamente scaricabili dalla
rete. Neppure le esibizioni live riescono ad invertire la tendenza, perché spesso le livehouse richiamano
gente in cerca di un semplice svago
e di nuovi trend sociali piuttosto che
di buona musica.
Ce ne sarebbe abbastanza per interrogarsi su come, nonostante tutto,
le etichette indipendenti cinesi stiano
sempre più aumentando. Per registrare in Cina basta poco, pochissimo: un registratore, un computer, un
masterizzatore, un cd vergine. A prescindere dalla ricerca di registrazioni
di qualità. In barba alle esigenze legali
connesse con il copyright. Ma non si
tratta solo di questo, c’è qualcosa
che si muove nell’aria, come una coscienza di un processo ormai avviato
e inarrestabile. Qualcosa di molto vicino ad una scena musicale in via di
diversificazione e di definizione in cui
è possibile riconoscersi, tanto per chi
la musica la propone, quanto per chi
quella musica la ascolta.
sinologi di diverse nazionalità. Sfruttando il valore aggiunto della presenza sul
territorio cinese, si propone di ascoltare,
osservare e raccontare la Cina contemporanea nella sua complessità, troppo
spesso ridotta a interpretazioni in bianco e nero.
Mauro Crocenzi, Lucia Di Carlo,
Desiree Marianini
* China Files [www.china-files.com]
è un’agenzia di stampa composta da
giornalisti, videomaker, fotoreporter e
91
Rearview Mirror
—speciale
Orange Juice
Londra, 20 febbraio 2005: il quarantaseienne Edwyn Collins viene ricoverato nel reparto di terapia intensiva del
Royal Free Hospital per la seconda di due emorragie
cerebrali susseguitesi nel corso di pochi giorni; un evento che lo lascia semiparalizzato e con una lunga e lenta
riabilitazione neurologica da affrontare. Era allora arduo
pronosticare un lieto fine a una vicenda così tragica e
devastante, eppure la scommessa con il destino è stata
in qualche modo vinta. “Sto lavorando di nuovo e scrivendo
canzoni, lentamente” diceva già un po’ di tempo dopo.
Ecco allora un album, Home Again, già registrato allora
e poi uscito nel 2007, seguito l’anno dopo da un’effimera
e celebrativa reunion della sua band, fino al ritorno vero
e proprio con Losing Sleep (omaggio a un prime mover
da parte di estimatori come Roddy Frame, Johnny
Marr e Franz Ferdinand), cui si accompagna la pubblicazione su Domino di un ricchissimo cofanetto retrospettivo dei suoi Orange Juice, Coals To Newcastle
(6 CD e un DVD di cui potete leggere sul sito <http://
www.sentireascoltare.com/recensione/7720/orangejuice-coals-to-newcastle.html>). Non c’è dunque migliore occasione per ripercorrere la storia del gruppo
madre, ancor oggi misconosciuto capostipite dell’indie
pop, scozzese e non solo, di cui in seno alla Postcard
Records ha decretato la nascita.
S tar t
Alieni in top ten
Se è indie, perché non deve essere anche pop? La parabola creativa degli scozzesi, prime mover pop soul in
pieno post-punk, tra anarchia e tentazioni top ten. Una
retrospettiva ne celebra le gesta.
92
Testo: Teresa Greco
con contributi di Antonio Puglia
again !
Gli Orange Juice (Edwyn Collins, David McClymont,
James Kirk e Steven Daly nel nucleo originario) provenivano da Bearsden, un quartiere borghese della periferia
di Glasgow e all’alba degli Ottanta erano già una novità
pressoché assoluta nella convulsa scena post-punk. Pur
con un recentissimo passato più punk oriented sia pur sui
generis (erano nati nel 1976 come Nu-Sonics), si erano
infatti formati alla scuola dei Velvet Underground,dei
Byrds, della psichedelia pop dei ’60, del soul di Stax e
Motown, della New York di Television e Talking Heads,
della disco e del funk. La novità consisteva anche e soprattutto nel rifiuto della degenerazione punk nel machismo
e dell’imperizia tecnica, ponendosene in netta antitesi fin
dal nome scelto, che sapeva di autoironia e colore psichedelico. “Nessuno di noi beveva alcool all’epoca… sembrava
perfetto, perché il succo d’arancia era ciò che bevevamo durante le prove” ricordava Collins. La sua voce particolare
e calda, debitrice di Pete Shelley, Vic Godard nonché
del maestri di stile David Bowie e Brian Eno rompeva totalmente gli schemi della ribellione e della militanza
post-punk, con ironia, goiosità e un sorprendente inedito
romanticismo; la stessa immagine del gruppo richiamava il
loro ibrido di sixties e America (giacche di pelle scamosciata, camicie a scacchi Creedence, t shirt warholiane).
Come sottolinea Simon Reynolds nel suo Post Punk (titolo originale? Rip It Up And Start Again, ovviamente), il
chitarrismo che di lì a poco imperverserà grazie anche
ai cugini da Edimburgo Josef K. e i concittadini Aztec
Camera parte da qui; l’essenza del suono era infatti la
seicorde ritmica, suonata in tempo doppio rispetto alla
batteria, sul modello degli ultimi VU e degli Chic, altra
grande influenza. Come ricorda il batterista Daly, “la nostra idea di fondere Chic e Velvet suona molto audace sulla
carta, ma se si ascolta Live 69 la chitarra in doppio tempo di
“Rock and Roll” non è molto lontana da quella di Nile Rodgers negli Chic, molto netta e secca”.
Fondamentale per la crescita e il passaggio da Nu-Sonics
a Orange Juice fu l’incontro nel 1978 con lo scafato sia
pur diciannovenne Alan Horne, singolare appassionato
di musica pre-punk (dal Northern Soul al rock psichedelico), un amore condiviso con la band che dal canto suo
si lascia influenzare volentieri. Nasceva così la Postcard
Records (gestita direttamente da Horne, anche manager dei gruppi) proprio con la pubblicazione nella primavera del 1980 del primo singolo in arancio (cofinanziato
da Collins, Horne e McClymont), Falling and Laughing:
puro jingle jangle, con un basso pulsante e un oscuro
sentore velvetiano.
A differenza dei colleghi contemporanei, Horne puntava
però a un mercato più vasto rispetto al circuito indipendente, attraverso la distribuzione, la ricerca dell’appoggio della stampa musicale e i primi contatti con le
major. Nella label arrivarono poi via via anche i citati
Aztec Camera e Josef K. e gli australiani Go Betweens,
idealmente vicini a quei suoni, creando una vera e propria identità locale sul modello idolatrato della Motown
(lo slogan dell’etichetta era, non a caso, “The Sound Of
Young Scotland”). Gli Orange Juice sfornavano così una
serie di 45 (Blue Boy e il retro Love Sick, gioiellini funky e
pop-soul adeguatamente riscaldati dal crooning sghembo di Collins; Simply Thrilled Honey, Poor Old Soul) che
dominavano le classifiche indipendenti; Horne però continuava a nutrire ambizioni più ampie. Se è indie, perché
non deve essere anche pop?
La band così si apprestava a preparare un album (Onwards And Upwards) e un singolo (Wan Light) per la
Postcard nel 1981 (mai usciti, vedranno la luce solo nel
’92 con il titolo Ostrich Churchyard), mentre nello stesso tempo si metteva alla ricerca di un contratto major,
trovando infine la Polydor disponibile (con l’ideale benedizione di Horne, cui non restò che chiudere l’etichetta
dopo il naufragio dell’esordio dei Josef K.). Non era più
l’isola felice della label casalinga. Le cose non andarono
infatti come sperato e l’album venne reinciso e ripulito
nei suoni, uscendo con il titolo di You Can’t Hide Your
93
Love Forever (1982), incontrando modesta fortuna commerciale. Una versione clean del classico suono Postcard,
che sapeva di già sentito rispetto alla musica di appena un
paio di anni prima; un paradosso temporale. Sul mercato
intanto cominciavano ad apparire alcuni epigoni, come gli
inglesi Haircut One Hundred, dal suono e look sorprendentemente simile agli Orange del recente passato,
sia pure un po’ più raffinati, e i Nostri erano messi nettamente - e ingiustamente - in secondo piano.
A questo punto l’intuito pop di Collins ebbe la meglio:
via dal gruppo James Kirk e Steven Daly (“gli elementi non
professionali”) a favore di una formazione più stringata e
snella: alla chitarra Malcolm Ross dei Josef K. e alla batteria Zeke Manyika, con cui si sarebbero realizzati i seguenti due album e tre singoli d’eccezione: L.O.V.E. Love (cover
di Al Green), il funk di Rip It Up e il Philly sound di Flesh
of My Flesh. Il gioiellino Rip It Up riuscì dove non si era
arrivati prima: entrò infatti in top ten nella primavera del
1983. Uno spigoloso funk dance di matrice ottanta che
sarebbe rimasto la loro maggiore hit, con un giro di basso di origine Roland 303 poi sinonimo di acid house e la
solita chitarra Chic. Un hook di richiamo a Spiral Scratch
dei Buzzcocks metteva poi bene in chiaro le loro radici
(You know the scene it’s very humdrum /And my favourite
song’s entitled Boredom, - Sai la scena è molto monotona, e la
mia canzone preferita è Boredom – mentre seguiva un riff a
due note che citava quello di Pete Shelley in quel pezzo).
Perfetti alieni in top ten.
Il pop (o New Pop che dir si voglia, reynoldsianamente)
intanto sbancava in classifica anche oltreoceano, con una
94
versione piuttosto edulcorata rispetto alla prima eccellente ondata di Soft Cell, Associates e Human League
(Duran Duran, Culture Club, Wham! e compagnia
danzante). Pur spinto dall’omonimo singolo, Rip it Up
(1983) ebbe però scarse fortune commerciali, mentre i
rapporti tra la Polydor e gli OJ intanto si deteriorarono
sempre più per le scarse vendite. Non bastasse,durante
le registrazioni le tensioni interne sfociarono nell’uscita di Malcolm Ross (lo ritroveremo più tardi negli Aztec
Camera) e David McClymont e la band si ridusse essenzialmente allo stesso Collins e al batterista Zeke Manyika, che registrarono l’EP Texas Fever (1984) così come
l’ultimo album in studio, l’eponimo Orange Juice, il cui
compatto blue-eyed soul apparve timidamente in classifica. La rescissione del contratto con la major all’inizio
del 1985 segnò infine il capolinea. Singolarmente, il leader avrebbe conosciuto il vero successo a metà ’90 con
il tormentone A Girl Like You, eccezione commerciale di
una carriera solista più che dignitosa trascorsa sino ad
oggi tra album di classe e una soddisfacente attività di
producer. E di leggenda vivente, perché l’eredità artistica degli Orange Juice è stata di ispirazione per disparati
artisti e movimenti, dagli Smiths ai Pastels, alla C86 e
alla Creation, per non parlare della successiva Glasgow
School (per citare una fortunata retrospettiva uscita nel
2005) dei vari Jesus & Mary Chain, Teenage Fanclub,
Delgados, Belle And Sebastian, Franz Ferdinand. E
la storia e la musica continuano.
95
(GI)Ant Steps #42
classic album rev
Herbie Hancock
Black Crowes
Head Hunters (Columbia Records, Settembre
1973)
Shake Your Money Maker (Universal, Settembre
1990)
"No, non suono jazz. Suono musica nera". Parole e musica
- la citazione è approssimativa - di Miles Davis. Chissà
se ad Herbie Hancock frullarono tra le orecchie,
assistendo all'attacco incrociato che la critica jazz
riservò ad Head Hunters, album numero dodici a
poco più di un decennio dall'esordio. E' probabile altresì
che appena iniziarono a fioccare le royalty certi crucci
siano evaporati come caligine mattutina: ci sono voluti
quasi trenta anni affinché Come Away With Me di
Norah Jones lo scalzasse dal piedistallo degli album
jazz più venduti di sempre. Nel frattempo anche la
critica aveva aggiustato il tiro, anche perché molto di
quel che era accaduto individuava proprio in Head
Hunters un capostipite, punto di riferimento e fonte
d'ispirazione per hip-hopper d'ogni ordine e grado.
Troppo facile però salire sul carro del vincitore. Meglio
restare, per quanto possibile, al merito e all'epoca.
Il pianista chicagoano usciva da un terzetto di album
sperimentali che spostavano da par loro l'asticella della
fusion (i notevoli Mwandishi, Crossings e - soprattutto Sextant). Tuttavia, dopo i fasti artistici e commerciali dei
sixties, il mercato si era messo di traverso procurandogli
non pochi grattacapi. Non per buttarla sul prosaico spiccio, ma la svolta di Head Hunters somiglia davvero ad
una rivalsa nei confronti di chi lo calcolava ormai astruso, cervellotico, genio perso nel proprio formidabile labirinto. La metamorfosi investì in primis la band: della
formazione precedente confermò il solo Bennie Maupin
ai sax (più clarinetto e flauto), completando il quintetto
con Paul Jackson al basso, un batterista (Harvey Mason)
ed un percussionista iperversatile come Bill Summers
(ecco a voi i futuri Headhunters). Per se stesso, il pianista si era apparecchiato un arsenale di piani elettrici e
sintetizzatori.
Ecco, dunque, mettiamo che il jazz - postulando Miles non esista. E che se c'è un obiettivo ce l'hai tutto intorno.
Erano giorni caldi sul fronte del funk. Una rivoluzione
96
preparata a lungo e sancita da There's a Riot Goin'
On di Sly And The Family Stone, ovvero l'abbattimento del muro tra la dimensione artistica e politica.
Un incaricarsi della questione razziale senza sconti né
vaselina. Un diverso porsi. Che investe tutti gli aspetti
dell'espressione, visti come tanti anelli di un'unica catena,
dall'acconciatura ai testi passando per il recupero delle
radici sonore africane. Tenuto conto di questo, Head
Hunters risponde ad un progetto preciso di concretizzazione del jazz. Il funk è un passaggio formale inevitabile e naturale. E' il codice della contemporaneità, ponte
aereo verso i territori primordiali e ritorno all'urbanità
selvaggia. Lo sguardo è metropolitano, il cuore impara
battiti tribali. E il jazz? Il jazz è una, dieci, cento chiavi di accesso. Hancock ed i cacciatori di teste possono
inventare uno spazio coerente e aperto, artificioso ed
emblematico. Come dei buoni jazzisti trasfigurano tutto
il portato black - contrasti, conflitti, rivalse, rivolte, consapevolezza... - in musica. Astraggono.
Il risultato sono quattro tracce accattivanti e inesorabili:
il funk è sostrato mercuriale (l'omaggio a Sly Stone di
Sly) e sornione (la celeberrima Chamaleon) per invenzioni futuristiche e assolo incandescenti consumati tra
fughe tribali e sospensioni robotiche. In Watermelon Man
un motivetto carpito ai pigmei Ba-Benzelé spalanca una
liquida meditazione soul-errebì come potrebbe un fantasma ridanciano Steely Dan. Infine quella Vein Melter
che incede chimerica come uno stregone accigliato sulla
strada silenziosa. Con la sua fruibilità disarmante, Head
Hunters è un album che ha stabilito un prima e un
dopo.
Stefano Solventi
"Cosa significa 'originale? Non mi va di sbattere tra loro due
rottami recitano poesie e dire 'questa è una novità.' Noi suoniamo musica tradizionale. Musica etnica, insomma." Così
Chris Robinson, cantante e frontman dei Black Crowes,
metteva il punto a ogni malinteso in occasione dell'uscita
del suo primo album. Chiarendo come la sua band non
fosse una masticatrice di luoghi comuni come i farlocchi
Guns n' Roses e men che meno l'ennesima mediocre
imbucata al karaoke di Exile On Main Street. Non che il
ragazzo (bianco che voleva la pelle nera) e il fratello chitarrista Rich Robinson (Keith Richards senza droga
più Duane Allman senza megalomania) facessero mistero delle proprie fonti d'ispirazione, al contrario. Solo
che nel 1990 erano figure piuttosto strane nel pieno
dell'acid techno e dei Primal Scream che - traendo
però spunto da una rielaborazione di Sympathy For The
Devil - abbattevano la barriera tra discotecari e rokkettari.
Sembravano, grunge escluso, dei reazionari col quel guardare l'arco '69-'72 allorché tali rivolgimenti copernicani
erano in corso. Lo capimmo col distacco e la calma che,
viceversa, il ruolo dei Corvi Neri era quello dei meravigliosi artigiani come non ne nascono (quasi) più, dei
custodi competenti e abilissimi di una tradizione che sin
da Elvis era di già un impuro crossover.
Dove soul e country, blues e boogie si impastano e stratificano sino all'indistinguibile facendo peraltro il botto
di vendite. Nondimeno, la gavetta era iniziata nell'84 e in
quei sei anni c'è una chiave fondamentale di grandezza,
quando oggi ascolti ragazzetti che passano dallo spremersi i foruncoli a incidere dischi. Impossibile imporsi
con autorevolezza in quel contesto se privi delle adeguate conoscenze storiche e tecniche: hai voglia a scopiazzare Faces, (parecchio Rod Stewart, ma pure Steven
Tyler nell'ugola di Chris: vedi sopra) e Led Zeppelin,
ma stai tranquillo che Rick Rubin e George Drakoulias
mica s'accorgono che esisti e mai Jimmy Page suonerà
con te. Non resterai vent'anni sulla scena senza smanie
da star; siccome badi al sodo invece che al soldo, puoi
dirti orgoglioso di una discografia sostanzialmente im-
peccabile. E che rinviene qui le proprie saled coordinate
in una penna appuntita di melodie appicLontani da una
ben gestita tendenza alla jam che giungerà, i sudisti infilano con Chuck Leavell alle tastiere un gioiello dietro
l'altro: omaggi a Otis Redding con i mezzi del Dirigibile che scalano le "charts" (Hard To Handle) e autografi
singoli perfetti (Jealous Again); dimostrazioni di un cuore
romantico (Seeing Things, Sister Luck, l'altra hit She Talks To
Angels) mentre ci si lancia a tutta nel rock 'n' roll (Thick
N' Thin) assaporando le sfumature tra i due estremi (Twice As Hard, Struttin' Blues). Standard compositivo che rimpiangiamo e che, smerciato in tre milioni di copie, diede
il via a una carriera forse al definitivo capolinea (ma ci
avevano già provato e vanamente, i fratelli, a separarsi
).
Classica al punto che potevamo raccontarvi della completezza di Southern Harmony And The Musical Companion
o del policromo Amorica e il discorso sarebbe rimasto
immutato. (Non) solo rock and roll, e ci piace. Da matti.
Giancarlo Turra
97