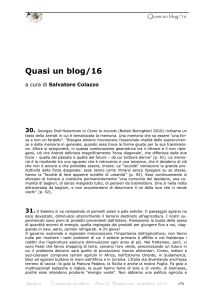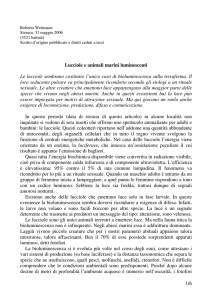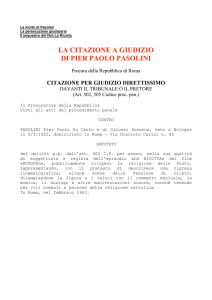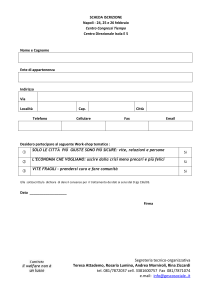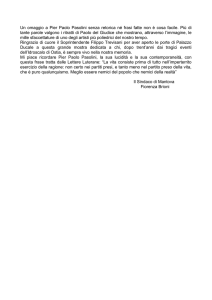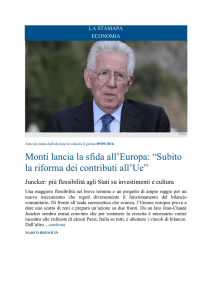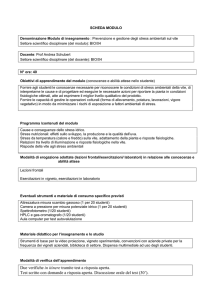E lo chiamano lavoro…
di
Sandra
PhD in History and Sociology of Modernity/ University of Pisa (Italy)
Burchi
Il volume di Carla Ponterio e Rita Sanlorenzo è l'occasione per osservare la parabola del diritto del
lavoro verso una flessibilità, che - senza interventi sul versate del welfare - diventa pura precarietà
I. Il libro di Carla Ponterio e Rita Sanlorenzo racconta, come si legge immediatamente già dalla
quarta di copertina, «la parabola del diritto del lavoro», dal momento di apice rappresentato dallo
Statuto dei lavoratori del 1970 al Jobs act che è stato approvato da Camera e Senato in questi giorni.
E’ un testo con un piglio deciso che fa vedere con chiarezza come questa parabola abbia condotto a
una flessibilità non governata delle forme di lavoro, una flessibilità che – lontano dall’essere
accompagnata da dispositivi e strumenti di welfare coerenti – si è tradotta in una precarietà diffusa,
indebolimento stesso dell’idea di lavoro (da qui il titolo) e un peggioramento sostanziale delle
condizioni di vita. Di tutti. Le riforme, che hanno accompagnato questi processi, sono presentate nel
loro progressivo allontanarsi dalla cornice di senso rappresentata dalla Costituzione che non solo
fonda la Repubblica sul lavoro, ma è molto attenta a pensare a una società in cui i rapporti di forza
trovino nel diritto e nei diritti un regolatore sociale.
Le autrici nel procedere delle argomentazioni mostrano come, superando questa cornice, si sia
andati con decisione verso la prospettiva di sganciare l’idea di lavoro da quella di diritto,
promuovendo una cultura che progressivamente evolveva in tal senso, utilizzando giustificazioni di
ordine sostanzialmente ideologico.
«Meno lavoro e meno diritti» si intitola uno dei capitoli che introduce il «giro di boa» degli anni
Novanta, anni sensibili nel riassetto delle forme organizzative del mercato del lavoro, anni
«dell’abbrivio della flessibilizzazione e dell’accelerazione del lavoro atipico». Per un lavoro che
stava cambiando e di cui è si proclamata la fine anche in sociologia (una sociologia «di consumo»
vorrei dire, se penso al successo del libro di Rifkin[1], ma anche una sociologia più seria se penso ai
lavori di Gortz[2], Beck[3]) si è cominciato a pensare e a strutturare cambiamenti di tipo normativo,
con lo scopo di «modernizzare il paese» , di «renderlo più europeo» e di favorire un processo di
partecipazione al mondo del lavoro più «libero» e più «plurale», meno ingabbiato nelle forme del
lavoro dipendente, subordinato e tanto monotono da durare una vita.
Questo forse è l’unico punto veramente realizzato dalle riforme, se pensiamo alla riduzione
progressiva dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Comincia dunque negli anni Novanta, lo
sappiamo tutti, quel processo di de-standardizzazione del lavoro di cui gli esiti effettivi – prevedibili
- si sono cominciati a vedere con qualche anno di ritardo. Le autrici per parlare di questo processo
fanno riferimento a una metafora geologica, parlano di fracking «una tecnica di estrazione degli
idrocarburi che agisce sulla consistenza degli strati idrologici sotterranei e a cui gli scienziati
attribuiscono l’aumento della sismicità». In altre parole «una frantumazione sotterranea del terreno
delle regole che erano state poste, secondo gli imperativi dettati dalla Costituzione, per dare tutele al
lavoro. Con il risultato – che è sotto gli occhi di tutti – della generale svalorizzazione, non solo
economica ma anche sociale, del lavoro in tutte le sue forme». Era già chiaro, dicono le autrici, che
questa cosa del doppio binario, non avrebbe fatto che indebolire le condizioni di tutti.
Siamo al pacchetto Treu, individuato come una sorta di punto di partenza.
E anche io vorrei andare a quel periodo, mi viene facile perché il periodo in cui io ho iniziato il mio
ingresso nel mondo del lavoro e contemporaneamente ho iniziato ad occuparmi di flessibilità.
II. Proprio per il mutare di paradigma produttivo (tutto il discorso sul post-fordismo a cui fa
riferimento anche il libro) era molto facile in quel periodo proporre a vari soggetti istituzionali e
organizzati (dalle università, ai sindacati, agli enti pubblici) delle ricerche e delle indagini sulle
nuove condizioni di lavoro, sulla riorganizzazione delle vite di quei soggetti che stavano
sperimentando le varie forme di flessibilità. Per ragioni di continuità e di vicinanza - anche
esistenziale - con il mio gruppo di ricerca eravamo molto interessate a studiare la condizione dei
giovani in uscita dal mondo della formazione e a capire che tipo di opportunità offriva un mondo
del lavoro in cui si erano aperte nuove opportunità attraverso la liberalizzazione dei contratti.
Questo ci portava a fare inchieste – con il metodo dell’intervista in profondità – sulle condizioni di
vita e di lavoro di lavoratori e lavoratrici indipendenti (collaboratori, consulenti, nuovi
professionisti) occupati a dare senso e seguito alle proprie competenze, o di operatori di vario
genere, contrattualmente dipendenti, ma magari nella forma di socio-lavoratore o di responsabili di
una cooperativa sociale. Insomma soggetti ai margini del lavoro «standard» - come si diceva – cioè
dal lavoro dipendente, garantito, a tempo indeterminato. Raccoglievamo molte informazioni e le
interviste erano piene di dati – oggettivi e soggettivi – e di riflessioni. Anche di «indizi».
Racconto sempre che a cavallo degli anni 2000 in una ricerca sul lavoro flessibile e indipendente
che indagava le condizioni di lavoro di donne con un titolo di studio «superiore» in tre città del
centro nord (Bolzano, Milano e Lucca), in oltre 50 interviste e migliaia di parole, non compariva
mai la parola «sfruttamento» mentre compariva tantissime volte una parola dal tono più entusiasta
«investimento»: «investire su di sé, investire sul proprio capitale di conoscenza, investire sulle
proprie abilità».
Cinquanta soggetti che a pochi anni dal primo pacchetto di riforme che liberalizzava il lavoro (il
pacchetto Treu appunto), affrontavano un percorso professionale autonomo (di «seconda
generazione» lo definivano Bonomi e Fumagalli) con questa spinta positiva, non che mancassero
loro delle incertezze o la consapevolezza delle difficoltà, ma si davano una prospettiva tenendosi
sugli aspetti positivi ed emancipativi della loro scelta. Pensavano di darsi una chance, di forzare le
gabbie presenti nel mercato del lavoro, «inventandosi un lavoro» (anche questa era un’espressione
molto in voga). Potremmo fermarci a considerare questa inversione di termini fra sfruttamento e
investimento come l’effetto di una spinta ideologica molto forte - la spinta con cui si è cercato di
traghettare il paradigma della flessibilità in quegli anni– ma non sarebbe sufficiente.
E’ bene considerare gli attori sociali per la loro intelligenza, considerarli alle prese con più fattori,
capaci di essere strategici, di mettere in fila – pur nella difficoltà – condizioni date e forme di
reazione (agency, direbbero i sociologi). E’ bene quindi chiedersi davvero cosa volevano quei
soggetti – donne oltrettutto – dichiarandosi disponibili a imboccare una strada non protetta,
piuttosto insicura, tanto da non lasciarsi fermare dai rischi, tanto da non nominare i problemi che
affrontavano in termini di «sfruttamento»? Facile, volevano lavorare, togliersi dall’impasse
occupazionale attraverso un lavoro che stesse in relazione con i loro desideri. In un momento in cui
era praticamente impossibile, se non a costo di attese e tentativi che potevano durare anni, accedere
a un posto di lavoro stabile (perché intanto, mentre si incoraggiava il lavoro flessibile, le assunzioni
nel pubblico, nella scuola, nei grandi apparati di inclusione di lavoro femminile e istruito
scarseggiavano) speravano in un lavoro instabile ma possibile.
Non diversamente i tanti operatori e operatrici, attivi soprattutto nel terzo settore e nelle cooperative
sociali – tanto più quelle di tipo A – pensavano di poter partecipare positivamente alla
trasformazione del mondo dell’assistenza alla persona e dei servizi alla comunità.
Attraverso le interviste in profondità a questi lavoratori e lavoratrici – sia i lavoratori indipendenti,
sia gli operatori di ogni ordine e grado – si poteva vedere un mondo del lavoro in fermento in cui le
singole esperienze e le singole vite erano leggibili come laboratori, pieni di idee, di materiali, di
nuovi aggiustamenti e adattamenti. Erano già presenti molte fatiche, esistenziali soprattutto, ma
anche di reddito, era già evidente un senso di sbilanciamento fra quello che attraverso il lavoro
molti di loro si promettevano di ottenere e quello che riuscivano a realizzare. Ma c’era anche una
grossa spinta in avanti e una certa fiducia.
Durante le interviste era molto raro sentir parlare di diritti e di diritti legati al lavoro.
In queste vite era completamente traghettata l’idea che il lavoro fosse un problema a cui trovare una
soluzione personale, un’invenzione soggettiva più che un diritto, un progetto, anche piuttosto
complicato, attraverso cui mirare a un obiettivo duplice: quello del reddito e – da non sottovalutare
– quello del senso. Tutto questo, però, lontano da una cultura (forse trasformatasi in retorica, di
fatto) del lavoro come diritto, come dispositivo di regolazione della società. Organizzazioni fragili,
in corso di definizione o in crisi permanente –sia nel pubblico che nel privato– producevano
risposte individuali, aggiustamenti anche virtuosi (il «mettersi in gioco») ma lontani da un
atteggiamento rivendicativo.
Nelle esperienze che andavo repertoriando trovavo un atteggiamento non rinunciatario ma
frammentario, che non cercava un piano collettivo, ma una risposta singola, individuale, concreta.
Queste vite che andavo conoscendo attraverso un lavoro di indagine minuzioso, dettagliato, non
«rappresentativo» in senso numerico ma senz’altro significativo per la sua «esemplarità», non erano
vite consegnate al disastro di un lavoro in corso di definizione – anche in termini di tutela -, erano
vite laboriosamente alla ricerca di un’esperienza professionale che tenesse insieme il piano di realtà
con quello delle aspirazioni, il bisogno di reddito e il desiderio di realizzazione. Senza nessuna
spocchia o atteggiamento «choosy» questi soggetti pretendevano di fare un lavoro desiderato o
semplicemente un lavoro «possibile», accettando anche degli aggiustamenti e delle rinunce in
termini di reddito e di tutele. Ognuno per sé, e da solo, però. Contando sulle proprie forze e sulla
propria capacità di negoziare, di far valere le proprie idee, le proprie capacità, le proprie
competenze. Soli, ma non per mancanza di intelligenza sociale o per essere stati catturati dal
miraggio «dell’imprenditore di se stessi», soli perché all’interno di due fenomeni incrociati con cui
molti sociologi hanno letto il passaggio di millennio alle nostre latitudini.
Da una parte l’insediarsi di un progressivo processo di individualizzazione sociale che possiamo
riassumere nell’incapacità/impossibilità di «tradurre le preoccupazioni private in questioni
pubbliche e inversamente di identificare le questioni pubbliche in problemi privati» (Baumann), una
tensione crescente verso un’individualità fortemente privatizzata e sganciata da ogni spazio
collettivo o pubblico capace di interpretare e fornire sostegno ai progetti individuali. Un «fare tutto
da soli, un tenere insieme tutti i pezzi» nella percezione di uno spazio pubblico lontano, svuotato
della presenza di soggetti in grado di fare da connettore, di raccogliere le istanze individuali e
trasformarle in istanze collettive (il Sindacato in primis, percepito come lontanissimo dai più,
proprio non nominato).
Nessuno a raccogliere la voglia di cambiamento di quei lavoratori e quelle lavoratrici impegnati in
un processo di trasformazione, nessuno a rimodellare le possibilità di cittadinanza da riservare a chi
si impegna in una flessibilità lavorativa agli albori, se non dei legislatori che liberalizzano le forme
di lavoro possibile, senza pensare dispositivi che l’accompagnino, che la rendano vivibile e
praticabile. Le narrazioni individuali si fanno instabili, precarie, transitorie, frammentarie e il lavoro
di ricucitura è rimandato alla capacità dei singoli di dire di sé, di raccontarsi e di creare legami
possibili.
«La corrosione del carattere» (di cui parla Sennett ne L’uomo flessibile, che è di quegli anni) è la
fatica vissuta in termini esistenziali, questo sganciarsi non solo dallo spazio pubblico ma da una
dimensione temporale ovvia, quella che lega presente e futuro, progetto e realizzazione. «Anomia»,
la possiamo anche chiamare così e non è più l’egoismo, quel voler prevalere del singolo sulla
collettività, ma proprio l’incertezza, l’incapacità di definire azioni coerenti, restringendosi a un
orizzonte sempre più limitato, abituandosi a vivere in «presente esteso[4]».
Questo accompagna un fenomeno connesso al processo di individualizzazione, la progressiva
deistituzionalizzazione della vita sociale, la progressiva crisi delle istituzioni che garantivano nella
prima modernità l’attualizzarsi soggettivo (seppur in modo problematico e conflittuale) il rapporto
individuo/società. Di questa morte dello spazio pubblico, classicamente inteso, si è parlato molto fra
la fine del Novecento e l’inizi del nuovo millennio, e certo la frantumazione delle regole di diritto,
su un terreno tanto scivoloso come quello del lavoro, non ne ha diminuito la portata, né ha ridotto i
margini di contraddizione di fenomeni che appunto stavano diventando globali e sempre più
ingovernati.
Sullo svuotamento dello spazio pubblico come terreno di regole condivise e al tempo stesso di
differenze vitali, su cui costruire appunto degli artifici di convivenza (e credo che il diritto del
lavoro abbia voluto essere questo), io sono molto affezionata a due immagini che, nel loro essere
metaforiche raccontano bene la forza con cui questo svuotamento si è imposto nella percezione
comune. Sono due immagini che vengono dal passato, due intuizioni di lunga durata, una è di
Hanna Arendt (particolarmente efficace) e una di Pier Paolo Pasolini (che Federico Chicchi[5] e
prima di lui Didi-Huberman hanno brillantemente reso attuali).
In Vita Activa, Arendt dà una straordinaria definizione di spazio pubblico, è «lo spazio comune a
tutti, distinto da quello che ognuno di noi occupa privatamente». E’ uno spazio inventato, uno
spazio artificiale, un prodotto delle mani dell’uomo, dice lei. «Vivere insieme nel mondo significa
essenzialmente che esiste un mondo di cose fra coloro che lo hanno in comune, come un tavolo è
posto fra quelli che vi siedono intorno, mette in relazione e separa… La sfera pubblica, in quanto
mondo comune, ci riunisce insieme e tuttavia ci impedisce, per così dire di caderci addosso a
vicenda[6]».
Cosa succede secondo Arendt in quella che lei, a metà degli anni Cinquanta definisce «la società di
massa» e che ora certo vale per la società globale e investita da un unico capitalismo (e finanziario
per di più)? Il tavolo svanisce, dice Arendt, il mondo perde il potere di riunire le persone, ognuno
pensa allo spazio fra sé e gli altri, come uno spazio in cui prolungare la propria individualità, la
propria «vita di famiglia», i propri interessi. «La stranezza di questa situazione , scrive in Vita
activa, ricorda una seduta spiritica dove alcune persone raccolte intorno a un tavolo vedono
improvvisamente per qualche trucco magico, svanire il tavolo in mezzo a loro, così che due persone
sedute ai lati opposti non sarebbero soltanto separate, ma sarebbero del tutto prive di relazioni,
non essendoci niente di tangibile tra loro[7]».
Il tavolo scompare nell’impossibilità di riconoscere gli elementi comuni e i rapporti possibili, anche
i rapporti di forza, che restano da regolare proprio attraverso quel tavolo, «per non cadersi addosso
l’uno all’altro» scrive lei. Nelle condizioni di un mondo comune, la realtà non è garantita dalla
«natura comune» di tutti gli uomini che lo compongono, ma dal fatto che nonostante «le differenze
di posizione e la risultante varietà di prospettive» ciascuno si occupa dello stesso oggetto, il mondo
comune appunto. Quello che Arendt chiama «l’innaturale conformismo della società di massa» fa
comportare tutti come se facessero parte di «una sola famiglia, moltiplicando e prolungando
ciascuno la prospettiva del suo vicino».
Di questo stesso conformismo parla Pasolini quando in uno degli Scritti corsari parla della
scomparsa delle lucciole. Duro e polemico, e per questo poco amato a sinistra, nei confronti di una
società che si era troppo velocemente industrializzata distruggendo appunto il tessuto di differenze,
la civiltà, la chiamava lui, Pasolini scrive poche righe sulla scomparsa di questi singolari insetti
luminescenti : «nei primi anni Sessanta a causa dell’inquinamento dell’aria e, soprattutto in
campagna a causa dell’inquinamento dell’acqua (gli azzurri fumi e le rogge trasparenti) sono
cominciate a sparire le lucciole»[8].
Agli occhi di Pasolini le lucciole rappresentano il segnale di qualcosa di totalmente opposto rispetto
a un capitalismo che si impone con le sue mega-macchine, colonizzando il paesaggio o a tutto
quello che cattura l’attenzione, saturando lo sguardo. Le lucciole non scompaiono nella notte, «nel
buio più profondo, possiamo cogliere il loro baluginio» scrive Pasolini: no, le lucciole scompaiono
«nell’accecante bagliore dei «feroci» riflettori: i riflettori delle torri di guardia, degli stadi di
calcio, dei palcoscenici televisivi»[9].
Le lucciole scompaiono dentro il troppo di luce, di una società che cancella le differenze, che si
trasferisce negli studi televisivi, che si lascia «ricreare e deformare» dal potere coatto dei consumi.
In questo troppo di luce le differenze, quelle differenze che posizionano i soggetti e gli attori sociali
all’interno del «tavolo-mondo comune» di cui parla Arendt, si cancellano, e la percezione dei
rapporti di forza svaniscono, si appiattiscono, lasciando il campo a una esperienza dei rapporti
sociali confusa, astratta, in cui tutti sembrano essere messi sullo stesso piano.
III. Se facessi ora le interviste che ho fatto ormai 15 anni fa, avrei risposte molto diverse,
continuerei a incontrare – come incontro – persone, «per amore[10]» ai margini del lavoro tutelato
ma più consapevoli delle contraddizioni e meno disposte ad accettarne i rischi come necessari.
Quindici anni di flessibilità e poi precarietà e poi crisi e poi dispositivi di austerità hanno talmente
minato le condizioni di vita e di lavoro da aver reso tutti più consapevoli di un passaggio d’epoca.
Nonostante continuino ad essere difficilmente individuabili dei soggetti in grado di attivare delle
grandi mobilitazioni come quelle che hanno caratterizzato alcuni momenti della storia del
movimento dei lavoratori, proprio in quei laboratori che sono le singole esistenze si sono riattivati la
consapevolezza e la necessità di ricostruire legami sociali. Nelle interviste forse continuerei a sentir
parlare di «investimento»ma sono sicura che in molti mi parlerebbero dello «sfruttamento» dei
propri talenti e del progressivo abbrutimento delle condizioni di vita e di lavoro. Oggi saprebbero di
essere soli, e saprebbero che da soli non possono farcela. Continuerebbero probabilmente a pensare
di non poter avere risposte da quello spazio pubblico individualizzato e de-istituzionalizzato, ma
credo sarebbero più consapevoli della necessità di recuperare spazi di azione, di dover inventare
forme se non di tutela almeno di riconoscimento, per sé e per gli altri.
Sentirebbero, per averli sperimentati, i rischi di un posizionamento pulviscolare nella società e la
pesantezza di non essere visti e riconosciuti, presi in considerazione. Sicuramente mi parlerebbero
dei tentativi di sottrarsi da una situazione di invisibilità, puntando magari sui rapporti di prossimità
e quelli di condivisione. Quello che è successo in questi anni è che diverse generazioni si sono
passate il testimone di situazioni di lavoro povero, sottopagato, incerto in ogni forma.
L’esperimento «flessibilità», si può dire con certezza, non ha funzionato, non è servito a «rilanciare
l’economia» e non ha aperto quei percorsi di scelta e di autonomia, nel lavoro, che pure sembrava
incoraggiare. L’immagine della parabola proposta dalle autrici per raccontare il percorso della
tenuta del diritto del lavoro nella nostra organizzazione sociale, potrebbe essere applicata anche al
valore del lavoro, alla sua considerazione sociale, alla capacità di funzionare come base di nessi
possibili verso la cittadinanza.
Se non stiamo solo all’immagine di melanconia che questa considerazione produce siamo obbligati
a interrogare le pratiche di cittadinanza – intesa come presenza nel mondo, come capacità di esigere
ed esercitare diritti - che si costruiscono in uno scenario come quello presente, di evidente crisi non
solo economica ma dell’intero patto sociale. E sono proprio quei soggetti che hanno verificato
un’esclusione inattesa dal sistema dei diritti (penso ancora a quei lavoratori indipendenti orfani
delle protezioni della «società salariale») che oggi sono protagonisti di piccole esperienze che
nascono da un bisogno primario – antecedente a qualsiasi rivendicazione – quello cioè di
riconoscimento.
Si tratta di soggetti che, conoscendo l’oscillazione fra libertà sostanziale e tutela formale, tipica di
un diritto perennemente esposto al rischio di colonizzazione sistemica,hanno attivato forme di
cooperazione e di solidarietà a partire dalle esperienze di lavoro (e non lavoro) che vivono. Un
esempio è quello di Strade (www.traduttoristrade.it), un piccolo sindacato nato proprio
dall’esperienza concreta di alcune lavoratrici dell’editoria, donne che lavorano – spesso da casa –
producendo servizi, qualificati e quasi sempre sottopagati nel mondo delle traduzioni, della cura
editoriale. A partire da un lavoro di rete, di conoscenza reciproca, queste lavoratrici hanno deciso di
cercare dei «ripari» (se non delle tutele) alla loro condizione di lavoro, rifacendosi a un modello
mutualistico e solo in un secondo tempo cercando legami con le organizzazioni sindacali
confederali. Elena Doria racconta bene la storia «anomala» di questo sindacato dovuta «alla
capacità e dedizione con cui le figure dirigenti, e non solo, sempre a titolo volontario, hanno
perseguito l’obiettivo di superare il momento di protesta e di indignazione e dato vita a un soggetto
organizzato, strutturato e stabile che ambisce a trattare con la controparte, gli editori»[11].
Quello di Strade è solo un esempio ma dice, banalmente, che «qualcosa si muove»: l’asimmetria dei
rapporti sociali ritorna ad essere vista, interpretata, agita anche con strumenti la cui origine è
lontanissima, e tutta da ripensare. E, come Strade, altre esperienze nascono dalla stessa esigenza di
darsi strumenti, di promuovere un’azione di tessitura fra situazioni simili ma diverse, una tessitura
che cerca regole per un lavoro ignorato, come quello delle nuove professioni e del lavoro
indipendente, le famose «partite iva» a cui si è tardato a guardare.
Queste soggettività oggi si trovano a fare rete, a chiedere visibilità, a intercettare la riforma del
lavoro perché sia più equa e inclusiva. E qui l’esempio è quello di ACTA (www.actainrete.it ), la
prima associazione costituita in Italia per dare rappresentanza ai professionisti del «terziario
avanzato», quei lavoratori autonomi operanti al di fuori di Ordini e Albi professionali totalmente
oggi alle prese con una richiesta sostanziale di riconoscimento e di diritti legati al loro lavoro.
«Richieste di equità», si legge così nel loro sito, «riforme che mirino alla eliminazione di
discriminazioni o all’estensione di diritti che dovrebbero essere universali». Si tratta di due
esperienze, e probabilmente se ne potrebbero repertoriare altre, in cui la richiesta di riconoscimento,
individuale, ha portato alla creazione di una rete, una soggettività che è in grado di muoversi con
più forza nello spazio pubblico, invocando un’equità che passa da dispositivi di tutela, forme di
welfare, diritti.
Soggettività che si sono mosse in un vuoto normativo per reinventarlo, reinterpretarlo azionando un
passaggio dall’esperienza al diritto che forse è paragonabile – con tutte le distinzioni da fare – al
punto di partenza della parabola del diritto del lavoro disegnata da Ponterio e Sanlorenzo. Oggi i
soggetti che si fanno artefici di questi passaggi – «diritto generativo» lo chiamano Giardini[12] e
Lessi[13] guardando la prima alla questione dei Beni Comuni, la seconda alle figure femminili che
hanno portato il diritto a modellarsi sull’esperienza dei corpi femminili, su questioni come la nascita
o la violenza ad esempio) non hanno la forza dei grandi soggetti collettivi che hanno fatto sentire la
propria voce lungo la storia del movimento operaio.
Sono soggetti inattesi, il cui rapporto con il lavoro è totalmente cambiato, oscillando fra la totale
identificazione (pensiamo ai fenomeni tutti contemporanei del work alcoholic e dei burnout) e il
totale disincanto, soggetti le cui vite sono frammentate, la cui presenza nello stesso posto di lavoro è
labile e ricattabile, ma che cominciano a ricostruire legami per reclamare il diritto a un’esistenza
dignitosa.
Non a caso il libro termina con un capitolo sulle battaglie per i Beni comuni e considera le
dinamiche di movimento – che oggi sono frastagliatissime – come un terreno privilegiato per la
generazione di nuovi diritti.
[1] Jeremy Rifkin, La fine del lavoro, il declino della forza lavoro globale e l'avvento dell'era postmercato, Baldini e Castoldi, Roma 1995
[2]André Gortz,Metamorfosi del lavoro. Critica della ragione economica, Torino1992; André
Gortz, Miserie del presente, ricchezza del possibile Manifesto libri, Roma, 1998.
[3]Ulrich Beck, Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro. Tramonto delle sicurezze e nuovo
impegno civile, Einaudi, Torino, 2000
[4]Carmen Leccardi,Sociologie del tempo. Soggetti e tempo nella società dell’accelerazione,
Laterza, Roma 2009
[5]Federico Chicchi, Soggettività smarrita. Sulle retoriche del capitalismo contemporaneo, Bruno
Mondadori, Milano 2012
[6]Hannah Arendt, Vita activa. La condizione umana, Milano, Bompiani, 1994, p. 39.
[7]Ibid., p.41
[8]Pier Paolo Pasolini, L’articolo delle lucciole, dal « Corriere della sera » del 1 febbraio 1975 con l
titolo « Il vuoto di potere in Italia », in Scritti Corsari, Garzanti, Milano, 2000 p. 129
[9] Georges Didi-Huberman, Come le lucciole. Una politica delle sopravvivenze, Bollati
Boringhieri, Torino 2010, p. 129
[10]Cristina Morini,Per amore o per forza. Femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo,
Ombrecorte, Verona 2010
[11]Elena Doria, Tra vecchie e nuove pratiche. Il mutualismo, in Sandra Burchi e Teresa Di Martino
(a cura di) Come un paesaggio. Pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro, Iacobelli Editori, Roma
2013 pp. 188-198
[12]Federica Giardini, Statica e dinamica. Appunti filosofici sui beni comuni (www.academia.edu)
[13]Maria Pia Lessi, Diritti generativi. Quando la giustizia nutre la vita, in Sandra Burchi e Teresa
Di Martino (a cura di) Come un paesaggio. Pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro, Iacobelli
Editori, Roma 2013 pp. 56-65
21 dicembre 2014