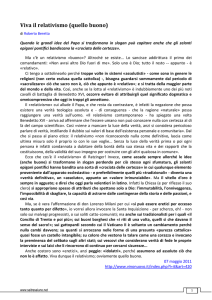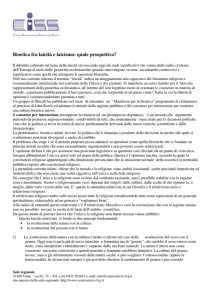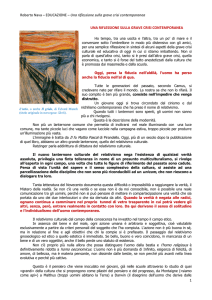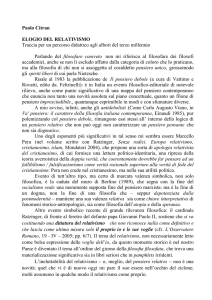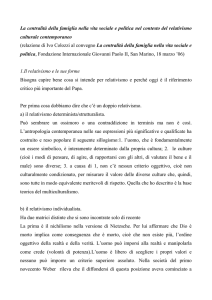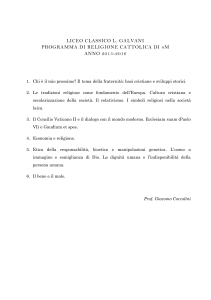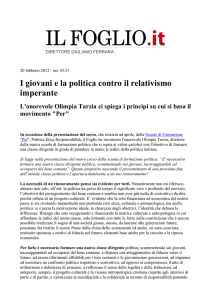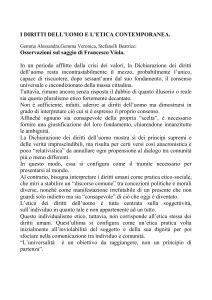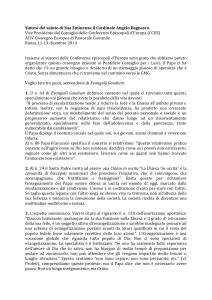da Il bello del relativismo a cura di Elisabetta Ambrosi
(Venezia Marsilio 2005), pp. 105-14
!
Elogio del relativismo
di Enzo Di Nuoscio
!
Al pari della natura, anche lo spazio pubblico aborre il vuoto. Così, dopo il crollo
delle ideologie abbiamo assistito ad una battaglia condotta, spesso senza il senso del
limite, da politici, giornalisti, intellettuali neo-assolutisti, non solo credenti, ma anche
atei devoti, per i quali l’unica salvezza dell’Occidente è quella di ristabilire una
egemonia dell’etica cattolica, combattendo quello spettro che si aggira per l’Europa
chiamato relativismo. E, nonostante si ritenga che dalla sconfitta del relativismo
dipendano le sorti della civiltà occidentale, di questo pericoloso nemico ognuno
sembra farsene una rappresentazione di comodo, e verrebbe da dare ragione a John
Ladd quando dice che «tutte le comuni definizioni di relativismo vengono formulate
dai suoi avversari e sono definizioni assolutiste». Contro tale vulgata neofondamentalista, questa vuole essere una modesta difesa del relativismo,
dimostrando che, se correttamente inteso, «relativismo» si oppone tanto ad
«assolutismo» e «dogmatismo» quanto a «nichilismo» e «irrazionalismo», e che la
vera forza dell’Occidente è stata proprio quella di essere stato (nella scienza, nell’
etica e nel campo della fede) né dogmatico e assolutista, né nichilista o irrazionalista,
ma semplicemente relativista.
!
Il relativismo nella scienza
Se per relativismo epistemologico si intende l’impossibilità razionale di
dimostrare con certezza la verità delle teorie, allora la scienza è senz’altro relativista,
perché per dimostrare che una teoria è certamente vera dovremmo dimostrare vere
tutte le sue conseguenze, operazione – come ci ha insegnato il logico polacco Alfred
Tarski con la sua teoria semantica della verità – logicamente impossibile, essendo queste
ultime di numero infinito. Per quante conferme possa trovare, lo scienziato non è in
grado di dimostrare vere le proprie ed altrui teorie, egli può solo farle false,
individuando eventuali fatti contrari che consentano di revisionare o di abbandonare
le ipotesi esistenti. La verità oggettiva della scienza non va intesa come certezza, ma
come pubblica controllabilità. Anzi, solo rinunciando alla certezza si progredisce
verso la verità scientifica, perché si eliminano i dogmi. Come ha scritto Georg
Simmel, nella scienza la verità ha un senso, «non benché relativa, ma perché relativa»,
cioè non assoluta.
Questo relativismo di tipo popperiano non va confuso con un relativismo
scettico di chi – come Th. Kuhn, P. Feyerabend e i «nuovi sociologi della scienza»
propugnatori, come D. Bloor, del cosiddetto «programma forte» propone una sorta
di egualitarismo epistemologico, il quale rinuncia non solo alla nozione di certezza
ma anche a quelle di verità e di oggettività. Non ci sarebbe una verità scientifica, ma
molte etno-verità, tutte epistemologicamente legittime, perché molte sono le forme di
vita. Essendo le «verità» incommensurabili perché determinate da differenti
frameworks culturali, lo scienziato non sarebbe in grado di esercitare proprio quella
facoltà critica che storicamente ha consentito la crescita della conoscenza scientifica.
Più che di relativismo, in questo caso è corretto parlare di una certa forma di
scetticismo (figlio naturale del sociologismo collettivistico) che nega l’idea stessa di
progresso della conoscenza scientifica.
!
Il relativismo nell’ etica
Quella stessa tradizione filosofica di razionalismo critico (quella, tra gli altri, di
Mill, Popper, Albert e Bartley), che in epistemologia propone un tertium genus tra le
verità certe dei positivisti e lo scetticismo degli epistemologi e dei sociologi della
scienza «post-popperiani», in campo etico ci aiuta a definire una posizione né
fondazionistica né irrazionalistica. Nella storia del pensiero filosofico non sono
certo mancati i tentativi di proporre un’etica basata su fundamenta inconcussa (fattori
economici, biologici, teologici, calcolo utilitaristico, natura umana ecc.), che quindi
fosse valida erga omnes. Questa pretesa di fondare razionalmente l’etica è stata
devastata, tra gli altri, da David Hume, che ha dimostrato come sia logicamente
impossibile derivare i valori dai fatti. Da proposizioni descrittive che parlano di fatti
si possono logicamente dedurre soltanto altre proposizioni descrittive, non mai
proposizioni normative. Da tutte le proposizioni fattuali delle scienze sociali non si
può logicamente derivare la decisione che è giusto che uno Stato aiuti i più deboli.
Queste scelte etiche non possono essere fondate sulla scienza, ma si basano sulla
coscienza: è la coscienza individuale a giudicare i fatti; e se la conoscenza è fallibile,
la coscienza è inviolabile. La legge di Hume è dunque il fondamento della libertà di
coscienza; e se i critici del relativismo non accettano questo tipo di relativismo in
nome di un’etica che non sia rimessa all’ «arbitrio» delle coscienze dei singoli, che
non contempla punti di vista privilegiati e valori esclusivi, devono scendere sul
terreno logico per combattere queste argomentazioni di Hume, e verrebbe da
!2
augurare loro buona fortuna. E devono anche sapere – come hanno insistito
soprattutto Weber, Kelsen e Popper – che il relativismo etico, così inteso, è uno dei
fondamenti della «società aperta», perché fonda quel «politeismo dei valori» che
rappresenta il tratto più intimo della democrazia. «La causa della democrazia», ha
ammonito Hans Kelsen, «risulta disperata se si parte dall’idea che sia possibile la
conoscenza della verità assoluta».
E tuttavia se la scienza è senza certezza ma non senza virtù, l’etica è senza verità
ma non senza ragione. E così come nella scienza l’impossibilità di trovare verità
certe non deve portare a conclusioni scettiche, parimenti l’impossibilità di un’etica
razionalmente dimostrata non deve far concludere che le nostre opzioni morali
siano decisioni totalmente irrazionali. È vero che l’etica non ha un fondamento
razionale, ma ciò non significa che essa non abbia un contenuto razionale, che cioè le
opzioni morali non siano decisioni razionali di individui che hanno buone ragioni
per adottarle. Le proposte etiche sono empiricamente e logicamente indecidibili, ma non
sono razionalmente indicihili. Se giudichiamo un’azione giusta è perché siamo
razionalmente convinti del suo valore in sé e magari delle conseguenze prevedibili
della sua attuazione; ci sforziamo di decidere sulla base di un giusto equilibrio tra
esprit de finesse e esprit de géométrie, tra «etica della convinzione» e «etica della
responsabilità».
Solo commettendo il grave errore di identificare il contenuto con il fondamento
razionale delle nostre decisioni, di non distinguere tra dimostrazione more geometrico e
argomentazione, di identificare il significato di un sentimento morale con un senso
assoluto, in altre parole di far coincidere l’intera razionalità con la razionalità
apodittica, si può concludere che le opzioni morali sono mera intuizione o atti del
tutto irrazionali. Più che ad un relativismo per questa via si approda ad un
nichilismo etico, che afferma non che le proposizioni etiche abbiano un nihil di
senso assoluto, ma che siano invece caratterizzate da un nihil di senso e basta.
Così come nella scienza l’esito scettico è l’effetto perverso prodotto dalla ricerca
(fallita) di verità certe, parimenti in campo etico l’irrazionalismo è l’altra faccia della
ricerca di fondazioni: «razionalismo e irrazionalismo, ha scritto Hans Albert, hanno
in comune il giustificazionismo». La prospettiva del razionalismo critico consente
dunque di evitare la Scilli della ricerca di un’etica oggettiva senza cadere nella
Cariddi dell’irrazionalismo più paralizzante, secondo il quale l’etica sarebbe
semplicemente indicibile, e quindi i sistemi etici sarebbero al di là di ogni possibile
confronto critico. L’etica non può quindi essere espunta dal dominio della ragione,
di una ragione che non dimostra ma che argomenta, di una ragione «pratica» che
!3
non pretende di essere «pura», che è consapevole dei gravi pericoli derivanti non
solo dall’osare troppo, ma anche dall’essere troppo rinunciataria. Come ha scritto
Chaïm Perelman: «Se si dovesse considerare ragionamento ingannatore ogni
argomentazione non dimostrativa, l’insufficienza delle prove logico-razionali
lascerebbe, in tutti i campi essenziali della vita umana, via del tutto libera alla
suggestione o alla violenza». È dunque questa forma di nichilismo etico, e non il
relativismo humiano, che va combattuta in nome della democrazia.
Tra i primi compiti della ragione in campo etico vi è quello di indagare i
presupposti e le conseguenze delle nostre decisioni, di illuminare le possibili opzioni
affinché la nostra non sia una scelta alla cieca.Fiat iustitia ne pereat mundus. Si prenda il
caso della libertà: l’epistemologia può farci comprendere i presupposti gnoseologici
(dispersione e fallibilità della conoscenza) e le scienze sociali le conseguenze
(politiche, economiche, giuridiche) della sua scelta, ma tutto ciò si limita ad offrirci
preziosi materiali per le nostre valutazioni. Anche da questa prospettiva di
giustificazione evolutiva dei valori non si annulla quindi il posto della decisione. Nel
weberiano «mondo disincantato» è definitivamente tramontata l’ «antica alleanza» tra
conoscenza del mondo e senso della vita: «Ciò che sappiamo», per dirla con Kant,
non ci dice «ciò che dobbiamo fare» e «ciò che possiamo sperare». La conoscenza
non ci rende giusti e non salva; ci aiuta nelle nostre opzioni etiche ma non elimina il
momento della scelta di coscienza. E proprio perché è in ultima istanza sempre la
coscienza di ogni singolo a giudicare i fatti, e anche i valori altrui, che le tradizioni
culturali sono sì tutte relative nel senso di non avere un fondamento assoluto, ma
sono ognuna diversa dall’altra, perché ogni persona può dare di esse un giudizio
diverso: dal politeismo dei valori fondato dalla legge di Hume si originano le versioni
plurime del mondo.
!
Il relativismo culturale
Considerare lo scetticismo epistemologico e l’irrazionalismo etico come effetti
perversi della ricerca di un fondamento razionale aiuta anche a capire quel relativismo
culturale, sostenuto da una folta pattuglia di filosofi e sociologi post-moderni, molto
influente in antropologia e in etnolinguistica, i quali, richiamandosi non senza
forzature al «secondo Wittgenstein», hanno parlato di forme di vita incomunicanti, di
mondi culturali separati, di linguaggi intraducibili, di schemi concettuali
incommensurabili. Il confronto e quindi la critica tra norme etiche e punti di vista
appartenenti a differenti civiltà o culture sarebbe semplicemente impossibile. Oltre
ad uno scetticismo epistemologico e a un egualitarismo etico, si approda per questa
!4
strada a un comunitarismo culturale e morale: essendo impossibile la critica
interculturale, non resta che concludere che i valori sono non confrontabili e quindi
in qualche modo tutti uguali.
Ora, a parte il fatto, come ha osservato un filosofo non sospetto di
antirelativismo come Richard Rorty, che parlare di linguaggi intraducibili è un po’
come parlare di colori invisibili, anche in questo caso non è difficile notare come
l’esito scettico dei mondi separati è un figlio degenere di un certo monismo teorico: la
fallita ricerca di uno standard non-culturale in base a cui esaminare le differenti culture,
porta a concludere che esse sono incommensurabili. La verità è che è inutile cercare
uno schema interpretativo che non sia legato ad una cultura; noi leggiamo
inevitabilmente il mondo con la grammatica della nostra «precomprensione»
fornitaci da quella tradizione, che, offrendoci soluzioni a problemi e regole di
esperienza, ci permette di conoscere e di essere liberi. Rinunciare ad una tradizione
culturale per ricercare un punto di vista privilegiato significa precludersi ogni
possibilità di conoscenza e di giudizio. Ma è proprio questa impossibilità di trovare
un punto di appoggio archimedeo che fonda il dialogo, che permette quella
discussione critica che consente di evitare che le cornici culturali siano delle prigioni
mentali e culturali, trasformandole invece in occasioni di confronto tra differenti
soluzioni di problemi comuni. Il politically correct non può essere dunque inteso come
livellamento delle verità scientifiche ed etiche, come eguaglianza aritmetica dei
sistemi di significato, come sospensione del giudizio, ma va interpretato come
«sottomissione» al dialogo, il quale, come fa notare Gadamer, può esercitare la sua
«autorità» solo se gli interlocutori sono consapevoli della propria e altrui fallibilità e
dell’impossibilità di dimostrare razionalmente la superiorità di un valore rispetto agli
altri. Affermare l’esistenza di valori privilegiati, se non esclusivi, significa dunque
rinunciare alla discussione critica e porsi fuori da una società liberale.
!
Il relativismo nella fede
Anche nel campo della fede la prospettiva relativista è inevitabile: essa si oppone da
un lato a una ragione assoluta che tenta la scalata al cielo, dall’ altro a un nichilismo
e a un materialismo accomunati dal fatto di confinare il sentimento religioso nel
limbo del non senso. Se chi critica il relativismo in questo campo vuole proporre un
fondamento razionale alla fede, deve essere consapevole che assolutizzando la ragione
finisce per relativizzare Dio, subordinando la fede alle sorti di una teoria razionale. Un
bel risultato per un antirelativista, magari credente. La verità è che la ragione può
fare veramente poco per la fede, anche se quel poco merita di essere fatto ed è tutto
!5
quello che l’uomo può fare. Essa può evitare che lo spazio del sentimento religioso
venga indebitamente occupato da assoluti terrestri, riconoscendo, come diceva
Kant, i propri limiti; ma oltre non può andare. «L’ultimo passo della ragione –
afferma Pascal – sta nel riconoscere che c’è un’infinità di cose che la sorpassano», a
cominciare dalla fede, la quale «è differente dalla dimostrazione: l’una è umana l’altra
è un dono di Dio».
Dunque, la fede può essere concepita soltanto come dono a parte Dei; essa non ha
un fondamento razionale, né è l’esito di una scelta. Non ha senso parlare di una
scelta della fede a parte hominis, perché – come ha evidenziato L. von Mises – la
decisione individuale, qualunque essa sia, è sempre razionale, si svolge
necessariamente dentro le categorie della ragione. Essendo un controsenso parlare
di una scelta irrazionale da parte del singolo, c’è di conseguenza una contraddizione
nel dire che la fede non può essere il frutto della ragione, ma è una scelta a parte
hominis. Non è l’uomo a scegliere Dio, ma Dio a scegliere l’uomo. Con la ragione
possiamo arrivare all’invocazione di senso, a porci la Grande domanda, questa è
l’estrema frontiera del linguaggio; ma la risposta può essere solo attesa come dono.
Razionalmente possiamo solo stazionare, come diceva Heidegger, nella
«disponibilità dell’attesa», perché quello della fede è un salto irrazionale che
evidentemente la ragione non può fare; si rischierebbe altrimenti di fare come il
barone di Münchhausen che voleva sollevarsi da terra tirandosi per i capelli. La fede
può esistere solo laddove non ci può essere convinzione e opzione razionale, dove
la razionalità, non solo quella more geometrico, ma anche quella argomentativa, si rivela
impotente.
E tuttavia se la scienza è senza certezza ma non senza verità e se l’etica è senza
verità ma non senza ragione, la fede è senza ragione ma non senza significato. Solo
che è un significato – a differenza di quello etico – razionalmente indicibile. Perché
se cercassimo di addurre ragioni saremmo costretti ad usare lo strumento improprio
della ragione, e non potremmo dire alcunché senza entrare in contraddizione. Se la
fede è il sommo bene e se Dio è misericordioso, perché egli priva di questa luce
alcune delle sue creature? E se lo fa, è forse perché essa non è sommo bene o
perché il Dio misericordioso è mosso da un intento punitivo? Sono contraddizioni
inevitabili perché, come avrebbe detto Wittgenstein, si cerca di parlare di ciò di cui
si deve tacere. (Per l’Assoluto – ha scritto Kierkegaard – non si possono dare
ragioni, al massimo si possono dare ragioni che non ci sono ragioni». Il mistero non
si dimostra, né si argomenta; o si contempla con il silenzio, altrimenti svanisce. «È
difficile portare sulla nostra bilancia le cose divine – ha scritto il grande Montaigne
– senza che esse non vi abbiano un calo».
!6
!
Relativismo e laicità
!
Se, infine, si prendono in considerazione le critiche di coloro che attaccano il
relativismo con l’intento di criticare una eccessiva laicità dello spazio pubblico in
nome di una morale cristiana ritenuta oggettivamente privilegiata, non è difficile far
osservare come queste critiche, oltre che epistemologicamcnte insostenibili, siano
semplicemente autocontraddittorie. Per un cristiano, Dio è l’unico assoluto, e quindi
il mondo storico è il regno della contingenza, nel quale va applicato il precetto
evangelico di «dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Nel
mondo degli affari umani non c’è di conseguenza posto per punti di vista esclusivi,
valori universali e quindi per interpreti privilegiati – in nome di Dio o della Ragione
– della storia umana. Distaccando il mondano dal divino, desacralizzando e
deassolutizzando ciò che è umano, il cristianesimo combatte l’idea che la perfezione
possa appartenere a questo mondo. Ma proprio perché desacralizzato, il mondo
umano diventa mondo storico, che l’escatologia biblica trasforma nel luogo e nel
tempo della lotta contro il male. In questo modo, dopo aver espunto l’idea di
perfezione si introduce nell’ordine mondano l’idea di perfettibilità, si elimina il mito
utopico di una società perfetta edificata su valori assoluti per aderire al principio
pragmatico dell’ eliminazione progressiva delle miserie. E proprio nella rinuncia alla
perfezione in nome della perfettibilità, di una perfettibilità che scaturisce dal
continuo confronto tra tradizioni diverse, consiste la vera essenza della democrazia
e della tradizione occidentale. Se la desacralizzazione del mondo naturale e
l’antidogmatismo hanno favorito la nascita della scienza, la storicizzazione del
mondo umano ha prodotto la laicizzazione della politica, la creazione di uno spazio
pubblico di discussione critica nel quale non c’è posto per punti di vista privilegiati,
e quindi anche per dogmi di fede, cioè per idee espresse «in nome di Dio». Chiedere
dunque a un cristiano di non essere laico e relativista significa chiedergli di preferire
il Dio dei filosofi al Dio di Abramo. «Cristiano antirelativista» e «cristiano non laico»
sono ossimori; ossimori proprio come «ateo devoto».
!
!7