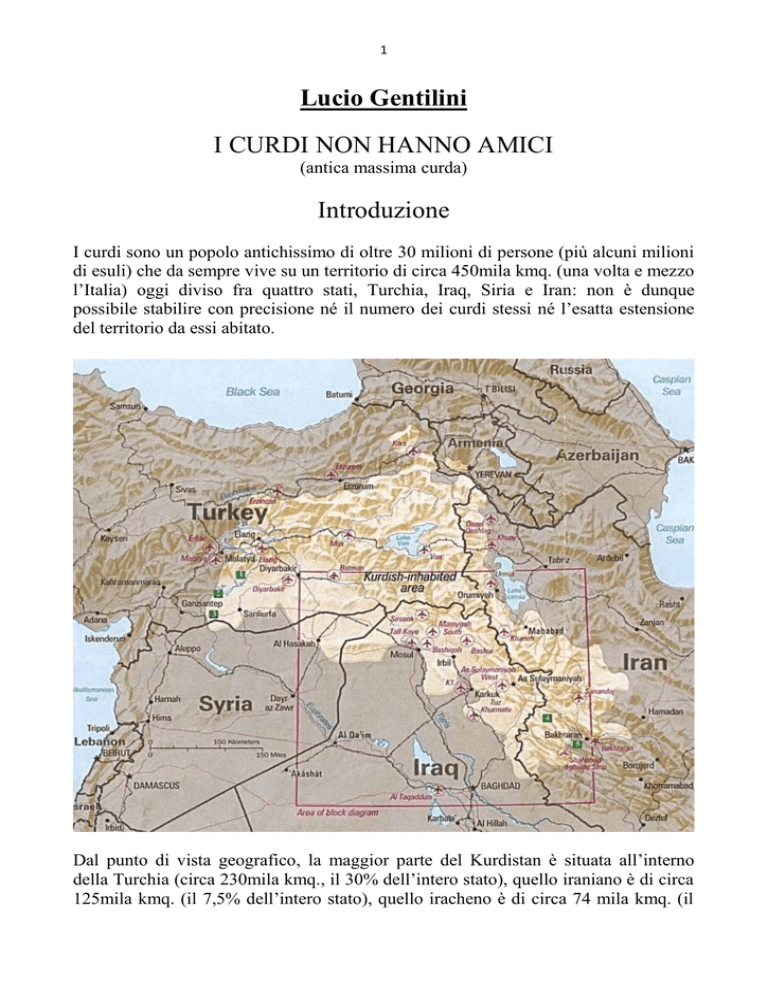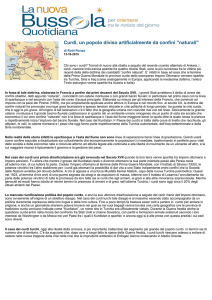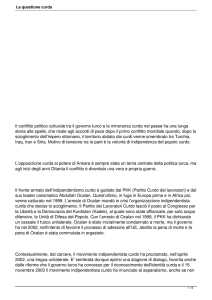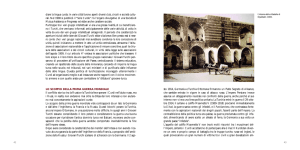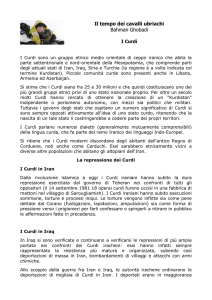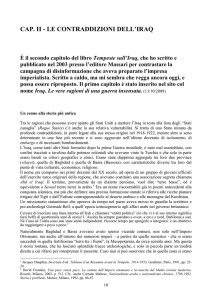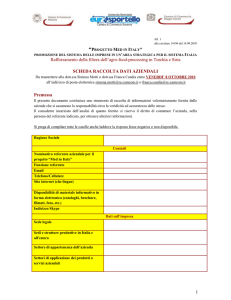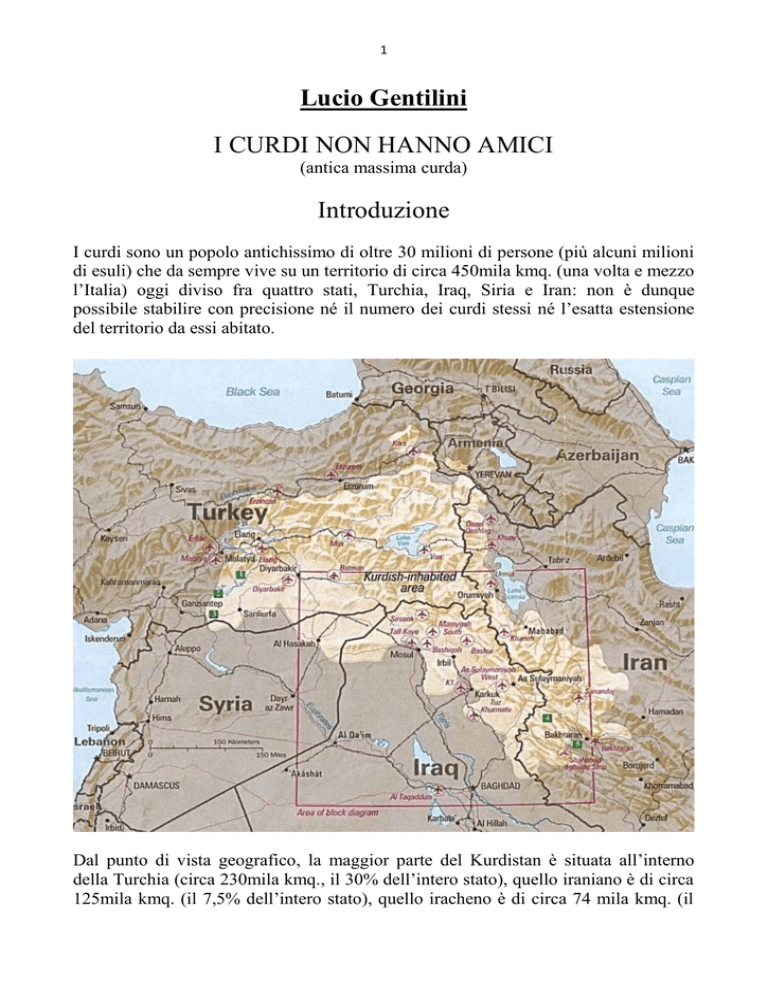
1
Lucio Gentilini
I CURDI NON HANNO AMICI
(antica massima curda)
Introduzione
I curdi sono un popolo antichissimo di oltre 30 milioni di persone (più alcuni milioni
di esuli) che da sempre vive su un territorio di circa 450mila kmq. (una volta e mezzo
l’Italia) oggi diviso fra quattro stati, Turchia, Iraq, Siria e Iran: non è dunque
possibile stabilire con precisione né il numero dei curdi stessi né l’esatta estensione
del territorio da essi abitato.
Dal punto di vista geografico, la maggior parte del Kurdistan è situata all’interno
della Turchia (circa 230mila kmq., il 30% dell’intero stato), quello iraniano è di circa
125mila kmq. (il 7,5% dell’intero stato), quello iracheno è di circa 74 mila kmq. (il
2
17% dell’intero stato) e quello siriano è di circa 18.300 kmq. (il 10% dell’intero
stato).
Dal punto di vista della popolazione, in Medio Oriente i curdi costituiscono il quarto
gruppo etnico (dopo arabi, turchi e iraniani): circa il 50% (15 milioni) vive in Turchia
di cui rappresenta il 20% della popolazione totale, altri 8-9 milioni vivono in Iran
(11% della popolazione totale), 5-6,5 milioni in Iraq (15-20% della popolazione
totale) e 1,5-2,3 milioni in Siria (7-10% della popolazione totale), senza contare
naturalmente i curdi della diaspora (in Europa occidentale ce ne sarebbero 1 milione
metà del quale in Germania).
Se il Kurdistan fosse uno stato unito e indipendente sarebbe quello più ricco del
Medio Oriente date le risorse e le materie prime di cui dispone, che vanno dalle
sorgenti idriche ai numerosi minerali (fosfati, ferro, argento, lignite, uranio e in
particolare cromo) e soprattutto al petrolio che viene estratto in tutti e quattro i
territori curdi.
I curdi sono invece un popolo diviso e senza stato anche se hanno una loro lingua,
una loro cultura e insomma, pur fra mille difficoltà, un’identità che li accomuna
anche se non li unisce politicamente: questa mancanza di unità politica è sempre stato
ed è un grave handicap per i curdi che si sono spesso trovati divisi anche durante le
loro numerose rivolte, tanto che le rivalità fra tribù ne hanno spinto alcune ad
appoggiare i governi contro cui altre combattevano.
I curdi hanno scritto pochissimo su di sé e sulla loro storia e oltretutto in tempi molto
recenti, praticamente solo nel Novecento e particolarmente nel periodo sovietico (nei
centri di Mosca e di Yerevan): è comunque proprio nell’ultimo secolo che la loro
tragedia si è consumata (e si sta consumando) mentre la loro fierezza e il loro
coraggio li hanno resi sempre più meritevoli di ammirazione e di considerazione.
In queste pagine si cercherà allora di tracciare un quadro storico dell’ultimo secolo di
questo popolo che lotta e che combatte alla ricerca di un futuro e del riconoscimento
della sua stessa esistenza in un’area profondamente instabile, martoriata e piena di
conflitti e tensioni di cui nessuno oggi può ancora prevedere l’esito finale.
Quella dei curdi è infatti una storia non ancora conclusa, una ferita ancora
sanguinante, un diritto non ancora riconosciuto e un problema di equilibrio
internazionale ancora aperto, proprio mentre la caotica situazione in Medio Oriente e
le sue guerre recentissime e ancora in corso li vede nettamente protagonisti.
Le dominazioni sui curdi
Sulle origini stesse dei curdi circolano diverse ipotesi e quella prevalente li ritiene
discendenti, o comunque imparentati, cogli antichi medi (a loro volta imparentati coi
caldei, coi georgiani e con gli armeni): essi sarebbero dunque estranei ad arabi e
turchi ma in qualche modo collegati invece agli iraniani.
Anche se essi da sempre parlano una loro propria lingua di origine iranica, il termine
Kurdistan come denominazione geografica risale comunque agli inizi del XII secolo.
3
Nel 550 a.C. Ciro II il Grande, re dei Persiani, mossa guerra ai medi ne conquistò la
favolosa e favoleggiata capitale Ecbatana (oggi Hamadan nella regione dei monti
Zagros in Iran): i medi persero così la loro indipendenza ma non la loro influenza
culturale tanto che è lecito parlare di civiltà medo-persiana, mentre la stessa Ecbatana
mantenne praticamente intatto il suo ruolo centrale nella regione.
Nel 331-330 a.C. Alessandro Magno conquistò poi il regno persiano (e, fra l’altro,
distrusse Ecbatana) e alla morte del grande conquistatore (323 a.C.), anche il
(chiamiamolo già così) Kurdistan entrò a far parte del regno ellenistico dei Seleucidi.
Verso la metà del II secolo a.C. furono poi i Parti che conquistarono la regione.
Nel 224 a.C. il secondo regno persiano dei Sasanidi riconquistò anche il territorio dei
curdi e ne mantenne il dominio per otto secoli.
A partire dal 636 furono poi gli arabi che nell’ambito della loro leggendaria
espansione occuparono anche buona parte del territorio abitato dai curdi, ma non la
sua parte sud-orientale che rimase sotto i persiani: i curdi persero così la loro unità.
La storia dei curdi comincia comunque ad essere meglio conosciuta proprio a partire
dalla conquista araba che ebbe profondi effetti sul loro mondo.
La conquista araba viene considerata dai curdi il primo genocidio che dovettero
subire nella loro tragica storia: anche se la cifra (di fonte araba!) di mezzo milione di
famiglie curde trucidate con ogni probabilità è eccessiva, rimane il fatto che fra
uccisioni, deportazioni e vendita come schiavi, in seguito alla conquista araba una
larga fetta della popolazione curda venne eliminata, né il disastro finì qui.
Fino alla conquista araba i curdi avevano seguito la religione zoroastriana, ma ora
anche loro dovettero subire la diffusione dell’Islam che, oltre a cancellare alcuni dei
loro tratti caratteristici (anche se però le tradizioni curde in genere rimasero vive e
seguite), soffocò anche la loro già debole identità nazionale dato che gli islamici
consideravano preminente l’appartenenza religiosa piuttosto che quella etnica.
Fino a quel momento la donna aveva occupato una posizione di tutto rilievo nella
società curda: essa era molto considerata in famiglia, poteva essere capo-tribù, capoclan e addirittura regnare su più tribù unite, ma con l’avvento dell’Islam essa perse il
suo ruolo paritario e iniziò per lei un lunghissimo periodo di sottomissione e di
oppressione durato praticamente fino alla metà del secolo scorso.
Dopo la conquista araba i curdi continuarono a rimanere un popolo frammentato nè
svilupparono una coscienza nazionale anche se vennero favoriti dal loro famosissimo
consanguineo Saladino (1137-1193).
Il periodo favorevole dei curdi fu comunque di breve durata perché a partire dal 1231
i mongoli si riversarono con le loro tristissime stragi e devastazioni anche sul
Kurdistan e sulla Mesopotamia e, terribili e spietati, strapparono agli arabi (ma non ai
persiani) i territori curdi.
Nel XIV fu poi la volta dei turchi ottomani la cui opera conquistatrice nel 1402 fu
interrotta dall’arrivo del temibilissimo Tamerlano, il cui sterminato ma effimero
impero non sopravvisse però alla morte del suo fondatore (1405) così che gli
ottomani, conquistata Costantinopoli nel 1453, continuarono la loro marcia trionfale e
nel 1501 scacciarono infine i mongoli (ma, ancora una volta, non i persiani) anche dai
territori curdi di cui divennero i nuovi signori.
4
I curdi erano ora divisi (e contesi) fra turchi e persiani.
L’epoca d’oro del Kurdistan
Questa divisione dei curdi comportò un ulteriore problema perchè i due grandi imperi
islamici - in costante competizione fra loro – seguivano (e seguono) le due varianti
principali dell’Islam in quanto i turchi erano (e sono) sunniti come i curdi, e i persiani
sciiti: mentre dunque nell’impero ottomano contro i curdi non c’era opposizione
religiosa, non così fu in quello persiano dove i curdi vennero invece perseguitati, col
prevedibile effetto che nelle guerre fra i due imperi essi in genere si posero dalla parte
dei turchi nonostante soldati curdi fossero ovviamente arruolati anche nell’esercito
persiano.
La grande maggioranza dei curdi viveva comunque nell’impero ottomano dove
godeva di condizioni molto migliori rispetto a quelle di coloro che vivevano
nell’impero persiano: i turchi infatti – adottando tale sistema non solo nei confronti
dei curdi – ne raggrupparono le tribù in principati semi-indipendenti (imarat)
largamente autonomi e con ampie libertà.
Il Kurdistan era poi il punto di partenza per l’ulteriore espansione ottomana verso sud
e verso ovest, come avvenne nel 1515 con la conquista di Bagdad e dell’Egitto: fu in
quest’occasione che, fra l’altro, varie tribù curde vennero spostate intorno al lago Van
per tenere meglio sotto controllo i poco affidabili armeni cristiani.
Gli ottomani utilizzarono inoltre i curdi per la difesa dei loro confini orientali e anche
per questo le loro tribù più importanti ottennero feudi militari, dignità e cariche
amministrative: il Kurdistan ottomano era dunque suddiviso in una miriade di
principati e/o di piccoli feudi spesso rivali e in guerra fra loro, retti da dinastie
ereditarie, col potere di battere moneta e dotati addirittura di propri eserciti di forza e
di dimensioni anche considerevoli.
Nell’impero ottomano i curdi godevano insomma di una quasi completa
autonomia: dovevano pagare un tributo al sultano e fornirgli soldati in caso di
bisogno, ma molti capi erano in grado di sottrarsi a questi obblighi o di onorarli solo
saltuariamente.
Inutilmente nel corso del XVII secolo i sultani cercarono di centralizzare il loro
potere, di esautorare i principi curdi e di sostituirli con governatori da loro nominati:
non ne avevano semplicemente la forza e i loro tentativi fallirono anche a causa delle
molteplici e continue guerre che allora combattevano in Europa e contro la Persia
(queste ultime concluse nel 1639).
Secondo gli stessi storici curdi fu questa l’epoca d'oro del Kurdistan: l’autorità
dell’impero ottomano (e anche di quello persiano!) era nominale e molti principati
e/o feudi erano di fatto indipendenti o quasi.
Il Kurdistan era una sorta di terra di nessuno, clanica, tribale, remota ed inaccessibile,
che costituiva un ampio cuscinetto montagnoso fra i due imperi islamici rivali, ma
proprio questo isolamento, se di fatto proteggeva i curdi, grazie anche alle rivalità tra
i loro signori feudali e all’arretratezza economica dei loro principati, ne impedì però
5
l’unità politica: anche se parlavano la stessa lingua e partecipavano della stessa
civiltà, i curdi insomma non conobbero alcun processo di aggregazione e di
unione mancando completamente di quella che poi sarebbe stata chiamata
coscienza nazionale.
Questa sorta di anarchia particolaristica fu possibile ed accentuata anche perché di
fatto il confine fra i due imperi (stabilito e variato da vari trattati nel corso dei secoli)
era puramente nominale né impediva ai curdi di muoversi liberamente da una parte
all’altra di esso: insomma: i curdi erano padroni del vasto territorio che abitavano e
l’autorità dei due imperi su di loro era praticamente inesistente, ma non avevano
coscienza di essere un popolo, non avevano uno stato né ci pensavano perché
evidentemente stavano bene così come stavano.
Nonostante le politiche centralizzatrici periodicamente tentate dai governi ottomano e
persiano, la maggior parte dei principati curdi sopravvisse almeno fino alla metà del
XIX secolo, ma evidentemente questa loro condizione non poteva continuare
indefinitamente.
La fine della quasi-indipendenza curda
La situazione cambiò (e cominciò a precipitare) con l’avvento sul trono di Istanbul di
Abdul Mecid (1839-61) che, consapevole dell’arretratezza e della disarticolazione del
suo impero, l’anno stesso della sua incoronazione varò il famoso programma di
riforme (Tanzimat) che avrebbe impegnato politica della Porta per un quarantennio.
Scopo e perno delle riforme era la centralizzazione del potere e la modernizzazione
dello stato che, fra l’altro, comportava l’effettivo controllo dei suoi vasti territori e lo
sfruttamento delle loro risorse.
Tutto ciò significava evidentemente anche la fine della libertà dei curdi, così la
sostituzione dei loro capi (feudali) con governatori turchi, l’inasprimento
dell’esazione fiscale e l’imposizione della coscrizione obbligatoria provocarono
immancabili rivolte e sollevazioni di queste genti tanto fiere e bellicose.
Ciò naturalmente non può stupire: il vasto piano di riforme volto alla
modernizzazione dell’impero turco implicava necessariamente una forte limitazione
dell’autorità dei capi curdi e la fine della loro quasi-indipendenza: essi imbracciarono
così le armi per preservare le condizioni di autonomia in cui da secoli vivevano,
seppur ancora lontani, estranei e privi di una coscienza nazionale.
Non si trattava oltretutto solo dell’imposizione del potere del sultano sui curdi
riottosi, ma anche del vasto progetto di transizione dal feudalesimo (l’unico sistema
che i curdi conoscevano) alla modernità dello stato accentrato di tipo europeo.
Così il generale Helmuth von Moltke, futuro riformatore dell’esercito prussiano di
Bismarck e allora consigliere militare presso le forze armate ottomane, descrive la
situazione: ‘L’Impero ottomano abbraccia grandi territori dove la Porta non esercita
alcuna autorità di fatto, ed è certo che il Sultano ha molte conquiste da fare nella
periferia dei suoi propri Stati. Di questo numero è il paese montuoso tra la frontiera
persiana e il Tigri (...). Non è mai riuscito alla Porta di atterrare in questi monti la
6
potestà ereditaria delle famiglie. I Principi curdi hanno un gran potere sui loro
sudditi; guerreggiano fra loro, sfidano l’autorità della Porta, negano le imposte, non
permettono la leva e cercano un ultimo rifugio nelle rocche che hanno innalzato sulle
alte vette’.
Né il problema era solo di politica interna: nel cruento scontro il sultano poteva
contare infatti sull’aiuto e sul sostegno della Francia e dell’Inghilterra che, timorose
dell’espansionismo russo, avevano sviluppato una loro già notevole penetrazione
economica nell’impero ottomano in aperta competizione con quella della Germania,
mentre Iran e Russia - nell’ambito delle loro complicate lotte contro i turchi soffiavano invece sul fuoco del malcontento curdo.
Divisi, arretrati, al centro di giochi tanto più grandi di loro, i curdi erano insomma
soli contro tutti e le loro rivolte (una cinquantina!) furono combattute con armamenti
antiquati mentre le divisioni profonde fra le varie tribù e la mancanza dell’unità
politica impedirono sempre il coordinamento degli sforzi e una strategia comune.
L’isolamento, le divisioni e l’arretratezza dei curdi ne segnarono insomma
l’irreparabile sconfitta: la cinquantina di rivolte del XIX secolo nel Kurdistan
ottomano vennero infatti tutte represse nel sangue e la sistematica brutalità dei turchi,
tipica nei confronti di chi si ribellava al loro dominio, si manifestò ancora una volta
spietata e ripetuta.
Alla fine del secolo tutti i principati curdi indipendenti erano scomparsi: i secoli
dell’età dell’oro si erano conclusi nel sangue e quello della tragedia curda era appena
cominciato.
La partecipazione dei curdi al genocidio degli armeni
Il trattato di Berlino del 1878 (che indebolì fortemente la presenza ottomana nei
Balcani e sancì la nascita del principato di Bulgaria) rafforzò contemporaneamente
sia le spinte all’autonomia delle varie etnie (in primo luogo di quella armena) sia il
nazionalismo turco, ottenendo dunque il paradossale risultato di acuire le tensioni
interne all’impero: fu in questo contesto che sarebbe maturato il terribile genocidio
degli armeni (vedi il mio ‘Il genocidio degli armeni’).
Gli armeni erano cristiani, portatori di una civiltà molto avanzata e dotati di un forte
senso di appartenenza: dai turchi essi furono avvertiti sempre più come un corpo
estraneo ed ostile, un ostacolo per la compattezza dell’impero, un impedimento al suo
collegamentocogli islamici dell’Asia centrale e oltretutto una minaccia perché protetti
e sostenuti dai russi che erano arrivati a creare un’Armenia russa all’interno
dell’impero zarista subito al di là del confine con quello ottomano.
Per distruggere e schiacciare gli armeni il sultano Abdul Hamid II (1876-1909)
cominciò con la tattica del ‘brigantaggio organizzato’ (dall’alto) nei loro confronti di
cui i curdi furono i principali artefici dato che quelli del nord-est erano entrati
disinvoltamente nei corpi speciali ottomani (hamidiye): si noti come questo
arruolamento dei curdi nelle milizie di chi ne aveva appena soffocato nel sangue le
7
rivolte è davvero sintomatico e ancora una volta rivelatore della mancanza di una loro
coscienza nazionale.
I massacri di armeni da parte delle hamidiye (composte principalmente da curdi) e
poi anche da regolari turchi iniziarono così nel 1894 e non si sarebbero più fermati
fino al genocidio del 1915.
Le responsabilità dei curdi in questo orrore sono evidenti: essi furono la più o meno
convinta e consapevole arma nelle mani dei turchi che ancor oggi nell’ambito del loro
negazionismo tentano di scaricare su di loro la colpa dell’accaduto o almeno buona
parte di essa.
La nascita della coscienza nazionale curda
I tentativi riformatori del XIX secolo nell’impero ottomano non ne impedirono il
progressivo sfaldamento e forse addirittura lo aggravarono perché di fatto acuirono i
contrasti e le contraddizioni interne fra le varie nazionalità che lo componevano,
mentre le grandi potenze europee, in competizione per spartirsi le spoglie del ‘grande
malato’, lo penetravano e intervenivano sempre più pesantemente nei suoi affari
interni: la cosiddetta ‘questione d’Oriente’ si stava insomma aggravando e presto
sarebbe arrivata alla sua conclusione finale.
Nel 1908 un gruppo di giovani ufficiali dell’esercito tentò la definitiva
modernizzazione (in senso europeo) dell’impero impadronendosi del potere con una
rivoluzione di stampo nazionalista: fu questa la rivoluzione dei Giovani Turchi che
fin dall’inizio mostrò tuttavia caratteri ambigui e contraddittori perché da una parte si
fondava sull’affermazione della coscienza nazionale turca, ma – almeno nella sua
fase iniziale – dall’altra si presentò anche con un forte intento democratizzatore,
suscitando così l’entusiasmo di tutte le altre nazionalità dell’impero.
La presa del potere da parte di Giovani Turchi sembrò insomma portare una ventata
di democrazia e di tolleranza ed è significativo che nel nuovo Parlamento (ai sensi
della nuova Costituzione) sedessero 147 turchi, 60 arabi, 27 albanesi, 26 greci, 14
armeni 10 slavi, 4 ebrei ma 1 solo curdo: da queste semplici cifre emerge con
evidenza l’iniziale intento democratizzatore del nuovo regime ma anche l’arretratezza
politica curda, alla quale tuttavia si cominciò finalmente a cercare un rimedio.
Se infatti alcune tribù curde si erano schierate dalla parte del sultano (che
nominalmente rimase comunque ancora in carica), la parte più avanzata della società
curda - e soprattutto l’intellettualità formatasi ad Istanbul e nell’Europa occidentale iniziò a porre il problema dell’identità e dell’indipendenza nazionale: il clima di
relativa tolleranza seguito alla rivoluzione dei Giovani Turchi portò così alla
formazione di associazioni politiche, sociali e culturali sotto la guida di personalità
curde a Istanbul e in Europa occidentale, ma non nella loro terra natale.
Questa nascente intellighenzia curda rimaneva però seriamente divisa al suo interno
ed era pressochè sconosciuta in patria mentre i suoi tentativi di collegarsi alle altre
etnie dell’impero era appena accennata e assai poco significativa.
8
La democratizzazione dell’impero turco durò comunque lo spazio di un mattino: oltre
che per motivi di politica interna, le due guerre balcaniche (1912-13) e l’entrata della
Turchia nella prima guerra mondiale al fianco degli Imperi Centrali (1914) fecero
cadere la maschera della democratizzazione dal volto dell’intransigente e intollerante
nazionalismo turco che venne pienamente riaffermato: bandita ogni attività
nazionalistica non-turca (in quanto giudicata antiturca), le persecuzioni delle altre
etnie ricominciarono così il loro triste corso.
Il Kurdistan nella prima guerra mondiale
Non è questa la sede per una trattazione esaustiva della prima guerra mondiale e
dunque qui se ne tratteranno solo gli aspetti che riguardarono e coinvolsero i curdi e i
territori da essi abitati.
Si è già detto che i Giovani Turchi avevano presto abbandonato i loro programmi
democratici per ripiegare invece sul ‘panturchismo’ nazionalista: quando l’impero
turco entrò in guerra contro il suo tradizionale nemico russo (29 ottobre 1914) essi
avevano così in mente la riconquista dei Balcani (da loro appena persi nelle due
guerre dette appunto ‘balcaniche’) mentre il sultano Maometto V (1909-18) proclamò
subito anche la jihad, la guerra santa contro gli infedeli, e il suo appello trovò i
seguaci più convinti proprio fra i curdi.
I curdi pagarono prezzi altissimi alla guerra perché il loro territorio divenne un campo
di battaglia, pressati come furono fra turchi da una parte e russi ed inglesi dall’altra: i
curdi si trovarono stretti in una tenaglia e coinvolti nella lotta tra le maggiori potenze
imperialistiche del tempo per la spartizione del mondo.
Lo scontro tra Inghilterra, Francia e Germania per impadronirsi del petrolio
mediorientale costituì poi un importante tassello sul gigantesco scacchiere e il fatto
che una delle zone più ricche di petrolio, il vilayet di Mosul, era in territorio curdo,
lungi dal rappresentare una ricchezza e una risorsa per questo popolo, tutto al
contrario lo trasformò invece in una preda e in un obiettivo strategico.
Il Kurdistan, terreno di scontro e campo di battaglia, venne distrutto e spogliato sia
dai nemici che dagli alleati mentre su di esso si moltiplicavano manovre di ogni tipo:
mentre i curdi combattevano contro i russi questi ultimi rinnovarono infatti anche le
iniziative per unirli e mobilitarli contro i turchi facendo loro intravedere una possibile
indipendenza a guerra finita.
Era più o meno quello che gli inglesi e il famoso Lawrence cercavano di fare con gli
arabi che comunque in cambio della loro sollevazione antiturca rivendicavano
proprio anche quelle parti del Kurdistan che oggi fanno parte dell’Iraq e della Siria:
fra i due litiganti (arabi e curdi) fu comunque il terzo a godere, l’imperialismo
europeo, visto che anche il destino dei territori curdi rientrò nell’accordo spartitorio
Sykes-Picot (16 maggio 1916) fra Russia, Francia e Inghilterra.
Nonostante ciò, una prima riunione di tutti i capi delle tribù curde si tenne nel
luglio1917 nel Kurdistan iraniano (l’Iran era neutrale) alla presenza di rappresentanti
9
di Inghilterra e Russia mentre in una seconda venne stabilita l’unione di tutte le tribù
curde in un unico stato.
Insomma: mentre il territorio dei curdi era appetito da più parti e veniva devastato
dalla guerra e dalle persecuzioni, a questi ultimi venivano fatte molte promesse che
però erano false ed avanzate in completa in malafede perché - a parte il fatto che il
Kurdistan iraniano non era in discussione - sul resto della regione arabi, russi, inglesi
e francesi si accordavano, o avanzavano le loro pretese contraddittorie, o stipulavano
patti spartitori che trascuravano completamente gli impegni pur presi coi curdi stessi
cui si continuava ugualmente a far intravedere l’indipendenza.
I giochi non erano però ancora conclusi: il succitato trattato Sykes-Picot aveva infatti
assegnato alla Russia la maggior parte del Kurdistan ma la rivoluzione d’Ottobre la
eliminò dalla scena mentre in Medio Oriente il vuoto politico era notevole nè l’Iran
era in grado di esercitare alcuna influenza: i tempi sarebbero stati dunque propizi per
un’azione curda in vista dell’indipendenza, ma l’occasione non venne colta.
Come riconosce amaramente lo storico curdo Baykar Sivazliyan ‘il movimento
nazionale curdo … ancora influenzato dal proprio background feudale e tribale, semidistrutto dalle vicende della guerra, suddiviso in numerosi comitati, non all’altezza
della situazione, e diviso dalla profonda frattura fra autonomisti e indipendentisti,
lasciò cadere nel vuoto questa grande occasione.’
Tutte le decisioni sarebbero state prese così dai vincitori della guerra.
Da Sèvres a Losanna
L’impero ottomano dovette infine arrendersi e l’armistizio di Mudros (30 ottobre
1918) impose dure condizioni ai turchi sconfitti: mentre anche Istanbul veniva
occupata, le truppe stanziate fuori dell’Anatolia furono richiamate, l’esercito
ottomano fu smobilitato e ridotto a 50mila unità, la marina potè mantenere solo 13
navi e l’aviazione venne proibita: agli alleati fu concesso il diritto di occupare i
Dardanelli, il Bosforo, il mar di Marmara (smilitarizzati e trasformati in territori
internazionali), porti, ferrovie, punti strategici e ogni altro territorio turco utile a
garantire la sicurezza (dei vincitori).
Mentre la Turchia era allo sfascio, la ‘megali idea’, la grande idea di un Egeo lago
greco con tutta la sua costa anatolica riunita alla madrepatria ellenica, sembrò così sul
punto di avverarsi e trovò in Eleutherios Venizelos il suo ardente apostolo e
propugnatore.
Volendo approfittare dello sbandamento turco i greci si mossero così con grande
velocità e gli eventi presero a correre con un ritmo incalzante.
Pur senza disporre ancora di un piano preciso e con l’ Italia assente, il 6 maggio 1919
i Tre Grandi (USA, Inghilterra e Francia) acconsentirono all’invio di un corpo di
spedizione greco che prendesse possesso dei territori intorno agli Stretti, al mar di
Marmara e sulla costa orientale egea, e già il 13 ratificarono l’accordo.
10
Solo due giorni dopo Smirne venne occupata da un corpo di spedizione greco che,
memore dei patimenti subiti dai suoi connazionali, si abbandonò alla violenza sui
turchi mentre i greci precedentemente espulsi cominciarono subito a rientrare.
Posto di fronte all’emergenza dell’invasione, alla necessità di evitare lo
smembramento dello stato, di rifondare la nazione e mentre il sultanato era ormai una
parvenza insignificante, nell’estate 1919 il nazionalismo turco rinacque però sotto la
capace guida del generale Mustafa Kemal.
Il 26 gennaio 1920 Kemal lanciò il Patto Nazionale Turco fondato sul riconoscimento
e sul rispetto dei diritti della maggioranza musulmana dell’ex-impero, cioè dei turchi
e dei curdi da lui associati nella lotta nazionale che si stava riorganizzando nelle
impervie e difficili (ma sicure) regioni dell’interno - e i curdi risposero
positivamente al suo appello.
Eppure si è visto che già durante la guerra l’Inghilterra aveva cercato di sollevare le
popolazioni curde (e quelle arabe) contro l’impero turco promettendo loro
l’indipendenza mentre l’art. 12 dei famosi ‘14 Punti’ del presidente statunitense
Wilson aveva affermato che ‘Le nazionalità che vivono attualmente sotto l’Impero
turco devono godere una sicurezza certa di esistenza e di potersi sviluppare senza
ostacoli; l’autonomia deve essere loro concessa’: dopo la firma dell’armistizio di
Mudros l’emiro Kanucan Bédir Khan e il senatore Abd Al-Kadir avevano così creato
un’Associazione per il risorgimento curdo ed era stato fondato addirittura un Partito
nazionale curdo.
Il riconoscimento della partecipazione curda al genocidio degli armeni ebbe però una
pessima influenza sulle trattative di pace tanto che la delegazione curda non vi fu
nemmeno ammessa, eppure, nonostante ciò, fu allora che per la prima volta in sede
internazionale venne affrontato il problema dell’indipendenza del Kurdistan.
I
Al tavolo di pace la parte del leone la fecero le due potenze imperialiste rimaste sul
campo, Francia ed Inghilterra, che, pur sostenendo ufficialmente il diritto
all’indipendenza dei popoli oppressi dell’ex-impero ottomano, di fatto se ne divisero
le spoglie: il summenzionato accordo Sykes-Picot e gli accordi segreti stipulati tra le
potenze alleate nella Conferenza di Sanremo (aprile 1920) servirono infatti da base
per la spartizione e la sistemazione dell’ex-impero ottomano stabilita dal trattato di
Sèvres (10 agosto 1920).
Questa spartizione e sistemazione dell’ex-impero ottomano fu la quadratura del
cerchio: secondo una rinnovata logica colonialista ed imperialista e nel quadro
giuridico dei ‘mandati’ approvati poi dalla neonata Società delle Nazioni, la Francia
ottenne il Libano e la Siria, l’Inghilterra la Palestina e la Mesopotamia, cioè i territori
più fertili e più ricchi di petrolio.
Gli arabi non ottennero niente, ma, data l’esigenza di istituire una ‘cintura di
sicurezza’ fra la neonata URSS e la Turchia (in Europa venne creato invece il
‘cordone sanitario’) in modo da bloccare la diffusione della rivoluzione bolscevica, a
Sèvres venne sancita anche la nascita di uno stato armeno e di uno stato curdo
11
(seppur ridotto ai suoi territori settentrionali e con una sovranità limitata), in
posizione strategica nelle vicinanze dei pozzi petroliferi sovietici nel Caucaso: l’eximpero ottomano venne ridotto insomma a un modesto stato della penisola anatolica,
privo di tutti i territori arabi, del controllo degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli e
con le sue coste meridionali in mano a Grecia, Italia e Francia.
In realtà l’esistenza stessa e i confini dello stato curdo prevedevano ulteriori
consultazioni e un referendum: l’art. 62 del trattato di Sèvres stabilì infatti che ‘Una
commissione … redigerà entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente trattato un
progetto di autonomia locale per le regioni in cui domina l’elemento curdo, situato ad
est dell’Eufrate, a sud della frontiera meridionale dell’Armenia, come sarà
determinato in seguito, a nord delle frontiere della Turchia con la Siria e con la
Mesopotamia’ mentre l’art. 64 aggiungeva che ‘Se, entro un anno dall’entrata in
vigore del presente trattato, la popolazione curda delle regioni descritte all’art. 62 si
rivolgerà al consiglio della Società delle Nazioni, dimostrando che la maggioranza
degli abitanti delle dette regioni desidera la propria indipendenza dalla Turchia, il
consiglio riterrà che la detta popolazione è in grado di godere di questa indipendenza
e proporrà di concedergliela. La Turchia fin d’ora si impegna ad attuare siffatta
proposta e a rinunciare a ogni suo diritto e titolo in quelle regioni … le principali
potenze alleate non faranno ostacolo all’accessione volontaria dei Curdi che abitano
la parte del Kurdistan compresa nel Vilayet di Mossul – attuale Kurdistan iracheno –
allo Stato indipendente del Kurdistan.’
Questo Kurdistan indipendente lasciava fuori dai suoi confini i curdi dell’Iran, quelli
dell’Iraq (assegnato all’Inghilterra) e quelli della Siria (assegnata alla Francia) e
costituiva così solo il 20% dei territori popolati dai curdi e il 25% di quelli da loro
rivendicati, ma era comunque un inizio e segnava la nascita di un nuovo stato e di una
nuova patria: era poi ormai nata una coscienza nazionale curda e le questioni
12
territoriali cogli armeni vennero così risolte dall’accordo del 20 dicembre 1920
firmato dal curdo Scerif Pascià e dall’armeno Boghos Nubar Pascià.
In realtà si erano però fatti i conti senza l’oste (turco) e, soprattutto, tutte queste
decisioni erano state prese mentre l’invasione greca della Turchia era ancora in pieno
svolgimento così come la resistenza turca sotto la capace guida di Kemal: il corso
degli eventi avrebbe così annullato le speranze degli armeni e dei curdi e il trattato di
Sèvres non sarebbe mai entrato in vigore.
II
Anche se era stato firmato da quattro delegati del governo ottomano ed era stato
accettato dal sultano Mehmed VI, il trattato di Sèvres non solo non venne ratificato
dal parlamento ottomano (per il semplice fatto che il 18 marzo 1920 era stato abolito)
ma soprattutto le sue clausole vennero nettamente rifiutate dal movimento
nazionalista guidato da Mustafa Kemal.
La rivolta nazionalistica di Mustafa Kemal si intersecava e si fondeva con la
resistenza turca contro l’aggressione greca: per le Potenze vincitrici era questo
dunque l’ultimo ostacolo ed esse intesero superarlo sostenendo con ancor maggior
convinzione gli invasori greci.
Il 7 luglio 1921 la Grecia sferrò un nuovo attacco verso l’interno (il terzo da quando
il suo esercito era sbarcato a Smirne) per chiudere una volta per tutte i conti con
Kemal, ma i tempi erano cambiati e il rapporto delle forze in campo non era più lo
stesso di prima, così già l’11 settembre le truppe greche dovettero cominciare a
ritirarsi.
La ritirata greca assunse sempre più il carattere della rotta, con folle di civili greci e
armeni che fuggivano terrorizzati insieme all’ormai stanco esercito: questa volta le
violenze seguirono la strada inversa e furono inflitte dai turchi che incalzavano
memori di quelle subite ad opera dell’esercito invasore (che a sua volta ricordava
quelle patite dai suoi connazionali durante la guerra).
La marcia turca assunse invece sempre più il carattere di un’epopea e i suoi successi
galvanizzavano l’intera popolazione che la considerava una vera e propria liberazione
nazionale mentre i fuggitivi greci e armeni aumentavano ed erano ormai un mare di
disperati in cerca di protezione e di salvezza.
Smirne sarebbe dovuto essere lo sbocco e il punto d’arrivo finale dell’esercito in
ritirata, ma le scomposte truppe greche la evitarono cercando piuttosto di imbarcarsi
per la madrepatria in porti meno ingolfati dalle folle di civili allo sbando più
completo: fu così che il 9 settembre 1922 i primi reparti turchi entrarono in una città
abbandonata a se stessa e gremita di rifugiati su cui infierirono senza pietà
provocando quella che Llewellyn Smith chiama ‘catastrofe’ e Glenny ‘inferno’.
Mentre le Grandi Potenze, come le stelle, stettero a guardare, nessuna violenza fu
risparmiata agli infelici civili greci e armeni (solo questi ultimi cercano di reagire e
difendersi) finchè i quartieri da loro abitati vennero incendiati e rasi al suolo.
La oltre bimillenaria presenza greca (e armena) in Asia Minore finì per sempre in un
bagno di sangue: l’Asia Minore non sarebbe stata mai più la stessa e le sue imponenti
13
e diffuse rovine elleniche sono ancor oggi testimonianze di un passato davvero
passato.
III
Il completo e drammatico disastro greco della megali idea in Asia Minore coincise
colla nascita della Repubblica Turca come la conosciamo ancor oggi: uno stato
moderno, nazionalista, coeso, compatto, etnicamente definito, i cui confini, rimasti
finora immutati, dopo numerosi e complicati esodi e controesodi (a questo proposito
vedere il mio ‘La ricomposizione etnica dell’Europa’) vennero stabiliti in varie
tappe che culminarono nel trattato di Losanna, definitivamente ratificato il 24
luglio 1923 dalla Turchia e dalle Potenze dell’ex-Intesa.
A Losanna trionfarono così le esigenze del nuovo regime turco e gli interessi
dell’imperialismo anglo-francese: il trattato di Sèvres venne rigettato ma non per quel
che riguardava i mandati che Francia e Inghilterra avevano ottenuto in Medio
Oriente, ampi territori cui la Turchia rinunciava insieme a tutto il Nordafrica in
cambio della completa abolizione del regime delle Capitolazioni (accordi di favore
nei confronti degli europei) e della serie di privilegi sino ad allora riconosciuti alle
loro comunità colà residenti, ma soprattutto dei nuovi confini che escludevano ogni
presenza straniera in Asia Minore e inglobavano in Turchia i territori dei
precedentemente previsti Kurdistan e Armenia (la cui parte orientale divenne una
repubblica dell’URSS).
A Losanna la Turchia rientrava nel pieno possesso di tutti i suoi territori in Asia
Minore e a farne le spese furono dunque armeni e curdi il cui sogno di uno stato
indipendente era durato lo spazio di un mattino.
14
E non bastava ancora perché lo status di minoranza etnica venne riconosciuto solo ai
greci, agli armeni e agli ebrei, ma non ai curdi (!): evidentemente la rigorosamente
laica nuova Repubblica Turca continuava la tradizione ottomana di dividere e
classificare la popolazione non secondo l’etnia ma secondo la religione in modo che i
musulmani erano stati considerati un’unica entità e ogni appello all’appartenenza
etnica un attentato all’integrità dello stato.
Insomma: un greco era un ortodosso, un armeno un monofisita, un ebreo uno di
religione ebraica, ma un curdo era un musulmano esattamente come un turco.
Mentre per secoli la grande maggioranza del popolo curdo aveva goduto di una
sostanziale autonomia e unità all’interno del tollerante impero ottomano, dopo
la prima guerra mondiale esso si trovò diviso in quattro stati, Turchia, Iraq,
Siria ed Iran, e, quel che forse era peggio, minoranza in regioni in cui il
nazionalismo (turco, persiano e arabo) si era fortemente affermato.
Esso pagava caramente la sua scarsa o mancante coscienza nazionale e la sua
conseguente divisione in gruppi più o meno tribali: la sua tragedia era cominciata ed
anzi era ormai in pieno svolgimento.
Persecuzioni e rivolte: genocidio?
La divisione del popolo curdo in quattro stati stabilita a Losanna era stata decisa nel
più completo disprezzo per le sue esigenze ed i suoi diritti: dopo il trattato di Losanna
tutti i quattro stati furono concordi nella volontà di mantenere e anzi di rafforzare i
nuovi confini e ciò evidentemente implicò che la divisione dei curdi doveva diventare
sempre più effettiva e operante.
Se - oltretutto - si volevano mettere le mani sulle risorse e sulle ricchezze dei territori
curdi, il loro separatismo era il nemico da battere e il pericolo da scongiurare.
Ai curdi venne così impedito di passare da uno stato all’altro e nell’ansia di
spegnerne lo spirito di appartenenza e di cancellarne l’identità venne vietato persino
15
l’uso della lingua curda: anche i loro campi e pascoli erano stati divisi e ciò bloccava
la tradizionale transumanza delle greggi e delle mandrie.
Sembra incredibile ma, come riconosce Baykar Sivazliyan, nonostante i curdi fossero
stati pesantemente coinvolti nel genocidio degli armeni ‘Soltanto all’interno della
Repubblica Sovietica Socialista dell’Armenia la minoranza curda ha goduto di libertà
e di autonomia culturale’: secondo lo storico curdo questa pacifica convivenza
continuava ancora nel 2008 (anno in cui scriveva), a quasi vent’anni dal crollo
dell’URSS, mentre, come si è accennato nell’Introduzione, era stato nel contesto
sovietico che la storiografia curda aveva dato le sue prove migliori.
Fu in queste condizioni che i curdi, già decimati e immiseriti dalle devastazioni della
guerra, cominciarono a reagire alle discriminazioni ed alle persecuzioni con
sollevazioni e rivolte a testimoniare il tragico destino di questo popolo diviso,
oppresso, dimenticato e abbandonato.
Molto schematicamente si può comunque affermare che le condizioni dei curdi sono
state meno peggiori in Iran e tutto sommato anche in Siria piuttosto che in Iraq e in
Turchia.
I
In Iran i curdi ottennero risultati scarsi se non nulli: separati dal resto del loro
popolo, da secoli abitavano all’interno di un più che bimillenario stato col quale in
qualche modo avevano dovuto imparare a convivere e nel quale accettare meglio che
altrove la loro condizione di minoranza, senza dimenticare che avevano forti affinità
col ceppo etnico iraniano (a differenza che con quelli arabo e turco).
Negli anni Venti anche in Iran scoppiarono comunque rivolte che vennero però a
cessare nel 1930 in seguito al proditorio assassinio del loro leader Agha Simko,
sistema al quale il governo iraniano avrebbe più volte fatto ricorso (come nel 1989 e
nel 1992) dopo che anche la rivolta contro il nuovo regime di Khomeini era stata
stroncata nel 1981.
Al fallimento delle rivolte seguì il ritiro di coloro che erano meno disposti a
sottomettersi a Teheran nelle regioni isolate e montagnose ai confini coi Paesi in cui
vivevano le altre comunità curde (da cui vennero aiutati e soccorsi).
I curdi iraniani furono però spesso divisi fra loro ed anzi le varie fazioni si
affrontarono più volte in scontri anche sanguinosi.
II
In Siria (indipendente dalla Francia dal 1946) i curdi fino a pochissimi anni fa non
avevano mai ottenuto il posto e il rilievo che pur avrebbero meritato: essi erano
rimasti ai margini degli sviluppi politici generali e di quelli dei curdi stessi residenti
negli altri stati, così che si era parlato di loro solo a proposito di ciò che era avvenuto
nel Kurdistan irakeno o in quello turco.
Il motivo principale di questa assenza e di questo silenzio fu sicuramente la continuità
politica nella Siria di Hafiz al-Assad (alla guida del Paese dal 1970 dopo che nel 1963
il partito Baath era salito al potere) e il conseguente negazionismo dell’esistenza
16
stessa di un popolo particolare e diverso dei cui diritti ed esigenze ci si dimenticò e si
fece finta di niente.
I curdi siriani patirono in silenzio per gli stessi problemi e per le stesse vicissitudini
degli altri curdi: nemmeno i curdi siriani si videro riconoscere i loro diritti (dal 1960
nemmeno quello di cittadinanza) e accettare la loro identità e, oltre a ciò, corsero
addirittura il rischio di scomparire quando la famiglia degli al-Assad decise la
confisca delle terre curde e la loro redistribuzione alle popolazioni arabe nell’evidente
tentativo di ‘arabizzare’ l’intero Paese.
In particolare, nel 1962 iniziò la totale espulsione dei curdi da una striscia di territorio
profonda 15 km. lungo il confine con la Turchia e con l’Iraq e la loro dispersione:
queste deportazioni (e i massacri dei resistenti) avevano evidentemente il duplice
scopo di separare i curdi siriani dai loro connazionali d’oltreconfine ma anche fra loro
stessi visto che i deportati vennero ridistribuiti in tre aree intervallate da altre
popolate da arabi: si volle insomma annullare l’esistenza stessa dell’entità curda in
quanto tale mediante la sua divisione interna e il suo annullamento nella maggioranza
araba.
Eppure, nonostante tutto ciò, negli anni Settanta e Ottanta la Siria, a causa
dell’ostilità nei confronti della Turchia, ospitò e protesse il PKK, rivelando così
quanto la questione curda si intersecava e si inseriva nel più vasto, complicato e
contraddittorio panorama politico mediorientale.
In ogni caso, la (diciamo così) remissività dei curdi siriani era più apparente che
reale: in realtà il fuoco covò sotto la cenere per decenni finchè nel nuovo secolo
sarebbe divampato impetuoso.
III
In Iraq il mandato britannico stabilito dalla Società delle Nazioni il 25 aprile 1920
venne subito rifiutato dagli irakeni e lo scoppio di una rivolta anti-britannica nei mesi
immediatamente successivi costrinse gli inglesi a concedere la semi-indipendenza già
nel 1922: ai sensi di un apposito trattato anglo-irakeno la politica estera e militare
irakena rimaneva sotto lo stretto controllo di Londra che si riservava anche il diritto
di intervenire in altri campi ritenuti strategici, ma l’Iraq diventava una monarchia
retta da re Fayṣal al-Ḥusayn della dinastia degli Hashemiti.
Il 3 ottobre 1932, terminato ufficialmente il periodo di amministrazione britannica,
l’Iraq venne definitivamente riconosciuto indipendente, seppur ancora con forti
limitazioni in campo militare (comprese alcune basi aeree sotto esclusivo controllo
britannico) ed economico.
Era insomma sempre la stessa storia: i colonialisti (inglesi) cercavano (con successo)
in tutti i modi di conservare per sé il maggior numero di vantaggi possibile sia in
campo strategico-militare che economico, concedendo (come se avessero avuto tale
diritto) quel che non poteva più essere negato e che comunque non intaccava
seriamente i loro interessi.
Di tutto ciò erano ben consapevoli gli irakeni: l’indipendenza del 1932 non
soddisfece infatti la parte più attiva dell’opinione pubblica e della società che a causa
17
della persistente presenza britannica considerava (a ragione) il governo e i suoi
sostenitori asserviti e complici degli inglesi.
Dal 1936 al 1941 si susseguirono così due colpi di stato militari intesi non tanto ad
abolire la monarchia, quanto a porre fine alle pesanti ingerenze dell’Inghilterra: essi
però non ebbero successo.
Pur divisi e antagonisti fra loro, inglesi e irakeni erano però alleati e concordi nel
combattere i curdi che tentarono, a volte soli ed altre sostenuti dai loro connazionali
in Turchia e in Iran, di boicottare la nuova amministrazione e di ribellarsi per ottenere
l’indipendenza o almeno l’autonomia.
Tre furono i motivi che contribuirono a mantenere i curdi irakeni in uno stato di
rivolta quasi continua: 1) in Iraq i curdi costituivano una percentuale maggiore della
popolazione rispetto a quelli in Iran e in Siria; 2) l’artificiosità dell’Iraq (come della
Siria) nato unicamente per favorire gli interessi coloniali degli inglesi (e dei francesi);
3) la stessa popolazione araba era divisa fra sunniti e sciiti.
Se si considera che circa i 2/3 della produzione petrolifera dell’Iraq e buona parte
della terra fertile si trovavano nell’area abitata dai curdi si comprende facilmente
come i governi irakeni temessero il separatismo curdo, preludio, fra l’altro, di quello
sempre possibile fra sciiti e sunniti, cioè della dissoluzione dello stato.
Il primo a rivoltarsi fu lo sceicco Maḥmud di es-Suleimaniyyah che però,
pesantemente bombardato dalla RAF, dovette arrendersi già nello stesso 1923,
mentre le altre rivolte di rilievo furono quelle guidate dello sceicco Mustafa
Barzani, padre del Kurdistan irakeno, la prima delle quali scoppiò nel 1931 e fu
soffocata nel 1935.
A questo proposito è interessante e rivelatore seguire le vicende dell’avventurosa vita
di Barzani che, riparato in Iran, nel 1942 tornò in Iraq a continuare la sua battaglia
ma, nuovamente sconfitto, fuggì ancora una volta in Iran dove divenne ministro della
difesa della Repubblica di Mahabad quando quel territorio era sotto controllo
sovietico: nel 1946 in seguito al ritorno degli iraniani a Mahabad Barzani riparò
ancora una volta in Iraq per proseguire colà la rivoluzione curda alla guida del Partito
Democratico del Kurdistan (PDK) ma, sconfitto per la terza volta, trovò rifugio
nell’Azerbaijan sovietico e infine a Mosca (dove incontrò addirittura Stalin).
Nell’ambito dell’ampio processo di decolonizzazione del mondo arabo, anche gli
irakeni riuscirono finalmente a scrollarsi il giogo inglese: il 14 luglio 1958 un colpo
di stato del Comitato degli Ufficiali Liberi guidati dal generale Abdul Karim Kassem
fondò infatti la Repubblica Irakena e giustiziò sommariamente l’intera famiglia reale
hascemita accusata di connivenza e soggiacenza agli inglesi.
La condizione dei curdi tuttavia non migliorò ed anzi era destinata a peggiorare:
inizialmente Kassem tentò un riavvicinamento ai curdi tanto che invitò Barzani a
tornare in patria, ma le posizioni si dimostrarono subito inconciliabili.
Barzani chiese infatti molto più di quanto Kassem aveva immaginato, cioè la piena
autonomia delle regioni curde, e ancora una volta nel 1961 si arrivò allo scontro
armato: insomma: anche se il regime politico in Iraq era cambiato, non era però
cambiata la sua politica volta al dominio ed all’asservimento dei curdi.
18
Il nuovo regime nazionalista (e neutralista in politica estera) irakeno durò cinque anni
finchè l’8 febbraio 1963 un nuovo colpo di stato assassinò Kassem e portò al potere il
partito Baath, di ispirazione socialista, panaraba, sostenuto dall’Egitto di Nasser e
favorevole a un avvicinamento all’Unione Sovietica.
I tempi non erano però ancora maturi e il 18 novembre 1963 il regime del Baath
venne rovesciato da un ulteriore colpo di stato ad opera degli ex-sostenitori di
Kassem, finchè il 17 luglio 1968 il partito Baath tornò al potere con un ennesimo
colpo di stato, guidato questa volta dal generale Ahmad Hasan al-Bakr (parente di
Saddam Hussein).
Naturalmente anche il nuovo regime dovette affrontare la spinosa ed irrisolta
questione curda e nel marzo 1970 si giunse a un accordo di pace, fu proclamato il
cessate-il-fuoco per consentire l’avvio di negoziati e sembrò che una soluzione fosse
finalmente imminente: il governo irakeno riconobbe infatti l’etnia e la cultura del
popolo curdo e ne considerò la lingua come seconda lingua ufficiale della repubblica
assieme all’arabo mentre il vice-presidente Saddam Hussein offrì ai curdi
l’autonomia delle regioni settentrionali (seppur con alcune importanti eccezioni) e le
sottrasse al pieno controllo delle forze armate irakene.
Il movimento di Barzani conobbe allora la defezione di chi a questo punto accettò di
cooperare col regime di Bagdad ma, ancora una volta, si trattò di un’illusione che
durò lo spazio di un mattino perchè nel marzo 1974 i negoziati erano già falliti e lo
scontro armato ricominciò peggiore di prima.
IV
Dopo che Saddam Hussein si era accordato con lo scià dell’Iran perché nessuno dei
due fornisse sostegno ai curdi dell’altro, quella del 1974-75 fu una vera e propria
guerra e Saddam Hussein fece le cose in grande non si limitandosi alla ‘semplice’
controguerriglia ma ricorrendo ai bombardamenti a tappeto, al napalm, ai gas nervini,
alla chiusura di territori mentre i combattenti curdi, i peshmerga (‘avanguardia della
morte’), ricorsero disperatamente a tutte le armi a loro disposizione, compreso il
blocco del passaggio del greggio: era questa una misura assai efficace dato che il
petrolio era (ed è) la risorsa fondamentale del Paese, ma la sproporzione delle forze in
campo era tale che i curdi – al solito soli contro tutti – non poterono che essere
sconfitti.
Mentre il posto di Mustafa Barzani veniva preso dal figlio Massud, la sconfitta
provocò la scissione del PDK a causa della fuoruscita di intellettuali e di attivisti che,
sotto la guida di Jalal Talabani, il 1 giugno 1975 fondarono l’Unione Patriottica del
Kurdistan (UPK).
Intanto Saddam Hussein volle risolvere il problema dell’insorgenza curda alla radice:
dopo che già dagli anni Sessanta era iniziata l’arabizzazione della regione di Kirkuk
(ricca di giacimenti) con la deportazione di 40mila curdi e il suo ripopolamento con
arabi, il 21 luglio1976 il rais rese noto il progetto di impedire la possibilità di
qualsiasi contatto fra i curdi irakeni e quelli al di là dei confini.
19
Fu così che – come ci informa Sivazlijan – ‘lungo una fascia di confine profonda
oltre 20 km su di un’area grande circa tre volte il Libano, sono stati distrutti dai
bulldozer 1500 villaggi, fatte esplodere e chiuse col cemento le sorgenti, bruciate con
agenti chimici foreste e coltivazioni. I deportati sono stati dispersi a piccoli gruppi in
villaggi arabi o raccolti in gran numero in ‘villaggi strategici’, in pratica campi di
concentramento appositamente costruiti e sorvegliati da forze speciali.’
V
Mentre l’operazione era ancora in corso il 22 settembre 1980 Saddam Hussein invase
improvvisamente l’Iran (dov’era appena avvenuta la rivoluzione komeinista)
scatenando una guerra sanguinosa che sarebbe durata ben otto anni e che sarebbe
terminata senza né vinti né vincitori solo nell’agosto 1988.
I curdi colsero l’inattesa occasione per ribellarsi ancora una volta ma subirono la
terribile ritorsione del tiranno che non esitò a ricorrere a politiche apertamente
genocide: dal 1986 al 1989 (con un picco nel 1988) su ordine di Saddam venne
scatenata l’operazione ‘Anfal’ durante la quale furono rasi al suolo 5mila villaggi
curdi e l’esercito irakeno fece ricorso a tutte le armi di sterminio di massa di cui
disponeva.
Secondo lo Human Rights Watch questo vero e proprio genocidio dei curdi irakeni
costò circa 100mila vittime.
Tragico episodio ed esempio della strategia irakena si verificò il 16 marzo 1988
quando la città di Halabja venne bombardata con gas al cianuro che fecero strage
degli abitanti (5mila morirono subito ma ad essi vanno aggiunti tutti quelli che
sarebbero periti in seguito all’intossicazione).
Il 1 marzo 2010 la Suprema Corte dell’Iraq avrebbe definito ‘genocidio’ il
raccapricciante episodio, in realtà culmine degli anni del terrore sterminatore che
evidentemente era stato ritenuto il solo mezzo per risolvere il problema curdo:
finalmente l’opinione pubblica internazionale aveva però preso atto e coscienza del
dramma di questo popolo diviso e dimenticato, calpestato e violentato, così che
(come si vedrà) nel 1991, dopo la sconfitta di Saddam nella nuova guerra che avrebbe
presto scatenato, sarebbero state adottate misure per sottrarlo alla sua follia omicida.
VI
In Turchia, dove viveva la maggior percentuale della popolazione curda, dopo
Losanna le rivolte scoppiarono subito intense: qui i capi curdi insistettero
particolarmente sul sentimento religioso offeso e scandalizzato dal deciso laicismo
del governo di Ankara che aveva definitivamente deposto il sultano e abolito il
califfato (la guida di tutti i musulmani sunniti) spingendo vigorosamente la Turchia
sulla via dell’occidentalizzazione.
Già nel febbraio 1925 i curdi si sollevarono così in tutti i vilayet orientali ma
resistettero solo per alcuni mesi: nel maggio la rivolta era ormai domata e i suoi capi
arrestati e condannati a morte.
20
Una seconda rivolta scoppiata nel 1927 obbligò il governo turco a nuove spedizioni
militari e rese necessario aprire trattative con l’Iran per una chiara definizione dei
confini che si conclusero col trattato turco-iraniano del 23 gennaio 1932: il motivo e
la convenienza dei due stati all’accordo era evidentemente la volontà di tener ben
separati i rispettivi curdi fra loro.
Una terza rivolta (1936-38) finì infine con la disfatta curda come le due precedenti.
Tutto cospirava a rendere difficile se non impossibile l’intesa fra turchi e curdi:
l’accentuato nazionalismo turco non poteva tollerare il particolarismo curdo e
intendeva soffocarlo mentre la sua spiccata politica di occidentalizzazione non poteva
che urtarsi frontalmente col sistema di privilegi e di tradizioni feudali che il tollerante
impero ottomano aveva lasciato sussistere ed al quale i curdi erano legati e abituati e
che volevano mantenere.
Anche se alcune tribù curde avevano collaborato col governo turco nello schiacciare i
rivoltosi e se altre si erano mantenute neutrali, il programma di sviluppo occidentale
dei turchi si scontrava insomma col retaggio medievale (o quasi) dei curdi, il laicismo
turco colla religiosità curda, l’accentramento turco col separatismo curdo, in
definitiva l’identità stessa della nuova Turchia con quella curda.
Per risolvere il problema alla radice una legge del 1932 decise la deportazione e la
dispersione dei curdi lontano dal loro territorio: nel tempo si moltiplicarono poi gli
ordinamenti atti a (diciamo così) facilitare l’assimilazione dei curdi rimasti nelle
originarie province orientali anche mediante la turchizzazione dei nomi di persone,
paesi, città, fiumi, montagne, ecc. curdi.
VII
Ma i curdi non desistettero mai e ancor oggi combattono per il riconoscimento del
loro diritto di autodeterminazione: la lotta anzi si intensificò da quando il 27
novembre 1978 Abdullah (Apo) Ocalan fondò il Partito del Lavoratori del
Kurdistan (PKK) che, opponendosi ai gruppi curdi favorevoli a trovare forme di
dialogo con il governo di Ankara, al contrario intese agire in senso rivoluzionario e
lottare con le armi in pugno per l’indipendenza.
Il 24 dicembre 1978 lo stato turco rispose con la proclamazione della legge marziale
in tutto il Kurdistan turco mentre in seguito al colpo di stato militare del 12 settembre
1980 venne avviata una vera e propria campagna di terrore e la conseguente
costituzione del 1982 adottò poi tutta una serie di misure (come il divieto di scrivere
e di parlare in curdo) volte a cancellare l’identità curda stessa.
Rifacendosi alla pratica ottomana di considerare i sudditi a seconda solo della loro
religione e al trattato di Losanna che non aveva riconosciuto l’etnia curda, la
costituzione del 1982 continuò a negarla arrivando ad affermare che l’approccio
politico fondato sulla razza era stato una vergogna del secolo: sostenere la diversità
dell’identità curda venne considerato un reato volto a minare l’integrità dello stato.
Dal punto di vista militare la tattica del governo turco nei confronti dei guerriglieri
curdi fu poi la solita: fare il vuoto intorno a loro evacuando villaggi, diffondendo il
terrore e perseguitando insomma i civili.
21
Il governo di Ankara si impegnò con la forza e l’oppressione in un complesso e
spietato programma di assimilazione dell’elemento curdo al nuovo regime che
Sivazliyan descrive sinteticamente ma efficacemente: ‘ogni resistenza armata contro
le brutalità del regime venne repressa con stragi di civili. L’affermare di essere curdo,
il pronunciare la parola Kurdistan, farsi sentire a parlare curdo costituisce tuttora
[2008]e per chiunque – non solo per i Curdi – reato di separatismo. Dal 1925 al 1965
il Kurdistan è stato zona militare proibita agli stranieri. In seguito, dopo le repressioni
feroci dei movimenti politici, sindacali, culturali degli anni Settanta e la costituzione
di speciali reparti anti-curdi addestrati al più spietato razzismo, dal golpe militare del
1980 il Kurdistan è rimasto continuamente sotto assedio militare. Nelle zone della
terra curda sono stanziati due terzi dell’agguerritissimo esercito turco; si compiono
rastrellamenti e arresti di massa. Nel 1981 è iniziata l’evacuazione dei villaggi più
remoti, ai confini con Iran, Iraq e Siria per spezzare i contatti tra i Curdi attraverso le
frontiere. La deportazione e la dispersione degli abitanti e in particolare la sistematica
evacuazione delle aree di frontiera sono un dato comune del genocidio in atto da
ottant’anni nei confronti della popolazione curda.’
Michael M. Gunter nel 2010 potè così concludere che ‘più della metà della
popolazione di etnia curda della Turchia non vive … nella sua terra natale nel sud-est
dell’Anatolia ma è sparpagliata per tutto il paese’ mentre ‘un considerevole numero
di curdi turchi è stato quasi completamente assimilato nella più vasta identità civica
turca.’
Per giustificare in qualche modo questa repressione il governo turco fece ricorso a
tutti i mezzi, come spiega ancora Gunter: ‘la cosiddetta Teoria del Sole insegnava che
tutte le lingue derivano da una originaria lingua turca primigenia in Asia centrale.
Isolati nelle roccaforti montane dell’Anatolia, i curdi avevano semplicemente
dimenticato la loro madrelingua. Il molto abusato e criticato appellativo di ‘Turchi
della montagna’ quando ci si riferiva ai curdi turchi serviva da termine codificato per
queste azioni. Qualsiasi cosa che ricordava una identità curda separata doveva essere
abolita: lingua, abbigliamento, nomi, e così via.’
I racconti degli esuli (presenti soprattutto i Germania ma anche in altri Paesi europei
fra cui l’Italia) e dei sopravvissuti parlano di un’orribile sequenza di brutalità, di
prevaricazioni, di soprusi e soprattutto di violenze (anche gratuite) gravissime, volte a
terrorizzare e a spersonalizzare la popolazione quando, naturalmente, a non ucciderla.
I dirigenti del PKK dovettero fuggire all’estero ma al loro secondo congresso (agosto
1982) decisero di tornare e di riprendere la lotta armata: vennero così organizzate le
Unità di Liberazione del Kurdistan (HRK) e il 21 marzo 1985 fu fondato il Fronte di
Liberazione Nazionale del Kurdistan (ERNK).
La mobilitazione dei curdi della Turchia si sviluppò anche attraverso l’attività in
Parlamento e nel Paese di partiti legali (come il Partito della Democrazia del Popolo),
ma fu il PKK a tenere banco e lo scontro armato fu aperto e senza esclusione di colpi:
nel 1984 il PKK lanciò l’insurrezione cui il governo turco rispose dichiarando il PKK
un’associazione terroristica (alla fine del secolo si parlò di circa 40mila morti), con
3mila villaggi distrutti o devastati e 3 milioni di persone deportate e ricollocate in
zone giudicate ‘sicure’.
22
Uno scontro così aspro coinvolse naturalmente anche i curdi negli altri Paesi e i loro
governi: i curdi del PKK poterono così trovare appoggi e riparo soprattutto in Siria
(per la sua ostilità nei confronti della Turchia) ma le pressioni turche e la minaccia di
una guerra alla fine costrinsero il governo di Damasco a cessare ogni sostegno al
PKK e il 9 ottobre 1998 anche Ocalan dovette lasciare il Paese.
Rifiutato da Mosca, allontanato dall’Italia, transitato in Grecia, arrivato in Kenya
(invece che nel promesso Sudafrica di Mandela) il 16 febbraio 1999 Ocalan fu infine
rapito dai turchi e imprigionato nel carcere sull’isolotto di Imrali al largo di Istanbul.
Nascita del Kurdistan irakeno
In Iraq il confronto e la guerra fra i curdi e il regime di Saddam Hussein si
modificarono profondamente in seguito a quella che passò alla storia come la prima
guerra del Golfo (vedi il mio ‘Guerre USA’ – parte quarta).
Il 2 agosto 1990 l’Iraq di Saddam Hussein invase improvvisamente il piccolo ed
indifeso Kuwait (ricchissimo di petrolio), primo passo per la conquista e per
l’occupazione dell’Arabia Saudita (gli irakeni arrivarono ad un kilometro dal confine)
e degli Emirati del Golfo: era evidente che con questa mossa Saddam Hussein
intendeva unificare l’intera area così ricca di petrolio, lanciare una campagna per la
riscossa del mondo arabo e muovere in modo finalmente risolutivo contro Israele.
Mentre l’URSS boccheggiava negli ultimi spasmi della sua esistenza e non poteva
intervenire, fu così la reazione americana ad essere quella decisiva: l’Iraq (la cui
economia dipendeva quasi esclusivamente dalle esportazioni di petrolio) venne
immediatamente sigillato da un blocco aereo, navale e commerciale mentre prese
subito il via l’operazione ‘Desert Shield’.
Forze americane accorsero rapidissime in difesa ed a protezione dell’Arabia Saudita
(con 500 testate atomiche contro l’eventuale uso di armi chimiche da parte degli
irakeni!) dando prova di un’organizzazione logistica che stupì il mondo: il presidente
Bush (1989-93) mise poi in piedi la più vasta coalizione dai tempi della seconda
guerra mondiale e ben 34 stati (Arabia Saudita, Inghilterra ed Egitto principali alleati)
si unirono agli USA contro l’Iraq.
Dopo che l’Iraq non si era piegato all’ultimatum del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
(che aveva autorizzato anche l’uso della forza contro l’aggressore) perchè
abbandonasse il Kuwait entro il 15 gennaio 1991, il 17 iniziarono i bombardamenti
(1500 al giorno! Il più violento bombardamento della storia!) dell’operazione ‘Desert
Storm’: nonostante le paurose devastazioni e il fatto che nelle capitali arabe in pochi
ora manifestassero in suo favore, Saddam Hussein tentò però di non arrendersi e di
non ritirarsi dal Kuwait ma dovette infine prendere atto dell’impossibilità di resistere
e della necessità di negoziare la resa.
Saddam Hussein non fu però rovesciato ed anzi, rimasto al suo posto più forte che
mai, subito potè soffocare nel sangue la ribellione contro il suo regime scoppiata nel
sud e soprattutto la sollevazione dei curdi nel nord: i ribelli avevano confidato e
23
creduto alle promesse di liberazione degli alleati ma questi quando non ebbero più
bisogno di loro li abbandonarono al loro triste destino.
Contro i rivoltosi Saddam Hussein fu addirittura autorizzato ad usare gli elicotteri dai
quali sganciò bombe ed armi chimiche sulle folle.
In realtà gli Stati Uniti non poterono andare oltre la liberazione del Kuwait ed il
divieto all’Iraq di costruire o comunque di dotarsi di armi di distruzione di massa
perché il crollo del regime di Saddam Hussein avrebbe provocato problemi troppo
gravi in un Paese in cui la maggioranza della popolazione era sciita e nel cui nord-est
era presente una forte componente curda.
Ecco perché dopo la liberazione del Kuwait la macchina bellica irakena non venne
distrutta e Saddam Hussein venne lasciato al suo posto, libero ed indisturbato di
schiacciare senza pietà chi si era levato contro di lui: tutto quello che fu fatto per
quelle povere genti fu l’imposizione all’Iraq di due ‘no fly zones’ a sud del 33°
parallelo (aree abitate principalmente da sciiti) e a nord del 36° (territori abitati dai
curdi), garantite dalle aviazioni di USA e di Inghilterra ospitate nelle nuove basi
americane costruite nei paesi confinanti.
Fu comunque proprio questa limitata e tardiva misura a segnare l’inizio di una
nuova stagione per i curdi irakeni: la risoluzione 688 dell’ONU (5 aprile 1991)
condannò infatti ‘la repressione della popolazione civile irakena … nelle aree
popolate da curdi’ e chiese ‘che l’Iraq … cessasse immediatamente questa
repressione’.
Fu un’iniziativa importante perché, a differenza del silenzio di fronte ai massacri del
1988, questa volta la comunità internazionale per la prima volta prendeva atto della
questione curda e vi faceva finalmente esplicito riferimento.
Da questo momento per i curdi gli eventi cominciarono a marciare per il verso giusto:
nel settembre 1998 gli USA riuscirono a far cessare l’insensata guerra civile (!!!) fra
PDK e UPK (le rivalità interne sono sempre state una delle maledizioni dei curdi) e ai
curdi venne destinato il 13% dei proventi petroliferi del Paese (seppur limitatamente,
dal 1995 l’Iraq aveva potuto ricominciare a vendere il proprio greggio).
Sotto l’ombrello protettivo dell’aviazione anglo-americana nel Kurdistan irakeno
pace, una certa prosperità e democrazia sbocciarono come fiori nel deserto dopo la
pioggia e la regione divenne sempre più autonoma e praticamente una nazione, tanto
che nell’ottobre 2002 il suo Parlamento dichiarò che quando Saddam Hussein fosse
caduto il Kurdistan irakeno sarebbe diventato uno stato federato dell’Iraq.
E Saddam Hussein sarebbe caduto molto presto.
I
Sull’onda della profondissima emozione degli attentati dell’11 settembre 2001 e dopo
aver invaso l’Afghanistan, il presidente americano George W. Bush (2001-09) pensò
infatti che fosse arrivato il momento di chiudere definitivamente i conti anche con
Saddam Hussein (vedi il mio ‘Guerre USA’ – parte quarta).
Il 20 marzo 2003 con la missione ‘Iraqi Freedom’ una coalizione internazionale
guidata dagli Stati Uniti aggredì e invase l’Iraq e le sue forze, coadiuvate dalle milizie
24
curde, in pochissimo tempo riuscirono ad abbattere il regime di Saddam Hussein: già
il 9 aprile i 260mila soldati inviati da Washington entrarono a Bagdad costringendo
alla fuga il rais ed i suoi uomini e il giorno dopo i curdi entrarono a Kirkuk, capitale
dell’omonima regione, largamente curda e ricca di giacimenti petroliferi.
Il 1 maggio 2003 il presidente Bush potè così dichiarare che la guerra era stata vinta e
che la missione era stata compiuta, ma l’ottimismo ed il trionfalismo dei primi giorni
furono presto smentiti dal disfacimento del Paese in balia di ogni forma di violenza e
dei continui attacchi alle truppe alleate: com’era stato fin troppo facilmente previsto,
l’Iraq, che era una congerie di fazioni (religiose e non) e di etnie, privo del pugno di
ferro di Saddam Hussein si stava disgregando nel caos.
Insomma: conseguenza immediata dell’invasione, della demolizione dell’apparato
statale e dello scioglimento dell’esercito irakeno fu lo scatenamento di una micidiale
guerra civile in quasi tutto il Paese.
Saddam Hussein aveva imposto all’Iraq l’ideologia laica, nazionalista e con tendenze
socialiste del partito Baath, ma in realtà la società irakena era ancora percorsa da
divisioni etniche, religiose e soprattutto tribali: il regime aveva sfruttato queste
divisioni ed aveva favorito grandemente la minoranza sunnita (circa il 25% della
popolazione) e specialmente i clan originari della regione di Tikrit, città natale di
Saddam Hussein stesso, a tutto svantaggio degli sciiti (oltre il 50%) e dei curdi (circa
il 20%), ma adesso che le divisioni potevano emergere e che iniziava la lotta per le
risorse (il petrolio si trovava soprattutto nel nord curdo e nel sud sciita) era l’Iraq
stesso che si stava sfasciando.
Sotto l’egida americana il 30 gennaio 2005 venne comunque eletta un’Assemblea
Costituente: vinse ovviamente l’Alleanza Nazionale Irachena (un’alleanza di 22
partiti confessionali sciiti) col 48% dei voti, l’Alleanza Democratica Patriottica del
Kurdistan (che aveva finalmente raccolto tutti i partiti curdi in un’unica lista) arrivò
seconda con il 26% dei voti mentre la Lista Irakena (sunnita) giunse solo terza col
14% dei voti.
La nuova costituzione, approvata con la schiacciante maggioranza del 79% dei
votanti nel referendum popolare del 15 ottobre 2005 (in pratica solo gli spodestati
sunniti votarono contro), pur insistendo sul ruolo dell’Islam (non si potevano fare
leggi contrarie ad esso), concedeva però ampie autonomie alle singole province alle
quali era permesso aggregarsi per costituire confederazioni regionali, veri e propri
microregni dotati di ampi poteri.
Fu in questa situazione e ai sensi della nuova costituzione che i curdi irakeni si videro
riconoscere numerosi diritti e soprattutto un’ampia autonomia gestita dal vero e
proprio governo del Kurdistan irakeno (formato dalle province di Dohuk, Arbil e
Sulaimaniya) con capitale Arbil.
Era una speranza storica che cominciava a prendere forma: almeno in Iraq tanti
soprusi, tanti sacrifici, tante sofferenze, tante ingiustizie patite per tanto tempo
sembravano essere finite.
Subito si stabilì l’alleanza fra le vittime di Saddam Hussein, sciiti e curdi, che diede
luogo ad un governo di coalizione nazionale in cui i curdi ottennero un grande rilievo
(Talabani divenne presidente dell’Iraq) conseguendo vittorie impensabili fino a
25
pochissimo tempo prima, come il veto curdo ad ogni futuro cambiamento
costituzionale, la limitazione del ruolo dell’Islam, i diritti delle donne e il divieto
dello stazionamento di truppe arabe nel Kurdistan e a Kirkuk.
Il 15 dicembre 2005 si tennero poi le elezioni per l’Assemblea Nazionale Irachena
che non alterarono i rapporti di forza: le trattative per il nuovo governo furono però
laboriose e solo nel maggio 2006 lo sciita Nouri al-Maliki fu nominato capo di
governo e Talabani capo di stato.
Ancora una volta i perdenti furono i minoritari sunniti, concentrati nei quattro
governatorati della fascia centrale meno fertile e molto meno ricca di petrolio del
Paese, mentre gli sciiti erano presenti nei nove governatorati del sud e i curdi nei tre
(più quello di Kirkuk) del nord.
Questo squilibrio presto avrebbe prodotto effetti nefasti, ma intanto si cercò di porvi
rimedio con una distribuzione condivisa dei proventi delle risorse naturali come
riconosciuto dall’art. 25 della Legge Amministrativa Transnazionale secondo cui ‘le
risorse naturali dell’Iraq … appartengono a tutto il popolo, di tutte le regioni e di tutti
i governatorati dell’Iraq’ e dall’art.111 della costituzione secondo cui i proventi del
petrolio e del gas andavano assegnati ‘in proporzione alla distribuzione della
popolazione in tutte le parti del paese’.
II
Nel nuovo Iraq federale i curdi avevano ottenuto tutto quel che avevano voluto, visto
che la piena indipendenza non era possibile (ci sarebbe voluto il consenso di tutti i
Paesi della regione oltre a quello degli USA) e forse nemmeno opportuna perché il
regime federale impediva o comunque rendeva più difficili le devastanti lotte
fratricide interne mentre una sempre possibile invasione del Kurdistan irakeno (che i
75mila peshmerga non avrebbero potuto fermare) sarebbe stata l’invasione dell’intero
Iraq.
Soprattutto però, il sistema federale (e l’esclusione dei sunniti dal potere) permetteva
ai curdi di giocare contemporaneamente su due tavoli: da una parte erano infatti
padroni del Kurdistan irakeno (dove Massud Barzani, figlio di Mustafa e leader del
PDK, nel luglio del 2009 venne rieletto capo del governo col 66% dei voti) e
dall’altra esercitavano un ruolo di primo piano nell’Iraq stesso dove occupavano
numerose cariche politiche di primo e primissimo piano che mantennero anche nel
secondo governo al-Maliki seguito alle elezioni del marzo 2010.
Il Kurdistan irakeno presto fiorì anche economicamente: la pace interna e le cospicue
risorse attrassero numerosi capitali stranieri (per i quali venne adottata una
legislazione di favore) e in poco tempo la regione si arricchì e si sviluppò a ritmi
inimmaginabili fino a pochissimo tempo prima, tanto da diventare una sorta di
‘California mesopotamica’ che, di fatto vietata agli arabi, estraeva solo ad Arbil
250mila barili di petrolio al giorno i cui contratti ormai non passavano più per
Bagdad.
In un clima e in una congiuntura così favorevole anche lo spinoso problema di
Kirkuk trovò la sua soluzione.
26
La politica di arabizzazione della regione operata in passato da Saddam Hussein
aveva prodotto una popolazione mista di curdi, arabi e turkmeni: dopo la sua caduta
si procedette così al reintegro dei curdi deportati e al ritorno degli arabi nei loro
luoghi di origine.
Kirkuk divenne insomma curda di fatto anche se non ancora ufficialmente, senza
pubblicità e senza ostentazione, esattamente come l’indipendenza del Kurdistan
irakeno che non veniva proclamata ma che non per questo era meno effettiva e
riempiva di orgoglio i curdi che si sentivano invincibili dietro lo scudo dei loro
peshmerga.
Il Kurdistan irakeno riuscì a mantenersi in equilibrio in numerosi settori (governo
regionale – governo centrale, con la Turchia, con gli USA, col soverchiante seppur
diviso mondo arabo, fra i due maggiori partiti curdi, uniti in un’unica lista ma pur
sempre attivi e rivali) mentre naturalmente anche qui sorsero problemi sociali e
generazionali e fecero la loro comparsa perfino piccoli partiti islamisti.
III
Del tutto sorprendente fu infine l’atteggiamento della Turchia che apparentemente
avrebbe avuto tutto da perdere dal contagio secessionista di un Kurdistan irakeno ai
suoi confini mentre invece non solo accettò di buon grado la formazione di uno stato
curdo-irakeno di fatto indipendente, ma vi permise e vi favorì massicci investimenti
turchi (che col loro 56% sul totale superavano evidentemente quelli di tutti gli altri
Paesi messi insieme) mentre il petrolio curdo era commercializzato dalla stessa
Turchia attraverso un apposito oleodotto.
L’atteggiamento amichevole della Turchia fu evidente e manifesto in svariate
occasioni, come ad esempio la presenza del premier turco Erdogan all’inaugurazione
del nuovo aeroporto di Arbil a fianco di Barzani: la Turchia guardava favorevolmente
al Kurdistan irakeno anche perché i suoi leaders erano ben attenti a non fomentare le
rivendicazioni dei curdi turchi e ispiravano insomma sicurezza e responsabilità.
Il comportamento così inaspettato della Turchia trovò poi riscontro nella complessa
fase politico-diplomatica in cui essa era allora impegnata coi ‘suoi’ curdi.
I curdi in Turchia fra kemalisti e l’AKP
Paradossalmente il problema curdo in Turchia, apparentemente insolubile, sembrò
invece aver trovato una via d’uscita proprio in seguito alla cattura di Ocalan.
Ocalan era stato il leader curdo che più di ogni altro aveva dato al suo popolo fiducia
e stima in se stesso (notevoli e scioccanti erano state le manifestazioni di affetto e di
sostegno degli esuli curdi in Italia nel periodo in cui egli vi era transitato) ma per i
turchi (che invece avevano protestato sconcertati per la sua accoglienza) era a capo di
un’organizzazione terroristica (giudicata tale anche da tutto l’Occidente) volta a
distruggere l’integrità territoriale della Turchia con metodi, appunto, terroristici:
amareggiatissimo, dopo la cattura del suo capo il PKK si era così abbandonato a una
27
serie di violenze in patria e in Europa mentre le elezioni turche del 18 aprile 1999
avevano portato al governo l’ultra-nazionalista Bulent Ecevit ma, mentre la
situazione sembrava destinata a degenerare in un’ulteriore scontro di eccezionale
violenza, fu lo stesso Ocalan a invertire le drammatiche aspettative.
Fin dal momento del suo arresto Ocalan cominciò infatti a esprimere il suo amore
sincero per la Turchia e la sua convinzione che il problema curdo poteva e doveva
essere risolto solo con sistemi pacifici e democratici all’interno di una Turchia unita e
indipendente: ordinò così ai suoi seguaci di cessare ogni violenza dal 1 settembre
1999 e di ritirarsi fuori dai confini turchi - e l’ordine venne eseguito immediatamente.
La sua inaspettata iniziativa trovò subito echi favorevoli da parte turca tanto che nel
settembre 1999 Sami Selcuk, presidente della Suprema Corte d’Appello Turca,
dichiarò che la costituzione del 1982 era illegittima perché dettata dai militari
(golpisti) e che andava emendata, mentre Ahmet Necdet Sezer, presidente della Corte
Costituzionale Turca, si pronunciò a favore di tutta una serie di libertà e di
riconoscimenti dei diritti dei curdi e della loro cultura e anche lui chiese una revisione
della costituzione.
Per parte sua, il PKK dichiarò che il popolo curdo era ‘pronto a vivere con orgoglio
in una Turchia’ disegnata secondo questo profilo mentre il presidente turco stesso,
Suleiman Demirel, incontrò ufficialmente sette sindaci dell’HADEP, il partito legale
curdo (fondato nel 1994).
In realtà lo stupefacente cambiamento di prospettiva di Ocalan era frutto di una lenta
maturazione che – indubbiamente anche in seguito alla fine della guerra fredda l’aveva fatto transitare dalla lotta armata (o terroristica) alla convinzione che una
pacifica e democratica convivenza dei turchi e dei curdi in un unico stato era la
soluzione migliore per tutti: secondo lui a soffrire della mancanza di democrazia e di
giustizia non erano solo i curdi, ma anche i turchi, e rimase fermo su questa posizione
anche dopo la condanna a morte con cui il 29 giugno 1999 si concluse il processo a
suo carico.
Ocalan si spinse a sostenere che era stato un errore combattere contro il vasto
programma modernizzatore di Ataturk (che – affermò - se fosse vivo sarebbe
d’accordo con lui), che lo stesso esercito turco doveva tornare ad essere il protettore
della democrazia e che i metodi militari del PKK erano giustificati dal tradimento del
programma originario della Repubblica Turca: Gunter testimonia che questa
posizione era già stata espressa da Ocalan nell’intervista che questi gli aveva
rilasciato nel marzo 1998.
Sembrava che tutte le tessere del problema cominciassero finalmente a trovare una
loro composizione e il 12 gennaio 2000 la condanna a morte di Ocalan venne
sospesa, provvedimento che il PKK non esitò a definire ‘decisione del secolo’.
Al suo settimo congresso straordinario (2-23 gennaio 2000) il PKK varò un suo
Progetto di Pace che fra l’altro prevedeva la possibilità dei curdi di tornare ai propri
villaggi, la fine delle misure d’emergenza, lo scioglimento dei guardiani (composti da
curdi collaborazionisti!) dei villaggi, un libero sistema elettorale, la liberazione di
Ocalan e infine investimenti economici nel disastrato ed abbandonato sud-est del
Paese.
28
Nonostante le forti resistenze da parte dei militari turchi che avevano puntato per un
secondo mandato di Demirel, nondimeno nel maggio 2000 venne eletto alla
presidenza della repubblica proprio il summenzionato Sezer e sembrava insomma che
il sistema politico turco si stesse svincolando dall’abbraccio dei generali, esattamente
come chiedeva la UE che insisteva che in un sistema democratico i militari devono
dipendere dal potere politico e non viceversa.
I
Oltre al cambio di strategia di Ocalan e del PKK, alla risposta cautamente positiva
delle autorità turche e (come si vedrà) all’apertura delle (difficili) trattative per
l’ingresso della Turchia nella UE, un ulteriore fattore sembrò spingere verso una
soluzione del terribile problema dei curdi in Turchia: mentre nel 2002 la condanna di
Ocalan veniva definitivamente trasformata in carcere a vita e le prime leggi per
armonizzare il Paese agli standard europei cominciavano ad essere votate, nel
novembre 2002 il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) vinse nettamente le
elezioni.
Fondato il 14 agosto 2001 sulle ceneri di vari partiti islamisti e guidato dall’abile e
deciso Recep Tayyip Erdogan, l’AKP si presentò come un partito islamista ma
rispettoso della laicità dello stato, liberale in economia e moderatamente nazionalista
anche se fin da subito venne sospettato di avere in realtà una ‘agenda nascosta’ con
un ben diverso programma: l’AKP era comunque del tutto favorevole all’ingresso
della Turchia nella UE, quindi riformatore e filo-occidentale (mentre kemalisti e
militari assunsero un atteggiamento del tutto opposto), e l’anno seguente rifiutò di
intervenire al fianco degli USA nella seconda guerra del Golfo.
Mentre i curdi turchi erano - al solito - ancora divisi fra loro e alcune formazioni
politiche avevano ripreso la lotta armata, Erdogan prese il toro per le corna e
nell’agosto 2005 non esitò a dichiarare che la Turchia aveva ‘un problema curdo’,
che in passato aveva compiuto ‘gravi errori’ e che ora aveva bisogno di ‘più
democrazia per risolvere il problema’.
Nonostante tante difficoltà, l’AKP sembrò davvero rispondere ai bisogni della società
turca quando nel luglio 2007 non solo vinse nuovamente le elezioni con una
maggioranza ancor più vasta della precedente, ma nelle aree curde del sud-est ottenne
il 52% dei consensi (!) perché la popolazione apprezzava le misure a sostegno
dell’economia e l’orientamento religioso del partito: entrarono così in Parlamento
deputati curdi più un’altra ventina di indipendenti del DTP, il pro-curdo Partito della
Società Democratica.
Il maggior ostacolo al programma dell’AKP veniva però dalle resistenze e
dell’attività del cosiddetto ‘stato profondo’.
II
Secondo Gunter ‘non è possibile definire precisamente’ lo ‘stato profondo’ turco, ma
comunque, nato ai tempi di Gladio e da allora notevolmente cresciuto, sarebbe ancor
29
oggi ‘composto da elementi [provenienti] dall’establishment militare, della sicurezza
e giudiziario uniti da un’ideologia fieramente nazionalistica e statalista che, se
necessario, sono pronti a bloccare o addirittura rimuovere un governo che non
condividesse la loro visione’: questa penetrante, sfuggente ma diffusa struttura
sotterranea (ma non troppo) secondo Gunter condizionerebbe e imporrebbe le sue
scelte ai governanti eletti, vigilerebbe costantemente sul loro operato, ricorrerebbe a
ogni mezzo (anche illegale) per affermare la sua volontà, convinta (a ragione) che, se
pur scoperti, i responsabili materiali di attività criminali compiute per motivi politici
dello ‘stato profondo’ eviterebbero la punizione che pure spetterebbe loro per legge.
Con lo ‘stato profondo’ ha sempre collaborato infatti la miriade di gruppi, di partitini
di estrema destra e di semplici criminali che si sono macchiati dei peggiori delitti ma
che sono sempre stati assolti o liberati nei pochi casi in cui erano stati arrestati: la
complessità e varietà di questi rapporti è comunque molto varia e mutevole.
Nei confronti dei curdi gli attivisti dello ‘stato profondo’ hanno sempre potuto agire
impuniti e con grande crudeltà.
Dopo aver affermato che lo ‘stato profondo’ sono i militari, Suleyman Demirel, più
volte primo ministro e anche presidente della repubblica, dichiarò che in Turchia ‘ci
sono due stati. C’è lo stato e c’è lo stato profondo … In caso di difficoltà anche
piccola lo stato civile si fa da parte e lo stato profondo prende le decisioni’.
Il generale Kenan Evren, alla testa del colpo di stato del 1980 e presidente della
repubblica dal 1982 concordò: ‘Demirel dice la verità. Quando lo stato si indebolisce
noi [i militari] lo sostituiamo. Noi siamo lo stato profondo’.
Questo inquietante ed impalpabile organismo è composto in realtà di molteplici
branche e apparati: nel 1961 (dopo il colpo di stato militare dell’anno precedente) in
qualche modo si era istituzionalizzato nel Consiglio per la Sicurezza Nazionale
(MGK) che, composto da dieci membri fra cui i massimi dirigenti nazionali e
controllato dai militari (fin dai tempi di Ataturk i custodi dello stato nazionalista e
della sua laicità), ebbe il ruolo di consulente e consigliere dei governi.
Dopo il colpo di stato militare del 1970 le indicazioni del MGK al governo erano
diventate vincolanti e dopo quello del 1980 i suoi poteri si erano vieppiù accresciuti
finchè negli anni Novanta il MGK ebbe direttamente nelle sue mani l’intero settore
della sicurezza (operativo soprattutto nei confronti dei curdi e del fondamentalismo
islamico).
E’ purtroppo evidente che strutture simili non sono appannaggio della sola Turchia
ma qui avevano assunto un ruolo e un peso molto rilevante (Gunter lo definisce
innanzitutto una ‘mentalità’) di cui occorre tener conto quando si considerano le
vicende storiche di questo Paese che non sarà mai democratico finchè non l’avrà
smantellato.
Era insomma evidente che l’AKP e l’establishment kemalista si stavano affrontando
dando luogo ad un duro scontro politico e il terreno di questo scontro fu la serie di
riforme intraprese dal governo per adempiere alle condizioni necessarie per l’ingresso
della Turchia nella UE.
30
III
La Turchia aveva cominciato a prestare orecchio alle proposte e alle offerte di Ocalan
e del PKK non solo perché il sanguinoso scontro armato stava effettivamente
portando tutti in un vicolo cieco, ma anche perché il lungo cammino intrapreso da
Ataturk per l’occidentalizzazione della Turchia stava ormai entrando nella nuova e
promettente fase della richiesta di ingresso della Turchia nella UE che l’11 dicembre
1999 accettò di iniziare i relativi colloqui.
Per entrare nella UE un Paese dev’essere riconosciuto in possesso di una lunga serie
di requisiti (i famosi Criteri di Copenhagen) fra i quali istituzioni democratiche e
pieno rispetto dei diritti civili, vero marchio distintivo della UE stessa: l’ingresso
della Turchia nella UE rendeva dunque assolutamente necessario che la questione
curda venisse risolta una volta per tutte proprio lungo la direttrice indicata da Ocalan
e, insomma, era vero che ‘la strada per la UE passa[va] per Diyarbakir’ (la capitale
informale del Kurdistan turco).
L’AKP promosse dunque una serie di importanti riforme tese alla democratizzazione
della Turchia (riduzione del peso dei militari, abolizione della pena di morte, delle
Corti per la Sicurezza dello Stato, aumento della libertà di stampa e di parola) e la UE
il 3 ottobre 2005 riconobbe che i colloqui per l’ingresso della Turchia potevano
cominciare.
Il 3 ottobre 2005 iniziarono dunque i negoziati per l’ingresso della Turchia nella UE
che per i curdi avrebbe significato la fine di molte se non di tutte le loro sofferenze,
ma le difficoltà emersero con forza e le trattative cominciarono a trascinarsi con
affanno crescente.
Il nocciolo del contendere era che la Turchia recalcitrava a rovesciare la sua
impostazione tradizionale che poneva la sicurezza dello stato al di sopra della legge e
dei diritti della persona: oltre alla negazione di tanti diritti delle donne e al ricorso alla
tortura, il Codice Penale e le varie Leggi Antiterrorismo che si erano succedute negli
anni erano infatti talmente vaghi e i loro articoli talmente onnicomprensivi che in
pratica qualsiasi critica pacifica o qualsiasi attività intellettuale non pienamente
ortodossa poteva essere giudicata sovversiva e filo-terroristica e quindi venire
pesantemente sanzionata.
I kemalisti, o lo ‘stato profondo’, erano stati sconfitti ma non domi e sicuramente
erano ancora molto potenti: l’opera di opposizione continuò così col ricorso ad ogni
mezzo e costrinse l’AKP a moderare i suoi toni e ad ingranare alcune retromarce:
nonostante la Turchia stesse attraversando un periodo di forte e marcata crescita
economica, le trattative con la UE presero a trascinarsi sempre più stancamente in un
clima in cui crescevano la percezione delle diversità e le incomprensioni.
IV
Circa le aperture di Erdogan ai curdi, i kemalisti l’accusarono di incoraggiare il
separatismo, il terrorismo del PKK (che comunque continuava con azioni militari), di
31
tradimento, di debolezza e di avviare il Paese sulla strada di una lotta fratricida: gli
arresti di curdi si moltiplicarono e il clima si infiammò di nuovo.
Proprio mentre le prime riforme di Erdogan entravano in vigore e i curdi potevano
almeno parlare la loro lingua, la Corte Costituzionale all’unanimità mise al bando il
DTP perché sospettato di avere legami col PKK e sequestrò i suoi beni, eppure
Ocalan nella sua intervista a Marco Ansaldo del 14 febbraio 2009 continuò a ripetere
che ‘o la guerra fra PKK e Turchia si risolve con il dialogo, o entro tre mesi il
conflitto in Kurdistan diventerà peggio di Gaza’ … ‘quest’anno si deve tracciare la
strada per un dialogo altrimenti noi curdi non possiamo essere ritenuti responsabili di
quello che potrebbe accadere nei prossimi tre mesi. I problemi non si risolvono
bombardando’, ma di fronte allo stallo delle trattative il 31 maggio 2010 annunciò
che il cessate-il-fuoco era finito così come i tentativi di dialogo col governo.
Anche se la tensione in Kurdistan era tornata molto alta e se il PKK veniva ancora
giudicato un’organizzazione terroristica (anche da tutto l’Occidente), il processo di
rinnovamento della Turchia però non si interruppe ed anzi culminò il 12 settembre
2010 colla vittoria del governo nel referendum per cambiare la Costituzione (quella
varata dai militari nel 1982 dopo il colpo di stato del 1980): il referendum constava di
ben 26 quesiti, i più importanti dei quali riguardavano proprio i poteri e il ruolo delle
forze armate.
In seguito alla vittoria al referendum il numero dei giudici della Corte Costituzionale
salì così da 11 a 17, di cui 14 nominati dal Capo dello Stato e 3 dal Parlamento;
sarebbe stata la Corte a giudicare i massimi gradi militari; tribunali civili, e non più
militari, avrebbero processato i membri delle forze armate accusati di reati contro la
sicurezza dello Stato e/o la Costituzione; e i civili non sarebbero più stati processati
da tribunali militari.
Altri emendamenti migliorarono la condizione delle donne, dei bambini, dei disabili,
degli anziani e dei lavoratori; il diritto di recarsi all’estero poteva essere limitato solo
per ordine di un giudice; e venne riconosciuto a tutti il diritto alla privacy.
Indubbiamente l’esito del referendum rese la Turchia più democratica, ma anche più
presidenzialista, e, dato l’orientamento dell’AKP, più islamica (o, almeno, fu questa
l’accusa degli oppositori): è infine estremamente significativo che il SI’ prevalse col
70% dei voti nell’est del Paese (regioni curde) mentre nell’ovest prevalse il NO, ma
già alle elezioni di tre anni prima l’AKP aveva ottenuto più voti curdi
dell’esplicitamente pro-curdo DPT (!).
Fu in queste condizioni che in Siria e in Iraq gli eventi precipitarono in modo inatteso
e drammatico.
Guerra mondiale in Siria
Sull’onda delle cosiddette ‘primavere arabe’, nel marzo 2011 anche in Siria
iniziarono le proteste - pacifiche – contro il regime liberticida di Bashar al-Assad (il
figlio di Hafiz al potere dal luglio 2000 dopo la morte del padre) che presto ruppero i
precari ed instabili equilibri (chiamiamoli così) su cui da decenni si reggeva: il Paese
32
fu così travolto da una spirale di violenza ancora oggi [novembre 2016] ben lungi
dall’essersi conclusa.
Anche se i contestatori erano pacifici e disarmati nè volevano la caduta del regime
ma solo la sua democratizzazione, la reazione del governo fu infatti di netta e violenta
chiusura: al-Assad imboccò la strada senza ritorno dello scontro armato e represse
con forza i suoi oppositori nell’evidente tentativo di radicalizzare il conflitto
favorendo gli estremisti e potendosi così presentare al mondo come il difensore
dell’ordine contro il terrorismo e il fondamentalismo islamico.
In un certo senso al-Assad riuscì nel suo intento perché i suoi oppositori si
moltiplicarono, presero le armi e dopo qualche mese la Siria precipitò nella guerra
civile.
Il gravissimo problema era che la società siriana era (ed è) percorsa da numerose
divisioni 1) confessionali, fra la grande maggioranza sunnita e la minoranza alawita
filo-sciita al potere, 2) economiche, fra il ceto benestante (in genere sunnita) che,
fortemente favorito dal regime, aveva lasciato agli alawiti il controllo e la gestione
dell’amministrazione, della difesa e della sicurezza, 3) sociali, fra le città per lo più
fedeli al regime e le campagne fortemente impoverite, 4) etniche, fra arabi e curdi e
5) claniche e tribali (molto forti e sentite, tanto che Declich, Glioti e Trombetta
affermarono che ‘i vincoli di sangue alla nascita sono il vero discrimine tra chi è
veramente vicino al regime e chi se ne allontana’): lo scontro armato scoppiato nella
primavera 2012 degenerò così ben presto in un caotico intrico e accavallamento di
gruppi e di milizie, tutte più o meno in guerra contro le forze regolari lealiste ma non
coordinate fra loro, anzi, spesso nemiche e comunque senza alcun progetto comune
per il futuro.
Insomma: la complessa frammentazione della società siriana (e araba in generale)
diede luogo a molteplici e variabili schieramenti fra cui regnarono disaccordo e
rivalità (spesso armata) mentre continuamente nascevano milizie armate di ogni tipo
e orientamento pronte a cambiare schieramento a ogni occasione utile.
Come se tutto ciò non bastasse, il conflitto, anzi i conflitti, non rimasero oltretutto
circoscritti nell’ambito una confusa guerra civile perché – data la caotica e complessa
convergenza nel Paese di interessi e strategie (geostrategiche, petrolifere e politiche)
molto più grandi di lui - la Siria divenne invece il campo di battaglia dove subito
presero ad affrontarsi potenze locali e addirittura mondiali.
I
Il regime della famiglia degli al-Assad consisteva in realtà nell’assoluta prevalenza
degli alawiti, una minoranza filo-sciita che vive nella zona costiera e meridionale del
Paese e che dal 1970 si era imposta sulla maggioranza sunnita (alla cui classe
imprenditoriale erano state comunque garantite ampie protezioni economiche) e,
naturalmente, sui curdi del nord.
Molto schematicamente si può allora affermare che gli alawiti di al-Assad erano e
sono sostenuti dagli sciiti (Iran e i loro affiliati Hezbollah libanesi) mentre i sunniti
(quelli ribelli, s’intende) erano sostenuti dalla Turchia, dall’Arabia Saudita e dagli
33
Emirati Arabi del Golfo (Qatar soprattutto): alawiti e sciiti erano inoltre appoggiati
dalla Russia (e dalla Cina) e i loro avversari dagli USA (e da Francia e Inghilterra),
questi ultimi peraltro molto riluttanti ad impegnarsi nuovamente in Medio Oriente.
E’ dunque evidente che una caduta di al-Assad avrebbe comportato un
rovesciamento degli equilibri dell’intera regione che a sua volta avrebbe influito
addirittura su quelli planetari: non stupisce dunque che in Siria giunsero (e
giungono) aiuti e sostegni da ogni parte e che forze armate di ogni tipo e
schieramento si affrontarono (e si affrontano) in una lotta senza quartiere che, oltre
alle centinaia di migliaia di morti, ha praticamente distrutto il Paese e ridotto alla
disperazione i suoi disgraziati abitanti spesso in fuga.
La situazione divenne comunque talmente caotica da rasentare il ‘bellum omnium
contra omnes’ anarchico, spesso criminale e senza certezze, così che una sua
descrizione completa è praticamente impossibile mentre, al solito, gli interventi dei
numerosi attori del conflitto sono sempre dovuti rimanere in qualche modo contenuti
(si fa per dire) per non provocare eccessive reazioni del campo avverso.
Più la guerra proseguiva, più le posizioni si radicalizzavano e si
‘confessionalizzavano’ (come per esempio accadde all’Esercito Siriano Libero), le
milizie si moltiplicavano e gli aiuti dall’estero aumentavano, soprattutto in favore di
quelle più radicali, ovviamente jihadiste.
II
La Turchia, membro della NATO, era dalla parte dei ribelli: essa temeva però che i
curdi siriani potessero contagiare quelli turchi ed era contro i fondamentalisti anche
se tutti questi stavano combattendo contro il suo stesso nemico, il regime di al-Assad.
Il premier Erdogan dovette così rinunciare alla sua politica estera di ‘zero problemi
coi vicini’ e di soft-power neo-ottomano (teorizzati e sostenuti dal suo ministro degli
Esteri Davutoglu) e fu costretto a giocare la sua partita in modo inevitabilmente
ambiguo e anche contraddittorio, lasciando passare uomini (anche fondamentalisti) e
mezzi in Siria attraverso la cosiddetta ‘autostrada turca’ perché combattessero contro
al-Assad; intervenendo a favore dei ribelli a lui favorevoli e contro quelli a lui
contrari; muovendo contro i curdi pur lasciando che all’inizio del 2013 il MIT (il
servizio di intelligence interno turco) riprendesse le trattative con Ocalan che però
non comportarono alcuna tregua col PKK.
Insomma: i contrastanti interessi della Turchia non le permettevano di schierarsi
interamente dalla parte degli oppositori del regime siriano perché il suo scopo
principale era sì la caduta di al-Assad ma non la vittoria dei fondamentalisti, né dei
curdi, né tantomeno dell’Iran.
Del tutto opposti (e lineari) erano infatti gli scopi dell’Iran (e di Hezbollah) e della
Russia che, come si è detto, erano aperti sostenitori del governo siriano (e di quello
irakeno).
34
III
Nel sanguinoso caos siriano curdi sono sempre stati un punto fermo perchè fin
dall’inizio hanno saputo con chiarezza quel che volevano: spazio, libertà e autonomia
per il loro popolo e per la loro terra.
Le regioni curde furono comunque quelle meno direttamente coinvolte nel conflitto:
qui il regime ricorse solo a sporadici bombardamenti e di fatto permise al PYD curdo
(Partito di Unione Democratica fondato nel 2003 e affiliato al PKK) di occupare
militarmente il Kurdistan siriano (Kirkuk fu comunque presa solo nel giugno 2014),
di farvi funzionare lo stato e di gestirne la commercializzazione di gas e di petrolio.
Giocò a favore dei curdi siriani il disegno di al-Assad di dividere il composito campo
avversario e di usarli come deterrente nei confronti della Turchia: i curdi siriani
poterono così ritagliarsi uno spazio vitale così come i curdi irakeni avevano fatto da
anni e in misura ben maggiore: si trattava comunque di un equilibrio abbastanza
precario perchè anche le comunità curde furono inevitabilmente coinvolte nella
guerra e il PYD e i suoi peshmerga cercarono (e cercano) di sopravvivere e di
garantirsi i considerevoli spazi di autonomia se non addirittura di indipendenza
conquistati reagendo e difendendosi sia contro i ribelli che contro i governativi
quando se ne sentivano (e se ne sentono) minacciati.
Il loro percorso è stato comunque molto simile a quello dei loro connazionali in Iraq
perché in ambedue i casi sono riusciti a inserirsi proficuamente negli scontri in atto
senza lasciarsene travolgere.
Essi hanno fatto parte per se stessi, alla perenne ricerca di diventare padroni e liberi
sulla propria terra.
IV
Per gli jihadisti la Siria, cioè Bilad al-Sam (‘Paese di al-Sam’, cioè di Damasco), è la
terra della resurrezione, dello scontro finale profetizzato già dallo stesso Maometto
che aveva posto ‘il centro dello stato islamico in al-Sam, dove gli angeli di Allah
diffonderanno il loro spirito. … Il giorno del giudizio avrà luogo a Damasco’, che
effettivamente fu la capitale del primo califfato (degli Omayyadi) fino al 750.
Ecco dunque che nella guerra civile siriana vanno infine ricordati i fondamentalisti
islamici (qaedisti dall’Iraq e vari gruppi jihadisti sempre più inglobati da Gabhat alNusra, Fronte della Salvezza, creato il 23 gennaio 2012) che combattono per se stessi
e sperano di uscire vincitori e padroni di uno stato che vorrebbero integralmente e
integralisticamente islamico.
I fondamentalisti erano (e sono) inassimilabili a tutti gli altri attori della tragedia
siriana perché lottavano (e lottano) per la ricostituzione di un califfato integralmente
basato sulla sharia (come la intendono loro ovviamente) ed erano (e sono) decisi a
impiegare qualsiasi mezzo per raggiungere il loro scopo, a utilizzare e/o a sterminare
chiunque ritenevano (e ritengono) opportuno e ad immolare anche se stessi, pronti
com’erano (e come sono) a quello che consideravano (e considerano) martirio.
I fondamentalisti in Siria erano comunque solo una delle componenti di quella
‘guerra mondiale a pezzi’ (come la definisce papa Francesco) cioè di quella jihad che
35
– mentre anche l’Occidente è sotto il suo attacco terroristico – da anni sta dilagando
in Africa, in Medio Oriente e in Asia, ormai vero problema planetario e drammatica
emergenza date le raccapriccianti e fanatiche, ma logiche e determinatissime,
iniziative che i suoi fautori non esitano a mettere in atto.
I fondamentalisti non avevano (né hanno) la minima intenzione di fermarsi finchè
non saranno giunti alla vittoria finale in tutto il mondo (o forse soltanto in tutto quello
islamico) e presto si fusero e si unirono a quelli in Iraq, anch’essi in guerra dal
fatidico 2011.
Guerra civile in Iraq
In Iraq dopo la caduta del regime di Saddam Hussein e i confusi e sanguinosi eventi
che ne erano seguiti (vedi il mio ‘Guerre USA’ - parte quarta) nel 2007 il
presidente americano Bush jr. aveva varato la ‘New Way Forward’ affidata al
generale Petraeus che aveva coniugato una politica di riforme con l’attenzione nei
riguardi dei sunniti sconfitti così da riuscire a spegnerne l’opposizione e ad attirarli
nell’area filo-governativo-americana: un certo equilibrio sembrava essere stato
raggiunto, ma con l’affrettata partenza degli americani nel dicembre 2011 (avvenuta,
secondo Maurin Picard, senza ‘negoziare un accordo per una ritirata graduale’) il
primo ministro (appartenente alla maggioranza sciita) al-Maliki cambiò
atteggiamento e politica cominciando a perseguitare e ad emarginare in tutti i modi i
sunniti (che, non va dimenticato, con Saddam Hussein erano stati al potere) proprio
quando un po’ dappertutto erano cominciate le ‘primavere arabe’ e, soprattutto,
quando in Siria era ormai scoppiata la guerra civile.
Non ci sarebbe potuta essere combinazione più esplosiva per dar fuoco alle polveri e
anche in Iraq proteste e manifestazioni presero a moltiplicarsi: al-Maliki ricorse alle
maniere forti, anch’egli spalleggiato dall’internazionale sciita (Iran e Hezbollah),
esattamente come qualche mese prima aveva fatto l’alleato e correligionario al-Assad
al di là del confine.
Nel 2013 ai sunniti che chiedevano lotta alla corruzione e miglioramento delle loro
condizioni di vita al-Maliki rispose con le armi: Giovanni Parigi commenta così che
‘Questa chiusura costò cara non solo al premier ma a tutto il paese. Maliki aveva
tradito ogni aspettativa sunnita, scardinando il fragile equilibrio ereditato dagli
americani e portando il paese a una crisi etnica e settaria.’
Con la sua politica sciitocentrica al-Maliki aveva ottenuto insomma il bel risultato di
coalizzare contro il suo governo, anzi regime, i baathisti (laici fino al giorno prima!) e
gli jihadisti, ambedue sunniti e quindi uniti dalla comune appartenenza tribale e
clanica.
Col ritiro americano le carceri erano state svuotate e gli spodestati baathisti (sunniti
ma laici) ne erano usciti spesso radicalizzati e islamizzati: ansiosi di rivincita e di
riaffermazione, confluirono così in massa nelle file dei fondamentalisti e l’apporto di
tanti ex-ufficiali dell’esercito e della Guardia Repubblicana di Saddam Hussein fu
36
fondamentale nel dotare gli jihadisti di armi (degli arsenali nascosti) e di personale
esperto in cose militari.
Emerse allora in tutta la sua gravità ed arrogante irresponsabilità l’errore di aver
sciolto l’esercito irakeno già nel maggio 2003 pretendendo di riplasmarlo (insieme
all’intero Paese) dalle fondamenta sotto il controllo americano e lasciando così una
scia di profondo risentimento e un’ansia di rivincita e di riappropriazione che ora si
faceva sentire con tutto il suo peso.
La guerra scoppiò anche in Iraq e si saldò subito con quella in corso in Siria.
Vincoli di comune appartenenza esistevano infatti al di qua e al di là del confine con
la Siria dove i sunniti erano in rivolta contro gli alawiti: come ricorda Giovanni
Parigi, ‘La frontiera tracciata cento anni fa da Sikes e Picot tra i due paesi non aveva
tagliato i profondi vincoli tribali, di religione e di cultura delle popolazioni arabe
sunnite dell’Est siriano e dell’Ovest iracheno … [che] … costituiscono un blocco
omogeneo di popolazione sunnita, di origine rurale e cultura beduina, dove si
intrecciano legami tribali, economici e storici. Le conseguenze inaspettate delle
‘primavere arabe’ hanno poi cementato ulteriormente l’identità di quest’area, definita
con azzeccato neologismo Siriaq: sia a Bagdad che a Damasco il conflitto era settario
e vedeva il potere centrale opprimere i sunniti’.
Insomma: i fortissimi e fondamentali legami famigliari, tribali e clanici dei sunniti
erano stati ignorati e negati del tutto artificialmente fin dai tempi del trattato SikesPicot; in Siria i sunniti erano stati sottomessi agli alawiti (minoritari) almeno fin dal
1970 e in Iraq agli sciiti (maggioritari) di al-Maliki dal 2011; al-Assad e al-Maliki
erano alleati e, sostenuti dall’Iran e da Hezbollah, reprimevano con le armi i sunniti
che chiedevano giustizia: gli scontri in atto nei due Paesi divennero così presto un
unico scontro.
L’Isis
Come sempre e dappertutto nel mondo arabo, i moderati filo-occidentali si rivelarono
presto deboli e inconsistenti e furono così gli jihadisti a prendere nelle loro mani la
guida della lotta contro i due regimi: il loro obiettivo era l’affermazione dell’Isis
(Stato islamico dell’Iraq e del Levante, chiamato anche Daesh, acronimo dall’arabo
Daiish) che, pensato in Iraq fin dal 2006, nell’aprile 2013 era stato proclamato
dall’allora quarantaduenne irakeno Abu Bakr al-Baghdadi sulla parte del territorio
siriano appena conquistata: l’anno seguente l’Isis allargò il suo raggio d’azione in
Iraq e si presentò come l’unico vero movimento unificatore dei sunniti di Siria e Iraq.
L’Isis apparve dunque come il difensore dei sunniti oppressi e nell’estate 2014
travolse ogni resistenza del demotivato e scoordinato esercito irakeno arrivando a
occupare larghi settori dell’Iraq che subito vennero uniti a quelli già conquistati in
Siria: sempre Parigi conclude che ‘lo Stato islamico ha riempito il vuoto … e ha
fornito ai sunniti l’unica alternativa politica al momento esistente’ mentre la
sostituzione di al-Maliki con Haider al-Ibadi (8 settembre 2014) risultò del tutto
tardiva ed irrilevante.
37
Il 29 giugno 2014 al-Bagdadi fu proclamato ufficialmente Califfo (successore e
vicario di Maometto, carica che era stata abolita da Ataturk nel 1924) e il 5 luglio si
rivelò al mondo comparendo in pubblico per proclamare la nascita dello Stato
Islamico dell’Iraq e del Levante e per chiamare a raccolta, alla mobilitazione e alla
lotta l’intera comunità musulmana mondiale in vista della jihad e
dell’islamizzazione violenta dell’intero pianeta.
‘Le parole più oneste sono le parole del libro di Dio’ disse in quell’occasione alBaghdadi ‘e la guida migliore è la guida di Muhammad. Non c’è cosa peggiore che
reinterpretarle e ogni reinterpretazione è una innovazione e ogni innovazione è una
deviazione e ogni deviazione è il fuoco dell’inferno.’ Dio ‘ci ha ordinato di
combattere i Suoi nemici e di condurre il jihad in Suo nome … per affermare la Sua
religione. … In verità questo è alla base della religione: un Libro che guidi e una
spada che aiuti a vincere. … combattete con i vostri beni e con tutti voi stessi sulla
Via di Dio. … [Egli] perdonerà i vostri peccati e vi farà entrare … nelle piacevoli
dimore dei giardini dell’Eden.’
Capitale dell’autoproclamato califfato fu Rakka (sulle rive dell’Eufrate in Siria), già
capitale del califfato abbaside a cavallo dell’VIII e del IX secolo, la prima città ad
essere stata conquistata dalla qaedista al-Nusra nel marzo 2013 e dopo pochi mesi
dall’Isis in lotta contro tale formazione: l’orrore del dominio fondamentalista e i raid
aerei della coalizione arabo-occidentale ridussero in breve tempo la popolazione di
Rakka dal milione che era stata a sole 400mila unità.
L’iniziativa di al-Baghdadi ebbe subito vasta eco e suscitò molteplici e diffuse
simpatie: come ricorda Lorenzo Declich ‘a pochi mesi dalla nascita dell’Isis …
[arrivarono] … riconoscimenti come leader ad Abu Bakr al-Baghdadi … provenienti
da Arabia Saudita, Somalia, Libano, Sinai, Ahwaz (Iran arabofono), Libia e Tunisia.
38
Sappiamo che poi, con la proclamazione del califfato, seguirono altre adesioni: ad
esempio Boko Aram e una frazione algerina di al-Qaeda’ anche se il suo effettivo
attecchimento derivava ‘dalle particolari situazioni locali’ e ‘in Siria … ci sono
quaidisti e altri jihadisti che combattono regolarmente contro l’Is’.
Il richiamo di al-Baghdadi suscitò una forte (e preoccupante) attrattiva internazionale:
secondo le Intelligences occidentali già nell’agosto 2014 i miliziani stranieri dell’Isis
(i foreign fighters addestrati alla violenza più estrema) costituivano 1/3 dell’intero
esercito jihadista ed erano stati reclutati in ben 83 Paesi fra cui molti europei dove
giovani della seconda o terza generazione di immigrati erano stati attratti dalla
prospettiva del trionfo planetario del Califfato.
Educati sui siti Internet e sui social media che conducevano senza soste campagne di
proselitismo e che predicavano un’accesissima e fanatica missione palingenetica,
20mila giovani (e non solo maschi) avevano abbandonato definitivamente la loro vita
precedente per andare a combattere e a commettere ogni sorta di atrocità nei territori
dell’Isis, pronti a tutto e a morire per una causa che giudicavano santa.
In Occidente ‘non poteva essere diversamente’ commenta Renzo Guolo ‘nel tempo
della globalizzazione che trasforma le società occidentali in società multietniche e
multiculturali’ … ‘nel tempo della fine delle grandi ideologie … in discussione, per
questi membri della generazione del rifiuto e del rancore, non vi è solo una politica
che, a loro dire, criminalizza sempre e comunque l’islam, ma anche un sistema di
valori’.
Presso molti musulmani era poi forte la volontà di riscatto dall’influenza
dell’Occidente e dai suoi soprusi unita alla volontà di rinascita in una società
integralmente ed integralisticamente islamica (o supposta tale), pura e incorrotta,
semplice ed elementare piuttosto che composita e complessa.
I
Bisogna riconoscere che effettivamente l’Isis rappresentò una svolta notevole rispetto
ad al-Qaeda perché sostituì l’attività terroristica e cospiratrice di quest’ultima
coll’edificazione di un nuova società basata sull’applicazione rigorosa ed integrale
della sharia: nei vasti territori occupati in Iraq e in Siria il Califfato divenne così un
vero e proprio stato che si manteneva colle risorse petrolifere su cui aveva messo le
mani e che commercializzava sul mercato nero attraverso la Giordania, la Turchia e
… il Kurdistan (!), con vere e proprie attività criminali, colla tassazione e colle
donazioni dei Paesi arabi del Golfo (Arabia Saudita, Qatar e Kuwait soprattutto).
Se il ‘Sunnistan’ della ‘Siriaq’ (cioè l’Isis) poteva avere insomma un senso e una
giustificazione storica perchè rimetteva in discussione l’ultimo secolo di divisioni
artificiali e imposte nella regione, la sua natura incredibilmente e follemente
apocalittica, omicida, estremistica, fanatica, sanguinaria, oppressiva e genocida nei
confronti di ogni minoranza etnica o religiosa e di ogni mussulmano ritenuto troppo
tiepido e di chiunque era accusato di non rispettare l’ordine della più rigida e
ossessiva sharia, cui si aggiunsero infine le dissennate distruzioni di monumenti e
39
reperti del passato, lo squalificarono completamente agli occhi dell’opinione pubblica
internazionale.
E non bastava ancora perché, come annunciato da al-Baghdadi, l’Isis non si
proponeva semplicemente la nascita di un nuovo stato sunnita etnicamente e
culturalmente omogeneo, ma, dopo la conquista integrale di Iraq e Siria, di
passo in passo puntava a quella del mondo intero.
Gli jihadisti dell’Isis sentivano (e sentono) di combattere una guerra mondiale
per giungere al completo trionfo dell’Islam da loro concepito ed applicato nel
modo più integralistico e sanguinario possibile: questo ambiziosissimo (e folle)
progetto fu alla base della decisione di al-Baghdadi di estendere l’Isis in Algeria,
Egitto, Libia, Arabia Saudita e Yemen mentre l’attacco all’Occidente fu portato
avanti con un’intensa campagna terroristica organizzata in grande stile dal
Califfato.
II
Di fatto fino a quel momento contro l’Isis avevano combattuto solo l’Iran sostenuto
dalla Russia, l’esercito irakeno (in realtà poco più che milizie sciite), quello siriano e
i curdi, ben intenzionati a tenere i fanatici sanguinari islamici al di fuori dei loro
confini, ora però per l’Occidente (cioè per gli USA) divenne imperativo muoversi con
maggior decisione e reagire sul serio invece di limitarsi all’invio di qualche
consigliere, a sporadici bombardamenti (magari effettuati da droni), a difendere i
curdi (dall’agosto 2014 armati anche dall’Europa) o a tentare (con scarsi risultati)
missioni umanitarie per salvare quelle comunità religiose o etniche che, come gli
yazidi e i turcomanni, erano minacciate di sterminio.
Sotto la presidenza Obama gli USA erano stati riluttanti a impegnarsi nel caotico
scenario mediorientale ma ora si imponevano scelte ben più impegnative: il 5
settembre 2014 il presidente Obama annunciò così la nascita di una coalizione di
dieci Paesi che, guidata da USA e Inghilterra, comprendeva anche Italia, Germania,
Francia, Danimarca, Turchia, Polonia, Canada e Australia col compito di ‘respingere,
e alla fine distruggere, questa organizzazione selvaggia’ ma senza intervenire con
truppe di terra e scegliendo invece di ‘sostenere le forze che combattono in prima
linea contro i jihadisti’ con massicci raid aerei, fornitura di armi e appoggio logistico.
La guerra da latente divenne aperta e i bombardamenti degli occidentali sulle
postazioni jihadiste si intensificarono.
III
La nascita del Califfato, oltre ad aver sconvolto gli schieramenti in campo, li aveva
però, se possibile, anche ulteriormente complicati tanto da renderli contraddittori e
spesso incomprensibili:
1) l’Occidente era nemico inconciliabile e intransigente dell’Isis così come lo erano
anche l’Iran, gli sciiti e la Russia: si sarebbero dovuti ritrovare tutti dalla stessa parte
della barricata invece erano in netta competizione e inimicizia per numerosi altri
motivi;
40
2) Turchia, Arabia Saudita e monarchie del Golfo, pur alleate dell’Occidente,
sostenevano però (seppur cautamente) anche l’Isis in funzione anti-al-Assad;
3) il caso dell’Arabia Saudita era emblematico: monarchia assoluta che si fonda sulla
convinzione di essere il regno perfetto della sharia, che ha inglobato il clero wahabita
nel suo sistema e che non tollera alcun mutamento del suo assetto interno, non esitava
a intervenire al di fuori dei suoi confini per combattere non solo i suoi nemici sciiti
(l’Iran e i suoi protetti e alleati) ma anche ogni movimento di democratizzazione della
società araba che giudicava destabilizzante e pericoloso per i suoi equilibri interni.
Ecco allora che, nell’ambito del suo tradizionale scontro con l’Iran, si era data a
promuovere (copertamente) anche l’attività degli jihadisti (che comunque temeva),
Isis compreso, ove questi – sunniti – fossero funzionali ai suoi disegni.
Contemporaneamente però l’Arabia Saudita era anche alleata degli USA e
dell’Occidente del cui ombrello protettivo aveva assoluto bisogno: come la Turchia,
anch’essa giocava sul filo del rasoio e cercava di mantenersi in equilibrio fra
Occidente e fondamentalismo, atteggiandosi ad amica di entrambi ma - attenzione! –
solo al di fuori dei propri confini;
4) la Turchia, membro della NATO e alleata dell’Occidente, aveva avuto però solo da
avvantaggiarsi dall’Isis (nemico dell’Iran, del suo nemico al-Assad e dei curdi), di
qui la permeabilità delle sue frontiere per gli uomini e per i mezzi del Califfato e la
commercializzazione del suo petrolio.
Questi paradossi resero la situazione dell’Occidente semplicemente assurda: i suoi
alleati arabi e turchi collaboravano (più o meno copertamente) anche coi suoi nemici
dell’Isis mentre tutti insieme attaccavano al-Assad, a sua volta nemico dell’Isis
stesso!
Non può non stupire l’apparentemente incomprensibile rapporto fra le monarchie del
Golfo, alleate degli USA, contestate e combattute dagli jihadisti ma
contemporaneamente loro finanziatrici: è un gioco pieno di luci e ombre, di manovre
e contromanovre che confonde l’osservatore ma che rivela l’intento di
controbilanciare l’influenza dell’uno e con quella dell’altro, di mantenere aperte più
porte, di non crearsi inutilmente troppi nemici in uno scenario tanto mobile e aperto
ad ogni futura possibile soluzione, mentre non si può dimenticare che tutto ciò
rientrava nel fondamentale scontro con l’Iran che faceva sì che i nemici di
quest’ultimo fossero in qualche modo loro amici.
Mentre l’Occidente si trovava a dover gestire una politica in se stessa semplicemente
contraddittoria, la Russia di Putin da tempo aveva fatto invece la sua scelta ben più
logica e lineare appoggiando senza esitazioni l’Iran, gli sciiti e il regime siriano.
Essa (da tempo impegnata anche contro i fondamentalisti di casa sua, vedi Cecenia)
col suo sostegno ad al-Assad aveva visto giusto e si era mossa con coerenza: il suo
scopo era stato mantenere aperto e operante il collegamento Iran-Siria-Libano
(Hezbollah), dal Golfo al Mediterraneo.
Intanto gruppi e milizie si moltiplicavano sul campo frammentando e complicando
senza fine e senza sosta i fronti di guerra.
41
IV
Come si è già detto, l’Occidente aveva titubato ma ora anch’esso era ormai
apertamente in campo contro l’Isis.
Mentre gli attacchi aerei occidentali presero a moltiplicarsi anche in Siria (Rakka
compresa), il punto di svolta si ebbe però colla battaglia della città di Kobane, nel
Kurdistan siriano al confine con la Turchia: il 19 luglio 2012 la città era passata come del resto praticamente tutto il Kurdistan siriano – sotto il controllo del PYD, ma
dal settembre 2014 i fondamentalisti dell’Isis avevano iniziato la sua conquista e in
gran parte erano riusciti nell’impresa.
Per respingere i fondamentalisti dell’Isis da Kobane i curdi combatterono duramente
in questa ‘Stalingrado del Vicino Oriente’ dall’alto valore simbolico e strategico:
mentre la Turchia di fatto sostenne gli sforzi del Califfato, dopo quattro mesi di duri
scontri il 26 gennaio 2015 i curdi riuscirono infine a riprendere la città anche perché
buona parte dell’aviazione della coalizione occidentale si era concentrata in loro
aiuto in quella zona.
L’epica impresa fu seguita in Occidente con entusiasmo e ammirazione: uomini e
donne curde combatterono fianco a fianco con tenacia e assoluta determinazione ed è
degno di nota che, anche se musulmani, appena i curdi sono liberi, subito le loro
donne riacquistano quel ruolo paritario e di prestigio che da sempre è una delle cifre
fondamentali della loro identità.
Le loro ragazze in tuta mimetica e con le armi in pugno esprimono perfettamente
l’abisso che le separa dalle loro coetanee dell’Isis tutte coperte e velate dal nero
niqab.
La caduta di Kobane fu un grave scacco per la Turchia: essa non solo non aveva
minimamente collaborato alla difesa della città (pur sul suo confine!) dai
fondamentalisti, ma anzi li aveva lasciati passare liberamente attraverso i suoi
confini.
Tutto il peso – ma anche tutta la gloria - dello scontro era gravato sulle spalle dei
peshmerga curdi (aiutati dall’Occidente) e ora il loro successo costrinse la Turchia a
rivedere i suoi piani e a rendersi conto che, mentre era chiaro che il regime di alAssad non sarebbe caduto tanto facilmente, gli americani avevano scelto ormai i
curdi come alleati di tutto rispetto da sostenere e da armare.
La partita siriana si giocava ormai in tre, al-Assad (con Russia e Iran), Isis e curdi
(con l’Occidente).
In questo scenario l’accordo USA-Iran del 14 luglio 2015 (sul nucleare di
quest’ultimo) fu un grosso successo per la diplomazia americana: le (solite) sanzioni
commerciali all’Iran vennero progressivamente tolte e il Paese tornò ad essere un
interlocutore accettato non più dalla sola Russia.
Nel nuovo scenario bellico questa mossa della diplomazia americana fu
assolutamente necessaria ma Israele, alleato di ferro dell’Occidente, temeva molto
più l’Iran dell’Isis (contro il quale non a caso non sarebbe intervenuto mai) e protestò
vivamente per quello che giudicò un tradimento e un suicida patto col diavolo.
42
Nascita del Kurdistan siriano
Dopo che, come si è visto, il PYD aveva occupato militarmente il Kurdistan siriano
(il Rojava) e vi faceva funzionare lo stato, i curdi, col rispetto duramente conquistato
sul campo di battaglia dai suoi peshmerga, erano ormai un punto fermo e di non
ritorno: anche in Siria essi avevano saputo imporsi sui terribili scenari di guerra in
modo tale da uscire finalmente dal loro stato di minorità e di discriminazione, di
oppressione e di negazione della loro stessa esistenza.
Scopo dei curdi siriani era evidentemente assumere il controllo di tutta l’area da loro
abitata fra Siria e Turchia, separando così i due Paesi e impedendo alla Turchia di
muovere in aiuto dei ribelli filo-turchi anti-al-Assad e di essere presi così fra due
fuochi.
Nell’ottobre 2014 a Dahuk tutti i partiti curdi siriani si erano uniti nel Kurdish
Political Reference che aveva proclamato unilateralmente l’autonomia da Damasco
ed aveva cominciato a organizzare la nuova entità su esempio e aiuto dei curdi
irakeni: la capitale del neonato Rojava era Qamisli mentre la People’s Protection
Unit (YPG) era invece l’articolazione militare del PYD, addestrata dai peshmerga
irakeni e aperta anche alle donne secondo la tradizione dei combattenti curdi.
Eppure anche nel caso del Kurdistan siriano i curdi erano consapevoli che il loro vero
interesse risiedeva nella pacificazione del Paese e nel ritagliarsi uno spazio di
autonomia al suo interno: così com’era avvenuto in Iraq, il fine politico dei curdi
siriani era dunque la nascita di una Siria federale in cui anche il Rojava fosse
riconosciuto regione autonoma dove i curdi potessero finalmente vivere liberi,
autoamministrandosi, gestendone in proprio le risorse, seguendo i propri costumi e
parlando la propria lingua.
I curdi siriani e i curdi irakeni ancor oggi non sembrano infatti pensare all’unità e
all’indipendenza del loro popolo che sconvolgerebbe l’intero Medio Oriente e
avrebbe esiti pericolosissimi e imprevedibili: al di là della loro comune civiltà, ai
curdi manca oltretutto ancora una vera coscienza nazionale che li identifichi
politicamente come un unico popolo e dunque puntano realisticamente ad essere
liberi, riconosciuti e rispettati in ogni Paese in cui abitano senza che ciò alteri
l’assetto internazionale e i confini ufficiali fra gli stati.
Questo comportamento spiega fra l’altro perché la Turchia ormai accetti la nascita dei
due Kurdistan autonomi alle sue frontiere mentre coi curdi ‘turchi’ nel suo sud-est
continua a giocare la complessa partita che mescola e alterna la ricerca di dialogo con
lo scontro armato col PKK.
Guerra in Medio Oriente e terrorismo in Europa
Ai bombardamenti degli USA (iniziati nell’agosto 2014 in Iraq e nell’ottobre
2014 in Siria) l’anno seguente si aggiunsero quelli della Turchia che sembrava
finalmente uscita dalla sua ambigua condotta e che il 24 luglio 2015 per la prima
volta bombardò l’Isis in Siria, offrì una buona volta le sue basi nel sud del Paese (fra
43
cui Incirlik) alla coalizione di cui fino a quel momento aveva fatto parte solo
nominalmente e partecipò alle offensive anche con carri armati: la svolta turca fu
motivata cogli attentati dei fondamentalisti sul suo territorio ma era dovuta
soprattutto alla necessità di non finire isolata.
In ogni caso, dopo l’accordo con l’Iran il sospirato diretto intervento turco era un
nuovo successo per la coalizione occidentale.
Contemporaneamente però l’aviazione turca bombardò anche campi del PKK in Iraq
nell’eterna oscillazione fra un dialogo difficile e la repressione: l’offensiva contro il
PKK continuò poi anche in patria con la chiusura di siti web, canali televisivi e radio
curdi.
Dopo che l’Inghilterra il 17 luglio 2015 aveva iniziato a bombardare le postazioni
dell’Isis in Siria, anche la Francia il 27 settembre 2015 cominciò i suoi raid aerei
sulla Siria motivati dal presidente francese Hollande colla necessità di proteggersi da
attentati in patria organizzati e diretti proprio nel territorio siriano in mano all’Isis
(come la strage di giornalisti del settimanale satirico ‘Charlie Hebdo’ del 7 gennaio
2015).
Per parte sua, nel settembre 2015 la Russia aumentò i suoi aiuti al regime di alAssad e il 30 di quel mese, accogliendo l’appello del governo siriano, iniziò a sua
volta i bombardamenti decollando dalla base appena costruita nei pressi di Latakia e
ben presto anche dal mar Caspio: anche Putin giustificò l’escalation sostenendo che
‘dobbiamo fermare il terrorismo prima che arrivi fino a noi’.
Apparentemente ciò costituiva un ulteriore rafforzamento del fronte anti-Isis, ma in
realtà la Russia (e l’Iran) erano (secondo un’alleanza che durava da molti anni) le
uniche nazioni a sostenere al-Assad, da tutte le altre indicato invece come un dittatore
che non era più possibile mantenere al potere: non a caso da parte occidentale subito
fioccarono le accuse secondo cui insieme a quelle dell’Isis i russi avevano colpito
anche postazioni di ribelli anti-al-Assad, ma questo rifiuto di accordarsi con al-Assad
impediva alla coalizione occidentale di muoversi con una prospettiva concreta perché
essa restava praticamente priva di alleati nel campo siriano e dunque non era in grado
di offrire prospettive concrete: inoltre, forse peggio ancora, impediva il
coordinamento delle forze e divideva con forti rivalità e sospetti il fronte anti-Isis.
Ormai il cappio sembrava comunque stringersi inesorabile al collo dell’Isis che
nell’aprile 2015 aveva perso Ramadi (Iraq) e Palmira (Siria), ma, per quanto micidiali
e devastanti, i molteplici e ripetuti bombardamenti non solo non piegarono il
Califfato ma militanti jihadisti, sempre incrollabilmente fedeli alla loro missione
planetaria, ripresero e rinnovarono i loro attentati in Europa.
I
Fu questo il senso e il significato degli spettacolari e sanguinosissimi attentati
terroristici, avvenuti soprattutto in Francia e compiuti materialmente da islamici
residenti (europei di seconda generazione), che nel farneticante delirio islamista si
susseguirono a partire da quello al ‘Bataclan’, famoso locale notturno di Parigi, il 13
novembre 2015, accompagnati e illustrati da un’imponente campagna propagandista
44
infarcita di invasati proclami e soprattutto di video (diffusi via Internet) in cui le
decapitazioni, gli sgozzamenti, le uccisioni feroci fatte eseguire anche da bambini
erano intervallati da scene di combattenti in marcia trionfale e dall’incitamento a tutti
i musulmani del mondo perchè insorgessero e travolgessero tutti i nemici dell’Islam,
cioè tutti quelli che non erano dei loro.
L’attività dell’Isis aveva ben oltrepassato i confini mediorientali e aveva cominciato a
scrivere un nuovo capitolo del terrorismo islamico in Occidente, problema del resto
endemico che non si riusciva a risolvere (e che forse è insolubile): in questa sede,
dove il tema in esame sono i curdi, non è assolutamente possibile dar conto delle
infinite complicazioni e varianti dello scontro in atto che vede la presenza di ben 142
movimenti jihadisti in Asia e in Africa e praticamente tutto il mondo contro di loro,
pur fra mille divisioni e manovre, opposizioni e sfiducie reciproche, interessi e calcoli
politici di ogni tipo.
In questo scontro mondiale l’inafferrabile, molteplice e multiforme galassia jihadista
mietè innegabili successi costringendo (come avviene comunque da decenni) le
società occidentali ad intensificare controlli e misure di sicurezza, a militarizzarsi e a
vivere sconvolte dall’incertezza: contemporaneamente però, l’Isis stava perdendo
tanti (più o meno velati) appoggi ed in pratica era riuscito ad coalizzare tutto il
mondo contro di sè - a meno che non fosse proprio questo ciò che voleva.
L’inizio della fine?
Dopo i folgoranti successi delle conquiste dell’Isis in Siria e in Iraq e dopo gli
attentati (riusciti o sventati) in Europa, era ormai evidente che al-Baghdadi aveva
preteso troppo dalle sue forze e che era cominciata la parabola discendente del suo
Califfato, stretto da troppi e troppo potenti nemici.
Dopo la strage del ‘Bataclan’ la Francia intensificò i raid aerei sul territorio del
Califfato e il 17 novembre 2015 chiese ed ottenne l’assistenza militare della UE:
soprattutto però fu la Russia a cogliere l’occasione per intensificare le sue azioni
‘insieme all’alleato francese’ colpendo soprattutto le risorse petrolifere, vera sorgente
vitale del Califfato, mentre il 2 dicembre anche l’Inghilterra votava a favore di nuovi
ulteriori raid aerei sulla Siria.
Nell’ambito della manovra concentrica contro l’Isis, il 17 ottobre 2016 iniziò così
l’attacco a Mosul, seconda città dell’Iraq e ganglio vitale del Califfato: da sud mosse
l’esercito irakeno supportato da milizie sciite, da est i curdi e dal cielo i
bombardamenti della coalizione internazionale a guida americana, mentre la Turchia
aveva finalmente chiuso il passaggio attraverso le sue frontiere agli uomini e ai mezzi
dell’Isis.
All’Italia era già stata affidata la ristrutturazione, la difesa e la sicurezza della grande
diga sul Tigri (a soli 35 km. dalla città) ma la cintura di difesa più esterna del
complesso era stata però riservata ai curdi.
E una donna curda, Jihan Cheikh Ahmad, ufficiale delle Syrian Democratic Forces
(arabe, curde e di altre etnie) il 6 novembre 2016 annunciò l’avvio dell’attacco a
45
Rakka, la capitale stessa del Califfato: non è un particolare da poco conto perché i
jihadisti pensano che essere uccisi da una donna sia un disonore talmente grande da
escludere che il caduto possa entrare in Paradiso (!).
Sembra insomma che per il Califfato sia cominciata la fine e che l’interminabile scia
dei suoi orrori sia sul punto di cessare, almeno nella scala fin qui praticata, ma la fine
dell’Isis non è ancora arrivata e certamente, dato l’accanimento con cui i suoi
miliziani resistono e sono intenzionati a resistere, ci vorranno ancora tempi lunghi,
molti morti e molte distruzioni prima che la vicenda possa dirsi finalmente conclusa
anche se non è dato prevedere quale sarà la sistemazione finale dei due Paesi, già
comunque stremati e distrutti e con masse di emigranti e di rifugiati fuggiti disperati
e pieni di lutti dopo aver abbandonato tutto quello che avevano.
E’ del resto l’intero mondo arabo ad essere fortemente frammentato, diviso,
destabilizzato, zeppo di rivalità e alla ricerca di un equilibrio che al momento non è
dato nemmeno sperare.
Conclusione
In questo mare di instabilità e di frammentazione delle società arabe i curdi
rappresentano un’oasi di fermezza e di unità: corazzati dopo tante sofferenze patite e
orrori subiti, in Iraq e in Siria essi hanno saputo cogliere al volo le opportunità che le
guerre scoppiate in quei Paesi hanno loro offerto e sono così riusciti a ritagliarsi spazi
di autonomia e di quasi-indipendenza nei territori in cui da sempre avevano vissuto:
si può tranquillamente affermare che il Kurdistan irakeno e il Kurdistan siriano
sono finalmente nati e non pare possibile che tale conquista storica possa esser loro
strappata.
Seppur confinanti e appartenenti allo stesso popolo, i curdi irakeni e quelli siriani
sembrano disposti ad accettare di rimanere comunque due entità distinte in due
diversi Paesi, dato che il popolo curdo non risulta sensibile al richiamo dell’unità
nazionale né tantomeno intenzionato al rovesciamento dell’assetto internazionale che
la nascita di un loro nuovo stato provocherebbe in una parte del mondo oltretutto già
di per sé tanto esplosiva.
Mentre in Iran i curdi sono sempre stati i più (diciamo così) tranquilli e i meno
disposti alla lotta armata, gravemente incerta è invece la situazione di quelli in
Turchia.
In Turchia la politica del ‘sultano’ Erdogan nei confronti dei curdi è sempre stata
ambigua e oscillante: era sembrato davvero disposto a stabilire una convivenza
almeno decente con questa minoranza così numerosa e dunque a chiudere una buona
volta il fosco periodo delle discriminazioni, delle persecuzioni e dell’oppressione;
anche il PKK da anni si dichiara disposto a intavolare una trattativa seria col governo
turco in modo da far finalmente cessare quella strisciante (ma non troppo) guerra che
è già costata almeno 40mila morti; tuttavia solo per limitati periodi il difficile dialogo
ha interrotto lo scontro armato; i buoni rapporti del governo turco col Kurdistan
irakeno e recentemente anche con quello siriano offrono tuttavia motivi di speranza.
46
Da qualche tempo però Erdogan ha cambiato politica adottando sempre più
atteggiamenti autoritari e richiamandosi con maggior insistenza all’Islam finchè la
situazione è drammaticamente precipitata il 15 luglio 2016 quando contro di lui fu
tentato un (ennesimo) colpo di stato militare: si trattò di un tentativo piuttosto
maldestro, confuso e dai contorni non ancora chiariti (costò comunque 290 morti e
1440 feriti) che venne rapidamente isolato e soffocato, ma la reazione del governo e
di Erdogan, uscito vincitore e trionfatore, è stata molto pesante.
Il governo turco accusa la CIA e soprattutto il fuoruscito Fethullah Gulen di essere
stati gli ispiratori del fallito putsch e gli arrestati e gli epurati sono decine di migliaia:
insieme ai veri o supposti partecipanti al colpo di stato sono stati imprigionati e
condannati infatti anche decine di migliaia di docenti, giornalisti, magistrati,
intellettuali, voci libere e tante personalità ritenute scomode da quello che ormai è
inevitabile chiamare regime.
Il fallito golpe avrebbe insomma fornito la scusa e l’occasione a Erdogan per far
pulizia dei suoi oppositori e dei suoi critici: ormai la Turchia è governata col pugno di
ferro dell’intolleranza, della censura, delle misure illiberali e di quant’altro serve al
governo per imporsi senza impacci sulla società.
In questa situazione in cui non è dato sapere se c’è stato o no un riavvicinamento di
Erdogan allo ‘stato profondo’ (che comunque avrebbe avuto inizio da tempo) e se
questo aveva parteggiato o no per i golpisti, che ruolo ha l’Islam (se ce l’ha) nella
nuova Turchia, il 4 novembre sono stati arrestati anche 11 deputati del partito procurdo HDP e pochi giorni dopo altri deputati curdi hanno subito la stessa sorte.
L’intera vicenda non è stata affatto chiarita e solo due sono le certezze: 1) Erdogan
sta diventando (o è già) un dittatore e la Turchia un regime; 2) il dialogo coi curdi è
stato interrotto e la loro condizione in Turchia appare in netto peggioramento.
Come si vede, mentre al di là dei confini il vulcano sirio-irakeno erutta ancora morte
e distruzione, la condizione dei curdi nei vari Paesi è molto varia e diversificata, ma
in ogni caso è evidente che col nuovo secolo questo popolo è finalmente uscito dal
silenzio e dall’abbandono e sta ormai occupando il posto che gli spetta nella storia e
nel consesso internazionale.
Sottomarina 19 novembre 2016