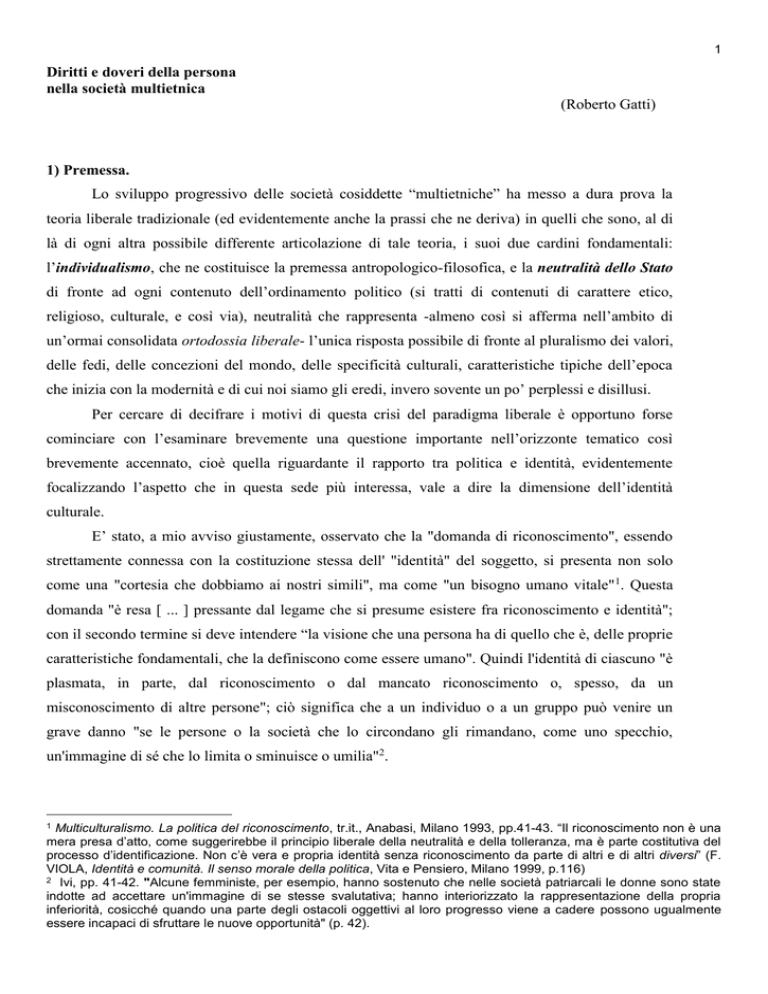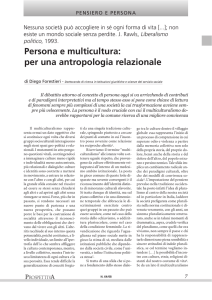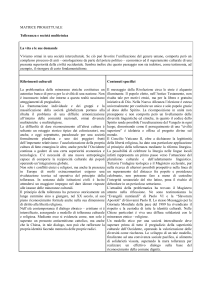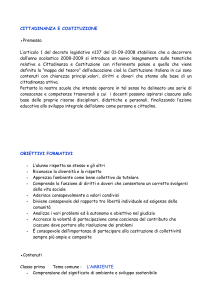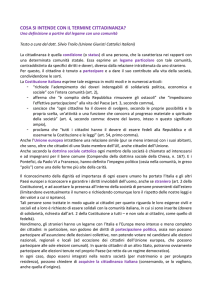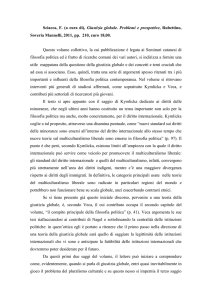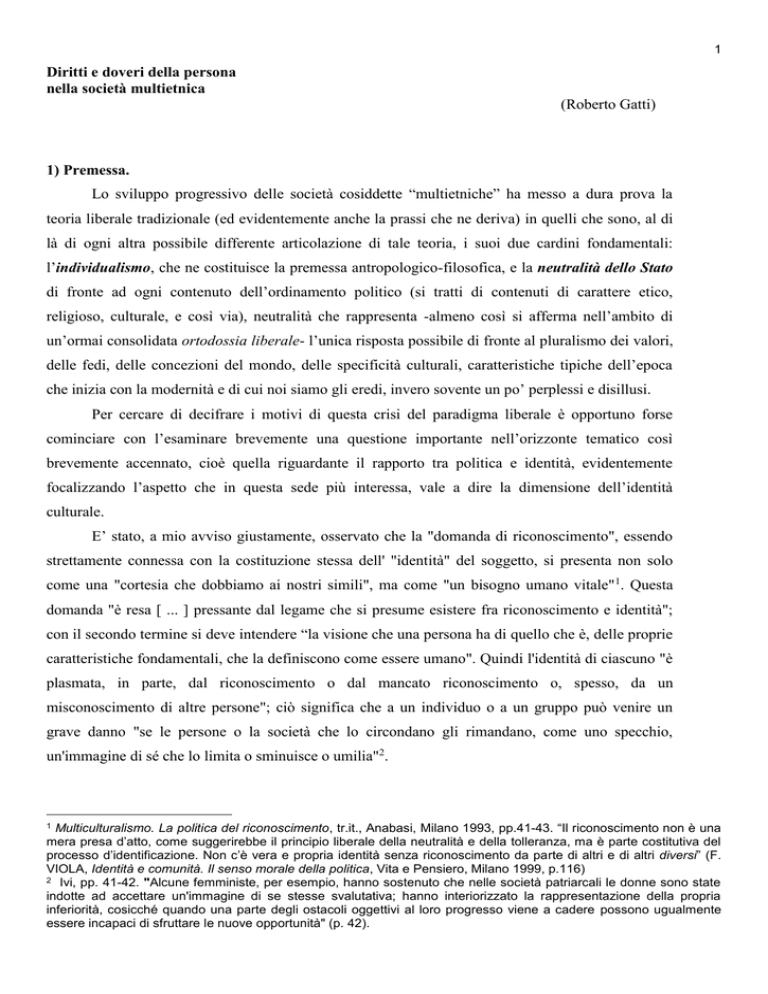
1
Diritti e doveri della persona
nella società multietnica
(Roberto Gatti)
1) Premessa.
Lo sviluppo progressivo delle società cosiddette “multietniche” ha messo a dura prova la
teoria liberale tradizionale (ed evidentemente anche la prassi che ne deriva) in quelli che sono, al di
là di ogni altra possibile differente articolazione di tale teoria, i suoi due cardini fondamentali:
l’individualismo, che ne costituisce la premessa antropologico-filosofica, e la neutralità dello Stato
di fronte ad ogni contenuto dell’ordinamento politico (si tratti di contenuti di carattere etico,
religioso, culturale, e così via), neutralità che rappresenta -almeno così si afferma nell’ambito di
un’ormai consolidata ortodossia liberale- l’unica risposta possibile di fronte al pluralismo dei valori,
delle fedi, delle concezioni del mondo, delle specificità culturali, caratteristiche tipiche dell’epoca
che inizia con la modernità e di cui noi siamo gli eredi, invero sovente un po’ perplessi e disillusi.
Per cercare di decifrare i motivi di questa crisi del paradigma liberale è opportuno forse
cominciare con l’esaminare brevemente una questione importante nell’orizzonte tematico così
brevemente accennato, cioè quella riguardante il rapporto tra politica e identità, evidentemente
focalizzando l’aspetto che in questa sede più interessa, vale a dire la dimensione dell’identità
culturale.
E’ stato, a mio avviso giustamente, osservato che la "domanda di riconoscimento", essendo
strettamente connessa con la costituzione stessa dell' "identità" del soggetto, si presenta non solo
come una "cortesia che dobbiamo ai nostri simili", ma come "un bisogno umano vitale" 1. Questa
domanda "è resa [ ... ] pressante dal legame che si presume esistere fra riconoscimento e identità";
con il secondo termine si deve intendere “la visione che una persona ha di quello che è, delle proprie
caratteristiche fondamentali, che la definiscono come essere umano". Quindi l'identità di ciascuno "è
plasmata, in parte, dal riconoscimento o dal mancato riconoscimento o, spesso, da un
misconoscimento di altre persone"; ciò significa che a un individuo o a un gruppo può venire un
grave danno "se le persone o la società che lo circondano gli rimandano, come uno specchio,
un'immagine di sé che lo limita o sminuisce o umilia"2.
Multiculturalismo. La politica del riconoscimento, tr.it., Anabasi, Milano 1993, pp.41-43. “Il riconoscimento non è una
mera presa d’atto, come suggerirebbe il principio liberale della neutralità e della tolleranza, ma è parte costitutiva del
processo d’identificazione. Non c’è vera e propria identità senza riconoscimento da parte di altri e di altri diversi” (F.
VIOLA, Identità e comunità. Il senso morale della politica, Vita e Pensiero, Milano 1999, p.116)
2 Ivi, pp. 41-42. "Alcune femministe, per esempio, hanno sostenuto che nelle società patriarcali le donne sono state
indotte ad accettare un'immagine di se stesse svalutativa; hanno interiorizzato la rappresentazione della propria
inferiorità, cosicché quando una parte degli ostacoli oggettivi al loro progresso viene a cadere possono ugualmente
essere incapaci di sfruttare le nuove opportunità" (p. 42).
1
2
Esistono oggi due vie principali per rispondere ai problemi posti dalla domanda di
riconoscimento. La prima consiste nella messa in opera della "politica dell'universalismo", alla quale
attinge la tradizione liberale classica; la seconda si identifica con la "politica della differenza", che è
fatta propria soprattutto (anche se non solo) da alcuni esponenti della corrente di pensiero ormai
generalmente etichettata con il termine di “comunitarismo” e che è contraddistinta dal fatto di
assumere con maggiore radicalità la sfide posta dalla "nozione moderna di identità", sviluppando
altresì una serrata critica della posizione liberale.
La via liberale coincide con "l'ugualizzazione dei diritti e dei titoli" e proclama la rigida
neutralità dello stato nei confronti delle differenze in quanto tali; la seconda prende altre strade.
"Naturalmente -scrive Charles Taylor- anche questa politica ha [...] una base universalistica"; infatti
sostiene che "ognuno dovrebbe essere riconosciuto per la sua identità, che è unica". Il fatto è che qui
"riconoscimento" ha un diverso significato rispetto all’accezione liberale: "ciò che si afferma con la
politica della pari dignità è voluto come universalmente uguale, come un bagaglio universale di
diritti", mentre la "politica della differenza" ci chiede invece di "riconoscere l'identità irripetibile,
distinta da quella di chiunque altro, di questo individuo o di questo gruppo".
E’ questa la ragione essenziale dell'impossibilità di assimilare le richieste che provengono dai
sostenitori della "politica del riconoscimento" alla logica del liberalismo tradizionale; essi ci
chiedono infatti “di concedere un riconoscimento a qualcosa di non condiviso universalmente",
come possono essere le differenze culturali o anche etniche. Per dirlo in breve: "là dove la politica
della dignità universale lottava per forme di non discriminazione dei tutto 'cieche' ai modi in cui i
cittadini si distinguevano fra di loro, la politica della differenza ridefinisce spesso la non
discriminazione come un qualcosa che ci impone di fare di queste distinzioni la base di un
trattamento differenziato". Tale trattamento deve valere anche a livello pubblico e implica scelte
precise dello stato che servano a tutelare, e anche a sostenere e a promuovere, abbandonando il
dogma della neutralità della sfera pubblica rispetto a tali problemi, i diritti connessi alle differenze
stesse, cioè i diritti “specificati”3.
2) L’identità e il contesto.
Risulta impossibile rispondere alla domanda concernente il perché sia da considerare così
importante il riconoscimento pubblico della differenza culturale senza riflettere su alcune
caratteristiche dell’identità del soggetto politico.
Il punto da evidenziare prima di tutti gli altri riguarda la considerazione che l’essere umano
non è fornito di un'identità definibile già a monte dello stabilirsi delle relazioni sociali, ma acquisisce
in modo pieno e compiuto tale identità soltanto nel contesto di queste relazioni. Un aspetto
3
Ivi, pp. 58-60.
3
essenziale dell'esperienza del soggetto morale è "il carattere fondamentalmente dialogico" attraverso
cui tale esperienza nasce e si sviluppa. In questa accezione il “dialogo” investe tutti i "modi di
espressione con i quali definiamo noi stessi, ivi compresi i 'linguaggi' dell'arte, della gestualità,
dell'amore e via dicendo"4. Ecco perché il riconoscimento degli altri, a livello informale e privato ma
anche sul piano formale e pubblico, diventa importante e, anzi, centrale sia per la teoria morale che
politica5.
Nella misura in cui accettiamo l’idea che l'identità del soggetto va ricondotta alle condizioni
culturali, sociali, storiche, in cui esso si è formato e sviluppato, siamo legittimati a concludere che
l'universalismo liberale6 può essere discriminatorio quando nega rilevanza pubblica, cioè pubblico
riconoscimento di tipo giuridico e politico, a differenze, come sono anche quelle culturali, che
rischiano di essere penalizzate o addirittura eclissate se si mantiene come unico parametro di
riferimento quello costituito dalla figura dei cittadino astratto, vale a dire se si tiene conto del
principio dell'uguaglianza inteso come principio formale che prescinde da ogni determinazione
specifica e particolare.
I dilemmi veramente seri e impegnativi delle attuali democrazie, infatti, nascono quando
gruppi non assimilabili ai codici culturali dominanti richiedono un tipo di trattamento giuridico
specifico che ne preservi l'identità entro un contesto in cui prevalgono norme e valori diversi: è
appunto ciò che accade sempre più frequentemente nelle società multietniche. Ai detrattori di una
politica favorevole al multiculturalismo sembra sufficiente affermare che, seguendo la strada del
riconoscimento pubblico delle differenze culturali, si finisce per ricadere in un relativismo
tribalistico che cancella di fatto lo stato di diritto e mina i diritti di cittadinanza, con la loro
fondamentale portata universalistica. Ma i sostenitori di tale posizione ignorano deliberatamente o
sottovalutano il problema cruciale: non si tratta di riporre nel cassetto, in nome di un contestualismo
acritico, questi diritti, quanto piuttosto di riconoscere, per un verso, il loro imprescindibile valore,
nonché la loro priorità normativa, e, per altro verso, di trovare il modo di tutelare, entro la loro
cornice e non fuori di essa, i diritti delle minoranze culturali7.
Senza soffermarsi sui casi particolari che possono evidentemente emergere se si accetta questa
prospettiva (e che sono notoriamente ormai materia di quotidiano dibattito), è comunque evidente il
fatto che comincia ad affiorare il possibile scarto tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale,
4
Ivi, p.50.
Sulla natura prettamente moderna del problema del "riconoscimento" Taylor, valorizzando soprattutto l'apporto di
pensatori quali Rousseau, Herder, Hegel, precisa che "con l'età moderna non è nato il bisogno di riconoscimento,
sono nate le condizioni nelle quali il tentativo di farsi riconoscere può fallire, ed è per questo che oggi, per la prima
volta, siamo consapevoli del bisogno di riconoscimento. Nell'età premoderna non si parlava di 'identità' o di
'riconoscimento' […] perché allora queste cose erano troppo poco problematiche per essere tematizzate"
(Multiculturalismo.... cit., p.54). Cfr. anche Radici dell'io. La costruzione dell'identità moderna, tr.it. di R. Rini, Il Mulino,
Bologna 1993, pp. 147ss.
6 Dato che il termine “universalismo” si presta, in questo genere di discussioni, a interpretazioni non univoche, è bene
precisare che l’accezione in cui da ora in avanti lo userò ricalca quella di Taylor.
7 Cfr., qui, anche il riferimento finale alle posizioni di Will Kymlicka.
5
4
la quale ultima sembra richiedere che, per essere veramente tale, l'opera di uguagliamento non ignori
ma offra spazio alla differenza, riconoscendone anche il valore nell’arena pubblica in riferimento ai
soggetti collettivi che in vari modi oggi chiedono di abitarla a pieno titolo e non solo come ospiti
temporanei o di secondo rango.
3) Il soggetto dei diritti.
In base a quanto rilevato fin qui è possibile affrontare due temi rilevanti: quello della
definizione del soggetto dei diritti e quello del rapporto tra diritti e doveri della cittadinanza nel
contesto creato dalla società multiculturale.
E’ stato appena accennato che le rivendicazioni di fronte alle quali si trovano gli stati
democratici in questo scorcio di secolo provengono sempre più da soggetti collettivi: le comunità
culturali sono appunto uno di essi. Sulla scorta di quello che si è sostenuto in precedenza, è forse
utile evidenziare alcune implicazioni, giuridiche e politiche, connesse a tale fenomeno. Si faceva
osservare sopra che è impossibile pensare l'identità dei soggetto entro un ambito che non sia
"dialogico", quindi relazionale: ciò che noi siamo dipende in maniera essenziale dai rapporti sociali
che intessiamo con gli altri e dal tipo di contesto in cui tali rapporti si instaurano. In sostanza "un io è
tale solo tra altri io e non può mai venir descritto senza fare riferimento a quelli che lo circondano";
soltanto nell' "interscambio dei parlanti", cioè nella "rete di interlocuzione", diviene possibile
rispondere alla domanda "chi sono io?"8. Il contesto relazionale non è né un optional, del quale si
può fare a meno se lo si desidera, né qualcosa da cui è possibile distaccarsi integralmente assumendo
nei suoi confronti, come osservatori asetticamente imparziali, l'atteggiamento di giudici neutrali, né,
ancora, un semplice mezzo utilizzabile per finalità di tipo individuale9. Esso è piuttosto una
condizione "trascendentale" e quindi insormontabile, anche se diverse sono le forme concrete e
storiche che può assumere10.
L'individualismo atomistico evidenzia, in questa prospettiva, un suo grave limite. Se accettiamo la
sua logica, infatti, siamo portati ad affermare che l'individuo stabilisce rapporti (in particolare quel tipo
specifico di rapporti che strutturano la convivenza politica) soltanto nella misura in cui questi si rivelino
indispensabili per la realizzazione delle finalità materiali dell'esistenza (l'ordine, la pace, la sicurezza),
mentre, per quanto concerne la sua identità morale e spirituale, è totalmente indipendente da ogni relazione.
L'idea, così tipica della filosofia morale moderna -e che ha trovato la sua massima espressione in Kant- dell'
"autonomia" lascia trasparire, tra i suoi molteplici significati, anche quello che richiama questa
autoreferenzialità del soggetto, questa autosufficienza in base alla quale diviene possibile definire se stessi e
scegliere i propri fini senza uscire minimamente dalla circonferenza definita dal proprio io. Non esiste un
nesso strutturale tra l'io e i suoi fini: questi ultimi rappresentano delle opzioni tra le quali è possibile decidere
basandosi sull'esercizio di una libertà la cui essenza non sta nella realizzazione di un obiettivo, di un
progetto, di un compito particolare, nel riferimento a un contesto, ma semplicemente nella facoltà di
C.TAYLOR, Radici dell’io, cit.., pp.52ss.
Ivi, pp.54-58.
10 Ivi, pp.48ss.
8
9
5
scegliere ciò che ci appare di volta in volta preferibile11. Nessun telos interno e nessuna finalità
collettivamente condivisa costituiscono elementi essenziali nella definizione dell'identità dell'io
"puntiforme" e "neutrale"12 che il pensiero morale, giuridico e politico della modernità ha progressivamente
precisato nei suoi contorni a partire da Hobbes, Locke, Hume, fino appunto a Kant (e ovviamente oltre: si
pensi, come riferimento particolarmente rilevante nel panorama filosofico contemporaneo, a Rawls).
Come questo influisca sulla teoria della cittadinanza e sul rapporto tra diritti e doveri è
chiaro. Innanzitutto il soggetto dei diritti è esclusivamente l'individuo. Non solo: si spiega anche il
ruolo assolutamente marginale che, nelle teorie liberali ispirate all'individualismo atomistico, viene
attribuito ai doveri rispetto ai diritti. Infatti, finché si pone l'accento su tutto quanto rende l'individuo
indipendente e prioritario rispetto alla società e sull'inesistenza di una socialità endogena all'essere
umano, è evidente che importanza primaria deve spettare all'attribuzione di quelle facoltà giuridiche
e politiche le quali consentono ai membri della società di perseguire i propri fini particolari e di
realizzare ciascuno il proprio progetto di vita nel rispetto dell'uguale diritto degli altri a fare la stessa
cosa. Seguendo tale linea interpretativa, la relazione tra diritto e dovere si configura come
radicalmente asimmetrica: il secondo è semplicemente lo strumento che consente di rendere stabile il
complesso equilibrio delle libertà dei singoli, e non esiste un dovere che non sia un mezzo specifico
per far valere un diritto. E' l'agenda dei diritti che determina quella dei doveri: se non ci fossero
diritti da reclamare e da garantire, non ci sarebbero doveri da compiere.
Ponendo invece in risalto la dimensione della relazionalità come aspetto non residuale o
funzionale, ma come determinazione ontologica della persona, il quadro muta notevolmente.
Cambia, in primo luogo, il rapporto tra sfera dei diritti e sfera dei doveri. In una prospettiva
generale si può affermare che, dal momento in cui la relazionalità viene considerata un costitutivo
dell'essere umano, il dovere riacquista la sua autonoma e specifica dignità di fine in sé rispetto ai
diritti: ciò che io debbo all'altro non è il corrispettivo funzionale della facoltà giuridica che mi
consente di esercitare la piena e intangibile sovranità sulle mie scelte, ma si presenta come
l'esplicitazione dell'essenziale rapporto di reciprocità che all'altro mi lega. Diritti e doveri sono, in
questo senso, le due facce della stessa medaglia e costituiscono l'espressione di una socialità che, nel
11
"Se una persona è dotata di un minimo tollerabile di buon senso ed esperienza il suo modo di formare la propria
esistenza è il migliore, non perché lo sia di per se stesso, ma perché è il suo" (J.STUART MILL, Saggio sulla libertà,
tr.it. a cura di G. Giorello-M. Mondadori, Il Saggiatore, Milano 1981, p.98). Taylor si impegna a mostrare la fragilità
dell’idea di autonomia e di “autenticità” in campo morale ove si intenda basare tale idea su un’opzione relativistica
come quella sviluppata a partire da una radicalizzazione in senso scettico della proposizione di Mill, radicalizzazione
che ha condotto a sostenere che “le cose hanno un’importanza non di per sé, ma perché gli uomini ritengono che
l’abbiano”. Ciò, sostiene Taylor, calcando i toni, “è una follia”, in quanto “una delle cose che non possiamo fare, se
vogliamo definire noi stessi in maniera significativa, è sopprimere o negare gli orizzonti entro i quali le cose assumono
un significato per noi”. Ed è proprio questa, invece, la “mossa auto-negatrice” che compie la nostra “civiltà
soggettivistica” quando si pretende di difendere il valore delle scelte che esprimerebbero l’autenticità e la capacità di
autodeterminazione del soggetto, asserendo contemporaneamente l’impossibilità di discernere razionalmente “gli
orizzonti di valore”. Ma, “a meno che alcune opzioni siano più significative di altre, l’idea stessa dell’auto-scelta scade
nella banalità”: “Non potrei rivendicare una vita auto-scelta e sfoderare l’intero vocabolario nietzschiano dell’autocreazione, per il solo fatto che a pranzo scelgo bistecca e patatine fritte anziché una poutine” (Il disagio della
modernità, tr.it. di G. Ferrara Degli Uberti, Laterza, Roma-Bari 1994, pp.43-47).
12 C.TAYLOR, Radici dell'io..., cit.,p.70.
6
suo attuarsi, richiede necessariamente un corretto equilibrio tra ciò di cui si deve godere in ragione
dell'insopprimibile dignità di quella particolare persona che io sono, da un lato, e, dall'altro, ciò che
debbo agli altri e alla società in ragione dei riconoscimento di quello che inscindibilmente mi lega ad
essi. Un'antropologia della relazionalità conduce alla contestazione e al rigetto della tesi della
"priorità dei diritti”, indicando invece la via verso il riequilibrio del rapporto tra doveri e diritti 13.
Nella prospettiva specifica qui adottata è opportuno mettere in rilievo il fatto che la sfera del
dovere risulta valorizzata anche nella direzione che riguarda quelli che potrebbero essere definiti i
nuovi destinatari di doveri nelle società multietniche. Infatti, se è accettabile quanto sin qui proposto
sul nesso indissolubile tra identità del soggetto e contesto specifico entro il quale questa identità si
forma e si sviluppa, ne consegue che garantire l’integrità di questi contesti, nonché il rispetto dei
valori che in essi hanno progressivamente assunto una determinata fisionomia, diviene un dovere cui
i cittadini delle attuali democrazie sono tenuti nei confronti di quanti, pur portatori di codici
normativi diversi da quelli dominanti nella nostra parte del mondo, domandano un riconoscimento
giuridico e politico della loro identità. A meno che, naturalmente, non si pretenda, come
contropartita per la loro accettazione entro i confini del nostro mondo, di far pagare l’alto prezzo
della rinuncia a questa identità, limitandosi a sostituire la barbara logica del rifiuto dell’ospitalità
(che comunque, come sappiamo, è molto meno rara di quanto ci si potrebbe attendere in società che
fanno degli ideali democratici il loro principio di legittimazione) con l’imposizione del criterio
secondo cui l’ospitalità diviene sinonimo di omologazione culturale, qualcosa cioè che finirebbe per
cancellare quello sfondo che dà senso all’identità morale del soggetto.
Si può passare da qui all’altro problema precedentemente accennato, concernente i soggetti
dei diritti della cittadinanza. Mentre per il liberalismo che si muove sulla scia di Locke il soggetto di
tali diritti non può essere, per i motivi già illustrati, che l'individuo nella sua singolarità, per
un'antropologia orientata nel senso di privilegiare l'essenza comunitaria della persona il soggetto dei
diritti è costituito anche dalle comunità e associazioni nelle quali si può esplicare la socialità
intrinseca dell'essere umano.
Non c’è dubbio sul fatto che la tradizione liberaldemocratica e liberalsocialista è una
tradizione estremamente diversificata al suo interno; ma l’elemento unificante -oggi ancor più
evidenziato dalle risposte che, nell’ambito di tale tradizione, vengono fornite ai problemi posti dalla
realtà delle società multietniche- è rappresentato proprio da quell'opzione individualistica che
conduce a interpretare le richieste di riconoscimento avanzate attualmente da gruppi e da soggetti
collettivi come se fossero la pura e semplice espressione di spinte irrazionali e di rigurgiti “tribali".
Sta di fatto però che, a meno di voler rimanere pervicacemente attaccati a pregiudizi ideologici, si
deve riconoscere che alcune rivendicazioni provenienti da gruppi culturali ed etnici in nome dei
13
Cfr. C.TAYLOR, Atomism, in Philosophy and the Human Sciences, Philosophical Papers 2, University Press,
Cambridge 1985, p.207.
7
diritti connessi alla loro specificità non sono affatto prive di fondamento razionale. Può
legittimamente nascere quindi il sospetto che l'etichetta di irrazionalismo e anche l'enfatizzazione
dei rischi connessi alla "politica dei riconoscimento" (favorire il particolarismo, disintegrare la
coesione sociale, distruggere le basi dello stato dì diritto, fomentare i conflitti etnici e localistici, e
così via14) sia spesso più che altro la manifestazione del disagio di fronte alla necessità di rimettere
in discussione presupposti considerati ormai al di sopra di ogni possibilità di critica. Che riconoscere
diritti “collettivi” introduca una tensione rispetto alla tradizione di pensiero e alla prassi liberali constatazione peraltro ovvia- non è, di per sé, un motivo plausibile per porre fuori gioco la
rivendicazione di tali diritti prima ancora di sondarne le radici e la possibile compatibilità con i
principi dello stato di diritto15.
Continuare a contrapporre, secondo la retorica di un liberalismo di maniera, uguaglianza e
differenza come polarità contrapposte e non componibili, legando il destino della libertà alla
reclusione della differenza nell’ambito della privatezza e del pre-politico non fa fare molti passi in
avanti alla riflessione su questi argomenti, anche se forse offre il vantaggio di poter incasellare i
conflitti attuali all’interno di schemi consolidati e quindi dotati, se così si può dire, di un certo potere
di rassicurazione. E’ significativo che un autore legato alla tradizione democratico-liberale come
Will Kymlicka abbia riconosciuto, in suo libro recente e importante, il fallimento della tesi liberale
secondo cui “la nuova importanza attribuita ai ‘diritti umani’ avrebbe risolto i conflitti” riguardanti
le minoranze culturali: “Piuttosto che una tutela diretta dei gruppi vulnerabili, ottenuta mediante il
conferimento di diritti speciali ai loro membri, si confidava nella tutela indiretta delle minoranze
culturali mediante la garanzia di diritti civili e politici fondamentali a ogni individuo, a prescindere
dalle sue appartenenze di gruppo. I diritti umani fondamentali -come la libertà di parola, di
associazione e di coscienza- benché siano attribuiti agli individui, vengono tipicamente esercitati
assieme ad altri e rappresentano quindi una tutela per la vita di gruppo. Secondo il ragionamento dei
liberali, laddove questi diritti individuali sono saldamente radicati, non serve conferire ulteriori diritti
ai membri di specifiche minoranze etniche o nazionali”16. Ma quella che Nathan Glazer ha definito
la “benigna noncuranza” dello stato nei confronti della pluralità delle culture esistenti oggi al suo
interno ha mostrato la corda di fronte ai nuovi problemi della cittadinanza multiculturale: ”Quali
lingue devono essere riconosciute nei parlamenti, negli uffici pubblici e nei tribunali? Ogni gruppo
Cfr., per esempio, E.VITALE, Il soggetto e la comunità. Fenomenologia e metafisica dell’identità in Charles Taylor,
Giappichelli, Torino 1996, specie cap.V. Si veda anche Liberalismo e multiculturalismo. Una sfida per il pensiero
democratico, Laterza, Roma-Bari 2000, che è l’espressione emblematica delle obiezioni del liberalismo tradizionale,
cioè di quel liberalismo che intende mantenere ferme le sue premesse individualistiche forti senza indebolimenti di
alcun genere (pp.XVIIss), al “liberalismo multiculturalista” (con particolare riferimento alle posizioni di Will Kymlicka).
15 Si veda una sintesi dei motivi che vengono addotti per criticare, dal punto di vista teorico, il concetto di “diritti
collettivi” in A.E.GALEOTTI, Multiculturalismo. Filosofia politica e conflitto identitario, Liguori, Napoli 1999, pp.17-81
(anche se poi nel testo si sostiene che, di fatto, talvolta per le democrazie liberali è consigliabile tenere una condotta
flessibile di fronte a questo tipo di diritti, i quali comunque non possono mai, in linea di principio, essere considerati
“pretese legittime” [p.81]).
16 W. KYMLICKA, La cittadinanza multiculturale, tr. it., Il Mulino, Bologna 1999, pp. 9-10.
14
8
etnico e nazionale deve poter accedere a forme di istruzione a finanziamento pubblico svolte nella
propria lingua madre? I confini interni (circoscrizioni elettorali, province, stati) vanno tracciati in
modo tale da permettere alle minoranze culturali di costruire una maggioranza in una determinata
area? I poteri di governo devono essere devoluti dal livello centrale a quelli regionali o locali
controllati da minoranze culturali, quanto meno su questioni culturalmente delicate, come
l’immigrazione, la comunicazione e l’istruzione? Gli incarichi politici vanno distribuiti secondo
criteri di proporzionalismo nazionale o etnico? I territori tradizionali di popolo indigeni devono
essere usati a loro esclusivo beneficio, e quindi ad altri deve essere vietato di insediarvisi o di
sviluppare le loro risorse? Le minoranze hanno il dovere di integrarsi? Quale grado di integrazione
culturale va richiesto agli immigrati e ai rifugiati prima di concedere loro la cittadinanza?”. Il punto
“non sta nel fatto che le tradizionali dottrine dei diritti umani forniscono una risposta sbagliata a
queste domande, ma risiede nel fatto che spesso esse non ci danno alcuna risposta. Il diritto alla
libertà di parola non ci dice quale sia la politica linguistica più adeguata; il diritto di voto non ci dice
come tracciare i confini dei collegi elettorali, né come distribuire il potere fra i vari livelli di
governo; il diritto alla mobilità non ci dice quali politiche dell’immigrazione e della naturalizzazione
adottare”. D’altra parte, nella misura in cui tali questioni sono state sottoposte “ai processi
decisionali di tipo maggioritario”, ciò ha creato spesso condizioni di ingiustizia per le minoranze
culturali, indotte proprio dalle scelte della maggioranza, portando ad una intensificazione dei
“conflitti etnoculturali”17. Da qui nasce la proposta di integrare i “diritti umani tradizionali con i
diritti delle minoranze”: “Una teoria completa della giustizia negli stati multiculturali
-scrive
Kymlicka- deve includere sia i diritti universali, accordati agli individui a prescindere dalle loro
particolari appartenenze di gruppo, sia alcuni diritti differenziati per gruppo o a ‘statuto speciali’ per
le culture minoritarie”. Poiché però non può essere dimenticato che il “linguaggio dei diritti delle
minoranze è stato usato a abusato” per operare forme di segregazione razziale e di apartheid, diventa
necessario che “una teoria liberale dei diritti delle minoranze [spieghi] come essi possano coesistere
con i diritti umani e incontrare vincoli nei principi di libertà individuale, democrazia e giustizia
sociale”18.
L’ultimo problema sollevato nella citazione che precede è ovviamente quello fondamentale.
Mi limito qui a proporre, senza poterla argomentare come sarebbe necessario, la tesi che la
coesistenza tra i diritti di cittadinanza basati su premesse universalistiche -che riguardano sempre più
non solo l’appartenenza a una singola nazione ma quella sovranazionale, configurandosi quindi
progressivamente, in una loro dimensione essenziale, come diritti cosmopolitici- e quelli delle
minoranze etnico-culturali si può ottenere riconoscendo un ordinamento gerarchico (per riprendere il
lessico rawlsiano) tra i primi e i secondi. Ciò significa che i diritti inerenti alle differenze culturali
17
18
Ivi, pp. 13-14.
Ivi, p. 15.
9
possono ambire a una tutela giuridica solo nella misura in cui il loro esercizio non violi i diritti
fondamentali inerenti alla dignità della persona, così come sono sanciti sia nelle costituzioni delle
singole società politiche democratiche, sia in ormai numerose dichiarazioni internazionali, questi
diritti, com’è noto, attengono al rispetto dell’integrità fisica e morale dell’essere umano, della libertà
civile e politica, della giustizia sociale. Infatti, se pure è vero che le basi filosofiche di tali diritti
fondamentali e gli strumenti giuridici per la loro garanzia istituzionale sono nati prevalentemente in
un contesto storico-culturale ben preciso e definito, circoscritto dai confini della tradizione morale e
politica dell’Occidente, risulta però anche ben difficile non riconoscere il fatto che in essi si
esprimono valori di portata universale, che possono essere oggetto di un consenso razionale tale da
imporsi, attraverso un confronto dialogico, al di là delle specificità culturali, etniche, religiose.
L’esempio più significativo e storicamente rilevante di questa possibilità rimane la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo del 1948.
Il che non esclude peraltro che proprio questo confronto possa costituire lo spazio entro il
quale far maturare un processo di maggiore autoconsapevolezza e autoriflessione critica in merito ai
valori in questione, che non sono degli assoluti fuori dalla storia, ma espressione di una ricerca
secolare mai definitivamente chiusa, e inevitabilmente sempre imperfetta e perfettibile, in merito a
ciò che definisce e delimita l’appartenenza a una società fondata sulla libertà. Niente documenta
meglio questa possibilità di autoriflessione critica che il ripensamento in corso del rapporto tra
libertà, uguaglianza, differenza come momenti costitutivi della cittadinanza democratica oggi,
ripensamento che è nato appunto come conseguenza del confronto imposto dal progressivo sviluppo
delle società multietniche.
Se ci si muove lungo tale linea, è evidente che pratiche come l’infibulazione, l’escissione, la
richiesta del marocchino che i carabinieri riportino a casa con la forza la moglie che ha deciso di
interrompere il rapporto matrimoniale, sono escluse. Ma escluse non dovrebbero essere però tutta
un’altra serie di pratiche (costruzione di luoghi di culto, spazi per la testimonianza e l’attività
culturale e politica, curricula scolastici differenziati o che comunque tengano colto delle differenze
culturali, provvedimenti a sostegno di minoranze che incontrino difficoltà particolarmente gravi per
la loro sopravvivenza, ecc.), che non configgono affatto con i diritti inerenti la dignità della persona,
ma consentono di garantirli in modo coerente e pieno.
Questa posizione è ovviamente diversa da quella liberale “ortodossa” per il fatto di schiudere
lo spazio pubblico alla differenza culturale. All’obiezione poi che, data la priorità attribuita ai diritti
della cittadinanza a base universalistica, altro non sia, in fin dei conti, che un modo per riproporre, in
forma forse solo un po’ più scaltrita, una logica eurocentrica, si può rispondere che sostenere quanto
sopra esposto non è più viziato di “eurocentrismo” di quanto lo sia l’affermazione secondo cui ogni
ragionevole riflessione sulla cittadinanza democratica deve muovere dal principio che, prima di
10
essere differenti in relazione all’appartenenza a questa o quella cultura, siamo uguali in quanto
persone, portatrici di una dignità che postula l’esercizio della libertà e il godimento di condizioni di
vita sociali eque. Come un universalismo irrigidito finisce per negare margini di libertà che sono
invece essenziali, così un “multiculturalismo” che assolutizzi la dimensione della differenza si toglie
il terreno da sotto i piedi, perché cancella quello sfondo comune a partire dal quale le differenze
culturali possono non solo assumere il loro pieno significato, ma anche convivere pacificamente e
quindi “riconoscersi” in modo autentico.
4) Tolleranza e reciprocità
Un’altra questione è frequentemente proposta quando ci si incammina lungo la strada così
brevemente delineata: deve valere, nell’ambito della politica del riconoscimento, il principio della
tolleranza reciproca? Prendo ad esempio, per illustrare una possibile risposta, il punto di vista
espresso qualche anno fa da Mario Losano: “La tolleranza presuppone un mondo di culture solo
diverse, ma non contrastanti. La reciprocità, invece, traccia confini tra amici e nemici: ‘Applicherò a
ciascuno degli altri le stesse misure che egli applica a me’. Si può dire che la reciprocità è il livello
minimo di tolleranza: dove un integralismo non ammette comportamenti diversi dai propri non è
possibile la convivenza di culture diverse. Solo l’uso di rigidi criteri di reciprocità può evitare che il
nostro ordinamento socio-economico venga travolto: possono venire ammessi al suo interno soltanto
quegli atteggiamenti culturali che non abbiano potenzialità distruttive […]. Dunque si può far parte
di un ordinamento soltanto se non si vuol distruggerlo […]. Sul piano teorico possiamo sognare
l’armonica società multietnica e multiculturale. Sul piano pratico non possiamo concederci il lusso di
realizzarla in un unico luogo”19.
E’ noto che questa posizione è riemersa recentemente nel dibattito sulle regole che
dovrebbero disciplinare l’immigrazione nel nostro paese; oltre che qualche esponente politico, anche
alcuni autorevoli esponenti della Chiesa cattolica in Italia lo hanno fatto proprio, pur con qualche
distinguo e qualche variazione sul tema. Altrettanto noto è il fatto che si tratta, mutatis mutandis,
della riproposizione di un problema filosofico-politico e giuridico che ha alle sue spalle qualche
secolo di storia e di discussioni: qual è l’estensione ragionevolmente accettabile e quali sono i limiti
invalicabili della tolleranza?
Che non si debbano tollerare gli intolleranti è senz’altro un principio che si può sottoscrivere,
e farlo serve a evitare il popperiano paradosso della tolleranza, cioè il rischio di creare quella
situazione in cui, per aver tollerato quanti non credono nel valore della tolleranza, possiamo
rischiare, concedendo loro la possibilità di fare proseliti e di conquistare il potere, di vedere abolita
19
M. LOSANO, Contro la società multietnica, in “Micro Mega”, 1, 1991, pp. 13-14.
11
la tolleranza e tutto il corredo delle libertà cui essa è associata. La storia, anche quella più vicina a
noi, ci ammonisce esaurientemente in proposito. In questione, però, mi pare, non dovrebbe essere, in
relazione ai casi di cui qui si tratta, il principio in sé, quanto piuttosto le modalità di applicazione di
esso. Detto in altri termini: la linea di demarcazione tra tolleranti e intolleranti non va tracciata sulla
base di petizioni di principio basate su una considerazione puramente astratta dei valori delle culture
e/o delle religioni che oggi popolano sempre più numerose le nostre società. Infatti questo tipo di
considerazione si presterebbe a dispute infinite e anche ad inevitabili arbitrii: chi ha ragione, in modo
incontrovertibile, tra quanti affermano che la religione islamica non è di per sé intollerante, ma lo è
diventata in un certo quadro storico del tutto particolare (che peraltro presenta varie differenziazioni
interne e non secondarie eccezioni), e quanti sostengono invece che l’intolleranza fa parte, per così
dire, del suo patrimonio genetico e del suo spirito? Ci si deve chiedere quale tipo di normazione
giuridica potrebbe nascere se si rimanesse su questo piano: probabilmente una normazione
profondamente viziata da ipoteche ideologiche, da pregiudizi di parte, da carenza di conoscenze
adeguate, e così via enumerando.
Appare piuttosto preferibile e più ragionevole basarsi non su argomenti a priori, ma sui
comportamenti di fatto, nei contesti specifici e in relazione ad azioni determinate, dei soggetti
interessati, secondo quello che è peraltro il principio basilare della tolleranza nella tradizione liberaldemocratica e anche nella maggior parte degli ordinamenti giuridici che ad essa si richiamano. Con
tutti i limiti precedentemente rilevati, resta pur sempre vero che questa tradizione serve
positivamente ad ammonirci ancora sulle incognite e sulle componenti potenzialmente inique di una
limitazione della tolleranza che assuma come base di giudizio le opinioni (anzi, molto spesso, ciò
che noi pensiamo delle opinioni degli altri o, peggio, ciò che gli esponenti di una cultura
maggioritaria pensano delle opinioni espresse dai rappresentanti di culture minoritarie non solo
lontane dai parametri di giudizio consolidato, ma sovente poco o male conosciute) e non le azioni,
che certamente si prestano ad arbitrii interpretativi molto minori. E ciò continua ad essere vero
malgrado il fatto che, come sappiamo, è alquanto labile e sfumato il confine che separa il “pensare”
e il “dire”, da un lato, e il “fare”, dall’altro. Un confine difficile da tracciare non è però un confine
inesistente, è semmai un confine da salvaguardare, vigilare e aggiustare con costante attenzione,
pazienza, prudenza.
Mi pare quindi che sia da escludere ogni tentativo di recinzione giuridica dell’area della
cittadinanza e ogni sostegno a criteri di ammissione o esclusione da essa secondo procedure stabilite,
per così dire, deduttivamente (es., la religione islamica è intollerante, erga non va concessa libertà di
espressione e di culto ai suoi seguaci che ospitiamo nel nostro paese, cominciando con l’impedire la
costruzione di moschee e iniziative simili), mentre sarebbe da ammettere un metodo che tenga conto
soltanto dei comportamenti di volta in volta oggettivamente e concretamente contrastanti con le
12
norme dell’ordinamento giuridico che tutelano la dignità e l’integrità della persona. Perseguibile è
chi viola di fatto queste norme e non la totalità composta da quanti noi presumiamo possano una
volta o l’altra violarle sulla base di quello che riteniamo sia lo spirito informatore della loro
professione di fede o del loro bagaglio culturale.
5) Quale libertà?
In sintesi, una schematica stilizzazione dei caratteri di una politica a favore del
multiculturalismo potrebbe essere articolata in queste succinte, e perciò fin troppo semplificate, tesi:
a) Accanto ai diritti tipici della tradizione liberal-democratica, devono essere riconosciuti i
diritti delle minoranze, che non sono interpretabili come diritti pertinenti solamente all’individuo, ma
attengono alla comunità culturale come peculiare soggetto di diritto.
b) I diritti “specificati” hanno il loro radicamento nell’appartenenza a tale comunità, la quale
può essere oggetto di politiche di sostegno e di tutela da parte dello stato, qualora le circostanze lo
richiedano (per esempio, quando esista il pericolo dell’estinzione di una determinata comunità
culturale o quando quest’ultima rischi di vedere eclissati i suoi caratteri da politiche tendenti, più o
meno consapevolmente, all’omologazione a favore dei contenuti culturali dominanti).
c) Nell’ambito del rispetto e della salvaguardia dei valori che definiscono il profilo culturale
di una nazione, cioè il suo ethos, deve essere ammesso e giuridicamente garantito lo spazio per
espressioni culturali diverse da quella maggioritaria.
Sia consentito un breve inciso: se molte “nazioni” dell’Occidente rischiano oggi di non essere
più tali -come spesso è stato detto anche della nostra-, il motivo principale non è certo l’insidia
costituita dalla concorrenza di culture alternative, ma perché, a differenza di molte di queste ultime,
le culture nazionali delle democrazie avanzate di questa parte del mondo hanno perso col tempo
l’aggancio con le proprie radici, hanno smarrito la memoria dei loro fondamenti morali, spirituali,
religiosi, hanno visto declinare la capacità di pensare a se stesse sulla base di codici di riferimento
condivisi che non siano quelli funzionalistici della società opulenta, sono rimaste vittime di un
relativismo che ha corroso la loro unità interna. In questo senso uno sguardo non sospettoso per
principio, ma semplicemente un po’ attento, non può non sorprendere una qualche malafede
nell’atteggiamento che relega a rigurgito del passato l’affacciarsi, nei nostri paesi, di culture la cui
forza di coesione viene bollata senza esitazioni come residuo delle “società chiuse” e arcaiche. Una
tolleranza che, dopo aver etichettato come equivalenti tutte le fedi religiose, le opzioni morali, le
scelte di vita, gira a vuoto su se stessa, non sa rispondere, se non con i clichès di un liberalismo di
maniera, a chi chiede rispetto senza voler pagare per questo il dazio dell’accettazione dei principi
13
della “ragione cinica”; e forse in questa sua impasse affiora, anche se subito soffocato, qualche
germe di ripensamento critico.
d) I confini che delimitano il campo legittimo di esercizio dei diritti delle minoranze sono
determinati dall’obbligo dell’accettazione e del rispetto dei diritti basilari della democrazia, cioè
libertà, uguaglianza, giustizia sociale, quei diritti in cui si compendia la dignità della persona
riguardo a ciò che la caratterizza al di là e al di sopra di ogni differenza etnico-culturale. Il
contestualismo fatto proprio dalla politica del riconoscimento non ha nulla a che fare -malgrado ciò
che spesso viene sostenuto dai critici di questa posizione- con un relativismo culturale che rigetta la
possibilità di stabilire una priorità nella scala dei codici normativi in base ai quali una società
democratica multietnica e multiculturale dovrebbe reggersi; propone invece l’idea che l’accettazione
dell’universalismo in relazione ai diritti fondamentali della persona possa convivere con il rispetto
dei diritti della differenza, quando i secondi non violino i primi e fermo restando anche che la stessa
riflessione sui diritti fondamentali può essere problematizzata e arricchita dal confronto con culture
politiche e giuridiche diverse dalla nostra: o crediamo veramente che il pensiero occidentale abbia
già detto tutto quello che c’era da dire sul tema dei diritti della persona, in ambito politico e non
politico, e che abbia il monopolio della corretta impostazione in merito a questioni di giustizia?
e) Il riconoscimento e l’eventuale sostegno pubblico delle differenze culturali così come si
presentano oggi nelle società democratiche è un dovere che nasce dalla consapevolezza che il
mantenimento, nei limiti del possibile, dello sfondo entro il quale si è formata e deve continuare a
svilupparsi l’identità della persona costituisce un requisito essenziale per la garanzia dell’integrità
etica e spirituale di essa; tanto più questo vale nelle circostanze di sradicamento nelle quali, a seguito
dei sempre più intensi e spesso drammatici processi di immigrazione, vivono le minoranze culturali
oggi presenti nei paesi dell’occidente sviluppato, dato che proprio queste circostanze rendono incerta
e precaria la stabilità di tale sfondo.
f) Questo riconoscimento pubblico e anche la tutela delle specificità culturali hanno, se
quanto sostenuto fin qui è accettabile, un fondamento che, lungi dall’essere collegato a una mentalità
incline al particolarismo “tribalistico”, si radica in una chiara istanza di universalità: in base ad essa
si può affermare che ogni persona deve disporre di condizioni tali da consentire la cura della propria
identità, inseparabile dal contesto di valori, di usanze, di costumi, di abitudini che hanno conferito
progressivamente a tale identità la forma e i contenuti che ha; negare queste condizioni equivale a
spezzare il filo della storia lungo la quale l’identità stessa si sviluppa e si definisce, significa privarla
dell’orizzonte che, solo, le può dare il suo pieno senso. C’è una violenza implicita nell’ideale
dell’universalismo così come lo ha formulato e sempre difeso il liberalismo nella sua forma
tradizionale: è la violenza che si esercita laddove l’uguaglianza coincide con l’ “equivalenza”, quella
equivalenza che riduce tutto all’interscambiabile e che quindi non tollera la differenza se non a
14
condizione di riassorbirla entro i suoi parametri, annullandola come tale (la società della
manipolazione sistematica ci ha insegnato purtroppo mille modi in cui la differenza può essere
apparentemente conservata ma sostanzialmente svuotata di significato)20.
Nessuno certo può negare che la coesistenza tra comunità etnico-culturali diverse sia difficile
e comporti anche dei pericoli: far convivere uguaglianza e differenza non è un compito agevole e se,
da un lato, richiede attenzione affinché la prima non annulli la seconda, impone anche di vigilare al
fine di evitare che le ragioni della differenza non conducano a rimettere in discussione i diritti umani
fondamentali che sono alla base della democrazia. Ma se, alle origini della democrazia liberale, non
ci fossero stati filosofi e uomini politici disposti a correre rischi e capaci di far fronte alle questioni
che allora erano sul tappeto, lo stato di diritto non sarebbe mai nato. E’ nell’essenza della libertà il
non poter essere irrigidita in una forma storica e istituzionale data: chi rinuncia alla sfida di
individuare, pur con tutta la fatica del caso, le strade sempre nuove che si devono percorrere per farla
vivere nella vicenda storica tradisce la sostanza della libertà stessa. Ammettiamo pure -anche se non
è poi così scontato- che le sfide attuali siano più impegnative di quelle che hanno accompagnato la
nascita della teoria liberale alle origini della modernità; ma nessun buon liberale, di allora e di oggi,
considererebbe questo un serio motivo per accontentarsi dello status quo e abbandonare la partita
che c’è da giocare, partita la cui posta è la costruzione di una più ospitale democrazia per chi oggi
bussa alla nostra porta portando con sé non solo la sua povertà, la sua nudità, la sua disperazione, ma
anche un patrimonio culturale al quale è dovuto rispetto; e porta anche la speranza che ci sia una
qualche corrispondenza tra l’ideale del rispetto della persona -di ogni persona, con la sua
insostituibile e specifica identità e con la sua storia-, questo ideale-cardine su cui la democrazia si
basa, e la realtà. Fortunatamente, come recita un venerando detto, che torna quanto mai a proposito
quando si assiste ai tentennamenti delle politiche di accoglienza praticate nelle nostre ormai
appagate e un po’ disincantate società dell’opulenza, la speranza, malgrado tutto, è l’ultima a morire
e mantiene tutta la sua tenacia di fronte all’incubo che, come alibi opposto alla difficoltà di risolvere
i tanti problemi sul tappeto, riemerga vincente, a poco più di mezzo secolo di distanza, il motto con
cui la Svizzera rispose ai profughi ebrei in fuga dalla Germania hitleriana: “Spiacenti, la barca è
piena”.
Che la fraseologia della libertà si trasformi, oggi, in copertura ideologica del cinismo di
società
appagate,
diventate
indifferenti
alle
sorti
dell’altro,
rese
ottuse
dai
processi
dell’omologazione che hanno invaso ogni forma espressiva: è questo esito, soprattutto e innanzitutto
questo brutale esito, che chi si sente erede della tradizione dell’ umanesimo politico è chiamato a
contrastare con tutto l’impegno e tutta la forza che la posta in gioco richiede.
20
M. HORKHEIMER-T. ADORNO, Dialettica dell’illuminismo, tr. it., Einaudi, Torino 1966, pp. 11-51 e 130-180.
15
Roberto Gatti