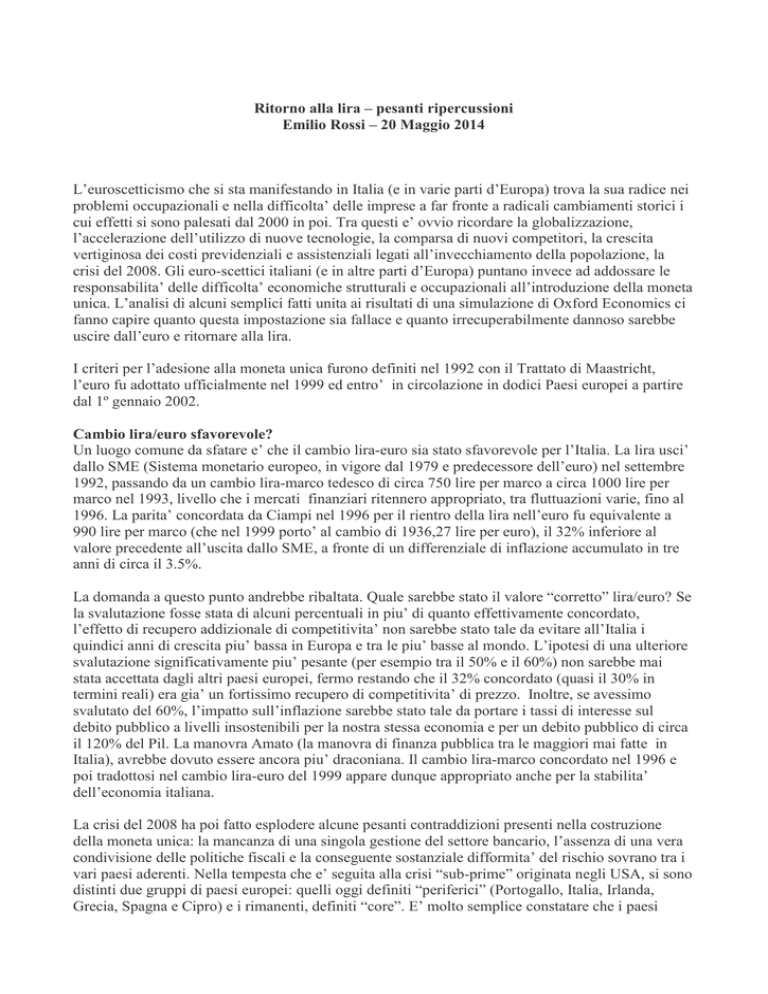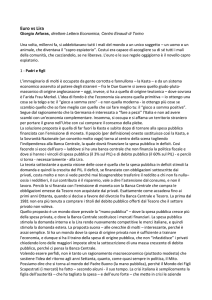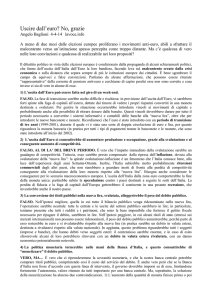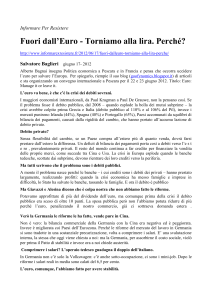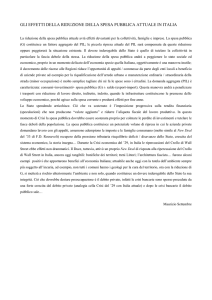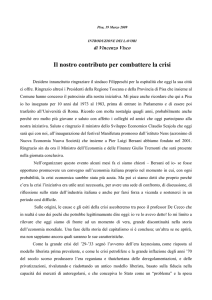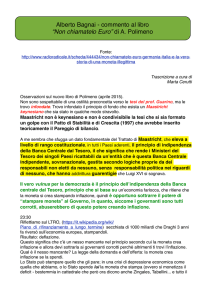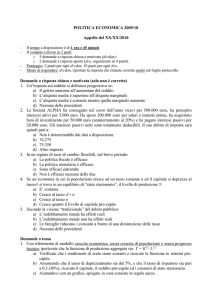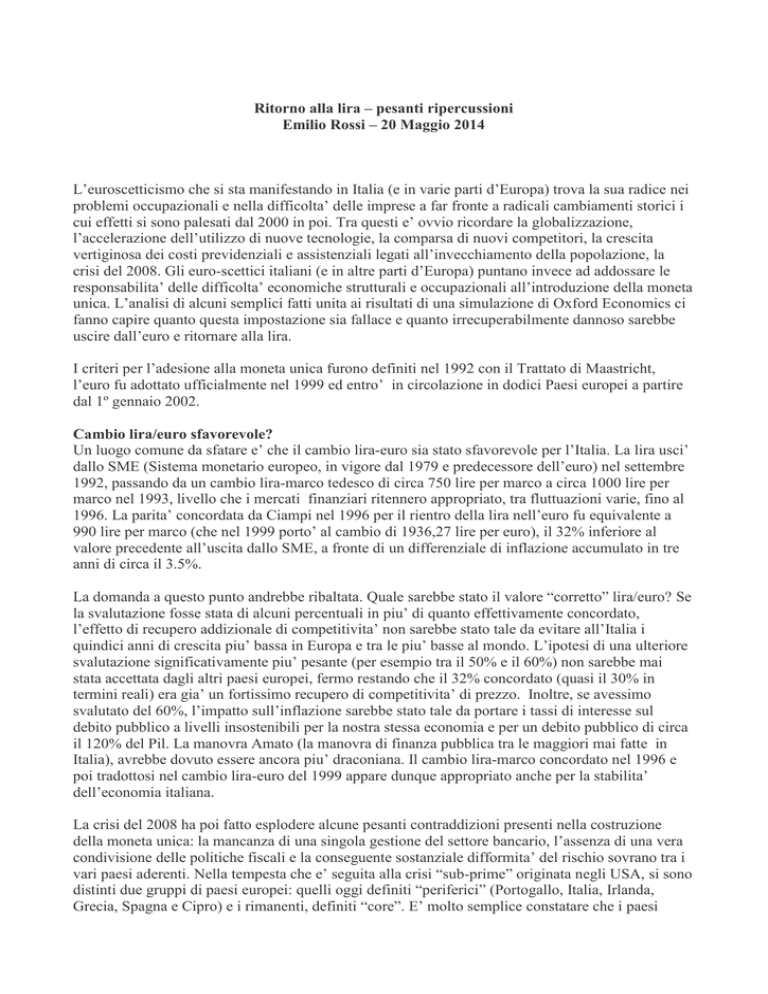
Ritorno alla lira – pesanti ripercussioni
Emilio Rossi – 20 Maggio 2014
L’euroscetticismo che si sta manifestando in Italia (e in varie parti d’Europa) trova la sua radice nei
problemi occupazionali e nella difficolta’ delle imprese a far fronte a radicali cambiamenti storici i
cui effetti si sono palesati dal 2000 in poi. Tra questi e’ ovvio ricordare la globalizzazione,
l’accelerazione dell’utilizzo di nuove tecnologie, la comparsa di nuovi competitori, la crescita
vertiginosa dei costi previdenziali e assistenziali legati all’invecchiamento della popolazione, la
crisi del 2008. Gli euro-scettici italiani (e in altre parti d’Europa) puntano invece ad addossare le
responsabilita’ delle difficolta’ economiche strutturali e occupazionali all’introduzione della moneta
unica. L’analisi di alcuni semplici fatti unita ai risultati di una simulazione di Oxford Economics ci
fanno capire quanto questa impostazione sia fallace e quanto irrecuperabilmente dannoso sarebbe
uscire dall’euro e ritornare alla lira.
I criteri per l’adesione alla moneta unica furono definiti nel 1992 con il Trattato di Maastricht,
l’euro fu adottato ufficialmente nel 1999 ed entro’ in circolazione in dodici Paesi europei a partire
dal 1º gennaio 2002.
Cambio lira/euro sfavorevole?
Un luogo comune da sfatare e’ che il cambio lira-euro sia stato sfavorevole per l’Italia. La lira usci’
dallo SME (Sistema monetario europeo, in vigore dal 1979 e predecessore dell’euro) nel settembre
1992, passando da un cambio lira-marco tedesco di circa 750 lire per marco a circa 1000 lire per
marco nel 1993, livello che i mercati finanziari ritennero appropriato, tra fluttuazioni varie, fino al
1996. La parita’ concordata da Ciampi nel 1996 per il rientro della lira nell’euro fu equivalente a
990 lire per marco (che nel 1999 porto’ al cambio di 1936,27 lire per euro), il 32% inferiore al
valore precedente all’uscita dallo SME, a fronte di un differenziale di inflazione accumulato in tre
anni di circa il 3.5%.
La domanda a questo punto andrebbe ribaltata. Quale sarebbe stato il valore “corretto” lira/euro? Se
la svalutazione fosse stata di alcuni percentuali in piu’ di quanto effettivamente concordato,
l’effetto di recupero addizionale di competitivita’ non sarebbe stato tale da evitare all’Italia i
quindici anni di crescita piu’ bassa in Europa e tra le piu’ basse al mondo. L’ipotesi di una ulteriore
svalutazione significativamente piu’ pesante (per esempio tra il 50% e il 60%) non sarebbe mai
stata accettata dagli altri paesi europei, fermo restando che il 32% concordato (quasi il 30% in
termini reali) era gia’ un fortissimo recupero di competitivita’ di prezzo. Inoltre, se avessimo
svalutato del 60%, l’impatto sull’inflazione sarebbe stato tale da portare i tassi di interesse sul
debito pubblico a livelli insostenibili per la nostra stessa economia e per un debito pubblico di circa
il 120% del Pil. La manovra Amato (la manovra di finanza pubblica tra le maggiori mai fatte in
Italia), avrebbe dovuto essere ancora piu’ draconiana. Il cambio lira-marco concordato nel 1996 e
poi tradottosi nel cambio lira-euro del 1999 appare dunque appropriato anche per la stabilita’
dell’economia italiana.
La crisi del 2008 ha poi fatto esplodere alcune pesanti contraddizioni presenti nella costruzione
della moneta unica: la mancanza di una singola gestione del settore bancario, l’assenza di una vera
condivisione delle politiche fiscali e la conseguente sostanziale difformita’ del rischio sovrano tra i
vari paesi aderenti. Nella tempesta che e’ seguita alla crisi “sub-prime” originata negli USA, si sono
distinti due gruppi di paesi europei: quelli oggi definiti “periferici” (Portogallo, Italia, Irlanda,
Grecia, Spagna e Cipro) e i rimanenti, definiti “core”. E’ molto semplice constatare che i paesi
“core” sono stati in grado di affrontare la peggior crisi del secondo dopoguerra facendo leva su
riforme interne e sul bonus che proprio l’euro aveva “regalato” a tutti gli aderenti alla moneta unica,
tramite l’abbassamento dell’intero spettro di scadenze dei tassi di interesse.
Disoccupazione colpa dell’euro?
Se e’ vero che dal 2000 ad oggi la crescita economica dell’area euro e’ stata mediamente solo dello
0.8% (vedi grafico), la prospettiva cambia in maniera rilevante se si considera lo shock esterno
costituito dalla crisi sub-prime del 2008-09.
PIL – crescita media annua 2001-13
Fonte: Oxford Economics
Ad eccezione dei paesi “periferici”, l’andamento del Pil e dell’occupazione a partire dalla fine della
crisi nei paesi dell’eurozona si configura sostanzialmente come quello di un ciclo economico di
paesi ad economia matura. I paesi “core” sono stati in grado, utilizzando tradizionali politiche di
bilancio e del mercato del lavoro, di attraversare senza gravi scossoni la piu’ pesante crisi
economica dagli anni ‘30. In questi paesi il confronto tra i tassi di disoccupazione negli anni
precedenti la crisi del 2008 con quelli attuali rivela, infatti, una sostanziale stabilita’, con la
disoccupazione francese aumentata di un punto percentuale e mezzo e quella tedesca oggi
addirittura piu’ bassa di quasi due punti rispetto al 2008. Gli altri paesi “core” si posizionano
all’interno di questa forchetta mentre in Italia la disoccupazione e’ aumentata di circa sei punti
percentuali nello stesso periodo.
La constatazione che solo pochi paesi si siano trovati in gravi difficolta’ dovrebbe farci riflettere
sugli errori commessi dal nostro sistema paese nel periodo dalla creazione dell’euro in poi, anche in
considerazione del bonus di risparmi (stimabile tra i 50 e i 60 miliardi di euro all’anno) sul servizio
del debito che l’adozione dell’euro ci ha offerto. Tra gli errori piu’ rilevanti bastera’ citare
l’aumento della spesa pubblica in rapporto al Pil negli anni 2000-2006 e 2008-2010, aumento non
compensato da aumenti di tasse ne’ da effettiva lotta all’evasione fiscale, e le mancate riforme dei
mercati di beni e servizi nonche’ del mercato del lavoro. Il combinato disposto dei vari errori
commessi ha posizionato l’Italia come paese debole nei confronti di un eventuale shock esterno –
nel momento in cui la crisi USA ha manifestato i suoi effetti in Europa, i paesi deboli come l’Italia
hanno pagato lo scotto degli errori precedenti.
Le cause delle difficolta’ del sistema Italia non dipendono quindi dall’euro, ma da scelte di politica
economica dissennate e tese a conservare lo statu quo invece di avviare le riforme necessarie ad
affrontare i cambiamenti che nel frattempo stavano avvenendo nel mondo e nel paese. Ma cosa
succederebbe se oggi per scelta politica si reintroducesse la lira?
Conseguenze del ritorno alla lira.
I primi effetti di un annuncio dell’uscita unilaterale dell’Italia dall’euro si manifesterebbero nel giro
di poche settimane. E’ poi difficile immaginare che l’avvio di una tale procedura possa non
contagiare, nel giro di pochi mesi, altri paesi “periferici” e in definitiva l’intera costruzione
dell’euro, in quanto decreterebbe l’esistenza di differenti livelli di affidabilita’ degli stati, cosa
inconcepibile per una moneta unica. Se l’euro possa continuare a esistere e in che modo e’
argomento complesso perche’ molto dipendente dalle azioni che i paesi “core” andrebbero a
intraprendere.
All’avvio della procedura di uscita dell’Italia dall’euro (procedura peraltro non prevista nei trattati)
si avrebbero una serie di effetti nel giro di poche settimane, al massimo entro pochi mesi:
1) Svalutazione della lira ad un livello definito dai mercati. Nessun analista ritiene che la
perdita di valore della moneta sarebbe inferiore al 30% (se fosse significativamente inferiore
sarebbe peraltro pressoche’ inutile uscire), e alcuni stimano piu’ realisticamente il 60%
come ad esempio uno studio recente della UBS. E’ probabile che la svalutazione finirebbe
per essere almeno del 50% (concorda, tra gli altri, anche il professor Tabellini, fino allo
scorso anno rettore della Bocconi), per compensare la perdita di produttivita’ dell’Italia sulla
Germania negli ultimi dieci anni piu’ un sostanzioso “premio” al rischio per gli investitori.
2) Ristrutturazione del debito e perdita di fiducia degli investitori internazionali. Il debito
andrebbe immediatamente ridenominato in lire, per la parte ove cio’ sia possibile –
altrimenti il suo valore nominale raddoppierebbe. L’inevitabile ristrutturazione del debito
potrebbe riguardare:
a) la sola componente detenuta da investitori italiani che si vedrebbero restituire le
loro obbligazioni al valore delle nuove lire, lasciando quindi invariato il valore della
quota di debito pubblico “domestico” rispetto al Pil, visto che il Pil sarebbe
ovviamente calcolato in lire – ma lasciando in euro la quota di debito in mano a
investitori esteri (oggi circa il 30%), tale quota raddoppierebbe facendo aumentare il
debito complessivo di quasi un terzo, superando il 180% del Pil; oppure
b) anche l’intero panorama degli investitori internazionali che hanno acquistato titoli
di diritto italiano. In questo caso, la ristrutturazione del debito italiano
comporterebbe una tale crisi di fiducia nel sistema Italia da determinare l’abbandono
da parte degli investitori internazionali dei mercati italiani. Per dare un senso logico
all’operazione, infatti, l’accordo dovrebbe essere di una dimensione sostanzialmente
indigeribile per gli investitori, sia nazionali che internazionali, che oltre alla
svalutazione dovrebbero subire almeno una ulteriore sforbiciata che consenta di
portare il rapporto debito/Pil a un valore almeno intorno a 100. L’aumento dei tassi
di interesse avrebbe conseguenze non solo sull’Italia ma su tutti i paesi periferici,
dato che lo spettro della disintegrazione dell’euro si farebbe di nuovo concreto
3) Default. Data la mobilita’ globale dei capitali, qualsiasi investitore, nazionale o straniero
che sia, deciderebbe rapidamente di ritirare i suoi capitali dall’Italia e di spostarli su un altro
paese ritenuto piu’ affidabile e a moneta piu’ forte. In Italia intanto l’assalto agli sportelli
bancari sarebbe inevitabile. La vendita precipitosa e contemporanea degli asset italiani
farebbe precipitare le quotazioni dei mercati azionari e obbligazionari (e in un tempo piu’
lungo anche di quello immobiliare), determinando una forte salita di tutto lo spettro dei
rendimenti italiani, inclusi quelli per il servizio del debito. Il Tesoro italiano si troverebbe
quindi presto nell’impossibilita’ concreta di emettere nuovi titoli e di far fronte ai pagamenti
di stipendi pubblici, pensioni, fornitori, ecc..
4) Forte recessione e inflazione elevata. Gli elevati tassi di interesse si rifletterebbero
negativamente sul credito alle imprese, sui mutui, sul credito al consumo, ecc. deprimendo
di nuovo l’attivita’ economica e l’occupazione. Una mossa inevitabile sarebbe quella di
riportare la Banca d’Italia al suo ruolo di banca centrale per consentirle di effettuare una
politica monetaria espansiva a supporto delle imprese e soprattutto del settore bancario che
sarebbe quello piu’ colpito dal combinato disposto di recessione, fallimenti e consumatori
con scarsa affidabilita’ di credito. Questo rinnovato ruolo della Banca d’Italia potrebbe
consentire anche di finanziare il debito pubblico (ricreando una banca centrale al servizio
del Tesoro) ma la “valvola di sfogo” della monetizzazione del debito avrebbe un ovvio
effetto di “azzardo morale”: quale governo sarebbe indotto a tenere sotto controllo i conti
pubblici, se sa che può sempre imporre alla banca centrale di comprarsi i titoli del debito
pubblico? Allo stesso tempo, la forte svalutazione comporterebbe un altrettanto forte
aumento nei costi di approvvigionamento energetico e di materiali e prodotti esteri (l’Italia
rimane ancora oggi un paese scarso di risorse naturali e un’economia di trasformazione). Tra
politica monetaria espansiva e aumento vertiginoso dei costi di importazione, l’inflazione
tornerebbe rapidamente a viaggiare a ritmi sud-americani. E’ appena il caso di ricordare che
una alta inflazione e’ equivalente ad una tassa indiretta, che colpirebbe percettori di salari,
stipendi e redditi (quelli non allineabili all’inflazione) indipendentemente dal reddito e in
misura molto maggiore di quello a cui abbiamo assistito negli ultimi anni.
5) Aumento dei costi di importazione e breve durata dei vantaggi per l’export. L’aumento
della bolletta energetica e dei prezzi all’import di beni e servizi peserebbe immediatamente
sui conti con l’estero, mentre l’inflazione a doppia cifra finirebbe per mangiarsi in pochi
anni il vantaggio competitivo di prezzo di cui godrebbero le esportazioni. A questo
proposito va anche ricordato che per i nostri prodotti la competitivita’ di prezzo non ha piu’
la stessa importanza che aveva fino a venti anni fa. Oggi i mercati dei prodotti a basso costo
sono territorio dei paesi emergenti dove il costo della manodopera e’ basso e le condizioni di
lavoro ancora non riflettono una cultura attenta ai diritti dei lavoratori.
Per provare a quantificare l’impatto combinato dei fattori elencati sopra, usiamo uno scenario
prodotto da Oxford Economics a inizio 2012, ossia al culmine della crisi greca. Tale studio limitava
la svalutazione attesa della lira al 25%, grazie a una uscita concordata con il resto dell’Eurozona,
mentre la Grecia avrebbe svalutato del 50% (il nostro destino in caso di uscita unilaterale) e avrebbe
visto i suoi tassi di interesse salire del 20%. Nella situazione odierna, considerando l’ipotesi di una
uscita unilaterale dell’Italia e una svalutazione del 50%, l’Italia avrebbe una perdita di Pil molto
vicina al 20% in due anni, con ulteriore decrescita nel terzo anno, un incremento dei tassi di
interesse di almeno il 15% e un tasso medio sul debito di circa il 18%. L’inflazione allo stesso
tempo salirebbe oltre il 10%, nonostante il forte aumento dei tassi di interesse e la forte recessione.
Dal quadro appena analizzato emerge con chiarezza l’incompatibilita’ tra un sistema economico e
monetario moderno e il ritorno alla lira. Il finanziamento da parte della banca centrale delle spese
dello stato darebbe luogo a svalutazioni successive e a fughe di capitali, facendo salire i tassi
d’interesse su livelli significativamente più elevati. Per fare cio’ sarebbe necessario ripristinare i
controlli sui movimenti di capitale, per impedire ai cittadini di investire all’estero e obbligarli a
usare i loro risparmi solo in titoli nazionali, anche se fossero più rischiosi e con minore rendimento.
Bisognerebbe, inoltre, costringere il sistema bancario ad acquistare titoli di Stato, imponendo
vincoli di portafoglio come quelli che venivano usati negli anni ‘70. Queste misure non sono
compatibili con l’attuazione di un mercato integrato come quello che è stato realizzato negli ultimi
20 anni in Europa. Chi propone di uscire dall’euro, e di ripristinare le condizioni istituzionali degli
anni ’70 propone in realtà che l’Italia esca dall’Unione Europea, anche se probabilmente non se ne
rende conto.
Emilio Rossi
Senior Advisor, Oxford Economics
Presidente, EconPartners