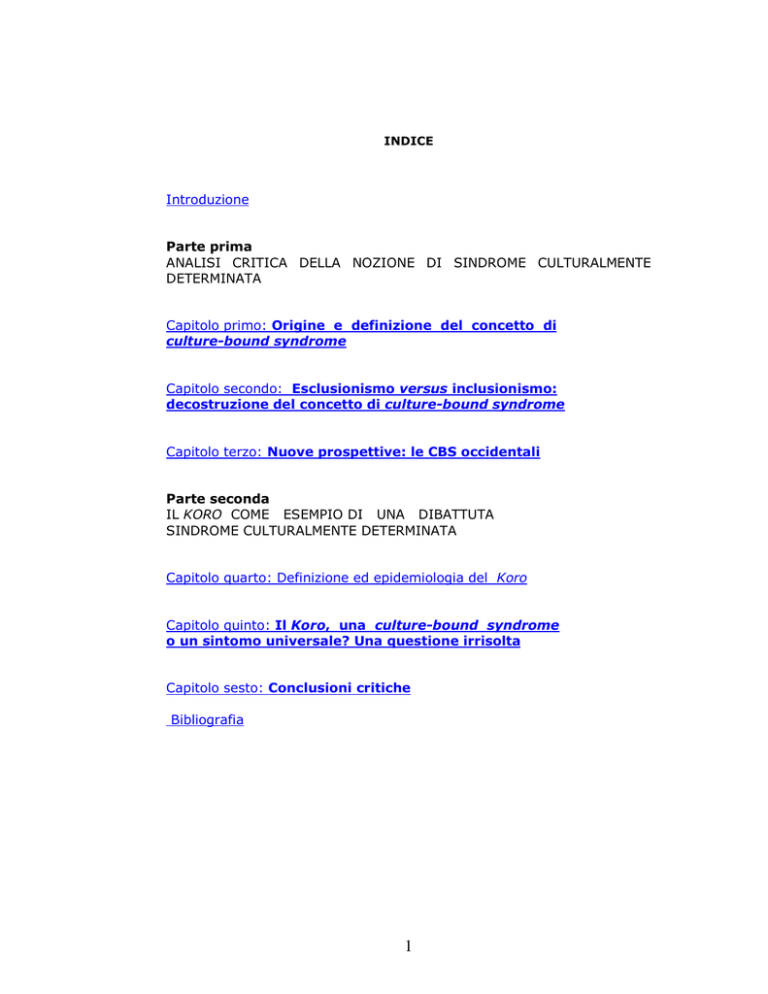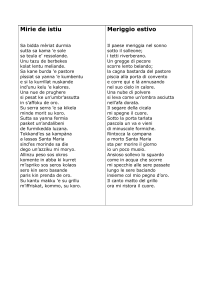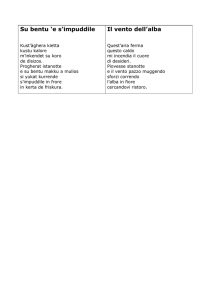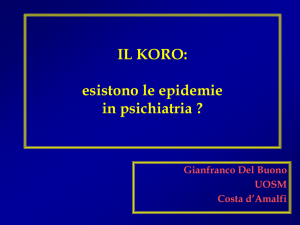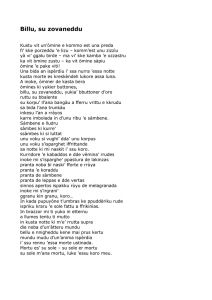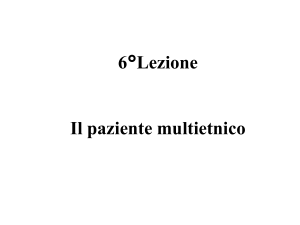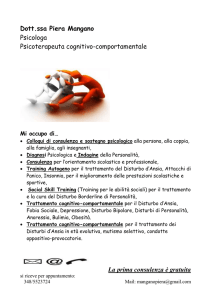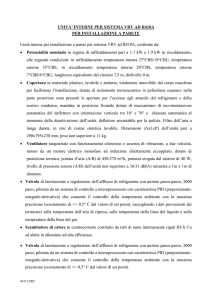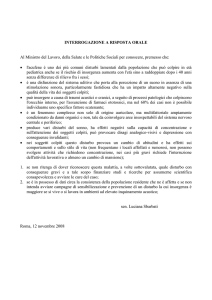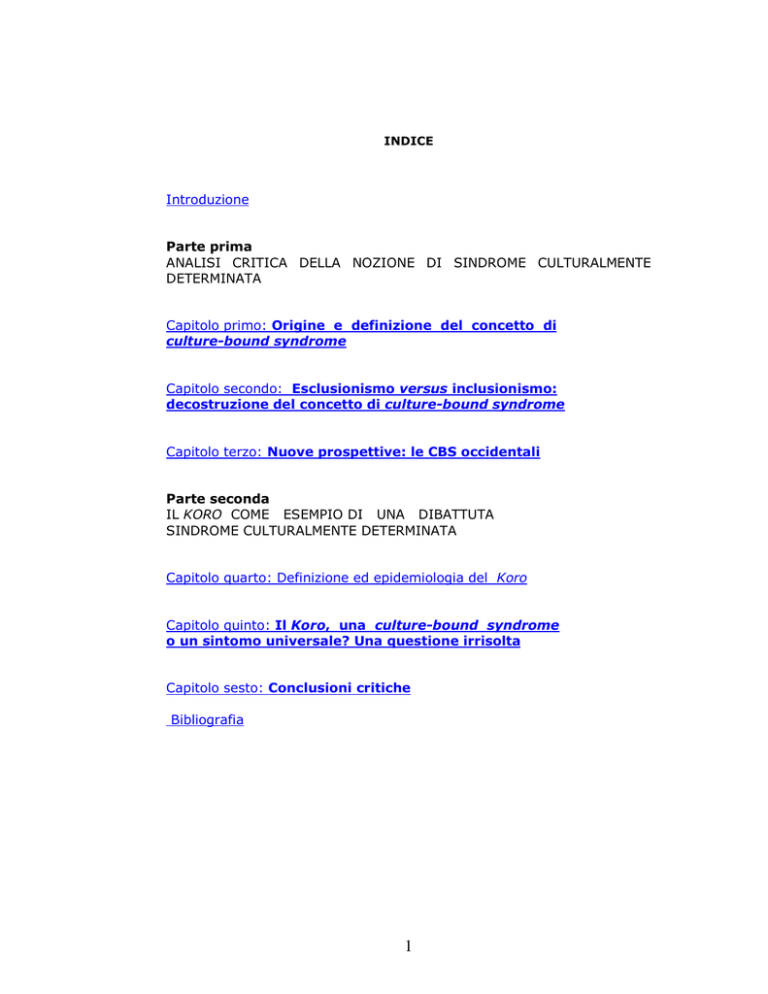
INDICE
Introduzione
Parte prima
ANALISI CRITICA DELLA NOZIONE DI SINDROME CULTURALMENTE
DETERMINATA
Capitolo primo: Origine e definizione del concetto di
culture-bound syndrome
Capitolo secondo: Esclusionismo versus inclusionismo:
decostruzione del concetto di culture-bound syndrome
Capitolo terzo: Nuove prospettive: le CBS occidentali
Parte seconda
IL KORO COME ESEMPIO DI UNA DIBATTUTA
SINDROME CULTURALMENTE DETERMINATA
Capitolo quarto: Definizione ed epidemiologia del Koro
Capitolo quinto: Il Koro, una culture-bound syndrome
o un sintomo universale? Una questione irrisolta
Capitolo sesto: Conclusioni critiche
Bibliografia
1
INTRODUZIONE
La nozione di sindrome culturalmente determinata o culture-bound syndrome
(CBS), com’è più nota in ambito internazionale, è dibattuta e fonte di notevoli
controversie. Quest’espressione è divenuta indicativa di una serie di presunti
disturbi mentali (amok, latha, koro, windingo, susto, ecc.), che si manifestano
generalmente al di fuori dell’Occidente. Il concetto di CBS essendo indicativo di
comportamenti “anomali”, “disturbati” che si palesano in culture esotiche, si
pone a limite tra le competenze etno-antropologiche e quelle psichiatriche.
L’incontro tra queste due discipline, però, non ha rappresentato un esempio di
facile alleanza, sono state forti, infatti, le riserve e critiche sollevate dagli
antropologi nei confronti delle pretese etnocentriche della psichiatria (Beneduce
1997). L’accusa sovente rivolta a questa disciplina, è stata quella di servirsi della
nozione di
CBS, per operare un’eccessiva semplificazione di una serie di
fenomeni proteiformi, e poterli, quindi, spiegare attraverso gli strumenti della
nosografia occidentali. Un simile processo rivela l’imposizione di categorie
mediche, da parte della psichiatria dominante, ad una serie di manifestazioni
complesse che richiederebbero, invece, un’attenta analisi contestuale per
coglierne il reale significato (Devereux 1978; Karp 1985). Il dibattito1 che vede
come protagoniste le CBS, è incentrato sulla definizione della loro natura; alla
prospettiva che le considera come prodotti culturali unici, determinati da uno
specifico contesto sociale, infatti, si contrappone quella che le definisce come
forme locali di un processo morboso universale.
In questo lavoro si cercherà di definire criticamente le linee guida di questo
dibattito, dopo, però, aver prima tracciato un sintetico quadro dell’evoluzione
storica della nozione di culture-bound syndrome. Si partirà, dunque, dalle origini
di questo concetto, per giungere ad introdurre l’idea di una sua possibile
decostruzione. Si metterà in discussione, inoltre, l’assunto secondo cui la
definizione di
CBS è esclusivamente connotativa di disturbi esotici che si
Nel 1983 è stato organizzato un simposio agli incontri dell’International Congress
of Anthropological and Ethnological Sciences, a Vancouver, per discutere la
questione delle culture-bound syndromes. Le dissertazioni presentate, più tardi
pubblicate in un numero speciale della rivista Social Science and Medicine (Vol. 21,
2, 1985), riflettevano una profonda divergenza di opinioni circa il valore e
l’applicabilità del concetto di CBS (cfr. Hahn 1985; Jilek – Jilek-Aall 1985 ; Karp
1985; Kenny 1985; Low 1985; Prince 1985; )
1
2
manifestano in culture “altre”, riportando degli esempi di sindromi culturalmente
determinate occidentali.
Nella seconda parte, invece, si proporrà l’analisi di una tipica culture-bound
syndrome: il koro. Dopo un iniziale tentativo di definire e delineare le
caratteristiche epidemiologiche di questo complesso disturbo, ci si addentrerà
nell’indagine dei vari modelli di definizione e classificazione che sono stati
proposti nel corso del tempo, per evidenziare uno stato di profonda confusione e
contrapposizione. Il caso del koro sarà indicato come esemplificativo di una
situazione fondamentalmente analoga per tutte le CBS, ovvero per una serie di
fenomeni che si rivelano ostili ad un’acritica categorizzazione attraverso gli
strumenti della nosografia occidentale, ma che richiedono, piuttosto, una
profonda analisi del contesto e delle influenze sociali e culturali che le
determinano, un’interpretazione che cerchi di considerarle come un «fatto sociale
totale» (Mauss 1965). In questo lavoro, dunque, ci si pone criticamente nei
confronti di un approccio dominante che cerca di ridurre le sindromi
culturalmente determinate ad un generico insieme di segni e sintomi che rivela
poco e crea molta confusione. Si ritiene indispensabile, invece, una prospettiva
più ampia che inquadri questi complessi fenomeni nella loro totalità, all’interno
della loro vasta e specifica rete di significati.
CAPITOLO PRIMO
ORIGINE E DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI
CULTURE-BOUND SYNDROME
Il termine culture-bound syndrome, potrebbe essere tradotto con sindrome
culturalmente caratterizzata, o determinata2. Esso sta ad indicare una serie
eterogenea
di disturbi comportamentali,
cosiddette
sindromi,
diffuse
generalmente in ambienti non occidentali. Come notano Prince & TchengLaroche (1987: 3-4), la nozione secondo cui
dei disturbi psichiatrici
possano essere ristretti ad una singola cultura, o un gruppo di culture, non è
nuova. Già nel diciottesimo secolo, George Cheyene (1733) pubblicò The English
Malady, in cui raccolse una seri di disturbi nervosi che, egli sosteneva fossero
molto più diffusi in Inghilterra che altrove. Cheyene ricondusse ciò a locali
fattori alimentari e climatici, nonché a determinate caratteristiche culturali
che, egli riteneva fossero tipicamente inglesi.
Prima ancora, nel 1688, un giovane medico, Johannes Hofer,
descrisse
accuratamente, nel suo Dissertatio medico, lo Heimwheh un disturbo mortale,
Inglese e Peccarisi ritengono più appropriato il termine «sindrome culturalmente
ordinata» (1997)
2
3
che per la sua endemica diffusione tra le truppe mercenari elvetiche che
combattevano in Europa, era considerato una malattia tipicamente svizzera
(Ernst 1949 cit. in Frigessi Castelnuovo – Risso 1982). Con il termine Heim, ci
fanno notare Frigessi Castelnuovo e Risso, in tedesco si indica il focolare
domestico, un luogo popolato da persone amate, dove ci si sente protetti, un
luogo al quale ritornare, spazio-tempo al quale si appartiene, storia vissuta di cui
si è partecipi pienamente. Con l’espressione Heimwheh, invece, si intende
letteralmente il dolore della casa, della terra natale, il timore di non ritornarci
più, una sorta di profondissima nostalgia. Molti giovani militari elvetici, dunque,
lontani dalla loro patria, cadevano in uno stato di assoluta apatia, disinteresse
per tutto e tutti, chiusura in sé stessi, sonno irrequieto o insonnia, senso di
ottusità, insensibilità per la fame e la sete, tristezza continua, costante pensiero
rivolto unicamente alla patria; a tali fenomeni si aggiungeva molto spesso febbre
costante o
intermittente, delirio, progressivo indebolimento fino al
sopraggiungere della morte. Uno dei principali fattori scatenanti nell’insorgenza
di questo male, fu ravvisato in un canto, la cosiddetta Kuhe-Reihenche che i
pastori elvetici erano soliti cantare e suonare coi loro corni nei pascoli alpini;
quando, infatti, le nuove reclute provenienti dalla Svizzera intonavano insieme
ai soldati più anziani questo canto, evocando con veemenza il pensiero del paese
natale, molti cadevano in uno stato febbrile e comparivano i sintomi dello
Heimweh. Per questo motivo gli ufficiali, con un’ordinanza che comminava a
severissime pene, proibirono il canto e il suono di questa melodia. Nonostante la
sua pericolosità, lo Heimweh era guaribile se la nostalgia di casa veniva
soddisfatta, inguaribile, mortale o, comunque, molto pericoloso se le circostanze
lo impedivano. Unico rimedio realmente efficace era, dunque, predisporre il
rientro in patria dei soggetti ammalati. Numerose esperienze, infatti,
dimostravano che tutti i soldati svizzeri colpiti da questo male, già durante il
viaggio di ritorno, o appena giunti a casa, guarivano. Dopo la descrizione offerta
da Hofer, molti altri medici si interessarono allo studio dello Heimweh,
avanzando disparate ipotesi eziologiche e presidi terapeutici. Nonostante abbia
trovato la sua massima diffusione nel periodo romantico, fa notare Frigessi
Castelnuovo, il termine Heimweh era già noto e utilizzato da almeno più di un
secolo prima della dissertazione di Hofer (1688).
Molto più rilevanti per il discorso che si intende condurre, sono, nel tardo
diciannovesimo secolo,
le descrizioni di
W. Gilmor Ellis e di Blonk
riguardanti
dei disturbi, ignoti in Europa, che essi riscontrarono essere
relativamente diffusi tra i Malesi. Tali disturbi erano, i ben noti oggi, amok
(Ellis1893), latah (Ellis 1897) e koro (Blonk 1895). È importante sottolineare,
però, che c’è una sostanziale differenza tra i resoconti medici di Cheyene o di
Hofer, e quelli di Ellis e Blonk. Mentre nel primo caso, infatti, il soggetto
osservante è l’oggetto osservato condividevano la stessa realtà sociale, ed un
medesimo retroterra culturale; nel secondo caso, invece, la prospettiva è
completamente diversa, si tratta, infatti, di studiosi europei alle prese con
un’analisi transculturale di disturbi, o meglio di manifestazioni, che si palesano
in un contesto culturale completamente diverso dal loro. L’antropologia c’insegna
che spesso l’osservazione e la descrizione di altri, geograficamente distanti o
4
culturalmente diversi, è stata offuscata da un vizio etnocentrico, che ha indotto
a considerare l’altrui diversità, spesso con accezione negativa, come assoluta e
non, come sarebbe corretto, in termini relativi: si è “Altro”, infatti, solo rispetto
a chi guarda. Ogni cultura si basa su di un proprio sistema di valori, di miti, di
credenze, una cosmologia che le appartiene intimamente. La cieca fiducia
nell’universalità della propria prospettiva, però, ha, non di rado, condotto a
commettere l’errore d’interpretare e spiegare usi e costumi di altri popoli
riconducendoli ai propri sistemi di significato, travisandone completamente il
senso. È sulla base di tali considerazione che vanno inquadrati i resoconti medici
di Ellis, di Blonk e di tutti i medici e psichiatri che dopo di loro si sono addentrati
nelle descrizioni e interpretazioni di presunte patologie esotiche.
Nel tentativo di tracciare un quadro sintetico del concetto di CBS, un
valido contributo è offerto da un articolo della Ciminelli (1997), nel quale è
proposta una ricostruzione storica di tale concetto. La Ciminelli riconduce
l’origine delle culture-bound syndroms, a quelle folk-illness
i
cui
nomi
indigeni erano noti in Europa sin dalla fine dell’Ottocento, grazie ai
resoconti di viaggiatori, funzionari coloniali e psichiatri. Ella, inoltre, vede nelle
formulazioni di
Emil Kraepelin
(1856-1926),
fondatore
della moderna
nosografia psichiatrica, delle premesse fondamentali per la nascita della
nozione di CBS. Kraepelin
si pone l’obbiettivo di estendere la comparazione
tra
malattie psichiche, non più solo tra gruppi differenti per età, sesso,
occupazione, all’interno di una stessa nazione, ma anche tra gruppi di differenti
razze. La finalità principale dell’estensione del confronto alle altre razze, è quella
di chiarire l’eziologia di tali malattie. Kraepelin, inoltre,
argomenta
che, i
disordini mentali, al pari di costumi, religione, azioni politiche e sviluppo
storico, esprimono il carattere e l’individualità di una nazione. Egli nel 1904, in
seguito ad una ricerca svolta a Giava nell’ospedale Buitenzorg, affermava, in
un suo articolo, che le malattie mentali giavanesi sono praticamente coincidenti
con quelle rilevabili in qualsiasi ospedale psichiatrico europeo. Minimizzando le
differenze, Kraepelin negava pertanto l’esistenza di malattie mentali nuove e
sconosciute tra la popolazione indigena, e attribuiva la causa dei tratti
inusuali, dei casi clinici trovati a Giava, al «background razziale del paziente»
(Kraepelin 1904 [74] : 111). Il suo scritto assumerà grazie all’autorità crescente
della sua figura scientifica, una considerevole importanza, anche perché, in un
certo senso, si erge a difesa delle ragioni e dei risultati della clinica occidentale.
Le nozioni scientifiche da lui diffuse si sono imposto, in ambito psichiatrico, fino
ai nostri giorni; è in questo stesso articolo che il celebre psichiatra tedesco
introduce il termine di «Psichiatria Comparata». Interessante, soprattutto per
l’influenza esercita fino ad oggi, è l’opposizione che Kraepelin traccia tra elementi
patogenici (intesi come cause necessarie e sufficienti all’identificazione di
un’entità nosologica) e fattori patoplastici (associati alle variazioni individuali),
nella definizione eziologica del disagio psichico. Tale opposizione, infatti, si è
riprodotta in campo transculturale fino ai nostri giorni, attribuendo all’elemento
culturale una ruolo patoplastico rispetto alla biologia, alla quale viene assegnata
un essenziale influenza patogenica nella determinazione sintomatologica dei
5
disturbi mentali (Kleinman 1987a). La Cimminelli, in seguito ad un’analisi delle
formulazioni kraepeliniane, sostiene che se si sostituisce «al termine ‘razziale’
il termine ‘culturale’» (1997: 91), le affermazioni di Kraepelin risultano coerenti
con quelle della psichiatria transculturale di oltre mezzo secolo successive.
Inoltre, continua affermando che:
Il tentativo di “comprendere ” i disturbi psichici di popolazioni diverse nel
quadro nosologico della psichiatria prosegue infatti di pari passo con le
varie modalità
di concettualizzazione dell’ alterità via via sviluppate
dalla civiltà occidentale.
Al
concetto di alterità biologica subentrerà
il
concetto
di
alterità
culturale e
le
“sindromi esotiche”
diverranno
le
culturebound syndromes: l’introduzione del concetto di
psichiatria comparata
, […] , non implicherà immediatamente la revisione del paradigma
classificazionista (ibidem).
Il legame tra paradigma classificazionista – inteso come il modello di
cui la clinica occidentale si serve per classificare i disturbi mentali – e
CBS, a cui accenna la Ciminelli, introduce l’idea della fallacia di tale concetto,
ovvero del suo essere uno strumento per collocare in una precisa categoria dei
“disordini” che si rivelano, altrimenti, refrattari ad
ogni
classificazione
scientifica.
Prima della Ciminelli, un altro autore italiano, Italo Signorini (1988), in un
articolo in cui si proponeva di indagare «lo spavento quale referente eziologico di
uno stato di malattia riconosciuto a un paziente» (25), aveva già, criticamente,
sottolineato l’ambiguità e le contraddizioni della nozione di culture-bound
syndrome. L’apostrofare come culturalmente caratterizzate una serie di
cosiddette sindromi, non implica un’analisi del contesto in cui tali
manifestazioni si palesano e assumono significato, ma piuttosto consente una
facile generalizzazione. Il concetto di CBS, inoltre, ha una valenza discriminatoria
in quanto distingue e svaluta, i disturbi esotici rispetto a quelli occidentali, i quali
sono implicitamente considerati culture-free. Tali limiti ed altri ancora sono stati
evidenziati con forza da diversi studiosi (Cassidy 1982; Ritenbaugh 1982; Karp
1985; Signorini 1988; Ciminelli 1997; Inglese – Peccarisi 1997), e ciò ha
condotto ad un processo di decostruzione del concetto di culture-bound
syndrome. Questo processo sarà successivamente analizzato (v. infra p. 49),
per ora è più opportuno continuare il percorso storico delle CBS.
Un contributo originale allo studio di disturbi esotici fu offerto da Georges
Devereux . Egli, in un suo saggio del 1956 (ripubblicato in Devereux, 1978),
distinse quattro tipi di categorie etnopsichiatriche di disturbi della personalità:
1) Disturbi tipici, che si riconvertono al tipo di struttura sociale.
2) Disturbi etnici, che si riconnettono al modello culturale proprio del gruppo.
3) Disturbi sacri, del tipo sciamanico.
4) Disturbi idiosincratici.
Non mi addentrerò in un ulteriore approfondimento di tutte queste categorie,
perché potrebbe essere fuorviante per il discorso che intendo condurre. Di
6
diretto interesse, però, sono quei disordini che Devereux indica come disturbi
etnici, è in questa categoria, infatti, che egli include una serie di affezioni
(amok, latha, koro, windingo, etc.), che in seguito diverranno più note come
culture-bound sindromes. Devereux sostiene che lo studio approfondito di un
solo caso di disturbo etnico può essere più rivelatore di uno studio comparativo,
e quindi superficiale, – sottolinea prontamente – di tutti i disturbi di questo tipo.
L’autore asserisce che c’è una profonda similarità tra la gran varietà di disturbi
etnici, che non riconduce però né ad un analogo quadro sintomatologico, né
tanto meno ad un comune fattore organico o biologico. L’idea della somiglianza
tra i vari disturbi etnici, viene ricondotta da Devereux, infatti, al medesimo
meccanismo con cui l’influenza culturale agisce su tali manifestazioni. Nella
maggioranza dei casi, egli sostiene, il gruppo ha teorie esplicite riguardo alla
natura e alle cause di questi disturbi, ed idee precise sui loro sintomi, sulla loro
evoluzione e sulla loro prognosi. Devereux, asserisce che nel caso dei disturbi
etnici è la cultura a fornire un modello di comportamento a coloro i quali, per
una qualsiasi ragione, soffrono di dissesti psichici. In situazioni di elevato stress
la cultura, quindi, fornisce essa stessa all’individuo indicazioni sulle modalità di
comportamento da adottare, modalità che Devereux indica come «modelli di
cattiva condotta». Lo studioso francese, afferma che «ogni società comporta non
soltanto aspetti funzionali, mediante i quali essa afferma e mantiene la propria
integrità, ma anche un certo numero di credenze, dogmi e tendenze che
contraddicono, negano e scalzano non soltanto le operazioni essenziali del
gruppo, ma talora persino la sua esistenza stessa» (1978: 48). Talvolta,
continua l’autore, particolarmente nelle situazioni di stress frequenti, è la cultura
stessa a fornire direttive esplicite per il cattivo uso di materiali culturali. Nel
caso dei disturbi etnici, è come se la cultura di appartenenza dei soggetti li
esortasse a non ammalarsi, ma se ciò avviene gli fornisce un modello di
comportamento da adottare. «Ogni società a idee ben ferme su come si
comportano i pazzi» (51). Nei soggetti affetti da disturbi etnici, secondo la
prospettiva tracciata de Devereux, quindi, la personalità
non sarebbe
disorganizzata al punto tale da spingerli a una rivolta totale contro l’insieme delle
norme sociali. Per cui questi disordini sono indicati come dei « modelli di cattiva
condotta» socialmente strutturati, in cui si verifica l’assunzione di «valori sociali
antisociali, che permettono all’individuo di essere antisociale in una maniera
socialmente approvata» (49). La cultura, dunque, mette a disposizioni di
individui sottoposti a forti tensioni una serie di difese sotto forma di sintomi
prestrutturati. La principale conseguenza di questa strutturazione culturale dei
disturbi etnici, è quella di rendere il comportamento del malato prevedibile,
inoltre, i sintomi culturalmente costruiti, possono essere visti come dei segnali
attraverso i quali l’individuo disturbato informa la società circa la sua forma di
devianza (malattia mentale) e allo stesso tempo si differenzia da altre forme di
devianza (criminalità per esempio). In ogni disturbo etnico, precisa in fine
Devereux, «la struttura del comportamento dell’individuo anormale è non solo
conforme a quanto la società si aspetta, […], ma è anche spesso del tutto
opposta alle nostre idee culturali circa la maniera in cui si comporta il pazzo»
(54).
7
Le formulazioni di Devereux, però, sono state a lungo inevase, si è preferito
privilegiare l’aspetto sintomatologico, o lo studio della modalità con cui
classificare questi disturbi esotici attraverso gli strumenti della nosografia
psichiatrica tradizionale. Piuttosto che intraprendere una prospettiva
interpretativa, per cogliere il significato culturale che i disturbi mentali assumono
in contesti non occidentali, ha prevalso, sospinta dalla deprecabile convinzione
della sua universalità, la volontà di esportare il pensiero biomedico dominante,
imponendo così alle sindromi esotiche le categorie psichiatriche occidentali.
L’espressione culture-bound syndrome fu coniata nel 1962 da Paw Meng Yap,
uno psichiatra cinese che lavorava ad Hong-Kong. Yap, nel 1951,
pubblicò
«“Mental Diseases Peculiar to Certain Cultures”», nel 1962 etichettò questi
disturbi come «“atypical culture-bound psychogenic psychoses”», e in
seguito,
nel 1967,
come «“culture-bound reactive syndromes”» o
semplicemente «“culture-bound syndromes”» (Prince & Tcheng Laroche 1987:
4). Altri autori hanno usato etichette alternate quali «exotic, unclassifiable,
culture-reactive or culture-related specific psychiatric syndromes» (ibidem), ma
l’espressione
culture-bound
syndrome è quella che si è più saldamente
consolidata. L’introduzione del concetto di cultura, da parte di Yap, non darà
vita ad un nuovo approccio metodologico, né supererà il paradigma
classificazionista. Le formulazioni di Yap mostrano notevoli somiglianze con
quelle di Kraepelin, permane
l’attribuzione
alla
natura, ovvero
alla
biologia, della
funzione
di determinante universale. Lo psichiatra cinese
sostituisce, quindi, il concetto di razza con quello di cultura, ma alla cultura
attribuisce il ruolo di plasmare un sostrato naturale comune. Come nota la
Ciminelli, «la cultura viene inserita nel paradigma esplicativo della psichiatria
alla stregua di una qualsiasi delle variabili […] sino ad allora considerate: non
vengono cioè recepite le indicazioni epistemologiche che il concetto di cultura in
nuce contiene anche in relazione alla costruzione dei dati psichiatrici»
(Ciminelli 1997: 95). Le medesime
sindromi esotiche
saranno
ora
etichettate come culture-bound syndromes, conservando però, come loro
fondamentale
tratto distintivo, quello dell’alterità o esoticità. Le variazioni
apportate da Yap furono quindi più formali che sostanziali, tuttavia, esse
esercitarono un’influenza sulla psichiatria comparata, termine introdotto da
Kraepelin (1904, cit. in Ciminelli 1997: 88), che da quel momento in poi si
definirà trans- o cross-culturale. Yap tentò ripetutamente di integrare le culturebound syndromes tra le categorie del DSM (Diagnostic and Statistical Manual)
pubblicato
dall’American
Psychiatric Association, tali tentativi però non
andarono a buon fine. Il primo di essi
fu tentato nel 1951 quando, lo
psichiatra cinese, cercò di inserire alcune CBS nel DSM come esempi di
«hysterical neuroses» (Marsella 1982/84: 370). Successivamente, come già si è
detto, nel 1962 Yap utilizzò l’espressione «atypical culture-bound psychogenic
psychoses», sostituita poi, nel 1967, con «culture-bound reactive syndrome»
(Yap 1974: 84, cit. in Ciminelli1997: 93). La Ciminelli individua, inoltre, l’ultimo
tentativo proposto da Yap di classificare le culture-bound syndromes, nella
sua opera postuma «Comparative Psichiatry» (1974), in cui viene proposta
la categoria nosografica delle «acute psychogenic reactions», come inclusiva
8
delle CBS (ibidem). Nonostamte i limiti dell’approccio di Yap, è da riconoscere a
questo pioniere della psichiatri transculturale, il merito di aver molto contribuito
ad attrarre l’attenzione sulla questione di come il disturbo mentale si palesa in
contesti non occidentali. É ad egli, inoltre, che viene riconosciuta la paternità del
termine culture-bound syndrome,
che se pure non ha svolto un ruolo
rivoluzionario rispetto ai precedenti modi di concettualizzare le malattie mentali
esotiche, poiché all’influenza determinante della cultura non è stato dato il
dovuto peso, esso ha senza dubbio partecipato alla presa di coscienza del fatto
che oltre agli elementi biologici, genetici, organici anche la cultura svolge un
ruolo importante nell’insorgenza e nel decorso della malattia.
Gli infruttuosi tentativi esperiti da Yap, di inserire le CBS all’interno degli
strumenti della nosografia psichiatrica occidentale, furono ripresi, in tempi più
recenti (1985), da Charls C. Hughes, il quale si impegnò nel trovare il
modo in cui le culture-bound syndromes potessero essere integrate con le
categorie per i disordini mentali, della terza edizione del Diagnostic and
Statistical Manual (DSM-III; APA 1980). Hughes propose tale contributo nella
sua introduzione al volume The Culture-Bound Syndromes: Folk Illnesses of
Psychiatric and Anthropological Interest (Ronald C. Simons and Charles C.
Hughes, eds.; Reidel, 1985), egli era motivato in questo suo progetto dalla
convinzione dell’utilità cross-culturale del DSM-III. Ronald C. Simons sostiene
che l’approccio di Hughes, non solo riveli la forza e i limiti del DSM-III, ma
illumini anche sui problemi teoretici inerenti ad ogni tentativo di conciliare
sistemi classificatori altamente disparati (1988: 525). Hughes pone l’accento sul
fatto che le culture-bound syndromes abbiano uno status anomalo, all’interno
della psichiatria occidentale, e ciò rappresenta per lui un’opportunità e
una sfida per focalizzare l’attenzione sull’adeguatezza del DSM-III. Hughes
sostiene che le CBS potrebbero svolgere il loro ruolo più significativo,
offrendo al DSM-III una sfida per superare il campanilismo culturale. In fine, egli
mette in discussione lo stesso termine culture-bound, il quale, come egli
stesso afferma, sfortunatamente sembra aver assunto una vita propria, e invece
di essere un utile costrutto che
faciliti l’analisi
di eventi empirici, è
diventato un inibitore di tale analisi.
Michal G. Kenny offre una prospettiva critica del lavoro di Hughes (1988: 513524). Egli in relazione alle considerazioni di Hughes, circa lo status delle CBS, si
chiede se e con che cosa, sia possibile rimpiazzarle, ma soprattutto se le
categorie del DSM-III siano realmente migliori. Kenny, infatti, mette in dubbio
l’universalità del DSM, in quanto concepito come strumento di fruizione
esclusivamente nel contesto statunitense. Egli, inoltre, osserva che il DSM
presenta problemi di applicabilità perfino in tale contesto, è evidente, quindi,
la difficoltà e l’impossibilità di utilizzarlo al di fuori di esso, e soprattutto per le
ambigue condizioni che caratterizzano le culture-bound syndromes. Essendo
quindi, sia il DSM che le CBS, categorie oscure e tendenziose, Kenny si
dichiara piuttosto scettico circa la possibilità di conciliarle. Nel lavoro
di
Hughes è avanzata la proposta di classificare le CBS all’interno del DSM-III
come: «Atipical Dissociative Disorders» o in alcuni casi come «Residual Type»
dei disturbi schizofrenici (Simons – Hughes 1985: 113), «Atypical Somatoform
9
Disorders» o «Panic Disorders» o «Disorders
Not Elsewher
Classified»
(193),
«Isoleted Explosive Disorders» o «Brief Reactive Psychoses» o
«Factitious Disorders with Psychological Symptoms» (264). Hughes afferma che
la maggior virtù del DSM-III è che, concentrandosi sulle manifestazioni
comportamentali del disturbo, esso tenta di evitare le sovrasemplificazioni che
potrebbero sorgere da qualche modo di classificare più ontologico. Egli inoltre
sostiene che, gli indicatori sociali del DSM-III (Axis IV e V) sono altamente
pertinenti
con la classificazione delle culture-bound syndromes, per cui,
attraverso il loro uso, sarebbe possibile ottenere una miglior conoscenza e
descrizione della situazione dell’ammalato. Il lavoro di Hughes, però, solleva
numerose perplessità, e lo stesso autore, come dice la Ciminelli (1997), nutre
dei dubbi al riguardo. Diversi autori (Beiser 1987; Good 1996; Kleinman 1987b;
Kapur 1987; Lewis-Fernandez 1996; Lock 1987), si sono posti criticamente nei
confronti dell’utilizzo del DSM. Essi hanno contestato l’eccessivo schematismo e
riduzionismo di questo strumento, nonché l’etnocentrica tendenza occidentale a
definire e classificare stati morbosi, o presunti tali, riscontrabili in culture altre,
attraverso le sue categorie diagnostiche. Margaret Lock (1987) in riferimento al
DSM-III, sottolinea che i sintomi considerati separatamente dall’individuo nella
sua totalità e ridotti a statistiche, diventano essenzialmente insignificanti. A
livello di un insieme di sintomi o di sindromi, continua l’autrice, il problema
diventa ancora più complesso. La Lock sostiene, che non si può presupporre, per
esempio, che la depressione, i disturbi d’ansia, o la sintomatologia da
menopausa, siano entità universali, né che concetti, apparentemente,
semanticamente
equivalenti siano interpretati, perfino da
professionisti
biomedici, nello stesso modo. Fare esclusivo riferimento a segni o sintomi
manifestamente tangibili e rilevabili è, sentenzia l’autrice, in se stesso un
approccio culturalmente costruito. La diagnosi, inoltre, ella afferma, è un
processo sociale, una costruzione frutto dell’interazione tra
paziente e
psichiatra. È quindi evidente, sostiene l’autrice, che i segni e i sintomi in
medicina non possono essere considerati come entità statiche e soggette a
comode tipologie. La Lock asserisce con forza che riducendo le sindromi
culturalmente determinate alle
categorie diagnostiche, professionalmente
costruite, del DSM-III, si otterrà come
conseguenza una insignificante
astrazione. Arthur Kleinman (1987b), in accordo con le formulazioni della Lock,
fa notare che «noi viviamo in un mediato, fenomenologico, mondo umano in cui
la percezione così come l’azione, l’interpretazione così come l’esperienza sono il
frutto di una dinamica dialettica tra costrizioni biofisiche e costruzioni culturali
(ma anche personali). Il risultato è un mondo simbolico in cui la struttura sociale
si estende entro l’interiorità del corpo-mente della persona e i processi fisiologici
risuonano sistematicamente con le relazioni» (Kleinman 1987b: 29). Kleinman,
criticamente sottolinea che la psichiatria, inesorabilmente, cerca di ridurre tutto il
“rilevante” della realtà umana, a una sintetica lista di stati morbosi mutuamente
esclusivi. Essa è avversa ad accettare ambiguità, incertezza, indeterminazione;
riduce la complessità dell’esperienza individuale, alle generalizzazioni di un
ridotto numero di classi psicologiche o fisiologiche. Essa trasforma problemi
sociali in disturbi medici. L’autore continua ancora nella sua aspra critica,
10
affermando che inoltre la psichiatria divide la mente dal corpo, le facoltà
cognitive da quelle emotive, la teoria dalla descrizione in accordo con
l’etnopsicologia dominante nella tradizione occidentale3. Seri problemi, sostiene
Kleinman, insorgono quando i criteri diagnostici occidentali sono applicati a
pazienti non occidentali. Il DSM-III, asserisce lo studioso americano, è un
sistema simbolo che condensa significati profondi e orientamenti di valore della
società americana, della psichiatria americana e della politica della American
Psychiatric Association. Kleinman ritiene inaccettabile che in società non
occidentali, dove risiede più dell’80% della popolazione mondiale, le principali
categorie di malattie devono essere relegate ai disturbi affettivi atipici, a disturbi
da ansia atipici e a molte altre categorie “atipiche”. La sola cosa “atipica”, fa
notare sarcasticamente l’autore, è considerare le popolazioni nord americane ed
europee come modello attraverso cui determinare delle tipologie cliniche, in un
mondo in cui esse sono solo una distinta minorità (sebbene la più potente).
L’autore insiste nel sottolineare che «certi sintomi in società non occidentali non
possono essere direttamente tradotti lessicalmente nei principali linguaggi euroamericani. Essi devono essere compresi nei termini della loro più ampia
metaforica rete di significati. […] I sintomi sono idiomi di sofferenza. I clinici
traducono questi idiomi di dolore in segni di malattia; il lavoro del clinico,
dunque, è completamente semiotico. L’interpretazione si verifica nel definitivo
atto di riduzione attraverso cui l’esperienza personale e culturale unica della
sofferenza è trasformata in un tipo di malattia o in un “caso”» (idem 51).
Kleinman conclude, ponendo l’accento sull’errore nel tradurre agevolmente
centinaia di idiomi di disagio culturalmente specifici, in
segni e sintomi
“oggettivi” da ricondurre ad una patologia nota in occidente. La questione del
rapporto tra sistemi di classificazione e disturbi culturalmente determinati,
conduce l’autore ad un’aspra e inevitabile critica del DSM-III. Good (1996) e
Lewis-Fernandez (1996), focalizzano la loro attenzione sull’ultima edizione del
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV4. Byron Good, pur
riconoscendo la maggiore importanza data all’influenza degli elementi culturali,
nella determinazione dei disturbi mentali, in quest’ultima revisione del DSM,
Ancora una volta, con fare polemico, Kleinman afferma la sua decisa idea
relativista. Non a caso si serve del termine «etnopsicologia»; egli, infatti, attraverso
l’utilizzo del prefisso “etno” intende sottolineare che la “psicologia” occidentale,
intesa come il modo umano di pensare e di agire, non ha una valenza universale –
come spesso implicitamente si cerca di affermare – ma è piuttosto un costrutto
locale, solo una delle tante etnopsicologie, seppure quella dominante, che si possono
rilevare nelle diverse società umane.
4
Le CBS, nonostante i propositi, non troveranno posto neanche all’interno degli assi
diagnostici di quest’ultima revisione del DSM. Tuttavia – probabilmente a scopo
riparatore – in questa edizione è stato inserito un glossario all’interno del quale sono
contenuti i nomi di 25 culture-bound syndromes accompagnate da una breve
descrizione.
3
11
rispetto alle edizioni precedenti, comunque si pone polemicamente nei confronti
di questo strumento diagnostico. Ci sono generiche difficoltà, argomenta
l’antropologo americano, nel tentativo di costituire un manuale diagnostico che
rifletta fedelmente la diversità di una società multiculturale. Particolari influenze
culturali sono inevitabili: non può esistere una prospettiva completamente libera
dai condizionamenti culturali, attraverso cui definire la malattia mentale. Inoltre,
sostiene Good, ogni sforzo per spiegare i disturbi psichiatrici come unici di
particolari culture, spesso si fonda su stereotipi, e accresce le possibilità di
stigmatizzazioni. L’autore contesta la netta distinzione tra malattie psichiche,
considerate come entità biologiche universali, e le forme di esperienza, e le
interpretazioni culturali di quelle esperienze, che riguardano singoli individui o
gruppi sociali. Egli contesta l’egemonia di particolari forme di scienza, il
fallimento nel combinare l’impegno nell’accrescere la conoscenza della
neurobiologia delle malattie mentali, con un uguale impegno nel riconoscere e
comprendere l’origine sociale delle psicopatologie, e nello sviluppare effettivi
interventi sociali. In fine Good contesta le, troppo comode, pretese di
universalità della psichiatria occidentale, ovvero, l’idea secondo cui ciò che si
osserva e si rileva in riferimento alla classe medio alta della popolazione europea
ed americana, sia generalizzabile a tutta l’umanità. A pagare le spese di tutto ciò
sono sempre i più poveri, quelli che vivono a margini della nostra società, gli
immigrati, i soggetti appartenenti a minoranze sociali. Sovente il disagio di
questi individui è frainteso, male interpretato ed essi sono confinati in squallidi
reparti psichiatrici, medicalizzati come malati di mente e trattati con neuorolettici
e antidepressivi. Gli individui più poveri e disagiati sono dunque vittime di uno
sterile processo di imposizione di etichette patologiche, la loro sofferenza è
destinata ad essere incompresa da chi si ostina in un atteggiamento che
diagnostica e cura prima ancora di osservare e capire. Good, ritiene
indispensabile un serio impegno per fronteggiare i meccanismi di potere, che
sono causa della marginalizzazione di molte persone e gruppi nella nostra
società. Ritornando alle proposte di classificazione delle CBS, un contributo più
originale rispetto a quello di Hughes, risulta essere l’approccio di Simons,
anch’esso pubblicato all’interno del volume The Culture-Bound Syndromes
(1985) di cui Hughes e Simons sono i curatori. Simons aspira ad un modello
multidisciplinare, all’interno del quale fattori biologici, psicologici, sociali e
culturali possano essere considerati insieme, e tenta di sviluppare uno schema
tassonomico che possa apportare chiarezza all’interno della confusa situazione
che caratterizza le culture-bound syndromes. Kenny
(1988) definisce tale
approccio etologico, poiché Simons, come un etologo, fa particolare attenzione
alla situazione in cui il disturbo si manifesta, accuratamente seleziona le
somiglianze e le differenze tra gli elementi comportamentali, e indaga per
spiegare quegli elementi che sembrano trascendere i limiti culturali. Egli
sostiene, afferma ancora Kenny, che nel caso delle culture-bound syndromes le
somiglianze spesso saranno biologiche e le differenze culturali. Per cui il pensiero
di Simons, come opportunamente fa notare Kenny, è che sebbene i significati
culturalmente assegnati di date afflizioni possono cambiare, il processo
soggiacente resta lo stesso. Egli inoltre afferma che, se un dato elemento
12
comportamentale appare in diverse culture, questa è una prova provvisoria
dell’esistenza di un fattore comune, non spiegabile dalla cultura. Simons propone
un sistema per classificare le culture-bound syndromes all’interno di taxa.
Hufford (1988) spiega che il termine taxon è stato preso a prestito da Simons
dalla biologia, e sta ad indicare un raggruppamento basato sulla somiglianza,
degli elementi raggruppati, senza specificare il livello di astrazione di tale
somiglianza. Adattare tale sistema per le CBS, consentirebbe di superare le
difficoltà e le ambiguità che sorgono, invece, con l’utilizzo di termini locali. I
taxa, all’interno dei quali Simons raggruppa le tradizionali culture-bound
syndromes, sono inseriti in vaste categorie in base all’ordine decrescente di un
supposto coinvolgimento biologico. Schematicamente possiamo sintetizzare il
modello di Simons riducendolo a tre categorie principali. La prima delle quali ( I
), quella con il più alto grado di ipotizzabile coinvolgimento biologico, contiene
taxa per i quali è sostenibile la presenza di un fattore neurofisiologico
strutturante; la seconda ( II ), quella con un leggermente inferiore
coinvolgimento, contiene taxa in cui il fattore neurofisiologico strutturante, è solo
presumibile; la terza ( III ), quella con un oscuro coinvolgimento biologico,
contiene culture-bound syndromes per le quali non è ipotizzabile un fattore
neurofisiologico strutturante, e che quindi, probabilmente, non dovrebbero più
essere considerate tali. Nel designare i rispettivi taxa, come si è già detto,
Simons abbandona le etichette esotiche in favore di una terminologia riflessiva
delle somiglianze cross-culturali, per cui le tradizionali CBS saranno classificate
nel modo seguente:
Ia: The Startle Matching Taxon – latah etc.
Ib: The Sleep Paralysis Taxon – old hag etc.
IIa: The Genital Retraction Taxon – koro etc.
IIb: The Sudden Mass Assault Taxon – amok etc.
IIc: The Running Taxon – pibloktoq etc.
IIIa: The Fright Illness Taxon – susto etc.
IIIb: The Cannibal Compulsion Taxon – windingo ( esclusivamente).
Il lavoro di Simons si rifà ad un modello multifattoriale e multicausale, nella
spiegazione delle CBS, cioè , un modello in cui i fattori ambientali, culturali,
psicologici e biologici sono inclusi come elementi interattivi e determinanti
nell’esperienza e nel comportamento umano. Tuttavia però, come nota la
Ciminelli (1997), permangono forti similitudini tra l’approccio di Simons e quello
di Kraepelin, di quasi un secolo precedente. Sostiene infatti Ciminelli, che
nonostante si assista «ad una graduale attenuazione e restrizione del campo di
causalità alla natura: certo più sofisticato rispetto al concetto pseudoscientifico di
razza, i taxa mediante i quali Simons ordina le CBS rispondono tuttavia, […], alla
medesima ricerca di universali biologici, pur se non più intesi come determinanti
esclusivi.» (1997: 100). Potremmo dire quindi, parafrasando Clifford Geertz
(1984), che anche per Simons, nell’affrontare le culture-bound syndromes, la
biologia resta la torta, e la cultura viene ridotta alla glassa, per cui le somiglianze
13
sono considerate essenziali, e le differenze superficiali. Come si è visto, nel corso
del tempo, le culture-bound syndomes sono state oggetto di trasformazioni
terminologiche e concettuali, nonché di disparati tentativi di ordinamento
tassonomico. Alla base di tali tentativi però, è possibile rintracciare una
medesima motivazione, cioè quella di trovare un comune denominatore, un
fattore naturale universale, che consentisse di categorizzare un fenomeno che
appare, invece, piuttosto refrattario ad ogni tentativo di classificazione
scientifica. Col tempo, dunque, alle sindromi esotiche viene attribuita una
valenza culturale, trasformandole nelle culture-bound syndromes, le quali sono
sottoposte a, più o meno riusciti, tentativi di collocazione all’interno degli
strumenti della nosografia occidentale. Si fanno strada poi, approcci con velleità
interdisciplinari, che si adoperano nel fornire ipotesi multicausali nella
spiegazione delle CBS. Nonostante le evoluzioni e le modifiche, permane,
comunque, una bramosa necessità di fondo, quella cioè di ricondurre le culturebound syndromes ad un fattore biologico comune e sovradeterminante, che
consenta di semplificare un fenomeno, altrimenti, troppo eterogeneo e
multiforme.
CAPITOLO SECONDO
ESCLUSIONISMO VERSUS INCLUSIONISMO:
DECOSTRUZIONE DEL CONCETTO DI
CULTURE-BOUND SYNDROME
L’antropologo Robert Hahn, indicò tre differenti prospettive circa le culture-bound
syndromes; una, egli sostiene, potrebbe essere indicata come «‘Exclusionist’», le
altre due come «‘Inclusionist’» (1985: 166). Hahn distingue le due posizioni
inclusioniste, per la diversa modalità con cui i fattori ‘natura’ e ‘cultura’ sono
considerati. Egli, infatti, indica una posizione come «‘Nature-Culture
Continuum’», e l’altra come «‘Nature-Culture Egalitarian’» (ibidem). La
prospettiva esclusionista, circa le CBS, è suggerita, afferma Hahn, dalla stessa
frase culture-bound syndrome, essa, infatti, implicitamente presuppone che
alcune condizioni siano culturalmente determinate, e altre no. Pertanto, le
condizioni che non sarebbero culturalmente determinate, potrebbero essere
considerate «culture-free» (ibidem), e quindi, probabilmente, determinate da
fattori biologici e fisiologici universali. Secondo l’ottica esclusionista se un
fenomeno è indicato come culture-bound, è esclusa la possibilità che esso possa
essere altrimenti determinato, e viceversa. Si crea, quindi, una netta divisione
tra condizioni che sono chiaramente culturalmente determinate, cioè il cui fattore
causale fondamentale risulta essere la cultura, e quelle che sono, invece,
chiaramente universali, ovvero, il cui fattore causale fondamentale risulta essere
naturale, biologico, invariante cioè in ogni luogo e situazione. La
contrapposizione tra fenomeni culture-bound/culture-free si rifletterebbe,
secondo Hahn, anche a livello di una divisione disciplinare, secondo cui, le
14
culture-bound syndromes sarebbero oggetto di indagine da parte di psicologi ed
antropologi, mentre, l’altro tipo di condizioni, sarebbe oggetto di esame da parte
della medicina e psichiatria. Hahn osserva che la prospettiva esclusionista si
rifà, nella spiegazione di un presunto disturbo mentale, alla contrapposizione tra
«‘disease’», che associa il disturbo a invarianti patologiche universali, e
«‘illness’», che lo associa, invece, con le particolarità culturali (Kleinman et al.
1978 , cit. in Hahn 1985: 167)5. La posizione esclusionista, a mio avviso, pecca
di una profonda presunzione etnocentrica. Essa, infatti, si basa sull’idea secondo
cui è possibile distinguere disordini mentali culturalmente determinati (culturebound), da quelli invece liberi da simili condizionamenti (culture-free). Tale
assunzione, però, cade in una sorta di discriminazione, che consiste nel
considerare le patologie occidentali, determinate da fattori biologici universali,
mentre, relega i condizionamenti culturali, esclusivamente alle culture “altre”.
Una simile visione, «equivale a sostenere che gli occidentali si ammalano per
cause profonde e razionali (eziologie biologiche) mentre gli “altri” si
ammalerebbero per cause superficiali e irrazionali (superstizioni e “credenze”)»
(Inglese & Peccarisi 1997: 17). Tale superficialità epistemologica fu evidenziata
già da Kleinman nel 1977, il quale indicò come «category fallacy» l’errore da
parte della psichiatria occidentale nel considerare le categorie, utilizzate per
classificare i disturbi psichiatrici, come entità nosografiche universali, prive cioè
di condizionamenti culturali (Kleinman 1977: 4). L’influenza dell’elemento
culturale quindi, sarebbe relegato a contesti non occidentali. In Occidente,
invece, la ricerca eziopatogenetica dei disturbi mentali, imbrigliata da un’ansiosa
volontà di trovare fattori causali organici o fisiologici, tenderebbe a
marginalizzare, o addirittura escludere, l’elemento culturale. Una simile
prospettiva trascura la nozione fondamentale, su cui insistono gli antropologi,
che il ruolo della cultura non può essere minimizzato, in quanto essa è alla base,
come fa notare Kleinman (1977), del modo in cui la malattia viene da noi
concepita. Il sintomo non può essere ridotto esclusivamente ad un presunto
fattore organico biologicamente innato ma, piuttosto – ritengo – che sia molto
più fecondo focalizzare l’attenzione anche sul modo in cui in ciascuna situazione,
occidentale o non, un disturbo sia socialmente costruito. A tale proposito
condivido a pieno l’idea espressa da Inglese & Peccarisi (1997), secondo cui la
cultura ordina le malattie e i relativi meccanismi di trattamento e terapia. Un
Robert Hahn, qui fa riferimento a due concetti che hanno uno specifico significato
nell’ambito dell’antropologia medica. La ricerca terminologica di questa disciplina,
infatti, ha elaborato un estensione dei termini disease, illness e sickness che nella
lingua inglese rappresentano tre diversi modi per esprimere il concetto di malattia. In
antropologia medica, dunque, con disease, si intende l’alterazione organica
riconosciuta dai paradigmi scientifici della biomedicina; illnes, invece, sta ad
indicare l’esperienza individuale dell’essere malato, ovvero, la percezione personale
di uno squilibrio nel proprio stato di benessere (Eisenberg 1977); con il termine
sickness si intende, infine, ogni modalità di categorizzazione sociale della malattia, e
delle strategie di prevenzione e cura della stessa (Young 1982).
5
15
determinato disturbo, e i modi in cui esso è affrontato e risolto, in un dato
contesto culturale, sono il frutto di una condivisione di significati da parte
dell’intera comunità. Un’affezione può essere intesa come una rappresentazione,
che varia a seconda dell’ambiente, i cui attori sociali sono: da una parte coloro
che manifestano il sintomo disturbante, e dall’altra quelli che si fanno carico di
risolverlo, nonché l’intera comunità che è partecipe del processo di definizione
dell’evento morboso. Come dicono Inglese & Peccarisi:
[…] le culture selezionano e prescrivono modi altamente specifici di
ammalarsi. Tale concezione statuisce che il fenomeno morboso si innesta
organicamente nel processo costitutivo e costruttivo dell’identità etnica e
culturale di una collettività. Le fenomenologie morbose esibite sono pertanto
altrettante partiture attraverso cui viene conseguentemente rappresentata
l’identità profonda che l’individuo assume nel corso dei processi di affiliazione
e di addestramento sociale e culturale. La cultura, cioè, prescrive (ordina)
modalità specifiche di malattia rispetto alle quali conosce e offre modalità
altrettanto selettive di terapia e trasformazione. La natura del malato viene
pertanto sempre inquadrata e risolta all’interno dei saperi generali elaborati
dalle diverse culture (1997: 18).
In virtù di tali considerazioni, appare estremamente limitativo considerare i
fattori culturali, quali ostacoli lungo il percorso che dovrebbe condurre a
individuare elementi biologici universali nell’eziologia di disturbi occidentali, o
confinarli ad un ruolo causale, esclusivamente nell’insorgenza di disordini
diffusi in contesti non occidentali. Risulta poi, a mio avviso, ingenuo il
tentativo di comprendere e risolvere, quelle che sono state etichettate come
“sindromi culturali”, con gli strumenti teorici e pratici propri della clinica
occidentale. Tutto ciò mi appare improbabile, poiché penso che sia possibile
affermare, adattando al campo della medicina un’espressione che Geertz
(1988)6 applica all’arte, che la malattia e l’attrezzatura per afferrarla si
fabbricano nella stessa bottega. I sistemi diagnostici e terapeutici sono
radicati in una data cultura; essi sono intimamente connessi con il sistema di
valori, la storia, l’organizzazione sociale, le tradizioni mitologiche e religiose di
ciascuna cultura. Inoltre, anche i concetti di salute e malattia non hanno un
significato universalmente condiviso ma, piuttosto, essi variano secondo le
diverse latitudini e longitudini. Diagnosticare, trascurando o minimizzando il
retroterra cultura dei pazienti, può condurre a grossolani errori, quali
etichettare come patologici fenomeni che sono, invece, considerati del tutto
normali nelle culture in cui si manifestano. La psichiatria occidentale, nelle sue
espressioni peggiori, offuscata da un delirio di onnipotenza, rigetta e nega i
successi di pratiche cliniche adottate da culture non occidentali. Riconoscere
l’efficacia terapeutica di rimedi tradizionali, appartenenti a culture diverse
dalla propria, probabilmente minerebbe le ambizioni egemoniche, e la cieca
convinzione dell’infallibilità e universale validità del proprio metodo clinico,
che buona parte di medici e psichiatri strenuamente difende. Ogni comunità
L’affermazione di Clifford Geertz è la seguente: «L’arte e l’attrezzatura per
afferrarla si fabbricano nella stessa bottega » (1988: 150)
6
16
umana, come ci fanno notare Inglese & Peccarisi (1997), assegna un proprio
valore e statuto alla persona, al corpo, alle emozioni. Ogni cultura possiede,
inoltre, una concezione ben determinata circa l’anatomia, la fisiologia, la
patologia, che è indispensabile conoscere affinché qualsiasi trattamento
terapeutico possa rivelarsi realmente efficace. Ritornando alle prospettive
individuate da Hahn (1985) circa le culture-bound syndromes, come si è
detto, oltre a quella esclusionista, egli ne descrive altre due che definisce
inclusioniste. La prima, di tali posizioni, è indicata come nature-culture
continuum, mentre, la seconda, che Hahn spiega essere una versione
specifica della prima, come nature-culture egalitarian. Le due prospettive
inclusioniste differiscono, dunque, per le modalità con cui il peso dei fattori
naturali e culturali è considerato determinante nelle CBS. La posizione natureculture continuum, sostiene che tutti gli eventi umani, inclusi quelli supposti
culture-bound, hanno aspetti culturali, naturali, cognitivi e psicodinamici,
sebbene alcuni eventi sono più profondamente costituiti da uno di questi
aspetti che da altri. Pertanto, diversamente da quello che sostengono gli
esclusionisti, nessuna condizione è esclusivamente culture-bound o culturefree, ma alcune potrebbero essere ampiamente culturalmente caratterizzate,
altre principalmente determinate da fattori fisiologici universali. Per cui,
secondo tale prospettiva, gli elementi ereditari, biologici, psicologici e culturali
hanno un peso maggiore o minore in differenti condizioni. Un difficile
problema, potrebbe sorgere dalla possibilità di quantificare le proporzioni in
cui i differenti fattori, contribuiscono nel determinare date condizioni. La
posizione nature-culture continuum, dunque, colloca i fenomeni patologici
lungo uno continuo, alle cui estremità si trovano da una parte fattori biologici,
fisiologici, dall’altra fattori psicologici, culturali. Tale approccio, quindi,
spiegherebbe l’influenza dei fattori naturali e culturali nella determinazione di
un fenomeno morboso, in termini di grado. Ovvero, affezioni quali il morbillo,
per esempio, potrebbero occupare il limite naturale, fisiologico di tale spettro,
mentre, le culture-bound syndromes l’altro. Non è chiaro però che tipo di
condizioni potrebbero cadere tra i due estremi, probabilmente, ipotizza Hahn,
disturbi quali la depressione e l’alcolismo. Hahn, vede nelle formulazioni di
Yap (1969) una adesione alla variante continuum della posizione inclusionista.
Yap, infatti, asserisce che le culture-bound syndromes si adattano all’interno
di una nosologia psichiatrica universale, e assumono forme insolite a causa di
distintive condizioni culturali locali. Benché, egli facesse una chiara distinzione
tra condizioni organiche e funzionali, riconosceva effetti biologici, oltre a quelli
culturali, in entrambe. Anche l’approccio di Simons (1985), e in genere degli
psichiatri inclini ad un modello multifattoriale, è riconducibile alla posizione
nature-culture continuum. Simons, infatti, afferma:
Comunque, Io credo che in almeno alcune delle sindromi gli effetti di fattori
psicologici, sociali, e culturali sono mescolati con gli effetti dei fattori
biologici
in modi intricati
[…]. E’ possibile, e Io credo in alcuni casi
necessario, considerare fattori in molte discipline simultaneamente (1985: 3,
cit in Hahn 1985: 168, trad. mia).
17
Appare evidente da questa citazione, la volontà di superare la netta
contrapposizione disciplinare che era stata proposta dalla posizione esclusionista.
Simons, infatti, anela ad un approccio interdisciplinare, che si adoperi nel fornire
una spiegazione multicausale delle culture-bound syndromes, in altre parole, un
paradigma che riconosca la presenza di concause nella determinazione di tali
condizioni. Nonostante tutto però, come già si è detto (v. infra p. 34), se si
analizzano più accuratamente sia le formulazioni di Yap sia quelle di Simons, si
evince che esse conservano l’antinomia patogenico/patoplastico. Infatti, il
legame intercorrente tra biologia e cultura, è spiegato in modo tale da assegnare
alla prima il potere causativo (patogenico), e alla seconda quella di dare una
forma espressiva apparente (patoplastico). Permane dunque l’idea di una sorta
di subordinazione degli elementi culturali rispetto a quelli naturali per cui, nei
termini di tali concettualizzazioni, il biologico si contrappone al culturale come: il
contenuto alla forma, l’universale al particolare.
La seconda versione della prospettiva inclusionista, individuata da Hahn, consiste
nell’attribuire un valore causativo uguale, sia agli elementi naturali, sia a quelli
culturali. Tale posizione, che è appunto indicata come nature-culture egalitarion,
si pone, spiega Hahn, a metà strada lungo il continuum tra natura e cultura.
Essa, asserisce che tutte le condizioni umane sono ugualmente naturali, culturali,
sociali, cognitive, psicologiche, psicodinamiche etc. Tale posizione risulterebbe
essere, per tanto, secondo Hahn, una versione specifica della modalità natureculture continuum. Essa, propone l’idea secondo cui la cultura, la biologia, e cosi
via, sono ugualmente rilevanti nella comprensione e spiegazione di tutti i
fenomeni umani. Una simile prospettiva prende, dunque, le distanze dalle
distinzioni operate dalla corrente esclusionista, e pone invece sullo stesso piano,
per esempio, disturbi quali il morbillo, la depressione e le culture-bound
syndromes. La modalità egalitarion della posizione inclusionista sostiene, quindi,
che tutte le sindromi sono ugualmente culture-bound pertanto, tale concetto
risulta essere inutile e superfluo. Naturalmente, se la nozione di culture-bound
syndrome è intesa come onnicomprensiva di qualsiasi disturbo, partendo dal
presupposto secondo cui la determinante culturale sarebbe presente in ogni
manifestazione di un sistema culturale, viene minata la coerenza logica della
categoria CBS. Tale categoria, infatti, è stata costruita per etichettare quelle
‘sindromi esotiche’ che non avrebbero trovato, altrimenti, nessuna collocazione
nei paradigmi della nosografia occidentale. Includendo, invece, nel concetto di
CBS qualsiasi sindrome, rilevabile in qualsiasi contesto culturale, si paleserebbe
la possibilità di abbandonare una simile nozione, in quanto, fallace e di dubbia
utilità. Dato che l’espressione culture-bound syndromes, è stata coniata per
indicare le qualità idiosincratiche di sindromi ‘altre’, cioè tipiche di collettività
umane delimitate, se esso è inteso come indicativo di qualsiasi morbosità, è
chiaro che si sfalda la sua valenza semantica, ed è messa in discussine la ragion
d’essere di tale categoria.
La posizione nature-culture egalitarian, è illustrata dal lavoro di Lehrman (1970,
cit. in Hahn 1985: 168), uno psicofisiologo che, pur non facendo riferimento a
nessuna patologia in particolare, insiste nell’affermare che ogni comportamento
è al 100% determinato dall’influenza della biologia, e al 100% determinato
18
dall’influenza della storia esperienziale. Più interessanti, per inquadrare
l’approccio egalitario alle CBS, risultano essere i lavori di Cassidy (1982) e
Ritenbaugh (1982). Le due autrici americane, hanno riformulato il concetto di
culture-bound syndrome in un articolo, rispettivamente, sulla P.E.M. (proteinenergy malnutrition)
e sull’obesità. Cassidy e Ritenbaugh partono dal
presupposto secondo cui tutte le società si preoccupano delle malattie e, tutte,
sviluppano significati per spiegarle e trattarle, e per preservare lo stato di salute.
Questi modelli esplicativi sono, secondo le due studiose americane, espressivi dei
valori fondamentali di ciascuna società; è pertanto discutibile limitare le culturebound syndromes all’esotico. Le due autrici nei due differenti articoli, pubblicati
sullo stesso numero della rivista «Culture, Medicine and Psychiatry» (6, 1982),
forniscono una ridefinizione del concetto di CBS che si dispiega in quattro punti
fondamentali. Esse scrivono:
Una culture-bound syndrome è una costellazione di sintomi che è stata
categorizzata come una disfunzione o malattia. Essa è caratterizzata da uno o
più dei seguenti punti: (1) Non può essere compresa al di fuori del suo
specifico contesto culturale o subculturale. (2) L’eziologia sintetizza e
simbolizza i significati profondi e le norme comportamentali di quella cultura.
(3) La diagnosi si basa su di una tecnologia oltre che su di un’ideologia
culturalmente specifiche. (4) Il successo nel trattamento è ottenuto solo dai
membri di quella cultura (Cassidy 1982: 326 e Ritenbaugh 1982: 351, trad.
mia).
Attraverso la ridefinizione del concetto di culture-bound syndrome, Cassidy e
Ritenbaugh vogliono dimostrare che il condizionamento culturale è comune, ed è
insito nelle categorie biomediche occidentali come in quelle non occidentali. Le
argomentazioni delle due autrici conducono a quello che potrebbe essere
indicato come un processo di decostruzione logica della categoria CBS (Karp
1985; Hahn 1985; Hufford 1988; Ciminelli 1997). I concetti di folk illness prima,
e quello di culture-bound syndrome poi, infatti, sono stati costruiti per
classificare una serie di disturbi, principalmente mentali, refrattari all’essere
inseriti nelle griglie della nosografia psichiatrica occidentale. Tali concetti,
dunque, avevano la finalità di essere indicativi di ‘particolari’ disordini
riscontrabili in culture altre. Allargando, invece, come fanno Cassidy e
Ritenbaugh, la categoria CBS, intendendola come un contenitore entro cui poter
includere qualsiasi tipo di disturbo, riscontrabile in qualsiasi contesto, si minano
le fondamenta su cui
tale costruzione logica si basa e se ne provoca
un’esplosione. Le due autrici, infatti, sostengono che la designazione di una
malattia si basa su di un processo di astrazione della realtà esperienziale,
attraverso l’utilizzo di modelli esplicativi che non sono universali, ma
idiosincratici di ciascuna cultura; pertanto qualsiasi determinata entità morbosa
risulta essere culture-bound. L’idea secondo cui anche in Occidente l’attribuzione
causale è culturalmente determinata, è stata ampiamente misconosciuta a causa
della tendenza, tra gli scienziati biomedici, a trattare la scienza come
culturalmente libera (culture-free), e universalmente comprensibile ed
esportabile. Un simile atteggiamento, come sottolinea criticamente la Ciminelli
(1997), può essere riscontrato sia in Hahn (1985) che in Prince (1987), i quali
19
manifestano una sorta di rifiuto nell’accettare le conclusioni di Cassidy e
Ritenbaugh, ed abbandonare il concetto di CBS. Robert Hahn, infatti, dopo aver
presentato l’approccio egalitarion alle culture-bound syndrome, e riconosciuto
che esso sfalda tale concetto, ne prende le distanze. Lo psichiatra Raymond
Prince, invece, addirittura fornisce una nuova definizione di culture-bound
syndrome, per evitare che se ne depauperi la valenza semantica fino a provocare
la scomparsa di tale concetto. Prince, infatti, afferma di opporsi all’idea secondo
cui qualsiasi disturbo sia culture-bound, e come reazione a questa «deriva verso
l’insensatezza» (1987: 3), cui le formulazioni di Cassidy e Ritenbaugh sembrano
condurre, propone una definizione di CBS intesa come una costellazione di segni
e sintomi, esclusa la nozione di causa, che è ristretta ad un limitato numero di
culture principalmente per ragioni legate ad alcune delle loro caratteristiche
psicosociali. Egli, inoltre, spiega che intende escludere dalla sua definizione i
riferimenti eziologici e i nomi indigeni dei vari disturbi, perché estremamente
forvianti e mutevoli, mentre l’insieme di segni e sintomi sarebbe costante nel
tempo e verificabile da qualsiasi ricercatore. Dalle affermazioni di Prince si palesa
un intento reazionario, che riafferma la vecchia idea di CBS come indicativa di
disturbi esotici, e cerca di offuscare la rivoluzione concettuale apportata invece
da Cassidy e Ritenbaugh. Il fatto che, fanno notare queste due autrici americane,
la biomedicina non includa, o marginalizzi, la cultura nel suo modello esplicativo
di base, porta a non individuare culture-bound syndrome all’interno delle culture
occidentali e del sistema biomedico; conduce, inoltre, alla ridefinizione di
sindromi di altre culture nei termini biomedici, cosi che importanti elementi
culturali saranno trascurati nel processo di diagnosi e terapia. Cassidy e
Ritenbaugh, inoltre, insistono sulla necessità da parte dei terapeuti,
per
ottenere un intervento di successo, di riconoscere e accettare che essi e i
pazienti potrebbero far riferimento a modelli esplicativi, culturalmente
determinati, completamente differenti. Se ciò si verifica non si instaura un
processo comunicativo, e il terapeuta e il paziente saranno destinati a non
intendersi, e la terapia, inevitabilmente, a fallire. L’errore nel quale non si deve
cercare di incappare è quello di ricondurre le manifestazioni morbose del
paziente al proprio modello esplicativo, poiché ciò, con molta probabilità,
determinerà nel paziente l’impressione di non essere ascoltato e compreso, e lo
spingerà a rigettare la spiegazione causale e il trattamento che gli viene offerto.
Il grado di incomprensione, tra terapeuta e paziente, sarà tanto maggiore quanto
più alto sarà il grado di divergenza tra i rispettivi modelli, e
quest’incomprensione, che non è rara nella pratica biomedica occidentale,
diviene particolarmente evidente quando la biomedicina è esportata. Ogni
terapeuta, ci dicono dunque le due autrici, dovrebbe imparare a sintetizzare e
integrare i diversi modelli, senza rigettare ne dare per scontato quelli del
paziente.
Particolarmente interessante, in questa prospettiva, è anche un articolo di Ivan
Karp (1985), il quale pur non facendo alcun riferimento esplicito ai lavori di
Cassidy e Ritenbaugh, presenta forti analogie concettuali con queste due autrici.
Karp partendo dal presupposto, espresso da Devereux (1956), secondo cui il
limite tra normale e anormale negli studi cross-culturali è estremamente difficile
20
da tracciare, sferra un’accesa critica al concetto di culture-bound syndrome. Egli
rivendica la valenza comunicativa di quelle cosidette sindromi, insistendo
nell’affermare che esse sono veicoli per la comunicazione, sono atti sociali, mezzi
attraverso cui si ridefinisce il proprio rapporto con la società. La connessione tra
CBS e disturbo mentale, dice Karp, è spesso discutibile. Infatti, sotto questa
etichetta, sono collocati una varia collezione di comportamenti che formano una
categoria solo per le difficoltà di interpretazione che pongono ad osservatori
esterni, e non perché abbiano in comune reali fattori di similarità. I
comportamenti, asserisce ancora l’autore, che vengono indicati come culturebound syndrome, sono spesso strumenti attraverso cui si esprime una
problematica relazione tra il sé e la società. Una caratteristica, infatti, di tali
comportamenti, è che essi drammatizzano aspetti concreti e non verbali della
relazione tra il sé la società e l’altro. Alcune CBS, sostiene Karp, potrebbero
essere esaminate come rituali e drammatiche forme che cercano di raggiungere
i loro scopi attraverso la trasformazione del comune, l’ordinario, in straordinario.
L’autore poi rivolge la sua critica al modello tassonomico, che tenderebbe, a suo
avviso, a degenerare verso un modo di fare simile al «collezionare farfalle in
base alle loro somiglianze superficiali» (223). Questo è infatti, sostiene Karp, ciò
che si è verificato con la categoria culture-bound syndrome, poiché essa è il
prodotto di un’acritica applicazione di nozioni basate su criteri medico-psichiatrici
occidentali ad altre società. Karp, asserisce che il concetto di CBS nasconde
molto più di quello che sembra rivelare, poiché esso combina molte forme
disparate sotto un’unica etichetta. L’autore ritiene che alcune culture-bound
syndromes costituiscono sottoclassi di una più ampie categoria, che potrebbe
essere indicata come agire sociale. Il significato di un’azione sociale, continua
ancora Karp, non è trasparente, e potrebbe probabilmente risiedere nella
relazione tra ciò che è stato fatto e il contesto in cui ciò è avvenuto, tra testo e
contesto. Le azioni non possono essere comprese indipendentemente
dall’ambiente in cui esse si manifestano. Gli osservatori che, ammonisce l’autore,
considereranno superficialmente le sfumature culturali, falliranno nella
comprensione del metamessaggio che l’azione esprime. Spesso il senso di
un’azione non risiede nel suo contenuto, ma nel modo in cui tale contenuto è
rappresentato. Karp si chiede, retoricamente, perché i significati profondi sono
così spesso oscuri agli osservatori, e poi, immediatamente dopo, afferma che la
risposta è da ricercare nell’imposizione di categorie etnocentriche e
nell’insensibilità verso le sfumature culturali. La difficoltà dell’interpretazione
nasce, dunque, secondo l’autore, perché le culture-bound syndromes sono
spesso articolate in un idioma culturale, una cosmologia – intesa come un
sistema di analogie attraverso cui l’esperienza è interpretata – differente dalla
nostra. Per cui, suggerisce Karp, si dovrebbero esaminare i locali sistemi di
significato che sono prodotti e riprodotti nelle azioni pratiche dei membri di
ciascuna società. A livello di strategie personali e sociali, nell’ottica espressa da
Karp, le CBS rappresenterebbero, per i membri di ciascuna comunità, dei mezzi
per ridefinire se stessi, mezzi che assumono la loro forma dalle cosmologie delle
società in cui emergono. Se ci si limita, fa notare ancora l’autore, ad etichettare
le culture-bound syndromes semplicemente come disturbi mentali, esse ci
21
appariranno solo come comportamenti anomali bizzarri o, talvolta, addirittura
ironici, ma continuerà a restare oscura la profondità e la drammaticità dei
significati che dietro tali manifestazioni si celano. Le argomentazioni di Ivan
Karp, nonché la
posizione nature-culture egalitarian in generale, che trova
nelle formulazioni di Cassidy e Ritenbaugh la sua forma più organica e originale,
gettano luce su problematiche d’ingente attualità. Il mondo è sempre più
immerso in un processo di globalizzazione, i saperi tecnico-scientifici devono,
pertanto, confrontarsi sempre più spesso con il diverso, l’eterogeneo, il dissimile.
La cultura occidentale non può fronteggiare una simile situazione arroccandosi
difensivamente all’interno delle proprie conoscenze in un atteggiamento
solipsistico. Diviene invece sempre più indispensabile trarre dal contatto con le
altre culture, la possibilità di superare i limiti ed espandere i confini della
conoscenza scientifica. È auspicabile, dunque, nel momento attuale più che mai,
come ancora una volta direbbe Geertz (1988), che prenda concretamente forma
la consapevolezza che «la nostra è una voce tra le altre» (299) e che «non siamo
circondati né da marziani né, [soprattutto], da riproduzioni di noi stessi riuscite
meno bene» (22).
CAPITOLO TERZO
NUOVE PROSPETTIVE: LE CBS OCCIDENTALI
L’articolo dell’americana Cheryl Ritenbaugh (1982), introduce un’interessante
riflessione sulla questione delle culture-bound syndromes. Ella, infatti,
criticamente nota come, sia le folk illness sia le CBS, che considera come
sinonimi per indicare un medesimo fenomeno, siano state ampiamente
individuate in contesti non occidentali, ma, stranamente, assenti in Occidente.
L’autrice attribuisce la causa di ciò ad un’etnocentrica tendenza da parte dei
ricercatori occidentali, i quali nell’impossibilità di comprendere disturbi di altre
culture, riconducendoli al modello biomedico, li avrebbero etichettati come
culture-bound syndromes; mentre, tutti i disturbi occidentali sarebbero stati
spiegati attraverso il suddetto modello. La Ritenbaugh, parte dal presupposto
secondo cui tutte le culture, organizzano le loro informazioni circa la biologia
umana, all’interno di categorie di malattie. La biomedicina, nelle società
occidentali, sarebbe il sistema predominante entro cui vengono organizzate
queste informazioni. Il privilegiare l’aspetto biologico, suggerisce l’autrice,
avrebbe oscurato, in Occidente, l’importanza della componente culturale nelle
definizioni biomediche di malattia. Ella sostiene che l’errore compiuto dagli
studiosi occidentali, è dovuto a una fusione concettuale tra dati biologici, ritenuti
dall’autrice misurabili su ogni organismo, e categorie biomediche, considerate
invece culturalmente specifiche. La biomedicina, afferma Ritenbaugh, è una
particolare struttura concettuale per interpretare dati biologici: essa è
culturalmente costruita. Secondo l’autrice, dunque, i dati biologici descrivono
solo un continuum biologico, mentre le malattie sono categorie discrete
sovrimposte al continuum biologico. Per chiarire questo concetto, la studiosa
22
americana, propone di esaminare la categoria biomedica “anemia”. C’è una
considerevole normale variazione tra gli individui e tra le popolazioni, spiega la
Ritenbaugh, della quantità di emoglobina nel sangue. Per esempio, le persone
che praticano attività faticose, o che vivono ad alte altitudini, tendono ad avere
più alti livelli di emoglobina, degli individui che praticano attività sedentarie e
vivono a livello del mare. Nelle persone con livelli di emoglobina estremamente
bassi, generalmente sono compromesse funzioni biologiche in rapporto alla
popolazione media. In biomedicina, gli individui con
livelli di emoglobina
considerati troppo bassi, sono indicati come affetti da anemia, una malattia. La
definizione di malattia è basata sulla misura dell’emoglobina nel sangue; valori
al disotto di
10g/100ml, un valore arbitrariamente scelto, come fa notare la
Ritenbaugh, indicano anemia. L’autrice sostiene, dunque, che i dati biologici
(livelli di emoglobina nel sangue) sono misurazioni che possono essere fatte per
ogni individuo in ogni cultura; ma la transizione dal registrare i dati, al
classificare gli individui come anemici, nasce dalla costruzione biomedica del
concetto di anemia. Effettuando, dunque, analisi
cross-culturali basate, per
esempio, sulla percentuale di popolazione anemica, ammonisce la Ritenbaugh, si
impone una categoria culturale occidentale ai dati biologici, limitando
rigidamente le potenzialità analitiche e le intuizioni che potrebbero essere
ottenute. Un interessante esempio di questo tipo di errore interpretativo, solo
recentemente riconosciuto, è la scoperta di evidenti differenze biologiche nei
livelli normali di emoglobina tra i Neri Americani e gli Anglosassoni (Garn et al.
1975).
In passato venivano rilevati tassi estremamente alti di “anemia” tra i Neri. Molti
articoli furono scritti nel tentativo di spiegare quest’alta frequenza di “malattia”
come dovuta a specifici fattori alimentari, quali una dieta carente di ferro. In
seguito Stanley Gern, un antropologo medico, insieme ai suoi collaboratori
misero in evidenza che i livelli di emoglobina erano più bassi per i Neri rispetto ai
Bianchi tra tutte le popolazioni studiate, perfino tra gli atleti ben nutriti. Altre
misure delle riserve di ferro che furono effettuate (Garn et al. 1981),
dimostrarono che un normale (sano, non patologico) valore dell’emoglobina nel
sangue per i Neri era circa 1g/100 ml inferiore rispetto a Bianchi. Grazie a
questo studio, dunque, molti casi di anemia tra i Neri scomparvero. I dati
biologici (livelli di emoglobina), come fa notare la Ritenbaugh, non cambiarono,
ciò che cambiò fu il modo in cui essi venivano interpretati all’interno della
biomedicina. Pertanto, in relazione a quanto detto, l’autrice ritiene non solo
possibile, ma indispensabile per evitare simili errori, concettualmente separare i
dati biologici dalle categorie biomediche. L’articolo della Ritenbaugh, poi, procede
in un’analisi del fenomeno dell’obesità nella società statunitense. L’autrice,
rifacendosi alla definizione di culture-bound syndrome proposta da lei e da
Cassidy (v. infra p. 48-49), asserisce che l’obesità può essere tranquillamente
considerata una CBS occidentale. Essa, infatti, rifletterebbe precisamente le
quattro condizioni indicate, dalle due autrici americane, come fondamentali nella
definizione di una culture-bound syndrome. L’obesità, dunque, è rapportata,
nell’articolo in esame, ai quattro punti principali che contraddistinguono, nella
concezione di Cassidy e Ritenbaugh, qualsiasi CBS.
23
1) Una culture-bound syndrome non può essere compresa al di fuori del suo
specifico contesto culturale o sub-culturale: una moderata obesità, infatti,
sostiene l’autrice, è tuttora considerata un segno di bellezza e di buona
salute in molte società, ed era considerata in questi termini anche negli
U.S.A. fino a questo secolo. Attualmente, invece, da molti anni, lo stesso
grado di obesità è considerato, da molti professionisti nella cura della salute,
come uno dei più diffusi problemi negli Stati Uniti. Essa, infatti, è stata
descritta come un’epidemia che affligge metà della popolazione adulta
(Lasagna 1980).
2) L’eziologia di una culture-bound syndrome sintetizza e simbolizza i significati
profondi e le norme comportamentali di quella particolare cultura: l’eziologia
dell’obesità, fa notare la Ritenbaugh, è descritta in biomedicina come una
sproporzione tra la quantità di energia ingerita e la quantità di energia
consumata. Più semplicemente, essa è il risultato di una sovralimentazione e/o
di un ridotto esercizio. Secondo l’autrice, questi sarebbero i termini biomedici per
indicare ì fallimenti morali della golosità e pigrizia. Nella società americana, ella
spiega, il controllo individuale e la paura del non controllo hanno una notevole
importanza, l’obesità sarebbe la prova evidente del non controllo.
3)La diagnosi si basa su di una tecnologia oltre che su di un’ideologia
culturalmente specifiche: la diagnosi di obesità si basa sull’idea che l’essere
grassi è poco salutare; essa inoltre necessita di un accordo su specifici criteri e
strumenti diagnostici. Se il criterio, fa notare la Ritenbaugh, è una valutazione
visiva di sé nudo davanti a uno specchio, risultano essere indispensabili lo
specchio e la volontà di guardarsi ed esaminarsi. Gli standars che stabiliscono le
“giuste” relazioni tra altezza e peso, si basano su taciti accordi convenzionali
stabiliti all’interno di una società. Inoltre, alla percezione del proprio peso si
perviene mediante gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione.
4) Il successo nel trattamento è ottenuto solo dai membri di quella cultura: un
trattamento di successo dell’obesità, infatti, ci dice l’autrice, come è percepito
all’interno della cultura americana, necessita di una serie di comportamenti non
immediatamente comprensibili da osservatori esterni. Un breve periodo di
perdita di peso, è da molti considerato il frutto di un trattamento di successo; il
peso rapidamente riacquistato è visto, però, come un evento separato. Perdere
peso senza aver preordinato lo sforzo per raggiungere quello scopo non è
considerato come un trattamento, benché il risultato finale è lo stesso. Inoltre,
continua la studiosa americana, il mettersi a dieta trasmette un preciso
messaggio, indipendentemente dal fatto che si perda o no peso, esso indica agli
altri membri della sua società che, il soggetto obeso, ha assunto il ruolo di
malato e accetta gli standards sociali, anche se il suo corpo sembrerebbe
indicare diversamente.
La Ritenbaugh, fornisce poi una breve prospettiva storica circa i diversi modi in
cui l’essere grasso è stato considerato nel corso del tempo, fino a giungere
all'attuale interpretazione dell'obesità, nel contesto statunitense, come
patologica. Ella parte nella sua analisi, dall’esame di alcuni dei primi esempi
d’arte, risalenti a circa 20000/25000 anni fa, in cui sono raffigurate donne
estremamente grasse. La precisione dei dettagli anatomici del corpo, in queste
24
raffigurazioni, conduce l’autrice a supporre che esse erano eseguite servendosi di
persone reali come modelle, o che, sicuramente, quel prototipo di corpo
femminile era molto diffuso, e quindi ben noto, nella società del tempo. Molto più
tardi, l’arte e la letteratura greca antica esaltavano come attributo positivo
l’essere grasso. Già nel Medio Evo, però, l’estrema grassezza cadde in discredito,
e la golosità divenne un peccato veniale. Riflessi di questo ascetismo religioso
continuano ad essere forti ancora oggi nella cultura occidentale. Sin dall’età
classica, matura un’associazione tra l’estrema grassezza e la scarsa salute. La
relazione tra l’eccessiva grassezza e un deficitario stato di salute, che era stato
sostenuto per centinaia di anni, conduce le compagnie di assicurazioni
statunitensi, agli inizi del nostro secolo, a stabilire dei tassi assicurativi più alti
per le persone particolarmente grasse. Per rendere ciò più sistematico, la Society
of Actuaries promulgò delle tabelle che stabilivano il rapporto ideale tra peso e
altezza, in modo che le penalità potevano essere opportunamente applicate.
Analizzando le successive revisioni che sono state introdotte nel corso degli anni,
fa notare l’autrice, si nota una regolare riduzione del peso ideale stabilito per le
donne, e una riduzione, sia pur meno regolare, per gli uomini. La Ritenbaugh,
dunque, suggerisce di cercare le cause della diffusione epidemica dell’obesità,
principalmente nella progressiva riduzione degli standards ideali di peso/altezza.
Paradossalmente, in contrasto al declini del peso ideale, diversi dati (Lew –
Garfinkel 1979; Keys 1980; Larssons 1981) sostengono l’idea secondo cui
l’essere più pesanti è più salutare, o almeno non meno sano. Sostiene l’autrice
americana, che l’obesità ha assunto notevole importanza nelle ricerche e nei
trattamenti medici poiché essa è strettamente legata a profondi valori sociali
occidentali; e che il cambiamento in senso discendente degli standards di peso,
non basato su dati biologoci, sarebbe la prova del lavoro delle forze culturali.
Per cui ci sarebbe un intima connessione tra le trasformazioni dei valori culturali
e i mutamenti negli standards biomedici, piuttosto che tra questi ultimi e una
reale base scientifica. La Ritenbaugh asserisce, che attualmente il mito della
magrezza si associa con quello della giovinezza, della bellezza e della ricchezza.
Sono, infatti, i soggetti più giovani quelli che più si avvicinano al peso ideale,
inoltre, la facoltà di accedere a dispendiosi prodotti alimentari, che abbiano il
massimo potere nutritivo in una minima quantità di calorie, nonché la possibilità
di sottoporsi a trattamenti dimagranti, sempre più costosi, sono sinonimi di un
elevato status economico. Giovinezza, bellezza e ricchezza sono sicuramente tra
le caratteristiche più ambite e ricercate nella società occidentale, l’obesità,
invece, rappresenta la negazione di tutti e tre questi valori, appare evidente
quindi la sua indesiderabilità. L’analisi condotta dalla Ritenbaugh, si pone la
finalità di dimostrare come, la nozione di peso ideale non si basa su dati
biologici, ma piuttosto è una costruzione sociale, che varia, dunque, con il
variare del suo contesto storico e culturale. Tuttora, la concezione negativa
dell’obesità, non è universale ma si espande geograficamente insieme
all’esportazione della cultura e della biomedicina occidentale. L’obesità, dunque,
e la sua epidemica diffusione, ci dice l’autrice, nasce dall’imposizione di una
categoria biomedica a dati arbitrariamente stabiliti. Il pregio principale
dell’articolo della Ritenbaugh, io penso, sta nella volontà di dimostrare che la
25
nozione di culture-bound syndrome non ha come suo carattere fondamentale
quello dell’esoticità, ovvero, le CBS non sono fenomeni che si manifestano
esclusivamente in culture altre, ma possono trovare cittadinanza anche nella
società occidentale. L’obesità sarebbe, nella prospettiva tracciata dall’autrice,
assolutamente, un esempio di culture-bound syndrome occidentale. Il merito
principale di questo lavoro della Ritenbugh, che
va indiscutibilmente
riconosciuto, sta nell’aver aperto una nuova prospettiva, quella cioè di
considerare anche alcuni dei disturbi occidentali, come culture-bound
syndromes. Un cospicuo numeri di articoli
(Prince 1985; Swartz 1985;
Littlewood – Lipsedge 1987; DiNicola 1990; Banks 1992; Lee 1996 etc.) si
interrogano circa la natura culture-bound di un altro disturbo molto diffuso in
Occidente: l’anoressia nervosa. Tale affezione, nonostante apparentemente
sembri diametralmente opposta all’obesità, in realtà condivide con questa un
sostrato comune. La fobia di ingrassare, infatti, che è un aspetto fondamentale
della definizione nosologica occidentale dell’anoressia nervosa (DSM-IV), è
profondamente dipendente da quello standard di peso ideale, auto ed etero
indotto, culturalmente costruito, che conduce all’etichettamento dell’obesità, in
Occidente, quale patologia di portata epidemica. Il rifiuto di nutrirsi da parte
degli anoressici, dunque, potrebbe essere letto come una risposta, spropositata,
alla paura di non conformarsi ad un modello fisico che la società occidentale
esalta, l’auto-affamamento, quindi, quale reazione estrema per assicurarsi il
consenso sociale. Sia Swartz (1985) sia Lee (1996), per motivare l’idea secondo
cui l’anoressia nervosa può essere intesa come una culture-bound syndrome,
conducono un processo molto simile a quello svolto da Ritenbaugh (1982) per
l’obesità. Essi, dunque, dimostrano l’assonanza dell’anoressia con i criteri indicati
da Cassidy/Ritenbaugh per la definizione di una CBS. Le osservazioni
epidemiologiche che inducono a sostenere l’ipotesi di un condizionamento
socioculturale nell’insorgenza di tale sindrome, possono essere così
schematicamente
sintetizzate: differenza cross-culturale, con una netta
prevalenza nei contesti più sviluppati e industrializzati; tasso di incidenza
ineguale tra i due sessi, con una predominanza nelle donne; differente
distribuzione in funzione della professione, con più alto rischio in caso di lavoro
in cui le persone devono vendere la propria immagine e le proprie prestazioni
fisiche; differente distribuzione fra le diverse classi sociali, con una
predominanza in quelle più alte (DiNicola 1990). I sostenitori della natura
culture-bound dell’anoressia occidentale, dunque, indicano tra i fattori scatenanti
di tale sindrome, l’importanza attribuita ai valori estetici, all’elogio della
magrezza come modello di bellezza, che è connesso con l’esaltazione
dell’autocontrollo, dell’assertività, della competitività, del successo sociale ed
economico. La pressione alla magrezza, esercitata soprattutto attraverso i mass
media, creerebbe una profonda insoddisfazione per il proprio corpo, da cui
deriverebbero poi comportamenti ed atteggiamenti alimentari disturbati.
Secondo quest’impostazione, gli ideali estetici si porrebbero come veri e propri
agenti causali nell’insorgenza di una serie di comportamenti disturbati: inedia,
continuo ricorso a diete, vomito autoindotto, massiccio uso di lassativi, esercizio
fisico estremo, tutti sintomi connotativi dell’anoressia nervosa. I dati sulla
26
disparità di incidenza di tale sindrome nei due sessi, conduce, inoltre, ad
un’analisi sul ruolo e sullo status della donna in Occidente. Viene sottolineata la
difficoltà dello sviluppo dell’identità di genere femminile, in un contesto che
propone come unico modello valido di essere umano, quello maschile,
esaltandone le caratteristiche di autonomia, d’indipendenza, di autocontrollo e di
assertività, mentre svaluta quelle femminili più tendenti all’attenzione agli aspetti
psicologici, al coinvolgimento emotivo ed all’impegno verso gli altri. Oggi, inoltre,
il ruolo della donna vive una situazione di bilico fra tradizione e modernità, il che
richiede un difficile processo di ridefinizione. Alcuni autori (Katzman – Lee 1997;
Catina – Käkele 1994) vedono in questi elementi fattori di rischio per
l’insorgenza dell’anoressia, inoltre, si servono di essi per spiegarne il diverso
tasso di incidenza tra i due sessi (predominanza nelle donne). Altro elemento
culturale addotto nella spiegazione eziologica dell’anoressia, è l’educazione
religiosa. Un valido contributo, a tale proposito, è offerto da Banks (1992).
Quest’autrice americana, infatti, inscrive l’auto-affamamento all’interno del
discorso religioso (cristiano), ovvero, vede l’anoressia come una ricerca mistica,
una volontà ascetica. Banks, dunque, lega le manifestazioni anoressiche agli
ideali
cristiani del rifiuto del cibo e della purezza sessuale7. Il digiuno
rappresenterebbe, quindi, per gli anoressici, un tentativo di raggiungere quegli
ideali normativi riguardo al controllo del corpo, forniti dalla loro tradizione
religiosa8. Di particolare interesse è anche l’articolo di Lee (1996), il quale
ribadisce la natura culture-bound dell’anoressia. Secondo questo autore, la fobia
di ingrassare incarna ed estremizza i valori estetici e morali dell’Occidente;
l’essere magro in tale contesto è diventato il simbolo non solo della bellezza, ma
anche della giovinezza, dell’efficienza, dell’autocontrollo e del benessere.
L’autore propone di considerare l’anoressia nervosa come
un complesso
meccanismo
di
controbilanciamento
all’effetto
della pressione
esercitata
sugli
individui, in particolare le donne, affinché si adeguino ad un immaginario
corporeo eccessivamente rigido. Il comportamento anoressico potrebbe, dunque,
essere visto come il mezzo attraverso cui si manifesta una sorta di sovversione
nei confronti di eccessivi canoni estetici, attraverso la loro esasperazione.
L’anoressia, infatti, propugnando un modello di magrezza estrema, provoca
reazioni sociali negative, che conducono alla messa in discussione dell’ideale di
snellezza e della sua affannosa ricerca, nonché ha la finalità di ammonire gli
individui preoccupati per il proprio peso ad accettare come salutare una più vasta
gamma di forme corporee.
Il ruolo della cultura nell’insorgenza di disturbi alimentari, è pressoché
unanimemente riconosciuto, benché con diversi accenti in relazione al particolare
approccio teorico utilizzato. L’accettazione della definizione
dell’anoressia
Si noti che uno dei principali sintomi dell’anoressia nervosa è l’amenorrea.
Per un approfondimento del legame tra anoressia nervosa e condizionamenti
religiosi si vedano anche: Bell 1997; Raimbault – Eliacheff 1991; Vandereycken –
Van Deth 1995.
7
8
27
nervosa come una culture-bound syndrome occidentale, da parte del pensiero
medico-psichiatrico dominante, appare però, come fanno notare acutamente
Cardamone e Zorzetto (1998), piuttosto contraddittoria: «mentre si riconosce
soddisfatti la natura culture-bound di simili disturbi, li si colloca sull’Asse I del
DSM-IV, ben distanti da quel glossario delle sindromi culturalmente
caratterizzate che in fin dei conti deve contenere solo il disagio irrazionale ed
esotico » (84).
Sulla scia tracciata dalla Ritenbaugh (1982), si inserisce un altro interessante
lavoro di due autori americani, Robert Hill e Dennis Fortenberry (1992). Questi
due autori, in accordo con la definizione di CBS proposta da Cassidy/Ritenbaugh,
sostengono che l’adolescenza, nel contesto sociale americano, può essere
definita come una culture-bound syndrome. Essi affermano che questa fase dello
sviluppo umano, nella società americana del ventesimo secolo, è
progressivamente divenuta connotativa di un complesso di sintomi, ovvero di
una condizione patologica. L’adolescenza è, dunque, descritta come una
tormentata e pericolosa fase di crescita, e gli adolescenti sono indicati come i più
esposti alle «‘epidemie’ multiple» che affliggono la nazione: malattie a
trasmissione sessuale, abuso di droghe, gravidanze indesiderate, alcolismo,
suicidi, sono tra le più note. Fanno notare polemicamente Hill e Fortenberry, che
l’adolescenza è vista come l’inevitabile fattore di rischio per questi diffusi
problemi, come se la loro origine fosse innata in essa, piuttosto che essere
considerata come il prodotta di una complessa interazione tra fattori biologici,
aspetti culturali, elementi di personalità, espedienti politici e disfunzioni sociali. I
due autori sostengono che l’adolescenza, soprattutto nel corso dell’ultimo
trentennio, è stata «medicalizzata» come una condizione essenzialmente
patologica. La «medicalizzazione» viene descritta come una tendenza, nella
società americano, a cercare spiegazioni biologiche per una vasta serie di
disturbi psicosociali, sospinti dalla convinzione che tali fenomeni siano definibili e
trattabili attraverso gli strumenti della moderna biomedicina. Il processo di
«medicalizzazione» della adolescenza, viene ricondotto a due professionali basi
culturali: la medicina e la psichiatria specializzate nella cura dell’adolescenza. Il
Diagnostic and Statistical Manual (DSM) dell’ American Psychiatric Association,
rappresenta la base scientifica, tecnica e ideologica della psichiatria americana.
Nelle diverse edizioni di questo manuale, che si sono successe nel corso degli
anni, si è verificato un progressivo aumento dello spazio dedicato
all’adolescenza, quale condizione di rischio per l’insorgenza di una serie di
disturbi comportamentali, nonché alla gravità ad essa attribuita. I due autori
americani sostengono che i vari DSM, nonché la letteratura psichiatrica in
generale, trascurano l’aspetto eziologico ed epidemiologico dei disturbi
comportamentali dell’adolescenza che classificano come patologici. Hill e
Fortenberry, invece, citano una vasto studio (Offer et al. 1990) condotto su più
di 300000 adolescenti, che mette in discussione l’idea di una diffusione
epidemica di disturbi comportamentali durante questa fase di sviluppo. Tale
studio concludeva, infatti, che circa l’80% dei giovani esaminati era normale e
non presentava disturbi comportamentali; se dal restante 20% si escludono le
diagnosi di ansietà e depressione, identificabili durante tutto il ciclo di vita,
28
rimane, fanno notare gli autori, una un esiguo numero di casi di disturbi mentali
attribuibili alla specificità della fase adolescenziale. L’origine della medicina
dell’adolescenza, come nuova specialità, viene attribuita a due principali forze:
da una parte la riduzione dei tassi di morbosità e mortalità delle malattie
infettive, che consentono lo spostamento delle ricerche (incluso i capitali) verso
problemi prima trascurati; dall’altra lo sviluppo di un movimento sociale medico,
per mezzo del quale un segmento di professionisti, con un simile background e
interessi comuni, iniziarono a considerare le medesime cose come problemi
(Silber 1980).
Progressivamente, ed in particolare negli anni ottanta, si è affermata
l’espressione «giovinezza ad alto rischio», con la quale si intendeva indicare
l’adolescenza come fattore predisponente all’insorgere di una serie eterogenea di
disturbi. Gli autori contestano questo processo che ha condotto ad eleggere
l’adolescenza come primario fattore di rischio e, quindi, a connotarla come
essenzialmente una situazione fortemente predisponente all’insorgere di
disordini comportamentali, o come, ancora peggio, una patologia in sé stessa.
Essi sostengono che questo processo si è fondato su una serie di stereotipi che si
sono sempre più rafforzati, ma non ha avuto un reale supporto scientifico. Hill e
Fortenberry, dunque, affermano che se si riconosce l’adolescenza come una
condizione morbosa, essa non può che essere indicata come una culture-bound
syndrome. I due autori avvalorano la loro tesi sostenendo che la natura culturebound dell’adolescenza, nella società americana, è dimostrata dalla sua
rispondenza ai criteri proposti da Cassidy/Ritenbeugh per classificare una CBS:
«essa ha distintive caratteristiche culturali, con distintive radici storiche nelle
sempre più ridotte stratificazioni d’età del diciannovesimo secolo; la sua eziologia
(la progressiva perdita della fanciullezza e l’acquisizione dello status di adulto)
sintetizza conflitti di conformità e individualismo; e, particolari culture
professionali hanno fornito un ideologia e una tecnologia culturalmente specifiche
per la diagnosi e il trattamento» (Hill – Fortenberry 1992: 74).
L’idea secondo cui l’adolescenza fosse una sindrome culturalmente determinata,
fanno notare gli autori, fu avanzata già da Margaret Mead (1968) agli inizi di
questo secolo. La crescente
diffusione, nel contesto americano, della
designazione dell’adolescenza come una fase particolarmente difficile della vita,
la «storm and stress» (Hall 1904 cit. in Hll – Fortenberry 1992), così veniva
definita; indusse la Mead, intorno al 1920, ad intraprendere un viaggio in
Polinesia, per determinare se le adolescenti samoane soffrivano delle stesse
difficoltà nello sviluppo delle adolescenti americane. Dopo nove mesi di studio in
questa piccola isola, la Mead riscontrò rari casi di stress e ribellione tra le
giovani indigene, il che la spinse ad ipotizzare che i particolari problemi associati
all’adolescenza, non fossero dovuti a questa fase di crescita, ma piuttosto a
come essa si manifestava nella società americana. Studi successivi (Havighurst
– Taba 1949; Elkin – Westly 1955; Bernard 1961; Coleman 1961) hanno
supportato la percezione della Mead secondo cui il contenuto dell’adolescenza
non è invariante e in se stesso determinato, ma, piuttosto, varia a seconda delle
diverse influenze culturali. L’articolo di Hill e Fortenberry si pone in perfetto
accordo con queste ultime conclusioni, asserendo con forza l’idea secondo cui
29
l’adolescenza nella sua accezione patologica, come viene indicata nel contesto
americano, è essenzialmente una culture-bound syndrome occidentale. Essi,
inoltre, ammoniscono circa il rischio connesso con la concettualizzazione
dell’adolescenza quale condizione costituzionalmente patologica. Ridurre, infatti,
i disaggi adolescenziali ad una spiegazione organica o biologica, rischia di
distogliere l’attenzione e l’impegno pubblico da ingenti problematiche sociali. E’
sicuramente più proficuo ricondurre le cause dei disturbi comportamentali, che
insorgono in questa fase dello sviluppo, a situazioni di emarginazione, di
discriminazione razziale, di disagio economico, piuttosto che etichettare
genericamente l’adolescenza come innato fattore di rischio. Pertanto,
probabilmente, più valido sarebbe, per la risoluzione delle problematiche
dell’adolescenza, un serio impegno politicosociale, piuttosto che una passiva
medicalizzazione.
Il discorso condotto all’interno di questo capitolo, è finalizzato a dimostrare che è
lecito utilizzare la nozione di sindrome cultur-bound per indicare una serie di
disturbi che si manifestano anche in Occidente: l’obesità, l’anoressia e i problemi
dell’adolescenza sono stati proposti come alcuni degli esempi possibili. In virtù di
tali considerazioni appare, dunque, estremamente limitativo e tendenziosamente
etnocentrico, da parte della biomedicina occidentale, relegare all’etichetta CBS
esclusivamente il disagio degli altri, i disturbi esotici. Questo atteggiamento
testimonia, da parte della cultura medica dominante, un’estrema difficoltà, una
sorta d’incapacità a porre le altre culture sul suo stesso piano e riconoscersi, non
superiore, ma simile ad esse. In questo senso, il caso dell’anoressia nervosa e
dei disturbi dell’adolescenza può essere considerato emblematico. Sebbene,
infatti, per entrambe si riconosca un influenza socioculturale come fattore
causale della loro insorgenza e della loro diffusione, nel DSM, lo strumento
principale della nosografia psichiatrica occidentale, si è ben lontani da qualsiasi
equiparazione o associazione tra tali disturbi e le culture-bound syndromes
rilevate in contesti non occidentali. Ad un simile atteggiamento sembra sottesa la
convinzione secondo cui il bias culturale, svolgerebbe un lavoro determinante
nell’insorgenza di situazioni patologiche, solo in cotesti extra-occidentali, mentre
in Occidente resterebbe disoccupato o, comunque, ridotto ad un compito molto
più esiguo. Gli Studi sinteticamente analizzati in questo capitolo (sull’obesità,
sull’anoressia, sull’adolescenza) hanno avuto, invece, la finalità di dimostrare che
la cultura ha un ruolo preminente nella genesi e nell’evoluzione di alcuni disturbi
occidentali, e di mettere in evidenza, come sostengono anche Cardamone e
Zorzetto, «il carattere esotico del proteiforme Occidente e la sua non possibilità
di ergersi a principio etico» (1998: 104)
CAPITOLO QUARTO
DEFINIZIONE ED EPIDEMIOLOGIA DEL KORO
Con il termine koro si usa indicare una condizione piuttosto diffusa nel sud-est
dell’Asia, ed in particolare nel sud della Cina, condizione che è caratterizzata da
30
disturbi legati alla retrazione degli organi genitali. I soggetti colpiti dal koro,
sono assaliti dalla terribile
sensazione
che gli organi genitali si stiano
progressivamente retraendo nell’addome, fino a scomparire del tutto. Questa
sensazione è accompagnata da un intenso timore di morte imminente. Casi
isolati di attacchi di koro sono alquanto rari; si pensi che Yap (1965) in 15 anni
di studi ne descrisse solo 19. Sono state riportate, invece, in alcune parti del
mondo, soprattutto in società cinesi, epidemie di koro che hanno investito, per
un breve periodo di tempo, centinaia o miglia di persone (Koro Study Teame
1969; Jilek – Jilek-Aall 1977; Suwanlert – Coats 1979; Chakraborty 1983; Mo
1987; Tseng et al. 1988;). L’origine della parola koro è incerta, si crede però
che essa derivi da alcuni termini malesi: kuru, kerukul, kereoh,
che si
riferiscono alla tartaruga e in particolare alla sua testa (Edwards 1985; Gwee
1968). Nel 1936 Wulfften Palthe sosteneva che il termine esatto sarebbe stato
kura, con il quale ancora oggi in Malesia si indica la tartaruga, egli affermava che
entrambi, malesi e cinesi, usassero la testa della tartaruga come espressione per
alludere al pene. Il fatto che, asseriva Wulfften Plathe, «la tartaruga può ritrarre
la testa con il suo collo retrattile sotto il suo guscio letteralmente dentro il
corpo suggerisce, dunque, il meccanismo cosi tanto temuto nel ‘Koro’ (‘Kura’) e
gli da il suo nome» (1936: 536). La retrazione dei genitali nell’addome sarebbe,
dunque, associata alla retrazione della testa della tartaruga nel guscio.
Attualmente il termine kura o kura-kura in Malesia e Indonesia significa
tartaruga, inoltre in molti stati dell’Asia si usa il riferimento alla testa di questo
rettile per alludere al pene (Sheung-Tak 1996). L’equivalente cinese del koro
(inteso come disturbo) ha due diverse variazioni ortografiche: suo-yang in
Mandarino, e suk-yang in Cantonese. Suo o suk sta per retrarre, restringere,
contrarre, ridurre, accorciare, decrescere, e yang significa pene o genitali
maschili (Werner 1961). In questo capitolo si cercherà di fornire, grazie ad
un’analisi della letteratura mondiale sul koro, un sintetico quadro generale circa
le caratteristiche esteriori di questo disturbo (diffusione, manifestazioni
sintomatologiche, caratteristiche delle vittime, etc.). Tutto ciò al fine di
consentire al lettore che non disponesse di alcuna nozione riguardo a questo
male, di maturare un’idea sommaria, prima di addentrarci nella controversia che
vede il koro conteso tra un riconoscimento quale sindrome essenzialmente
culture-bound, e l’essere ricondotto ad un sintomo invariabile e universale (v.
infra Cap. V).
La difficoltà di
fornire una definizione del
koro nasce dall’assenza di
un’opinione unanime circa le sue caratteristiche. Questo disturbo, infatti, per la
sua esotica natura, crea – discorso che vale per tutti i disturbi esotici, come si è
avuto modo di vedere nella parte precedente di questo lavoro – una spaccatura
tra gli studiosi che ad esso si sono dedicati. Il koro, infatti, si è rivelato
refrattario ai vari tentativi di ricondurlo ad un modello patologico occidentale.
Sono state arrancate diverse ipotesi che, spesso in contraddizione tra loro,
hanno proposto spiegazioni a carattere medico, biologico, psichiatrico,
psicanalitico, che, però, invece di svolgere un ruolo chiarificatore hanno
accresciuto la confusione. A complicare ulteriormente il quadro, già abbastanza
torbido, sono stati – a mio avviso – quei rari resoconti di chi ha indicato come
31
koro, forse perché non ha trovato nei manuali di psichiatria una diagnosi più
appropriata, isolati disturbi anomali con qualche lontana analogia con i sintomi
del koro, individuati magari in paesi dell’Africa, dell’Europa o dell’America.
Estremamente rari sono stati, invece, studi che hanno cercato di cogliere il
significato dell’epidemiche manifestazioni di koro, all’interno del loro ambiente
specifico. Quasi inesistenti sono state, dunque, le indagini finalizzate a
comprendere il drammatico messaggio che dietro le grottesche forme attraverso
cui il koro si palesa, poteva nascondersi; è stata snobbata, quindi, un’analisi
interpretativa volta a cogliere il senso di questo disturbo, una lettura del testo in
relazione al suo specifico contesto (Devereux 1978; Karp 1985).
In virtù di tali premesse, in questo capitolo si è cercato, allo scopo di tracciare un
quadro sintetico del koro, di riportare dati oggettivi sui quali ci fosse un certo
accordo consensuale da parte di diversi studiosi; le varie ipotesi eziologiche e i
diversi tentativi di classificazione, che sono fonte di disaccordi e controversie,
sono stati rimandati al capitolo successivo. Si farà sovente riferimento ai dati
riguardanti l’epidemia di koro verificatasi nel 1984-85 nel sud della Cina perché
è, tra le epidemie note, una delle più recenti, sicuramente quella di più vaste
proporzioni, e tra le meglio studiate.
DIFFUSIONE
Come si è detto, casi singoli di attacco di koro sono piuttosto rari, diversi
resoconti, però, riportano vere e proprie epidemie, in diversi periodi, in varie
zone del sud-est dell’Asia. Mo (1987) sostiene che i registri ufficiali dell’isola di
Hainan, nel Guangdong, Cina meridionale, documentano un’epidemia di koro già
nel tardo 1800. In queste stesse zone, dopo la seconda guerra mondiale, si sono
verificate altre sei epidemie, rispettivamente: nel 1948, 1955, 1966, 1974,
1984-85, 1987 (Sheung-Tak 1996). Circa le prime epidemie che hanno colpito
queste regioni della Cina non ci sono dati precisi, esse piuttosto sono state
ricostruite attraverso i racconti dei vecchi residenti dell’isola di Hainan.
Resoconti di forme epidemiche di koro non riguardano, però, solo la Cina
meridionale, si conosce, infatti, un epidemie di questo male avutasi nel 1969 in
Singapore (Ngui 1969; Koro Study Team1969), più di 1000 persone furono
colpite in Tailandia dopo la guerra del Vietnam (Jilek – Jilek-Aall 1977;
Suwanlert – Coates 1979; ), e un’altra forma epidemica è stata descritta in
India (Chakraborty et al. 1983). L’epidemia di più vaste proporzioni è,
comunque, sicuramente quella che si è avuta nel 1984-85 nelle province del
Guandong. Essa durò quasi un anno colpendo più di 3000 persone in 16 città e
contee. L’epidemia partì da Lingao, un paese nell’isola di Hainan, nel 1984 e si
estese ad altre parti dell’isola. Alcuni mesi più tardi, si ebbero notizie della sua
diffusione nel paese di Haikang, nella penisola di Leizhou, e da qui una nuova
ondata di epidemia partì colpendo in lungo e largo tutta la penisola, arrestandosi
in fine nella città di Zhajiang nella parte più a nord. Quest’epidemia è stata
attentamente studiata da Mo (1987) e Tseng et al. (1988); poiché la penisola di
Leizhou e divisa dall’isola di Hainan solo dal canale di Qiongzhou, questi due
autori hanno trattato i due posti come una sola area di ricerca. Tseng notò che
nonostante l’epidemia si fosse agevolmente diffusa tra queste due zone, essa
32
però non si estese mai ad altre province del Guangdong al di là della penisola di
Leizhou. Queste ultime riflessioni inducono Sheung-Tak (1996) a sollevare,
retoricamente, una serie di quesiti circa il perché le epidemie di koro in Cina si
siano limitate alle regioni della costa meridionale, e perché anche in queste zone
è stata colpita solo una determinata parte della popolazione complessiva. Questi
quesiti, sono le premesse di cui Sheung-Tak si serve per introdurre la sua idea
secondo cui le forme epidemiche di koro, che si sono manifestate nel sud della
Cina, sono state fortemente determinate da specifiche influenze culturali, più
radicate in certe zone e in una certa tipologia di persone. Egli sostiene che
l’insorgenza e la diffusione del koro in questi posti, si basa su particolari valori e
credenze, e che esso è un fenomeno sociale in cui la comunità intera è partecipe
della sua determinazione. Le interessanti argomentazioni
di Sheung-Tak
saranno approfondite in seguito, quando si analizzerà, come già è stato detto, la
controversia circa la natura del koro.
L’ultima epidemia di koro conosciuta e documentata, si è verificata nel 1987
anch’essa nelle province meridionali del Guangdong. In questo caso però la sua
diffusione è stata di gran lunga inferiore rispetto al 1984-85, essa, infatti, ha
colpito circa 300 soggetti nel giro di un paio di mesi (Mo 1987; Tseng et al.
1988; Tseng et al 1992; Sheung-Tak 1996).
Resoconti di singole manifestazioni di koro non sono limitati solo al sud-est
dell’Asia, ci sono, infatti, studi che riportano rari casi di attacchi isolati di koro
anche dalla Tanzania (Lucieer 1984), dalla Nigeria (Ifabumuyi – Rwegellera
1979), dal Canada (Ede 1976), dagli U.S.A. (Scher 1987), dall’Inghilterra
(Barrett 1978), dall’Irlanda (Tobin 1996; Sajjad et al. 1993), dalla Fracia
(Burgeois 1968).
QUADRO CLINICO
Il koro generalmente è considerato come un disturbo tipicamente maschile,
poiché è legato alla retrazione del pene. Tuttavia, sono stati indicati come koro,
anche rari casi di donne che lamentavano un’appiattimento del seno e una
retrazione dei capezzoli e delle labbra vaginali (Chowdury 1994); casi ancora
più rari, in genere ragazze preadolescenti, che lamentavano un restringimento
del naso, delle orecchie o della lingua, anche sono stati considerati come forme
di koro. Questo termine, dunque, quale indicativo di una categoria nosografica, è
stato esteso a qualsiasi disturbo anomalo che si manifestava attraverso il timore
di una retrazione di organi esterni all’interno del corpo ( Tseng et al. 1988).
Nella fase iniziale di un attacco di koro, il soggetto colpito diventa teso, le mani e
i piedi sono freddi, il battito cardiaco aumenta, il viso impallidisce, c’è un’intensa
sudorazione, una vaga ansietà, una perdita di sensibilità alle estremità degli arti.
La crisi vera e propria è caratterizzata da un irrigidimento del corpo, gli occhi si
gonfiano e le pupille sono a malapena visibili, il soggetto emette dei gorgoglii.
In casi estremi sopraggiunge la perdita di coscienza (Edwards 1984).
Sheug-Tak (1996) descrive il manifestarsi del koro come un evento
estremamente drammatico. Solitamente la malattia, ci dice questo autore,
insorge con la sensazione da parte del soggetto colpito che i suoi organi genitali
si stiano retraendo. Convinto che questa condizione sia fatale, la vittima diventa
33
estremamente ansiosa, inizia a fare qualsiasi cosa in suo potere per impedire il
ritrarsi dei genitali e urla vigorosamente invocando aiuto. Possono essere visti,
continua Sheung-Tak, uomini che cercano di tirare il proprio pene o provano a
tenerlo ancorato con pinzette di ferro o legato con pezzi di corda, tutto allo
scopo di prevenire la temuta retrazione. I parenti e i vicini corrono a portare i
loro soccorsi, e intervengono con massaggi o con una vigorosa pressione sul
glande, continuando finché la vittima non smette di urlare dal dolore. Chi è
colpito dal koro ha un forte timore di essere lasciato solo, perché è convinto che
se non è aiutato la morte sopraggiungerà immediatamente. L’assistenza da
parete di individui del sesso opposto è proibita; si pensa, infatti, che se il
soggetto è toccato da donne questo gli potrebbe essere fatale. Ad un osservatore
esterno, fa notare Seung-Tak, il manifestarsi del koro può apparire come una
situazione assurda: si immagini di vedere un uomo che urla invocando aiuto e
allo stesso tempo si tira i genitali esponendoli così in pubblico. Ma, questo
grottesco sintomo, trova consenso nel resto della comunità, che riconosce la
sofferenza della vittima, e condivide la convinzione che essa possa essere fatale.
Il soggetto in preda ad un attacco di koro, riferisce l’autore, appare come un
moribondo, si riscontra pallore, panico, tremori, iperventilazione, palpitazioni,
svenimenti. Egli si sottopone, o è sottoposto da altri, ad una serie di violente
operazioni per evitare che la presunta retrazione abbia luogo, finché, esausto,
l’ansietà diminuisce. Spesso dopo un attacco di koro, riferisce Edwards (1984), ai
soggetti colpiti sono date da bere delle pozioni che hanno la funzione di
rafforzare la virilità. Esse sono composte da: corno di cervo, schegge di bambù,
germogli fioriti di Borassus flabelliformis, steli della Arenga sacchariera. Questi
ingredienti sono polverizzati e miscelati insieme con una bevanda alcolica
derivata da un pastone di riso, per consentire al soggetto di ingerirli più
agevolmente.
COMPLICAZIONI
Le complicazioni che sorgono in relazione al koro non sono dovute al disturbo in
se stesso, ma piuttosto ai medicamenti che il soggetto stesso o altri membri
della sua comunità adottano per arrestare o prevenire la, presunta, retrazione
genitale. Sono frequenti, infatti, danni fisici dovuti ad applicazioni di lozioni
caustiche, trazioni manuali o meccaniche del pene, introduzione di fili metallici
nell’uretra, shock ipotermici dovuti ad immersioni o lavaggi con acqua molto
fredda, vomito indotto dall’ingestione forzata di sale comune (NaCl) (Chowdhury
1991). Contusioni, lacerazioni, perdite di sangue, infezioni, come risultato dei
rimedi adottati dalla vittima o da altri per arrestare gli effetti del koro non sono,
quindi, rare. Si conoscono addirittura casi di soggetti cui si è dovuto asportare il
pene perché era stato legato con una corda in modo così stretto da impedire
l'afflusso sanguigno (Mo 1987). Sono noti pochissimi decessi conseguenti ad
attacchi di koro, e anche per questi rari casi si è concordi nell’attribuire il
sopraggiungere della morte ad altri problemi di salute (es. disturbi cardiaci) o a
medicamenti incauti ed eccessivi (Gwee 1963). In sintesi, dunque, il koro in se
stesso, quale percezione di una retrazione genitale, non provoca alcun tipo di
danno ai tessuti del corpo; complicazioni fisiche, però, possono insorgere come
34
conseguenza dei presidi terapeutico messi in atto dal soggetto stesso o da chi
gli è vicino, per impedire il verificarsi di una condizione che è ritenuta fatale
per chi ne è colpito.
DECORSO
Il koro, generalmente, si manifesta come un attacco acuto ma di breve durata,
esso infatti, solitamente, si risolve tra i 20 e i 60 minuti e la maggioranza delle
vittime non ha altri attacchi dopo il primo episodio. In un campione di soggetti
colpiti dal koro, nella penisola di Leizhou, solo circa il 20% di essi ebbe un
secondo attacco, ed un numero estremamente esiguo ne ebbe più di due (Tseng
et al. 1988). In breve, quindi, l’attacco di koro può essere indicato come acuto,
breve e tendente a non ripetersi. Tuttavia, ci sono resoconti che descrivono di
soggetti che sono stati in preda ai sintomi del koro per anni (Geew 1963;
Oyebode et al. 1986). Recentemente sono stati riportati due casi di persone,
indicate come affette da koro, in cui il disturbo si manifestava: nella prima con
attacchi ricorrenti uno o due volte alla settima per un intero anno (Adityanjee –
Subramaniam 1991), nella seconda con episodi multipli, ricorrenti, stereotipati
due o tre volte al giorno, tre o quattro volte alla settimana per cinque mesi
(Chowdhury – Beta 1995).
CARATTERISTICHE DELLE VITTIME DEL KORO
Una panoramica della letteratura mondiale sul koro mostra che l’età,
rispettivamente più bassa e più alta, dei soggetti colpiti è di 8 e 54 anni
(Chowdury et al. 1988; Chowdury 1996). Un caso particolare riguarda i bambini,
ci sono, infatti, resoconti di epidemie di koro che riguardavano neonati o,
comunque, bambini molto piccoli (4 mesi a 4 anni). Naturalmente, il disturbo
non era manifestato direttamente dal bambino, ma, piuttosto, erano i genitori, in
particolare il padre, in forte apprensione poiché erano convinti che il figlio fosse
stato colpito da questo male (Mun 1968; Rubin1982). Attenti studi condotti nel
paese di Haikang, nella Cina meridionale, su soggetti colpite da epidemie di
koro, hanno fornito una serie di interessanti dettagli sulle caratteristiche delle
vittime di questo disturbo. Su 232 soggetti colpiti oltre l’85% era di sesso
maschile, il 26% era compreso tra i 10 e i 14 anni di età, il 32% tra i 15 e i 19, il
23% tra i 20 e i 24 e il 7% tra i 25 e i 29. Una percentuale piuttosto bassa
riguardava i soggetti che avevano più di 30 anni (9%). Solo il 3% dei casi erano
bambini compresi tra i 6 e i 9 anni (Mo 1987; Tseng et al. 1988). Il 22%
dell’intero campione era sposato. Il 7% delle vittime era analfabeta, il 58%
aveva frequentato la primary school, il 29% la junior high, e solo il 6% la senior
high. In uno studio ulteriore Tseng et al. (1992) studiarono le caratteristiche
delle vittime del koro somministrando ai soggetti che ne erano stati colpiti, e a
due gruppi di controllo reclutati nell’area epidemica, vari questionari self-report.
Il gruppo delle vittime del koro era costituito da 214 persone (173 maschi, 29
femmine) che erano state colpite dalle epidemie del 1984-85 e del 1987. I due
gruppi di controllo erano costituiti uno da 56 pazienti psichiatrici (27maschi, 29
femmine), a cui erano stati diagnosticati disturbi ansiosi o altre nevrosi, e l’altro
gruppo era composto da 153 soggetti normali ( 127 maschi, 26 femmine) che
35
non avevano mai avuto disturbi psichiatrici o attacchi di koro. I questionari che
furono somministrati erano: (a) la versione Guangzhou del Symptoms Checklist;
(b) il Sixteen Personality Factor Test (16PF)9; (c) un Life Problems Questionnaire
che determina l’esistenza di vari problemi psicologici, sociali e di salute, incluso
problemi riguardo al sesso e al matrimonio; e (d) un Folk Belief Questionnaire
che conteneva domande relative a credenze sul sesso (es., lo sperma dovrebbe
essere conservato e il rapporto sessuale dovrebbe essere controllato in modo da
proteggere la salute), sul koro (es., gli organi sessuali possono retrarsi
nell’addome e causare la morte), e in forze soprannaturali (es., le forze
soprannaturali sono potenti). I risultati delle vittime del koro al Symptoms
Checklist erano in nessun modo simili a quelli dei pazienti nevrotici. Mentre,
comparato con il gruppo di controllo, il gruppo clinico mostrava livelli più alti a
quasi tutte le sottoscale (depressione, ansietà, nevrastenia, ira/ostilità,
ossessione-compulsiva, ipocondria, sensibilità interpersonale), il gruppo del koro
riportò risultati appena elevati nella sottoscala dell’ansietà. Tuttavia, però, la loro
ansietà era di molto inferiore rispetto al gruppo clinico. Il 16PF rivelò notevoli
differenze tra il gruppo del koro e quello di controllo solo per il fattore
dell’intelligenza, dove, il gruppo del koro aveva punteggi più bassi di quelli del
gruppo di controllo. Il gruppo clinico si differenziò dagli altri due gruppi su una
serie di fattori: essi erano più tesi, sagaci, e intelligenti, meno sottomessi, calmi,
timidi, e pratici. I risultati del 16PF e del Symptoms Checklist, suggerirono che
le vittime del koro e le persone sane erano simili rispetto ai profili di personalità
e sintomi, e che entrambi differivano dai pazienti nevrotici. Attraverso il Life
Problemes Questionnaire non fu rilevato nessun problema in particolare tra le
vittime del koro, neppure problemi sessuali o relativi al matrimonio. In fine, i
risultati ottenuti dal Folk Belief Questionnaire non mostravano significative
differenza tra i tre gruppi circa credenze relative al sesso, ma le vittime del koro
ottennero punteggi significativamente più alti sulle credenze relative al koro e a
forze soprannaturali. Questo studio, dunque, ha dimostrato che i soggetti colpiti
dal koro non presentano alcuna similarità con i pazienti nevrotici, essi appaiono
del tutto simili alle persone psichicamente sane; inoltre, non presentano alcun
problema specifico a carattere sessuale o matrimoniale. La caratteristica che
9
È uno degli strumenti più noti per la valutazione delle caratteristiche “normali”
della personalità. Il questionario considera 16 “tratti” che nel loro insieme
dovrebbero descrivere la “sfera di personalità umana totale”. Il 16PF articola la
valutazione in 16 scale, identificate con una lettera dell’alfabeto ed elencate in ordine
decrescente di “rilevanza” statistica dei fattori, con riferimento alla percentuale di
varianza spiegata da ciascuno. Quasi tutti i tratti sono “bipolari”, cioè rappresentano
una caratteristica definita da due poli opposti tra loro. Un punteggio inferiore alla
media (da 1 a 5 sten) rappresenta il polo “negativo”, un punteggio superiore alla
media (da 6 a 10 sten) rappresenta il polo “positivo”. Gli items sono una decina per
ogni scala, seguiti da tre alternative di cui una, intermedia fra due sintomatiche, è
indicativa per lo più di incertezza (Boncori 1993: 658).
36
fondamentalmente li distingue, sembra essere il riconoscere il koro quale entità
morbosa e credere nell’esistenza di forze soprannaturali. In sintesi, la tipica
vittima del koro che sembra emergere da questa sezione è un individuo di sesso
maschile, giovane, di età compresa tra i 10 e i 24 anni, e di basso livello
socioculturale.
RIFERIMENTI FAMILIARI
Alcuni studi sul koro si sono occupati della sua diffusione all’interno di una
stessa famiglia, senza rilevare, però, alcun risultato in particolare.
Due casi di koro all’interno della stessa famiglia furono riportati, durante
l’epidemia verificatasi in Singapore, da Ngui (1969). Altri due studi, che si
occuparono dell’epidemia in India, notarono alcune relazioni familiari. Chowdhury
(1989) trovò 21 casi in 9 famiglie con un differente legame di parentela, cioè:
fratello-fratello; fratello-sorella; padre-figlio; padre-figlia; e marito-moglie.
Anche Sachdev (1985) riportò 4 casi di koro che avevano avuto altri familiari
colpiti da questo disturbo. Nessuna particolare relazione però, come si è detto, è
stata riscontrata tra l’insorgenza del koro e specifiche connessioni familiari.
Nel corso del tempo, in ambito medico-psichiatrico, ha prevalso la tendenza a
ricondurre il koro a disturbi organici o psichici già noti in occidente, ovvero a
categorie mediche universali, a psicopatologie ad eziologia nota. In questo lavoro
invece, in particolare nel prossimo capitolo, si intende sottolineare i limiti e le
contraddizioni di un simile approccio, che ha operato un’eccessiva riduzione e
semplificazione di questo fenomeno, ostacolando la possibilità di comprendere
l’evento koro nella sua interezza. Qui si intende appunto porre l’accento sulla
necessità di prendere in considerazione gli aspetti sociali, le influenze culturali, i
valori e le credenze popolari, le strutture mitiche e simboliche e il modo in cui
tutti questi elementi si combinano, per cercare di comprendere il senso, il
significato intimo che il complesso fenomeno koro, assume all’interno del suo
specifico contesto socioculturale.
CAPITOLO QUINTO
IL KORO, UNA CULTURE-BOUND SYNDROME O UN SINTOMO UNIVERSALE? UNA
QUESTIONE IRRISOLTA
Il caso del koro rappresenta un difficile problema di definizione nosologica per la
psichiatria, da più di un secolo. La difficoltà nasce dalla inadeguatezza delle
varie categorie diagnostiche occidentali, nel
definire e classificare una
condizione con specifiche caratteristiche culturali. Il koro, infatti, si è rivelato
ostile all’essere passivamente ricondotto al catalogo nosografico occidentale.
I primi resoconti di retrazione del pene, indicata come koro, furono riportati
dalle colonie olandesi in Indonesia, da diversi psichiatri: Blonk (1895), Brero
(1896), Vorstman (1897). Il fatto che essi scrivevano in giornali olandesi e
tedeschi spiegherebbe, secondo Jilek (1985), la relativamente poca familiarità di
studiosi anglosassoni con questi articoli. Il dizionario buginese (Celebes
37
meridionale: isola dell’Indonesia) di Matthes del 1874, contiene il
primo
riferimento noto al termine “koro”, inteso come «to shrink» (restringere,
ritirare), e l’espressione “lasa koro” indica «un ritirarsi del pene, una sorta di
malattia che non è insolita tra i nativi e deve essere molto pericolosa» (Wulfften
Palthe 1936: 536). Brero nel 1897, già cercò di definire in termini nosologici la
convinzione, diffusa nel sud della Celebes, che in seguito ad un attacco di koro, il
pene potesse retrarsi nella cavità addominale, e che ciò causerebbe
inevitabilmente la morte. Egli giunse alla conclusione che si trattava di un’idea
ossessiva-compulsiva, condivisa da molte persone nella Celebes meridionale,
dovuta ad uno scarso sviluppo delle facoltà critiche in coloro che egli indicò come
«half civilized people». Il koro, poi, per un certo periodo cadde nell’oblio, fino
alla sua riscoperta negli anni ’30, furono pubblicati, infatti, in questo periodo,
una serie di articoli che ripresero ad occuparsi di questo disturbo (Slot 1935,
Mulder 1935, Wulfften Palthe 1935, 1936, 1937). Ciò che emerge fin dai primi
resoconti sul koro, da parte di psichiatri europei, è una fortissima esigenza di
ricondurre questo “strano male” a categorie medico-psichiatriche occidentali.
Sebbene fosse indiscutibile una specificità culturale del koro, il problema
principale, avvertito da questi primi studiosi, fu quello di spiegare questa esotica
affezione, comparandola con disturbi psicopatologici noti in occidente. Kraepelin
(1921), infatti, prontamente affermò che una sintomatologia simile a quella
rilevata per il koro, poteva essere riscontrata nello stato di allucinazione
ipocondriaca di pazienti tedeschi maniaco-depressivi. L’affrettata comparazione,
tra patologie occidentali e esotiche manifestazioni, proposta da Kraepelin, è
importante perché rivela un atteggiamento fondamentale dell’approccio medicopsichiatrico, nei riguardi di eventi patologici. Il fenomeno morboso, in questa
prospettiva, è visto come un’entità autonoma che racchiude in se stessa tutti i
significati essenziali. Esso è estirpato dal suo contesto di origine, dalla rete di
significati culturali ad esso connesso, per essere classificato, diagnosticato,
etichettato. La valenza semantica che la manifestazione patologica, o presunta
tale, assume nell’ambiente in cui prende forma e si palesa, è completamente
marginalizzata. Un simile atteggiamento è evidente, dunque, nelle formulazioni
di Kraepelin in riferimento al koro, questo noto psichiatra tedesco, infatti, prima
ancora di osservare, si accinge a comparare, diagnosticare. È evidente, dunque,
una volontà di oscurare le differenze per affermare un universale modello
patologico. Riconoscere la difficoltà o l’impossibilità di definire attraverso il
paradigma nosologico occidentale i disturbi esotici, sarebbe stato un duro colpo
all’autorità psichiatrica, avrebbe rappresentato, inoltre, una tacita ammissione,
da parte degli adepti di questa disciplina, dei suoi limiti, e stroncato le loro
pretese universalistiche. Lo studio del koro, dunque, fin dall’inizio, è stato
improntato alla ricerca di caratteristiche che lo accomunassero a patologie
occidentali ad eziologia nota. Le differenze e particolarità socioculturali, sono
state ampiamente trascurate e misconosciute. Inoltre, nei casi in cui è stato
posto l’accento sulle peculiarità dei popoli studiati, questo, spesso, è stato fatto
con tono discriminatorio e svalutativo. Un esempio lampante di un simile
atteggiamento, è evidente nelle formulazioni di Brero (1897), uno dei pionieri
nello studio del koro. Questo studioso, infatti, dopo aver ricondotto i casi di koro
38
rilevati nella Celebes meridionale
ad un analogo disturbo occidentale, non
indugiò nel attribuire la sua relativa diffusione tra la popolazione autoctona, ad
una loro carenza, una deficienza, una forma di arretratezza e inferiorità.
Il problema della definizione e classificazione del koro, assunse particolare
importanza durante gli anni ’60-’70. Furono proposte, per definire il koro e altri
disturbi esotici,
varie etichette: «psychogenic psycosis» (Faergeman 1963),
«hysterical psychosis» (Langness 1967), «exsotic psychosis» (Yap 1969). Le
diverse nomenclature, che dovevano avere la funzione di stabilire la nosologia di
queste manifestazioni morbose, in realtà, acuirono ulteriormente lo stato di
confusione. Sin dal 1951, Yap aveva provato a fornire un coerente schema
classificatorio per il koro e altri disturbi tipici del sud-est dell’Asia. Egli analizzò
durante un periodo di oltre 15 anni, ad Hong-Kong, 19 casi di koro, e definì
questo disturbo come una «atypical culture-bound syndrome». Lo psichiatra
cinese, si impegnò anche nel tentativo di fornire una classificazione delle
«atypical culture-bound syndrome», e posizionò il koro nella categoria delle
«sindromi emozionali, con stati di depersonalizzazione». Per facilitarne la
concettualizzazione occidentale, Yap collocò il koro anche all’interno della
categoria di «culturally imposed nosophobia», definendolo come uno stato di
depersonalizzazione associato con elevata ansietà, indotta da paure irrealistiche,
e lo inserì all’interno della più vasta categoria delle psicosi reattive. Oltre a Yap,
negli anni ’60, diversi altri autori proposero definizioni per il koro: Gwee (1963)
lo indicò come un’acuta isterica reazione di panico, provocata da auto o etero
suggestioni e condizionamenti dovute al background culturale; Rin (1965) lo
definì come una paura di castrazione in associazione con deprivazione orale;
Ngui (1969) come un disturbo psicogeno culture-bound. Nelle formulazioni di
questi autori, come si vede, è posto l’accento sulla caratteristica culturale, che
agisce nella determinazione di questo disturbo. Tuttavia, però, il limite che
accomuna questi studiosi, è che sebbene essi
riconoscano una specifica
influenza culturale nell’insorgenza del koro, restano vincolati alla dicotomia
patogenico/patoplastico. Infatti, ai fattori culturali è attribuito un ruolo nella
strutturazione dell’aspetto esteriore della manifestazione morbosa, la quale però
è ricondotta ad un sostrato universale invariante (patogenico). Essi, quindi, non
differiscono sostanzialmente dai loro colleghi olandesi che, quasi un secolo
prima, verso la fine del 1800, fornirono le prime descrizioni sul koro. Infatti,
come questi, avvertono l’esigenza di ricondurre il disturbo esotico al modello
medico-psichiatrico occidentale, minimizzando l’importanza delle differenze che
le manifestazioni patologiche presentano nei diversi contesti, ed esaltando invece
le somiglianze. Per cui, se pure mutano le categorie nosografiche a cui il koro è
ricondotto, non cambia fondamentalmente l’approccio teorico ed epistemologico
a questo disturbo. Le innovazioni teoriche apportate, sembrano essere, dunque,
più formali che sostanziali (Ciminelli 1997). Si presuppone che alla base di
questo fenomeno vi sia un processo bio-psicologico invariante, e che esso sia
modellato patoplasticamente da distinti sistemi di credenza, collegati alla
malattia e al disordine. Alle specifiche influenze culturali, dunque, è attribuito il
ruolo di dar forma alle caratteristiche esteriori del disturbo, il quale, secondo
questi autori, è legato e generato da un processo
universale. Inoltre, la
39
convinzione più diffusa tra i vari studiosi che si sono occupati del koro, o di altri
disturbi esotici, è stata, come fa notare Signorini (1988), che si trattasse
essenzialmente di fenomeni patologici, non di sindromi clinicamente distinte,
però, ma le stesse già note alla nostra nosologia, tuttavia conformate e orientate
ciascuna in modo differente dalle singole culture, che verrebbero, così, a dar loro
quell’aspetto esotico che le contraddistingue. «In quanto alterazioni del
comportamento, e riconosciute come costituenti una sindrome
sono state
trattate in chiave solo psichiatrica così che culture-bound syndrome (o meglio,
secondo la definizione di Yap, culture-bound reactive syndrome) ha avuto subito
l’implicito significato di culture-bound psychiatric syndrome» (Signorini 1988:
28). L’idea secondo cui,
potesse trattarsi di manifestazioni intimamente
connesse alla complessa struttura culturale, di ciascuna comunità in cui esse
apparivano, è stata ampiamente misconosciuta. Quasi del tutto ignorata, è stata
la prospettiva che attribuisse a questi disturbi una valenza sociale, che li
considerasse, in qualche modo, funzionali per l’adattamento e la sopravvivenza
dell’intera società, che li vedesse all’interno della specifica e intricata rete di
significati, che si dispiega in ciascuna cultura.
Nella spiegazioni del processo che determina l’insorgenza e il decorso del koro,
è stato, sovente, riconosciuto un ruolo essenziale ai meccanismi psicoanalitici.
L’idea freudiana del complesso di castrazione, come caratteristica universale
dello sviluppo psichico, fu prontamente utilizzata da molti studiosi.
Nel 1936
Wulfften Palthe, dopo l’analisi di alcuni casi di koro in soggetti cinesi,
concludeva: «Noi
abbiamo, qui davanti, pertanto, un chiaro esempio del
complesso di castrazione di Freud» (1936 : 535). Più tardi, Yap sostenne (1969,
1974) che il fenomeno del koro, poteva essere riscontrato in società patriarcali,
che consideravano con particolare enfasi l’importanza della potenza sessuale
maschile. Partendo da queste premesse, lo psichiatra cinese, descrisse il koro
come una forma culturalmente orientata, dell’universale complesso di Edipo e
dell’angoscia di castrazione descritti da Freud. È stata frequente nella letteratura
psichiatrica (Kobler 1948; Rin 1965; Wittkower 1969; Yap 1969) l’idea che il
koro, interpretato come esempio non occidentale dell’angoscia di castrazione,
confermasse l’universalità delle teorie freudiane. Quest’interpretazione – a mio
avviso – rivela un ragionamento perverso, non solo, infatti, si riconduce,
acriticamente, un fenomeno (koro) che si manifesta in culture ‘altre’ ad un
modello
interpretativo
occidentale
(complesso
di
Edipo),
ma
poi,
paradossalmente, ci si serve di quello stesso fenomeno per dimostrare la validità
transculturale e, quindi, l’universalità del proprio modello. L’idea dell’universalità
del complesso di Edipo, è stata aspramente criticata dall’antropologia. È stato
messo in dubbio il principio secondo cui la spiegazione di certi comportamenti,
mediante le dinamiche edipiche,
potesse essere valida per ogni cultura.
«Ovunque e sempre si a che fare con lo stesso triangolo Padre-Madre-Figlio
(Ego)? Oppure il sistema freudiano offre una spiegazione relativa alla sola
cultura occidentale?» (Kilani 1996 : 117), questi sono i principali quesiti che sono
stati mossi. La prima critica all’universalità del complesso di Edipo è venuta nel
1927 da Malinowski (1969), che ha messo in rilievo la relatività delle culture.
L’esempio delle isole Trobriand dell’arcipelago corallino della Nuova Guinea
40
orientale, dove Malinowski compì le sue ricerche sul campo, mostrava
l’impossibilità del complesso edipico in una cultura che ignora la paternità
biologica, ed in cui l’autorità del padre biologico è sostituita da quella dello zio
materno. Nella polemica introdotta dall’antropologo polacco10, «tutto ruota
intorno ai diversi caratteri che presenta una società organizzata intorno al
principio della discendenza matrilinea e che inoltre non riconosce il ruolo del
padre nel processo riproduttivo. Spostando i sentimenti ambivalenti del figlio dal
padre allo zio materno, feroce matriarca, e centrando i tabù sessuali più sulle
sorelle che sulla madre, la società delle Trobriand, ci dice Malinowski, mette in
crisi il punto centrale dell’impianto freudiano: la pretesa universalità del
complesso di Edipo» (Schirripa 1996: 209). Tuttavia, le formulazioni di
Malinowski non sono esenti da critiche, anche esse, infatti, presentano una serie
di vizi etnocentrici (idem 211).
La critica più convincente alle spiegazioni
psicoanalitiche
freudiane, è venuta dall’antropologia strutturale. Lévi-Strauss
(1969), il suo fondatore, ha mostrato che occorre superare l’antinomia fra natura
e cultura, per porre il problema della proibizione dell’incesto in termini di regole
o di leggi. Nei sui lavori sulle strutture elementari della parentela ha sottolineato
che ciò che è importante non è tanto il contenuto biologico di una relazione (nel
caso particolare, madre-figlio, padre-figlio), quanto le obbligazioni che ne sono
all’origine, e che derivano dalla proibizione. La proibizione dell’incesto, sostiene
Lévi-Strauss, non ha un contenuto biologico o psichico universale, ma costituisce
una regola sociale universale fondata sul principio di interdire certe categorie e
prescriverne altre. Essa è, più in generale, una regola nel senso che costituisce il
principio di organizzazione in società, fondato sullo scambio e sulla reciprocità fra
gruppi che donano e gruppi che ricevono (Kilani 1996). Le istanze critiche verso
l’universalità delle teorie psicoanalitiche freudiane, e in particolare le dinamiche
del complesso di Edipo, sono state, in tempi recenti, ribadite con forza da
Obeyesekere (1990) e da Nathan (1993). Questi due autori, hanno sottolineato
quanto possa essere impropria l’utilizzazione di concetti psicoanalitici classici
nelle società tradizionali, o con pazienti di altre culture, se non si sia provveduto,
preliminarmente, ad una loro traduzione nel particolare universo di relazioni
parentali e simboliche proprie di quest’ultime. Nel tentativo di esportare le
formulazioni psicoanalitiche sul complesso edipico, insistono i due autori, non è
possibile trascurare l’orizzonte mitico, simbolico e sociale di altre culture.
Nonostante tutto, però, come si è visto per il caso del koro, l’ingenua e
presuntuosa convinzione dell’universalità del proprio metodo, ha spinto numerosi
studiosi ad una interpretazione psicoanalitica di fenomeni esotici, senza
preoccuparsi di appurare se tali strumenti fossero adeguati a cogliere quanto
accadeva in altre culture, se i concetti chiave della psicoanalisi potevano
funzionare per individui in cui relazioni parentali, forme di trasmissione del
sapere e della soggettività, codici della legge e dell’autorità erano radicalmente
diversi. Ritornando all’analisi dei modelli occidentali di concettualizzazione del
koro, che si sono alternati nel tempo, è opportuno rilevare che un momento di
Per un approfondimento del dibattito aperto da Malininowski si veda l’attenta
ricostruzione fatta da Schirripa (1996)
10
41
particolare ambiguità nella definizione nosologica di questo disturbo, si è avuto
tra gli anni ’70-’80. Nel 1970 Edwards pubblicò un resoconto con il titolo di
«Koro-pattern of depersonalization» che trattava di un caso di koro in un
paziente americano; negli anni ’80 furono pubblicati una serie di resoconti che
riportavano sporadici casi di koro, spesso associati con altri disturbi psichiatrici o
abuso di droghe, da differenti nazioni occidentali (Gran Bretagna, Francia,
U.S.A., Canada) e dall’Africa (Nigeria, Tanzania) (Chowdhury 1996). Alla base di
questi resoconti di, presunti, casi di koro, c’era un medesimo intento, quello,
cioè, di confutare l’idea secondo cui questo disturbo fosse legato ad una
specificità culturale. I vari studi che riportavano sporadici episodi di disturbi
classificati come koro o koro-like, da contesti lontani da quello tipico di questa
affezione (sud-est asiatico), implicitamente volevano affermare il suo essere un
sintomo universale, riscontrabile ovunque. Invece di incrementare un’analisi del
koro volta a comprendere questo disturbo nel suo ambiente naturale, ad
acquisire elementi che consentissero una lettura e una
comprensione del
drammatico significato che questa manifestazione assume nel suo specifico
contesto, ancora una volta sono prevalse delle azzardate comparazioni,
finalizzate ad una riduttiva generalizzazione. Si legge, dunque, in questi
resoconti una bramosa volontà di ricondurre il koro a patologie note, di cui si
conosce l’eziologia, la patogenesi, la terapia. Prevale la volontà di collocarlo in
una precisa categoria psichiatrica, imprigionarlo in una nicchia, imponendogli
un’etichetta che, però, non sembra mai essere realmente appropriata ed
esauriente. Ecco quindi che gli psichiatri si impegnano a cercare – o forse quasi
ad inventare – anche in occidente, isolati casi di disturbi che immediatamente si
apprestano a definire come koro
o, peggio ancora, koro-like. Tutto ciò,
probabilmente, allo scopo di dimostrare l’universalità di questo sintomo, di
ricondurlo, quindi, a questo puto lecitamente, al proprio modello psicopatologico
interpretativo, riaffermando così, la loro autorità professionale. È sorprendente il
fatto che talvolta, come esempi di primi casi di sporadici attacchi di koro in
occidente, vengano riportati i resoconti di due autori (Ivanov 1885 in Russia e
Raven 1886 in Inghilterrra), che sono addirittura precedenti alle informazioni
fornite dai primi pionieri olandesi che rilevarono la diffusione di questo disturbo
nel sud-est dell’Asia. Naturalmente, Ivanov e Raven non fanno alcun riferimento
al termine koro, visto che esso non era ancora noto, ma parlano di un’insolita
condizione il cui sintomo fondamentale è rappresentato da una sorta di
restringimento del pene. Raven scrive:
[…], un uomo sano, serio, scapolo, di ventisette anni, una notte subito
dopo essere andato a letto sentì una sensazione di freddo nella regione del
pene. Egli si agitò
nello scoprire che
l’organo, uno normalmente
sviluppato, si stava rapidamente restringendo, ed era, egli pensava,
definitivamente ritirato. Egli immediatamente diede l’allarme, e Io fui
rapidamente convocato per curarlo. Lo trovai molto nervoso e allarmato. Il
pene era quasi scomparso, il glande era appena percepibile sotto l’arco
pubico. Era visibile solo la pelle del pene, e appariva simile a quando
l’organo è sepolto in un idrocele, o, in un estremo esempio, come essa
appare dopo la morte per annegamento. Io lo rassicurai, e gli diedi
42
dell’ammoniaca, e riscontrai il giorno dopo che tutto era ritornato al suo
stato naturale. Ma egli continuò a sentirsi debole e nervoso per alcuni
giorni. Egli non fu in grado di dare nessuna spiegazione dell’accaduto, e la
innaturale condizione non si verificò mai più.(1886: 250, cit. in Edwards
1984: 15).
Il caso di retrazione genitale descritto, invece, da Ivanov (1885) riguardava un
contadino russo di 23 anni che aveva una moglie e una famiglia. La descrizione è
del tutto simile a quella offerta da Raven (Edwards 1984). L’associazione di
questi insoliti disturbi con il koro orientale, è avvenuta successivamente alla
scoperta di quest’ultimo. In modo del tutto discutibile, infatti, dopo le descrizioni
del koro riportate dal sud-est dell’Asia, si è superficialmente comparato questo
disturbo con quelli descritti da Ivanov e Raven rispettivamente in Russia e in
Inghilterra. La, presunta, similarità sintomatologica
è stata ampiamente
esaltata, mentre le profonde differenze sono state completamente oscurate. I
rari casi di retrazione genitale occidentale rilevati sia da Raven e Ivanov sia,
in tempi più recenti, da diversi studiosi (Barrett 1978; Burgeois 1968; Ede 1976
; Sajjad et al. 1993; Scher 1987; Tobin 1996), in alcuni stati europei o
americani, a cui indebitamente – ritengo – è stata attribuita l’etichetta di koro,
presentano, infatti, delle fondamentali divergenze
con le epidemiche
manifestazioni di questo disturbo che si sono verificate nel sud-est dell’Asia e in
particolare nel sud della Cina, differenze che non possono essere assolutamente
trascurate. La retrazione genitale che lamentano, in rari casi, pazienti
occidentali, può essere considerata semplicemente come un sintomo che fa parte
di un più ampio quadro patologico. Esso, infatti, il più delle volte è associato
con una preesistente situazione psicopatologica (depressione, schizofrenia ecc.)
o con abuso di sostanze tossiche (droghe, alcol ecc.), e si dissolve con la
risoluzione della condizione patologica primaria (Berrios – Morley 1984; Chadda
– Shome 1991; Favezza 1985; Mo 1992). Cosa completamente differente è
quella che riguarda
le vittime del koro sud-est asiatiche, essi, infatti,
normalmente non sono né pazienti psichiatrici né tossicodipendenti, e la loro
condizione difficilmente può essere compresa al di fuori del contesto
socioculturale in cui essi sono inseriti. Un elemento essenziale di un tipico
attacco di koro, inoltre, è l’angosciosa convinzione che questa condizione sia
fatale, che essa preannunci il sopraggiungere della morta. È questa convinzione
che fa precipitare le vittime in uno stato di terrore, che le porta ad adoperarsi in
tutti i modi per impedire questa situazione, che le spinge ad invocare
disperatamente aiuto. In nessuno degli isolati
casi di retrazione genitale
riscontrati in occidente, era presente una simile convinzione. Ma l’essenziale
differenza tra il koro orientale, e i fenomeni di retrazione peniena occidentali,
consiste nel fatto che il primo può essere sicuramente definito come un
“evento sociale”, mentre, i secondi, sono rari, indefiniti, disturbi isolati. Il koro,
infatti, nelle forme in cui si manifesta nei contesti del sud-est dell’Asia, è un
fenomeno che coinvolge l’intera comunità: tutti conoscono, condividono e
partecipano al dolore e ai timori delle vittime. La famiglia, il vicinato accorrono a
portare soccorsi al soggetto colpito dal male, si adoperano in tutti i modi
possibili per arrestare questa condizione, di cui anch’essi condividono la
43
convinzione che possa essere fatale. Il koro, dunque, per l’intera comunità
rappresenta un fenomeno morboso che ha una sua storia, è una condizione
reale, nota, verso la quale bisogna adottare degli specifici rimedi terapeutici
(massaggi e trazioni del pene per evitarne la retrazione, somministrazioni di
specifiche pozioni, bagni con acqua fredda, ecc.), e assolutamente evitarne altri
(i soggetti di sesso opposto non devono toccare la vittima, ciò gli causerebbe la
morte, ecc.). L’idea del koro è radicata quindi nelle comunità in cui si palesa, non
è un fenomeno oscuro e sconosciuto ma, piuttosto, appartiene all’insieme di
miti, di credenze, di simboli, di significati che costituiscono la specificità culturale
di ogni comunità umana. Le manifestazioni di
koro
potrebbero essere
considerate – a mio avviso – come una rappresentazioni sociale di un’antica
partitura, in cui tutti conoscono bene il proprio ruolo, e non disdegnano di fare
la loro parte. Cosa completamente diversa è l’insolito sintomo riscontrato in
qualche isolato paziente occidentale, le cause che lo determina, organiche o
psicogene che siano, sono del tutto individuali11. Nonostante queste differenze
siano evidenti e innegabili, la comparazione tra questi due fenomeni, però, è
stata tutt’altro che rara in ambito medico-psichiatrico. Essa, anzi, è stata
sovente addotta come argomentazione da coloro che si sforzano nel dimostrare
l’universalità di questo male.
Negli ultimi anni sono stati frequenti i tentativi di definire e classificare il koro,
riconducendolo ai modelli diagnostici e interpretativi propri della psichiatria
occidentale. Nel 1984 Edwards si pose l’intento di sfatare definitivamente l’idea
secondo cui le cause d’insorgenza del koro fossero culturalmente determinate, e
sottolineare, invece, il ruolo di fattori organici o fisiologici nell’eziologia di questo
male. Egli ritenne molto più appropriato indicare questo disturbo come «genital
retraction syndrome» ponendo così l’accento sull’aspetto puramente
sintomatologico, trascurando, invece, gli elementi
tipicamente culturali, e
definendo, quindi, questa affezione
quale un sintomo fondamentalmente
universale. Edwards formulò
una triplice classificazione: vera retrazione
fisiologica; panico di retrazione genitale come reazione a reali o immaginari
insulti ambientali; e somatizzazione culturalmente modellata. Egli suggerì che il
termine
koro poteva essere utilizzato per indicare questo disturbo
specificatamente nel contesto in cui questo termine è in uso, ma che comunque
esso andava ricondotto alla più vasta categoria delle «retrazioni genitali», in
quanto espressione di un sintomo, sia pur raro, invariante ovunque.
Un altro noto tentativo di definizione e classificazione del koro, e delle altre
culture-bound syndromes, fu effettuato da Ronald C. Simons (1985). Egli, come
si è avuto già modo di vedere (v. infra p. 33), propose uno schema tassonomico
in cui classificò le CBS in taxa. I taxa, nel modello di Simons, si basano sulla
comparazione cross-culturale delle similarità che si ricavano da una descrizione
accurata dei micro-dettagli comportamentali: questi ultimi costituiscono, infatti,
secondo Simons, i tratti descrittivi della sindrome, ovvero «la sua forma» (33).
Quest’autore raggruppa le CBS in base al sintomo più riconoscibile al di là delle
11
Di particolare interesse è la distinzione fatta da Devereux(1978) tra «disturbi
etnici» e «disturbi idiosincratici»
44
denominazioni e significati che tali sindromi assumono nei vari contesti culturali:
il sintomo prescelto risponde allo scopo di identificare un eventuale fattore
neuro-fisiologico comune. Simons, dunque, si propone sostanzialmente di
evidenziare il ruolo svolto dalla biologia nel dar forma alle manifestazioni delle
culture-bound syndromes. Nel suo schema tassonomico il koro è collocato
all’interno della categoria indicata come
«genital retaction taxon», che
raggruppa tutti quei casi che presentano, come caratteristica comune, «elevata
ansietà associata con la percezione che i genitali si stiano retraendo nel corpo»
(151). Simons era convinto che questo taxon era idoneo a classificare entrambi i
casi di koro, cioè sia quello del sud-est dell’Asia (con una forte specificità
culturale) sia quello occidentale (associato con panico o condizioni organiche).
Questo psichiatra, quindi, è incline a pensare che il koro – come del reste tutte le
altre CBS – collima con una nosologia psichiatrica universale e assume una
forma inusuale a causa di condizionamenti culturali localmente differenti.
La posizione di Simons è stata duramente criticata dall’antropologo Michael
Kenny (1988) il quale lo accusa di un eccessivo riduzionismo, e contesta l’idea
di un riflesso neuro-fisiologico comune che – a suo avviso – se mai fosse
dimostrato, non avrebbe, comunque, nessuna reale valenza esplicativa. Per ciò
che riguarda specificamente il genital retraction taxon, Kenny sostiene che esso
si fondi su di una confusione concettuale. Ciò che la letteratura etnografica
descrive, sostiene questo autore, è il timor panico che il pene si stia ritirando nel
corpo, non che esso si stia effettivamente verificando. Queste paure, sostiene
Kenny, potrebbero essere ben spiegate attraverso l’analisi della loro matrice
culturale, piuttosto che addurre una spiegazione neuro-fisologica, in virtù anche
al fatto che non si conoscono resoconti medici ben documentati che riportino
anomalie nel comportamento del pene. Kenny afferma che è impossibile
condurre un’analisi del koro senza tenere conto delle idee circa la virilità (nel
contesto in cui si manifesta), l’ambiente sociologico in cui gli episodi di koro si
sviluppano, le caratteristiche idiosincratiche che fanno si che sia una determinata
persona piuttosto che un’altra ad ammalarsi di koro, e in fine se pure ci fossero
degli elementi biologici a influenzare questa condizione o perfino a determinarla
completamente, comunque essa potrebbe essere culturalmente modellata.
Kenny, dunque, ritiene impossibile nell’analisi del koro, e naturalmente di tutte le
altre CBS, trascurare i fattori sociali e culturali, ma, piuttosto, considera
indispensabile assegnargli il peso che essi chiaramente meritano. La posizione di
Simons è rappresentativa del perdurare di un atteggiamento costante da parte
della psichiatria occidentale nei confronti di esotiche manifestazioni “morbose”,
cioè la volontà, o quasi un’ansiosa necessità, di ricondurle a universali fattori
biologici. Nello stesso volume in cui Simons presenta il suo modello tassonomico
per le CBS, Charles C.Hughes, l’altro curatore del libro insieme a Simons,
propone un tentativo di inserimento del koro, e delle altre culture-bound
syndromes, all’interno del DSM-III. Egli discute le diverse possibilità di
associazione dei sintomi del koro con i vari assi diagnostici, suggerendo come
potenzialmente appropriati quelli indicati come: «conversion disorder», «panic
disorder» o «atypical somatoform disorder» (Simones & Hughes 1985: 193). La
classificazione proposta da Hughes contempla la situazione in cui la retrazione
45
genitale è la sola primaria affezione del paziente, ma non considera i casi in cui
essa possa
essere secondaria a qualche altra diagnosi psichiatrica
(Chowdhury1996). Anche W.G. Jilek (1985), uno studioso che si occupò per
molto tempo dei disturbi tipici del sud-est dell’Asia, propose una definizione del
koro. Egli si pose polemicamente nei confronti della prospettiva che spiegava le
manifestazioni di koro esaltando esclusivamente l’aspetto legato alla sessualità,
interpretandole quindi come espressione dell’ansia di castrazione. Quest’autore,
infatti, condivide le critiche all’idea dell’universalità del complesso edipico. Egli
inoltre afferma la necessità di distinguere le manifestazioni epidemiche di koro
del sud-est dell’Asia, dai casi isolati di disturbi associati con preesistenti
condizioni psicotiche, nevrotiche o di abuso di sostanze tossiche, che sono stati
rilevati in alcune società occidentali ed etichettati come koro-like. Jilek, ritiene
che ciò che distingue i pazienti occidentali da quelli asiatici è, soprattutto, il fatto
che nel loro caso si tratta di una convinzione ‘autistica’ non condivisa dal resto
della comunità. L’autore conclude affermando che nel tentativo di spiegare
l’eziologia e l’epidemiologia del koro, non ritiene valido né un modello basato
sull’ansia da castrazione edipica, né uno che proponga una interpretazione nei
termini di una patogenicità culturalmente specifica. Egli sostiene, piuttosto, che
il koro sia il frutto di una distorta percezione dell’immagine corporea; e se si
vuole rintracciare un denominatore comune nelle popolazioni colpite
dall’esplosione di questa condizione, esso va ricercato nell’esperienza di una
minaccia alla loro sopravvivenza socioeconomica, etnica, culturale e biologica.
In questi contesti, sostiene Jilek, l’individuo che manifesta i sintomi del koro
risponde alla paura collettiva di uno sterminio da parte di un ben definito
nemico (un’altra popolazione ostile), che è percepito come pericoloso per la
sopravvivenza del proprio gruppo etnico, poiché ne minaccia la capacità
procreativa. Sebbene la prospettiva tracciata da Jilek sia suggestiva e originale,
essa però resta piuttosto oscura in diversi punti. Rifiutando l’idea di una
specifica influenza culturale nella determinazione delle manifestazione di koro,
non è chiaro, se pure si accetti la sua complessa spiegazione socio-politica,
perché la paura
collettiva di un attacco alla capacità procreativa, e quindi
all’esistenza del gruppo etnico, di cui lui parla, assuma quelle specifiche forme,
trovi espressione in una sorta di ritualità, si fondi su particolari credenze, miti,
simboli, sia inserita in una complessa rete di significati. In relazione alla
spiegazione di Jilek, dunque, ritengo che al di là della sua ipotesi eziologica, che
necessita, comunque, di una più approfondita indagine, tralasciando l’analisi
della
specificità culturale
dei contesti in cui
esplodono epidemiche
manifestazioni di koro, lascia irrisolti una serie di interrogativi: perché colpisce
alcune persone e non altre? Perché si espande in alcune zone e non in altre?
Perché sono cosi radicate certe convinzioni, prescritti certi particolari
comportamenti, adottati specifici presidi preventivi e terapeutici? Nonostante i
limiti del suo approccio, va riconosciuto a Jilek il merito di aver proposto una
prospettiva che contrasta l’egemonia delle spiegazioni psichiatriche classiche,
che si ostinano ad imprigionare complesse manifestazioni, quali il koro, in sterili
categorie nosologiche, che le inquadrano solo in una limitata ottica patologica,
che si sforzano di trovare un universale elemento biologico a cui finalmente
46
poterle ricondurre. Jilek introduce, invece, l’idea che il manifestarsi di questo
disturbo possa avere un qualche significato sociale, che esso possa essere inteso
come un messaggi, un segno, una spia che esprime uno stato di malessere
condiviso dall’intera comunità.
Devan e Ong (1987) tentarono di incorporare i recenti resoconti di koro in
associazione con altri disturbi psichiatrici ed organici, all’interno di una
semplificato schema classificatorio, nel modo seguente: koro classico (con forte
copertura culturale); koro innestato su primari soggiacenti disordini psichiatrici;
e koro come sintomo di malattie mentali.
Bernstain e Gaw (1990) fecero un’approfondita analisi della sintomatologia del
koro, e proposero una classificazione in tono con la filosofia del DSM-IIIR. Essi
asserirono che il tratto cardine del koro non era l’ansietà, ma la retrazione
genitale e la conseguente paura di morte. Panico e ansietà, invariabilmente
conseguono quando gli individui iniziano a temere che si verificheranno
alterazioni permanenti o, peggio, la morte. Pertanto essi, affermarono che da un
punto di vista descrittivo, un disturbo da retrazione genitale rappresenta «un
sintomo fisico che suggerisce un disturbo organico per il quale non ci sono
risultati organici dimostrabili e che è presunto essere psicogeno all’origine»
(1673).
Sebbene, sostennero gli autori, il koro è simile alla categoria di
«somatoform disorder» del DSM-IIIR, la sua particolare forma non collima con
nessuna delle sue sottocategorie, pertanto, essi proposero una nuova
sottocategoria indicata come
«genital retraction disorder», allo scopo di
consentire anche l’identificazione delle manifestazioni di koro culturalmente
specifiche. Essi proposero uno schema per l’inclusione del koro nel DSM-IV; i
criteri diagnosti, da essi stabiliti, per l’idividuazione e la classificazione di questo
disturbo sono riportati nella tabella I.
Bernstain e Gaw, suggerirono che per una completa classificazione del koro è
necessario prendere in considerazione 3 punti fondamentali: 1) se la retrazione
genitale è un disturbo psichiatrico primario o è causato da altre affezioni, 2) se
esso si verifica in uno specifico contesto culturale, e 3) se il disturbo si presenta
in una forma individuale o in un contesto epidemico.
TABELLA I
Criteri diagnostici del koro per il DSM-IV proposti da Bernstein e Gaw
(1990)
A. Un opprimente senso di panico associato con la sensazione o la credenza di
una retrazione genitale.
B. Una paura di morte
retrarre.
imminente, i genitali si potrebbero completamente
C. Una tendenza a prevenire la retrazione tenendo fermo il pene, chiedendo
aiuto in questo anche agli amici e ai parenti, o applicando aggeggi al pene.
47
D. Un comportamento che non è evidentemente strano o bizzarro, fatta
eccezione per la credenza e le sue ramificazioni.
E. Una assenza di confluenza con qualsiasi disturbo dell’asse I diverso dal
somatoform disorder, e dove
non si può stabilire un fattore organico
predisponente e mantenente il disturbo.
Specificare il tipo:
Se in un contesto culturale o non in un contesto culturale.
Se un caso singolo o uno epidemico.
Si deve, essi sostenevano, differenziare i casi di koro culturalmente specifici,
dalle situazioni koro-like. Inoltre, una persona sotto l’influsso della credenza
popolare sul koro non deve essere considerata psicotica, a meno che le funzioni
del suo ego non siano gravemente danneggiate. La presenza di una credenza
popolare nel koro o altre credenze condivise, è il fattore chiave per la
comprensione di questo fenomeno e per spiegare la genesi e la perpetuazione
delle forme epidemiche di koro. È questa relazione con le tendenze culturali
che rendono questo disturbo caratteristico, e la
sua rappresentazione
drammatica. Per dare chiarezza e adeguata considerazione a questi fattori
culturali, sostenevano gli autori, il concetto di disturbo culturalmente specifico
doveva essere inserito nel DSM-IV, dato che questa categoria era chiaramente
assente. La proposta di Bernstein e Gew è rimasta, però, tale, poiché nel DSMIV non fu inserita nessuna nuova categoria né per il koro né per altre CBS. Il
DSM è uno strumento classificatore legata alla cultura occidentale o, più
precisamente, è basato sulle concettualizzazioni psichiatriche della scienza
medica occidentale. Si rivela pertanto un difficile problema collocare le CBS nelle
nicchie di questa classificazione. A tale proposito considero molto appropriate le
osservazioni di Tsung-yi Lin, che condivido a pieno. Egli afferma:
La moderna psichiatria è nata in Occidente, e durante la sua crescita è stata
modellata da specifiche tradizioni filosofiche e scientifiche occidentali, essa si
è sviluppata come un figlio della cultura occidentale. Considerando, poi, la
prevalenza dell’etnocentrismo e l’infondata presunzione dell’universalità clinica
nella moderna psichiatria, non è difficile comprendere perché fenomeni
psichiatrici non familiari o folcloriche pratiche di guarigione dirette a disturbi
mentali in culture non occidentali sono considerate come strane, primitive,
prive di interesse, o perfino inferiori. Semplicemente essi sono considerati
come fenomeni e pratiche isolate dalla totalità del contesto culturale che gli
da forma e serve a definire il loro reale significato (1982: 235 ).
Questa lunga citazione pone l’accento sulla natura degli strumenti, dei modelli,
delle interpretazioni cliniche proprie della psichiatria occidentale, ci induce a
riflettere sul come esse – nonostante anelino ad una sorta di universale
oggettività – siano intimamente legate alla cultura occidentale. Gli studi, dunque,
che si occupano di definire e classificare nosologicamente particolari disturbi
48
esotici, sono a loro volta culturalmente condizionati e orientati. I fatti, i dati che
vengono osservati, riportati non sono semplicemente individuati, scoperti, ma
piuttosto essi sono retoricamente costruiti, adattati, corretti, e talvolta,
grossolanamente fraintesi. I fenomeni oggetto di osservazione spesso sono
decontestualizzati, isolati dalla intricata rete di significati locali che ad essi
sempre è connessa, oscurando il reale messaggio che
essi vogliono rivelare,
deprivandoli della loro essenziale valenza semantica. La psichiatria occidentale
manifesta le sue tentazioni egemoniche quando, sovente, disprezza i successi
clinici conseguiti dalle terapie tradizionali praticate in culture “altre”. Questi
successi devono essere minimizzati, trascurati, negati perché contestano, con
la loro stessa esistenza, la superiorità universale di cui si sentono portatori i
clinici occidentali. Un’analisi di tutte le precedenti postulazioni riguardanti la
definizione e classificazione del koro, mostra una notevole discrepanza nella
concettualizzazione di questo disturbo. Le numerose etichette che sono state
proposte (atypical psychosis, atypical somatoform disorder, panic disorder,
sexual disorder not otherwise specified, genital retraction panic disorder,
depersonalization disorder, conversion reaction ecc.) hanno creato un profondo
stato di confusione, rendendo estremamente difficile individuare precisamente la
natura, le caratteristiche, le cause alla base di questa complesso fenomeno.
Ciascuno ha presentato la propria definizione
come la definitiva, l’unica
veramente valida, contestando e criticando le proposte degli altri studiosi. In
questa ottusa disputa, però, quasi tutti sono stati d’accordo nel considerare
questa manifestazione come un fenomeno patologico, riconducibile e spiegabile
attraverso gli strumenti nosologici e i modelli diagnostici della psichiatria
occidentale. Il koro, però, si è rivelato refrattario, ribelle all’essere interpretato,
semplificato, imprigionato in una precisa nicchia nosografica, il che ha richiesto
agli psichiatri occidentali un continuo lavoro di revisione, riformulazione delle loro
teorie, senza mai raggiungere un accordo unanime, senza mai trovare, nel
catalogo delle patologie note, una valida categoria medico-psichiatrica che
riuscisse adeguatamente a incorporare e spiegare il koro nella totalità dei sui
aspetti. Come più volte è stato detto, estremamente rara è stata un’analisi
finalizzata a cogliere il significato che l’evento koro assume nel contesto in cui si
manifesta, come esso appare dal punto di vista dei nativi, quali sono le
specifiche
influenze
culturali
che
predispongono
e
determinano,
successivamente, l’insorgenza e la diffusione di questo drammatico disturbo,
come la comunità si pone e partecipa al verificarsi di questo evento. A questi
interrogativi ha cercato di dar risposta Sheung-Tak Cheng (1996), il quale ha
condotto un’analisi volta a mettere in evidenza i fattori socioculturali che non
sono mai stati sufficientemente presi in considerazione dalle precedenti
formulazioni. Sheung-Tak analizzando il koro nell’ambiente naturale in cui esso
si manifesta, attacca la nozione secondo cui questa condizione sarebbe una
psicopatologia individuale. Egli, piuttosto, sostiene che, almeno nei modi in cui si
manifesta in Cina, questo fenomeno non può che essere considerato come un
male sociale, sostenuto da fattori culturali, che colpisce l’intera comunità e non
solo quelli che presentano i sintomi del koro. I più dettagliati resoconti circa
forme epidemiche di koro, sono stati riportati dall’isola di Hainan e dalla penisola
49
di Leizhou che per la loro vicinanza sono state considerate come un’unica area.
Tseng et al.(1988) notarono che le
epidemie di koro, nonostante si
estendessero a zone vicine, non si diffusero mai
ad altre province del
Guangdong al di là della penisola di Leizhou. Partendo da questa osservazione,
Sheung-Tak solleva una serie di interrogativi: perché le epidemie di koro sono
limitate alle regioni della
costa meridionali? Quali fattori potrebbero aver
causato o facilitato la diffusione di questo disturbo in quella zona? Anche se il
koro è relativamente prevalente in quest’area, non tutta la popolazione ne soffre.
Le vittime del koro, condividono qualche caratteristica comune che le differenzia
dal resto della popolazione e li rende più vulnerabili nei confronti di questo male?
Ci sono dei valori e delle credenze sposati particolarmente dalla popolazione
della costa meridionale che la predispone a subire l’esperienza del koro, e
consentono di
ascrive
significati culturali al comportamento? Sheug-Tak
sostiene che, solo identificando un fenomeno culturalmente specifico come il
koro all’interno dell’ambiente in cui esso appare, e analizzando l’ambiente nella
sua totalità, possiamo veramente comprendere la natura di questo enigmatico
fenomeno. Solo integrando insieme una vasta serie di informazioni ( l’area
dell’epidemia, il modo in cui essa si è diffusa, le persone che ne sono state
colpite, la natura degli attacchi di koro, i sintomi manifestati, il modo in cui essa
è stata trattata dalla popolazione locale, gli atteggiamenti e le credenze popolari
della comunità nei confronti del koro), possiamo sviluppare una differente, e più
profonda, comprensione di questa condizione. L’autore ritiene che, sia molto
interessante il fatto che le notizie di un’epidemia di koro in un’isola vicina,
inneschino una nuova ondata epidemica. Egli sostiene che le dicerie, generano
un’aspettativa nella comunità, che ne influenza il comportamento. Sheung-Tak è
convinto che qualsiasi formulazione, che si occupi dell’epidemica diffusione del
koro, non possa ignorare il ruolo della collettiva anticipazione della minaccia.
Questo studioso, inoltre, protesta nei confronti della posizione che vede nel koro
un tipo di disturbo da panico. Egli sostiene, che questa associazione è stata
piuttosto frettolosa, e non ha considerato altri importanti aspetti di questa
affezione. Infatti, nel caso del koro, l’attacco di panico, normalmente, sparisce
nel giro di 20-60 minuti e, nella maggioranza delle vittime, non si verificano
ulteriori attacchi dopo il primo episodio. Poiché, una delle caratteristiche
distintive di un disturbo da panico, è rappresentata da ricorrenti attacchi di
panico, per la quasi totalità delle persone colpite dal koro, appare molto in
dubbio che si tratti di una analoga forma di disturbo. Le forme in cui il koro si
manifesta, il comportamento delle vittime, il processo di salvataggio dell’organo
genitale che essi mettono in atto, può apparire, fa notare l’autore, estremamente
assurdo ad un osservatore esterno, e perfino ad un cinese. Tuttavia, il fatto che
parenti, amici, vicini accorrono premurosi ad aiutare e soccorrere il soggetto,
per impedire la retrazione genitale, fa pensare che il koro non è qualche cosa
che sperimenta solo la vittima, ma che c’è una realtà sociale definita da
significati culturali assegnati al fenomeno koro, cosi che quelli che vivono
insieme nella comunità condividono analoghe aspettative. Infatti, ci dice SheungTak, capita spesso che molti dei cosiddetti “pazienti”, sono indicati come affetti
da koro, non perché essi ne manifestano i sintomi, ma perché altre persone che
50
gli stanno intorno, hanno mal interpretato i segni di disagio come tipici del
koro, e immediatamente messo in atto misure terapeutiche. Un esempio di
questo tipo, è evidente nei casi di koro che colpiscono bambini molto piccoli, in
queste situazioni, infatti, non sono le piccole vittime a lamentarne i sintomi ma,
piuttosto, sono genitori iperapprensivi, in forte allarme perché convinti che
questo male abbia colpito i propri figli. Alcuni soggetti, dunque, sono designati
come vittime del koro, e i loro genitali sottoposti ad operazioni di soccorso,
contro il loro volere. Il koro, afferma Sheung-Tak, almeno nel modo in cui è
esperito dalla popolazione del sud della Cina, non può essere considerato come
la conseguenza di una soggettiva distorta immagine corporea, come si verifica
nei pazienti con disturbi di depersonalizzazione – altra ipotesi dominante in
questo campo ( Mo 1987; Yap 1965). C’è infatti, egli spiega, un processo sociale
che rinforza la credenza nel koro della vittima, e virtualmente
di ogni persona
della comunità. Quasi tutte le vittime, riportavano una vivida sensazione che i
loro organi genitali si stavano ritirando. Sostiene Sheung-Tak, che non potrebbe
essere diversamente: la vittima crede nel koro, tutti coloro che gli stanno intorno
sono spaventati per la sua condizione, tutti raccontano la stessa storia e
partecipano nel portare soccorsi. Se c’è un disturbo, afferma l’autore, esso è un
disturbo di massa; le emozioni individuali delle vittime, non possono essere
separate dall’atmosfera circostante.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle vittime del koro, le ricerche condotte
nel paese di Haikang (penisola di Lizhou) hanno fornito interessanti informazioni.
Tutte le 232 vittime colpite in questo paese erano di etnia Han, il gruppo etnico
dominante in questa regione
e in tutto il resto della Cina. La più alta
percentuale di soggetti colpiti, era compresa tra i 15-19 anni di età, un numero
molto esiguo di vittime aveva dai trent’anni in su: solo il 9%. Solo il 22%
dell’intero campione considerato era sposato, una piccola proporzione degli
adolescenti colpiti frequentava la scuola, il livello medio d’istruzione era molto
basso. Inoltre, dai test che furono somministrati (Symptoms Checklist, Sixteen
Personality Factor Test, Life Problemes Questionnaire, Folk Belief Questionnaire),
emerse che le vittime del koro non presentavano alcuna analogia con pazienti
nevrotrici; avevano un punteggio più basso rispetto al gruppo di controllo per il
fattore dell’intelligenza, dato che rafforzava la scoperta che le vittime del koro
erano poco istruite; ottennero punteggi significativamente più alti agli items che
rivelavano la credenza nel koro, e in forze soprannaturali. In sintesi, dalle
indagini condotte, il profilo della
tipica vittima del koro che emergeva, era
quello di un soggetto di sesso maschile, di etnia Han, giovane, single,
scarsamente istruito, e con una forte credenza e timore in forze soprannaturali, e
nel koro (Mo 1987; Tseng et al. 1988). Vari autori si sono rifatti ad alcune
credenze connesse al sesso, diffuse tra la popolazione cinese, per spiegare il
verificarsi del koro. Questi autori (Gwee 1963; Tseng et al. 1988; Wen – Wang
1981), hanno costantemente fatto riferimento alla credenza culturale cinese
relativa al controllo sessuale. Più specificamente, una prospettiva originatasi con
il Taoismo, che ha fortemente influenzato il pensiero medico cinese, afferma che
la frequente eiaculazione, inclusa l’emissione notturna, è dannosa per
l’organismo. Lo sperma è considerato l’energia vitale maschile, e dovrebbe
51
essere trattato con cura. L’esaurimento del seme condurrebbe alla morte.
L’uomo è incoraggiato ad avere rapporti sessuali con la propria partner, ma non
ad eiaculare, eccetto nel momento in cui la donna ha più probabilità di essere
feconda, poiché l’eaiculazione, provocherebbe la riduzione dell’energia vitale. Il
coito dovrebbe essere sostenuto per più tempo possibile senza eiaculare, poiché
in questo modo si incrementerebbe l’energia dell’uomo (yang)
attraverso
l’assorbimento dell’energia femminile (yin). Allo stesso tempo, lo yin della donna
sarebbe rafforzato dall’amplesso, e di ciò ne beneficerebbe ulteriormente lo yang
maschile. Molti cinesi sono influenzati, a differenti gradi, da queste idee. Benché
siano state associate con l’esperienza del koro, non è stato spiegato in che
modo esse possano indurre un attacco, o creare una disposizione psicologica nei
confronti di questo disturbo. L’idea della morte causata dal completo
esaurimento del seme, sostiene Sheung-Tak, somigli in qualche modo all’idea
della morte causata dalla completa scomparsa degli organi genitali, ma il loro
presunto collegamento, è puramente speculativo. Anche se in alcune vittime del
koro, è stata rinvenuta l’idea del controllo sessuale, essa, però, non è stata
confermata da altri (Gwee 1963; Tseng et al. 1988). Sheung-Tak, rivolge
l’attenzione al fatto che le persone colpite dal koro, credono in forze
soprannaturali, e sono convinte che il koro realmente esista, e che loro ne
possano essere colpiti. Tutte le 232 vittime esaminate ad Hikang, avevano una
conoscenza del koro precedente all’attacco di questo male. Nel folclore cinese,
riferisce l’autore, si attribuisce ad un fox spirit la capacità di trasformarsi in una
bella donna, occasionalmente anche in un uomo, per sedurre e manipolare le
persone, e per impossessarsi della loro energia vitale. Il fox spirit è molto
potente, è capace di rendere le persone deboli, cosi come fisicamente e
sessualmente forti. È descritto, afferma Sheung-Tak, in un famoso libro di
storie di fantasmi, Strange Tales of Liao-Chai, che esso può provocare il
restringimento di tessuti umani. Sheung-Tak, in base ad una serie di
informazioni raccolte, avanza un’ipotesi molto interessante. Mo (1987) e Tseng
et al. (1988), rilevarono che le 232 vittime del koro di Haikang, erano tutte
appartenenti al gruppo etnico degli Han, nessuno apparteneva ai Li o ai Miao che
sono gruppi minoritari in Cina, e nell’isola di Hainan vivono sulle montagne. A
differenza degli altri gruppi etnici, nei cinesi Han è molto popolare la credenza
nel fox spirit, questo potrebbe fornire, secondo Sheung-Tak, una possibile
spiegazione del perché l’epidemia di koro si sia rapidamente estesa ad altre
zone costiere dell’isola di Hanan, ma non ha mai colpito le aree di montagna,
dove vivono i Li e i Miao.
Tseng et al. (1992) confrontarono la credenza
popolare delle vittime del koro, con quella di 100 persone del Guangzhou, una
città del Guangdong non colpita dall’epidemia, e trovarono che il campione di
Guangzhou era molto meno convinto dell’influenza di forze soprannaturali, e
della reale esistenza del koro. Guangzhou è una metropoli, mentre Hainan è in
larga misura una zona rurale (nel 1984 l’80% della popolazione era costituita da
contadini). Il basso livello d’istruzione delle vittime del koro, sostiene SheungTak, potrebbe essere un fattore legato alla maggiore ricettività di questi
soggetti nei confronti delle credenze popolari che, a loro volta, li rendono più
vulnerabili rispetto all’insorgenza del koro.
52
Dato che la comunità è convinta, riferisce lo studioso cinese, che la vittima del
koro è posseduta da un fox spirit che è venuto per rubare l’energia vitale del
soggetto, i trattamenti tipici risultano essere una combinazione tra esorcismo e
pratiche mediche. Sono frequenti preghiere rivolte a idoli, associate con
richieste a sacerdoti Taoisti di eseguire esorcismi. Quando si sospetta che un
soggetto abbia il koro, le persone che gli sono vicine, spesso, fanno forti rumori
o scuotono la vittima per fare in modo che il fox spirit scappi via, oltre ad
impegnarsi nel tentativo di salvare gli organi genitali. Saranno somministrate,
inoltre, delle pozioni, prescritte dalla medicina cinese, che hanno la funzione di
accrescere lo yang. Un numero estremamente esiguo di vittime, ricercano un
trattamento psichiatrico per risolvere la loro condizione.
Sheung-Tak nella sua analisi, cerca anche di delineare quelli che potrebbero
essere i fattori scatenanti nello scoppio di un’epidemia di koro. In accordo con
Mo (1987), l’autore riferisce che prima dell’esplosione della vasta epidemia del
1984-85, nelle province del
Guangdong, un indovino, preannunciò che la
seconda metà del 1984 sarebbe stato un anno disastroso, in cui in cui il suoyang
(nome cinese del koro), sarebbe stato molto diffuso ad Hainan. Poiché la
popolazione era scarsamente istruita e temeva l’azione di forze soprannaturali,
sostiene Sheung-Tak, fu fortemente influenzata da questa previsione. I primi
pochi casi di koro si manifestarono nell’agosto del 1984 – da quel momento in
poi la diffusione del
fox spirit ebbe inizio. Le notizie di casi di koro
intensificarono l’ansietà collettiva. Come si è detto, non è raro che alcune
persone fossero erroneamente identificate da altri come vittime del koro e,
contro il loro volere, sottoposte a trattamenti preventivi, questo dimostra lo
stato apprensivo e ipervigilante della comunità. Sfortunatamente, afferma
l’autore, quando la popolazione va a caccia del fox spirit, non c’è nessun segno
oggettivo che provi la sua presenza, o la sua assenza, ad eccezione della
comparsa di un attacco di koro in un membro della comunità. Poiché è quasi
impossibile tollerare una così elevata tensione, per un lungo periodo di tempo,
Sheung-Tak ritiene che sia lecito affermare, che una volta che la caccia ha inizio,
la “vittimizzazione” è inevitabile. Solo individuando o designando, infatti, alcuni
membri di una o più comunità quali vittime del
koro, si allevia l’ansietà
collettiva. Il senso di terrore, dunque, creato dall’anticipazione della presenza
dello spettro, sarebbe addirittura più difficile da sostenere se esso non si
manifestasse mai, piuttosto che, se esso si palesa (Jahoda 1969). L’epidemia
generalmente colpisce un paese o una città per pochi giorni e, poi, si sposta in
un altro posto. Questo modello di trasmissione, sostiene Sheug-Tak, potrebbe
essere compreso considerando – ancora una volta – i miti culturali. Poiché,
argomenta lo studioso cinese, nessuno
subisce una totale retrazione dei
genitali, la comunità ritiene che il fox spirit ha sostanzialmente fallito nella
realizzazione del suo malvagio fine e, per tanto, ci si aspetta che esso attaccherà
un’altra zona, per perseguire il suo tentativo. Dato che l’attacco di koro è acuto e
di breve durata, questo dimostra – secondo la prospettiva popolare – che
l’esorcismo è stato efficace. Nel momento in cui giunge notizia di un caso di koro
in un paese vicino, questo rappresenta, per la comunità, la prova che il fox
spirit veramente si è spostato. Il villaggio in cui il male ha avuto origine, ne è,
53
dunque, alleviato, e “l’infezione da koro” ha inizio nella nuova località. L’ultimo
degli interrogativi a cui Sheung-Tak cerca di dar risposta, nella sua accurata
analisi, riguarda il perché cosi tante vittime del koro sono adolescenti, o giovani
adulti non sposati. Dato che l’adolescenza è un periodo di maturazione sessuale,
afferma l’autore, i drastici cambiamenti fisiologici potrebbero generare una serie
di domande, per le quali l’adolescente ha bisogno di spiegazioni. Però, egli
sostiene, c’è in Cina una tendenza culturale ad evitare di parlare di questioni
sessuali. Come conseguenza della mancanza di un’educazione formale, gli
adolescenti delle zone rurali della Cina, sono particolarmente tendenti a ricevere
ambigue e inesatte informazioni sessuali. Ad aggravare la situazione,
contribuiscono la presenza di credenze popolari legate al sesso, soprattutto
quando queste sono radicate nell’ambiente (es., l’enfasi sulle forze
soprannaturali). Fondamentalmente, qualsiasi informazione riguardo al sesso,
avrebbe un grande impatto su questi adolescenti. I dubbi e le perplessità circa il
sesso, si dissiperebbero, però, con l’esperienza del matrimonio, e per tale
motivo, secondo Sheung-Tak, solo un numero limitato di soggetti, tra le vittime
del koro, è sposato. Un dato interessante, connesso con questo discorso, fa
notare lo studioso cinese, è che i rapporti sessuali prematrimoniali sono, al
contrario delle società Han, approvati nelle società Li e Miao (Deng 1992; Ma
1990; Wu 1991). Sostiene Sheung-Tak
che l’oppressione sessuale tra le
popolazioni Han, suggerisce il perché esse siano maggiormente esposte al koro,
l’atteggiamento liberale dei Li e Miao nei confronti del sesso, invece, suggerisce il
perché essi ne siano, in un certo senso, immuni. L’autore conclude, dunque, che
la credenze in forze soprannaturali, e l’oppressione sessuale, predispongono
all’insorgenza del koro, però, esse non sono sufficienti a causare un’esplosione di
questo male, a meno che non ci sia un’assai diffusa aspettativa, che il koro stia
per abbattersi sulla comunità. Sheung-Tak è convinto – convinzione da me
pienamente condivisa – che è impossibile comprendere il fenomeno koro, al di
fuori del contesto
sociale e culturale in cui appare. Una diagnosi basata
esclusivamente sulle manifestazioni sintomatologiche delle vittime di questo
disturbo, è grossolanamente inadeguata e destinata a fallire. L’essere maschi,
scarsamente istruiti, single, privi di corrette informazioni sessuali, e fortemente
influenzati dalla credenza nel koro, sono tutti fattori di rischio per l’insorgenza di
questa condizione. È futile e specioso considerare il koro
nei termini di una
psicopatologia individuale, poiché i maggiori fattori di rischio non sono presenti
nell’individuo, ma nella comunità. Per questa ragione, il tentativo di inserire il
koro in classiche categorie diagnostiche, può – come si è visto – solo creare
confusione. Sebbene, epidemie di koro sono state rilevate anche a Singapore, in
Malesia, in Tailandia, e in India, questo non prova certo – come in alcuni casi è
stato sostenuto – che il koro non sia, fondamentalmente, un fenomeno
culturalmente determinato. Naturalmente le influenze culturali varieranno nelle
diverse località, saranno specifiche per ciascuna società, ma è indispensabile che
esse siano seriamente indagate se si vuole raggiungere un sufficiente livello di
comprensione di una condizione che, altrimenti, apparirà sempre oscura e
indecifrabile. Si propugna, dunque, un approccio olistico, che cerchi di
interpretare il fenomeno koro nella totalità dei suoi aspetti, all’interno del
54
contesto in cui si origina e assume significato, piuttosto che perdersi in
definizioni e generalizzazioni ingenue, e senza forza.
CAPITOLO SESTO
CONCLUSIONI CRITICHE
L’analisi del fenomeno koro, nonché della nozione di sindrome culturalmente
determinata in generale, ha rivelato uno stato di
ambiguità, confusione,
disaccordo. La contrapposizione tra i diversi approcci teorici ed epistemologici,
che non hanno saputo confluire e sovrapporsi, arroccati nella difesa dei loro
saperi, della loro autorità professionale, timorosi di perdere la loro specificità, ha
reso torbida e oscura la comprensione di quei fenomeni esotici diffusamente
indicati come culture-bound syndromes. Una massa di fatti, di dati sono stati
accumulati, ma essi sono ancora in attesa di una corretta interpretazione. Ad
una recente conferenza, Good (1999) ha sottolineato in riferimento all’amok –
una delle più note e studiate CBS – una situazione che è – ritengo –
emblematica di tutte le culture-bound syndromes. L’antropologo americano ha
acutamente evidenziato come questa condizione sia stata manipolata, sfruttata
secondo le esigenze (politiche, ideologiche) di chi l’ha descritta. Prima la
psichiatria coloniale, poi la stampa di regime si sono servite del fenomeno amok
come strumento per perseguire i propri opportunistici fini, offuscando,
imbavagliando il reale messaggio che esso conteneva. La perentoria definizione
di questo fenomeno in termini di disturbo mentale, ha rappresentato una
comoda categoria per estreme strumentalizzazioni. L’amok, e le altre esotiche
manifestazioni hanno rivestito il ruolo di contenitori, che ciascuno (psichiatri
coloniali, dittature politiche ecc.) ha riempito di impropri e utilitaristici significati.
Ciò che ha accomunato queste indebite, e spudoratamente parziali,
interpretazioni è stata la connotazione negativa e svalutativa con cui questi
fenomeni sono stati “marchiati”. Essi, infatti, sovente, con fare discriminatorio,
sono stati apostrofati come la prova evidente del sottosviluppo, l’inferiorità di
individui o
popoli primitivi. Good, richiama l’attenzione sulla difficoltà di
pervenire al reale senso di queste drammatiche esotiche manifestazioni, senza
perdersi in una selva di fraintendimenti. Egli è convinto – convinzione da me
pienamente condivisa – che la valenza semantica delle culture-bound
syndromes, non sia accessibile attraverso le definizioni e le classificazioni della
nosografia psichiatrica occidentale. Il tentativo di cogliere il messaggio che dietro
la manifestazione eclatante si cela, non può fare a meno di considerare il
complesso intreccio degli elementi storici, politici, sociali, culturali, mitici e
simbolici che inevitabilmente determinano questo tipo di fenomeni. È necessario,
dunque, inquadrare questi eventi all’interno del loro ambiente naturale. È
indispensabile rintracciare la relazione tra questi fenomeni e il contesto in cui si
palesano, il rapporto che intercorre tra testo e contesto. Il drammatico senso
che ogni CBS contiene, continuerà a sottrarsi e a mantenersi imprendibile, nei
55
confronti di un sapere che tenta di comprenderlo, quantificandolo e fissandolo
nell’osservazione. Il pensiero medico-psichiatrico, appare imbrigliato nell’idea
che la conoscenza della malattia è vera e reale solo se oggettivabile, verificabile
e definibile. Il modo soggettivo di vivere la malattia, i legami che questa
presenta con il mondo di cui il soggetto fa parte ed è espressione, non possono
interferire in questa operazione. Ciò che è la malattia non deve dunque
interferire con ciò che la si fa diventare. La storia del cosiddetto paziente, è
un’altra storia, appartiene a un’altra vita, non ha niente a che fare con la storia
clinica che è solo la storia di una malattia (Basaglia 1978). La
triste
conseguenza di tutto ciò, sottolineata con forza critica da Frigessi Castelnuovo
& Risso (1982), risulta essere:
[…] la separazione definitiva tra soggetto che studia e oggetto che viene
osservato: la conseguenza, la meta è una verità fissa che coagula il
divenire storico e le sue dinamiche in definizioni di carattere tecnico. Viene
obliterata in tal modo la possibilità di esprimersi con un linguaggio
alternativo: l’espressione di un bisogno – di un desiderio profondo – sarà
una mancanza, una distorsione rispetto ad un ideale che i medici
chiameranno salute ma non sarà che la norma.[…] Il male appare quindi
rivestito dall’involucro interpretativo che il sapere ne dà. Ciò che appare, al
tempo stesso copre, giustifica; e infine tutto si limita nel campo circoscritto
da uno sguardo che, prima di vedere e denunciare, fissa e osserva,
diagnostica e «cura» (1982: 38-39).
Nella ricerca transculturale è in agguato il rischio di incorrere in grossolani
errori quando, sospinti da un deprecabile etnocentrismo, si impongono modelli
interpretativi occidentali a società che non condividono il nostro stesso orizzonte
sociale, culturale, simbolico. Ciò che intendo sottolineare con forza, in accordo
con Beneduce (1997), è la necessità di porsi nei confronti di presunte
manifestazioni morbose, tipiche di culture “altre”, con la consapevolezza che
esse non costituiscono mai una realtà biologica e/o psicologica separata,
individuale, quanto un complesso processo di costruzione sociale o, come
direbbe Mauss (1965), un «fatto sociale totale» nel quale i significati vengono
negoziati e condivisi, le esperienze narrate in contesti precisi, le strategie di cura
prodotte all’interno di vincoli individuali, culturali e istituzionali (Kleinman 1986).
Il caso del koro ha rivelato che la tendenza a decontestualizzare esotiche
manifestazioni nell’intento di ricondurle a entità patologiche universali, ingenera
molto spesso confusione e contraddizioni, e conduce ad insignificanti astrazioni
(Lock 1987). Non è possibile tradurre, come fa notare criticamente Kleinman
(1987b), i centinaia di idiomi di sofferenza, disagio, dolore culturalmente
specifici, attraverso cui le culture-bound syndromes si esprimono, nelle nostre
categorie diagnostiche, nel nostro linguaggio medico, senza che il significato, il
senso profondo di queste manifestazioni sia frainteso o, peggio, completamente
smarrito.
56
BIBLIOGRAFIA
ADITYANJEE, A.M.Z. – SUBRAMANIAM, M.
1991 Sporadic Koro and Marital Dysharmony, «Pychopathology», 24: 4952
*BANKS, C.G.
1992 Culture in culture-bound syndromes: the case of anorexia nervosa,
«Social Science and Medicine», 34, 8: 867-884
BARRETT, K.
1978 Koro in a Londoner, «The Lancet», 2, 8103: 1319
BASAGLIA, F.
1978 “Clinica”, in Enciclopedia, Torino, Einaudi,
BEISER, M.
1987 Commentary on ‘culture-bound syndrome and international disease
classifications’ « Culture, Medicine and Psychiatry», 11: 29-33
*BELL, R.M.
1987 La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi, Bari,
Laterza
BENEDUCE, R.
1997 «Etnopsichiatria: Modelli di ricerca ed esperienze cliniche», in
Ciminelli, M.L. – Lanternari, V. (eds.), Medicina, Magia, Religione, Valori,
vol. II, Napoli, Liguori
BERNARD, J.
57
1961 Teen-age culture: an overview, «Ann. Am. Acad. Polit. Soc. Sci.»
338: 1
BERNSTEIN, R.L. – GAW, A.C.
1990 Koro: Proposed Classification for DSM-IV , «American Journal of
Psychiatry», 147: 1670-1674
BERRIOS, G.E. – MORELY, S.J.
1984 Koro-like Symptom in a Non-Chinese Subject, , «British Journal of
Psychiatry», 145: 331-334
BLONK, J.C.
1895 Koro, «Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsh-Indie» 35: 56263
BONCORI, L.
1993 Teoria e Tecniche dei Test, Torino, Bollati Boringhieri
BRERO, P.C.J. VAN
1896 Koro, Eine Eigenthumliche Zwangsvorstellung,
Zeitschrift für Psychiatrie und Medicin», 53: 569-573
«Allegemeine
BURGEOIS, M.
1968 Un Koro Charentais (Transposition Ethnopsychiatrique), «Annales
Medico-Psychologiques», 126: 749-751
*CARDAMONE, G. – ZORZETTO, S.
1998 Scoprirsi esotici. Un’analisi critica del rapporto fra sindromi
anoressiche e cultura, «I fogli di Oriss», 9: 83-111
CASSIDY, C.M.
1982 Protein-energy malnutrition as a culture-bound syndrome, «Culture,
Medicine and Psychiatry», 6: 325-345
CATINA, A. – KÄKELE, H.
1994 Sviluppo adolescenziale, contesto sociale e disturbi alimentari: una
possibile risposta alla domanda «perché le adolescenti?», «Adolescenza»,
2: 299-310
58
CHADDA, R.K. – SHOME, S.
1991 “Koro: Proposed Classification for DSM-IV”: Comment, «American
Journal of Psychiatry», 148: 1766-1767
CHAKRABORTY, A.
1983 Koro Epidemic in India, «Transcultural Psychiatric Reserch Review»,
20: 150-151
CHEYNE, G.
1733 The Englsh Malady: Or, A Treatise of Nervous Diseases of All Kinds,
As Spleen, Vapours, Lowness of Spirits, Hypochondriacal, and Hysterical
Distempers, etc., London, Srahan and Leake
CHOWDHURY, A.N.
1989 Koro among Kinship, «Indian Journal of Social Psychiatry», 5: 24-26
CHOWDHURY, A.N.
1991 Medico-Cultural Cognition of Koro Epidemic: An Ethnographic Study,
«Journal of Indian Antropological Society», 26: 155-170
CHOWDHURY, A.N.
1994 Koro in Females – An Analysis of 48 cases, «Transcultural
Psychiatric Research Review», 31: 369-380
CHOWDHURY, A.N.
1996 The Definition and
Psychyatry», 20: 41-65
Classification of Koro, «Culture, Medicine and
CHOWDHURY, A.N. – PAL, P. – CHATTERJEE, A. – ROY, M ET AL.
1988 Analysis of North Bengala Koro Epidemic with Three Years followup,
«Indian Journal of Psychiatry», 30: 69-72
CHOWDHURY, A.N. – BERA, N.K.
1995 Koro in North Bengala Anew: An Unusual Case, «Journal of
Personality and Clinical Studies», 11: 55-58
CIMINELLI, M.L
59
1997 «La decostruzione del concetto di “culture-bound syndrome”», in
Ciminelli, M.L. – Lanternari, V. (eds.), Medicina, Magia, Religione, Valori,
vol. II, Napoli, Liguori
COLEMAN, J.
1961 The Adolescent Society: The Social Life of the Teenager
and Its Impact on Education, New York, The Free Press
DEVAN, G.S. – ONG, S.H.
1987 Koro and Schizophrenia in Singapore, «British Journal of
Psychiatry», 150: 106-107
*DI NICOLA, V.
1990 Anorexia multiforme: self-starvation in histerical and cultural
context. Part II: anorexia nervosa as a culture, «TPRR», 27: 245-286
DENG, Y.L.
1992 Minsue Fengsu Yu Shenghuo Qutan [Customs and Life Styles
Ethnic Minoritiesi], Beijing, China , Zinri Zhong Guo Publishing Co.
of
DEVEREUX, G.
1956 «Normal and abnormal: the key problem of psychiatric
antropology», in Some Uses of Anthropology:Theoretical and Applied, The
Anthropological Society of Washington
DEVEREUX, G.
1978 Saggi di Etnopsichiatria Generale, Roma, Armando
EDE, A.
1976 Koro in an Anglo Saxon Canadine, «Canadine Psychiatric
Association Journal», 21: 389-391
EDWARDS, J.W.
1970 The Koro Pattern of Depersonalization in an America Schizophrenic
Patient, «American Journal of Psychiatry», 126: 1171-1173
EDWARDS, J.W.
60
1984 Indigenus Koro, A Genital Retraction Syndrome of Insular South
East Asia: A Critical Reviwe, «Culture, Medicine and Psychiatry», 8: 1-24
EISENBERG, L.
1977 Disease and Illness. Distinction between professional and popular
ideas of sickness, «Culture, Medicine and Psychiatry», 1: 9-23
ELKIN, F. – WESTLY, W
1955 The myth of adolescent culture, «Am. Soc. Rev.» 20: 680
ELLIS, W.G.
1893 The Amok of the Malays, «Journal of Mental Science», 39: 325-338
ELLIS, W.G.
1897 Latah. A Mental Malady of the Malays, «Journal of Mental Science»
43: 32-40
ERNST, F.
1949 Vom Heimwech, Zürich, Fretz & Wasmut
FAERGEMAN, P.
1962 Psychogenic Psychoses, Londra, Butterworth
FAVEZZA, A.R.
1985 «Anthropology and Psychiatry» in Kaplan, H.I. – Sadock, B.J. (eds)
Comprehensive Textbook of Psychiatric, Baltimora, Williams & Wilkins
FRIGGESSI CASTELNUOVO, D. – RISSO, M.
1982 A mezza parete, Torino, Einaudi
GARN, S.– SMITH, N.J. – CLARK, D.C.
1975 The Magnitude and Implication of Apparent RaceDifferencein
Hemoglobin Values, «American Journal of Clinical Nutrition», 28: 563-568
GARN, S. – RYAN, A.S. – OWEN, G. ET AL.
61
1981
Income Matched Black-White Hemoglobin Difference after
Correction for Low Transferrin Saturations, «American Journal of
Clinical Nutrition», 34: 1645-47
GEERTZ, C.
1984 Distinguished Lecture: Anti Anti-Relativism, «American
Anthropologist», 86: 263-278
GEERTZ, C.
1988 Antropologia interpretativa, Bologna, Il Mulino
GOOD, B.J.
1996 Diagnosis, knowledge and power, «Culture, Medicine and
Psychiatry» 20, 2: 127-132
GOOD, B.J.
1999 Psychopathology and ‘mad’ violence in Indonesia. Cultural
psychology in a post-colonial setting, Conferenza, Rettorato “La Sapienza”
Roma 26 maggio ’99, MNSC.
GWEE, A.L.
1963 Koro–A Cultural Disease, «Singapore Medical Journal», 4 (3): 119122
GWEE, A.L
1968 Koro-Its Origin and Nature as a Disease Entity, «Singapore Medical
Journal», 9 (1): 3-6
HAHN, R.A.
1985 Culture-bound syndromes unbound, «Social Science and Medicine»,
21, 2: 165-171
HALL, G.S.
1904 Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Physiology,
Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education, New York,
Apleton
HAVIGHURST, R. – TABA, H.
62
1949 Adolescent Character and Personality, New York, Wiley
HILL, R.F. – FORTENBERRY, J.D.
1992 Adolescence as a culture-bound syndrome, «Social Science and
Medicine» 35, 1: 73-80
HOFER, J.
1688 Dissertatio medica
HUFFORD, D.J.
1988 Inclusionism versus reductionism in the study of culture-bound
syndromes, «Culture, Medicine and Psychiatry», 12: 503-512
IFABUMUYI, O.I.– RWEGELLERA G.G.C.
1979 Koro in a Nigerian Male Patient: A Case Report, «African Journal of
Psychiatry», 5: 103-105
INGLESE, S. – PECCARISI, C .
1997 Psichiatria oltre confine. Viaggio intorno alle sindromi culturalmente
ordinate, Milano, UTET
IVANOV, A.A.
1885 Citato in Raven (1886)
JAHODA, C.
1969 The Psychology of Superstition, London, Allen Lane
JILEK, W.G. – JILEK-AALL, L.
1977 A Koro Epidemic in Thailand, «Transcultural Psychiatric Research
Review», 14: 57-59
JILEK, W.G. – JILEK-AALL, L.
1985 The metamorphosis of ‘culture-bound’ syndromes, «Social Science
and Medicine», 21, 2: 205-210
KAPUR, R.L.
63
1987 Commenntary on culture bound syndromes and international
disease classification, «Culture, Medicine and Psychiatry», 11: 43-48
KARP, I.
1985 Deconstructing Culture-Bound Syndromes, «Social Science and
Medicine», 21, 2: 221-228
KATZMAN, M.A. – LEE, S.
1997 Beyond body image: the integration of feminist and transcultural
theories in the understanding of self starvation, «Int. J. Eating Dis.», 22:
385-394
KENNY, M.G.
1985 Introduction: new approaches to culture-bound mental disorders,
«Social Science and Medicine», 21, 2: 163
KENNY, M.G.
1988 Primitive classifications and the culture-bound syndrome, «Culture,
Medicine and Psychiatry», 2: 209-31
KEYS, A.
1980 Seven Countries: A Multivariate Analysis of Coronary Heart Disease
and Death, Cambridge MA: Harvard U Press
KILANI, M.
1996 Antropologia. Una introduzione, Bari, Dedalo
KLEINMAN, A.
1977 Depression, somatitization and the new cross-cultural psychiatry,
«Social Science and Medicine», 11: 3-10
KLEINMAN, A.
1986 Social Origins of Distress and Disease. New York & London, Yale
University Press.
KLEINMAN, A.
64
1987a Anthropology and psychiatry. The role of culture in cross-cultural
research on illness «British Jounal of Psychiatry», 151: 447-454
KLEINMAN, A.
1987b Culture and clinical reality: commentary on culture-bound
syndromes and international disease classifications, «Culture, Medicine
and Psychiatry», 11: 49-52
KLEINMAN, A. – EISENBERG, A.M. – GOOD, B.
1978 Culture illness and care: clinical lessons from anthropopological and
cross cultural, research «Ann. intern. Med. », 88: 251
KOBLER, F.
1948 Description of an Acute Castration Fear, Based on Superstition,
«Psychoanalytic Review», 35:285-89
KORO STUDY TEAM
1969 The Koro “Epidemic” in Singapore, «Singapore Medical Journal»,
10: 234-242
KRAEPELIN, E.
1904 Vergleichende Psychiatrie, «Centralblatt fur Nervenheil-kunde und
Psychiatrie, 27, 15: 433-37 (trad. ingl. in «Transcultural Psychiatric
Research Review», XI, 3, October 1974: 108-112)
KRAPELIN, E.
1921 Maniac-Depressive Insanity and Paranoia, Edinburgh, Livingstone
LANGNESS, L.L.
1967 Hysterical Psychosis. The Cross-Cultural Evidence, «American
Journal of Psychiatry», 124: 143-152
*LARSON, B. – BJORNTORP, P. – TIBBLIN, G.
1981 The Helth Consequences of Moderate Obesity, «International
Journal of Obesity» 5: 97-116
*LASAGNA, L.
65
1980 Operation Obesity: A National Challenge, «Medical Tribune»,
October, 5:
*LEE, S.
1996 Reconsidering the status of anorexia nervosa as a western culturebound syndrome, «Social Science and Medicine», 41, 1: 21-34
LEHRMAN, D.
1970 «Semantic and conceptual issues in the nature-nurture problem», in
Aaronson, L.R. et al. (eds.) Development and Evolution of Behavior, San
Francisco, Freeman
LÉVI-STRAUSS, C.
1969 Le strutture elementari della parentela, Milano, Feltrinelli
LEW, E. – GARFINKEL
1979 Variations in Mortality by Weight amog 750,000 Men and Women,
«Journal of Chronic Diseasea », 32: 563-576
LEWIS-FERNANDEZ, R.
1996 Cultural formulations of psychiatric diagnosis, «Culture, Medicine
and Psychiatry» 20, 2: 133-144
LIN, T.Y.
1982 Culture and Psychiatry: A Chinese Perspective, «Australian and New
Zealand Journal of Psychiatry», 16: 235-245
LITTLEWOOD, R. – LIPSEDGE, M.
1987 The butterfly and the serpent: culture, psychopathology and
biomedicine, « Culture, Medicine and Psychiatry», 11: 289-335
LOCK, M.
1987 DSM-III as culture-bound construct: commentary on culture-bound
syndromes and international disease classificationes, «Culture, Medicine
and Psychiatry», 11: 35-42
LOW, S.M.
66
1985 Culturally interpreted symptoms or culture-bound syndromes: a
cross cultural review of nerves, «Social Science and Medicine», 21, 2: 187
LUCIEER, W.M.
1983 The Bitter Taste of Liberty.
«Psychopathologic Africane», 20: 17-40
A
Study
in
Etnopsychiatry,
MA, X.L.
1989 Bai Wan Ge Wei Shen Me [A Million Questions “Why”],
Guangxi, Li Jiang Publishing Co.
Guilin,
MALINOWSKI, B.
1969 Sesso e repressione sessuale tra i selvaggi, Torino, BollatiBoringhieri
MARSELLA, A.J. – WHITE, G.M. (eds)
1982/84 Culture Conceptions of Mental Healt and Therapy, Dordrecht,
Reidel
MATTHES, B.F.
1874 Over de Bissoe’s of Heidenshe Priesters en Priesteressen de
Boeginezen, Amsterdam, C.G. Vander Post
MAUSS, M.
1965 Teoria della magia e altri saggi, Torino, Einaudi
MEAD, M.
1968
Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of
Primitive Youth for Western Civilization, New York, Dell
MO, K.M.
1987 Report of koro epidemic in Leizhou Peninsula, Hainan Island,
«Chinese Journal of Neuropsychiatry», 20 (4): 232-234
MO, K.M.
1992 Peculiar Features of Mental Disorders in Guangdong Area, «Journal
of the Hong Kong College of Psychiatriats», 2: 58-59
67
MULDER, J.G.A.
1935 Over Koro, «Geneeskunding Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie»,
75: 837-38
MUN, C.T.
1968 Epidemic Koro in Singapore, «British Medical Journal», 1: 640-641
NATHAN, T.
1993 Fier de n’avoir ni pays, ni amis, quelle sottise c’était. Principes
d’ethnopsychanalyse. Paris, La Pensée Sauvage
NGUI, P.W.
1969 The koro epidemic in Singapore, «Aust NZ J Psychiatry», 3: 263266
OBESEYKERE, G.
1990 The Work of Culture. Symbolic Trasformation in Psychoanalysis and
Anthropology, Chicago, University of Chicago Press.
OFFER, D. – OSTROV, E. – HOWARD K. I. ET AL.
1990 Normality and adolescence, «Psychiatr. Clin. N. Am.», 13: 377
OYEBODE, F. – JAMIESON, R. – MULLANEY, J. ET AL.
1986 Koro – A Psychophysiological Dysfunction?, «British Journal of
Psychiatry», 148: 212-214
*PRINCE, R.
1985 The concept of culture-bound syndrome: anorerexia nervosa and
brain-fag, «Social Science and Medicine», 21, 2: 1
PRINCE, R. – TCHENG-LAROCHE, FR.
1987 Culture-bound syndromes and international disease classifications,
«Culture, Medicine and Psychiatry», 11, 1: 3-19
RAIMBAULT, G. – ELIACHEFF, C
68
1991
Le indomabili, Milano, Leonardo
RAVEN, T.
1886 Retraction of the Penis, «The Lancet», 2: 250
RIN, H.
1965 A Study of the Aetiology of Koro in respect to the Chinese Concept
of Illness, «International Journal of Social Psychiatry», 11: 7-13
*RITENBAUGH, C.
1982 Obesity as culture-bound syndrome, «Culture, Medicine and
Psychiatry», 6: 347-361
RUBIN, R.T.
1982 «Koro (Shook Yang) – A Culture-bound Psychogenic Syndrome», in
Friedman, C.T.H. – Faguet, R.A. (eds.) Extraordinary Disorders of Human
Behavior, New York, Plenum
SACHDEV, P.S.
1985 Koro epidemic in North-East India, « Australian and New Zeland
Journal of Psychiatry», 19: 433-438
SAJJAD, S. H. – GILL, K. U.
1993 Koro: A case of genital retraction syndrome in Ireland, «Irish
Journal of Psychological Medicine », 10 (1) : 40-41
SCHER, M.
1987 Koro in Native Born Citizen of U.S. , « International Journal of Social
Psychiatry», 33: 42-45
SCHIRRIPA, P.
1996 Edipo e matriarchi nell’arcipelago di corallo, «I fogli di Oriss», 5:
207-213
SHEUNG-TAK, C.
1996 A critical review of Chinese koro, « Culture, Medicine and
Psychiatry», 20: 67-82
69
SIGNORINI, I.
1988 Spavento e Sindrome Culture-Bound. Sindrome?, «L’Uomo», vol I
n.s. – nn. 1/2, 25- 50
SILBER, T.
1980 adolescent medicine: the development
«Adolescence» 59: 495
of a
new
speciallty,
SIMONS, R.C. – HUGHES, CH. C. (eds.)
1985 The Culture-bound Syndromes. Folk illnesses of psychiatric and
Anthropological Interest, Dordrecht, Reidel
SLOT, J.A.
1935
Koro
in
Zuid-Celebes,
Nederlandsch-Indie», 75: 811-820
«Geneeskunding
Tijdschrift
voor
SUWANLERT, S. – COATES, D.
1979
Epidemic Koro in Thailand – Clinical and Social Aspects,
«Transcultural Psychiatric Reserch Review», 16: 64-66
*SWARTZ, L.
1985 Anorexia nervosa as a culture-bound syndrome, «Social Science and
Medicine», 20, 7: 725-730
TOBINE, J.
1996 A case of Koro in 20 year old Irish male, «Irish Journal of
Psychological Medicine », 13 (2): 72-73
TSENG, W.-S. – MO K.-M. – HSU, J. ET AL.
1988 A Sociocultural Study of Koro Epidemics in Guangdong, China,
«American Journal of Psychiatry», 145: 1538-1543
TSENG, W.S.– MO K.-M. – LI, L.S. ET AL.
1992 Koro Epidemics in Guangdon, China: A Questionnaire Survey,
«Journal of Nervous and Mental Disease», 180: 117-123
*VANDEREYCKEN, W. – VAN DETH
70
1995 Dalle sante ascetiche alle ragazze anoressiche. Il rifiuto del cibo
nella storia, Milano, Cortina
VORSTMAN, A.H.
1897 ‘Koro’ in de Westerafdeeling van Borneo, «Geneeskundig Tijdschrift
voor Nederlandsch-Indie», 37: 499-505
WEN, J.-K. – WANG, C.L.
1981 «Shen-K’uei Syndrome: A Culture-Specific Sexsual Neurosis in
Taiwan», in Kleinman, A. – Lin , T.Y. (eds) Normal and Abnormal Behavior
in Chinese Culture, Boston, Reidal
WERNER, E.T.C.
1961 A Dictonary of Chinese Mythology, New York, The Jiulian Press.
WITTKOWER, E.D.
1969 Perspectives of transcultural psychiatry, «Int. J. Psychiat.»,8: 811824
WU, Y.Z.
1991 Zhong Guo Nanfang Minsu Wenhua Yuanliu Shi [A History of the
Origin of Ethnic Minority Cultures in Southern China], Nanning, Guangxi,
Guanxi Education Publishing Co.
WULFFTEN PALTHE, P.M. VAN
1935 «Koro, eine Merkwurdige Angsthysterie, «Internationale Zeitschrift
für Psychoanalyse», 21: 249-57
WULFFTEN PALTHE, P.M. VAN
1936 «Psychiatry and Neurology in the Tropics», in De Langen, C.D. –
Lichtenstein (eds.) A Clinical Textbook of Tropical Medicine, Batavia,
Kolff& Co.
WULFFTEN PALTHE, P.M. VAN
1937 Il Significato Forense del ‘Koro’, «Archivio Di Antropologia Criminale,
Psichiatria, Medicina Legale», 57: 173-82
71
YAP, P.M.
1965 Koro–A Culture-Bound Depersonalization Syndrome, «British Journal
of Psychiatry», 111: 43-50
YAP, P. M.
1969 «The culture-bound reactive syndrome», in Caudill,W.- Lin, T.Y.
(eds.) Mental Health Research in Asian and the Pacific, Honolulu, East
West Center, pp. 33-53
YAP, P.M.
1974 Comparative Psychiatry. A Theoretical Framework, Lau M.P. –
Stokes A.B. (eds), Toronto, Clarke Inst. of Psych. Univ of Toronto Press
YOUNG, A.
1982 The anthropologies of
Anthropology», 11: 257-285
illness and sickness, «Annual Review of
72