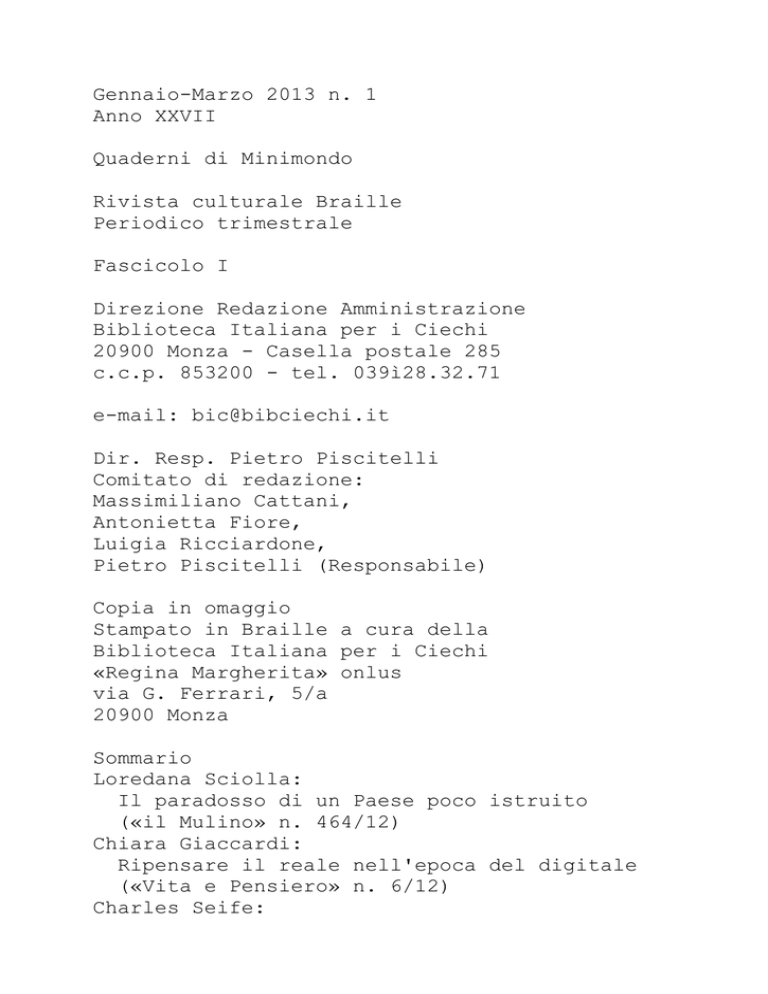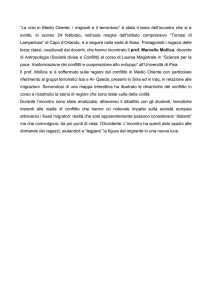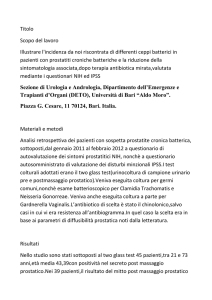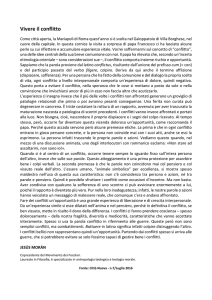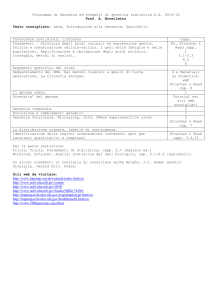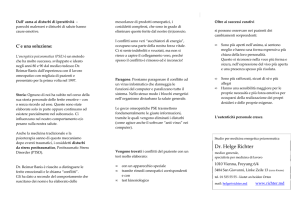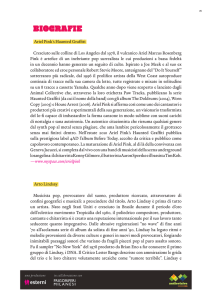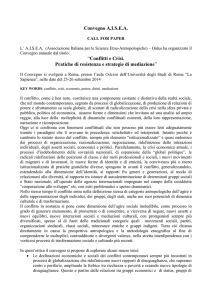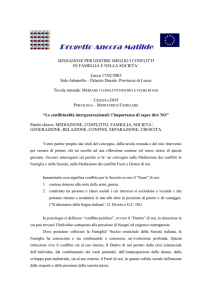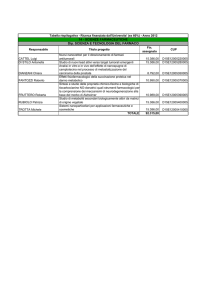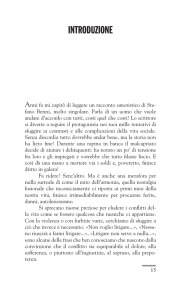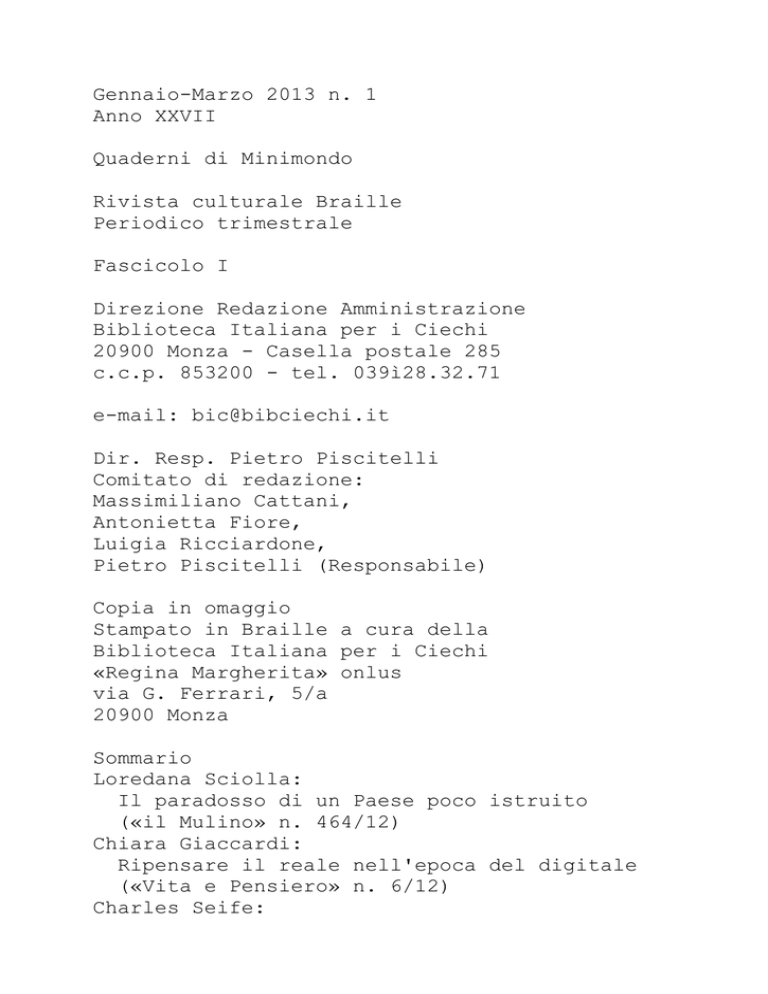
Gennaio-Marzo 2013 n. 1
Anno XXVII
Quaderni di Minimondo
Rivista culturale Braille
Periodico trimestrale
Fascicolo I
Direzione Redazione Amministrazione
Biblioteca Italiana per i Ciechi
20900 Monza - Casella postale 285
c.c.p. 853200 - tel. 039ì28.32.71
e-mail: [email protected]
Dir. Resp. Pietro Piscitelli
Comitato di redazione:
Massimiliano Cattani,
Antonietta Fiore,
Luigia Ricciardone,
Pietro Piscitelli (Responsabile)
Copia in omaggio
Stampato in Braille a cura della
Biblioteca Italiana per i Ciechi
«Regina Margherita» onlus
via G. Ferrari, 5/a
20900 Monza
Sommario
Loredana Sciolla:
Il paradosso di un Paese poco istruito
(«il Mulino» n. 464/12)
Chiara Giaccardi:
Ripensare il reale nell'epoca del digitale
(«Vita e Pensiero» n. 6/12)
Charles Seife:
La ricerca farmaceutica è affidabile?
(«Le Scienze» n. 534/13)
Alberto E. Minetti,
Gaspare Pavei:
La corsa verde dei veicoli ibridi
(«Le Scienze» n. 518/11)
Anna Oliverio Ferraris:
Media e politica
(«Psicologia contemporanea» n. 224/11)
Guido Petter:
I nonni oggi
(«Psicologia contemporanea» n. 223/11)
Carlo Bordoni:
C'era una volta la paura
(«Prometeo» n. 110/10)
Marco Serri:
Anna Magnani, un «animale da schermo»
(«Millenovecento» n. 29/05)
Marco Carminati:
Con Verdi in tour
(«Ulisse» n. 340/13)
Il paradosso di un Paese poco istruito
L'Italia, tra i Paesi avanzati, non brilla
per investimento in capitale umano, sia se
consideriamo l'indicatore più diffuso e
disponibile, gli anni di scuola, sia se ci
riferiamo a parametri più qualitativi. Se si
considera la sola espansione scolastica in
Italia, ossia l'andamento negli anni del tasso
di scolarità a tutti i livelli di istruzione,
osserviamo una tendenza molto simile a quella
degli altri Paesi europei, per cui si può dire
che si sia passati da una scuola e
un'università di élite a una scuola e
un'università di massa. Nel nostro Paese i
picchi dell'espansione si hanno in periodi
diversi, secondo il livello di istruzione
considerato. La scuola primaria raggiunge una
soglia elevata fin dagli anni Venti, ma
l'apice si situa negli anni Sessanta; la
scuola secondaria (di primo e di secondo
grado) ottiene la massima espansione nel
decennio successivo, negli anni Settanta. Gli
iscritti all'università, infine, crescono in
maniera costante, con una particolare
accelerazione negli anni Sessanta e negli anni
Ottanta del secolo scorso.
Se prendiamo come punto di riferimento i
primi anni Novanta, da cui si fa iniziare il
rallentamento della crescita economica
italiana, vediamo che i diplomati sono il 57%
nel 1992, ma salgono al 72,6% nel 2008. Così i
laureati rappresentano soltanto il 10,1% nel
1992 e ammontano, sempre nel 2008, al 34,3%
dei giovani di venticinque anni. La crescita
dell'istruzione è dunque continuata,
nonostante un rallentamento rispetto ai picchi
raggiunti. Certo, nel nostro Paese la
percentuale di laureati risulta ancora modesta
rispetto a quella raggiunta dai principali
Paesi europei. È questa un'anomalia italiana
che è stata spiegata chiamando in causa
numerosi fattori: dall'assenza di
differenziazione dell'istruzione terziaria,
alla scarsità di risorse destinate dallo Stato
a questo livello di istruzione, alla
dipendenza dal background famigliare, alle
scarse prospettive occupazionali e salariali
che segnalano l'esistenza di un vero e proprio
paradosso.
Già questi dati quantitativi mostrano che
l'Italia resta indietro per quanto riguarda
soprattutto l'istruzione terziaria, con il suo
basso numero di laureati (e nonostante i bassi
costi di ingresso all'università). Per non
parlare degli ultimi dati Ocse nell'annuale
studio sul sistema scolastico dei 34 Paesi
membri dell'organizzazione, dove emerge che
l'Italia si trova agli ultimi posti per la
spesa in istruzione. Nel 2008 il nostro Paese
dedicava il 4,8% del Pil all'istruzione,
contro una media Ocse del 6,1%. Inoltre in un
periodo di 8 anni - dal 2000 al 2008 l'Italia fa segnare il penultimo incremento
tra i Paesi avanzati (per quanto riguarda
scuola primaria, secondaria e post-secondaria
non universitaria): un incremento del 6%
contro la media Ocse del 34%. Lo scenario
diventa davvero sconsolante se da un lato
ampliamo lo sguardo all'intera popolazione
italiana e, dall'altro, consideriamo non solo
la tendenza quantitativa (tasso di scolarità
ai vari livelli), ma anche la qualità e
l'efficacia del sistema educativo. Se il
parametro di riferimento non sono i giovani di
19 e 25 anni, ma è l'intera popolazione
italiana in età lavorativa (25-64 anni),
secondo l'Ocse la popolazione italiana in
possesso di titoli di studio elevati rimane
assai inferiore a quella media dei Paesi
dell'Ue e dell'Ocse, perché sconta il basso
livello di istruzione delle generazioni più
anziane. Gli italiani che non hanno nemmeno il
diploma sono il 47%, quasi la metà della
popolazione in età lavorativa, contro il 27%
della media dei Paesi Ocse. Mentre gli
italiani in possesso di laurea sono solo il
14%, la metà della media Ocse (30%) (Oecd,
Education at a Glance 2011: Oecd Indicators,
Oecd Publishing, 2011).
A queste considerazioni sui tassi di
istruzione formale della popolazione italiana
bisogna aggiungere l'ampiezza sorprendente di
un fenomeno che sembrava retaggio di un
lontano passato. Se l'analfabetismo in senso
stretto, ossia l'incapacità di leggere e
scrivere, si riduce, secondo i dati Istat
(L'Italia in cifre, 2011), alla percentuale
dell'1,5% (certo ben altra cosa rispetto al
70% di analfabeti riscontrati dieci anni dopo
l'unificazione e perfino rispetto all'8,3%
rilevato nel 1961, a cent'anni dall'Unità),
ben più ampio è quello che viene chiamato
l'«analfabetismo funzionale», su cui da anni
richiama l'attenzione Tullio De Mauro.
L'analfabeta funzionale sa leggere e scrivere
nella propria lingua, ma non sa usare in modo
efficiente le abilità di lettura, scrittura e
calcolo nelle più semplici situazioni della
vita quotidiana (come comprendere le
istruzioni mediche, controllare i conti
forniti dalla banca, leggere articoli molto
semplici di giornale ecc.).
Due indagini comparative a livello
internazionale, svolte nel 1999-2000 e nel
2004-05 e promosse dall'Ocse (Ials International Adult Literacy Survey - e All Adult Literacy and Lifeskills) su un campione
di popolazione tra i 16 e i 65 anni, hanno
denunciato un quadro sconfortante della
situazione culturale italiana. Al campione
sono stati somministrati questionari, uno
molto elementare e cinque di difficoltà
crescente, con lo scopo di rilevare la
capacità di lettura, comprensione e calcolo
degli intervistati, a cui si sono aggiunte,
nella seconda indagine, anche le capacità di
problem solving. L'Italia ha mostrato le
performance più modeste tra i Paesi europei in
tutti gli ambiti di indagine. De Mauro,
citando queste ricerche, ha recentemente
sostenuto che «soltanto il 20% della
popolazione adulta italiana possiede gli
strumenti minimi indispensabili di lettura,
scrittura e calcolo necessari per orientarsi
in una società contemporanea». E ha aggiunto:
«Tra i Paesi partecipanti l'Italia batte quasi
tutti. Solo lo stato del Nuevo Léon, in
Messico, ha risultati peggiori. I dati sono
stati resi pubblici in Italia nel 2001 e nel
2006. Ma senza reazioni apprezzabili da parte
dei mezzi di informazione e dei leader
politici» (Analfabeti d'Italia,
«Internazionale», n. 734, 2008).
Assai preoccupanti sono anche i risultati
dell'indagine Ocse-Pisa (Programme for
International Student Assessment) che rilevano
la percentuale di adolescenti analfabeti
funzionali in lettura e comprensione di un
testo scritto, competenze matematiche e
nozioni scientifiche. Nelle prove del 2010 il
21,3% degli studenti italiani non risulta in
grado di svolgere attività di lettura
complesse, percentuale più elevata di quella
di altri Paesi dell'Unione europea (più del
doppio di quella rilevata in Finlandia dove
l'analfabetismo è stato molto ridotto). Questi
risultati internazionali sulle competenze
degli studenti italiani mettono a fuoco non
solo i bassi punteggi dell'Italia nel panorama
europeo (in realtà è la scuola media a essere
deludente, al contrario dei buoni risultati di
quella primaria), ma anche le forti differenze
interne al nostro Paese. Da recenti
elaborazioni che comparano i dati Pisa e Pirls
(Progress in International Reading Literacy
Study) risultano forti differenze regionali
(le competenze sono minime nelle isole,
massime nel Nord Est); l'immagine complessiva
che esse ci restituiscono è quella di una
spaccatura tra Nord e Sud Italia per quanto
riguarda il sistema scolastico nazionale. È
interessante osservare l'evoluzione dei divari
territoriali nella distribuzione delle
competenze. Come mostrano Michela Braga e
Daniele Checchi in un loro recente lavoro
(Sistemi scolastici regionali e capacità di
sviluppo delle competenze, «La Rivista delle
Politiche Sociali», 3/2010), i risultati sono
soprattutto due: il primo è che i divari
territoriali non si attenuano nel corso della
carriera scolastica e il secondo è la forte
correlazione tra il livello di competenze e le
caratteristiche dell'ambiente familiare (il
grado di istruzione dei genitori, il prestigio
occupazionale associato alle professioni
ricoperte, le risorse economiche e quelle
educative presenti in famiglia, il «capitale
culturale» familiare in generale costituito
dai libri posseduti, dalla presenza di
computer, dalla possibilità di disporre di uno
spazio individuale per lo studio). Anche se la
scuola risulta in grado, quando efficace, di
attenuare le differenze di origine sociale,
non c'è dubbio che queste ultime costituiscono
fattori sociali e culturali rilevanti nel
processo di formazione dei giovani e nelle
loro disuguaglianze cognitive e culturali.
Diversamente da quanto la teoria ci insegna,
il sistema scolastico italiano (nei suoi
diversi gradi) non attenua, ma riproduce le
disuguaglianze di opportunità derivanti
dall'origine sociale.
Quanto detto va nella stessa direzione di un
approfondito studio economico (Eric A.
Hanushek e Ludger Woessmann, The Role of
Cognitive Skills in Economic Development,
«Journal of Economic Literature», n. 46,
3/2008), che interviene nel dibattito sul
ruolo dell'istruzione sullo sviluppo economico
complessivo. I due autori spostano il fuoco
dell'attenzione dai livelli di istruzione
conseguiti alle competenze cognitive della
popolazione, concludendo che i nuovi risultati
mostrano una forte evidenza empirica della
correlazione positiva tra queste, gli stipendi
individuali e la crescita economica. A essere
chiamata in causa è dunque soprattutto la
qualità delle istituzioni scolastiche più che
il mero tasso di scolarità, misurata da test
internazionali comparabili in matematica,
scienza, lettura. Viene inoltre attribuita
grande importanza ai contesti sociali ed
educativi (famiglie, gruppi dei pari e altre
agenzie di socializzazione), generalmente
trascurati dalla maggior parte della ricerca
sull'impatto economico dell'istruzione, ma su
cui hanno spesso richiamato l'attenzione i
sociologi. La parola-chiave è education,
intesa come un ampio mix di input e di
processi intergenerazionali e di esperienza
che hanno un effetto formativo sul modo in cui
si pensa, si affrontano i problemi e si
agisce, processi che conducono
all'acquisizione di conoscenza, abilità e
valori. Anche se non appare interamente
superato, a mio parere, il problema delle
difficoltà di calcolo e di disponibilità di
dati statistici di componenti qualitative
dell'istruzione, questo studio mette in luce
aspetti importanti del rapporto tra abilità
cognitive e sviluppo economico. I meccanismi
attraverso cui l'educazione influisce sulla
crescita economica, individuati in questo
lavoro, sono: a) l'aumento del capitale umano
inerente alla forza lavoro, che accresce la
produttività del lavoro; b) l'aumento della
capacità innovativa dell'economia e della
conoscenza su nuove tecnologie, prodotti e
processi; c) lo stimolo alla diffusione e
trasmissione di conoscenza necessaria per
capire e processare nuova informazione e
accrescere con successo nuove tecnologie
inventate da altri. Sulla capacità di misurare
l'importanza del capitale umano rispetto alla
prosperità delle nazioni si è pubblicamente
espresso con toni decisamente ottimistici Gary
Becker, il cui volume del 1964 è un testo di
riferimento per gli studi in questo ambito. Al
Festival dell'Economia di Trento del 2007,
Becker ha sostenuto: «È stata misurata anche
l'importanza del capitale umano rispetto alla
prosperità delle nazioni. Ancora una volta si
tratta di un calcolo piuttosto difficile:
approssimativamente, stimerei una percentuale
pari al 70% di capitale umano rispetto a tutto
il capitale di una società». Ma ha poi
ritenuto di aggiungere: «Peraltro, la mancanza
di dati certi sottolinea ancora una volta
l'aspetto carente dei sistemi statistici
nazionali».
In sintesi, l'Italia si è inserita
stabilmente nella scia dei Paesi più
sviluppati per quanto riguarda i processi di
scolarizzazione, seguendone le tendenze verso
quella che viene chiamata la «società della
conoscenza», ma persistono gravi carenze
culturali. Nonostante l'espansione
quantitativa dell'istruzione, infatti, in
questo primo decennio del XXI secolo l'Italia
appare nel complesso, e comparativamente agli
altri Paesi europei, un Paese poco istruito,
per non dire piuttosto ignorante, sia per
quanto riguarda la bassa percentuale di
individui con livelli di istruzione elevata
sia per quanto riguarda la qualità delle
conoscenze e dell'apprendimento sia, infine,
per il diffuso analfabetismo nascosto, o
funzionale, della popolazione adulta.
Un risultato ritenuto consolidato negli
studi sul capitale umano è che tanto più è
elevato il livello di istruzione tanto
maggiori sono i tassi di occupazione e la
remunerazione del lavoro dell'individuo. Più
un individuo prosegue negli studi, maggiore è
l'incremento dei guadagni. Si osserva,
tuttavia, un fenomeno peculiare della realtà
italiana, che contraddice parzialmente questi
risultati. Resta valida anche per l'Italia la
correlazione tra livello di istruzione e tasso
di occupazione: i dati Istat ci dicono che il
tasso di occupazione aumenta all'aumentare del
titolo di studio; i dati Eurostat (elaborati
dall'Isfol nel Rapporto di monitoraggio del
mercato del lavoro, 2011) lo confermano, ma
evidenziano anche che negli ultimi dieci anni,
mentre il tasso di occupazione dei laureati è
rimasto sostanzialmente stabile nella media
europea, nel nostro Paese si è ridotto di
quasi 5 punti percentuali. Su questo piano,
dunque, nel decennio passato le distanze
dall'Europa si sono ampliate.
La correlazione fra titolo di studio e
livelli retributivi, quella considerata più
rilevante ai fini di determinare l'impatto
economico del capitale umano, appare per
l'Italia ancora più incerta. Gli studi più
recenti su dati della Banca d'Italia mostrano
che la differenza retributiva fra laureati e
diplomati è diminuita nel tempo (Fondazione
Agnelli, I nuovi laureati. La riforma del 3+2
alla prova del mercato del lavoro, Laterza,
2012). È vero che i laureati mantengono un
vantaggio retributivo, per quanto esiguo, ma
esso risulta in calo a partire dall'inizio
degli anni Novanta. La variazione nel tempo
delle remunerazioni dell'istruzione è stata
analizzata in uno studio di Paolo Naticchioni,
Andrea Ricci ed Emiliano Rustichelli che ha
utilizzato i dati dell'indagine della Banca
d'Italia dedicata a I bilanci delle famiglie
italiane per il periodo compreso tra il 1993 e
il 2004. Il campione su cui si è sviluppata
l'analisi è costituito dai lavoratori
dipendenti nel settore privato. Il livello di
istruzione è misurato in quattro categorie:
istruzione elementare, media, secondaria,
terziaria. La ricerca dimostra che i
rendimenti dei titoli di studio di livello
universitario e di scuola media superiore tra
il 1993 e il 2004 sono diminuiti in modo
consistente e statisticamente significativo.
Un discorso analogo vale anche quando si
utilizzano informazioni più dettagliate sulla
tipologia della laurea conseguita. La
diminuzione dei rendimenti dell'istruzione è
evidente per le lauree umanistiche e
professionali, mentre per le lauree
scientifiche i rendimenti, pur riducendosi nel
tempo, non manifestano una variazione
statisticamente significativa. Andamenti
decrescenti si riscontrano anche per il
diploma di scuola media superiore, che
riguarda sia i licei sia gli istituti tecnici.
È soprattutto dalla comparazione con altri
Paesi europei che emerge la peculiarità
italiana. I rendimenti dell'istruzione
terziaria sono sotto la media europea di 12
punti percentuali (36 versus 48%). Inoltre, se
in Italia i rendimenti tendono a diminuire o a
restare stabili, nei Paesi anglosassoni
aumentano notevolmente, producendo una
crescita dei redditi da lavoro delle persone
qualificate rispetto alle non qualificate.
Anche il già citato rapporto dell'Isfol
sottolinea che il guadagno relativo garantito
da un maggior livello di scolarizzazione tende
nel tempo, tra il 2005 e il 2010, a
decrescere.
Due sono le possibili spiegazioni: la prima
è l'inadeguatezza del sistema formativo e del
nostro capitale umano. Vi sarebbe una
discrepanza tra le competenze acquisite e
quelle richieste dal mercato del lavoro.
Cinquant'anni fa una laurea era in grado di
assicurare l'accesso alle occupazioni più
prestigiose e qualificate; non così oggi. Né
questa funzione è svolta, come invece avviene
all'estero, dalla diversità e dalla
differenziazione qualitativa delle istituzioni
(accanto alle istituzioni universitarie
compaiono i politecnici, le grandes écoles e
così via), in quanto in Italia questa
differenziazione non esiste. Tale situazione
astrattamente ugualitaria, o meglio
indifferenziata, non previene però, come
sottolinea tra gli altri Daniele Checchi
(Immobilità diffusa. Perché la mobilità
intergenerazionale è così bassa in Italia, Il
Mulino, 2010), il consolidarsi della
stratificazione sociale. Anzi, l'Italia si
caratterizza come uno dei Paesi in cui la
mobilità intergenerazionale è minore. Segno,
questo, che l'accesso alle posizioni d'élite è
ottenuto indipendentemente dalla struttura
istituzionale del sistema scolastico, in base
soprattutto alle reti familiari.
La seconda spiegazione è la scarsa
propensione all'innovazione da parte delle
imprese nazionali. Queste, nonostante i
cambiamenti avvenuti, hanno ancora
caratteristiche strutturali inadeguate alla
domanda di competenze elevate da parte
dell'economia della conoscenza. Chi privilegia
tale interpretazione non si limita a
sottolineare la piccola dimensione delle
imprese in Italia, ma chiama in causa la
specializzazione produttiva in settori
tradizionali, la gestione familiare e la
mancanza di cultura imprenditoriale.
Si verifica così una sorta di paradosso: i
giovani con livelli superiori di istruzione
sono, come si è visto, pochi, molti meno che
negli altri Paesi avanzati, ma il nostro
sistema produttivo non è in grado di assorbire
nemmeno questi. Questa situazione paradossale
si esprime nella differente composizione del
mercato del lavoro italiano rispetto agli
altri Paesi europei. Secondo i dati Eurostat i
giovani adulti italiani occupati (da 20 a 39
anni) risultano sistematicamente meno
rappresentati dei loro colleghi europei nelle
professioni intellettuali e dirigenziali, ad
alto livello di qualificazione e, diversamente
da questi, assai penalizzati rispetto alla
popolazione complessiva. In Italia sono il
fanalino di coda: sono solo il 9,9% contro il
14,2% della Spagna, il 17,5% della Germania,
il 18,2% della Francia, il 22,4% della Svezia
e il 26,6% della Gran Bretagna. Questo
fenomeno è stato solo accentuato dalla crisi,
in quanto era già presente negli anni
precedenti, almeno dal 2004. Si è dunque
registrata una riduzione della quota di
occupati in professioni specializzate in
controtendenza rispetto agli altri Paesi
dell'Unione europea, dove al contrario è
cresciuta.
In Italia, dunque, i giovani adulti, benché
più istruiti degli ultraquarantenni, hanno
minori occasioni di svolgere una professione
intellettuale e dirigenziale qualificata. Come
è stato sottolineato da studiosi del mercato
del lavoro, come Emilio Reyneri, una non
apprezzabile peculiarità italiana è quella di
penalizzare fortemente proprio i giovani più
istruiti. In Italia le posizioni più
qualificate si raggiungono più per l'anzianità
di servizio che non per le competenze
acquisite nel sistema educativo. Scarsa
propensione all'innovazione e mancanza di
selezione meritocratica, assai più che una
valorizzazione dell'esperienza lavorativa,
come un'interpretazione più benevola potrebbe
suggerire, sembrano essere all'origine di
questa situazione. Segnali non certo
incoraggianti per il futuro delle giovani
generazioni e dell'Italia.
Loredana Sciolla
(«il Mulino» n. 464/12)
Ripensare il reale nell'epoca del digitale
- Le dimensioni in gioco sono online e
offline, analogico e digitale. Non mondi
esclusivi tra cui scegliere: la realtà è
comunque una. «Digi-nativi» e «digi-immigrati»
imparino a sfruttare la «convergenza» delle
due sfere, ricreando le proprie relazioni. Un forte vento spinge inarrestabilmente
l'angelo della storia verso il futuro. «Ciò
che noi chiamiamo progresso è questa bufera»,
scriveva Walter Benjamin nelle sue «Tesi di
Filosofia della storia», prendendo
l'acquarello di Paul Klee, Angelus Novus, come
emblema del drammatico passaggio al futuro.
Il futuro è spesso minaccioso, soprattutto
dopo che il mito del progresso è stato
scalzato dall'immagine della società del
rischio. Ma a volte la minaccia non è che il
prodotto di un'incapacità di leggere il nuovo
con uno sguardo orientato in avanti. Secondo
Marshall McLuhan, tendiamo a «guardare il
presente dallo specchietto retrovisore». Ciò
che è nuovo ci spaventa, ci suscita un senso
di perdita e nostalgia di qualcosa che diventa
più desiderabile nel momento in cui sembra
scomparire: cosa che spiega, banalmente,
l'attuale successo del vintage, o la
fascinazione per l'aria rétro che assumono
oggi le foto grazie ai filtri di Instagram. Ma
i mutamenti non possono essere arrestati. Lo
scriveva già negli anni Cinquanta Romano
Guardini, nelle sue Lettere dal Lago di Como:
«Non dobbiamo opporci a ciò che è nuovo e
cercare di preservare un mondo meraviglioso
che sta inevitabilmente scomparendo».
I cambiamenti possono però essere
indirizzati, se si riesce a interpretarli.
Negli anni Novanta al centro delle
preoccupazioni erano i processi di
globalizzazione, che hanno profondamente
modificato sia il senso di ciò che è locale,
sia la nostra percezione del mondo nella sua
interezza, ridefinendo le due dimensioni come
sempre più interdipendenti e difficilmente
separabili (tanto che Roland Robertson coniò
nel 1995 l'aggettivo glocal). Oggi, peraltro,
la consapevolezza dell'interdipendenza nel
villaggio globale è parte del dato per
scontato, e la polarizzazione-competizione tra
i due poli ormai superata. «Globale» è
diventato sinonimo di «presente» e di «mondo»,
anche se i problemi non mancano.
Se l'angelo della storia guardava con
apprensione la piena trasformazione del mondo
in villaggio globale negli anni Novanta, nel
nuovo millennio è invece allarmato spettatore
di nuovi processi, all'insegna, questa volta,
della digitalizzazione.
Le dimensioni in gioco sono oggi online e
offline, o, meglio ancora, analogico e
digitale. La terminologia che ha accompagnato
l'inizio del dibattito, quella che
contrapponeva il reale-materiale al virtualedigitale (con le sfumature valutative
implicite di autentico per il primo e
inautentico per il secondo), è infatti oggi
superata e falsificata dalle pratiche e dai
vissuti. La tendenza a discutere il digitale
come una realtà virtuale separata da quella
fisica contrasta infatti con l'esperienza e i
significati attribuiti alla rete da chi la
usa; anzi, è causa di incomprensione e
fraintendimenti, perché definisce la questione
in modo da precludere la comprensione di
quanto sta effettivamente accadendo.
Anche il digitale è, infatti, reale.
Certamente lo è per i giovani, che ne hanno
fatto una dimensione cruciale della loro
socialità, come mostrano le ricerche empiriche
(tra le quali mi permetto di citare quella da
me pubblicata per l'editrice Vita e Pensiero
in Abitanti della rete, 2010, i cui risultati
erano già decisamente antidualisti). I due
mondi non sono separati, antagonisti, bensì
costituiscono articolazioni diverse dei
quotidiani contesti esperienziali,
relazionali, comunicativi. Una distinzione,
quella tra materiale e digitale, forse
destinata a diventare a sua volta pleonastica,
come quella tra locale e globale: c'è infatti
chi, come Luciano Floridi, sostiene che la
nostra - quella degli «immigrati digitali» sarà l'ultima generazione a distinguere ancora
tra online e offline (La rivoluzione
dell'informazione, 2012).
Il quadro oggi è complesso: da un lato i
digi-entusiasti (i «nativi») sono troppo
«dentro» per distinguere le insidie
dell'ambiente, che pur ci sono; dall'altro i
digi-pessimisti (gli «immigrati») rischiano di
essere troppo «fuori» per coglierne pienamente
la portata e sono inclini a vederne solo i
rischi. La posizione «no digital» appare
peraltro irrealistica, oltre che
insostenibile.
In ogni epoca storica (pensiamo alle
preoccupazioni di Platone rispetto alla
scrittura) ogni nuovo medium è stato visto
come una potenziale minaccia disumanizzante e
valutato, almeno inizialmente, soprattutto
sulla base di ciò che sembrava togliere. È
successo, senza andare troppo indietro nel
tempo, anche per la televisione. Purtroppo la
traiettoria tipica è quella di un passaggio
assai rapido dai timori e da una più o meno
esplicita demonizzazione a un'accettazione
acritica, fautrice di una incorporazione
banale, che non si interroga su come ogni
nuovo medium - già lo scriveva McLuhan negli
anni Sessanta - non si aggiunga semplicemente
al nostro ambiente, ma ne modifichi
l'ecologia, costringendo l'insieme a
riconfigurarsi, e sollecitando l'acquisizione
di nuove consapevolezze. In questo processo di
«rimediazione», i vecchi media non si
cancellano, ma cambiano di significato: oggi,
per esempio, la macchina fotografica non è
scomparsa ma è per pochi cultori del genere,
mentre nell'ordinarietà le foto si scattano
con gli smartphones, per poterle
immediatamente condividere.
Lo scarto tra acquisizione tecnica e
capacità di elaborarne i significati dal punto
di vista antropologico è esattamente una delle
ragioni per cui ci lasciamo sedurre - o
schiacciare - dalle tecnologie, anziché
«abitarle», come suggeriva lucidamente Günther
Anders parlando di «dislivello prometeico»
(L'uomo è antiquato, 1956), e ancor prima
Ortega y Gasset con l'immagine del «primitivo
tecnicizzato». L'era digitale, con la sua
comunicazione smaterializzata, ha prodotto una
nostalgia dell'analogico, e anche il rischio,
che alcuni studiosi giustamente sottolineano,
di una feticizzazione del reale (in primis
Nathan Jurgenson, che usa l'espressione IRL
fetish, dove IRL sta per in real life).
Ma perché dovremmo coltivare il mito di una
realtà «pura», incontaminata dal digitale?
Forse questa nostalgia è il frutto di un
errore di interpretazione. Oggi viviamo
infatti in una realtà mista, fatta di atomi e
bit, di organico e di tecnologico, di carbonio
e di silicio. Dove la compresenza fisica, tra
l'altro, non è certo di per sé garanzia di
autenticità e pienezza relazionale e
comunicativa.
Se vogliamo leggere i segni dei tempi, e
vivere con consapevolezza e libertà il nostro
presente, è urgente affrontare la questione
del digitale con uno sguardo purificato dai
pregiudizi, e cercare di comprendere senza
timori il carattere della realtà oggi.
Possibilmente mettendoci le mani: hands on è
uno dei principi dell'etica hacker, diventato
ormai habitus per i nativi digitali. Un po'
meno per gli immigrati, che si precludono così
la possibilità di comprendere i significati
del nuovo ambiente, evidenti solo a partire
dall'esperienza.
La domanda non è dunque se il digitale è
reale (comunque, la risposta è affermativa),
ma come (ri)pensare il reale nell'era del
digitale. Una ontologia della nostra era,
oltre che urgente, è la condizione di una vita
buona, di un'etica al tempo della rete. E
forse, come suggerisce Antonio Spadaro nella
sua riflessione sulla cyberteologia, anche di
un ripensamento della fede alla luce di quanto
il digitale ci fa comprendere di essa in modo
nuovo.
Il pregiudizio fondamentale da scardinare,
più radicato di quanto si pensi, è quello che
il già citato giovane sociologo americano,
Nathan Jurgenson, molto attivo sul web, ha
efficacemente definito «dualismo digitale».
Come sostiene Jurgenson (ma sono sulla stessa
posizione anche Barry Wellman, Mark Deuze,
Luciano Floridi, solo per fare qualche altro
nome) il dualismo digitale va superato, perché
ci impedisce di comprendere e interpretare il
presente.
Analogico e digitale non sono due mondi
distinti tra i quali dobbiamo scegliere; e il
loro non è un rapporto a somma zero, dove una
dimensione toglie tempo e ruolo all'altra.
L'esperienza ci insegna piuttosto che non
saper sfruttare la loro «convergenza» provoca
una perdita: le relazioni che non sfruttano le
opportunità di «manutenzione» offerte dal web
e restano dipendenti dai vincoli spaziotemporali, per esempio, sono destinate a
impoverirsi.
E forse anche l'idea stessa di faccia a
faccia va ripensata: nell'incontro, infatti,
portiamo ciò che ci siamo scritti, detti,
mostrati online; esso a sua volta diventa
oggetto di scambi sul web. L'online è ormai
incorporato nel nostro modo di guardare la
realtà e fare esperienza di essa. E ciò che
esprimiamo in rete non è il nostro alter ego
digitale, ma siamo noi. L'essere umano è uno,
e così la realtà.
Ma c'è di più: non solo non dobbiamo, ma non
possiamo separare materiale e digitale (come,
da cristiani, possiamo distinguere, ma non
separare, per esempio, materia e spirito,
contemplazione e azione, silenzio e parola,
pathos e logos, verità e vita). La realtà,
infatti, è una: ricca, diversificata,
materiale e immateriale insieme; e mai
totalmente riducibile al qui-ora, alla pura
presenza fisica. Forse la rete, da questo
punto di vista, aiuta. Va dunque ripensata la
cornice entro la quale i singoli cambiamenti
acquistano significato.
La cultura contemporanea tende a oscillare
tra i due ugualmente indesiderabili estremi di
un «monismo materialista» (efficace
espressione del teologo benedettino Ghislain
Lafont), che è inevitabilmente riduzionista, e
di un dualismo digitale che divide e oppone
ciò che sempre più si costruisce, invece,
entro un legame di reciprocità e
interdipendenza.
Esistono dunque le condizioni per passare da
una fenomenologia del digitale a una rinnovata
riflessione ontologica (che cos'è la realtà
nell'era digitale?); e per un'antropologia diversa da quella del cyborg, un modello ben
poco allettante - che tenga conto del mutato
ambiente, del fatto che non siamo mai
completamente disconnessi, anche quando i
dispositivi sono spenti, e che il qui-ora è
ormai sempre più «misto».
Una ontologia che però non suoni
semplicemente le campane della realtà
aumentata: un concetto a sua volta da
problematizzare, poiché ad alto rischio di
ideologia e retorica se estrapolato dal
livello puramente fenomenologico (l'aumento di
strati di informazione non è infatti di per sé
un aumento ontologico). Nathan Jurgenson ha
suggerito una tipizzazione del dualismo
digitale e della visione a esso contrapposta,
quella della realtà aumentata (in
http://thesocietypages.org/cyborgology/2012/10
/29/strong-and-mild-digital-dualism/), che
ripropongo, modificata e rivista alla luce
delle considerazioni fatte fin qui. Sia il
dualismo digitale sia la realtà aumentata si
presentano, a seconda dei contesti, in una
versione «radicale» e una «moderata», che non
vanno sovrapposte, né confuse.
Il dualismo radicale è ben espresso in
alcuni dialoghi del film Matrix: in una scena,
l'esperto Morpheus spiega al neofita Neo che
«Matrix è ovunque. È intorno a noi. [...]. È
il mondo che ti è stato messo davanti agli
occhi per nasconderti la verità», mentre in
un'altra scena l'agente Smith osserva: «A
quanto pare lei sta vivendo due vite distinte.
In una di queste lei è Thomas A. Anderson,
programmatore per una rispettabile società
informatica [...]. L'altra vita lei la passa
al computer, è una celebrità tra gli hacker
con il soprannome di Neo [...]. Una di queste
vite ha un futuro, l'altra invece no». Più in
generale, si presuppone che materiale e
digitale siano separati, abbiano proprietà
diverse, competano per la supremazia. Non c'è
relazione tra i due, se non nella forma
negativa della contrapposizione. Il digitale
non è reale ma virtuale e minaccia la «vera»
realtà. Applicando la terminologia che Lévinas
utilizza per parlare dell'identità personale,
si può dire che il virtuale è, rispetto alla
realtà materiale, aliud, alterità radicale.
Nella versione moderata (quella di Sherry
Turkle in Insieme ma soli, per esempio) i due
mondi sono separati, ma interagiscono.
Tuttavia il digitale, da un lato, è un reale
impoverito, dall'altro costituisce una
minaccia per la realtà materiale, e
soprattutto per le relazioni in presenza,
sottraendo tempo ed energie, ma anche capacità
relazionali, all'incontro faccia a faccia.
Secondo la versione radicale della realtà
aumentata non c'è più alcuna differenza tra
reale e digitale: siamo tutti cyborg, non
esiste più un'esperienza propriamente offline.
I due mondi sarebbero ormai totalmente
sovrapposti e indistinguibili. La realtà è
una, ma senza differenze (solo equivalenze).
La versione moderata vede invece un rapporto
di unità nella differenza tra analogico e
digitale: due ambiti reali, diversi ma parte
di un'unica realtà, che non solo
interagiscono, ma si definiscono
reciprocamente. Il digitale è alter, alterità
in relazione e costitutiva.
È questa la prospettiva da esplorare e
approfondire. Se la realtà aumentata
caratterizza il livello fenomenologico, quello
che possiamo definire «realismo digitale» ne
rappresenta il correlato sul piano ontologico,
come declinazione contemporanea di quel
realismo critico (per il quale la realtà
esiste, ma ciò che è non si riduce a ciò che
appare) sostenuto da un importante filone di
pensiero che va da Lonergan ad Archer, a
Donati.
Un «monismo plurale» in cui non c'è
contrapposizione, per quanto li si possa
distinguere, tra atomi e bit, bensì «unità
nella differenza».
Forse il web, in questa chiave, ci può
persino aiutare a ridimensionare la pesante
eredità del dualismo che, da Platone a
Cartesio, ha attraversato la cultura
occidentale. Due sono i punti chiave di questo
«realismo digitale»: la realtà esiste ed è
complessa, multidimensionale, non riducibile
alla somma delle sue parti; la realtà è
comunque una. Il primo è ben illustrato dalla
cosiddetta teoria dell'emergenza, che si
iscrive nella tradizione del realismo critico:
ci sono proprietà emergenti, che scaturiscono
dall'interazione tra livelli di realtà sempre
più complessi, che non esistevano prima di
tale interazione, né erano prevedibili a
partire dalle singole componenti (come le
proprietà dell'acqua non sono ricavabili da
quelle dell'idrogeno e dell'ossigeno).
Il dualismo digitale impedisce la
comprensione di quanto sta accadendo perché,
tenendo separati i due livelli del materiale e
del digitale, ne contrappone le proprietà
intrinseche e si preclude di cogliere la
realtà che «emerge» dalla loro interazione.
Sia idrogeno sia ossigeno alimentano la
fiamma, mentre l'acqua la spegne: una
proprietà non desumibile dalle due sostanze
componenti prese isolatamente. Così è per la
realtà mista, che oggi va sempre più prendendo
forma.
L'emergentismo è l'opposto del riduzionismo
(posizione alla quale è ascrivibile, tra
l'altro, anche il determinismo tecnologico):
anziché ridurre il complesso al semplice, come
fa quest'ultimo, cerca di cogliere il nuovo
che si produce a partire dalla complessità.
Ma la realtà multidimensionale è comunque
una. Distinguere i livelli non significa
separarli. Come opportunamente suggerisce
Ghislain Lafont (Che cosa possiamo sperare?,
2011), «tra il dualismo di due cose e il
monismo di una sola, c'è l'unità dell'essere
distintamente composto». Un essere che non è
il prodotto delle macchine (secondo un
determinismo tecnologico che alimenta a sua
volta l'ipotesi dualista) né un artefatto
totalmente umano (secondo l'ipotesi prometeica
che ha mostrato tutta la sua fragilità, oltre
che gli orrori di cui è capace). Un essere che
va prima di tutto ascoltato.
Riconoscere la ricchezza e pluralità del
reale è un passo per liberarsi dalla prigione
del materialismo. E per riaprire la via del
simbolico, dello spirituale e, perché no,
anche del trascendente.
Chiara Giaccardi
(«Vita e Pensiero» n. 6/12)
La ricerca farmaceutica è affidabile?
- Le aziende farmaceutiche pagano scienziati
per importanti ricerche che riguardano i loro
prodotti. E nessuno sembra in grado di
fermarle. Quando Robert Lindsay decise di dedicarsi
alla ricerca medica, all'inizio degli anni
settanta, non lo fece per denaro. Il suo campo
di interesse, l'effetto degli ormoni sul
tessuto osseo, era in fase di stasi. Per un
giovane ricercatore quel campo era
un'opportunità per lasciare il segno e, almeno
così sperava, per aiutare migliaia di persone
che soffrivano di osteoporosi. A volte, quando
il corpo invecchia, le ossa perdono la
capacità di ricostruire il proprio tessuto con
la rapidità necessaria a tenere il passo del
normale processo di usura, e lo scheletro si
indebolisce.
Nessuno capiva granché delle dinamiche di
questo fenomeno, compreso Lindsay. Ma c'erano
buone ragioni per credere che fossero
coinvolti gli ormoni. Alcune donne sviluppano
osteoporosi subito dopo la menopausa, quando i
loro livelli ormonali crollano bruscamente,
forse alterando il bilancio fra formazione e
distruzione del tessuto osseo. Se era così,
pensava Lindsay, la sostituzione degli ormoni
con una pillola avrebbe bloccato o addirittura
invertito la progressione della malattia. A
Glasgow, in una clinica piccola e con pochi
finanziamenti, il giovane ricercatore aveva
programmato uno dei primi trial della terapia
ormonale sostitutiva a base di estrogeni per
la perdita di tessuto osseo in donne in postmenopausa. La stella di Lindsay stava
sorgendo.
Il suo progetto successivo ebbe enormi
implicazioni commerciali e catturò
l'attenzione dell'industria farmaceutica. Dopo
essersi trasferito all'Helen Hayes Hospital,
un centro di riabilitazione a nord di New
York, nel 1984 Lindsay aveva pubblicato uno
studio in cui determinava la dose minima
efficace di un farmaco antiosteoporotico con
estrogeni chiamato Premarin. I risultati
suggerivano che combattere l'osteoporosi
equivaleva a incoraggiare milioni di donne a
usare il farmaco, e questo aveva reso Lindsay
un personaggio di spicco agli occhi di WyethAyerst Laboratories, azienda produttrice di
farmaci, che in effetti arruolò Lindsay tra
gli autori del proprio video informativo
Osteoporosi: una tragedia che si può
prevenire.
A metà degli anni novanta, quando Wyeth fu
coinvolta in una lite brevettuale relativa al
Premarin, Lindsay era un alleato fedele
dell'azienda. Il ricercatore si era espresso
contro l'approvazione di una versione generica
del farmaco che avrebbe fatto perdere quote di
mercato, anche se il generico avrebbe
facilitato l'accesso alla terapia. Secondo
Lindsay, un farmaco generico avrebbe potuto
non essere del tutto equivalente al farmaco
registrato (o «griffato»), un fatto che in
alcuni casi può essere vero. Questa posizione
però era anche in linea con la posizione
dell'azienda. «Tutto ciò che chiediamo è di
non approvare qualcosa di cui in futuro ci
pentiremo», dichiarò all'Associated Press nel
1995. Lo stretto rapporto di Lindsay con Wyeth
e altre case farmaceutiche proseguì per
decenni, con modalità spesso nascoste. Il
ricercatore consentì a Wyeth di scrivere le
bozze dei suoi articoli e incassò decine di
migliaia di dollari da interessi farmaceutici
che avevano tutto da guadagnare dalle sue
ricerche.
Lo scandalo non è quello che ha fatto
Lindsay, dal momento che il suo è un caso
tipico. Negli ultimi anni le case
farmaceutiche hanno trovato molti modi per
mettere ingenti somme di denaro - in alcuni
casi sufficienti per garantire a un figlio la
frequenza all'università - nelle tasche di
medici indipendenti che effettuano ricerche
riguardanti, in modo diretto o indiretto,
farmaci in fase di produzione o commercio da
parte di queste aziende. Il problema non
riguarda solo imprese e ricercatori, ma il
sistema nel suo insieme: istituzioni
finanziatrici, laboratori, riviste
specialistiche, ordini professionali e così
via. Nessuno offre un sistema di controllo in
grado di evitare conflitti di interesse. Le
organizzazioni, invece, sembrano scaricarsi
tra loro le responsabilità, lasciando spazi
nell'applicazione di regole in cui ricercatori
e aziende si destreggiano con facilità, per
poi prendere decisioni coperte da segreto.
«Non c'è un solo settore della medicina o
della ricerca accademica, né della formazione
medica, in cui i rapporti con le aziende non
siano un elemento assai diffuso», afferma il
sociologo Eric Campbell, professore di
medicina alla Harvard Medical School. Questi
rapporti non sono sempre negativi. Dopo tutto,
senza l'aiuto delle aziende i medici che fanno
ricerca non sarebbero in grado di tradurre le
proprie idee in nuovi farmaci. Allo stesso
tempo, sostiene Campbell, alcuni di questi
rapporti coinvolgono gli scienziati nella
vendita di prodotti farmaceutici, invece che
nella produzione di nuova conoscenza.
Il rapporto fra ricercatori e case
farmaceutiche può assumere forme diverse. Ci
sono gli speaker bureau: un'azienda finanzia i
viaggi di un ricercatore - spesso in prima
classe - in tutto il paese, dove a volte il
ricercatore tiene un discorso e mostra
diapositive preparati entrambi dall'azienda.
Poi c'è il lavoro di ghostwriting: un
produttore scrive la bozza di un articolo e
paga uno scienziato per firmarlo e sottoporlo
al giudizio di una rivista peer review. Infine
c'è l'attività di consulenza: un'azienda
arruola un ricercatore per avere consigli. «I
ricercatori credono che queste aziende li
cerchino per la loro intelligenza, ma di fatto
vengono dopo il marchio», dice Marcia Angell,
già direttore del «New England Journal of
Medicine». «Per ingaggiare un ricercatore
universitario senior illustre, il tipo di
persona che parla ai convegni, scrive libri e
articoli specialistici, vale la pena spendere
come per 100.000 venditori».
Le riviste peer reviewed sono piene di studi
che dimostrano come il denaro proveniente
dall'industria farmaceutica stia indebolendo
l'obiettività scientifica. Una ricerca del
2009 pubblicata su «Cancer» ha dimostrato che
i partecipanti a uno studio vivevano più a
lungo quando gli autori avevano conflitti di
interesse rispetto a quando gli stessi autori
non avevano interessi in gioco. Uno studio del
1998 pubblicato dal «New England Jounral of
Medicine» ha trovato una «forte correlazione»
fra le conclusioni dei ricercatori sulla
sicurezza dei bloccanti dei canali del calcio,
una classe di farmaci usati per ridurre la
pressione del sangue, e il loro rapporto
finanziario con le aziende che producono i
farmaci.
Non si tratta solo di un problema
accademico. I farmaci sono approvati o
respinti in base a ricerche apparentemente
indipendenti. Quando una pillola non funziona
come pubblicizzato e viene ritirata dal
mercato o rietichettata come pericolosa c'è
spesso un percorso di ricerche deviate e di
compensi per gli scienziati. Per esempio
diversi anni fa, quando i pazienti hanno
cominciato a citare in giudizio Wyeth per un
altro farmaco basato su estrogeni, Prempro
(che è stato correlato al rischio di tumore al
seno, ictus e altre malattie), gli accordi di
Wyeth per l'attività di ghostwriting e firma
di articoli previo pagamento sono diventati
una parte centrale del caso.
Anche quando è stata la volta
dell'analgesico Vioxx, prodotto da Merck e che
era stato collegato a infarto e ictus, è
emerso il problema del denaro delle case
farmaceutiche. In uno studio sul Vioxx, per
esempio, sembra che alcuni ricercatori
universitari abbiano sottoscritto un progetto
sponsorizzato da Merck dopo che l'azienda
aveva già effettuato tutte le analisi dei
dati. Secondo uno studio del 2010 pubblicato
sul «British Medical Journal», l'87 per cento
dei ricercatori che hanno dato «parere
favorevole» al farmaco per il diabete Avandia,
prodotto da GlaxoSmithKline, sebbene ci
fossero indicazioni sul fatto che potesse
aumentare il rischio di infarto, avevano
rapporti finanziari con il produttore del
farmaco. E quando una commissione della Food
and Drug Administration statunitense ha
iniziato a valutare se ritirare o meno Avandia
dal mercato a causa del collegamento con gli
episodi di infarto è emerso anche che alcuni
membri della commissione prendevano denaro
dalle case farmaceutiche.
La risposta della comunità scientifica al
problema del conflitto di interesse è:
trasparenza. Riviste specialistiche,
istituzioni che finanziano la ricerca e
organizzazioni professionali fanno pressione
sui ricercatori affinché dichiarino
apertamente - ai soggetti delle loro ricerche,
ai colleghi e a chiunque altro sia coinvolto
nelle loro attività - quando hanno rapporti
che potrebbero compromettere la loro
obiettività. In questo modo è la comunità
scientifica a decidere se uno studio è etico
e, una volta che l'esperimento è stato
effettuato, fino a che punto fidarsi dei
risultati. È un sistema basato sull'onore. I
ricercatori spesso omettono di riferire
conflitti di interesse, a volte perché non si
rendono nemmeno conto del fatto che questo è
un problema. (Anche «Scientific American»
chiede che sia rilasciata una dichiarazione
volontaria sui conflitti di interesse da parte
dei ricercatori che scrivono gli articoli).
In teoria, c'è un sistema di riserva.
Diversi livelli di controllo dovrebbero
garantire che siano scoperti e resi pubblici i
conflitti di interesse anche quando un
ricercatore inconsapevole o disonesto non li
dichiara. Quando uno scienziato non riferisce
dell'esistenza di un simile conflitto è
compito dell'università o dell'ospedale in cui
lavora scoprirlo e comunicarlo. E quando
un'università, o un ospedale, non fa il suo
lavoro individuando ricerche con conflitti di
interesse, allora dovrebbe scendere in campo
l'agenzia governativa che finanzia la maggior
parte di questi studi, come gli statunitensi
National Institutes of Health (NIH).
Purtroppo il sistema di riserva fa acqua da
tutte le parti. «Spesso le istituzioni
ragionano in modo opposto, oppure hanno
politiche abbastanza deboli», dice Adriane
Fugh-Berman, professore al Dipartimento di
farmacologia e fisiologia della Georgetown
University. Più incredibile ancora è
constatare che gli NIH, oltre a non far
rispettare norme etiche pensate per fermare la
strisciante influenza del denaro delle case
farmaceutiche, potrebbero addirittura violare
quelle stesse norme.
Il Parlamento degli Stati Uniti cerca di
fermare la corruzione nel campo della ricerca
medica attraverso l'approvazione di nuove
leggi. Nel 2010, nell'ambito di un pacchetto
di riforme sulla sanità, il Parlamento ha
approvato il Physician Payments Sunshine Act.
A partire dal 2013 la legge imporrà alle case
farmaceutiche e ai produttori di dispositivi
medicali di dichiarare la maggior parte dei
soldi che versano nelle tasche dei medici.
Dato che la maggior parte dei medici che fanno
ricerca si occupano anche di pratica clinica,
questi dati dovrebbero aiutare università e
ospedali dove si fa ricerca e gli NIH a
scoprire i casi in cui il medico che riceve un
finanziamento ha un potenziale conflitto di
interesse. Tuttavia, se non saranno usate, le
informazioni andranno sprecate.
Il caso di Robert Lindsay mostra quanto sia
grave il problema delle ricerche mediche che
hanno conflitti di interesse, e quanto sarà
difficile rimediare.
Un intrico di rovi
Spesso gli sforzi che le case farmaceutiche
compiono per influenzare le conferenze
scientifiche iniziano dal ghostwriting. Quando
un produttore farmaceutico riesce a
indirizzare la stesura di un articolo è anche
in grado di controllare, in gran parte, il
modo in cui un risultato scientifico è
compreso e usato dagli specialisti clinici e
dai ricercatori.
Uno degli articoli più prestigiosi di
Lindsay, pubblicato nel 2002 e in cui si
dimostrano gli effetti benefici del Prempro su
donne in postmenopausa, venne inizialmente
redatto da DesignWrite, azienda che era stata
ingaggiata da Wyeth per scrivere per conto
terzi articoli destinati alla pubblicazione su
riviste peer reviewed. Dopo aver incontrato
Lindsay a metà aprile 2001 per discutere
l'impostazione dell'articolo, DesignWrite
elaborò una scaletta e la spedì a Lindsay (e
Wyeth). DesignWrite spedì una bozza a Lindsay
all'inizio di giugno per avere i suoi
commenti, effettuò analisi aggiuntive e
corresse il manoscritto. In agosto il «Journal
of the American Medical Association» (JAMA)
approvò la pubblicazione. Successivamente,
nello stesso anno, DesignWrite modificò
nuovamente l'articolo in risposta ai commenti
ricevuti, e il lavoro fu pubblicato nel maggio
2002. Alla fine dell'articolo, Lindsay e i
suoi tre coautori ringraziarono Karen
Mittleman per il suo aiuto editoriale, senza
dichiarare che la donna era una dipendente di
DesignWrite o senza rivelare i suoi rapporti
con Wyeth.
Lindsay nega che DesignWrite abbia avuto un
ruolo di rilievo nella stesura dell'articolo
del 2002 o di tutte le altre sue versioni.
L'azienda, piuttosto, si sarebbe limitata
semplicemente a «fornire una bozza seguendo le
nostre indicazioni», ha dichiarato lo
scienziato. Insieme agli altri coautori citati
nel lavoro, era responsabile della concezione
e della direzione presa dallo studio. Se così
fosse, Lindsay meriterebbe di essere citato
come coautore e a Karen Mittleman non dovrebbe
essere riservato nulla più che un breve
riconoscimento, secondo quanto afferma Phil B.
Fontanarosa, direttore esecutivo di «JAMA».
«Non è chiaro se le attività di Mittleman
abbiano incluso concezione e progettazione
dello studio, acquisizione dei dati o la loro
analisi e interpretazione», mi ha scritto
Fontanarosa in una e-mail.
Questo uso di un'azienda esterna incaricata
della stesura degli articoli non è stato un
episodio isolato. Nel 2009 Kathleen Ohleth,
che all'epoca lavorava per DesignWrite, ha
aiutato Lindsay a scrivere un articolo per la
rivista «Fertility and Sterility». (Dopo la
mia intervista iniziale Lindsay si è rifiutato
di rispondere a ulteriori domande, incluse
quelle relative a chi ha pagato Ohleth nel
2009, e mi ha indirizzato a un addetto
stampa). Anche due anni dopo, in un articolo
pubblicato su «Osteoporosis International»,
Lindsay ha ringraziato Ohleth per la sua
assistenza nella scrittura dell'articolo e ha
ammesso che lo studio era stato finanziato da
Pfizer (che nel 2009 aveva acquisito Wyeth),
ma ha dichiarato di «essere l'unico autore
responsabile della concezione e della
direzione presa dal contenuto dell'articolo».
In particolare l'articolo affermava che un
gruppo di ormoni in fase di sviluppo presso
Pfizer offriva «un nuovo paradigma per la
terapia della menopausa».
Nello stesso periodo in cui Lindsay
accettava l'aiuto redazionale di Pfizer,
stringeva anche un gran numero di accordi di
natura economica che ponevano un potenziale
conflitto di interesse. Secondo una banca dati
compilata dal gruppo di giornalismo
investigativo ProPublica, nel 2009 e nel 2010
Eli Lilly ha dato a Lindsay più di 124.000
dollari, la maggior parte dei quali per le sue
prestazioni in qualità di conferenziere.
La maggior parte delle riviste peer reviewed
ha regole precise riguardo alle dichiarazioni
di rapporti di natura economica. Per la
precisione, quello che uno scienziato deve
rendere noto dipende dalla materia in oggetto
e dalla rivista, quindi è difficile
individuare con esattezza quando un
ricercatore viola queste regole. Lindsay ha
reso pubblici i suoi rapporti con Lilly in un
gran numero di articoli, ma non lo ha fatto in
modo uniforme. Per esempio, in un articolo che
riguardava uno studio sull'osteoporosi,
pubblicato nel settembre 2010 dalla rivista
«Mayo Clinic Proceedings», molti degli autori
hanno dichiarato di essere nello speakers
bureau, o di avere altre forme di rapporto con
l'azienda; Lindsay tuttavia, pure lui fra i
coautori, non ha fatto alcuna dichiarazione in
questo senso. In seguito mi ha detto che aveva
cambiato idea riguardo alla dichiarazione di
questo tipo di rapporti: «Fino a poco tempo fa
le mie dichiarazioni includevano qualsiasi
casa farmaceutica i cui prodotti sono citati
nelle mie presentazioni» o negli articoli, ha
spiegato. «Ho cambiato un po' questa
filosofia, perché ora, per garantire che ci
sia una reale chiarezza, dichiarerei tutti i
contatti».
Nemmeno nei casi in cui l'oggetto dello
studio era un prodotto di Lilly Lindsay
rivelava sempre il suo rapporto economico con
l'azienda. Lo studio che ha pubblicato nel
2008 sul «Journal of Clinical Endocrinology
and Metabolism», che riguardava il
teriparatide, principio attivo alla base del
Forsteo, commercializzato da Lilly, e la
possibilità che interferisse con altri farmaci
contro l'osteoporosi, non citava il fatto che
Lindsay, negli anni precedenti, avesse
ricoperto il ruolo di consulente e
conferenziere per il produttore di Forsteo.
«Dato che in questo studio tutti erano stati
trattati con il teriparatide, non c'era la
possibilità di creare un conflitto», ha
sostenuto Lindsay. «E, naturalmente, lo studio
non era stato finanziato in alcun modo da Eli
Lilly».
La dichiarazione incoerente di Lindsay va
ben oltre gli articoli. Come eminente
ricercatore, ha avuto un ruolo chiave nella
pubblicazione delle linee guida che altri
medici usano per curare l'osteoporosi. Nel
2008, per esempio, ha contribuito a sviluppare
e scrivere Clinician's Guide to Prevention and
Treatment of Osteoporosis, della statunitense
National Osteoporosis Foundation. La guida,
che è stata sottoscritta da numerose
associazioni mediche, descrive le diverse
opzioni terapeutiche, incluso il teriparatide.
(«Il teriparatide è in genere ben tollerato,
sebbene alcuni pazienti avvertano crampi agli
arti inferiori e vertigini», si legge). In
un'apposita sezione la guida riporta che
nessuno degli autori, Lindsay compreso, ha «un
rapporto finanziario di rilievo con un
qualsiasi interesse commerciale».
Inoltre, apparentemente Lindsay ha omesso di
citare questi potenziali conflitti quando ha
fatto domanda per ricevere finanziamenti
federali. Sebbene almeno dal 2004 fosse
consulente di Lilly, nel 2005 ha chiesto agli
NIH - l'agenzia statunitense responsabile
della maggior parte della ricerca medica
nazionale sostenuta dal governo federale - di
finanziare uno studio sul Forsteo: Lindsay
voleva effettuare biopsie di pazienti per
vedere in che modo il farmaco incideva sulla
loro struttura ossea. Ha ottenuto il
finanziamento. Negli anni successivi gli NIH
hanno finanziato gli studi di Lindsay sul
farmaco con 3,4 milioni di dollari. Nel 2010
il ricercatore ha fatto domanda per un nuovo
finanziamento per confrontare due modalità di
somministrazione del Forsteo. Ancora una volta
ha ottenuto il denaro, questa volta 364.000
dollari per il 2010 e ulteriori 345.000
dollari per il 2011.
I regolamenti federali sui potenziali
conflitti di interesse nei finanziamenti
erogati dagli NIH stabiliscono che chi riceve
i fondi debba identificare qualsiasi conflitto
di interesse reale o apparente, e dichiarare
in che modo questi eventuali conflitti sono
stati gestiti, ridotti o eliminati. Il mancato
rispetto di queste norme è una violazione
della legge. Sembra abbastanza chiaro, ma in
pratica non lo è affatto. La responsabilità
dell'applicazione dei regolamenti passa da
un'istituzione all'altra, fino al punto che
spesso conflitti come quello di Lindsay
sfuggono dalle crepe del sistema.
Segui il denaro
Ogni anno gli NIH finanziano la ricerca
medica con decine di miliardi di dollari. Con
tutto questo denaro in gioco il rischio di
corruzione è enorme. Gli NIH non sono molto
abili nell'arrestare la corruzione, perché non
sono sufficientemente aggressivi nello
scoprire i conflitti di interesse dal lavoro
dei propri scienziati. Quando li ho contattati
nell'ambito di questa inchiesta per avere
informazioni sulle potenziali falle nelle
regole etiche, i funzionari degli NIH hanno
serrato le fila.
Interrogato su possibili conflitti di
interesse nei finanziamenti ricevuti da
Lindsay per studiare il teriparatide, Faye
Chen, funzionario degli NIH, si è rifiutato di
fornire copie delle assicurazioni scritte
dall'Helen Hayes Hospital, datore di lavoro di
Lindsay - una documentazione richiesta delle
leggi federali - in cui si affermava che i
conflitti di interesse erano stati
adeguatamente gestiti. Chen ha continuato ad
affermare che era tutto in ordine. «L'impegno
degli NIH è conservare la fiducia del pubblico
sul fatto che le ricerche finanziate
dall'agenzia sono condotte senza pregiudizi e
secondo i più elevati standard scientifici ed
etici», mi ha scritto in una email. E ha
aggiunto: «Posso assicurarle che l'ente del
Dr. Lindsay ha fornito le certificazioni
richieste e le necessarie garanzie prima di
ricevere il finanziamento, e che verrà chiesto
loro di fornire questa certificazione ogni
anno prima di ciascuna nuova assegnazione». I
documenti ottenuti con una richiesta basata
sul Freedom of Information Act non facevano
cenno ad alcun potenziale conflitto di
interesse, niente che indicasse che Lindsay
riceveva denaro dal produttore del farmaco in
fase di studio. I funzionari degli NIH non
hanno rilasciato commenti sul fatto che
avrebbero continuato o meno a seguire la
questione.
Le azioni degli NIH non dovrebbero
sorprendere. Alcuni anni fa l'ufficio
dell'ispettorato generale del Department of
Health and Human Services ha messo le mani su
comunicazioni interne degli NIH in cui si
scopre che i dirigenti scoraggiano le
inchieste sui conflitti di interesse fra i
ricercatori finanziati dagli NIH.
(Nell'interesse della trasparenza: mia moglie
lavora per l'ufficio dell'ispettorato
generale, ma non ha nulla a che vedere con
questi studi o con questo articolo.) Per
esempio, un memorandum affermava: «Non
dovremmo cercare ulteriori dettagli sulla
natura del conflitto di interesse o sul modo
in cui è stato gestito, a meno che non ci sia
una sufficiente preoccupazione programmatica
che induca in questo senso».
Il caso di Lindsay non sembra isolato. In
tutti gli Stati Uniti ci sono scienziati che
conducono ricerche finanziate dal governo e
contemporaneamente prendono denaro da case
farmaceutiche, comportamento che spesso pone
un potenziale conflitto di interesse. Per
avere la percezione della quantità di denaro
che dalle case farmaceutiche finisce nelle
tasche di ricercatori che ricevono
finanziamenti dagli NIH, ho sfruttato una
banca dati che contiene tutti i finanziamenti
erogati dagli NIH tra il 2009 e il 2010, e ho
usato la banca dati ProPublica, che contiene i
pagamenti delle case farmaceutiche, per
identificare quali ricercatori fossero sul
libro paga dei produttori di farmaci. Nel solo
Stato di New York abbiamo identificato
pagamenti per 1,8 milioni di dollari erogati
da poche aziende a beneficiari di
finanziamenti degli NIH: si trattava di
pagamenti per prestazioni effettuate negli
speakers bureau, per consulenze e altri
servizi. (Probabilmente il totale dei
finanziamenti dati a ricercatori dello Stato
di New York è molto più grande). Molti di
questi pagamenti potrebbero non creare alcun
reale conflitto di interesse.
I ricercatori che ottengono un finanziamento
dagli NIH non sono i soli a prendere denaro
dalle case farmaceutiche: ci sono anche le
persone che decidono quali ricercatori debbano
ricevere i finanziamenti degli NIH. La banca
dati ProPublica con cui ho identificato i
pagamenti delle aziende a ricercatori
finanziati dagli NIH mi ha anche permesso di
individuare il flusso di denaro proveniente
dalle aziende e diretto alle tasche dei membri
delle commissioni consultive e di revisione e
valutazione degli NIH. In questo modo abbiamo
scoperto che 70 membri di commissioni
consultive percepivano una somma superiore a
un milione di dollari per partecipazioni a
speakers bureau, consulenze e altri servizi
prestati alle case farmaceutiche. Alcuni di
questi pagamenti potrebbero violare le regole
etiche federali, che vietano ai membri delle
commissioni consultive di partecipare a
decisioni che potrebbero influire su
un'organizzazione dalla quale ricevono
cospicue remunerazioni.
Il problema, dunque, non si limita ai
ricercatori che ricevono i finanziamenti degli
NIH. Il denaro proveniente dalle case
farmaceutiche si è infiltrato negli stessi
NIH. Se l'agenzia fosse a conoscenza dei
potenziali conflitti d'interesse dei suoi
dipendenti e non facesse nulla per garantire
che questi conflitti non incidano sulle
decisioni dei comitati, violerebbe la legge.
Per scoprirlo ho compilato una richiesta
secondo il Freedom of Information Act
chiedendo di consultare la documentazione che
indicava se gli NIH sapessero, o meno, di
pagamenti delle case farmaceutiche ai membri
dei propri comitati e, in caso di risposta
affermativa, se consentissero ai beneficiari
di quei pagamenti di svolgere le proprie
mansioni nonostante fossero sul libro paga di
un produttore di farmaci. Gli NIH si sono
rifiutati di consegnare questi documenti. Li
ho citati in giudizio, e dopo una causa durata
nove mesi un giudice federale ha costretto
l'agenzia a rilasciare tutto ciò che aveva
cercato di tenere nascosto.
Alcuni dei documenti ottenuti grazie al
procedimento legale implicano che la politica
interna degli NIH sul conflitto di interesse è
in gran parte dedicata a scoprire moduli
mancanti. Inoltre, da questi documenti
sembrerebbe che diversi istituti degli NIH non
abbiano mai avviato neppure una singola azione
di sostegno all'applicazione di norme contro
il conflitto di interesse nei confronti dei
propri impiegati fin dal 2008. Eppure i
documenti più significativi, quelli che gli
NIH hanno cercato disperatamente di tenere
nascosti, hanno a che fare con quelli che sono
definiti «accordi (o atti) di rinuncia».
In circostanze limitate, gli NIH possono
concedere un atto di rinuncia. ovvero un atto
che esenta un impiegato governativo in
conflitto (per esempio un membro di un
comitato consultivo) dal rispetto di norme
etiche. Ho chiesto informazioni sugli accordi
di rinuncia che erano stati concessi a diversi
membri dei comitati consultivi degli NIH,
persone che conoscevo dalla banca dati
ProPublica e da altre fonti, e che avevano
ricevuto migliaia di dollari dalle case
farmaceutiche. Volevo scoprire perché gli NIH
permettevano a queste persone di far parte di
comitati nonostante un potenziale conflitto e,
informazione altrettanto importante, quale
fosse la natura di questi conflitti.
La maggior parte dei pagamenti provenienti
dalle case farmaceutiche non era citata in
quei documenti. Per esempio Louis Ptàcek, che
all'epoca era membro del National Advisory
Neurological Disorders and Stroke Council,
aveva ottenuto il permesso di partecipare a un
certo numero di riunioni, nonostante
possedesse numerose azioni di case
farmaceutiche, ma l'atto di rinuncia non
citava il fatto che avesse ricevuto oltre
50.000 dollari da Pfizer in qualità di
consulente. (Ptàcek non ha risposto a una
richiesta di commento sulla faccenda.)
Analogamente un atto di rinuncia per Arul
Chinnaiyan, che fa parte del comitato
scientifico del National Cancer Institute, non
ha reso noto negli atti il fatto che avesse
ricevuto 9000 dollari nel 2009 e 21.000
dollari nel 2010 da GlaxoSmithKline. Ma
Chinnaiyan ha detto di aver comunicato questi
accordi agli NIH. Perché, allora, non sono
stati citati nel suo atto di rinuncia?
Gli NIH non hanno fatto commenti su casi
individuali. Un funzionario dell'agenzia ha
accettato di parlare della politica generale,
ma solo a condizione di non essere nominato.
In generale i compensi per le prestazioni di
consulenza e per gli accordi degli speakers
bureau, mi ha spiegato questa persona, non
sono inseriti in un atto di rinuncia, ma in un
documento separato che tratta di problematiche
specifiche relative a quali membri del
comitato debbano astenersi dalle proprie
funzioni a causa di conflitti di interesse.
Quando questo articolo è andato in stampa
Susan Cornell, funzionario del Freedom of
Information Act presso gli NIH, ha confermato
che l'agenzia non era riuscita a consegnare
documenti riguardanti alcune astensioni per
conflitto di interesse in risposta alla mia
richiesta basata sul Freedom of Information
Act, come invece avrebbe dovuto fare.
La divulgazione incoerente di documenti da
parte degli NIH e la segretezza che li
circondava hanno reso impossibile stabilire
con certezza che cosa stava accadendo. Come
minimo, nel controllare i potenziali
conflitti, gli NIH fanno un lavoro
approssimativo. Per esempio, se accordi di
consulenza appartengono a un documento di
astensione, come mai gli accordi di consulenza
stipulati fra Lawrence R. Stanberry e
GlaxoSmithKline compaiono sui suoi atti di
rinuncia? (Stanberry, direttore del
Dipartimento di pediatria del College of
Physicians and Surgeons della Columbia
University siede nel comitato dei consulenti
scientifici del National Institute of Allergy
and Infectious Diseases). E come mai la
rinuncia non include il lavoro di consulenza
che Stanberry ha svolto per conto di SanofiPasteur? «Non so perché la consulenza a
Sanofi-Pasteur non è stata inserita nella
rinuncia», mi ha scritto Stanberry in una email. Forse i funzionari incaricati di
produrre i documenti relativi alla rinuncia
hanno fatto degli errori.
Applicare le regole: il gioco delle tre carte
Le informazioni ottenute con un'altra
richiesta sempre secondo il Freedom of
Information Act, questa volta presentata
all'Office of the Government Ethics l'agenzia incaricata di garantire che le
agenzie governative come gli NIH seguano le
regole etiche - implicano che gli NIH non
rispettano le regole federali sugli atti di
rinuncia.
Dal punto di vista del governo, concedere
una rinuncia è una questione seria;
sostanzialmente significa garantire l'immunità
da una legge, ed è un provvedimento che
dovrebbe essere attuato soltanto di rado e con
una supervisione rigorosa. Le regole federali
impongono che gli NIH debbano confrontarsi con
l'Office of the Government Ethics prima di
concedere questi privilegi. Negli ultimi anni
gli NIH hanno rilasciato decine di rinunce
simili a favore di membri dei comitati
consultivi, ma dal 2005 l'ufficio etico ha
documentato solo tre episodi in cui gli NIH si
sono consultati con l'ufficio, come richiesto,
e nessuna delle rinunce in questione
riguardava un membro di un comitato
consultivo. Ho chiesto spiegazioni a
funzionari dell'agenzia, i quali hanno
risposto che gli NIH erano perfettamente in
linea con i regolamenti federali nei casi in
cui si trattava di rilasciare atti di
rinuncia, ma non hanno fornito prove del fatto
che l'agenzia si consultava con l'Office of
the Government Ethics quando rilasciava queste
rinunce, come richiesto dalla legge.
Le istituzioni che gestiscono finanziamenti
dovrebbero fornire un ulteriore controllo sul
conflitto di interesse, ma in realtà non lo
fanno. Storicamente gli NIH non si sono
assunti la responsabilità di controllare i
conflitti di interesse nelle ricerche che
finanziano. Nel 2007, in risposta a un reclamo
dell'Office of Inspector General riguardo il
fatto che la gestione dei conflitti di
interesse da parte dei National Institutes of
Health era tragicamente inadeguata, Elias
Zerhouni, che allora dirigeva l'agenzia, ha
dichiarato che non era compito degli NIH
stabilire se i beneficiari dei suoi
finanziamenti rispettavano le leggi etiche.
«Riteniamo che sia fondamentale mantenere
l'obiettività nelle ricerche», ha scritto in
una lettera all'Office of Inspector General,
«tuttavia le responsabilità per
l'identificazione dei conflitti di interesse
di natura finanziaria devono rimanere a carico
degli istituti per cui lavorano i beneficiari
dei finanziamenti». I funzionari degli NIH
affermano che la politica non è cambiata.
E tuttavia anche gli istituti dei
beneficiari hanno esempi di casi in cui non
sono stati affrontati problemi di natura etica
che coinvolgevano i loro ricercatori. Un
rapporto del 2009 dell'Office of Inspector
General ha analizzato il modo in cui le
organizzazioni che ricevono finanziamenti
dagli NIH scoprono potenziali conflitti di
interesse. Il 90 per cento lasciava alla
discrezione del ricercatore l'identificazione
di qualsiasi problema. Addirittura le
istituzioni che sposano pubblicamente una
linea dura contro i conflitti di interesse
sono spesso deboli nell'imporre le proprie
politiche. Alla fine del 2010 ProPublica ha
utilizzato la propria banca dati di case
farmaceutiche per controllare la Stanford
University e diverse altre università con
solide politiche contro il conflitto di
interesse, scoprendo che decine di docenti
percepivano denaro da queste aziende in
violazione delle regole delle istituzioni di
appartenenza.
L'Helen Hayes Hospital, dove lavora Lindsay,
non sembra far rispettare rigorosamente le
regole. Senza dubbio l'organizzazione è
complessa, è una struttura statale, dunque il
Department of Health dello Stato di New York
ha diversi interessi in gioco, e tutti i suoi
finanziamenti sono gestiti attraverso la
Health Research Inc., organizzazione no-profit
che aiuta il Department of Health a ottenere
fondi esterni per la ricerca medica. Health
Research Inc. gestisce mezzo miliardo di
dollari all'anno di finanziamenti. Tuttavia è
sorprendente il fatto che con così tanti fondi
e tanto denaro in gioco Health Research Inc.
non scopra numerosi casi di conflitti di
interesse ogni anno. «Ho lavorato qui come
direttore di programmi sponsorizzati per 11
anni, e sono stato dipendente di Health
Research Inc. nell'ufficio che amministrava i
fondi per 17 anni. Non ho mai visto un
conflitto di interesse», mi ha detto Terry
Dehm, di Health Research Inc. «Non un singolo
conflitto di interesse in nessuno dei
finanziamenti per i quali abbiamo fatto
richiesta... Semplicemente, non ne abbiamo mai
visti».
Quando le ho spiegato che il finanziamento
ricevuto da Lindsay dagli NIH per studiare
Forsteo, finanziamento gestito da Health
Research Inc., attirava anche denaro dal
produttore del farmaco che Lindsay stava
studiando grazie a fondi federali, Dehm mi ha
risposto che il direttore esecutivo di Health
Research Inc., Michael Nazarko, mi avrebbe
chiamato quel pomeriggio o il giorno dopo. Non
lo ha mai fatto, né ha mai risposto ai
ripetuti tentativi di far seguito alla
questione. Alla fine, tramite un addetto
stampa del Department of Health di New York,
Nazarko si è rifiutato di rispondere a
qualsiasi domanda, e lo stesso hanno fatto Val
Gray, amministratore delegato dell'Helen Hayes
Hospital, e Felicia Cosman, direttore delle
ricerche cliniche all'Helen Hayes Hospital.
Secondo ProPublica, Cosman ha ricevuto
finanziamenti dagli NIH per studiare il
farmaco Forsteo nonostante avesse ottenuto
135.000 dollari da Eli Lilly per tenere
conferenze e per consulenze. Quando ho chiesto
un commento, Helen Hayes Hospital e HRI mi
hanno spedito per e-mail una copia delle loro
politiche sul conflitto di interesse e un
comunicato in cui si affermava che, con
entrambi i finanziamenti di Lindsay e Cosman,
«le procedure descritte nel documento sulle
politiche aziendali contro il conflitto di
interesse erano state rispettate».
Qualche giorno dopo una mia telefonata
all'Helen Hayes Hospital per chiedere
informazioni sul lavoro di Lindsay e su
potenziali conflitti di interesse, sono stato
contattato da funzionari dell'ospedale per
effettuare una revisione etica del lavoro di
Lindsay. All'inizio l'ospedale ha cercato di
trovare una commissione indipendente per
esaminare se nel lavoro di Lindsay ci fossero
conflitti a causa dei suoi rapporti con Lilly.
Tuttavia, visto che la ricerca era vana, alla
fine l'ospedale avevo deciso di chiedere al
proprio Institutional Review Board (IRB) di
dare un'occhiata. (Lindsay è membro di questa
commissione, ma non ha partecipato alle
discussioni). L'Institutional Review Board ha
scoperto che Lindsay aveva ricevuto
significative somme di denaro da Lilly, ma che
questi compensi non ponevano alcun conflitto
di interesse. Sono venuto a conoscenza di
questi procedimenti nei mesi successivi, dopo
aver fatto ricorso alla New York State's
Freedom of Information Law per informarmi su
documenti relativi ai finanziamenti.
Purtroppo un IRB - che viene istituito per
approvare i protocolli di ricerca in un trial
clinico e garantire che i pazienti vengano
curati in modo appropriato - è mal
equipaggiato per rispondere a domande sui
conflitti di interesse di natura finanziaria.
«La composizione di un IRB non è stata pensata
per gestire conflitti di interesse nel mondo
di oggi», dice Arthur Caplan, del Langone
Medical Center della New York University
(nonché membro del comitato scientifico di
«Scientific American»), uno dei maggiori
esperti di bioetica al mondo: «È abbastanza
chiaro che questa persona all'Helen Hayes
Hospital ha un grave conflitto di interessi»,
dice Caplan. Carl Elliott, dell'Università del
Minnesota, concorda. «L'IRB non era l'organo
giusto a cui chiedere un'opinione», mi ha
scritto in un'e-mail.
In ogni caso, l'Helen Hayes Hospital non è
attrezzato per eliminare alla radice i
conflitti. Gli avvocati dell'ospedale si sono
adattati al linguaggio standard delle linee
guida dei finanziamenti degli NIH, che, fra le
altre cose, chiedono a un ricercatore di
riferire «qualsiasi fatto collegato con
interessi finanziari, in denaro o in altro
genere di benefici, ricevuti dallo sponsor di
una ricerca (per esempio gettoni di
consulenza, onorari, viaggi, pasti o
divertimenti)». La clausola inserita restringe
l'ambito di quello che deve essere dichiarato.
Visto che Lilly non è lo sponsor delle
ricerche di Lindsay, ma lo sono gli NIH, in
base a queste linee guida i pagamenti
effettuati dall'azienda non sembravano
rientrare nel conflitto di interesse.
Di fatto, è difficile evocare una
circostanza in cui il beneficiario di un
finanziamento degli NIH possa avere un
conflitto di interesse sulla base di regole
stabilite dall'Helen Hayes Hospital. Non c'è
ragione di pensare che l'ospedale sia speciale
in questo contesto. Le istituzioni che
gestiscono fondi non hanno uno stimolo reale
per preoccuparsi dei conflitti. Tanto più
denaro da finanziamenti ricevono i loro
dipendenti, tanto meglio è per i dipendenti
stessi. Perché preoccuparsi?
Aggiustare il sistema
I ricercatori non possono frenare
l'influenza del denaro che proviene dalle case
farmaceutiche. Gli ospedali e le università
non lo faranno. Gli NIH si rifiutano di farlo.
Come risultato, milioni di dollari provenienti
dai contribuenti finanziano ricerche la cui
obiettività è sospetta. Il Parlamento degli
Stati Uniti, che tiene i cordoni della borsa,
è fuori di sé.
La maggior parte delle sue ire è diretta
agli NIH, che ha anche richiamato per il fatto
di non seguire le linee guida etiche. «Per gli
anni che ho trascorso come presidente di
questo sotto-comitato, conosco fin troppo bene
l'atteggiamento che spesso caratterizza gli
NIH: queste regole non si applicano alla
nostra agenzia», ha detto nel 2004 Joe Barton,
delegato del Texas, all'epoca presidente
dell'House Energy and Commerce Committee, in
un'audizione sulle mancanze etiche degli NIH.
«Ci si può solo chiedere: se gli NIH possono
essere così permissivi sulle regole etiche più
fondamentali del governo federale, che cosa
deduciamo a proposito della loro capacità di
gestire i denari dei contribuenti e,
soprattutto, di garantire che la ricerca
finanziata dai contribuenti venga tradotta in
cure?», ha aggiunto. Eppure l'atteggiamento
continua anche dopo che il Parlamento ha
esercitato una pressione maggiore sugli NIH
affinché si rimettano in carreggiata.
A partire dal 2008 Charles Grassley,
senatore dell'Iowa, ha avviato una serie di
interrogazioni parlamentari relative ad alcuni
episodi in cui i beneficiari di fondi degli
NIH hanno omesso di dichiarare pagamenti
ricevuti dalle case farmaceutiche e in cui le
università hanno fallito nel punire
adeguatamente i ricercatori coinvolti.
L'esempio più clamoroso riguarda il caso di
Charles Nemeroff, che fino a poco tempo fa era
direttore del Dipartimento di psichiatria alla
Emory University. I documenti della Emory
mostravano che già nel 2000 c'erano problemi
sull'opportunità da parte di Nemeroff di avere
legami con l'industria, come quelli relativi
al denaro che riceveva dalla casa farmaceutica
Smith-Kline Beecham, che in seguito sarebbe
diventata GlaxoSmithKline. (L'azienda aveva
anche donato denaro per sovvenzionare una
cattedra nel dipartimento di Nemeroff.) Nel
2003 i ricercatori hanno accusato Nemeroff di
non aver dichiarato i propri legami con i
produttori di tre trattamenti di cui riferiva
un articolo pubblicato da «Nature
Neuroscience».
Come risposta, la Emory ha avviato
un'inchiesta. Nel 2004 l'università ha
stabilito che Nemeroff era, di fatto,
coinvolto in «molti casi di violazione del
conflitto di interesse, consulenza e altre
politiche». Messo di fronte a queste scoperte,
Nemeroff ha accettato di ridurre le proprie
consulenze con GlaxoSmithKline a causa delle
implicazioni che avrebbero potuto avere per un
progetto finanziato dagli NIH su cui stava
lavorando e ha anche accettato di ridurre i
rapporti con diverse altre aziende. Dopo che
nel 2008 un'inchiesta del Parlamento ha
nuovamente portato alla luce un altro
conflitto di interesse, Nemeroff si è dimesso
da direttore del Dipartimento di psichiatria e
la Emory University gli ha vietato per due
anni di chiedere finanziamenti sponsorizzati
dagli NIH. Da allora Nemeroff ha lasciato la
Emory per l'Università di Miami, dove è
attualmente preside della Facoltà di
psichiatria e scienze comportamentali e
responsabile di una nuova ricerca finanziata
con 400.000 dollari dagli NIH.
Dopo queste indagini parlamentari, gli NIH
hanno adottato nuovi ordinamenti in base a cui
i beneficiari dei finanziamenti devono
dichiarare agli istituti di appartenenza ogni
rapporto finanziario che supera i 5000
dollari. Oltre a ciò, le regole impongono alle
istituzioni di fornire una spiegazione
pubblica, per sommi capi, di ogni conflitto di
interesse del personale coinvolto in ricerche
finanziate dagli NIH. Questi cambiamenti
implicano che il pubblico avrà accesso a una
maggiore quantità di informazioni sui bersagli
del denaro proveniente dalle case
farmaceutiche. Francis Collins, direttore
degli NIH, ha elogiato i nuovi regolamenti
definendoli «un messaggio inequivocabile del
fatto che gli NIH sono impegnati a promuovere
l'obiettività nelle ricerche che finanziano».
Comunque, nel nuovo regolamento non c'era
alcun cambiamento su chi fosse responsabile
dell'individuazione di questi conflitti o
della gestione dei problemi etici. «Dato che
le istituzioni conoscono il contesto in cui
lavorano i loro dipendenti, e dato che queste
persone sono dipendenti di istituti di ricerca
e non del governo, la responsabilità della
gestione spetta a loro», dice Sally Rockey,
vice direttore degli NIH per le ricerche extra
moenia. «Le istituzioni si trovano nella
posizione migliore per gestire gli interessi
finanziari dei loro impiegati».
L'unica speranza di risolvere il problema
dei conflitti di interesse nella scienza
risiede negli scienziati stessi. La cultura
della scienza può cambiare. Attraverso le
riviste peer reviewed (la cui reputazione
soffre a causa di una ricerca minata da
preconcetti) e attraverso le accademie
scientifiche (che stabiliscono standard etici
che gli scienziati dovrebbero osservare), i
ricercatori possono esercitare pressioni sui
loro colleghi affinché rinuncino al denaro
delle case farmaceutiche. Come minimo,
potrebbero convincerli che è nel loro
interesse a lungo termine essere trasparenti
sui pagamenti che ricevono dalle aziende.
La speranza di fornire una direzione etica e
di esercitare una pressione fra pari è
rappresentata dalle organizzazioni
professionali e dalle riviste peer reviewed.
Nel settore di Lindsay, questi attori
sarebbero la National Osteoporosis Foundation
e «Osteoporosis International». Ma queste
organizzazioni hanno intenzione di assumere il
comando nell'azione mirata all'eliminazione
dei conflitti di interesse e sono in grado di
farlo? Una persona alla quale porre questa
domanda potrebbe essere l'ex presidente della
National Osteoporosis Foundation, l'attuale
direttore di «Osteoporosis International»:
Robert Lindsay.
Charles Seife
(«Le Scienze» n. 534/13)
La corsa verde dei veicoli ibridi
- Una stima delle rispettive emissioni di
anidride carbonica ha mostrato che i veicoli
ibridi sono più verdi della locomozione umana.
Per sostenere la squadra del cuore, quattro
amici decidono di andare allo stadio
dall'altra parte della città. Emetteranno meno
CO2, se raggiungeranno lo stadio correndo o a
bordo di un'auto ibrida? Nonostante il
carattere ibrido sia del movimento umano sia
delle nuove automobili, la tecnologia dei
nuovi veicoli permette di trasportare quattro
passeggeri in città con minore emissione di
CO2, rispetto agli stessi passeggeri che si
spostano di corsa.
I veicoli ibridi sono alimentati solo a
benzina, ma usano anche altre forme di energia
per muoversi. Durante le inevitabili e
frequenti frenate che capitano in città, parte
dell'energia cinetica del mezzo non è
dissipata in calore come avviene nelle auto
convenzionali, ma si accumula nelle batterie
dopo essere stata convertita da un motore
elettrico. Lo stesso motore riconverte poi
l'energia elettrica accumulata in movimento,
per esempio nelle ripartenze. Per quanto possa
sembrare strano, la locomozione umana, e più
in generale quella animale, ha molte
caratteristiche in comune con la tecnologia
delle auto ibride.
Camminando a velocità costante, bipedi e
quadrupedi si spostano come un pendolo
invertito. Il tipico vincolo con il terreno di
questa modalità locomotoria provoca un
inevitabile innalzamento-abbassamento e
accelerazione-decelerazione del centro di
massa corporeo durante ogni passo. Ogni
periodico cambiamento di stato (altezza,
velocità) dovrebbe essere associato a una
certa energia metabolica spesa, ma la
somiglianza tra la nostra andatura e il
movimento del pendolo invertito permette un
continuo scambio tra energia potenziale e
cinetica del baricentro corporeo. Così, circa
il 60 per cento dell'energia meccanica è
conservata nel corpo, mentre il restante 40
per cento deve essere fornita dai muscoli.
Anche il costo metabolico del cammino, che
corrisponde nelle automobili ai litri di
carburante necessari a percorrere una certa
distanza (per esempio 100 chilometri), è poco
sensibile a più consistenti cambiamenti di
velocità. La meccanica di più ampie
oscillazioni, come accelerazioni-decelerazioni
su più passi, può essere vista come il
risultato della somma degli incrementi e della
somma dei decrementi dell'energia totale a
ogni passo, e può avvenire senza un costo
extrarispetto al cammino alla stessa velocità
media con passi uguali l'uno all'altro. Questo
è il risultato di esperimenti con cicli
oscillatori della durata di sei secondi e
variazioni sinusoidali della velocità di
cammino fino a più 40 per cento.
La corsa, ma anche il trotto e il galoppo
nei quadrupedi, usa un'altra strategia
«ibrida» per contenere i consumi e di
conseguenza le emissioni di CO2. Durante la
prima metà del contatto del piede con il
terreno, l'energia potenziale e quella
cinetica diminuiscono simultaneamente, e una
parte di esse è temporaneamente immagazzinata
nelle strutture elastiche tendinee, che la
restituiscono al baricentro corporeo nella
successiva fase di spinta in modo da ridurre
il lavoro muscolare necessario a generare il
balzo successivo.
Quindi sia la dinamica del cammino sia
quella della corsa incorporano una sorta di
frenata rigenerativa, la stessa strategia
delle più innovative automobili ibride
moderne. Altre analogie includono la molto
simile efficienza muscolare e quella del
motore a scoppio, del 25-28 per cento circa,
che implica una produzione di calore e del
relativo vapore acqueo (due dei maggiori
determinanti dell'effetto serra) analoga nei
due «motori». Anche i tendini e i motori
elettrici, le parti ibride dei due «veicoli»,
hanno un'efficienza simile (rispettivamente 95
e 88 per cento).
L'emissione di anidride carbonica di un
corridore «standard» si può calcolare
conoscendo il suo costo metabolico del
trasporto. Misurazioni sperimentali e modelli
teorici che hanno analizzato i record del
mondo in distanze da 1 chilometro alla
maratona (42,195 chilometri), in genere
stabiliti da atleti di 65 chilogrammi, hanno
rilevato un costo del trasporto di circa 270
joule per metro percorso, indipendentemente
dalla velocità di corsa. Quando correggiamo il
costo per un soggetto di 75 chilogrammi,
otteniamo una produzione di 13,7 millilitri di
CO2 per metro. Considerando che una mole di
CO2 (44 grammi) occupa 24,1 litri in
condizioni standard di pressione e
temperatura, l'emissione di un corridore
«standard» risulta di 25,1 grammi di CO2 per
chilometro. Per confrontare le emissioni
dell'uomo e delle automobili dobbiamo
considerare quattro corridori, i quali
emettono circa 100 grammi di CO2 per
chilometro (un valore di riferimento che
abbiamo chiamato ECO2R).
L'auto con i più bassi consumi disponibile
al momento sul mercato produce circa 87 grammi
di CO2 per chilometro, ma il valore riportato
si riferisce al «ciclo combinato», che è meno
dispendioso del «ciclo urbano», e a un carico
a bordo di 180 chilogrammi, corrispondente a
2,4 passeggeri. Quando questi dati sono
corretti per il «ciclo urbano» e quattro
passeggeri, solo le auto ibride riportano
emissioni inferiori a ECO2R, corrispondente ai
4 corridori. La loro maggiore economia
rispetto ad altre tipologie di veicolo (per
esempio diesel) è dovuta al bassissimo
coefficiente correttivo per il fattore urbano,
alla frenata rigenerativa e al sistema stopand-go, che rendono i consumi delle auto
ibride meno sensibili ai frequenti cambi di
velocità che si verificano in città. C'è una
dozzina di questi modelli sul mercato, e per
il più economico le emissioni nel ciclo urbano
con quattro passeggeri sono di circa 95 grammi
di CO2 per chilometro.
Umani contro automobili
Pare che il muro sia stato infranto: un'auto
ibrida con quattro passeggeri emette meno CO2
rispetto a quanto ne sarebbe emessa se i
passeggeri percorressero di corsa la stessa
distanza in città. Per una strabiliante
coincidenza che potrebbe sembrare dettata da
criteri «fisiologici», uno degli obiettivi
dell'Unione Europea per contenere
l'inquinamento atmosferico è limitare le
emissioni delle automobili a un livello di
poco inferiore a ECO2R, 95 grammi di CO2 per
chilometro, entro il 2020. Altri due
interessanti traguardi per i veicoli del
futuro riguardano la capacità di emettere meno
di quattro persone che camminano e di quattro
ciclisti, che producono aerobicamente 50
grammi di CO2 per chilometro (ECO2W alla
velocità di 5,5 chilometri all'ora) e 25
grammi di CO2 per chilometro (ECO2B, a 30
chilometri all'ora con una bicicletta da
corsa), rispettivamente.
ECO2W è stato già battuto da prototipi che
hanno partecipato alla Shell Eco-marathon
2010, gara mondiale di minimo consumo su pista
che si svolge dal 1939. Un prototipo di
automobile per la città, alimentata a benzina
e costruita dal Liceo francese «Louis Delage»
di Cognac ha percorso 303 chilometri con un
litro di carburante (emissione corrispondente
a 31 grammi di CO2, per chilometro quando si
considerano quattro veicoli con un passeggero
ciascuno). Il team Polyjoule del Polytech
dell'Università di Nantes ha raggiunto il
record d'economia di 4896 chilometri percorsi
con l'equivalente energetico di un litro di
combustibile della loro cella a idrogeno,
corrispondenti a circa 2,8 grammi di CO2 per
chilometro (calcolati per quattro veicoli da
un passeggero!), con un siluro monoposto
carenato.
Nonostante le strategie per contenere il
costo metabolico della locomozione umana e
animale, le ruote sono ruote. La nostra
modalità di contatto con il terreno obbliga a
continui innalzamenti-abbassamenti e
accelerazioni-decelerazioni del centro di
massa, con un inevitabile lavoro muscolare e
un elevato dispendio metabolico. Pur avendo
inventato e affinato la bicicletta, che riduce
al minimo questi problemi propulsivi, la
tecnologia e l'ingegneria del trasporto ora ci
ha battuto, in termini di consumi ed
emissioni, 9 a 1.
Finora abbiamo parlato solo di uomini: la
minore massa media delle donne (-15
chilogrammi rispetto agli uomini) riduce il
fattore di carico delle automobili meno del
fattore metabolico della corsa. Quattro donne
«standard» producono correndo meno CO2 di
un'automobile con quattro donne
indipendentemente dalla tecnologia dell'auto.
Ma la stessa attitudine «verde» dei quattro
uomini in un veicolo ibrido è ottenuta
estendendo a cinque il gruppo delle donne che
corrono o si muovono in automobile.
Non abbiamo trattato l'inquinamento
atmosferico delle auto e la caratteristica non
rinnovabile del carburante fossile, se
confrontata con gli alimenti, che potrebbero
far pendere la bilancia verso la corsa.
Comunque si dovrebbe considerare anche il
costo del trattamento e della distribuzione
degli alimenti: per la stessa quantità di
energia estraibile l'olio d'oliva, per
esempio, è più costoso (200-300 per cento) del
carburante per autotrazione.
L'allievo supera il maestro
L'ingegneria meccanica e dell'autotrazione
ci ha portato a un punto di svolta in cui le
automobili, nonostante la massa elevata, hanno
un'economia del trasporto che sfida i nostri
naturali schemi locomotori (solo i veicoli
elettrici commerciali hanno già battuto anche
ECO2W, anche se probabilmente grazie al minor
costo di produzione dell'elettricità).
L'evoluzione della ricerca, testimoniata dalla
diminuzione esponenziale delle emissioni nelle
competizioni di minimo consumo per prototipi
dal 1939 al 2000, è rallentata negli ultimi
dieci anni.
Se si pensa però ai recenti record e che già
nel 1939 si era arrivati a consumi
(prototipali) vicini agli obiettivi attuali
dell'industria, si capisce che le auto
commerciali hanno ancora ampio spazio per
migliorare la propria economia. La frenata
rigenerativa, la tecnica di stop-and-go,
un'aerodinamica sofisticata e lo studio dei
materiali per pneumatici che minimizza la
resistenza di rotolamento potranno ridurre le
emissioni per unità di distanza percorsa,
anche se probabilmente tra qualche tempo
saremo vicini a un valore limite. In ogni
caso, per ora tra tecnologia e natura
l'allievo, usando inconsapevolmente la
biomimetica, ha superato il maestro.
Alberto E. Minetti
Gaspare Pavei
(«Le Scienze» n. 518/11)