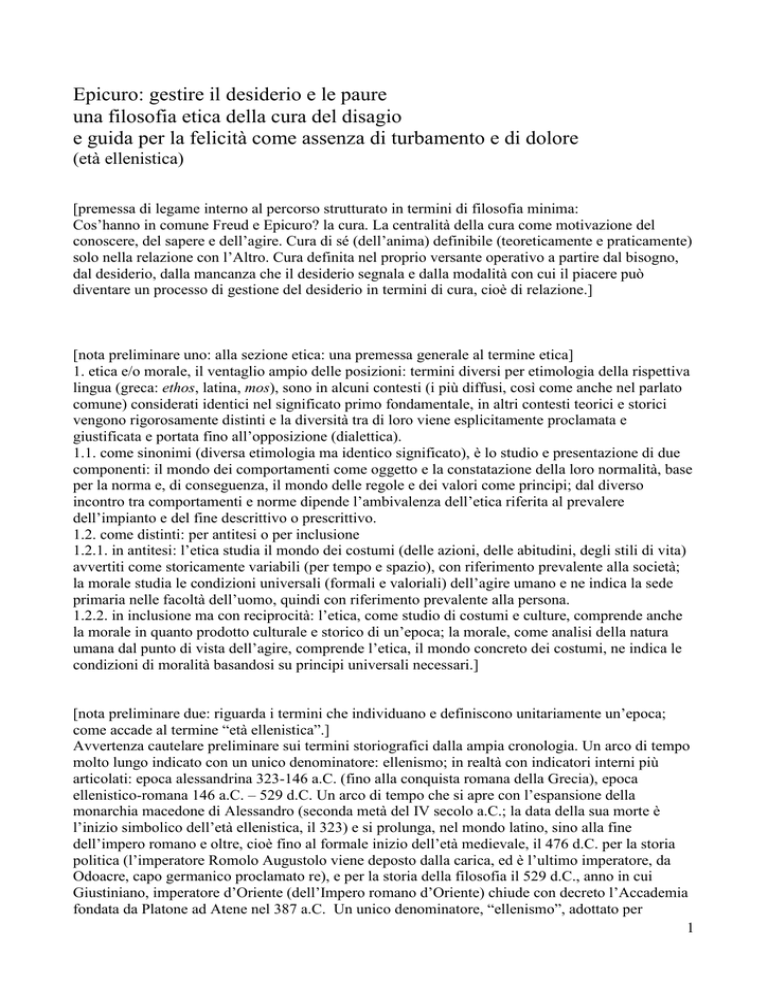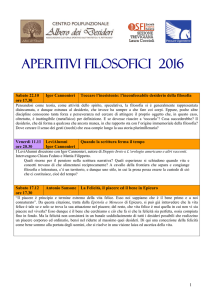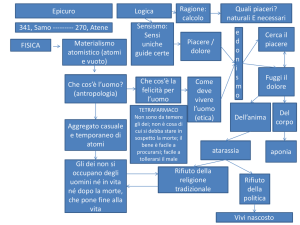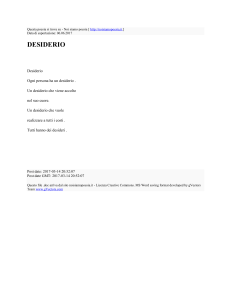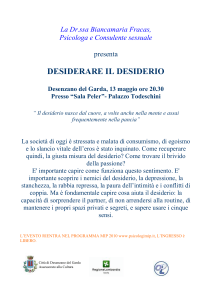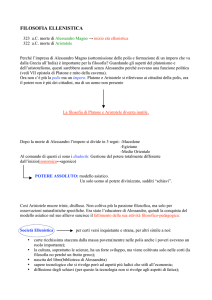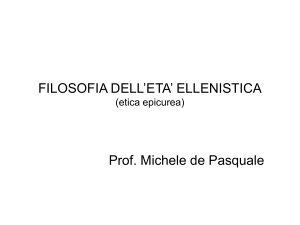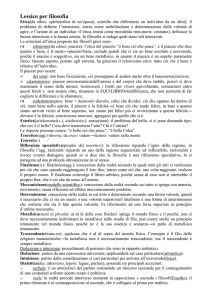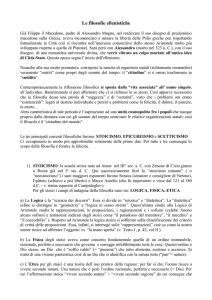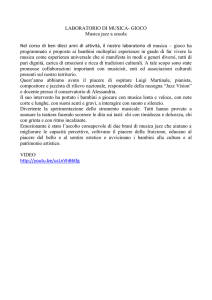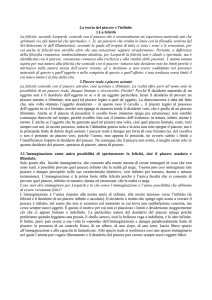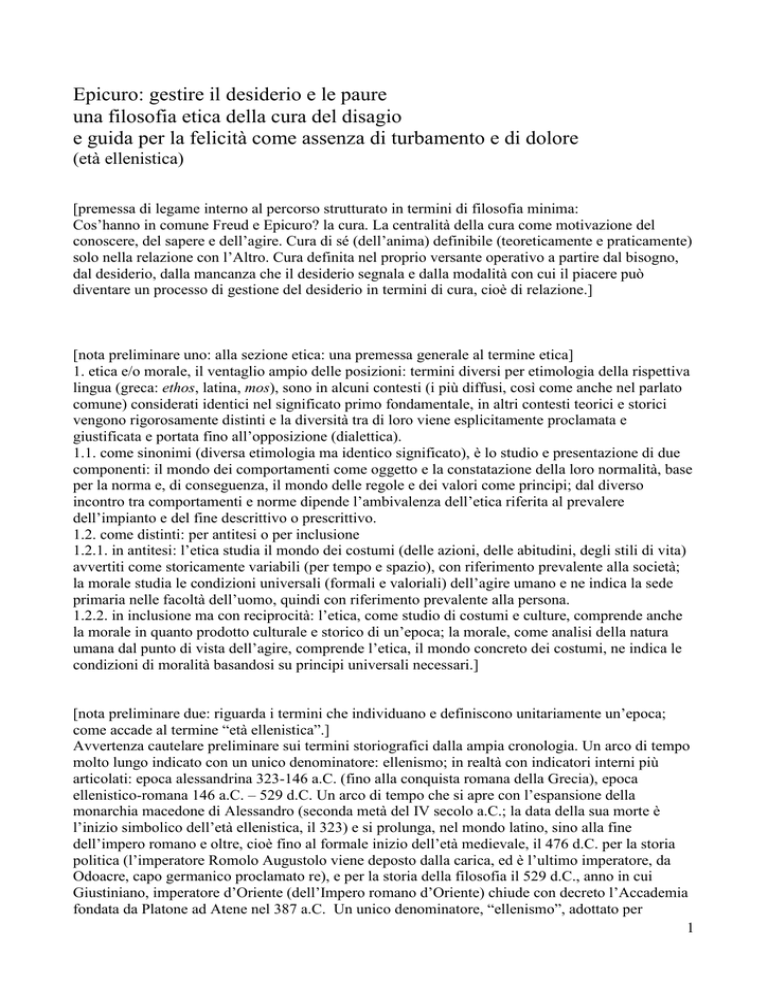
Epicuro: gestire il desiderio e le paure
una filosofia etica della cura del disagio
e guida per la felicità come assenza di turbamento e di dolore
(età ellenistica)
[premessa di legame interno al percorso strutturato in termini di filosofia minima:
Cos’hanno in comune Freud e Epicuro? la cura. La centralità della cura come motivazione del
conoscere, del sapere e dell’agire. Cura di sé (dell’anima) definibile (teoreticamente e praticamente)
solo nella relazione con l’Altro. Cura definita nel proprio versante operativo a partire dal bisogno,
dal desiderio, dalla mancanza che il desiderio segnala e dalla modalità con cui il piacere può
diventare un processo di gestione del desiderio in termini di cura, cioè di relazione.]
[nota preliminare uno: alla sezione etica: una premessa generale al termine etica]
1. etica e/o morale, il ventaglio ampio delle posizioni: termini diversi per etimologia della rispettiva
lingua (greca: ethos, latina, mos), sono in alcuni contesti (i più diffusi, così come anche nel parlato
comune) considerati identici nel significato primo fondamentale, in altri contesti teorici e storici
vengono rigorosamente distinti e la diversità tra di loro viene esplicitamente proclamata e
giustificata e portata fino all’opposizione (dialettica).
1.1. come sinonimi (diversa etimologia ma identico significato), è lo studio e presentazione di due
componenti: il mondo dei comportamenti come oggetto e la constatazione della loro normalità, base
per la norma e, di conseguenza, il mondo delle regole e dei valori come principi; dal diverso
incontro tra comportamenti e norme dipende l’ambivalenza dell’etica riferita al prevalere
dell’impianto e del fine descrittivo o prescrittivo.
1.2. come distinti: per antitesi o per inclusione
1.2.1. in antitesi: l’etica studia il mondo dei costumi (delle azioni, delle abitudini, degli stili di vita)
avvertiti come storicamente variabili (per tempo e spazio), con riferimento prevalente alla società;
la morale studia le condizioni universali (formali e valoriali) dell’agire umano e ne indica la sede
primaria nelle facoltà dell’uomo, quindi con riferimento prevalente alla persona.
1.2.2. in inclusione ma con reciprocità: l’etica, come studio di costumi e culture, comprende anche
la morale in quanto prodotto culturale e storico di un’epoca; la morale, come analisi della natura
umana dal punto di vista dell’agire, comprende l’etica, il mondo concreto dei costumi, ne indica le
condizioni di moralità basandosi su principi universali necessari.]
[nota preliminare due: riguarda i termini che individuano e definiscono unitariamente un’epoca;
come accade al termine “età ellenistica”.]
Avvertenza cautelare preliminare sui termini storiografici dalla ampia cronologia. Un arco di tempo
molto lungo indicato con un unico denominatore: ellenismo; in realtà con indicatori interni più
articolati: epoca alessandrina 323-146 a.C. (fino alla conquista romana della Grecia), epoca
ellenistico-romana 146 a.C. – 529 d.C. Un arco di tempo che si apre con l’espansione della
monarchia macedone di Alessandro (seconda metà del IV secolo a.C.; la data della sua morte è
l’inizio simbolico dell’età ellenistica, il 323) e si prolunga, nel mondo latino, sino alla fine
dell’impero romano e oltre, cioè fino al formale inizio dell’età medievale, il 476 d.C. per la storia
politica (l’imperatore Romolo Augustolo viene deposto dalla carica, ed è l’ultimo imperatore, da
Odoacre, capo germanico proclamato re), e per la storia della filosofia il 529 d.C., anno in cui
Giustiniano, imperatore d’Oriente (dell’Impero romano d’Oriente) chiude con decreto l’Accademia
fondata da Platone ad Atene nel 387 a.C. Un unico denominatore, “ellenismo”, adottato per
1
richiamare circa otto secoli, più che definire, segnala la lontananza prospettica di chi osserva e
definisce; lo sguardo coglie delle uniformità e delle tendenze di lungo corso ma ad esse sacrifica
realtà singolari uniche e processi plurimi in atto, destinati a rivelarsi strumenti irrinunciabili di
osservazione e di scoperta. Bisognerà adottare uno sguardo a doppia distanza capace di vedere
prima la situazione culturale complessiva di lungo periodo, e poi le proposte e le tesi di carattere
filosofico-scientifico dei diversi soggetti storici: scuole, autori, testi.
Il contesto
1. dimensione politica imperiale (autonoma, universale e “trascendente”) e cultura
1.1. monarchie uniche, monarchi divini e sudditi devoti. L’ampio arco di tempo che si apre con
l’espansione della monarchia macedone di Alessandro (seconda metà del IV secolo a.C.) e si
prolunga, nel mondo latino, sino alle soglie della crisi dell’impero romano (III secolo d.C.) vede
mutare il quadro politico che aveva fatto da sfondo al nascere e all’affermarsi della filosofia greca.
La fine dell’indipendenza delle pòleis è segnata dal prevalere di regni di vaste dimensioni, come
l’impero macedone, le monarchie ellenistiche, l’impero romano: il cittadino, divenuto suddito,
dispone di scarse libertà e l’intellettuale, privato di spazio politico, tende a circoscrivere l’ambito
delle proprie ricerche a quei saperi, come la logica, l’etica, la matematica o la medicina, che non
suscitano il sospetto dei sovrani; in cambio della rinuncia a ogni ruolo politico, sia come studioso
sia come cittadino, il filosofo e lo scienziato ottengono dai sovrani il riconoscimento di una certa
libertà di ricerca e la disponibilità di istituzioni attrezzate come biblioteche e laboratori in cui
studiare e operare per nuclei, scuole e circoli di iniziati.
1.2. scienze e filosofie nell’età degli imperi. Si moltiplicano, in quest’epoca, le scuole filosofiche i
cui programmi, pur diversi tra loro, sono orientati prevalentemente verso la liberazione dalle paure e
dai turbamenti; per favorire il conseguimento di tale fine, nel quale consiste la saggezza, ogni
scuola elabora specifici esercizi spirituali, forme di riflessione, terapie per la cura dell’anima: sotto
la guida dei maestri, all’interno di scuole, come il Giardino di Epicuro o la Stoa di Zenone, gli
allievi riflettono sui testi filosofici, ne discutono le proposte, si preparano ad affrontare gli eventi
della vita, imparando a vedere in essi (anche in quelli più difficili da sopportare come il lutto, la
malattia, gli insuccessi) accadimenti naturali dotati di una loro ragion d’essere; nella scuola che
Plotino apre a Roma, la rilettura dei testi antichi induce al distacco da ciò che è reale, molteplice,
per tendere misticamente verso il principio supremo, l’Uno. La filosofia diventa soprattutto un’arte
di vivere, una pratica di saggezza che non si esaurisce nella conoscenza, ma si traduce in un ideale
di vita filosofica che dovrà essere caratterizzato da serenità e moderazione, amicizia e solidarietà.
Dalle riflessioni filosofiche, in cui prevalgono le preoccupazioni etiche, vanno sempre più
distinguendosi le indagini scientifiche, alla ricerca di una loro autonomia di metodo e di contenuto:
nasce in età ellenistica la figura dello scienziato come figura autonoma dal filosofo e si affermano
forme di razionalità, come quella geometrica di Euclide e quella medica di Galeno, che
domineranno per secoli la cultura scientifica.
2. luoghi e forme del filosofare e dei testi
2.1. le istituzioni e il sostegno pubblico, la ricerca di spazi liberi.
La diffusione del trattato scientifico e il costituirsi di autonome discipline scientifiche fanno leva su
istituzioni culturali, come il Museo di Alessandria e le grandi biblioteche delle città ellenistiche, in
cui la comunità degli studiosi può operare. Importanti poli di attrazione per filologi, letterati, eruditi,
filosofi, scienziati, il Museo e le biblioteche di Alessandria, Pergamo, Antiochia nascono per
iniziativa dei sovrani ellenistici; con il prioritario fine di imporre a una società caratterizzata dalla
presenza di molte etnie e tradizioni, una nuova omogeneità fondata sulla superiorità della cultura
greca e della lingua della koiné, i re ellenistici avviano, spesso in rivalità fra loro, un imponente
processo di raccolta delle opere del mondo antico: creano biblioteche (con responsabili della
conservazione e della catalogazione delle opere, traduttori, copisti, disegnatori e, infine,
2
commentatori e interpreti, ispiratori e guide per circoli di dotti e di fedeli), dove immagazzinano
testi appartenenti alla tradizione culturale greca, orientale, ebraica che provengono dalle più diverse
regioni del bacino del Mediterraneo e del Vicino Oriente; finanziano l'istituzione di centri di ricerca
scientifica in cui lo studioso possa disporre di opere da consultare, laboratori in cui operare, edifici
in cui alloggiare a spese dei sovrani.
Spazi protetti, nei quali gli intellettuali trovano mezzi e finanziamenti messi a disposizione dal
sovrano, le grandi istituzioni culturali ellenistiche possono però apparire come carceri dorate nelle
quali il filosofo è limitato nella sua libertà e autonomia; all’ironico sguardo del filosofo scettico
Timone, il Museo alessandrino, massima istituzione culturale egiziana, si presenta come una
«gabbia di Muse» dove «vengono allevati degli scribacchini libreschi che si beccano eternamente».
Una consapevolezza che si riflette nella pluralità dei luoghi in cui la filosofia decide di operare: le
pubbliche Accademie (per lo più per specialisti) e accanto, o per differenza, i circoli culturali aperti
di iniziazione come il giardino (orto di Epicuro), il portico (degli “stoici”), e accanto, per ulteriore
differenza ed esplicito contrasto e contrapposizione, la pubblica piazza, i luoghi alla periferia della
città (ai confini, al margine come i cimiteri per Antistene). In quest’ultimo caso, l’opposizione
critica è pressoché totale: non le scuole ufficiali di ricerca e studio come l’Accademia di Platone o il
Liceo di Aristotele, nemmeno i luoghi culturali di ricerca gestiti e finanziati dal potere politico
come la Biblioteca di Alessandria d’Egitto e nemmeno i circoli pur aperti ma sempre per iniziati
come la scuola epicurea e stoica; la natura e il diretto rapporto con essa in tutti i suoi aspetti è il
luogo in cui vivere per una autentica cultura, per una libera scienza, per un’etica che si oppone ad
ogni forma di asservimento.
2.2. felicità e specialismi. Nelle scuole filosofiche, il dato culturale dominante è quello di una
stretta congiunzione tra filosofia e scienza a partire da una nuova urgenza, quella etica; tratto che
emerge da tutta la produzione filosofica del periodo ellenistico pur nella estrema varietà delle
posizioni e delle contrapposizioni. Non la conoscenza per se stessa e dunque i saperi e gli
specialismi, ma la ricerca di tranquillità, serenità, felicità genera la domanda di senso e
conseguentemente lo studio del mondo condotto su basi scientifiche empiriche e razionali. In questa
congiuntura si delinea un legame strettissimo tra etica e fisica; tra la ricerca delle condizioni di
serenità e lo studio del mondo nei suoi aspetti generali e in quelli specifici dei molti fenomeni che lo
riguardano. La filosofia propone una visione d’insieme, armonica, del mondo, componendo i vari
specialisti, contenendone la settorialità e riportando la scienza all’interno di una finalità etica.
Nella produzione rimasta ricorrono forme del testo molto distanti dalla tradizionale impostazione di
un programma di studio o di un trattato (come accade nelle opere aristoteliche), come lettere e
raccolte di sentenze; ma immediato e programmatico è in esse il passaggio dal fine etico
all’impegno scientifico per la definizione di una cosmologia complessiva e per l’analisi di settori
particolari. Al di là dell’apparente frammentarietà dell’epistolario o dell’aforisma, le principali
filosofie ellenistiche sono sostenute da un solido sistema filosofico la cui struttura logica geometrica
è comunque solitamente delineata in forme che richiamano l’architettura del trattato: in esso il
filosofo e lo scienziato sistemano ordinatamente le conoscenze dell’intera realtà, riproducono
l’ordine razionale che governa l’universo, ora richiamandosi al moto degli atomi, come fanno gli
epicurei, ora al disegno di un Lógos provvidenziale, come gli stoici, ora a una gerarchia di gradi
della realtà emanati dall’Uno, come i neoplatonici; nell’ordine sistematico del trattato vengono
ricomposte (anche in forma eclettica) tutte le conoscenze sul mondo fisico e umano a disposizione.
Alla radice di queste procedure ordinate secondo logica vi è un’opera che fin dal III secolo
accompagna e definisce, in modo particolare, la cultura ellenistica; infatti, nell’ambito delle ricerche
scientifiche, a partire dal III secolo, è il rigoroso ordine argomentativo degli Elementi di Euclide che
diviene il modello di esposizione scientifica ritenuto capace di archiviare tutte le conoscenze; a esso
si ispireranno Archimede per le sue opere di meccanica, Aristarco per quelle di astronomia, Galeno
per quelle di biologia e medicina.
3
2.2.1. Trattati e formalizzazione scientifica: una nuova pratica di generazione delle opere filosofiche
e l’emergere di nuove forma del testo scientifico, il trattato; forma nuova per modalità di
formazione e per esigenze di trasmissione del sapere. «Per spiegare il diverso clima culturale
occorre tener conto anche di un diverso tipo di organizzazione e di trasmissione del sapere. La
cultura filosofica e scientifica dei secoli V e IV a.C. era una cultura affidata in gran parte alla parola
e alla discussione, benché il libro fosse già una realtà. Ma il libro — si pensi ai dialoghi di Platone e
a quelli perduti di Aristotele — era più il deposito di un’elaborazione orale che una costruzione
autonoma. L’ambito di formazione delle dottrine filosofiche e scientifiche erano le scuole,
l’Accademia e poi il Liceo, ove gli scambi orali erano intensi. Ma già nelle scuole prende forma un
tipo di scritto, la bozza di lezioni, gli appunti (tali sono le opere conservate di Aristotele) che si
muovono nella direzione del trattato. Nell’epoca ellenistica, filosofia e scienze si scindono anche a
livello istituzionale: ad Atene restano le vecchie scuole filosofiche e se ne fondano di nuove, ma gli
scienziati sono altrove, ad Alessandria o a Siracusa. Ad Atene continua la tradizione della
discussione filosofica, ma ad Alessandria il libro nella nuova veste del trattato diventa la vera forma
dell’elaborazione scientifica come forma appropriata all’autonomia di ogni edificio scientifico
assiomatico.» (Cambiano Giuseppe 1981 Filosofia e scienza nel mondo antico, Loscher, Torino,
26-27) È il caso dell’opera di Euclide. Ricomposizione ordinata e rigorosa delle conoscenze dei
matematici greci, gli Elementi, con la loro articolata scansione in definizioni, postulati, assiomi,
dimostrazioni, offrono un modello nuovo e organico di sistemazione del discorso scientifico: ogni
conoscenza e ogni questione trova la sua collocazione in un ordine espositivo serrato e impersonale
che non ammette lacune e ripetizioni, genericità o ambiguità espressive; ogni termine viene definito
e ogni proposizione è connessa alle altre secondo un rigoroso procedimento dimostrativo. Il trattato
euclideo si presenta così come forma costitutiva della scientificità: solo se si rivelano riconducibili
alla sua rigorosa struttura, i saperi (la biologia, l’astronomia, la fisica, la medicina ecc.) possono
qualificarsi come scientifici.
2.2.2. Lettere, massime, sentenze, esortazioni. È il caso di Epicuro e delle opere dello stoicismo (o
almeno di ciò che resta delle loro opere). Convinto assertore del carattere liberatorio
dell’insegnamento filosofico, Epicuro ripetutamente raccoglie in massime da imparare a memoria e
ricordare, in lettere da rileggere e meditare, i punti essenziali del programma di liberazione dai
turbamenti indicati nel quadrifarmaco (riassunto in un papiro scoperto ad Ercolano: «La divinità
non è cosa da far paura. La morte non è cosa da guardare con sospetto. Il bene è cosa facile da
conseguire. Il terribile è cosa facile da sopportare.» Terapia, il cui scopo è la guarigione degli
allievi-amici ancora lacerati dai timori della morte, degli dei, del dolore, la filosofia è per Epicuro il
solo farmaco in grado di fornire all’uomo i mezzi per conquistare la salute dell’animo: tali mezzi
consistono in esercizi di meditazione e memorizzazione da condurre «giorno e notte», in sforzi
concreti per tradurre in pratica i principi appresi nella scuola, attraverso l’analitica messa in
discussione delle convinzioni popolari sul destino umano, sull’oltretomba, sui castighi divini, sul
dolore. Epicuro fa ampio ricorso alla forma epistolare per indirizzare ai propri allievi brevi
compendi della filosofia che egli espone nelle lezioni orali e nei più articolati trattati. Nelle lettere
egli condensa gli aspetti più significativi della sua riflessione, facendone l’oggetto di una facile
lettura, di una rapida memorizzazione e di un’ampia diffusione tra allievi e amici del Giardino. La
scelta della brevità, leggibilità e divulgabilità va posta in relazione con la triplice finalità
pedagogica, pratica e terapeutica della filosofia di Epicuro; tesa a formare eticamente i suoi studenti
(fine pedagogico), a orientarli verso un ideale di vita filosofica (fine pratico), a liberare i loro animi
da ogni infondata paura (fine terapeutico), la lettera indica precisi esercizi spirituali da compiere
«giorno e notte», precetti e massime da apprendere e applicare, farmaci con cui guarire gli animi.
È il caso di Seneca, principale esponente della tradizione stoica nella cultura latina. Le Epistulae
che egli indirizza all’amico Lucilio costituiscono il momento culminante della riflessione del
filosofo, oltre che la sua opera più celebre e originale. In esse Seneca applica il modello epicureo
della lettera come colloquium destinato non solo a discutere temi teorici generali, ma anche a
esortare al bene e a fornire una guida per la meditazione. L’epistula si presenta come il genere
4
letterario più adatto a una pratica quotidiana della filosofia: essa consente di prendere spunto dalla
realtà vissuta per delineare un magistero spirituale che accompagna il destinatario in un percorso di
perfezionamento progressivo.
2.2.2.1. il “pharmakon” e la sua ambivalenza. Nella tradizione linguistica greca il termine
pharmakon indica sia la causa del male che il suo rimedio; quasi a significare che il male può
diventare la strumento del suo rimedio; è veleno e cura (come accade proprio al farmaco), sciagura
e salvezza. Il prototipo tragico di questa ambiguità è Edipo: l’oracolo lo indica come causa della
pestilenza che ammorba Tebe e ad un tempo il rimedio, il modo per porvi fine allontanandosi da
Tebe. È contemporaneamente il male che contagia la città e che, rimosso, cioè rimuovendo se stesso
attraverso una tragedia della conoscenza e del riconoscimento, la porta a guarigione e salvezza;
Edipo incarna e assume su di sé l’intero male rimuovendolo dalla collettività. Come la vittima
sacrificale, nel rito, assume su di sé il male e il suo sacrificio determina la salvezza. Nel
“quadrifarmaco” proposto da Epicuro, ciò che incute paura è sventura e salvezza. Le paure e i
timori espressi nel loro confronti, specie se alimentati ad arte e assecondati, distruggono la
piacevolezza del vivere, se invece si trasformano in domande portano alla retta nozione nei
confronti di ciò che genera timore e guidano l’uomo lungo un cammino personale verso la
tranquillità e quindi felicità. Personale: a partire cioè dalle paure e dai bisogni individuali. Per
questo la filosofia sceglie la forma della “epistula” e non del trattato; questo è uguale per tutti,
quella si rivolge alla persona.
2.2.3. Performances filosofiche critiche, provocatorie, libertarie. È il caso dei cinici. «Sul piano
teorico e nella pratica quotidiana, i Cinici sviluppano una vera e propria contestazione globale non
più solo della Città, ma della Società e della Civiltà. La loro protesta è una critica generalizzata
dello stato civilizzato, critica che sorge nel IV secolo, con la crisi della Città, e che vede tra i suoi
terni principali il ritorno allo stato selvatico. Sul piano negativo, essa si realizza attraverso la
denigrazione della vita nella città ed il rifiuto dei beni materiali prodotti civiltà. In positivo,
abbiamo uno sforzo per recuperare la vita semplice dei primi uomini, che bevevano l’acqua delle
sorgenti e si nutrivano di ghiande raccattate sul suolo o raccogliendo i frutti delle piante. Per
apprendere di nuovo a mangiare erbe crude, poi, i Cinici si propongono due modelli: i popoli
selvaggi che hanno conservato inalterato questo tenore di vita, e gli animali che non sono stati mai
contaminati fuoco di Prometeo. In effetti, il Cinismo è percorso da una corrente antiprometeica,
volta contro l’invenzione del fuoco, portatore di tecniche e di civiltà. Per inselvatichirsi, non basta
mangiare cibi crudi, né praticare l’omofagia di quel Diogene che, pagando di persona, disputa ai
suoi cani un pezzo di polpo crudo; occorre anche disarticolare il sistema di valori su cui la società si
fonda. Il ritorno alla selvaticità passa attraverso la critica a Prometeo, non più sacrificatore
responsabile della separazione tra dei ed uomini, ma Titano civilizzatore dell’antropologia culturale,
mediatore colpevole di aver tratto l’umanità dallo stato selvaggio facendole il dono attossicato del
fuoco.» (M. Detienne, Dioniso e la pantera profumata, Laterza, Bari 1981, p.113)
Contro ingiustificate convenzioni, inutile complessità, istituzioni politiche sede storica di violenza,
menzogna, esclusione. «Antistene non lesinava il suo disprezzo per gli Ateniesi che si vantavano di
essere autoctoni, anzi diceva che non erano più nobili delle chiocciole e delle cavallette»
«(Antistene) Consigliava agli Ateniesi di decretare che gli asini sono cavalli e poiché quelli lo
ritenevano assurdo, disse: “Eppure da voi per diventare strateghi non occorre alcuna istruzione:
basta l’alzata di mani”.»
«(Diogene) Era bravo nel trattare gli altri con estrema alterigia. Definiva bile (kolé) la scuola
(skolé) di Euclide, la conversazione di Platone “perdita di tempo” (diatribén – katatribén) gli
agoni dionisiaci grandiose meraviglie per gli sciocchi, i demagoghi ministri della massa.»
(testimonianze tratte da: Diogene Laerzio, Vite di filosofi, Libro VI, Laterza, Bari 1976 pp. 203213)
A commento: «…ciò per cui un essere umano deve davvero provar pudore non può essere stabilito
in alcun modo mediante convenzioni sociali, tanto più che la società stessa sembra basata su
perversioni e irragionevolezze di ogni genere. Il cinico, dunque, prende allegramente congedo
5
dall’incarnita tutela del comune senso del pudore, con relativi comandamenti. Infatti, i costumi
morali — pudiche convenzioni incluse — potrebbero poi in realtà rivelarsi assurdi o perversi; e
allora: solo un controllo ispirato ai principi della natura e della ragione potrà fornire basi sicure.
L’animale politico rompe con la politica del pudendum. Mostra come gli esseri umani, di norma,
provino pudore per le cose sbagliate, per la loro physis, per il loro lato animale, che è innocuo,
mentre restano intatti comportamenti irragionevoli e orribili come l’avidità, l’ingiustizia, la crudeltà,
la vanità, la prevenzione e la cieca follia. Diogene rovescia questa prospettiva.» (Sloterdijk, Critica
della ragion cinica, Garzanti, Milano 1992 p.137)
Vivere al meno. Il mantello «Antistene era soprannominato il puro Cane o il Cinico schietto. Come
afferma Diocle, fu il primo a rendere due volte tanto il mantello e ad usare soltanto questo
indumento e a portare un bastone e una bisaccia. Anche Neante conferma che fu il primo a
raddoppiare il mantello. Invece Sosicrate nel terzo libri, delle Successioni dei filosofi afferma che
il primo fu Diodoro di Aspendo, che pure si lasciò crescere la barba e usava bisaccia e bastone.»
(Diogene Laerzio o.c.) «Secondo alcuni, (Diogene) fu il primo a raddoppiare il mantello per la
necessità anche di dormirci dentro, e portava una bisaccia in cui raccoglieva le cibarie; si serviva
indifferentemente di ogni luogo per ogni uso, per far colazione, per dormirci, per conversare» (ivi)
«Tutto quello che possiedono, i cinici se lo portano addosso. Per Diogene e i suoi vuol dire: un
mantello parapioggia, buono per ogni stagione, un bastone, uno zaino contenente i pochi averi (fra
cui forse uno stuzzicadenti), un pezzo di pomice per le pulizie personali, una borraccia di legno, i
piedi calzeranno semplici sandali.» (Peter Sloterdijk, Critica della ragion cinica, Garzanti, Milano
1992 p. 122) Il cibo: «Una volta (Diogene) vide un fanciullo che beveva nel cavo delle mani e gettò
via dalla bisaccia la ciotola, dicendo: “Un fanciullo mi ha dato lezione di semplicità”. Buttò via
anche il catino, perché pure vide un fanciullo che, rotto il piatto, pose le lenticchie nella parte cava
di un pezzo di pane.»
3. le parole comuni della filosofia etica nella forma di filosofia dell’uomo.
Si tratta di “scuole” (che tendono ad assumere la forma di circoli, comunità) che identificano nella
dimensione individuale il primo e diretto contesto di lavoro filosofico. Il saggio è artefice della
propria felicità e libertà e, quindi, «ciò che distingue la filosofia antica da quelle che seguiranno è la
proposizione di esercizi spirituali aventi lo scopo di produrre una trasformazione della natura del
soggetto che li pratica.» (Onfray Michel Cinismo, Principi per un’etica ludica, Rizzoli, Milano
1992 p.10). L’obiettivo è la felicità e la felicità è intesa come liberazione dal turbamento fonte di
schiavitù. Liberazione affidata, contemporaneamente, ad un passaggio: dall’esterno all’interno;
dall’osservazione scientifica della realtà, all’ascolto e indagine prioritaria dei modi con cui l’uomo
osserva, ricorda, conserva e, in generale, vive quella realtà in cui si trova immerso. L’osservazione
scientifica serve alla tranquillità interiore e alla sintonia con la natura, l’esplorazione di sé e delle
proprie capacità apre il soggetto ad una attenta e non pregiudiziale sensibilità nei confronti degli
stimoli e dei segni che la realtà invia all’uomo.
3.1. il primo impegno: la mappatura del disagio; ambiti e forme. Occorre esplorare ed
evidenziare l’universo delle schiavitù vincendo le resistenze che l’abitudine oppone al
riconoscimento e alla scoperta di ciò che effettivamente opprime. È proprio l’universo delle
schiavitù, la dinamica del suo estendersi e del suo automatico riprodursi a costituire il campo di
applicazione e presenza della filosofia ellenistica.
3.2. le indicazioni di uscita coinvolgono teoria e prassi in una sorta di terapia integrata
3.2.1. la retta conoscenza ci libera dalle paure. Risalta con evidenza qui la finalità e la funzione
etica della scienza; anch’essa è saggezza o non può prescinderne, perché trova la propria spinta
nell’obiettivo di realizzare la funzione terapeutica della filosofia attraverso la conoscenza
scientifica. La constatazione della diversità dei luoghi della cultura tra la filosofia ( con sede nelle
scuole e nei circoli) e la scienza, ha fatto sorgere tesi su di una separazione tra scienza e filosofia o
6
di una loro non comunicazione; la tesi che è in grado di registrare il processo culturale in atto è più
complessa. È proprio nel periodo ellenistico che prendono il via e trovano espressione le ricerche
scientifiche settoriali nelle forme di autonomia che ancora oggi caratterizzano la produzione
scientifica, così come trova espressione specifica la definizione delle coordinate formali del sapere
scientifico, come accade negli Elementi di Euclide; ma, contemporaneamente si riflette sul destino e
sulla finalità etica della produzione scientifica. Una articolata riflessione sulle procedure che
garantiscono un esito scientifico trova la sua esposizione proprio nelle opere degli epicurei e degli
stoici (come degli scettici, dei cinici e dei neoplatonici) la cui finalità prima è quella di garantire per
l’individuo le condizioni per la felicità.
3.3. le tecniche: laboratori di etica filosofica per educare al piacere e alla felicità: meditazione,
colloqui, scambi, confronti, corrispondenza, esercizi “spirituali” che educano allo sguardo
d’insieme (filosofico e scientifico) rivolto all’intera realtà… «abbiamo infatti bisogno di una
visione di insieme e non di conoscenze specialistiche. Bisogna dunque risalire spesso a quei
principi e, imprimendoseli nella memoria, far sì che da essi derivi innanzitutto una visione generale
delle cose» (Epicuro, Lettera a Erodoto)
esploro riconosco e catalogo riconducendo a
forme l’universo delle paure e delle schiavitù
gli ambiti
le forme
biologico
bisogni
passioni
sofferenze
morte
corpo
cosmico
catastrofi naturali
eventi fatali
leggi inesorabili
sociale
obblighi sociali
consuetudini
differenze sociali
potere politico
legami …
fonti di turbamento
nella scuola-circolo attivo una terapia filosofica
teorica e pratica che attua la liberazione
liberazione teorica
liberazione pratica
la ricerca (sképsis) e i
un laboratorio “ascetico”
suoi fini etici: una retta attuato con la tecnica del
nozione, una
“togliere” (del ridurre al
spiegazione scientifica, minimo, eliminare il
un giusto giudizio
superfluo, il lusso
riguardante i settori da [regola etica e logica])
cui provengono timori
a-tarassia
paure preoccupazioni:
a-diaforia
dio e il cielo
a-prassia
destino
a-ponia
mondo
a-fasia
vita e morte
e: senza opinione
verità e errore
senza inclinazione
virtù
senza agitazione
piacere e dolore
senza coinvolgimento
desideri
“epoché” = sospensione
….
(di giudizio e di azione)
assenza di turbamento = felicità “eudaimonia”
3.3.1. in un prefisso, l’alpha privativo, è posta la tecnica della liberazione e si definisce l’intero
progetto etico delle filosofie ellenistiche. La libertà è libertà da (non libertà di), il piacere non sta
nell’accumulo ma nella saggia e serena eliminazione del superfluo, il giusto giudizio è quello che si
accompagna anche alla sua sospensione ... e così vengono ridefiniti tutti i termini dell’etica secondo
una tecnica e una concezione che mira a dare all’uomo la piena autonomia del proprio sguardo e
delle proprie scelte sia nel campo dell’agire sociale sia nel campo della ricerca e costruzione della
scienza.
3.3.2. L’alpha privativo, la “libertà da”, il modus tollens … non sono espressioni che si limitano ad
indicare una massima ascetica di comportamento che ha sede e valore solo in campo etico, si tratta
di un indirizzo metodologico che fonda e sorregge l’intero atteggiamento conoscitivo e, nello
specifico, quello scientifico. È un indirizzo per gestire le proprie facoltà riducendo al minimo
interferenze e ostacoli (pregiudizi, opinioni fallaci, consuetudini unidirezionali…); per affrontare
7
l’esperienza sapendo mirare all’essenza, cogliere la natura, dare il giusto nome a ciò che ci accade;
per definire percorsi di scoperta riconoscendo ed eliminando false piste, anche quando queste ci
vengono imposte da autorevoli pensatori e lunghe consuetudini di pensiero; costruire teorie legando
la loro efficacia e verità alla semplicità dei principi e delle procedure, alla bellezza dell’insieme.
3.3.3. Dunque una direzione comune o condivisa o collegata. «Tuttavia, sotto questa apparente
diversità, c’è un’unità profonda, nei mezzi impiegati, e nel fine cercato. I mezzi impiegati sono le
tecniche dialettiche e retoriche di persuasione, le prove di padroneggiamento del linguaggio
interiore, la concentrazione mentale. Il fine cercato in tali esercizi da tutte le scuole filosofiche è il
miglioramento, la realizzazione di sé. Tutte le scuole concordano nell’ammettere che l’uomo, prima
della conversione filosofica, si trova in uno stato di inquietudine infelice, che è vittima della cura,
delle preoccupazioni, lacerato dalle passioni, che non vive veramente, che non è se stesso. Tutte le
scuole concordano anche nel credere che l’uomo possa essere liberato da questo stato, che possa
accedere alla vera vita, migliorare, trasformarsi, raggiungere uno stato di perfezione. Gli esercizi
spirituali sono precisamente destinati a questa educazione di sé, a questa paidéia che ci insegnerà a
vivere non già conforme ai pregiudizi umani e alle convenzioni sociali (poiché la vita sociale è essa
stessa un prodotto delle passioni), ma conforme alla natura dell’uomo, che non è altro che la
ragione. Tutte le scuole, ciascuna a suo modo, credono dunque nella libertà della volontà, grazie a
cui l’uomo ha la possibilità di modificare se stesso, di migliorare, di realizzarsi. Alla base di questo
c’è un parallelismo tra esercizio fisico ed esercizio spirituale: come, con esercizi fisici ripetuti,
l’atleta dà al suo corpo una forma e una forza nuove, così, con gli esercizi spirituali, il filosofo
sviluppa la sua forza d’animo, trasforma la sua atmosfera interiore, cambia la sua visione del mondo
e infine l’intero suo essere. L’analogia poteva parere tanto più evidente in quanto proprio nel
ghimnasion, ossia nel luogo dove si praticavano gli esercizi fisici, si tenevano anche le lezioni di
filosofia, ossia si praticava l’allenamento alla ginnastica spirituale. … La vera filosofia è dunque
esercizio spirituale, nell’antichità. Le teorie filosofiche sono messe esplicitamente al servizio della
pratica spirituale, come accade nello stoicismo e nell’epicureismo, o sono fatte oggetto di esercizi
spirituali, ossia di una pratica della vita contemplativa che a sua volta non è null’altro che un
esercizio spirituale » Hadot Pierre Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 1988, p.5863 passim)
3.3.4. Alla radice strutturale delle filosofie del periodo “ellenistico” si articola un particolare tipo o
modello di logica; ragionando in termini di modelli, si può parlare di una logica propria del periodo
ellenistico; una propria logica estetica della percezione sensibile, del ruolo attribuito all’esperienza
dei sensi, del coordinare sensazioni e segni in parole, del gestire le parole grammaticalmente e
sintatticamente, dell’arte del ragionare componendo enunciati, dimostrazioni, teorie. È un tipo di
logica che sorregge e rende sperabilmente possibile l’obiettivo etico generale della felicità. Le
divergenti impostazioni interne ai diversi circoli o scuole non mettono in discussione ma
corroborano l’obiettivo di un’etica della vita felice.
3.3.5. L’obiettivo della cura in vista di una felicità come assenza di turbamento, propria delle
filosofie ellenistiche, può essere messa in luce, nella sua direzione, con ragionamenti offerti dalla
riflessione psicanalitica (con particolare riferimento a quella espressa da Jacques Lacan) che,
ragionando per estremi, oppone la paranoia della certezza assoluta e la nevrosi del dubbio come
stato fine a sé e irrisolvibile.
«La certezza paranoica resiste a ogni tentativo di simbolizzazione. Per questa ragione Lacan la
separa con decisione dai fenomeni nevrotici che riguardano il tormento assiduo del dubbio o il
vacillamento delle proprie convinzioni al quale il nevrotico è sempre esposto. […] La certezza
paranoica - "tutto è segno" ! -viene dunque situata da Lacan in netta opposizione alla fragilità
costitutiva delle convinzioni nevrotiche. E la ragione che giustifica il potere seduttivo e aggregativo
esercitato su soggetti comunemente nevrotici - assillati costantemente dal dubbio e dall'incertezza dai paranoici, non a caso così frequentemente a capo di sette pseudoreligiose o di partiti politici;
soggetti capaci di organizzare, attorno a sé e alla propria fede granitica nei confronti di un Altro
assoluto e identitario, intere comunità. […] Differenziando la struttura del soggetto diviso della
8
nevrosi da quella del soggetto paranoico che si costituisce come un'identità attorno alla propria
certezza delirante, Lacan vuole evidenziare la caratteristica solida del delirio paranoico, opposto
non solo al carattere dubitativo delle convinzioni nevrotiche, ma anche alla dimensione
permanentemente frammentata del delirio schizofrenico. Questa solidità scaturisce da una certezza
delirante che dipana ogni ombra: il persecutore è oggettivamente e indubitabilmente l’Altro. Per
questa ragione, da un punto di vista psicopatologico, la paranoia si manifesta elettivamente nel
delirio di persecuzione; il mondo intero si organizza a partire dalla certezza delirante della necessità
di difendersi da una volontà di distruzione – persecutoria – animata dall'Altro. In questo modo
l'oggetto-cattivo non aderisce più al soggetto, ma viene esternalizzato, spostato, trasferito, proiettato
sull'Altro.» (Recalcati Massimo 2016, Jacques Lacan, Volume II. La clinica psicoanalitica:
struttura e soggetto, Raffaello Cortina editore, Milano, 134-135) Tutto è segno per il paranoico e
dei segni solo lui possiede la lettura. Contro una simile chiusura nei confronti del reale, la cultura
ellenistica e soprattutto la scuola stoica oppongono la distinzione tra i segni e forniscono l’arte
dell’interpretazione. Per l’evidenza sensibile non servono segni, per domande infinite non esistono
segni, per il vivere pratico quotidiano bastano segni rammemorativi, per le realtà più importanti
abbiamo segni indicativi. Questi ultimi, centrali in ogni riflessione sulla realtà, non possono venire
liquidati da verità certe e definitive, come vorrebbero inventori e speculatori sulle paure e, di
conseguenza, venditori di menzogne, ma richiedono l’arte dell’ascolto, dell’interpretazione e del
confronto nel rispetto della profondità e varietà del mondo.
In stringata sintesi.
[1.] La logica stoica dell’ascolto e interpretazione dei segni indiziari che la realtà continuamente ci
invia; dunque l’ascolto e la disponibilità a procedere per ipotesi capaci di conservare l’apertura
sensibile e mentale nei confronti dei segni del mondo. Non dunque una logica che parte dalle parole
e rischia di ridursi ad una ripetizione linguistica dei segni rammemorativi, cioè di ciò che risulta
noto in parole e che diventa pensiero dominante sulla base della semplice ripetizione e della vasta e
supina condivisione.
[2.] La logica epicurea: l’attenzione al sentire del corpo come fonte unica di ogni possibile e
controllata conoscenza e non la subordinazione a verità che vengano indotte nell’anima
dall’esterno, contro e senza alcune legame con le sensazioni, il vivere corporeo e sensibile di ogni
singolo. Nei soli segni rammemorativi e nella nozioni che vengono iniettate dall’esterno si basa
l’arte dell’incutere timori nell’uomo e consegnarlo a forme di schiavitù e di dolore; di escludere
l’umanità dal vivere felice in nome di un’etica assoluta, sovrana, esterna all’uomo.
[3.] Una comune conciliazione di fato (destino, fortuna, necessità…) e volontà (scelta, assenso,
libertà, determinazione…) « Il fatto che le cose accadano per una ragione, proprio come nel
platonismo e in Aristotele, non significa soltanto che le menti razionali possano tentare di
comprendere perché gli eventi naturali accadano come vediamo che accadono; significa anche - e
questo è molto più importante in contesti etici e psicologici - che le menti razionali sono in grado di
comprendere e apprezzare l'universo dal punto di vista dell'universo. Per dirlo in un altro modo, lo
stoicismo presuppone che gli esseri umani possano adottare una prospettiva decentrata, oggettiva,
sugli eventi naturali, includendo quegli eventi che si scontrano direttamente con noi e con ciò che ci
è più caro. Raggiungiamo questa prospettiva (vivere in accordo con la natura umana e universale)
quando riconosciamo che niente di ciò che rientra nell'attività umana potrebbe risultare
diversamente da ciò che di fatto accade. Gli eventi naturali che ricadono al di fuori della sfera
umana sono affari degli dèi - i cambiamenti di stagione, ad esempio, il sorgere e il tramontare del
sole, la mortalità delle forme di vita che vivono sulla terra, il nostro codice genetico, e persino
disastri come terremoti e tsunami. Simili eventi vanno accettati; dobbiamo reagire a essi
comprendendo che essi sono come dovevano essere, nel mondo fisico che l'intelletto divino ha
creato e portato all'essere.
Questa posizione, senza ulteriori spiegazioni, potrebbe dare l'impressione di indurre al fatalismo, o
comunque di diminuire grandemente il significato delle attività umane. In realtà significa l'esatto
9
contrario. E ciò perché la struttura deterministica che riguarda il sistema causale divino e gli eventi
esterni, ben lungi dall'escludere l’autonomia e la responsabilità umane, riserva uno spazio speciale
agli uomini grazie alla dottrina stoica secondo cui i nostri intelletti sono «parti» o «germogli»
dell'intelletto divino. Nell'universo stoico, l'azione (da intendersi come la causalità specifica degli
intelletti) è distribuita fra l'intelletto supremo di Zeus o natura universale, che è assolutamente
divina, e la razionalità derivata delle persone.» (Long A. Anthony, 2015, La mente, l’anima, il
corpo. Modelli greci, Einaudi, Torino 2016, 122-123)
Epicuro 341 – 271
1. fare i conti con le paure e la scoperta della corretta nozione delle cose
2. il piacere: la sua centralità e il diritto al piacere
3. il piacere come arte per gestire il desiderio
4. lo statuto di una scienza che nasce all’interno di un’etica della felicità
5. la felicità e il non turbamento nei confronti del divino
6. la felicità e il non turbamento nei confronti della morte
1. Fare i conti con le paure e la scoperta della corretta nozione delle cose.
Le due direzioni della filosofia della cura: la prima richiama alla presenza a se stessi, invita alla
relazione con il proprio stato di paure, di bisogni, di attese e di disposizioni in termini di attenzione
e cura. La seconda è guida alla conoscenza aperta rivolta all’intero mondo della realtà e alle sue
componenti materiali e dinamiche di ordine o disordine.
1.1. Non vanno disprezzate le paure o sbrigativamente trascurate liquidandole come un fatto
emotivo privo di fondamento, né accentuate sino a porle al centro del nostro vivere. Sono un ottimo
strumento personale di orientamento, segnalano un disagio, devono essere correttamente valorizzate
e gestite. Si espongono ad un doppio rischio. Le alimenta indiscriminatamente l’ignoranza; infatti,
chi le vuole incutere come mezzo facile per sottomettere l’uomo al proprio arbitrio e indiscusso
potere, conserva l’ignoranza. Le alimenta però anche uno stato mentale apparentemente opposto, la
convinzione e l’obiettivo di poter raggiungere un sapere totale. Occorre ricordare, come sostiene
Epicuro, che ogni nostra conoscenza deriva dai sensi e non da arcane e definitive rivelazioni. E i
sensi ci portano a situazioni conoscitive di diversa efficacia: di certezza, di probabilità e di
spiegazioni molteplici possibili relative agli stessi fenomeni (i fenomeni naturali), di assoluta
impossibilità conoscitiva.
1.2. Per tutti questi casi, lo strumento che la conoscenza può fornirci come orientamento è la strada
della retta nozione, ricavata dall’esperienza. Si gestisce la paura e si prende in cura lo smarrimento
attraverso la retta nozione di ciò che maggiormente incute timore: la morte, il futuro, gli dei… e
secondo il livello di conoscenza e di azione possibile (una ribadita delusione nei confronti del
vivere, come quella espressa dal giovane Aristotele in uno dei suoi dialoghi giovanili, sottintende
sogni di onniscienza e onnipotenza; la rinuncia a questi restituisce la possibilità di progettare).
Questo è il piano di terapia filosofica svolto e applicato da Epicuro per sé e per i discepoli nella
scuola-circolo da lui fondata e gestita. «È compito della scienza della natura darci preciso conto
della causa dei fenomeni più importanti, ... in questo risiede la felicità, e nel conoscere la natura
dei corpi che contempliamo nei cieli, ed in tutte le conoscenze congeneri rispetto al raggiungimento
della perfetta scienza che renda la vita felice.» (Epicuro, ad Erodoto) «Bisogna esser persuasi che
dalla conoscenza dei fenomeni celesti in qualsiasi modo se ne tratti, o unitamente ad altre dottrine
o separatamente, non può derivare altro scopo se non la tranquillità e la sicurezza dell’anima, ciò
che del resto è pure lo scopo d’ogni altra ricerca.» (Epicuro, a Pitocle) «Della scienza della
natura non avremmo bisogno se sospetto o timore delle cose dei cieli non ci turbasse, e non
temessimo che la morte possa essere per noi qualcosa, e non ci nocesse il non conoscere i limiti dei
10
dolori e dei desideri.» (Epicuro, Massime capitali XI)
2. il piacere: la sua centralità e il diritto al piacere.
A fondamento e garanzia di questo progetto di filosofia è la scoperta e la difesa dell’umanità nella
sua radice sensibile ideale: il piacere e la conoscenza. «E per questo noi diciamo che il piacere è
principio e termine estremo di vita felice. Esso noi sappiamo che è il bene primo e a noi
connaturato, e da esso prendiamo inizio per ogni atto di scelta e di rifiuto, e ad esso ci rifacciamo
giudicando ogni bene in base alle affezioni assunte come norma. E poiché questo è il bene primo e
connaturato, perciò non tutti i piaceri noi eleggiamo, ma può darsi anche che molti ne tralasciamo,
quando ad essi segue incomodo maggiore; e molti dolori consideriamo preferibili ai piaceri
quando piacere maggiore ne consegua per aver sopportato a lungo i dolori. Tutti i piaceri dunque,
per loro natura a noi congeniali, sono bene, ma non tutti sono da eleggersi; così come tutti i dolori
sono male, ma non tutti sono tali da doversi fuggire.» (Epicuro, a Meneceo)
La felicità è promuovere togliendo per conservare il piacere e il desiderio in una relazione corretta.
Questo può avvenire sotto la guida della retta nozione che ha la propria radice nell’arte (il Canone)
di gestire conoscitivamente l’esperienza sensibile, unica fonte di conoscenza (di prenozioni,
nozioni, sensazioni). L’etica diventa l’arte di salvare il desiderio attraverso la gestione del piacere,
principio dell’agire umano (e divino).
Le affermazioni di Epicuro: «noi diciamo che il piacere è principio e termine estremo di vita felice.
Esso noi sappiamo che è il bene primo e a noi connaturato» propongono con forza il legame tra
piacere e natura umana e quindi il tema del diritto dell’uomo e del vivente al piacere. La sua
filosofia, e la terapia che ne segue, diventano scoperta e promozione delle condizioni che rendono
possibile la naturalezza del piacere.
2.1. Una prima avvertenza è quella di non interrompere la relazione tra sensazione e concetti, quindi
tra anima e corpo, uscire dai dualismi è anche scongiurare ogni volgare forma di riduzionismo: né
ridurre concetti a sensazioni e nemmeno ridurre le sensazioni ai concetti annullando la natura e il
piacere indistinto del loro autonomo e proprio accadere. Commenterebbe Françoise Héritier «Il
mondo esiste nei nostri sensi, prima di esistere come un tutto ordinato nel nostro pensiero, e
dobbiamo fare il possibile per conservare nelle fasi successive della nostra esistenza questa facoltà
creatrice di senso: vedere, ascoltare, osservare, sentire, toccare, accarezzare, percepire, annusare,
assaggiare, avere “gusto” per ogni cosa, per gli altri, per la vita.» (Héritier Françoise 2012 Il sale
della vita, Rizzoli, Milano 91-92) e lei stessa ricorda: «… il viaggio interiore attraverso emozioni e
percezioni è un modo di esplorare la nostra identità. Siamo fatti dell’accumulo di queste
esperienze. La nostra anima è il nostro corpo. … far apparire l’importanza del corpo nella
costituzione delle diverse culture.» (intervista, la Repubblica 15.06.2012)
2.2. Una seconda avvertenza è la corretta nozione del piacere.
«Ti invito invece ad assidui piaceri non a vacue e stolte virtù ch’abbiano inquiete speranze di buoni
frutti.» (ad Anassarco) «Quanto a me, non so farmi un concetto del bene, se ne detraggo i piaceri
del gusto, ne detraggo quelli di Venere, o quelli dell’udito ed i soavi moti che dalle forme riceve la
vista» (Frammenti, Del fine)…
Riprendendo, per intero e per contesto, una sequenza dalla Lettera a Meneceo: «E per questo noi
diciamo che il piacere è principio e termine estremo di vita felice. Esso noi sappiamo che è il bene
primo e a noi connaturato, e da esso prendiamo inizio per ogni atto di scelta e di rifiuto, e ad esso
ci rifacciamo giudicando ogni bene in base alle affezioni assunte come norma. E poiché questo è il
bene primo e connaturato, perciò non tutti i piaceri noi eleggiamo, ma può darsi anche che molti ne
tralasciamo, quando ad essi segue incomodo maggiore; e molti dolori consideriamo preferibili ai
piaceri quando piacere maggiore ne consegua per aver sopportato a lungo i dolori. Tutti i piaceri
dunque, per loro natura a noi congeniali, sono bene, ma non tutti sono da eleggersi; così come tutti
i dolori sono male, ma non tutti sono tali da doversi fuggire.
In base al calcolo e alla considerazione degli utili e dei danni bisogna giudicare tutte queste cose.
Talora infatti esperimentiamo che il bene è per noi un male, e di converso il male è un bene.
11
Consideriamo un gran bene l’indipendenza dai desideri, non perché sempre dobbiamo avere solo il
poco, ma perché, se non abbiamo il molto, sappiamo accontentarci del poco; profondamente
convinti che con maggior dolcezza gode dell’abbondanza chi meno di essa ha bisogno, e che tutto
ciò che natura richiede è facilmente procacciabile, ciò che è vano difficile a ottenersi. I cibi frugali
inoltre danno ugual piacere a un vitto sontuoso, una volta che sia tolto del tutto il dolore del
bisogno, e pane ed acqua danno il piacere più pieno quando se ne cibi chi ne ha bisogno.
L’avvezzarsi a un vitto semplice e frugale mentre da un lato dà la salute, dall’altro rende l’uomo
sollecito verso i bisogni della vita, e quando, di tanto in tanto, ci accostiamo a vita sontuosa ci
rende meglio disposti nei confronti di essa e intrepidi nei confronti della fortuna.
Quando dunque diciamo che il piacere è il bene, non intendiamo i piaceri dei dissoluti o quelli
delle crapule, come credono alcuni che ignorano o non condividono o male interpretano la nostra
dottrina, ma il non aver dolore nel corpo né turbamento nell’anima. Poiché non banchetti e feste
continue, né il godersi fanciulli e donne, né pesci e tutto quanto offre una lauta mensa dà vita felice,
ma saggio calcolo che indaga le cause di ogni atto di scelta e di rifiuto, che scacci le false opinioni
dalle quali nasce quel grande turbamento che prende le anime.» Epicuro, Lettera a Meneceo.
2.2.1. Il piacere (edoné) consiste nella semplice assenza di dolore, la felicità nella completa
liberazione da ogni fonte di turbamento e sofferenza; non è edonismo ma saggezza (edonismo come
risultato di saggezza). Sobria voluttà; il vero piacere è sobrio; tesi che va sia contro il mito e la
tradizione dello sfrenato e dell’orgiastico, sia contro “l’orgia rovesciata” presente nel rigore
ostentato dell’asceta e nella violenza dell’ordine [vedi Nietzsche, Aurora, Hesse, Siddharta,
Yourcenar, Memorie di Adriano]. «La malattia della lingua fa entrare l'uomo in un'economia della
soddisfazione in perdita, votata allo spreco e alla dispersione, marcata da una irrisolvibile
privazione del bene. È l'economia della pulsione che al posto dell'oggetto ha un vuoto, che è un
movimento acefalo, insensato, idiota, senza la finalità della sopravvivenza ed è per questo che nella
sua forma più radicale è letteralmente pulsione di morte. […] La domanda cruciale diventa allora:
che cosa ne è della soddisfazione umana? Che ne è della felicità dell'uomo se fa tutt'uno con questa
volontà di godimento estranea? Siamo in grado di essere felici? La domanda sembrerebbe mettere
in questione la nostra attitudine a raggiungere la felicità. Invece, è un interrogativo sulla nostra
capacità di sopportarla. Noi sappiamo reggere la felicità? Siamo strutturati per poterla vivere?
Siamo fatti per accettare la volontà di godimento che ci anima? » (Galimberti Fabio, 2015, Il corpo
e l’opera. Volontà di godimento e sublimazione, Quodlibet, Macerata, 19)
«Dunque, quanto è giusto possedere, che cosa determina il limite (“mensura” XIV, 316, parola cara
a Giovenale)? La fame, la sete, il freddo». (Gardini Nicola, 2016, Viva il latino. Storie e bellezza di
una lingua inutile, Garzanti, Milano, 180)
Per Epicuro la felicità (assenza di turbamento) è propria degli dei, non è data agli uomini; in questo
gli dei sono modelli di vita etica. Presso gli uomini, l’urgenza di imbrigliare le sensazioni in
concetti, nelle prenozioni, allo scopo di riconoscerle e gestirle, crea un ordine simbolico concettuale
e linguistico che in modo inadeguato e insoddisfacente riesce a gestire l’indeterminata tendenza del
corpo al piacere; anzi, spesso compie tale cammino di soddisfazione in modo solo apparente, poiché
presenta come piacere prioritario ciò che non soddisfa il desiderio ma lo rigenera in forma ampliata
e come fine a sé. Dunque, il rischio che il desiderio venga consegnato all’ossessione ripetitiva di un
consumo senza necessità e senza motivo.
2.2.2. Il legame tra felicità e piacere in forza di una loro retta nozione. L’uomo trova dunque in se
stesso, nella inclinazione al piacere, il solo fondamento di eticità [vi è uno stretto legame tra la
teoria gnoseologica di Epicuro interamente basata sulle sensazioni come unica fonte materiale di
conoscenza e la sua teoria etica che pone il piacere a principio e fine dell’etica stessa]: «quando
diciamo che il piacere è il bene — specifica però Epicuro, consapevole degli equivoci cui si presta
la sua tesi, — non intendiamo i piaceri dei dissoluti o quelli delle crapule, come credono alcuni che
ignorano, o non condividono, o male interpretano la nostra dottrina»; il piacere che dà
«l’indipendenza dai desideri» (definito catastematico, in quanto si realizza nella quiete) differisce
da quello che nasce dallo sforzo per la loro soddisfazione (cinematico, cioè ricercato nel movimento
12
e nell’azione): il primo proviene dalla limitazione dei bisogni; il secondo avvia un processo di
continua autoalimentazione dei desideri, accende bisogni sempre maggiori (di cibi raffinati, oggetti
preziosi, divertimenti smodati) e non porta alla completa liberazione dai desideri. Riprendendo il
passaggio precedente: «Consideriamo un gran bene l’indipendenza dai desideri, non perché sempre
dobbiamo avere solo il poco, ma perché, se non abbiamo il molto, sappiamo accontentarci del
poco; profondamente convinti che con maggior dolcezza gode dell’abbondanza chi meno di essa ha
bisogno, e che tutto ciò che natura richiede è facilmente procacciabile, ciò che è vano difficile a
ottenersi.»
2.3. Il piacere, la felicità e la tecnica della sottrazione. L’esercizio di riflessione filosofica più
efficace consiste in un analitico lavoro di sottrazione che deve essere compiuto, ora per separare
quanto la natura impone all’uomo (come la soddisfazione del bisogno di cibo, bevande e riparo) da
quanto è superfluo (come sono, ad esempio, gli eccessi e le raffinatezze), ora per liberare dalla loro
ingombrante presenza fantasmi come l’oltretomba, la sofferenza, le punizioni divine, la morte: di
ciascuna di queste temute presenze Epicuro dimostra l’infondatezza con un rigoroso procedimento
di sottrazione che sposta il fenomeno indagato (le punizioni divine, l’aldilà, il dolore, la morte) sul
piano del non essere o di una lontana trascendenza, neutralizzandone così la temibilità.
Il procedimento «per sottrazione» di cui Epicuro si avvale nel lavoro di liberazione dell’animo dalle
paure trova il suo fulcro nella concezione del piacere (edoné), anch’essa caratterizzata in negativo:
il piacere è assenza di dolore e turbamento. Esso non nasce dalla soddisfazione del bisogno, e
dunque non consiste nel mangiare o bere o riposarsi, ma sorge dal non avere bisogni: non aver
fame, sete, freddo. Il vero piacere è catastematico, consiste in uno stato di quiete, non nel
movimento per la soddisfazione del bisogno.
Riconducendo il dolore, la morte, l’aldilà al non essere, e opponendo a esso l’essere del piacere,
della vita, dell’aldiquà, Epicuro dà così un preciso fondamento ontologico alla sua etica. Egli
imposta il proprio ragionamento, dilatando il proprio sguardo, tra gli estremi della immortalità e
della mortalità, dell’assenza di limite e del limite cogliendo, sorprendentemente, il carattere
distruttivo, per l’umanità, della dimensione della assenza di limiti (l’immortalità) quando è pensata
e perseguita come obiettivo reale e non vissuta come modello ideale di immanente trascendenza.
2.4. Piacere ed ascesi. L’etica epicurea — pur incentrata sulla nozione di piacere — si fonda dunque
su di una attenta ascesi, sulla limitazione dei desideri, sulla riduzione dei bisogni materiali a quelli
naturali e necessari al puro vivere, come il nutrimento e il riparo (Epicuro non annovera i bisogni
sessuali tra quelli necessari). Così descritto, il piacere si identifica con la virtù; entrambi trovano
nella natura il loro fondamento: la virtù, in quanto consiste nel vivere secondo una norma interna al
ritmo vitale, il piacere, in quanto è la condizione emotiva che accompagna tale modalità del vivere.
La ricerca del piacere è esercizio di ascesi e, viceversa, l’ascesi non assume un volto di sofferenza
ma è contesto di piacere. Un ruolo determinante nel raggiungimento di questa condizione di felicità,
che consiste «nel non soffrire nel corpo (aponìa) e nel non essere turbati nell’anima (ataraxia)»,
spetta perciò alla filosofia e ai quotidiani esercizi di lettura, meditazione, memorizzazione,
applicazione dei principi elaborati nella scuola: la felicità si raggiunge infatti solo nella scuola,
attraverso la riflessione filosofica, sotto la guida del maestro, in quel clima di solidarietà e amicizia
che può realizzarsi nella comunità dei filosofi e che non si dà invece mai nella comunità sociale;
Epicuro ripetutamente consiglia l’autoesclusione politica, («vivi nascosto» è un motto del
Giardino).
3. il piacere come arte per gestire il desiderio
Se il piacere «è il bene primo e a noi connaturato», occorre contemporaneamente chiederci quale
godimento può davvero animare il vivere? Quello che sa mantenersi connesso alla trascendenza del
desiderio e sa mantenere questa trascendenza. Lo strumento per questa arte etica è l’accurata
distinzione analitica del desiderio nelle sue forme e la descrizione del modo in cui si connette con il
piacere e con quali sue modalità. La filosofia, con il suo ordine simbolico, lavora per la felicità se
impedisce al piacere, “principio a noi connaturato”, di intraprendere una deriva distruttiva per
13
l’uomo e se ne indica l’impostazione come arte per la realizzazione e gestione del desiderio. Somma
viltà etica non è “cedere al desiderio”, ma “cedere sul desiderio”, cioè non voler sapere la verità del
proprio desiderio, rinunciare ad assumere il proprio desiderio, ritrarsi dalla dimensione del desiderio
(dimensione che costituisce l’essenza dell’umano) in nome di una non corretta e disumana
concezione del piacere, della sua natura e del suo ruolo.
La relazione desiderio-piacere è l’intreccio centrale dell’etica umana;
in sommario schema
coincidente
la crisi dell’etica: tra coincidenza e senza
piacere
desiderio
nella relazione piacere e desiderio
senza
la strada etica: gestire la relazione
tra desiderio e piacere
3.1. Il piacere è l’arte di gestire il desiderio, ad impedire che si estingua, e viceversa il desiderio è
una protezione del godimento e dal godimento, ad impedire che il piacere diventi un motore
autonomo di se stesso, macchina routinaria che si afferma annullando ogni presenza attiva, ogni
funzione personale e personalizzante del desiderio. Due aspetti imprescindibili: il piacere né
coincide con il desiderio, né può prescinderne o escluderlo; non può prescindere dal desiderio (non
sarebbe piacere o si nega nella propria dinamica realizzazione), non può coincidere con il desiderio,
non può esaudirlo (non può esaurirlo, sarebbe estinguerlo; il desiderio lo supera nel suo limite; ne
viene alimentato ma lo rilancia mentre lo motiva personalmente).
Affinché il desiderio possa continuare a esistere come desiderio, è necessario riconoscerlo
mantenerlo nella sua insoddisfazione; o meglio, deve essere orchestrato nella sua soddisfazione
quale si verifica nel necessario percorso di sottrazione del bisogno; l’ipotesi della sua soddisfazione
coinciderebbe con la sua estinzione; la soddisfazione del bisogno non può coincidere con la
soddisfazione del desiderio; questo mantiene una immanente pulsione di trascendenza. Ma il
desiderio senza piacere, consegnato unicamente ad essere conservato nella sua insoddisfazione,
colpito attraverso la sistematica non soddisfazione del bisogno, è negato o distorto (distorto nella
forma del godimento della stessa privazione) nella sua trascendenza generativa, nella sua capacità di
esprimere il soggetto nella sua realizzazione etica specifica e propria. In questa dinamica di
relazione del piacere con la trascendenza del desiderio, che il piacere stesso è in sorte ma anche in
grado e in dovere di salvaguardare, si colloca sia il tormento, la melanconia (la dolce melanconia)
del piacere, sia la proposta etica che si esprime anche nella tecnica della sottrazione formulata da
Epicuro. Nei due casi, sia il piacere senza il desiderio, sia il piacere che coincide con il desiderio, il
piacere è la fine del desiderio e di quello scarto etico, di trascendenza e di movimento nei confronti
di sé, che segna la condizione propria dell’umanità.
Dunque occuparsi del desiderio, del proprio desiderio è occuparsi dell’anima, prendersi in carico. Il
soggetto si sperimenta come desiderio e il desiderio è il tratto unitario e continuativo del soggetto,
campo della sua identificazione primaria e della sua continua scoperta di sé, che può essere gestito
da un’etica del piacere; non dal piacere privo di analisi ma da un’etica del piacere espressa da
Epicuro nel binomio ricorrente: assenza di sofferenza, assenza di turbamento.
La situazione si muove dunque tra due estremi: non è piacere quello che si separa dal desiderio, anzi
Epicuro sembra già alludere all’orrore distruttivo del godimento privo di desiderio (e viceversa)
ricorrente in società di lusso; se c’è solo il piacere, senza desiderio, questo attiva comportamenti
distruttivi; («sganciamento del desiderio dal godimento facendo del godimento stesso un puro
godimento di morte, profondamente nichilistico, tendenzialmente dissipativo… un godimento che
consuma fino a distruggere se stesso [accompagnato dalla conseguente] riduzione nichilistica del
mondo a risorsa da sfruttare illimitatamente.» Recalcati Massimo 2016, Jacques Lacan, Volume II.
La clinica psicoanalitica: struttura e soggetto, Raffaello Cortina editore, Milano, 630).
Ma è altrettanto distruttivo il piacere che coincide o che si vuol far coincidere con il desiderio,
annullando il desiderio perché non si sopporta la trascendenza e la “mestizia” che quella
trascendenza può generare, annullando la situazione di mancanza che esso segnala e costituisce,
14
ottenendo così l’effetto di annullare, cancellare il futuro. Posizioni che finiscono per incontrarsi.
3.1.1. A distanza di molti anni, per cammini propri e non con riferimento alle tesi di Epicuro,
osserva Jacques Lacan: « … l'esperienza analitica ci permette invece di enunciare la funzione
limitata del desiderio. Il desiderio, più di qualunque altro punto della spanna umana, incontra da
qualche parte il suo limite. … sottolineo di aver detto desiderio e non piacere. Il piacere è ciò che
limita la portata della spanna umana – il principio del piacere è principio di omeostasi [in biologia,
la condizione interna di equilibrio degli organismi animali, che assicura una normale attività
biologica delle cellule e dei tessuti]. Il desiderio, dal canto suo, trova la sua linea di contorno, il suo
rapporto fissato, il suo limite, ed è nel rapporto con questo limite che si sostiene come tale,
superando la soglia imposta dal principio del piacere.» (Lacan Jacques 1964, Il seminario. Libro XI.
I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi 1964, Einaudi, Torino 2003, 31-32) In questo
contesto, l’analisi della depressione si apre a una posizione etica: la depressione passa dal campo
dei disturbi psichici al campo dei comportamenti etici; si tratta di un difetto etico, quello della viltà,
qui intesa come incapacità o non volontà di stare presso o nel proprio desiderio, che significa stare
presso o nella propria umanità. «…della "tristezza" depressiva: «La tristezza [...] viene qualificata
come depressione quando le si dà come supporto l'anima o la tensione psicologica [...]. Ma non è
uno stato d'animo, è semplicemente una pecca morale, come si esprimeva Dante, o anche Spinoza:
un peccato, il che vuole dire una viltà [lâcheté] morale [...].» Jacques Lacan. La depressione viene
sottratta drasticamente ai cosiddetti disturbi dell'umore e ricondotta alla sua dimensione etica, al suo
rapporto stretto con la responsabilità soggettiva. In questo modo Lacan si riaggancia a una celebre
tradizione - non solo a Dante e a Spinoza, ma ancora più significativamente ai Padri della Chiesa che si condensa nell'idea di Tommaso d'Aquino secondo cui la depressione, sotto forma di
"accidia", viene annoverata come uno tra i sette "vizi capitali". Lacan si affida all'autorità dei Padri
della Chiesa per mettere in risalto lo statuto specifico di "peccato morale" della depressione. In
gioco non è una malattia dell'umore o della volontà, ma una viltà, quella appunto di cedere sul
proprio desiderio […]quella soprattutto di non volere sapere la verità del proprio desiderio
inconscio, che è il principio che orienta, invece, l'etica della psicoanalisi. […] La colpa che rapporta
nella nevrosi il soggetto al proprio desiderio e che si intreccia con la dimensione etica della
responsabilità…» (Recalcati Massimo 2016, Jacques Lacan, Volume II. La clinica psicoanalitica:
struttura e soggetto, Raffaello Cortina editore, Milano 251-252, 253)
3.1.2. La funzione del piacere nella gestione etica del desiderio è di fondamentale rilievo. È il
piacere infatti che forgia il desiderio secondo le forme di una fisionomia personale, sottraendolo a
gestioni eteronome, esterne (dai dubbi fini); lo porta cioè alla gestione attiva e al giudizio morale
del soggetto; rende di conseguenza l’etica non un insieme di norme e principi esterni all’uomo, ma
un processo di definizione e formazione di sé nel massimo potenziamento etico del desiderio,
conservandone la natura di principio e la irrinunciabile trascendenza. Il piacere diventa la tecnica
pratica attraverso cui l’uomo gestisce la dimensione della propria strutturale mancanza.
3.2. La coincidenza di piacere e desiderio o mette in luce la pochezza del desiderare o, se ricercata,
genera sconforto e turbamento, spinge alla continua ricerca di una ossessiva ripetizione
dell’identico quando si avverte (si percepisce anche e per lo più non concettualmente) come non sia
possibile che i due processi (godimento e desiderio) possano identificarsi e coincidere. In tal caso
entrambi si annullano e con loro perisce ogni individualità o ogni senso del vivere. La ripetizione e
la sua ricerca, magari affannosa, non significa il trionfo del desiderio, ma la sua agonia febbrile o la
sua perdita mortifera. Sono poste qui le categorie per la lettura di un sistema di civiltà che si regge
in termini di dominio culturale e di profitto economico sullo sfruttamento subdolo, leggero ma
sistematico, di questa perdita o di questo sfruttamento, collocando in quella assenza e in quel vuoto
del desiderio ipotesi di infinito godimento. «Offrendo merci, oggetti-feticcio, oggetti-gadget,
oggetti-idoli, che, anziché rispondere ai bisogni dei cosiddetti consumatori, rinnovino una domanda
permanentemente insoddisfatta. Questa è la sua astuzia pazzesca: generare nel soggetto false
mancanze per mantenere il soggetto stesso in uno stato di continua insoddisfazione […] Il possesso
e il consumo dell'oggetto, anziché dare pace al soggetto, devono alimentare in esso sempre una
15
nuova insoddisfazione. La produzione della mancanza diventa così altrettanto importante
dell'illusione offerta del suo soddisfacimento. Il raggiro consiste nel promettere perversamente la
negazione della perdita che il linguaggio iscrive nel cuore dell'umano, di cancellare l'impossibile
che accompagna l'esperienza del desiderio. […] la merce si anima socialmente di un valore
che prescinde dal suo uso perché lo stravolge, lo eccede, lo distorce sistematicamente per
valorizzare la dimensione più estesa del prestigio, del sembiante, dell'apparenza come nuova forma
di vita. […] L'oggetto di godimento come trasfigurazione fasulla … illude di poter guarire il
soggetto dalla perdita di godimento che il discorso della Civiltà impone alla vita umana. […] da
una parte promette la felicità in terra … - offrendosi come guaritore della divisione soggettiva -,
dall'altra fa riapparire il reale nella forma della ripetizione priva di soddisfazione di un consumo di
tutto che si rivela come totalmente mortifero. Il consumo … è sganciato dal desiderio del soggetto;
è un consumo privo di soddisfazione; è consumo di consumo; consumo fino all'esaurimento, fino
alla morte stessa del soggetto.» (Recalcati Massimo 2016, Jacques Lacan, Volume II. La clinica
psicoanalitica: struttura e soggetto, Raffaello Cortina editore, Milano, 631, 632, 634)
Epicuro, nel proporre la centralità etica del piacere, non celebra affatto il godimento fine a se stesso,
che diventa la perenne ripetizione dello stesso; godimento mortale che è pulsione di morte e dissipa
la vita proprio quando la esprime come potenza vitale che non conosce limiti e quindi non conosce
relazioni; si pone come autoconsistente e come godimento senza adesione alla concretezza del
vivere mortale; anzi denuncia proprio questa situazione.
3.2.1. Il desiderio attesta nell’uomo uno scarto tra soggettività e “nuda vita” e delinea lo specifico
dell’umano; occorre allora gestire il desiderio o stare in questo scarto evitando gli estremi della sua
assolutizzazione (diventa l’unico scopo) e della sua negazione (annullare il desiderio per la nuda
vita in dimensione animalità). L’etica come scienza e arte dell’uomo e non sistema delle regole
deve rispondere a questa urgenza; cioè, gestire il desiderio è gestire la soggettività in quello scarto
che caratterizza l’essere umano, non riducibile né all’animalità né alla divinità; animali e divinità
che si caratterizzano per l’assenza di desiderio, nei primi si può parlare di bisogni, nella seconda di
beata e imperturbabile felicità senza “fantasmi”.
«…uno scarto irriducibile tra «soggettività» e «nuda vita»: «al di fuori della fame che può essere
soddisfatta, della sete che può essere estinta e dei sensi che possono essere appagati» il soggetto
resta, comunque e irrimediabilmente, abitato da un desiderio che di continuo lo riapre e sconcerta
portandolo al di là della «nuda vita», cioè «al di là delle soddisfazioni» ; o anche: «l'uomo "è ciò
che mangia"», e pur tuttavia egli «è e resta desiderio in quanto tale». Lo sconcerto del soggetto è
pertanto da ricondurre allo spaesamento, allo spiazzamento a cui il desiderio lo costringe
sollecitandolo verso un altrove, un al di là, in cui egli, il soggetto, non riesce più a risolvere la
totalità di se stesso (la propria verità) nel puro dominio (potere e sapere) sugli oggetti: il desiderio
decentra il soggetto marcandolo con una mancanza che in verità non potrà mai trovare compimento
e pace nel godimento centrato sul possesso di un oggetto «in quanto tale». (Petrosino Silvano, 2015,
L’idolo. Teoria di una tentazione dalla Bibbia a Lacan, Mimesis, Milano, 81)
3.3. Desiderio e piacere devono allora trovare un’alleanza. Bisogna resistere e restare fedeli al
proprio desiderio e occorre trovare la via giusta per far sì che il piacere sia capace di recuperare un
godimento in grado di rendere la vita soddisfatta, di promuovere la felicità e non di promuovere se
stesso; l’esperienza dimostra che arrivati a un certo punto gli oggetti e le esperienze ripetute
ossessivamente hanno la tendenza a spiazzare i bisogni emotivi, le attese e i progetti che avrebbero
dovuto sostenere.(«Se gli oggetti conquistano ogni luogo, anche mentale, non si consuma forse la
condizione stessa dell’esperienza e del desiderio?» Giulio Azzolini) «I desideri limitati sono in
armonia con il mondo, i desideri che contengono l’infinito non lo sono.» (Simone Weil)
Osserva Judith Butler: « Lacan – sciaguratamente, a mio parere – metteva in guardia: "Non
rinunciare al tuo desiderio". E la sua era un'affermazione ambigua, perché non diceva che il tuo
desiderio potrebbe o dovrebbe essere soddisfatto. Si limitava a dire che il desiderio non dovrebbe
mai essere frenato. Eppure, in realtà, la soddisfazione spesso è proprio il mezzo per rinunciare al
16
desiderio, il mezzo con cui si reagisce a esso decretandone una rapida morte.» (Butler Judith 2005,
Critica della violenza etica, Feltrinelli, Milano 2006, 62)
3.4. Contro l’ascetismo fine a se stesso e contro il moderno (?!) ascetismo del lusso: il moderno
ascetismo che esasperando il piacere facendo riferimento ad esso come processo irrinunciabile, ma
rendendolo complesso e sempre più attrezzato, lo nega; genera insoddisfazione e vuoto, percezione
di non-senso. Ad un tempo la paura della morte, che viene socialmente occultata, è la paura della
conclusione. Dunque il circolo dell’inquietudine negativa: esasperazione dell’attesa (fino al sogno
divino dell’immortalità), paura della conclusione (fino all’occultamento della morte vissuta come
un fallimento). Riflessione intorno a due limiti antropologici: il divino, la morte.
3.5. in sintesi e riepilogo (con ripetizioni) espositivo.
[1] le due situazioni estreme (da escludere) e il loro comune esito
[1.1] l’assenza del desiderio: un piacere senza desiderio…
[1.2] la coincidenza col desiderio: un piacere che coincide con il desiderio…
nei due casi il piacere è la fine del desiderio, la fine del desiderare e, con ciò, del senso del vivere.
[2] la direzione da intraprendere e salvaguardare
[2.1] mantenersi connessi alla trascendenza del desiderio e saperla conservare, vivendo la
“mestizia” struggente e feconda di quella trascendenza (contro l’ascetismo devastante del lusso)
[2.2] trovare un’alleanza tra desiderio e piacere restando fedeli al proprio desiderio e al suo
personale limite. Torna qui l’arte della sottrazione (del “modus tollens”), la consapevolezza
espressa da Simone Weil: «I desideri limitati sono in armonia con il mondo, i desideri che
contengono l’infinito non lo sono.» Far sì che la vita sia capace di recuperare un godimento in grado
di rendere la vita soddisfatta (senza dolore e paure).
4. lo statuto di una scienza che nasce all’interno di un’etica della felicità
Il nuovo statuto della scienza, una scienza etica: non un’etica che ricava il proprio metodo dalla
scienza, ma un’etica che indica il fine della scienza e le condizioni del suo rispetto: liberi da paure e
bisogni. Tutto ciò a partire dalla centralità del piacere e del ruolo che esso svolge nella gestione del
desiderio secondo felicità, cioè tranquillità fisica e mentale.
4.1. Il metodo di un’etica per l’uomo. L’obiettivo totalmente umano dell’etica di Epicuro si fonda
su di una impostazione che, a distanza, mostra tutto il proprio aspetto rivoluzionario nei confronti di
etiche che si affermano prima e dopo la filosofia di Epicuro, e sono ancora ai vertici della fama e
della stima oggi. Risulta rivoluzionaria nei confronti di quelle etiche che si presentano come sistemi
scientifici deduttivi in quanto dichiarano di fondarsi su principi e valori primi definiti indubitabili e
imprescindibili. Le formule che garantiscono ai loro enunciati di partenza il ruolo di principi sono
consegnate alla dichiarazione del loro essere universali, trascendenti, astorici… e comunque
assoluti. Le dottrine etiche che ne derivano (in un plurale che risulta di per sé contraddittorio)
tendono di conseguenza ad assumere la forma di un sistema scientifico deduttivo da cui ricavano la
possibilità di concludere in tavole di leggi morali universali e necessarie.
L’impostazione dell’etica di Epicuro e la sua lontananza da qualunque dottrina morale-valoriale. Se,
infatti, le morali tradizionali hanno legato e legano l'etica al piano dei valori ideali, la morale di
Epicuro la vincola al piano dell’umano nella sua realtà concreta e totale. La mossa che Epicuro
compie appare analiticamente frutto di un doppio movimento: di liberazione e di proposizione.
Libera l'etica dall'assillo dei valori, dalle ombre degli ideali, riconducendone il fondamento al
principio del bene soggettivo (in quanto tale formalmente universale), mostrando però come il
godimento non coincide affatto né con l'utile, né con il bene del soggetto proclamati da dottrine
universali astratte. Proprio lavorando sul principio del piacere dal punto di vista etico, Epicuro
mostra la tendenza del soggetto a ricercare il proprio male. È quanto accade in una sorta di
“compulsione a ripetere” (come la chiamerà Freud): il soggetto trascende la cornice del principio di
piacere perché tende a ripetere esperienze che gli procurano sofferenza. «Tutti i piaceri dunque, per
loro natura a noi congeniali, sono bene, ma non tutti sono da eleggersi; così come tutti i dolori
sono male, ma non tutti sono tali da doversi fuggire. In base al calcolo e alla considerazione degli
17
utili e dei danni bisogna giudicare tutte queste cose. Talora infatti esperimentiamo che il bene è per
noi un male, e di converso il male è un bene. Consideriamo un gran bene l’indipendenza dai
desideri, non perché sempre dobbiamo avere solo il poco, ma perché, se non abbiamo il molto,
sappiamo accontentarci del poco; profondamente convinti che con maggior dolcezza gode
dell’abbondanza chi meno di essa ha bisogno, e che tutto ciò che natura richiede è facilmente
procacciabile, ciò che è vano difficile a ottenersi. […] Quando dunque diciamo che il piacere è il
bene, non intendiamo i piaceri dei dissoluti o quelli delle crapule, come credono alcuni che
ignorano o non condividono o male interpretano la nostra dottrina, ma il non aver dolore nel corpo
né turbamento nell’anima». Epicuro, Lettera a Meneceo.
Le tesi di Freud e della psicanalisi possono presentarsi come un utile commento per comprendere
l’impianto di metodo dell’etica di Epicuro: «Il principio di piacere definiva per Freud la legge più
elementare dell'apparato psichico, secondo la quale l'obiettivo del soggetto è quello di mantenere la
tensione interna al livello più basso possibile. Il principio di piacere definisce, in senso aristotelico
secondo Lacan, il criterio dell'azione soggettiva come ispirato da una ragione naturale: evitare il di
spiacere e procurarsi il piacere. Ma con Al di là del principio di piacere Freud sfonda questa cornice
edonistica dell'etica. Egli svela l'attrazione inquietante dell'uomo verso un godimento non naturale,
eccessivo, maligno, strutturalmente masochistico. Di qui la centralità assegnata dall'ultimo Freud
alla pulsione di morte come principio che, al di là del principio di piacere, spingerebbe il soggetto
verso la ripetizione di un godimento maligno, contrario alla legge dell'omeostasi, antinaturale.» (Di
Ciaccia, Recalcati, 2000, Jacques Lacan, 197-198). Prende avvio da qui un’etica dell’uomo e per
l’uomo che può tendere all’obiettivo della felicità in quanto ne rispetta e sostiene l’intrinseco
principio al piacere secondo un desiderio che non ne alteri la naturale funzione.
4.2. L’etica di Epicuro non adotta l’impianto deduttivo di carattere scientifico per definirsi come
dottrina ma non per questo ritiene di secondaria importanza la scienza, anzi ne rilancia la funzione e
ne definisce il ruolo indispensabile costruendo per essa un procedimento di metodo sulla tesi del
fine etico della scienza, della filosofia, della conoscenza in generale.
È ancora sul principio del piacere e della sua base per la felicità che prende forma l’utilità, anzi
l’urgenza e la necessità della ricerca, della scienza e della conoscenza. La scienza si impone in
contesto antropologico in quanto si abbina alla consapevolezza che tra il principio del piacere e la
disponibilità delle nozioni secondo l’ordine del significare logico esiste una discontinuità radicale e
una distanza incolmabile per il doppio più di possibilità: del piacere/desiderio, della realtà.
Il carattere strumentale della conoscenza scientifica, costantemente subordinata al supremo fine
etico, l’imperturbabilità, è efficacemente riassunto nella lapidaria prosa dell’undicesima massima
capitale di Epicuro: «Se non ci turbassero per nulla i sospetti delle cose celesti e quelli sulla morte,
che essa non abbia a essere qualcosa per noi, e ancora il non conoscere i confini dei dolori e dei
desideri, non avremmo bisogno della scienza della natura».
La conoscenza dell’universo fisico trova dunque la sua legittimazione non nella meraviglia, cui
Aristotele fa esplicito riferimento nelle sue opere, o in se stessa, ma nella sua capacità di liberare
l’uomo dalle paure infondate, dai fantasmi prodotti dall’immaginazione popolare o dai sistemi
metafisici della tradizione.
«È compito della scienza della natura darci preciso conto della causa dei fenomeni più importanti,
... in questo risiede la felicità, e nel conoscere la natura dei corpi che contempliamo nei cieli, ed in
tutte le conoscenze congeneri rispetto al raggiungimento della perfetta scienza che renda la vita
felice.» (ad Erodoto)
«Bisogna esser persuasi che dalla conoscenza dei fenomeni celesti in qualsiasi modo se ne tratti, o
unitamente ad altre dottrine o separatamente, non può derivare altro scopo se non la tranquillità e
la sicurezza dell’anima, ciò che del resto è pure lo scopo d’ogni altra ricerca.» (a Pitocle)
«Non scioglie il terrore di ciò che all’uomo più importa, chi non sa quale sia la natura
dell’universo e sta in ansia e sospetto per le favole dei miti. Senza studio della natura non è dunque
possibile godere schietti piaceri.» (Massime capitali XII)
«Non vi è tranquillità d’animo se non nell’essere sgombri da tutti questi errori e nel ricordarci
18
assiduamente delle dottrine generali e fondamentali… Quelli poi che non possono del tutto
considerarsi fra i perfettamente edotti della mia dottrina, possono da questi precetti, per quanto è
concesso senza insegnamento orale, compiere mentalmente l’esame complessivo delle dottrine più
importanti per il conseguimento di una vita serena.» (ad Erodoto)
spunti di lettura:
—la scienza, il sapere, tende ed ha il suo movente nella felicità (rapporto scienza —felicità come
criterio di validità della scienza)
—felicità: non definita in positivo, come conseguimento di precisi obiettivi o stati, ma come libertà
dalla paura o da turbamenti
—ci libera dalla paura la scienza
—questo è il massimo piacere: il non essere turbati da...; il piacere è la stato in cui ci colloca il
sapere, piacere inteso come vita serena, come quiete, tranquillità frutto di saggezza
—premesse per un’etica fondata sul piacere
4.3. Il metodo della scienza e della filosofia, ispirato dal fine etico (atarassia – eudaimonia), ha il
proprio fondamento sulla base materiale di cui si occupa, atomi e vuoto, e sui mezzi di cui l’uomo
dispone per arrivare alla conoscenza: la sensibilità, l’accordo con i fenomeni,lepre nozioni, il
raziocinio dimostrativo.
«Per prima cosa occorre convincersi che nello studio dei fenomeni celesti, sia considerati nella
loro relazione reciproca sia indipendentemente gli uni dagli altri, non vi è altro scopo da
conseguire se non la imperturbabilità dell’anima e la sicura fiducia, così come nelle altre ricerche;
e non si deve far forza alle cose per ottenere l’impossibile, né usare lo stesso metodo riguardo a
tutti gli oggetti, sia che si tratti della ricerca sui modi di vita o della ricerca volta alla soluzione dei
problemi che pone la scienza della natura, come per esempio «il tutto consta di corpi e della natura
intattile [il vuoto]», o «gli elementi ultimi della realtà naturale sono indivisibili», o altre
proposizioni che, come queste, comportano una sola soluzione in accordo con gli oggetti
dell’esperienza. Per ciò che riguarda i fenomeni celesti, le cose vanno diversamente: essi
ammettono più spiegazioni causali della loro origine e la possibilità di più determinazioni della
loro essenza, purché sempre in accordo con le sensazioni. Quando si studia la scienza della natura,
non bisogna procedere per enunciati vani e posizioni arbitrarie, ma così come richiedono gli stessi
oggetti dell’esperienza sensibile.» (Lettera a Pitocle)
Quindi, quanto al metodo, Epicuro, nella Lettera a Pitocle, ricorda che lo studioso «non deve far
forza alle cose per ottenere l’impossibile né usare lo stesso metodo riguardo a tutti gli oggetti»: vi
sono ambiti della ricerca nei quali è possibile e doveroso pervenire a una spiegazione unica e certa,
altri in cui invece ci si trova dinanzi a più spiegazioni che si presentano come ugualmente valide in
quanto nessuna di esse è smentita dall’esperienza
Lo studioso deve avere ben chiara la distinzione tra gli ambiti in cui è necessario applicare il
metodo della spiegazione unica e quello in cui deve aprirsi ad accogliere «spiegazioni multiple»:
nelle scienze della natura in cui si tratta di ammettere l’esistenza di qualche cosa che c’è o non c’è
— come ad esempio gli atomi e il vuoto — si deve pervenire a una sola spiegazione che affermi in
modo rigoroso e necessario se tale ente esiste o non esiste; quando invece si indagano fenomeni,
come quelli celesti, per i quali si possono inferire diverse spiegazioni «plausibili», si devono
ammettere tutte le spiegazioni possibili che non sono smentite dall’esperienza; preferire una
spiegazione alle altre, senza la sicurezza che questa sia vera e le altre false, significa cadere nel
mito.
Il principio ispiratore è ancora una volta etico: le caratteristiche ed il metodo del sapere saranno tali
da consentire il fine etico del piacere e della felicità [sempre rettamente intesi] (o: metodologia da
seguire nella spiegazione dei fenomeni fisici, ai fine di arrivare all’animo sereno e felice):
a) procedere per analogie.
«...l’ordinata successione dei fenomeni celesti deve spiegarsi con l’analogia di consueti fenomeni
che accadono sulla terra. Non si assuma invece mai come causa di essi la natura divina, ma la si
conservi libera da ogni ministerio e in illibata beatitudine. Se così non si farà ogni nostra indagine
19
sulle cause dei fenomeni celesti sarà vana.» (a Pitocle)
b) spiegazione meccanica, non intenzionale-personalistica, dei fenomeni fisici.
«Senza dubbio poi i moti celesti e le rivoluzioni e l’eclissarsi ed il sorgere ed il tramontare degli
astri, e tutti i simili fenomeni, non si deve credere siano prodotti per apposito ministerio di alcuno
che dia loro o debba dare regola o misura, o pur tuttavia possegga l’assoluta beatitudine o
l’immortalità. Infatti occupazioni o cure od ire e benevolenze, non s’accordano con lo stato di
perfetta beatitudine, ma vengono da debolezza e timore e necessità di assistenza da parte dei vicini.
Ed altresì non è dubbio che l’universo fu sempre quale è ora, e tale sarà sempre; perchè non vi è
nulla in cui possa mutarsi; infatti oltre il tutto non vi è nulla, che possa penetrandovi produrvi
mutazione.» (segue la teoria dei corpi: atomi o vuoto, e del loro movimento eterno). «Ed ancora, i
mondi sono infiniti, sia quelli simili ai nostri sia quelli dissimili dal nostro. Perchè gli atomi, che
abbiamo testè dimostrato essere infiniti, percorrono anche i più lontani spazi.» (ad Erodoto)
c) le diverse spiegazioni possibili
«Senza dubbio si ottiene l’assoluta tranquillità spirituale su tutti quei problemi che si risolvono
secondo il metodo delle spiegazioni molteplici, in accordo con i fenomeni, quando rispetto ad essi
si mantengono, secondo è giusto, quelle spiegazioni che sono probabili. …Coloro invece che
accettano un solo modo di spiegazione, non solamente si pongono in contrasto con i fenomeni, ma
anche perdono di vista il limite imposto alla possibilità della umana conoscenza [cioè le sensazioni
come unica fonte di conoscenza] ... Del resto l’esperienza dei fenomeni terrestri indica che diverse
possono essere le cause anche di questi fenomeni dei quali qui ci occupiamo. In più modi si
originano i lampi ...» (tale metodo viene applicato ai vari fenomeni studiati: tuoni, lampi, nubi,
cicloni, terremoti, venti ecc. e viene ribadito che il non attenersi a questo metodo è cadere nel mito)
(a Erodoto, a Pitocle)
(riassumendo: pretendere di avere una spiegazione unica (una causa unica) è: non rispetto del limite
sensitivo, cadere nel mito (prestar fede a favole mitologiche e non aver più alcun strumento di
difesa dalla paura e impedirci la serenità—tranquillità—felicità), stoltezza = non conoscenza e
ancora non serenità; la filosofia di Epicuro è “esame complessivo delle dottrine più importanti per il
conseguimento di una vita serena”)
d) accordo con i sensi
«E nel Canone appunto dice Epicuro, essere criteri del vero: le sensazioni, lo prenozioni, i sensi
interni. Infatti gli dice che ogni sensazione è irrazionale e non partecipa di memoria, e certamente
non ha attività di per se stessa, né mossa da oggetto può nulla aggiungervi e togliergli. E neppure
v’è nulla che possa confutarla... né d’altra parte può la ragione, perchè ogni ragionamento dipende
dai sensi: e neppure una sensazione può confutarne un’altra, perchè a tutte ci atteniamo… E certo
anche ogni nozione intellettiva procede dalle sensazioni, secondo l’incidenza, l’analogia, la
somiglianza o la composizione, contribuendovi in qualche misura anche il raziocinio.» (Diogene
Laerzio, Vita di Epicuro)
Il “metodo delle diverso spiegazioni possibili” è tratto dalla natura della sensazione: «Infatti tutte
queste possibilità (di spiegazione) e quelle affini ad esse, non contrastano a nulla che sia attestato
dalla evidenza effettiva dei fenomeni; purchè a tali argomenti, badando sempre al criterio della
possibilità, si sappia ricondurre ciascuna di queste spiegazioni all’accordo con i fenomeni, senza
paura degli artifizi degli astronomi, degni solamente di gente servile.» (a Pitocle) (Ciò rafforza e
indebolisce il criterio di verità basato sulla sensazione sia perchè la sensazione è suscettibile di
spiegazioni-letture diverse, sia per il concetto di prenozione).
e) le prenozioni
(precedenza dello nozioni —prolessi— per l’indagine)
«La prenozione (prolessi) essi (epicurei) designano come apprendimento o retta opinione, o
concetto o nozione universale insita in noi, cioè memoria di ciò che spesso ci è apparso dall’esterno:
come, per esempio, l’essere l’uomo ciò che ha certe determinate qualità: infatti appena
pronunziamo la parola uomo, subito, per prenozione, si pensa la sua forma e carattere proprio,
secondo i dati precedenti dei sensi… E non potremmo compiere le nostre indagini se questo prima
20
non conoscessimo; per esempio, data la domanda: Quello che è laggiù è cavallo o bue? per
rispondervi conviene, per mezzo della prenozione, conoscere già la forma del bue e quella del
cavallo.» (Diogene Laerzio ivi)
f) vanno escluse altre pratiche di spiegazione, quali:
—1) la divinità come causa; ciò è in contrasto con la natura della divinità: «Il supremo
perturbamento sorge negli uomini, primieramente ove si creda che tali nature siano beate ed
immortali, e che pur abbiano volontà ed opere e cause che contraddicano a questi attributi loro…
Non è irreligioso chi gli dei del volgo rinnega, ma chi le opinioni del volgo applica agli dei.» (a
Erodoto, a Meneceo); ed è in contrasto con la natura delle cose, che richiedono una spiegazione
meccanica e non personalistica. In questo contesto viene escluso il regresso all’infinito presente
nella logica di spiegazione causale totale; escluso anche e soprattutto quando, per introdurlo, si fa
riferimento ad una causa prima , divina (causa non causata) arrestando immotivatamente il processo
delle cause e contraddicendo il modello causale stesso.
—2) il destino (il fato, la fortuna ecc.): «Meglio era infatti tenersi ai miti sugli dei, che essere
schiavi al destino dei fisici, perchè quelli almeno ammettono speranza di placare i numi
onorandoli, questo invece ha implacabile necessità. E la fortuna, il saggio non la stima una
divinità...» (a Meneceo)
—3) la spiegazione unica (cfr. sopra)
—4) la spiegazione mitologica
nota l’equazione: spiegazione unica = spiegazione mitica
e l’equazione: spiegazione unica = paura (e altre eguaglianze possibili: spiegazione unica =
spiegazione mitica = desiderio di immortalità = paura della morte = paura della realtà nella sua
complessità = non scienza = non felicità)
— 5) nella spiegazione scientifica che si traduce nella ricerca di una spiegazione eterna unica
immutabile ecc. (e quindi mitica) è presente il desiderio e l’atteggiamento mentale dell’immortalità;
alla spiegazione unica, quindi mitica, Epicuro oppone il metodo delle molte spiegazioni possibili,
unico modo per restare fedeli alle sensazioni e restare in sintonia con la realtà.
4.4. il metodo ispirato dal fine etico è il contesto della analogia interna e profonda tra etica e
scienze: l’attenzione alla realtà, la ricerca per sottrazione dell’inganno e del superfluo: è il «metodo
dello scultore che abbozza la forma in un blocco di marmo, avvicinandosi alle superfici finali con
prudenza e moderatezza, procedendo per approssimazioni successive.» (Dennett C. Daniel 2013,
Strumenti per pensare, Raffaello Cortina editore, Milano 2014, 84-85)
5. la felicità e il non turbamento nei confronti del divino
La beatitudine divina del non turbamento. Nell’arte di gestione del piacere, in rapporto al desiderio
e alla felicità, e quindi alla conoscenza, non possono guidarci precetti e leggi esterne. Resta
l’assunzione etica di sé come Epicuro indica e propone, senza sentenze ma indicando un modello;
un modello che trova proprio nella divinità mentre paradossalmente afferma che in questo, come in
altro, il cielo non ci assiste.
5.1. La vera empietà e la vera religiosità, come retta nozione nei confronti del divino. «Le cose che
ti ho sempre raccomandato mettile in pratica e meditale reputandole i principi fondamentali
necessari a una vita felice. Per prima cosa considera la divinità come un essere indistruttibile e
beato, secondo quanto suggerisce la comune nozione del divino, e non attribuire ad essa niente che
sia estraneo all’immortalità o discorde dalla beatitudine; riguardo ad essa pensa invece a tutto ciò
che è capace di preservare la felicità congiunta all’immortalità. Gli dei esistono: evidente è infatti
la loro conoscenza; non esistono piuttosto nella maniera in cui li considerano i più, perché così
come li reputano vengono a toglier loro ogni fondamento di esistenza. Empio poi non è colui che
gli dèi del volgo rinnega, ma chi le opinioni del volgo attribuisce agli dèi, poiché non sono
prenozioni ma fallaci presunzioni i giudizi del volgo a proposito degli dèi. Da ciò i più grandi
danni e vantaggi si traggono dagli dèi; infatti dediti di continuo alle loro proprie virtù accolgono i
loro simili, tutto ciò che non è tale considerando come estraneo.» (Epicuro, a Meneceo)
21
5.2. L’assunzione umana del proprio limite consegue dalla retta nozione del divino. Non è empio
colui che nega l’esistenza degli dei ma colui che ne parla in modo volgare. E parla del divino in
modo volgare chi vi fa ricorso secondo il proprio bisogno e le proprie convinzioni; chiedendo aiuto
e contemporaneamente derogando dalle proprie responsabilità; citandolo a conferma di proprie tesi,
testimonianze, giuramenti, usandolo cioè come mezzo per il proprio vivere e per i propri interessi;
giocando sulla paure, sulle superstizioni, sull’incapacità generale a definire la natura degli dei per la
quale nessun dato sensibile ci fornisce materia. La retta nozione del divino, la cui esistenza è certa
(e solo questa è la certezza che l’uomo ha) si accompagna al concetto di perfezione, quindi, in
termini umani, di felicità e beatitudine, cioè assenza di turbamento; e ciò perché (o perciò) il divino
non si occupa di noi, non interferisce con la responsabilità dell’agire umano, ma è modello ideale di
vita felice per la imperturbabilità che lo caratterizza.
5.3. «Epicuro ha caratterizzato i suoi dèi come «esseri beati e immortali», che vivono un'esistenza
eternamente priva di turbamenti, disinteressati all'universo in cui abitano gli esseri umani. […]
Epicuro ha condiviso con gli stoici la credenza secondo cui la divinità è il paradigma di beatitudine:
una vita autenticamente felice presuppone una tranquillità che niente può sconvolgere; tanto più
perfezioneremo la nostra razionalità tanto più provvederemo gli esseri umani della capacità di
diventare simili agli dèi e sapienti.» (Long A. Anthony, 2015, La mente, l’anima, il corpo. Modelli
greci, Einaudi, Torino 2016, 114, 115)
6. la felicità e il non turbamento nei confronti della morte
Nel limite estremo del vivere, la morte, la retta nozione colloca le condizioni della felicità e della
piena apertura, senza timori, al reale o la felicità nella dimensione materiale finita; una retta nozione
della morte «rende gioibile la mortalità della vita».
6.1. Il presupposto fisico/metafisico o i principi universali. Muovendo dall’esperienza sensibile, ma
superandone i limiti oggettivi con il rigore della dimostrazione razionale, Epicuro individua negli
atomi e nel vuoto, nelle forme degli atomi e nel loro movimento continuo i principi con i quali è
possibile spiegare l’intera realtà, pervenendo così a una organica «visione generale delle cose». Non
percepibile con i sensi (gli atomi sono infatti minuscoli e il vuoto è per natura «intattile») l’esistenza
degli atomi e del vuoto è dimostrata razionalmente: i corpi devono infatti essere idealmente
divisibili in elementi minimi (gli atomi) oltre i quali non è possibile andare nella scomposizione, se
non si vuole dissolverli nel nulla; il movimento di tali atomi è inoltre possibile solo se si ammette
l’esistenza di uno spazio vuoto nel quale esso possa avvenire. Negare l’esistenza di atomi e vuoto
equivale a contraddire i sensi (che ci attestano l’esistenza dei corpi, la loro divisibilità e il loro
movimento) e il rigore della ragione (che, appunto, dimostra inequivocabilmente tale esistenza).
Atomi e vuoto sono ad un tempo realtà richieste dalla sensibilità e fondate sulla ragione o risultato
della lettura che la ragione, applicata all’esperienza, ci permette di raggiungere.
6.1.1. corpo anima si riconducono ad atomi e vuoto: un idealismo materiale senza dualismi.
Non c’è dualismo di sostanze tra anima e corpo ma differenza di composizione materiale; non c’è
materialismo in Epicuro (anche se molta vulgata nel tempo lo affermerà, Marx compreso) e non c’è
determinismo. Epicuro parla di “atomos ìdea” e lega strettamente realtà e mente: fa distaccare dagli
oggetti simulacri sottilissimi che penetrano poi negli organi di senso (Hans Blumenberg, La
leggibilità del mondo, il Mulino, Bologna 1981, p.17).Gli atomi sono infiniti, il vuoto è il loro
contesto, una inclinazione del loro movimento rende infinite e casuali (casuali nell’esito,
comprensibili nella dinamica) le possibilità aggregative; tutto ciò contro i limiti posti dalle
numerose teorie fisiche circolanti: fato, superstizione, causalità necessitante immanente o
trascendente, finalismi. Occorre aprirsi all’imprevedibile divenire del mondo come contesto di
libertà e scelta. Non c’è materialismo in Epicuro e perciò non c’è determinismo ma eterna e
imprevedibile vicenda di movimento.
6.1.2. la morte o il non essere. La morte, tanto temuta dagli uomini, appartiene al regno del non
essere: «quando ci siamo noi, non è presente la morte, e quando sia presente la morte, allora noi
22
non siamo». La morte esiste per gli altri, per coloro che sopravvivono e constatano la nostra fine,
ma per noi essa non c’è, non è esperibile in prima persona: tanto vale dunque non affliggerci con il
pensiero del suo incombere («giacché quel che essendo presente non affligge, vanamente addolora
anticipato nel pensiero»), ma anzi è bene vivere intensamente il presente, nella consapevolezza che
«nasciamo una volta sola, due volte non è possibile nascere». La morte è atomi in diversa
disposizione ma non rinascita; quest’ultima esprime solo e sempre un desiderio di immortalità.
6.2. La liberazione della paura della morte su base metafisica, su base scientifica e quindi anche su
base sociologica e psicologica e la serenità della dimensione mortale.
«Abituati o pensare che nulla è per noi la morte: in quanto ogni bene e male è nel senso, mentre la
morte è privazione del senso. Perciò la retta conoscenza che la morte è nulla per noi, rende gioibile
la mortalità della vita.... Il supremo turbamento sorge negli uomini … anche per la paura di quella
stessa insensibilità che è nella morte, come fosse per noi un male» (Epicuro, a Meneceo, a
Erodoto). Cioè non la morte è un male per l’uomo, essa è cessazione di mali, lo è invece la paura
della morte e questa, a sua volta, va fatta risalire, come alla sua causa, al desiderio della
immortalità. La direzione del pensiero di Epicuro sulla morte fonte di paura muove la mente ad un
cammino di smontaggio realizzato al contrario e con circolarità: il desiderio di immortalità genera la
paura della morte e, di converso, la paura della morte rivela e nutre un desiderio di immortalità, quel
desiderio che non accetta la morte come fatto naturale, dunque alimenta un desiderio non naturale di
immortalità; la morte è resa evento dal desiderio della immortalità e dal mancato rispetto della
natura dell’animo e dell’uomo conosciuti come mortali (Lucrezio, De rerum natura, III, 830-831;
l’intero libro III affronta il problema della natura dell’anima, dell’animo e del corpo e del problema
della morte trattato dal punto di vista fisico, sociale, psicologico ed etico ). La vera morte è quella a
cui noi riduciamo la vita quando siamo dominati dal timore della morte e l’ansia che ne deriva ci
rende incapaci di gestire la vita attraverso un piacere che si rapporta e regola il desiderio; in questa
situazione siamo morti in vita, è una “mortua vita”: «Tu cui la vita è quasi morta, mentre sei ancora
vivo e vedi» («mortua cui vita est prope iam vivo atque videnti» Lucrezio, De rerum natura, III,
1046). Lo stesso pianto per la morte altrui è l’espressione delle nostre paure e del nostro
smarrimento.
Giovenale, nelle Satire, riprende anche le tesi di epicurei e storici:
«Fortem posce animum mortis terrore carentem,
qui spatium vitae extremum inter munera ponat
naturae» (satire, X, 357-359)
«Chiedi un animo forte, libero dal terrore della morte,
che ponga un lungo corso della vita come ultimo tra i doni della natura».
6.2.1. Anche quando parliamo della nostra morte, ne parliamo dall’esterno, come se ne fossimo
estranei ed osservatori, escludendola implicitamente dalle nostra vicende. Osservatori sdoppiati
che assistono con angoscia alla propria morte: «Ognuno infatti che da vivo si rappresenta dopo la
morte… commisera se stesso; e infatti non riesce a separarsi da lì, né si stacca abbastanza dal
cadavere… confonde se stesso con quello e, stando dritto lì accanto, gli trasfonde il proprio senso.
Per questo si duole d’esser nato mortale e non vede che nella vera morte non ci sarà un altro se
stesso che possa, vivo, piangere la perdita di sé per se stesso e, stando in piedi, lamentarsi di
giacere a terra…» (Lucrezio, De rerum natura, III, 879-887). In tal modo la morte non ci riguarda
come qualcosa di proprio, la vita non è colta nella sua dimensione mortale e nella funzione fisica
ed etica di tale componente; il pensiero è dominato dalla immortalità, reincarnazione,
risurrezione, vita eterna (come accade per lo più nei riti funebri, anche della religione cattolica),
pensieri che rendono incomprensibile la vita o, magari, la rendono degna di disprezzo. Osserva
Sigmund Freud: un fattore «per cui secondo me oggi ci sentiamo così stranieri in questo mondo
che un tempo è stato così bello e rassicurante, è il turbamento determinatosi nel nostro modo, fino
ad ora ben fermo, di considerare la morte. Questo atteggiamento non era sincero. A sentir noi,
eravamo naturalmente pronti a sostenere che la morte costituisce l'esito necessario di ogni forma
di vita, che ognuno di noi ha verso la natura questo debito e deve essere preparato a saldarlo, e
23
che dunque la morte è un fatto naturale, incontestabile, inevitabile. In realtà però eravamo abituati
a comportarci in tutt'altro modo. C'era in noi l'inequivocabile tendenza a scartare la morte, a
eliminarla dalla vita. Abbiamo cercato di mettere a tacere il pensiero della morte e c'è in tedesco,
a tal proposito, persino un modo di dire: "pensare a una cosa come alla morte"; alla propria
naturalmente.[in nota: C'è, in italiano, un modo di dire analogo. Quando rifiutiamo qualcosa che
ci è sommamente sgradevole diciamo: "al solo pensiero mi sento morire".] In verità è impossibile
per noi raffigurarci la nostra stessa morte, e ogni volta che cerchiamo di farlo possiamo costatare
che in effetti continuiamo ad essere ancora presenti come spettatori. Perciò la scuola
psicoanalitica ha potuto anche affermare che non c'è nessuno che in fondo creda alla propria
morte, o, detto in altre parole, che nel suo inconscio ognuno di noi è convinto della propria
immortalità. Per quanto riguarda la morte altrui, l'uomo civile evita accuratamente di parlare di
una tale eventualità quando l'individuo in questione è presente […] Questo nostro modo di
considerare la morte ha comunque un grande effetto su tutta la nostra vita. La vita s'impoverisce,
perde interesse se non è lecito rischiare quella che, nel giuoco dell'esistenza, è la massima posta, e
cioè la vita stessa. Quest'ultima diventa vuota […] I nostri legami emotivi, la insopportabile
intensità del dolore quando un lutto ci colpisce, ci distolgono dall'esporci a pericoli per noi stessi
e per i nostri cari. Siamo restii ad avventurarci in una serie di imprese rischiose, anche se
necessarie…» (Freud Sigmund 1915, Considerazioni attuali sulla guerra e la morte, Opere 8,
Introduzione alla psicoanalisi e altri scritti 1915-1917 Bollati Boringhieri, Torino 2011, 137-138)
6.2.1.1. Radici storiche e lettura psicanalitica del desiderio dell’immortalità e del conseguente
atteggiamento di paura e turbamento nei confronti del vivere e del suo destino di morte. Sempre
da Freud. «Divenne allora logico prolungare la vita anche nel passato, immaginando le esistenze
anteriori, la trasmigrazione delle anime e le reincarnazioni: tutto allo scopo di togliere alla morte
il suo significato di annullamento della vita. Così ha avuto presto origine quel disconoscimento
della morte che abbiamo indicato… come una delle convenzioni della vita civile. […]
Dobbiamo qui appoggiarci al metodo d'indagine della psicoanalisi, l'unico che arriva fino a tali
profondità. Ci domandiamo: come si comporta il nostro inconscio in relazione al problema della
morte? La risposta sarà: quasi esattamente come l'uomo delle origini. Sotto un tale riguardo, come
sotto molti altri, l'uomo preistorico continua a vivere inalterato nel nostro inconscio. Il nostro
inconscio non crede dunque alla propria morte, si comporta come se fosse immortale. Ciò che
chiamiamo "inconscio" — gli strati più profondi della nostra psiche, fatti di moti pulsionali — non
conosce alcunché di negativo, non conosce la negazione (gli opposti infatti in esso coincidono), e
quindi neppure la propria morte, alla quale si può dare soltanto un contenuto negativo. La credenza
nella morte non trova in noi alcuna rispondenza pulsionale». (Freud Sigmund 1915, Considerazioni
attuali sulla guerra e la morte, Opere 8, Bollati Boringhieri, Torino 2011, 143-144)
6.2.2. È dunque il desiderio dell’immortalità, di possedere per noi un tempo senza fine (che, in
realtà, come dei re Mida del tempo ci porterebbe a non dare ad esso alcun valore, vista la sua
disponibilità senza limiti), che fa sorgere il discorso intorno all’anima considerata come sostanza
diversa e separata o separabile dal corpo e il tema della sua destinazione all’immortalità. Essa
sarebbe congiunta al corpo solo momentaneamente; ospitata o racchiusa e incarcerata in un corpo
che per natura sua è destinato a sicura corruzione. Su queste convinzioni fa leva una cultura del
disprezzo del corpo e un’etica del distacco dal corpo da realizzare con esercizi di ascesi già nella
vita corporea materiale par far sì che l’anima possa prepararsi ad un destino di immortalità. A tali
convinzioni Epicuro (e poi Lucrezio) oppone l’eternità materiale degli atomi e la riduzione
dell’anima a forme di atomi materiali; dunque una universale eternità cosmica.
6.3. La vita dell’uomo è felice solo nella dimensione mondana (materiale e spirituale indistinte)
finita. Il desiderio dell’immortalità ospita l’idea che il mondo non abbia valore di per sé ma in un
fine che lo trascende, in realtà ‘ideali’ che gli sono essenzialmente estranee. A quel desiderio e a
quella convinzione Epicuro oppone il suo ideale di felicità tutta mondana, l’insussistenza del
problema della morte, la convinzione che la soluzione di tutte le nostre difficoltà non sta
nell’aggiungere ‘infinito tempo alla vita mortale’ ma nel togliere il desiderio dell’immortalità, cioè,
24
nel conciliare l’uomo con la vita, con quel limite che la definisce in modo assolutamente individuale
e specifico. L’immortalità infatti non è prolungamento della vita ma la sua distruzione,
contestualmente infatti essa produce l’annullamento del ricordo e del desiderio. È invece la morte
(la sua naturale certezza) che genera il ricordo, la sua urgenza e il suo piacere; l’immortalità rende il
tempo irrilevante, annulla attese, progetti e “prenozioni”; annulla l’etica e con essa l’umanità e il
suo intrinseco e mondano trascendimento e produce, proprio mentre si vive una “mortua… vita”. Ed
è questa la vera morte; una morte al vivere, vivendo; riducendo così la vita ad una parvenza o
vivendola come tempo inutile. Ricostruendo il pensiero di Epicuro e della tradizione epicurea,
commenta Francesco Giancotti: «Folle chi, rincorrendo un bene futuro che vanamente immagina
superiore al presente, si defrauda degli unici beni sicuri: il grato ricordo delle gioie passate e il
godimento sereno delle presenti. Se il segreto della nostra felicità è qui, in noi stessi, pure qui,
nell’immanente cerchia della nostra coscienza, è la fonte della nostra infelicità, il nostro inferno. «E
senza dubbio tutte quelle cose che secondo la tradizione sono nell’Acheronte profondo, sono tutte
nella nostra vita. – Atque ea nimirum quaecumque Acherunte profundo prodita sunt esse, in vita
sunt omnia nobis» Lucrezio, De reum natura, III, 978-979; «È qui che la vita degli stolti diventa un
inferno – Hic Acherusia fit stultorum denique vita» Lucrezio, De reum natura, III, 1023. (Ritorna il
proposito di Freud: «Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo», Virgilio, Eneide VII, 312 «Se non potrò muovere le potenze del cielo, solleverò quelle degli inferi»).
Le mitiche figure di tormentati dell’oltretomba non sono vere che come simboli dei tormenti delle
nostre coscienze di vivi. La morte che noi dobbiamo fuggire non è quella che segue alla vita, ma
quella che è nella vita stessa, come sopore e delirio e terrore dell’animo: la “mortua vita” di
«mortua cui vita est prope iam vivo atque viventi» («tu la cui vita è quasi morta, mentre sei ancora
vivo e vedi» (Lucrezio, De rerum natura, III, 1046; e note p. 481).
«Perciò la retta conoscenza che la morte è nulla per noi, rende gioibile la mortalità della vita».
Appendice. In forma di confronto e di bilancio per definire le tesi etiche a partire dalle sue
radici (e come conclusione all’etica della cultura greco – latina)
5.1. la base: si assume come presupposto la tesi che il sentire etico trova la propria radice, la propria
definizione teorica e funzione pratica a partire dal modo con cui ci si rapporta al proprio corpo e alla
propria morte.
5.2. le posizioni: la cultura greco – latina mette di fronte a tre posizioni, filosoficamente (e con
sintesi di semplificazione) così richiamabili:
5.2.1. dualismo anima corpo (spirito – materia). È la nota tradizione filosofica (secondo la
tradizione storiografica) che caratterizza le posizioni di Pitagora, Socrate (?), Platone… Il corpo è
carcere, zavorra, strumento dell’anima, vera realtà dell’uomo; in tale ambito prendono corpo i temi
della trasmigrazione, liberazione, immortalità dell’anima in uscita dal corpo.
5.2.2. composizione e sinolo: anima è forma del corpo. La tesi si fonda sui concetti metafisici di
forma e materia, atto e potenza espressi dalla metafisica di Aristotele. Ne consegue che al
dissolversi del corpo, nella morte, la stessa anima si dissolve in quando cessa la propria essenza di
principio delle funzioni proprie e necessarie del vivente.
5.2.3. unicità e omogeneità della natura in relazione ad un unico principio. Non è dunque possibile
distinguere anima e corpo come due sostanze o come espressione di due diverse realtà (tra loro
difficilmente conciliabili) o due diversi principi metafisici e fisici. Si tratta delle posizioni di
Epicuro che pone atomi e vuoto a principi materiali della realtà, degli Stoici che presentano l’intera
realtà come manifestazione, razionale e provvida, del Logos, principio unico, dei Cinici che nel
proposito di smascherare le convenzioni e le costruzioni razionali che condannano l’uomo alla
paura e quindi alla schiavitù attaccano le posizioni ufficiali e in particolare l’insostenibile
distinzione tra dei, uomini, animali. In questa tradizione (come in quella espressa da Aristotele)
prende forma l’invito e l’imperativo ad aprirsi eticamente, in modo attivo e sereno, alla dolce
mortalità della vita; la coincidenza e l’incontro tra bene, virtù, felicità, piacere è possibile solo se si
abbandona ogni forma di dualismo metafisico tra anima e corpo, ogni desiderio di immortalità.
25