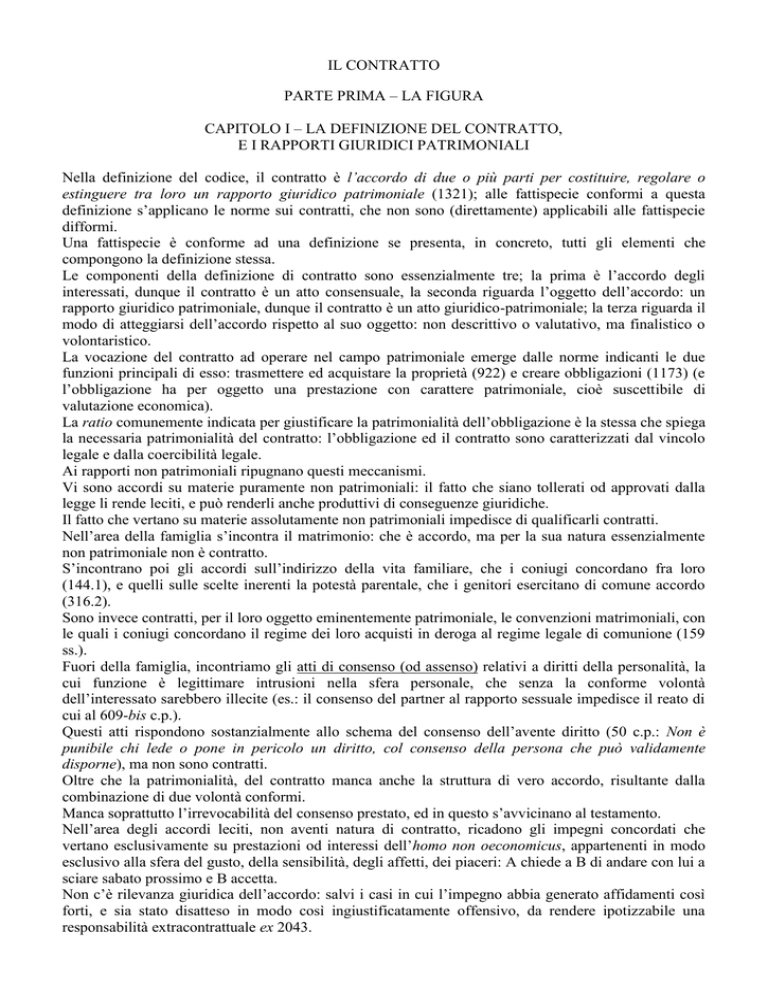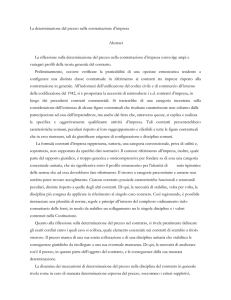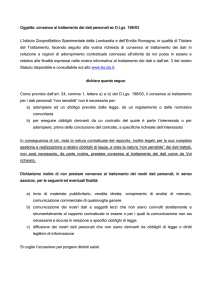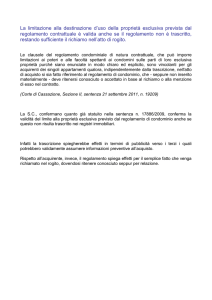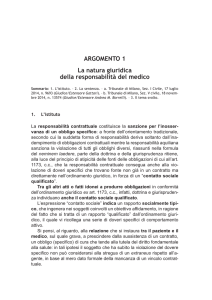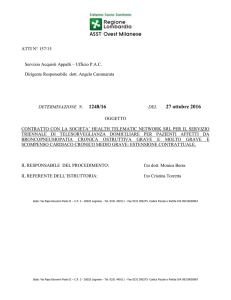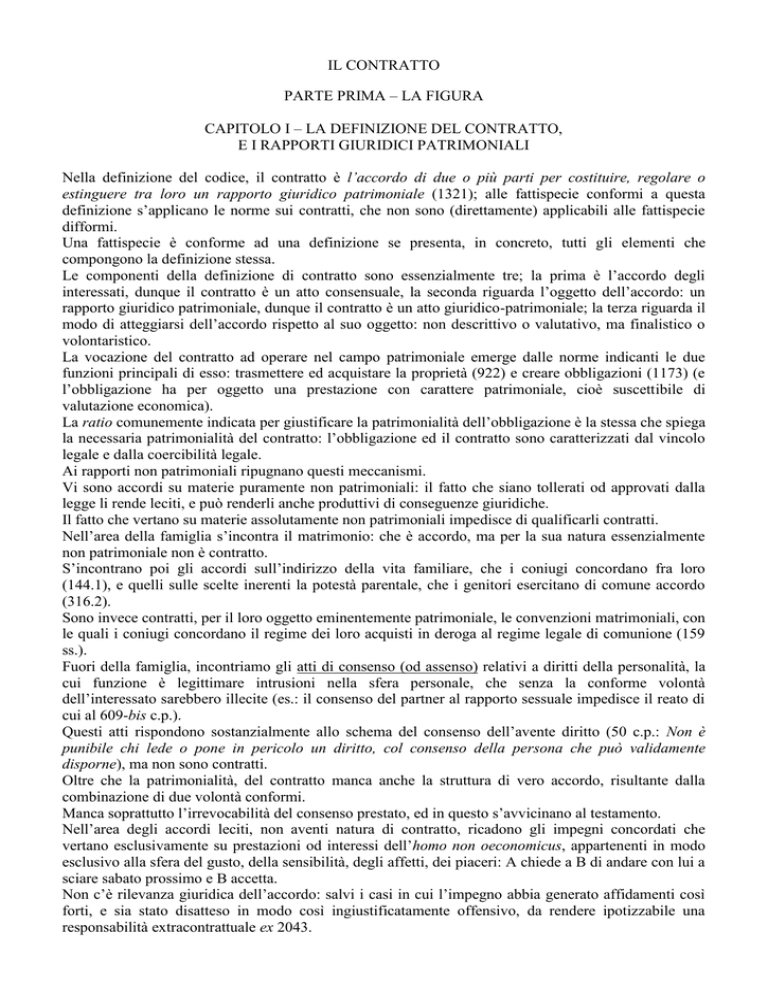
IL CONTRATTO
PARTE PRIMA – LA FIGURA
CAPITOLO I – LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO,
E I RAPPORTI GIURIDICI PATRIMONIALI
Nella definizione del codice, il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (1321); alle fattispecie conformi a questa
definizione s’applicano le norme sui contratti, che non sono (direttamente) applicabili alle fattispecie
difformi.
Una fattispecie è conforme ad una definizione se presenta, in concreto, tutti gli elementi che
compongono la definizione stessa.
Le componenti della definizione di contratto sono essenzialmente tre; la prima è l’accordo degli
interessati, dunque il contratto è un atto consensuale, la seconda riguarda l’oggetto dell’accordo: un
rapporto giuridico patrimoniale, dunque il contratto è un atto giuridico-patrimoniale; la terza riguarda il
modo di atteggiarsi dell’accordo rispetto al suo oggetto: non descrittivo o valutativo, ma finalistico o
volontaristico.
La vocazione del contratto ad operare nel campo patrimoniale emerge dalle norme indicanti le due
funzioni principali di esso: trasmettere ed acquistare la proprietà (922) e creare obbligazioni (1173) (e
l’obbligazione ha per oggetto una prestazione con carattere patrimoniale, cioè suscettibile di
valutazione economica).
La ratio comunemente indicata per giustificare la patrimonialità dell’obbligazione è la stessa che spiega
la necessaria patrimonialità del contratto: l’obbligazione ed il contratto sono caratterizzati dal vincolo
legale e dalla coercibilità legale.
Ai rapporti non patrimoniali ripugnano questi meccanismi.
Vi sono accordi su materie puramente non patrimoniali: il fatto che siano tollerati od approvati dalla
legge li rende leciti, e può renderli anche produttivi di conseguenze giuridiche.
Il fatto che vertano su materie assolutamente non patrimoniali impedisce di qualificarli contratti.
Nell’area della famiglia s’incontra il matrimonio: che è accordo, ma per la sua natura essenzialmente
non patrimoniale non è contratto.
S’incontrano poi gli accordi sull’indirizzo della vita familiare, che i coniugi concordano fra loro
(144.1), e quelli sulle scelte inerenti la potestà parentale, che i genitori esercitano di comune accordo
(316.2).
Sono invece contratti, per il loro oggetto eminentemente patrimoniale, le convenzioni matrimoniali, con
le quali i coniugi concordano il regime dei loro acquisti in deroga al regime legale di comunione (159
ss.).
Fuori della famiglia, incontriamo gli atti di consenso (od assenso) relativi a diritti della personalità, la
cui funzione è legittimare intrusioni nella sfera personale, che senza la conforme volontà
dell’interessato sarebbero illecite (es.: il consenso del partner al rapporto sessuale impedisce il reato di
cui al 609-bis c.p.).
Questi atti rispondono sostanzialmente allo schema del consenso dell’avente diritto (50 c.p.: Non è
punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente
disporne), ma non sono contratti.
Oltre che la patrimonialità, del contratto manca anche la struttura di vero accordo, risultante dalla
combinazione di due volontà conformi.
Manca soprattutto l’irrevocabilità del consenso prestato, ed in questo s’avvicinano al testamento.
Nell’area degli accordi leciti, non aventi natura di contratto, ricadono gli impegni concordati che
vertano esclusivamente su prestazioni od interessi dell’homo non oeconomicus, appartenenti in modo
esclusivo alla sfera del gusto, della sensibilità, degli affetti, dei piaceri: A chiede a B di andare con lui a
sciare sabato prossimo e B accetta.
Non c’è rilevanza giuridica dell’accordo: salvi i casi in cui l’impegno abbia generato affidamenti così
forti, e sia stato disatteso in modo così ingiustificatamente offensivo, da rendere ipotizzabile una
responsabilità extracontrattuale ex 2043.
Vi sono anche accordi su materie non patrimoniali, che vengono patrimonializzati dall’introduzione di
elementi economici destinati ad affiancare quelli non economici: questa patrimonializzazione indiretta,
o parziale, rende patrimoniale l’intero accordo: e così ne fa un contratto.
È principio comunemente accertato in giurisprudenza che una prestazione in sé non patrimoniale possa
dedursi in contratto, se a fronte di essa sia prevista una controprestazione patrimoniale, o se per il suo
inadempimento siano previste conseguenze economiche.
Una terza serie di casi riguarda accordi su materie non patrimoniali, la cui caratteristica dominante è
d’essere accordi illeciti, cioè disapprovati dall’ordinamento giuridico.
La disapprovazione può dipendere dal fatto che l’accordo colpisce direttamente un valore fondamentale
della persona umana, di cui l’ordinamento non tollera in modo assoluto lesioni o manomissioni (ad es.
l’integrità fisica).
In altri casi non è questione d’indisponibilità, ma d’incommerciabilità.
Gli atti di disposizione del corpo sono vietati senz’altro solo se ledono in modo permanente l’integrità
fisica; se non portano una lesione tanto grave, non è detto che siano vietati: possono esserlo, ad es., se
prevedono un corrispettivo economico, ed essere invece consentiti se non lo prevedono.
Non tutti gli accordi su rapporti patrimoniali sono contratti: per essere materia di contratto il rapporto
deve presentare due caratteristiche: dev’essere non solo un rapporto patrimoniale, ma ancor prima un
rapporto giuridico (1321).
“Rapporto” è concetto prenormativo, che la legge non definisce ma presuppone, ed impiega in
significati diversi: nel 1321, rapporto giuridico significa relazione implicante uno specifico impegno
legale all’attuazione di quanto concordato, la cui violazione attira sul violatore conseguenze legali
conformate sul risultato che in base al rapporto doveva realizzarsi.
Il problema è distinguere i casi in cui l’accordo su materie patrimoniali crea un impegno siffatto, dai
casi in cui non lo crea.
È decisivo, al riguardo, il modo in cui le parti intendono il loro accordo: ovvero, è decisivo l’intento
delle parti.
Per creare il rapporto giuridico contrattuale non occorre un vero e proprio intento giuridico delle parti,
cioè la chiara e completa rappresentazione degli impegni legali che derivano dal rapporto, e la specifica
volontà di assumerli: basta il c.d. intento empirico: la rappresentazione del risultato economico che si
vuole conseguire col rapporto, e la generica consapevolezza che quel risultato implica l’attivazione di
meccanismi legali.
L’accordo verte su un rapporto giuridico anche se le parti ignorano i precisi impegni legali che ne
derivano: esse sanno che ne derivano impegni legali, e tanto basta.
Decisivo, per questa conclusione, è che la giuridicità del rapporto si presenti come socialmente tipica,
in relazione al contesto ed al contenuto dell’accordo: A non può dire che il suo accordo di
compravendita con B non è un contratto perché egli non sapeva d’assumere con esso impegni legali.
Normalmente l’accordo gratuito non suggerisce la propria giuridicità con la stessa forza dell’accordo
oneroso; ciò non significa che l’accordo gratuito crei, come regola, rapporti non giuridici.
Vediamo per esempio il trasporto, esso può essere di tre tipi: oneroso (1678), gratuito (1681.3) o
amichevole (o di cortesia: 414 e 949 c.n.): nei primi due casi dà luogo a contratto, giuridicamente
impegnativo per il vettore: nel terzo caso il rapporto non è giuridico.
Ciò non esclude qualsiasi conseguenza giuridica dell’inesecuzione o cattiva esecuzione della
prestazione di trasporto: si pensi all’incidente causato dall’imprudenza del vettore amichevole: il
vettore può essere chiamato a rispondere del danno subito dal passeggero, non per violazione di un
impegno contrattuale, bensì per violazione del più generico dovere di non danneggiare ingiustamente
gli altri, e dunque alle condizioni e nei limiti del 2043.
Per distinguere, nell’area delle prestazioni promesse o rese senza corrispettivo, quelle che danno luogo
a contratto gratuito (ma contratto) e quelle che non danno luogo a contratto, ci si può appoggiare alla
distinzione fra prestazioni consistenti in attività personali e prestazioni implicanti la consegna di cose.
Nell’area delle prestazioni senza corrispettivo, consistenti in attività personali, il criterio per
discriminare fra contratto gratuito e rapporto di cortesia è l’interesse di chi s’impegna a prestare.
Se costui s’impegna a prestare senza corrispettivo, ma perché interessato a qualche vantaggio obiettivo
ed esterno che, sia pure indirettamente, può attendersi dalla prestazione resa, allora c’è contratto
(gratuito): si pensi al trasporto offerto da A a B per fargli provare l’auto che vorrebbe vendergli.
Nell’area delle prestazioni senza corrispettivo, implicanti la consegna di cose, il criterio può essere
quello dell’avvenuta consegna.
Se A chiede a V di prestargli gratuitamente una cosa e B accetta, l’accordo crea fra loro un rapporto
sociale di cortesia, ma non un rapporto giuridico: non c’è contratto; il contratto (di comodato) c’è nel
momento in cui A consegna a B la cosa che gli aveva promesso in prestito.
C’è differenza, al fine di valutare il grado di giuridicità del rapporto, fra prestazioni promesse e
prestazioni eseguite od in via di esecuzione; se A promette a B un trasporto disinteressato da eseguire
fra 10 giorni, fin qui il rapporto è di pura cortesia, con tasso di giuridicità zero, se alla data prevista A
inizia il trasporto e poi lo interrompe lasciando B a metà strada, la violazione colpisce una relazione
d’intensità giuridica superiore (anche se ciò non vuol dire che il rapporto di cortesia s’è trasformato in
contratto di trasporto).
La valutazione del rapporto come giuridico-contrattuale anziché di semplice cortesia può essere
influenzata dalla qualità professionale del soggetto che presta: salire su un taxi è diverso da fare
autostop.
Gli accordi di cortesia sono esclusi dal campo giuridico-contrattuale perché le parti si muovono su un
terreno extralegale: esse considerano che il loro rapporto potrebbe essere un rapporto giuridico, e
desiderano precisamente evitare ciò: preferiscono non creare vincoli legali sottoposti alle regole ed ai
meccanismi del diritto dei contratti, ma semplici impegni di coscienza e d’onore fra gentiluomini.
Non vi è tanto rifiuto del diritto, quanto considerazione del diritto come fattore residuale, per la
sistemazione di rapporti che primariamente e normalmente si sistemano fuori del diritto.
Altre volte il fenomeno segna una più marcata e specifica volontà di fuga dal diritto: ciò accade con gli
accordi che le parti desiderano mantenere segreti agli occhi dei concorrenti, del pubblico od addirittura
della legge; ne sono esempi i patti parasociali, coi quali i soci disciplinano al di fuori delle previsioni
statutarie l’esercizio dei loro poteri rispetto alla società; e le intese regolatrici della concorrenza fra
imprese.
Gli accordi fra gentiluomini si situano in una zona grigia fra giuridico e non giuridico; sono estranei al
giuridico in quanto non creano un rapporto giuridico nel senso del 1321, e infatti non sono contratti; ma
per altro verso vi appartengono, perché la relazione fra le parti è pur sempre regolata giuridicamente.
Se l’accordo persegue fini riprovevoli, il trattamento giuridico consiste nell’impedirne l’attuazione:
risultato possibile, anche se non lo si qualifichi come contratto (illecito).
Se l’accordo è lecito, si devono regolare le posizioni reciproche degli interessati: che non sono parti di
un rapporto contrattuale, ma nemmeno sono estranei, bensì sono reciprocamente coinvolti in una
relazione intensa e qualificata.
Alla luce di ciò, il fondamentale principio regolatore dei loro comportamenti è quello della correttezza
o buona fede oggettiva: l’applicazione del principio ha come conseguenza tipica il sorgere di
responsabilità ed obblighi risarcitorii a carico della parte che deluda ingiustamente le aspettative e gli
affidamenti nutriti dall’altra in base alla relazione (pur non contrattuale) che le lega.
Fra l’area degli accordi che sono certamente contratti e quella degli accordi che certamente non lo sono,
si stende un’ampia zona grigia di accordi paracontrattuali o semicontrattuali.
Si consideri un pagamento fatto (dal debitore) e ricevuto (dal creditore): il pagamento è atto non
autonomo ma dovuto del debitore, prescinde dall’accordo del creditore, che non può rifiutarlo se non
contestandone la conformità all’obbligazione.
Ma se la prestazione fatta dal debitore ed accettata dal creditore è diversa da quella dovuta, scatta fra i
due un contratto di datio in solutum (prestazione in luogo di adempimento: 1197).
Posta la premessa che il contratto riguarda un rapporto giuridico, scatta il riflesso condizionato ch’esso
riguardi un diritto soggettivo (considerato, d’abitudine, termine ineliminabile del rapporto); e allora:
sono contratti gli accordi che vertono non su diritti ma su situazioni di fatto, come il possesso o la
detenzione (ad es. l’accordo con cui si stabilisce che il possesso della cosa – impregiudicato il diritto
corrispondente – passi da A a B in un dato momento e a date condizioni)?
Il rapporto ed il diritto che vi è contenuto sono materia di contratto in quanto l’accordo punti a
costituirli, regolarli od estinguerli (1321), e allora: sono contratti gli accordi che si limitano invece a
riconoscere ed accertare, senza modificarli, diritti già esistenti?
È uno dei problemi che si pongono in relazione al contratto di accertamento.
Ed ancora: sono contratti gli accordi coi quali, senza costituire un diritto a favore di controparte né
rinunciare al proprio, ci si limita ad autorizzare certi atti incompatibili col proprio diritto (c.d. accordi di
tolleranza)?
Quando si parla di rapporti e diritti, si pensa essenzialmente a rapporti e diritti sostanziali, che
attribuiscono direttamente al titolare qualche bene della vita; ed allora: sono contratti gli accordi che
vertono invece su rapporti e posizioni strumentali?
L’accordo che non è contratto (né corrisponde ad altro atto legalmente tipizzato) precipita per ciò
nell’abisso del giuridicamente irrilevante?
La risposta dipende dalle specificità dei diversi casi concreti, ma dipende anche da un generale
atteggiamento dell’interprete: dalla sua maggiore o minore simpatia per l’autonomia dei privati; dalla
sua concezione dei rapporti fra questa ed il diritto dello Stato.
La parola contratto non ha (né nel linguaggio comune, che in quello legislativo) un unico significato,
ma ne ha diversi, a seconda delle materie e dei problemi volta a volta considerati.
Alla firma del contratto si è giunti dopo 3 mesi di trattative: qui s’intende contratto come fattispecie
concreta, come insieme di fatti e comportamenti umani che la legge qualifica accordo raggiunto fra le
parti.
Il contratto s’è sciolto per il recesso di una parte: qui s’intende il contratto come rapporto, cioè come
l’insieme delle posizioni reciproche (diritti ed obblighi) delle parti.
Il contratto non è chiaro: qui s’intende il contratto come testo contrattuale, cioè come complesso di
parole (o segni) con cui le parti hanno manifestato il loro accordo circa il loro rapporto.
Il contratto impegna le parti a determinate prestazioni: qui s’intende il contratto come regolamento
contrattuale, cioè come l’insieme dei vincoli che le parti assumono per sistemare i loro interessi.
Gli stessi significati della parola contratto sono talora espressi con parole diverse.
Un sinonimo può essere “patto”: i patti successori sono contratti (458) così come i patti di non
concorrenza (2596).
Più spesso patto indica la singola clausola inserita in un più ampio contratto (ad es. il patto che esclude
o limita la garanzia nel contratto di compravendita: 1490.2).
Un altro sinonimo può essere “convenzione”: le convenzioni matrimoniali sono contratti.
Un altro ancora “trattato”: i contratti generali di riassicurazione relativi ad una serie di rapporti
assicurativi (1928) si chiamano di solito “trattati di riassicurazione”.
CAPITOLO II – IL CONTRATTO COME ACCORDO: VOLONTÀ E LIBERTÀ CONTRATTUALE
“Il contratto è l’accordo…” (1321): nella definizione legislativa, l’accordo è il primo fra gli elementi
costitutivi del contratto; esso è accordo per costituire, regolare o estinguere […] un rapporto giuridico
patrimoniale.
Il “per” indica tensione ad uno scopo, intenzionalità, volontà.
L’accordo del 1321 è dunque volontà comune delle parti, finalizzata ad incidere su rapporti (giuridici,
patrimoniali) delle parti stesse.
Il principio dell’accordo esprime due valori primari: in primo luogo, indica l’esistenza d’una sfera di
libertà dei soggetti di fronte al potere pubblico ed alla legge.
Il sistema legale prevede casi in cui rapporti e posizioni dei soggetti sono conformati od incisi da fattori
esterni alla libera scelta volontaria degli interessati: l’obbligazione risarcitoria del danneggiante nasce
per il torto commesso da lui, e non per la sua volontà di obbligarsi.
Il concetto che esprime meglio questo significato è “autonomia”, cioè potere di darsi da sé le proprie
regole.
Autonomia contrattuale è sinonimo di libertà contrattuale.
Il secondo valore dell’accordo è una specificazione del primo: il principio dell’accordo protegge
l’autonomia e la libertà dei soggetti contro gli attacchi provenienti da altri soggetti, ovvero contro le
intrusioni di estranei nella loro sfera giuridica.
Più precisamente, garantisce ogni soggetto che le sue posizioni giuridiche non saranno incise per
decisione unilaterale di un altro soggetto controinteressato, senza la corrispondente volontà (senza
l’accordo, appunto), del soggetto interessato.
L’accordo è volontà comune delle parti del rapporto che ne forma oggetto; dunque l’accordo è
bilaterale, ed il contratto, in quanto accordo, è atto bilaterale.
Ma esistono anche atti unilaterali: ovvero atti che non consistono in un accordo, ma nella decisione
solitaria del soggetto, non condivisa con nessun altro soggetto.
Gli atti unilaterali possono incidere su posizioni e rapporti giuridici patrimoniali, proprio come i
contratti; si consideri quel particolare tipo d’incisione che è lo scioglimento del rapporto contrattuale
esistente fra A e B: esso può derivare sia da un contratto fra A e B (mutuo dissenso), sia da un atto
unilaterale di A o di B (recesso unilaterale).
Vi sono atti che incidono esclusivamente nella sfera giuridica del soggetto che li compie, e di nessun
altro: il volontario abbandono della cosa mobile (derelizione) fa perdere la proprietà; non occorre
l’accordo di nessun altro, per la semplice ragione che la sfera di nessun altro è toccata dall’atto.
Potrebbe obiettarsi che in realtà toccano sfere diverse da quella dell’autore: la derelizione toglie ai
futuri eredi la possibilità di ereditare il bene relitto; ma le posizioni di questi soggetti vengono toccate
non in senso giuridico, ma solo empirico: ad essi non si tolgono diritti, ma mere aspettative di fatto, ed
il principio dell’accordo protegge dalle intrusioni le sfere giuridiche, non le sfere degli interessi
materiali prive di rivestimenti giuridici.
Il problema si pone per gli atti che incidono nelle sfere giuridiche di due soggetti; e qui il discorso deve
differenziarsi, in relazione alla diversa qualità e gravità dell’incisione che l’atto produce: alla luce di
questo dato, infatti, si determina se l’atto non richieda accordo, e quindi sia unilaterale, o invece sia un
contratto in quanto richiede accordo.
La graduatoria delle incisioni più gravi vede nella fascia alta gli atti che scaricano sulla sfera giuridica
dei soggetti un sacrificio forte e certo: impongono obbligazioni; tolgono o diminuiscono diritti.
Questi atti richiedono l’accordo di tutti i soggetti incisi così duramente: sono necessariamente contratti
(caso tipico la compravendita).
Abbiamo poi una fascia intermedia, dove si colloca un atto come la donazione: che bisogno c’è di
proteggere la sfera giuridica da un atto che, gratuito, non addossa nessun sacrificio ma attribuisce solo
vantaggi?
La risposta è che anche questi effetti implicano almeno la potenzialità di qualche sacrificio del
donatario: empirico, ma anche giuridico.
La peculiare disciplina della donazione fa sì che il donatario sia notevolmente esposto a perdere i
benefici della donazione: revoca per ingratitudine o sopravvenienza di figli (803), riduzione per
integrare legittime lese (555).
Inoltre la titolarità del diritto reale costituisce il titolare in una posizione giuridica che può comportare
fastidi empirici, ma anche oneri e responsabilità legali (ad es. obbligo di risarcire i danni derivati dalla
cosa).
Infine, ricevere una donazione può creare implicazioni della sfera personale sgradevoli al donatario (il
cui orgoglio, o la cui antipatia verso il donante, potrebbero rendere imbarazzante per lui esserne
beneficato).
La protezione si realizza stabilendo che non v’è donazione senza accordo del donatario, ovvero che la
donazione è un contratto.
Troviamo infine la fascia bassa, occupata da atti che attribuiscono ad un beneficiario solo vantaggi e
nessun sacrificio: nemmeno quei sacrifici potenziali ed indiretti che sono insiti nella donazione.
Vi rientrano la remissione, con la quale il creditore cancella il debito del debitore, e gli atti coi quali
solo una parte assume obbligazioni verso l’altra, che per contro non promette né dà né perde alcunché
(fideiussione, opzione e prelazione gratuite, espromissione ed accollo non liberatori).
Qui l’intrusione è solo benefica per il destinatario, che in forza di essa non perde né rischia nulla:
semplicemente è liberato dal debito, semplicemente ha un nuovo credito.
Ma è pur sempre un’intrusione, e potrebbe non essere gradita.
La legge tutela l’autonomia delle sfere giuridiche non solo contro le intrusioni attualmente o
potenzialmente gravose, ma anche contro quelle obiettivamente e sicuramente vantaggiose: per il
semplice fatto che sono intrusioni.
Si esprime quest’idea parlando di sovranità formale dei soggetti sulla propria sfera giuridica: dove
“formale” indica appunto l’irrilevanza della sostanziale vantaggiosità o svantaggiosità dell’intrusione.
Tutte le intrusioni nella sfera giuridica richiedono accordo.
Ma le intrusioni hanno gravità diverse: in relazione a ciò il principio dell’accordo ha ragione di operare
con forza variabile, ed in modo corrispondente variano la struttura e l’intensità dell’accordo richiesto
per il contratto.
Per le intrusioni più gravi occorre un accordo forte, a struttura pesante: la parte incisa nella sua sfera
giuridica deve manifestare la volontà di accettare l’incisione.
Il principio dell’accordo significa qui che nessuno può subire intrusioni nella sua sfera, attualmente od
anche solo potenzialmente svantaggiose, senza la sua volontà.
Per le intrusioni più blande (le mere intrusioni della terza fascia, che obiettivamente portano solo
vantaggi a chi le subisce), ci s’accontenta di un accordo più debole, a struttura leggera.
Per essi l’accordo può strutturarsi come mancato rifiuto del contratto (es.: il debitore a cui viene
rimesso il debito): il principio dell’accordo significa qui che nessuno può subire intrusioni nella sua
sfera giuridica, anche se obiettivamente vantaggiose, contro la sua volontà.
Consideriamo a questo punto gli atti unilaterali: possiamo distinguerli in due classi.
Da un lato, atti che non realizzano nessuna vera e propria intrusione nella sfera giuridica di soggetti
diversi dall’autore (anche se in qualche modo la toccano): atti non intrusivi.
Dall’altro, atti che realizzano un’intrusione siffatta (atti intrusivi): ma autorizzata, o giustificata.
Alla prima classe appartengono per es. il testamento, la rinuncia all’eredità, la procura.
In verità essi toccano, modificandola, la sfera giuridica di soggetti diversi dall’autore, ma queste
modifiche non possono dirsi intrusioni perché non tolgono a chi le subisce il potere di autodeterminarsi
totalmente rispetto ad esse.
Questi atti attribuiscono non già posizioni sostanziali, ma semplici poteri prodromici e strumentali.
Alla seconda classe appartengono atti unilaterali che realizzano indiscutibili intrusioni nella sfera di un
soggetto diverso dall’autore, modificando direttamente sue posizioni sostanziali.
L’atto unilaterale intrusivo può essere previamente autorizzato dallo stesso destinatario dei suoi effetti
(es.: il recesso convenzionale).
Oppure l’atto unilaterale intrusivo può essere giustificato da interessi o valori che l’ordinamento
considera, nel caso specifico, preminenti sugli interessi ed i valori sottesi al principio dell’accordo (per
es., nei rapporti a tempo indeterminato la parte può recedere unilateralmente anche se il potere di
recesso non era concordato con controparte: sulla preservazione della sfera giuridica di questa, prevale
l’esigenza di salvaguardare spazi di libertà del recedente contro la prospettiva di un vincolo eterno).
La promessa è l’atto volontario con cui l’autore assume un’obbligazione verso il soggetto cui la
promessa è rivolta (promissario); esistono promesse contrattuali e promesse unilaterali.
Non sussistono dubbi sulla natura contrattuale e non unilaterale della promessa: quando questa è fatta a
condizione di, od in vista di, una controprestazione del promissario.
Quando la promessa non è fatta in vista d’una controprestazione del promissario, il problema di
distinguere fra promesse contrattuali ed unilaterali si complica.
Sono importanti le norme (1987-1991) comprese nel titolo IV del libro IV del Codice civile, intitolato
“Delle promesse unilaterali”.
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla
legge (1987).
Alla norma possono attribuirsi due significati: il primo è ribadire il valore generale dell’accordo,
ovvero il principio di sovranità formale del soggetto sulla propria sfera giuridica.
Solo in via eccezionale, nei casi tassativamente tipizzati dalla legge, le promesse possono fare a meno
dell’accordo del destinatario.
E sono tutti casi in cui l’efficacia della promessa in forza della sola volontà del promittente, a
prescindere dall’accordo del promissario, non è un’intrusione particolarmente grave nella sfera di
questo.
Promessa di pagamento e ricognizione di debito non hanno l’effetto sostanziale di creare debiti e
crediti, ma solo l’effetto processuale d’invertire a favore del destinatario l’onere della prova circa il
fondamento causale dell’attribuzione promessa (1988).
Per i titoli di credito rilevano soprattutto l’incorporazione, e la legittimazione legata al possesso.
L’attribuzione del diritto cartolare al prenditore è legata all’esistenza fisica del documento, e solo
possedendo il documento c’è legittimazione all’esercizio.
Il secondo significato del restrittivo principio di tipicità delle promesse unilaterali è salvaguardare
l’applicazione della disciplina del contratto, come disciplina equa e razionale delle operazioni
economiche e delle corrispondenti relazioni fra i protagonisti di queste.
Ed infatti, ammettere in via generale le promesse unilaterali (anche atipiche) rischierebbe di svuotare
od incrinare la disciplina del contratto: specie quella dei rimedi contrattuali.
Se X ed Y fanno un contratto da cui nascono obbligazioni contrapposte, ed X non esegue la sua,
scattano a favore di Y giusti rimedi che si basano proprio sul nesso d’interdipendenza delle due
obbligazioni (rimedi sinallagmatici).
S’immagini invece che, in luogo del contratto, X prometta unilateralmente ad Y la sua prestazione; e
così faccia, in senso inverso, Y verso X: la situazione può sembrare identica dal punto di vista
economico, ma dal punto di vista giuridico sarebbe molto diversa: i due spostamenti patrimoniali si
presenterebbero isolati e non correlati fra loro, sarebbe dissolto il nesso che li lega, e non si
applicherebbero i rimedi che lo presuppongono.
Le figure del contratto e dell’atto unilaterale ricevono applicazioni particolari nel campo segnato
dall’azione dei gruppi e delle organizzazioni.
Caratteristica di questo campo è la presenza di più soggetti, cui fa capo un interesse comune (ad es., i
comproprietari di un bene).
La decisione sull’interesse comune passa necessariamente attraverso le decisioni dei singoli
componenti del gruppo o dell’organizzazione (i singoli comunisti).
Oppure attraverso le decisioni dei componenti di un più ristretto gruppo, competente a decidere per
l’intero gruppo organizzato.
L’atto con cui il singolo decide dell’interesse comune manifesta la sua volontà rispetto ad un’iniziativa
od una materia suscettibile d’incidere su tale interesse.
La manifestazione di volontà può essere resa in una sede non formalizzata (come accade per le società
di persone, che non hanno una vera e propria assemblea); oppure in una sede formalizzata,
caratterizzata dall’unità di tempo e di luogo entro cui tutti i singoli partecipi o portatori dell’interesse
comune manifestano la propria volontà (assemblea, consiglio di amministrazione); in quest’ultimo
caso, l’atto del singolo si chiama “voto”.
Il voto è un atto unilaterale del singolo componente, esprime la sua volontà, ed in base a questa sola
produce i suoi effetti.
Gli effetti del voto riguardano l’interesse comune, e dunque toccano le sfere degli altri soggetti, in
quanto partecipi dello stesso interesse.
Forse che il voto realizza allora un’intrusione nelle sfere altrui? La risposta è no: il voto del singolo da
solo non incide direttamente nelle sfere degli altri titolari dell’interesse comune, perché da solo non ha
la competenza e la forza per disporre di quell’interesse.
Esso può semplicemente concorrere, coi voti degli altri titolari, a creare l’atto che potrà disporre
dell’interesse comune: tale atto si chiama deliberazione.
“Deliberazione” indica un certo risultato del concorso dei singoli voti.
Il risultato dipende da un dato empirico, cioè dal modo in cui i singoli titolari dell’interesse votano e da
un dato giuridico, cioè dal modo in cui le norme regolano la formazione della deliberazione.
Sotto quest’ultimo profilo, i modelli possibili sono due.
Il modello unanimistico, quando occorre che i voti (le volontà) di tutti i titolari dell’interesse comune
siano favorevoli della deliberazione (ad es., per deliberare la vendita della cosa comune), od il modello
maggioritario, quando la deliberazione si forma se i voti favorevoli sono più numerosi dei voti contrari,
ed eventualmente raggiungono una certa percentuale del complesso dei voti, variamente fissata a
seconda dei casi.
Il criterio della maggioranza è il solo a consentire l’azione dei gruppi organizzati, che il criterio
dell’unanimità potrebbe paralizzare; d’altra parte, anche il criterio dell’unanimità determina intrusioni
(in negativo) nella sfera altrui: chi dissente dall’azione voluta da tutti gli altri impedisce a tutti gli altri
di determinare nel senso voluto la situazione e l’interesse di cui sono (con)titolari.
La deliberazione implica volontà concordi, ma questo accordo fra quanti hanno votato a favore non
forma un contratto fra loro.
La deliberazione non è un contratto perché non è un accordo fra più parti, bensì esprime la volontà di
una sola parte: il gruppo o l’organizzazione, considerati come un tutt’uno.
La deliberazione può essere il presupposto di un contratto (es.: la maggioranza degli amministratori
della società X vota perché si faccia un certo contratto fra X ed Y).
I contratti delle organizzazioni (private o pubbliche) scontano alcune complicazioni rispetto ai contratti
degli individui; prima complicazione: il procedimento con cui l’individuo forma la sua interna volontà
contrattuale non è regolato dal diritto (se non nella misura in cui intervengano in esso fattori patologici,
come i vizi della volontà); invece il procedimento di formazione della volontà contrattuale delle
organizzazioni è soggetto a regole giuridiche – le regole sulle deliberazioni.
Seconda complicazione: l’individuo può manifestare direttamente all’esterno la propria volontà
contrattuale, senza l’intermediazione di altri soggetti; invece l’organizzazione ha bisogno che la sua
volontà (meglio, la volontà ad essa imputata in base alla deliberazione) sia portata all’esterno da un
altro soggetto abilitato a farlo.
Terza complicazione: il momento della deliberazione e quello della rappresentanza sono sì distinti, ma
al tempo stesso intrecciati fra loro.
In quanto fondato sulla volontà, il contratto è anche espressione di libertà.
Le parti sono libere di decidere se, ed in che modo, le proprie sfere giuridiche abbiano ad essere incise
dal contratto.
Il senso ed il ruolo della volontà delle parti nel contratto si è profondamente trasformato
nell’evoluzione storica.
Nel secolo XIX domina una concezione tutta soggettiva del contratto: la volontà umana è la forza
creatrice degli effetti giuridici, e nel contratto la volontà degli individui contraenti è tutto.
“Dogma della volontà” è la formula che esprime questo ruolo totalizzante della volontà nel contratto.
Significato ideologico e politico: esaltare la volontà dell’individuo significa esaltare la libertà
individuale; esaltare la libertà individuale è precondizione culturale per la fondazione del modello
socio-economico che si afferma in gran parte dell’occidente a partire dai primi dell’ottocento: il
modello della società borghese e dell’economia capitalistica, contrapposte alla società ed all’economia
dell’ancien régime.
Il dogma della volontà porta anche notevoli conseguenze pratiche: qualunque fatto problematico, che
tocchi la volontà del contraente, mette in discussione il contratto ed i suoi effetti.
Se la volontà scaturisce da una sfera fisiopsichica menomata o non matura, il contratto va sempre
cancellato.
Se la volontà si forma sotto l’influenza di fattori psichici che ne turbano il regolare procedimento di
formazione, il contratto va sempre cancellato.
Se il modo in cui la volontà del soggetto viene manifestata all’esterno e dichiarata a controparte non
coincide con l’effettivo atteggiamento psichico del soggetto stesso (ad es. per un suo lapsus), la
divergenza fra volontà dichiarata e volontà reale porta sempre alla cancellazione del contratto.
Verso la fine dell’800 il dogma della volontà entra in crisi, e con esso la teoria soggettiva del contratto.
Ciascuna parte vive il proprio contratto nella sgradevole e scoraggiante dimensione dell’incertezza, ma
una depressione dell’intrapresa è intollerabile per gli sviluppi del capitalismo.
Paradigmatica delle concezioni oggettive del contratto è la “teoria della dichiarazione”, che prende
piede nel Novecento; per essa nel contratto è importante non solo l’effettiva volontà individuale, ma
anche la sua proiezione sociale esterna.
La teoria della dichiarazione si fonda sul valore dell’affidamento.
Principio di responsabilità (meglio, autoresponsabilità) del dichiarante: chi immette una dichiarazione
contrattuale nel traffico giuridico si assume il rischio degli affidamenti che la dichiarazione crea.
La moderna disciplina del contratto segue la teoria della dichiarazione.
Le regole ispirate alla teoria della dichiarazione lasciano pur sempre ampi spazi alla possibilità che il
contratto venga cancellato per debolezze o turbamenti della sfera volitiva del contraente.
Innanzitutto, la dichiarazione non rileva se non è riferibile al soggetto che ne appare l’autore.
Inoltre, la dichiarazione non rileva quando al suo autore non sia riferibile la volontà d’impiegarla come
dichiarazione contrattuale, destinata alla formazione di un contratto.
La tendenza ad una concezione oggettiva del contratto si manifesta anche nella c.d. teoria precettiva,
coltivata in Italia verso la metà del novecento: essa ritiene che l’essenza del contratto non sia il
fenomeno psicologico della (concorde) volontà delle parti, ma il fenomeno dell’autoregolamentazione
degli interessi delle parti.
Porre l’accento sulla regola (il precetto) che il contratto impone alle parti è utile, ma senza dimenticare
che la regola contrattuale deriva fondamentalmente dall’accordo contrattuale, e senza tale accordo non
sussisterebbe.
Un altro prodotto della concezione oggettiva del contratto è la teoria dei rapporti contrattuali di fatto:
alla stregua di essa, un rapporto contrattuale può costituirsi fra due parti anche in assenza di loro
(valide) manifestazioni di volontà contrattuale, semplicemente in forza del contratto sociale stabilitosi
fra esse.
Il contratto sociale può stabilirsi in due modi, cui corrispondono i due filoni di fattispecie che
abitualmente si riconducono alla figura: il filone dei c.d. negozi di attuazione, ed il filone del contratto
nullo eseguito.
Nei c.d. negozi di attuazione il contratto sociale si stabilisce perché il soggetto interessato alla
prestazione si appropria direttamente di questa.
Nel filone del contratto nullo (che riguarda i contratti di lavoro e di società) il contatto sociale fra le
parti si stabilisce perché il contratto fra loro, ancorché nullo, è stato effettivamente eseguito: in tal caso
le conseguenze giuridiche sono sostanzialmente le stesse che si produrrebbero in base al contratto se
esso fosse valido.
Il fenomeno è inverso a quello dei rapporti di cortesia: nei rapporti di cortesia, quello che prima facie si
presenta come un rapporto contrattuale (perché vi è accordo su materia patrimoniale) non lo è perché
manca l’intento di vincolarsi giuridicamente; nei rapporti di fatto, quello che prima facie non si
presenta come un rapporto contrattuale in realtà lo è, o almeno è trattato come tale.
Questa stessa ratio ispira la giurisprudenza che qualifica la responsabilità medica come contrattuale,
pur in assenza di formale contratto fra medico e paziente.
L’economia e la società di massa inducono bisogni standardizzati; questo implica la standardizzazione
dei beni e dei servizi offerti dalle imprese sul mercato, la quale a sua volta determina la
standardizzazione dei relativi contratti: per la vendita dei propri beni e l’erogazione dei propri servizi,
ciascuna impresa utilizza un contratto standard che viene uniformemente applicato nei rapporto con
tutti i suoi clienti.
Il testo contrattuale non esce da una trattativa fra l’impresa ed il cliente, ma viene elaborato dalla stessa
impresa interessata, che presenta al cliente un contratto compiutamente preconfezionato e non
modificabile.
Per questo i contratti della moderna economia di massa sono contratti per adesione.
Il contratto, sul quale la volontà di una parte non riesce ad influire in modo significativo, può dirsi
fondato sull’accordo di questa; una corrente di pensiero invece sostiene che in queste condizioni il
contratto ha piuttosto il valore di norma che una parte impone all’altra.
Come la norma, inoltre, il contratto standard presenta i caratteri della generalità e dell’astrattezza.
Ma devono tenersi logicamente distinti il profilo dell’adesione e quello della standardizzazione: il
profilo dell’adesione (mancanza di trattativa sul contratto, sua imposizione unilaterale) deriva
fondamentalmente dall’ineguaglianza di potere contrattuale delle parti: questo è un dato fisiologico del
contratto e si manifestava anche in epoche che non erano di economia massificata.
È legittimo distinguere i contratti negoziati (fra parti con pari potere contrattuale) dai contratti non
negoziati, ovvero per adesione.
Ai fini della configurabilità della fattispecie come contratto, ciò che conta è che non vi sia una
costrizione formale-legale della parte a subire una certa conformazione del suo rapporto.
L’aspetto sostanziale non rileva per la configurabilità della fattispecie come contratto, esso invece
rileva per il trattamento del contratto, che è materia di politiche del legislatore.
Le risposte tradizionali prescindono dal fenomeno della standardizzazione: in altre parole, si applicano
anche ai contratti personalizzati.
Esse consistono nel dare alla parte con ruolo volitivo menomato la possibilità di cancellare il contratto
(compatibilmente con l’esigenza di tutelare l’affidamento di controparte) quando la menomazione del
ruolo volitivo dipenda da fattori con connotazione più o meno marcatamente patologica, ma comunque
a base individuale: errore, minaccia, inganno; stato di pericolo o di bisogno.
Le risposte più innovative sono specificamente rivolte ai casi in cui la menomazione del ruolo volitivo
di una parte, la natura più formale che sostanziale del suo accordo, appartengono alla fisiologia delle
relazioni sociali, avendo per così dire base di massa: il problema s’è posto in primo luogo per i
lavoratori subordinati, parte del contratto di lavoro.
Poi anche per altre categorie socio-economiche: gli inquilini, di fronte ai padroni di casa; i lavoratori
autonomi della terra, di fronte ai proprietari terrieri; i consumatori di beni e di servizi, di fronte alle
imprese che li producono e distribuiscono sul mercato.
E la risposta del legislatore è stata: speciali discipline dei corrispondenti contratti, mirate a proteggere
la parte della categoria debole.
Un altro dato importante è lo straordinario incremento delle manifestazioni di autonomia collettiva.
Continuano ad esistere i contratti fra individui, manifestazione dell’autonomia individuale, ma è
cresciuta enormemente la sfera in cui il contratto si manifesta ed opera in una dimensione collettiva,
spersonalizzata.
Ad es. i contratti delle organizzazioni sono fatti di volontà non individuali, ma collettive (tradotte nelle
deliberazioni); e comunque esprimono un’autonomia non individuale ma di gruppo.
Poi i contratti standardizzati.
L’autonomia collettiva reagisce alla disparità di potere contrattuale.
Il contratto viene portato in una dimensione collettiva, perché in questo modo si rafforza la posizione
della parte socio-economicamente più debole: questa resterebbe debole se contrattasse su base
individuale; recupera forza contrattuale se contratta su base collettiva, e cioè attraverso la propria
organizzazione di categoria.
Una variante dell’autonomia collettiva è la c.d. autonomia assistita, ovvero il fenomeno per cui il
contratto individuale viene fatto direttamente dall’individuo interessato, assistito nella contrattazione
dall’organizzazione che rappresenta e tutela la relativa categoria sociale: ad es. le transazioni su
controversie di lavoro si fanno con l’assistenza del sindacato (410 ss. c.p.c.).
Un meccanismo analogo si applicava alle locazioni abitative, con la previsione che le parti potessero
derogare alla disciplina legale protettiva dell’inquilino, purché i patti in deroga fossero stipulati con
l’assistenza delle associazioni di inquilini e proprietari edilizi; la nuova disciplina prevede invece che
alla disciplina legale di protezione dell’inquilino possa derogarsi solo se il singolo contratto derogatorio
è conforme al contratto tipo concordato in sede locale fra le contrapposte organizzazioni di categoria.
Vi è crescente limitazione della libertà contrattuale ad opera del potere pubblico.
In un sistema liberale, a causa delle disuguaglianze economico-sociali, i contraenti più deboli sul piano
economico-sociale godono però di una libertà solo formale, perché nella sostanza la loro libertà è
schiacciata di fatto dal superiore potere contrattuale dei contraenti forti.
Nello Stato sociale si afferma l’idea che spetta al potere pubblico intervenire: si ritiene compito del
potere pubblico assicurare ai cittadini libertà ed uguaglianza non solo in senso formale, ma anche in
senso sostanziale (3.2 Cost.); e comunque impedire che la ricerca dell’interesse privato danneggi
l’interesse generale.
Tende così ad assumere crescente rilevanza l’appartenenza dei soggetti contraenti ad una determinata
categoria socio-economica.
Rilevanza empirica: essere consumatori significa avere posizioni contrattuali determinate dai contratti
standard predisposti dalle imprese.
Ma anche rilevanza giuridica: essere consumatori significa godere, nei propri rapporti contrattuali, delle
regole protettive stabilite dalla legge, mentre essere imprese significa soggiacere ai corrispondenti
regimi legali restrittivi.
Alcune restrizioni pubbliche della libertà contrattuale sono particolarmente dure, come il meccanismo
della sostituzione automatica dei contenuti contrattuali difformi da quelli voluti dalla legge, ed il
meccanismo dell’obbligo legale di contrarre: chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale
ha l’obbligo di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa
(2597).
L’obbligo di contrarre è completato da quello di osservare la parità di trattamento.
La durezza della previsione suggerisce di non estenderla per analogia: così, riferita testualmente la
norma al monopolista legale, la si ritiene inapplicabile al monopolista di fatto.
Un obbligo di contrarre grava anche sull’imprenditore di trasporti che esercita pubblici servizi di linea
(1679.1).
Si pone una questione: il contratto è accordo di volontà delle parti; qui il contratto può non avere alla
sua base la volontà di una delle parti, costretta al contratto dalla legge anche contro la sua volontà (od
inchiodata ad un contratto diverso da quello voluto), ed allora, siamo di fronte ad un vero contratto?
Innanzitutto, la norma che obbliga a contrarre non modifica direttamente le posizioni delle parti, ma
implica che le modifiche scaturiscano dal contratto fra queste, in base alle loro manifestazioni di
volontà; inoltre, la volontà contrattuale in genere non è mai del tutto libera da condizionamenti empirici
o giuridici; infine: è pur sempre una scelta libera ed autonoma del soggetto esercitare la particolare
attività economica, cui il contratto imposto è funzionale.
CAPITOLO III – IL CONTRATTO NELL’ORGANIZZAZIONE GIURIDICA
L’intensità del legame fra contratto ed obbligazione è resa esplicita già dalla collocazione delle regole
codicistiche sul contratto entro il libro (IV) “Delle obbligazioni”: il contratto è fonte dell’obbligazione
(1173).
Il contenuto della promessa è la creazione di un’obbligazione: in quest’ultimo senso, il contratto non si
contrappone alla promessa, ma al contrario s’identifica con questa.
A partire dalla stagione del diritto comune, il problema fondamentale del contratto è consistito
nell’individuare le condizioni per il carattere vincolante della promessa, cioè le condizioni alle quali la
promessa genera l’obbligazione del promittente, azionabile in giudizio dal promissario: nella
prospettiva del diritto occidentale, c’è un ideale primato del contratto con effetti obbligatori sul
contratto con effetti reali; del contratto come fonte di obbligazioni piuttosto che come mezzo per
trasferire la proprietà.
Fino al periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore del codice del 1942, lo studio del
contratto e lo studio dell’obbligazione erano ben integrati; poi, nella nostra civilistica, la cultura
dell’obbligazione e la cultura del contratto hanno iniziato a divaricarsi.
La sistematica del codice napoleonico (e sulle sue orme, del codice italiano del 1865) collocava il
contratto in posizione subordinata e strumentale alla proprietà.
Questa concezione rifletteva un’economia prevalentemente agricola, in cui la terra era la risorsa
produttiva fondamentale.
Si apre poi una fase in cui la ricchezza e le risorse produttive non s’identificano più con (la proprietà di)
cose immobili, e nemmeno materiali: ciò erode la tradizionale supremazia della proprietà, ed esalta il
ruolo del contratto.
Nei sistemi economici evoluti la ricchezza economica e le risorse produttive consistono, molto più che
in cose, in rapporti – in pretese collegate ad obblighi altrui: e pretese ed obblighi nascono dai contratti.
Se si mantiene l’equazione che assimila a proprietà ogni valore economico fortemente tutelato dal
diritto, il contratto crea proprietà.
Il fenomeno è particolarmente marcato nel settore dei beni finanziari: il contratto si configura esso
stesso, direttamente, come bene.
Compravendere quote di multiproprietà significa compravendere non tanto entità immobiliari, quanto
posizioni contrattuali.
La responsabilità extracontrattuale surroga od integra i rimedi contrattuali a favore di chi, parte di un
contratto, abbia visto leso un proprio diritto, coinvolto nel contratto stesso: è il problema del concorso e
cumulo fra azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, possibile tutte le volte che
l’inadempimento di un impegno contrattuale implichi al tempo stesso la violazione di un diritto
assoluto della vittima, rilevante come illecito ex 2043.
Può verificarsi anche quando la lesione della posizione contrattuale proviene da un terzo: è il problema
della responsabilità (extracontrattuale) del terzo “complice” dell’inadempimento contrattuale; o, con
formula più ampia, della tutela aquiliana delle posizioni contrattuali.
Inoltre, la responsabilità extracontrattuale entra in competizione con la responsabilità contrattuale,
quando si tratta di offrire tutela a posizioni d’interesse che, pur non essendo propriamente contrattuali,
per la peculiare intensità della relazione fra le parti si avvicinano all’area delle relazioni contrattuali.
Si pensi alla natura della responsabilità precontrattuale.
Da meccanismo essenzialmente funzionale alla proprietà, il contratto diventa meccanismo
essenzialmente funzionale all’impresa.
Il contratto (di società) definisce e fonda la struttura giuridica dell’impresa, che per lo più è struttura
societaria; il contratto governa l’organizzazione ed il funzionamento dell’impresa.
Il processo legislativo conduce, verso la metà del secolo XX, all’abrogazione del codice di commercio,
ed alla riunificazione del diritto privato entro un unico codice (civile).
Tuttavia, la formale unificazione del diritto non elimina del tutto il problema dei contratti delle imprese,
e di una loro disciplina in qualche modo speciale.
La specialità dei contratti delle imprese si coglie oggi su due piani: un piano è quello delle regole sul
contratto in genere, alcune delle quali conoscono variazioni od integrazioni della disciplina comune
quando una parte sia imprenditore, ed il contratto attenga all’impresa (ciò si verifica nei campi della
rappresentanza, della conclusione del contratto e dell’interpretazione); l’altro piano è quello della
disciplina di determinati tipi o classi di contratti, di cui siano parti imprese: alcuni tipi contrattuali,
disciplinati già nel codice, presuppongono necessariamente la qualità d’impresa in una delle parti (ad
es., l’assicurazione, l’appalto, i contratti bancari).
Recenti discipline di settore impostano l’intera regolamentazione del rapporto contrattuale sulla
specificità data dal fatto che (almeno) una parte è imprenditore.
La specificità può consistere nel fatto che una parte è imprenditore, e l’altra no (contratti fra imprese e
consumatori (business-to-consumer): contratti bancari, contratti a distanza, etc.).
Oppure la specificità può consistere nel fatto che una parte è imprenditore con una certa posizione di
mercato, e l’altra è imprenditore con una diversa posizione di mercato (business-to-business): vi si
riconducono le discipline dei contratti di subfornitura e dei contratti per la cessione di crediti d’impresa.
In passato lo status familiare costituiva anche legalmente un ostacolo alla libertà contrattuale dei
soggetti; un esempio lampante è la regola per cui la donna sposata non poteva concludere una serie
d’importanti contratti senza l’autorizzazione del marito.
Col progressivo declino delle funzioni politico-economiche della famiglia, con la tendenza a concepirla
come comunità d’affetti libera da vincoli gerarchici ed aperta alla valorizzazione delle sfere individuali
dei suoi componenti, lo status familiare ha cessato di costituire un limite alla libera partecipazione dei
soggetti al traffico contrattuale: dallo status al contratto.
Oggi le relazioni fra contratto e famiglia s’esprimono fondamentalmente in tre modi.
Per un verso, il contratto aiuta la famiglia: c’è possibilità, per i coniugi, di conformare il regime
patrimoniale della famiglia secondo schemi diversi dal regime legale (comunione).
Per altro verso, la famiglia aiuta il contratto: s’allude alle funzioni di rappresentanza legale ed
assistenza dei minori e degli altri incapaci d’agire.
Ma per un altro verso ancora, la famiglia minaccia il contratto sotto due profili: il primo profilo
riguarda i soggetti coniugati in regime di comunione legale, il secondo profilo riguarda i soggetti che
abbiano o siano per avere dei legittimari (tali in virtù dello stretto rapporto familiare): le donazioni o le
altre liberalità del soggetto sono esposte al rischio di diventare inefficaci.
La relazione fra contratto e successione mortis causa è tendenzialmente antinomica.
Il contratto è ammesso per dare un assetto, liberamente scelto dagli interessati, solo alle successioni già
aperte, mentre è precluso l’impiego del contratto come mezzo per dare un assetto alle successioni
future, in forza del generale divieto dei patti successori (458).
La ratio è la salvaguardia della libertà di disporre a causa di morte fino all’ultimo istante della propria
vita; la stessa ratio conduce a ritenere l’inammissibilità della donazione mortis causa.
Il divieto copre anche i patti dispositivi e rinunciativi, coi quali il soggetto si vincola in relazione ai
diritti che potrà avere in futuro sull’eredità altrui: qui la ratio è piuttosto l’esigenza di legare le scelte
giuridico-economiche a presupposti di serietà, certezza, non precarietà.
Il rapporto contrattuale è trasmissibile agli eredi, o si estingue con la morte dell’originario titolare?
Nel primo caso, se gli eredi sono più di uno, come gestire la sopravvenuta pluralità di contitolari del
rapporto, che vengono a costituire una parte complessa in luogo dell’originaria parte unisoggettiva?
Gli enti pubblici hanno potestà pubbliche, ma insieme hanno anche capacità giuridica di diritto privato,
nel cui esercizio possono compiere attività regolate dal diritto privato: quindi gli enti pubblici (ed in
particolare le pubbliche amministrazioni) possono fare contratti.
La disciplina di questi contratti è, in linea di principio, la stessa disciplina del codice (1321 ss.), tuttavia
vi sono alcune specificità.
La più importante ha natura strutturale, e riguarda il peculiare modo di formazione delle decisioni
(della volontà) degli enti pubblici.
Le deliberazioni degli enti pubblici danno luogo ad un procedimento amministrativo, formato da una
serie di atti amministrativi che trovano la loro disciplina nel diritto amministrativo.
Esauriti i procedimenti amministrativi che precedono il contratto, questo può essere concluso, ed una
volta concluso è un contratto regolato dal diritto privato.
Ma con questa persistente peculiarità: eventuali difetti del procedimento amministrativo a monte,
conseguenti a violazioni di norme pubblicistiche, possono rifluire sul contratto a valle, mettendone in
discussione la validità o l’efficacia anche sul piano del diritto privato.
Di un’altra specificità si può parlare prevalentemente al passato: essa discende da una certa concezione
della sfera pubblica e dei suoi rapporti coi privati: una certa idea di supremazia dello Stato e degli enti
pubblici in quanto portatori d’interessi della collettività conduceva a ritenere che ai contratti delle
pubbliche amministrazioni fossero inapplicabili una serie di regole della disciplina comune dei
contratti: ad es., sulla responsabilità precontrattuale.
Secondo una visione giacobina dell’azione pubblica, solo nel campo delle relazioni internazionali è
ammissibile il ricorso al paradigma consensuale: le convenzioni fra Stati, viste come la sola possibile
alternativa alla guerra.
Il paradigma consensuale è invece escluso all’interno del singolo Stato: dove si ritiene che il massimo
di efficacia, razionalità e giustizia possa raggiungersi solo se l’azione pubblica procede per decisioni
unilaterali non negoziate, e la contrattazione delle politiche pubbliche è vista come un attentato a valori
non negoziabili.
L’affermarsi di un modello di società neocorporativa allarga l’area entro cui le decisioni formalmente
pubbliche sono, in realtà, negoziate informalmente coi destinatari di esse; il fenomeno investe la stessa
attività legislativa: si parla di legge contrattata.
Ma il giurista è colpito anche da un fenomeno più specifico: la crescente contrattualizzazione
dell’azione amministrativa.
Si diffonde sempre più il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni impegnate nell’attuazione di
politiche pubbliche, a strumenti modellati sul paradigma del contratto anziché sul tradizionale
paradigma dell’atto amministrativo come atto unilaterale autoritativo.
Il fenomeno investe, per iniziare, i rapporti fra la pubblica amministrazione ed i suoi dipendenti: in
precedenza il rapporto d’impiego pubblico si basava su atti amministrativi: oggi si modella come
contratto fra l’amministrazione ed il dipendente, fonte di posizioni soggettive tutelabili non più davanti
alla giurisdizione amministrativa ma davanti all’ordinario giudice del lavoro.
Ma la contrattualizzazione dell’azione amministrativa si manifesta soprattutto nei rapporti fra la
pubblica amministrazione ed i suoi interlocutori esterni.
La formula “urbanistica contrattata” designa il fenomeno per cui il contratto sostituisce il piano come
strumento di governo pubblico del territorio.
A partire dall’ultimo decennio del secolo XX, la tendenza s’espande: essa trova un riconoscimento
generale nella legge 241/1990: le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi
previsti dalla legge, in sostituzione di questo, e possono altresì concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune.
I giuristi si chiedono se essi diano luogo a veri contratto nel senso del 1321: negli anni ’70 del XX
secolo s’era tentata una risposta con la categoria del c.d. contratto di diritto pubblico, poi deperita.
In una linea di pensiero giuridico dominante per oltre un secolo, il contratto è sottocategoria d’una
categoria più ampia: la categoria del negozio giuridico.
Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici.
La definizione ricorda quella del contratto, al netto di due elementi (l’accordo e la patrimonialità del
rapporto inciso).
È negozio anche l’atto che non sia accordo, ma atto unilaterale: recessi, procure, testamenti etc.
È negozio anche l’atto che non sia patrimoniale: ad es., il matrimonio.
L’origine della categoria non è legislativa, ma dottrinale; non è italiana, ma tedesca.
La teoria del negozio giuridico è sorta con una funzione pratica ed una funzione ideologica.
La funzione pratica è creare un concetto ed un termine capaci di razionalizzare e semplificare il
ragionamento ed il discorso giuridico.
La funzione ideologica si lega al ruolo dominante che la teoria del negozio giuridico assegna alla
volontà umana.
Al cuore della teoria del negozio giuridico vi è il dogma della volontà, ed il senso ideologico di essa
coincide con quello del dogma della volontà: esaltazione della libertà individuale.
In altri ambienti giuridici la categoria non ha pari fortuna: in quelli anglosassoni è del tutto sconosciuta;
quello francese conosce una categoria assimilabile (acte juridique).
C’è una differenza tra la posizione del negozio giuridico in Italia ed in Germania: in Germania il BGB
del 1900 lo prevede e lo regola espressamente, facendone una categoria anche legislativa; in Italia il
codice civile (sia quello del 1865 che quello del 1942) lo ignora.
Nella seconda metà del ‘900 la funzione pratica è messa in discussione perché si rileva che proprio la
generalità della categoria determina eccessiva genericità ed astrattezza dei suoi contenuti.
Si mette in discussione anche la funzione ideologica del negozio: nel quadro del medesimo processo
politico-culturale che accompagna le crescenti restrizioni pubbliche della libertà contrattuale.
Inoltre i processi di oggettivazione del contratto mettono complessivamente in angolo quel dogma della
volontà individuale, con cui la teoria del negozio faceva tutt’uno.
Quanto al diritto positivo, i soli referenti possibili della categoria sembrano da cercare nelle norme che
parlano di atti intesi come atti di autonomia privata.
Le norme si riconducono agli artt. 2.1 (La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una
età diversa) e 428.1 (Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati
compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa,
se ne risulta un grave pregiudizio all’autore), sui requisiti di capacità di agire (legale e rispettivamente
naturale) dell’autore dell’atto; ed all’art. 1350 n. 13 (Devono farsi per atto pubblico o per scrittura
privata, sotto pena di nullità [… elenco di atti] gli altri atti specialmente indicati dalla legge) sulla
forma degli atti.
La categoria degli atti negoziali smarrisce la sua unità e chiede di essere scomposta almeno in tre più
ristrette categorie.
La prima categoria comprende gli atti personali (ed in primo luogo familiari), caratterizzati
dall’incidenza su situazioni giuridiche non patrimoniali, e dalla stretta connessione alla sfera più intima
della persona: prototipo il matrimonio.
La seconda comprende gli atti a causa di morte, compiuti in vista della fine della vita del soggetto e
destinati a produrre effetti in relazione a tale evento: prototipo il testamento.
La terza comprende gli atti patrimoniali fra vivi: da un lato il contratto, dall’altro gli atti unilaterali tra
vivi aventi contenuto patrimoniale, evocati da una norma (1324: Salvo diverse disposizioni di legge, le
norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi
aventi contenuto patrimoniale).
Il negozio è manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici conformi alla volontà stessa.
A contrario, sono atti non negoziali gli atti illeciti produttivi di danno (2043); gli atti dovuti, come i
pagamenti (1176 ss.); gli atti consistenti in dichiarazioni di scienza, come la quietanza (1199) e la
confessione (2730); le partecipazioni o comunicazioni, come la denuncia dei vizi della cosa
compravenduta (1495).
La categoria del contratto richiama in vari modi la categoria della norma giuridica, cioè della regola di
condotta o comunque del vincolo che incide nella sfera dei soggetti.
La richiama per assimilazione: il contratto come norma.
La definizione del 1321 assegna al contratto anche la funzione di regolare un rapporto giuridico; il
1372.1 dota il contratto di forza di legge fra le parti; lo stesso termine autonomia evoca l’idea di norma.
Sul piano del pensiero giuridico, l’idea normativa del contratto è fortemente valorizzata dalla teoria
precettiva.
Nella concezione di Hans Kelsen, il contratto (e più in generale il negozio) si colloca entro la
costruzione a gradi dell’ordinamento in quanto produce norme funzionalmente legate a norme (legali)
di livello superiore, che le legittimano.
La medesima idea del contratto come norma è però sottesa ad una concezione antitetica a quella
kelseniana, come la concezione della pluralità degli ordinamenti giuridici, elaborata da Santi Romano:
è il contratto a fondare molti di quegli ordinamenti privati che, accanto all’ordinamento statuale ed in
posizione di pari dignità con questo, danno corpo alla realtà giuridica complessiva.
L’idea del contratto come norma è poi sostenuta, sul piano empirico, da fenomeni che esaltano il valore
generale o comunque super-individuale della regola contrattuale: i contratti standard; i contratti
associativi; i contratti collettivi.
È sostenuta anche dal fenomeno dell’autoregolamentazione di categoria.
Ma sotto altro profilo, il richiamo del contratto alla norma è un richiamo per contrapposizione: i termini
si contrappongono quando “norma” viene intesa nell’accezione di norma legale o comunque pubblica
ed eteronoma, mentre nel contratto si valorizza la natura di auto-regolamento degli interessi delle parti.
La contrapposizione si coglie ad es. quando si ragiona delle restrizioni pubbliche della libertà
contrattuale.
L’analisi economica del diritto è un metodo di valutazione ed interpretazione delle regole giuridiche,
fondato sul criterio dell’efficienza, intesa come allocazione ottima delle risorse.
In base ad esso, una regola merita di essere approvata se orienta i comportamenti dei destinatari in
modo da garantire la massima efficienza.
L’analisi economica del diritto dei contratti si esercita soprattutto in tre aree: una è quella dei contratti
conclusi da una parte che si trova in condizioni minorate; la seconda è quella dei contratti caratterizzati
da asimmetria informativa fra le parti (una delle quali ha contrattato sulla base di un suo errore, o di
informazioni false od insufficienti); la terza area riguarda l’adempimento e l’inadempimento del
contratto: criteri della responsabilità per l’inadempimento, rimedi per il caso d’inadempimento,
sopravvenienza di fatti che alterano l’originario equilibrio economico del contratto.
Un concetto chiave dell’analisi economica del diritto è quello di costi transattivi (transactions costs): i
costi relativi alla ricerca della controparte, alle trattative con lei, alla redazione del contratto, alla
gestione del rapporto contrattuale.
Il calcolo dell’efficienza implica non solo il calcolo delle risorse direttamente messe in gioco come
oggetto del contratto, ma anche il calcolo dei costi transattivi riferibili allo stesso.
L’analisi economica del diritto presuppone che il contratto sia la veste giuridica di un’operazione
economica, od economicamente valutabile; ne discende una conseguenza: per giudicare di una lite su
un singolo contratto, è necessario cogliere l’operazione economica che questo sottende.
CAPITOLO IV – LE FONTI DEL DIRITTO DEI CONTRATTI
Le regole sui contratti scaturiscono da una varietà di fonti del diritto.
Le norme costituzionali operano quali fonti del diritto in due modi: come parametri per il giudizio di
legittimità delle leggi ordinarie, e come regole direttamente applicabili ai rapporti fra soggetti.
Si deve affrontare una questione: se la libertà contrattuale sia costituzionalmente tutelata.
Se la risposta fosse affermativa, s’aprirebbe il problema della possibile incostituzionalità delle leggi che
variamente limitano la libertà contrattuale.
Nel nostro sistema la libertà contrattuale non riceve una tutela costituzionale diretta, ma solo indiretta:
è tutelata nella misura in cui sia funzionale o strumentale ad altri valori, direttamente tutelati dalla
Costituzione.
I valori costituzionali direttamente tutelati, capaci di fondare l’indiretta tutela costituzionale della
libertà di contratto, sono soprattutto due: l’iniziativa economica privata (41 Cost.) e la proprietà privata
(42 Cost.).
Ma nel momento stesso in cui garantiscono iniziativa economica e proprietà privata, le norme
costituzionali le limitano: l’iniziativa economica subisce i limiti necessari per renderla compatibile con
l’utilità sociale e la sicurezza, libertà e dignità umana, nonché con l’esigenza che l’attività economica
sia indirizzata e coordinata a fini sociali; la proprietà quelli necessari per assicurarne la funzione
sociale.
Col secondo dei modi in cui la Costituzione opera come fonte del diritto dei contratti, l’applicazione
diretta delle sue norme ai rapporti fra privati, la Costituzione non presidia la libertà contrattuale, ma la
restringe.
Contro i contratti illeciti, diretti a risultati che l’ordinamento disapprova, scattano reazioni: i contratti
sono nulli, e non producono effetti.
Ciò accade quando il contratto viola norme imperative, o principi di ordine pubblico.
Le norme imperative ed i principi di ordine pubblico possono risultare non solo dalle leggi ordinarie,
ma anche dalla Costituzione.
Ad es., gli artt. 36.1 e 37.1 Cost. (principio della retribuzione giusta e sufficiente, e principio di parità
fra lavoratrici e lavoratori) hanno permesso ai giudici di dichiarare nulle le previsioni di singoli
contratti di lavoro.
Un principio fondamentale della Costituzione è il principio di uguaglianza (3 Cost.): come incide sul
contratto?
Come limite posto all’arbitrio del legislatore, il principio di uguaglianza vieta le discriminazioni
irragionevoli: la Corte costituzionale ha potuto dichiarare l’incostituzionalità del 781, che vietava le
donazioni fra coniugi.
Uguaglianza significa non solo non trattare diversamente situazioni uguali, ma anche trattare in modo
(ragionevolmente) diverso situazioni diverse.
Il principio di uguaglianza trova applicazione diretta ai rapporti contrattuali?
In linea di massima no: nella misura in cui è regno della libertà, il contratto può essere anche regno
della diseguaglianza e della discriminazione, basate su libere scelte dei contraenti.
Ciò non toglie che, in certi casi, i contratti discriminatori siano vietati.
Un marcato sfavore per i contratti discriminatori si manifesta nella legislazione antitrust.
Questa vieta gli abusi di posizione dominante, ed uno dei possibili abusi è applicare nei rapporti
commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti.
Per l’impresa in posizione dominante, discriminare è vietato in sé; per l’impresa in posizione non
dominante, non è vietato in sé discriminare, ma solo concordare con altre imprese un impegno
reciproco a discriminare soggetti estranei all’accordo.
Entro la struttura del quarto libro del codice, la disciplina del contratto si presenta organizzata in due
parti: la disciplina del contratto in generale è racchiusa nel titolo II (1321-1469-sexies); invece il titolo
III (1470-1986) contiene la disciplina dei singoli contratti.
Nella concezione tradizionale il contratto in genere è una figura unitaria, regolata con una disciplina
omogenea; invece la disciplina si frammenta in relazione ai singoli contratti.
La disciplina generale ha valore di regola applicabile ad ogni contratto: tutti i contratti […] sono
sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo (1323); invece la disciplina del singolo tipo ha
carattere eccezionale e portata circoscritta: può derogare alla disciplina generale solo sui punti per i
quali espressamente se ne discosta; il cuore della disciplina del contratto è costituito dalle norme di
parte generale, le norme di parte speciale hanno una posizione di secondo piano.
Queste premesse sono oggi in crisi, quasi tutte le nuove regole sui contratti non sono regole sul
contratto in genere, ma regole su singoli tipi (o classi) di contratti.
La figura conosce frammentazioni interne: l’elemento che soprattutto le determina è di natura
soggettiva, ovvero la qualifica socio-professionale dei soggetti contraenti: sicché si profila la
bipartizione fra contratti delle imprese e contratti fra privati.
La frammentazione corre anche sul filo di criteri oggettivi: cresce la rilevanza della distinzione fra
contratti effettivamente negoziati fra le parti, e contratti predisposti ed imposti da una parte all’altra.
Per contro, le discipline speciali relative a singoli contratti acquistano generalità e sistematicità.
Si organizzano in microsistemi; generano principi dotati di forza espansiva, regole transtipiche capaci
d’imporsi anche al di là degli stretti confini del tipo per cui furono dettate.
Dopo il 1942 le novità legislative sul contratto, seppur numerose, di rado entrano a novellare il codice:
il caso più importante è la nuova disciplina dei contratti fra professionisti e consumatori, introdotta nel
1996; altro es.: nel 1992 compare il nuovo 1938 sulla fideiussione omnibus.
Vi è una caratteristica di contenuto: le nuove leggi speciali riguardano prevalentemente contratti fra
soggetti che s’incontrano sul mercato, per scambiare beni o servizi che una delle parti produce e/o
distribuisce professionalmente.
Una seconda caratteristica tocca l’origine di questa legislazione: quasi sempre essa ha un’origine non
razionale ma sovrannazionale: attua direttive europee, recependo nell’ordinamento italiano la disciplina
elaborata in sede di Unione.
Una terza caratteristica riguarda tecniche e fonti della regolazione: è raro che la nuova disciplina dei
contratti sia direttamente versata in norme di legge formale, di produzione parlamentare.
Più spesso si tratta di leggi delega.
Nemmeno è infrequente che la norma primaria (legge o decreto delegato) rinvii per un supplemento di
disciplina a fonti secondarie, ed in particolare a provvedimenti delle Autorità amministrative
competenti per il governo del mercato cui appartengono i contratti da regolare.
Qui il problema tecnico è la riserva di legge: se la disciplina dei contratti sia riservata a fonti primarie, e
se la riserva sia assoluta o relativa.
Le caratteristiche della legislazione speciale sui contratti danno luogo ad ulteriori aspetti problematici;
per l’origine europea, essa introduce nel nostro ordinamento elementi di diritti stranieri, non sempre
filtrati o mediati in modo consapevole.
Un’ultima questione, in tema di fonti: se ed in che misura regole sui contratti possano essere poste dalle
leggi regionali.
Vi è una forza espansiva della disciplina del contratto in genere.
Il primo dato emerge dal codice stesso, che recita: salvo diverse disposizioni di legge, le norme che
regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto
patrimoniale (1324); la previsione pone diversi problemi interpretativi.
Un problema riguarda il raggio dell’estensione: e sul punto prevale – in dottrina ed in giurisprudenza –
un’idea non restrittiva.
L’ultrattività delle norme sul contratto può coprire anche atti a causa di morte; atti non patrimoniali;
s’ammette che possa spingersi fino a coprire atti non negoziali.
Altri problemi riguardano l’individuazione dei limiti posti alla forza espansiva della disciplina del
contratto.
Il 1324 ne indica due: il primo è l’esclusione espressa (“Salvo diverse disposizioni di legge…”): così,
ad es., la disciplina del contratto simulato non si applica tout court alla simulazione di tutti gli atti
unilaterali, ma solo agli atti unilaterali ricettizi qualificati da un accordo simulatorio fra autore e
destinatario (1414.3); il secondo limite è l’incompatibilità (“…in quanto compatibili”): a differenza del
primo, posto direttamente dal legislatore, questo secondo limite va costruito dall’interprete.
L’evocazione di una categoria di “atti”, più ampia di quella dei contratti, ha portato a vedere nel 1324
una base normativa per la figura del negozio giuridico, sovraordinata al contratto.
L’argomento non è probante: anzi appare fallace, sia per difetto sia per eccesso: per difetto, poiché
l’atto evocato dal 1324 ha confini ben più ristretti di quelli del negozio; per eccesso, se è vero che la
norma, nell’interpretazione comune, non esclude che la disciplina del contratto possa applicarsi anche
ad atti non negoziali.
La forza espansiva delle norme sul contratto in genere proietta gli artt. 1321 ss. anche in aree che non
sono quelle degli atti di diritto privato, quale quella dell’accordo come paradigma generale dell’azione
pubblica.
I principi del codice civile penetrano perfino in luoghi dove l’autonomia privata è straniera, come il
processo penale: l’irrevocabilità del patteggiamento proposto dall’imputato ed accettato dal pubblico
ministero (599.4 e 599.5 c.p.p.) si motiva rilevando che in materia non possono che applicarsi i criteri
stabiliti per il contratto dagli artt. 1326 e 1328 c.c., da intendersi come criteri generali per ogni negozio
bilaterale.
Le norme di diritto internazionale privato compiono una scelta fra leggi: indicano quale legge nazionale
sia applicabile ad un rapporto, in presenza di elementi che lo ricondurrebbero a più ordinamenti
giuridici diversi.
In materia di contratto vale un articolo che rinvia alla Convenzione di Roma del 1980, la quale adotta
un criterio principale ed un criterio subordinato: il criterio principale è la scelta delle parti, solo se
manca la scelta delle parti, soccorre il criterio subordinato, secondo il quale s’applica la legge del Paese
con cui il contratto presenta il collegament più stretto.
Per individuarlo, scattano alcune presunzioni: se ad es. il contratto ha per oggetto un immobile, si
presume che sia più strettamente collegato col Paese in cui è sito l’immobile.
Altri articoli della Convenzione riguardano singoli tipi o classi di contratto, come i contratti dei
consumatori.
L’intera materia è governata dalla clausola generale dell’ordine pubblico: la norma straniera che
risulterebbe applicabile in base ai criteri predetti, non s’applica se la sua applicazione è manifestamente
incompatibile con l’ordine pubblico italiano.
Il ricorso alle norme di diritto internazionale privato diventa superfluo quando non occorre compiere
una scelta fra leggi nazionali, in quanto al contratto s’applica una disciplina internazionalmente
uniforme.
Ciò può conseguirsi tramite convenzioni internazionali, la più importante convenzione in materia
contrattuale è la Convenzione di Vienna (1980) sulla vendita internazionale di beni mobili.
Ma l’uniformazione internazionale può perseguirsi anche con strumenti non giuridicamente vincolanti.
Nel 1994 Unidroit (Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato) ha licenziato un testo di
Principi dei contratti commerciali internazionali; un’area di riferimento più limitata hanno i Principi del
diritto europeo dei contratti; infine vi sono le direttive dell’Unione.
CAPITOLO V – LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: PROPOSTA E ACCETTAZIONE
Il contratto è accordo (1321): l’accordo è un requisito del contratto (1325 n.1).
Esiste una pluralità di schemi normativi per la conclusione del contratto, ciascuno schema s’applica ad
una determinata classe di contratti.
Dalle norme si ricava uno schema generale, destinato ad applicarsi in linea di principio alla generalità
dei contratti: lo schema definito dal 1326, con l’integrazione del 1335.
E si ricavano schemi particolari.
Lo schema generale implica che la conclusione del contratto sia determinata da due distinti atti,
provenienti in sequenza dall’una e dall’altra parte: la proposta (od offerta) di contratto, e l’accettazione
della proposta da parte dell’oblato.
L’incontro fra proposta ed accettazione è l’accordo contrattuale.
Proposta ed accettazione non sono, isolatamente considerate, il negozio contrattuale, non sono il
contratto, ma elementi del contratto in via di formazione.
Nondimeno sono atti negoziali, in quanto dichiarazioni di volontà finalizzate a creare un negozio (il
contratto); e dichiarazioni che generano di per sé effetti giuridici conformi alla volontà del dichiarante.
Sono atti negoziali precontrattuali.
Proposta ed accettazione sono atti unilaterali, e (con l’eccezione dell’offerta al pubblico) atti ricettizi.
Dal punto di vista della fattispecie, gli atti ricettizi sono quelli indirizzati ad una persona determinata;
dal punto di vista della disciplina, essi producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza
della persona a cui sono destinati (1334).
La proposta, l’accettazione […] e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si
reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di
essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (1335).
Sia per la proposta sia per l’accettazione vale il requisito dell’indirizzamento volontario.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione
dell’altra parte (1326.1).
Lo schema generale per la conclusione del contratto è perciò uno schema duplice, a due varianti: nella
variante della conoscenza, il contratto si conclude quando comunque il proponente conosce
l’accettazione dell’oblato, anche se la relativa dichiarazione non sia ancora giunta al suo indirizzo; nella
variante della ricezione, il contratto si conclude quando l’accettazione giunge all’indirizzo del
proponente, anche se questi non ne abbia, in concreto, avuto conoscenza.
La legge non indica i requisiti che la proposta deve presentare: vi provvedono gli interpreti.
La proposta dev’essere completa, e cioè contenere tutti gli elementi del futuro contratto, necessari e
sufficienti perché con la sua accettazione pura e semplice si possa dire formato l’accordo sul contratto.
La proposta non deve contenere, od essere accompagnata da, riserve sul proprio carattere attualmente
impegnativo.
Se la proposta è condizionata ad un fatto futuro ed incerto, è inefficace fino all’eventuale verificarsi del
fatto.
La proposta (così come l’accettazione) produce effetti non semplicemente in quanto giunga a
conoscenza dell’oblato, ma in quanto sia dal proponente volontariamente indirizzata all’oblato
(indirizzamento volontario).
Se la proposta di A perviene a B, ma la sua spedizione non corrispondeva alla volontà del proponente,
l’analogia con la regola del 1433 sull’errore ostativo suggerisce che se l’involontarietà della
trasmissione non era riconoscibile da B, e questi accetta, il contratto può concludersi.
L’involontarietà della trasmissione può essere più facilmente riconoscibile, o sospettabile, quando la
proposta perviene all’oblato tramite un terzo: la giurisprudenza pone la regola che in tal caso è onere di
B accertare che la proposta sia stata volontariamente affidata da A al terzo per la trasmissione a B.
Non è cedibile la posizione dell’oblato, creata dalla ricezione della proposta.
L’accettazione è l’atto unilaterale col quale l’oblato manifesta la sua volontà negoziale di concludere il
contratto; l’accettazione è atto ricettizio.
La scelta di tutela del proponente, che la legge fa con lo schema della cognizione (1326), viene poi
temperata con lo schema della ricezione: all’effettiva conoscenza della dichiarazione ricettizia la legge
equipara il fatto materiale del giungere della dichiarazione all’indirizzo del destinatario.
L’accettazione deve giungere all’indirizzo del proponente: termine che si tende ad interpretare in senso
largo, ricomprendendosi sia la dimora, sia la residenza, sia il domicilio, sia anche altro recapito che
possa considerarsi abitualmente frequentato dal proponente o comunque sotto il suo controllo.
Una regola è posta dall’inciso finale del 1335: anche se l’accettazione giunge all’indirizzo del
proponente, ciò non equivale a presa di conoscenza da parte sua se il proponente si trova, senza sua
colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Se l’accettazione è ignorata dal proponente per impossibilità dovuta a sua colpa, il contratto è
senz’altro concluso.
Impossibilità incolpevole è qualunque fattore che impedisca al proponente di conoscere l’accettazione
giunta al suo indirizzo e non possa essergli rimproverato secondo ragionevolezza e buona fede, tenuto
conto della sua organizzazione e di ogni altra circostanza rilevante.
L’accettazione difforme non determina conclusione del contratto, ma equivale a nuova proposta
(1326.5); conformità e difformità vanno intesi qui in senso oggettivo (testuale), e non soggettivo.
Sul grado di difformità necessario e sufficiente per impedire la conclusione del contratto, la
giurisprudenza apparentemente sposa una linea molto rigida: la conformità dev’essere totale ed
assoluta, qualunque difformità – relativa non solo ad elementi essenziali, ma anche ad elementi
secondari – impedisce la conclusione del contratto.
Sembra da preferire un approccio più flessibile, illuminato dal principio di buona fede.
Può pensarsi che la regola di buona fede imponga al proponente – di fronte a difformità
dell’accettazione “leggere” – un onere di replica immediata e motivata con la quale egli dica che non
accetta le modifiche ancorché marginali, o contesti che le clausole depennate siano nulle, o protesti di
non condividere l’interpretazione della clausola data dall’accettante.
Un’accettazione espressa in lingua diversa da quella della proposta, anche se testualmente difforme,
non necessariamente è difforme nel senso del 1326.5: se essa traduce i termini della proposta,
fedelmente e senza ambiguità, in una lingua straniera che non risulti cervellotica alla luce delle
condizioni delle parti, non vi è ragione di considerarla difforme.
Se l’oblato dichiara di accettare la proposta, ma contemporaneamente prospetta il desiderio di
modificarne qualche termine, l’ambiguità della sua dichiarazione richiede un lavoro interpretativo.
Analoga incertezza può accompagnare l’accettazione di massima, qualificata dal rinvio ad un atto
ulteriore (ad es. “segue lettera”).
Può l’oblato pentirsi del rifiuto, e successivamente accettare la proposta? Od il rifiuto fa cadere la
proposta, impedendo all’oblato di determinare la conclusione del contratto con una successiva
accettazione? Gli interpreti propendono per quest’ultima tesi.
Diverso sarebbe se il rifiuto fosse qualificato con un’apertura a possibili ripensamenti: qui il
proponente che vuole chiudere il discorso ha l’onere di revocare la proposta.
La controproposta non fa cadere la proposta originaria: il controproponente può tornare sui suoi passi e
con un’accettazione conforme concludere il contratto (salvo, forse, che la controproposta fosse così
radicalmente difforme da avere il senso, e generare la percezione, di un sostanziale rifiuto).
L’accettazione dev’essere tempestiva, e cioè arrivare al proponente entro un certo termine.
Il termine può essere indicato dallo stesso proponente; in mancanza è “quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi” (1326.2).
Scaduto il termine, la proposta diventa inefficace.
Il proponente può rinunciare a far valere la tardività dell’accettazione, e considerare questa – ancorché
tardiva – idonea a concludere il contratto.
Se vuole farlo, ha però l’onere di darne immediatamente avviso all’altra parte (1326.3).
Ci si può chiedere se la discrezionalità del proponente nell’imporre all’oblato il tempo dell’accettazione
sia illimitata: s’immagini che il proponente fissi all’oblato un termine assurdamente breve, impossibile
da rispettare, e che l’oblato accetti con la massima velocità possibile, ma pur sempre dopo quel
termine: la giurisprudenza ritiene che il contratto non si concluda, ma che il proponente possa essere
chiamato a rispondere della sua scorrettezza a titolo di responsabilità precontrattuale.
S’immagini che il proponente fissi per l’accettazione dell’oblato non un termine massimo, ma un
termine minimo, prima del quale non si può accettare: la giurisprudenza s’è pronunciata per
l’inammissibilità d’un siffatto termine a quo, per cui anche con l’accettazione precoce il contratto
sarebbe concluso.
La tesi va disapprovata: fissare per l’accettazione un termine a quo può corrispondere ad un
ragionevole interesse del proponente, e non lede alcun interesse prevalente dell’oblato.
Se conformità e tempestività sono requisiti necessari dell’accettazione, è solo eventuale il terzo
requisito: la formalità.
In linea di principio (fatti salvi i contratti formali), l’accettazione è atto a forma libera, senza vincolo di
simmetria con la proposta: può accadere che l’accettazione richieda d’essere espressa in una forma
determinata: la forma che lo stesso proponente abbia imposto all’oblato per l’accettazione.
In tal caso, l’accettazione che sia espressa in forma diversa non è efficace, e non vale a concludere il
contratto (1326.4).
Dovrebbe valere anche qui il principio della disponibilità dell’interesse: il proponente può ritenere
efficace l’accettazione non fatta nella forma indicata (purché ne dia immediato avviso all’accettante,
come suggerisce l’analogia col 1326.3, inciso finale).
Può accadere che la proposta sia rivolta non ad un destinatario determinato, ma “al pubblico”: della
fattispecie s’occupa il 1336: ciò che rileva per qualificare l’offerta al pubblico non è il numero più o
meno grande dei destinatari, né il fatto che questi siano noti od ignoti all’offerente, ma solo il fatto che
l’offerente si rivolga ad una platea di destinatari in modo non individuale ma collettivo, usando un
mezzo di comunicazione di massa.
Una proposta pur trasmessa con mezzo di comunicazione di massa è una proposta individualizzata se si
rivolge ad un destinatario determinato.
Per molti aspetti il regime dell’offerta al pubblico dettato dal 1336 coincide con quello dell’offerta
individualizzata.
L’offerta al pubblico vale come proposta a due condizioni: la prima è che contenga gli elementi
essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta; la seconda è che non risulti diversamente dalle
circostanze o dagli usi.
Una proposta incompleta, una proposta completa ma che per espressa volontà del proponente o per dati
esterni (quali le circostanze o gli usi) non impegna ancora il proponente, possono valere come semplice
invito ad offrire.
La proposta individualizzata è ricettizia, l’offerta al pubblico è atto non ricettizio: è efficace dal
momento in cui viene (volontariamente) emessa.
Certamente ricettizia è invece l’accettazione dell’offerta al pubblico; l’art. 1336.2 dice che la revoca
dell’offerta, se fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in
confronto di chi non ne ha avuto notizia.
Contrariamente al rifiuto della proposta individualizzata, può ammettersi che il rifiuto di un esponente
del pubblico cui si rivolgeva l’offerta non faccia cadere quest’ultima, ma la lasci in vita non solo per gli
altri esponenti, ma anche per il rifiutante, cui è dato pentirsi del rifiuto e successivamente accettare.
Se l’offerta al pubblico non è espressa verbalmente, ma con l’esibizione della prestazione dedotta in
essa, e l’accettazione consiste nell’appropriarsene (portare alla cassa e pagare merce esposta nei banchi
del supermercato; salire sul mezzo di trasporto pubblico: c.d. offerte a prelievo diretto) i problemi che
ne nascono trovano risposta nelle dottrine del comportamento concludente e dei negozi di attuazione.
Se l’offerta al pubblico ha la forma della c.d. asta televisiva e della c.d. televendita, il legislatore se ne
occupa specificamente.
Così per la questione delle accettazioni incompatibili.
In un’opa per il 100% delle azioni di una società, tutti gli azionisti possono efficacemente accettare, e
con tutti può farsi il contratto; il problema si pone per le offerte al pubblico che possono dar luogo solo
ad un numero limitato di contratti, con l’eventualità di lasciar fuori qualche esponente del pubblico che
pure intenderebbe accettare l’offerta: si pensi ad un’opa non totalitaria; si pensi ad un’offerta pubblica
per la vendita di beni esistenti in numero elevato ma non illimitato.
Il criterio per risolvere il conflitto fra accettazioni eccedenti l’offerta può esser dettato dall’offerta
stessa (come accade di solito con le opa, che dispongono meccanismi di riparto).
In mancanza, vale la regola della priorità della conclusione del contratto.
Nel caso di scuola di simultaneità fra accettazioni incompatibili, è rimesso all’offerente scegliere con
quale accettante ritenere concluso il contratto.
Se l’offerente manca d’avvertire che la sua offerta darà luogo ad un numero di contratti non illimitato,
può incorrere in responsabilità precontrattuale verso gli accettanti delusi.
L’offerta al pubblico va distinta dalla promessa al pubblico (1989-1991); l’offerta al pubblico non crea
di per sé l’obbligazione, l’obbligazione è creata dal contratto.
Invece la promessa al pubblico, come atto unilaterale (non intrusivo), opera essa stessa come fonte
dell’obbligazione.
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una
determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena
questa è resa pubblica (1989.1).
Consideriamo le due varianti della promessa al pubblico.
La prima variante è la promessa di prestare a chiunque si trovi in una determinata situazione: una
promessa del genere si sovrappone allo schema del contratto con obbligazioni del solo proponente, che
si forma ex 1333 in base al mancato rifiuto dell’oblato; la seconda variante è la promessa di prestare a
chiunque compia una determinata azione: qui la promessa si sovrappone allo schema del contratto ex
1327 senza preventiva risposta da parte dell’oblato, semplicemente per il fatto che questi esegue la
prestazione indicata nella proposta.
Non sembra che qualificare le fattispecie in un modo piuttosto che nell’altro faccia enorme differenza;
alla prestazione promessa s’applicano comunque le norme sul contratto avente come oggetto tipico la
prestazione stessa.
Dal 1327 si ricava un principio, che sembra applicabile a tutti i contratti, quale che sia lo schema per la
loro conclusione: il luogo di conclusione del contratto è quello in cui si produce l’ultimo fatto che
completa la fattispecie della conclusione.
Per il 1327, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio la prestazione richiesta
dal proponente; nei casi in cui s’applica lo schema generale, il contratto si conclude nel luogo in cui il
proponente ha conoscenza dell’accettazione (1326.1).
CAPITOLO VI – SCHEMI PARTICOLARI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Gli schemi particolari sono prima di tutto schemi legali: previsti ora dal codice, ora da leggi speciali;
ma possono essere anche schemi giurisprudenziali.
Il 1327 detta uno schema particolare di conclusione per la classe dei contratti in cui la prestazione
debba eseguirsi senza una preventiva risposta; lo schema è: proposta inviata e giunta all’oblato, seguita
da inizio della prestazione dell’oblato: il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto
inizio l’esecuzione (1327.1).
Si toglie al proponente la garanzia dello schema generale, dandogli in cambio una maggior velocità
dell’operazione.
Lo schema implica l’accordo delle parti sulla proposta: la volontà di accettare è manifestata non con
una dichiarazione espressa, ma con un comportamento concludente; e la manifestazione produce effetto
non nel momento in cui giunge alla conoscenza od all’indirizzo del proponente, ma nel momento in cui
è realizzata dall’oblato.
Sotto questo profilo, è atto non ricettizio.
Un diverso orientamento dottrinale nega invece che l’esecuzione da parte dell’oblato possa qualificarsi
manifestazione di volontà: con quel comportamento la volontà contrattuale non verrebbe manifestata,
ma direttamente attuata; la fattispecie ricadrebbe così nella categoria dei negozi di attuazione.
La classe dei contratti ai quali si riferisce il 1327 è identificata da tre elementi alternativi: la superfluità
della preventiva risposta può dipendere dalla richiesta del proponente, dalla natura dell’affare, o dagli
usi (1327.1).
Questi elementi sono alternativi fra loro: ne basta uno a rendere applicabile lo schema.
Ma per la giurisprudenza sono anche tassativi.
Il 1327 è inapplicabile ai contratti che prevedano a carico dell’oblato prestazioni di non fare, o
prestazioni la cui esecuzione resti chiusa nella sfera dell’oblato stesso: idonee a manifestare l’accordo
dell’oblato sulla proposta sono solo le attività corrispondenti a prestazioni positive, destinate ad uscire
dalla sfera dell’oblato per entrare nella sfera del proponente.
Fuori di questi casi (dei tre elementi alternativi), se l’oblato comincia ad eseguire la prestazione
richiesta senza prima comunicare al proponente che accetta, il contratto non si conclude con l’inizio
dell’esecuzione ex 1327, ma ex 1326.1 e 1335: ovvero quando l’inizio di esecuzione (che per fatto
concludente manifesta l’accettazione dell’oblato) giunge a conoscenza del proponente od al suo
indirizzo, e nel luogo in cui ciò si verifica.
Lo schema del 1327 non può operare per i contratti formali, in cui l’accettazione va espressa nella
forma vincolata e non può manifestarsi per fatto concludente; una notevole eccezione risulta da una
legge speciale: il contratto di subfornitura richiede forma scritta, ma se il proponente-committente
rivolge al subfornitore proposta scritta, il contratto si ritiene validamente concluso per iscritto quando il
subfornitore, senza rispondere per iscritto, inizia la fornitura o le lavorazioni richieste.
Il destinatario di una proposta ex 1327 può concludere il contratto secondo lo schema generale degli
artt. 1326.1 e 1335? Non v’è ragione per escluderlo, ove ciò non pregiudichi l’interesse del proponente.
Date le condizioni di applicabilità del 1327, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha
avuto inizio l’esecuzione.
L’iniziata esecuzione conclude il contratto solo se proviene dall’oblato, e non se proviene dal
proponente (come nel caso di chi invia un ordine di merci, accompagnato dal pagamento delle merci
ordinate); diversamente mancherebbe l’accordo delle parti.
L’oblato ha un obbligo: concluso il contratto con l’inizio dell’esecuzione, di ciò deve dare prontamente
avviso all’altra parte, pena il risarcimento del danno (1327.2).
L’obbligo tutela il proponente, nel suo interesse a sapere se il contratto è concluso oppure no.
L’avviso è superfluo quando la prestazione raggiunge il proponente in tempi più veloci di quelli che
impiegherebbe l’avviso; se la proposta ha un termine di efficacia, può comunque considerarsi pronto
l’avviso che raggiunga il proponente prima della scadenza.
Se l’esecuzione è iniziata, l’avviso non produce, ed il mancato avviso non pregiudica, una conclusione
già prodotta; ma se non c’è ancora inizio dell’esecuzione, l’avviso che la preceda e la preannunci può
valere come accettazione espressa della proposta.
Il mancato avviso o la mancata prontezza dell’avviso determinano responsabilità (precontrattuale)
dell’oblato verso il proponente; il danno risarcibile è dato dai costi non recuperabili, che il proponente
abbia sostenuto per procurarsi altrove una prestazione che poi risulta inutile, giacché il contratto era
invece concluso.
Il contratto concluso mediante proposta non tempestivamente rifiutata si applica ai contratti da cui
derivino obbligazioni per il solo proponente (1333.1).
La categoria comprende, in linea di principio, i contratti gratuiti, in forza dei quali solo il proponente
s’impegna senza corrispettivo a carico dell’oblato.
Ma non tutti i contratti gratuiti: ne resta esclusa la donazione formale, che richiede accettazione
dell’oblato, ed i contratti gratuiti con modus a carico del beneficiario, perché da essi nascono pur
sempre obbligazioni anche a carico dell’oblato.
La dottrina s’interroga sul senso del “mancato rifiuto”, produttivo del contratto: secondo una tesi
estrema, la norma non si riferirebbe in realtà a contratti, bensì ad atti unilaterali, ma prevale
l’orientamento che riconosce agli atti ex 1333 la natura di contratti: ma all’interno di essi le varianti
dottrinali sono molte.
Secondo una prima variante, qui vi è contratto perché vi è accettazione, ancorché tacita.
Per una seconda variante, qui v’è contratto perché – pur non essendo il nudo silenzio dell’oblato
accettazione, ancorché tacita – il 1333 lo qualifica e lo tratta come accettazione, ricollegandovi gli
effetti corrispondenti.
Più lineare e persuasiva è la tesi secondo cui non v’è qui accettazione, e tuttavia vi è contratto.
Qualcuno si spinge ad aggiungere che contratto senza accettazione significa contratto senza accordo: il
1333 derogherebbe perciò non solo allo schema degli artt. 1326.1 e 1335, ma anche al 1325, laddove
indica nell’accordo delle parti uno dei requisiti del contratto.
Questa posizione non è da condividere: l’accettazione della proposta è il modo più diretto e consueto
per creare l’accordo, ma non è l’unico.
Può esservi contratto senza accettazione, ma non contratto senza accordo.
Lo schema del 1333 – atto formato mediante proposta non rifiutata – si ritrova nel 1236, a proposito
della remissione; dunque anche la remissione, pur essendo atto a formazione unilaterale, che non
richiede accettazione del debitore liberato, implica l’accordo di questo.
Il 1334 stabilisce in via generale che l’atto unilaterale ricettizio produce effetti nel momento in cui
perviene al destinatario: applicata alle promesse, la regola significherebbe che queste creano
l’obbligazione del promittente ed il credito del promissario non appena giunte a quest’ultimo, senza
bisogno della sua accettazione, e ciò metterebbe fuori gioco il principio dell’accordo.
Il 1987 impedisce questo risultato, disponendo che la regola non si applica in generale ad ogni
promessa, ma solo alle promesse tassativamente indicate dalla legge.
Per tutte le altre promesse, in luogo del 1334 si applica il 1333, che ripristina il principio dell’accordo:
la promessa non produce effetti (non crea l’obbligazione) quando giunge al destinatario, perché bisogna
dare a costui il tempo di valutarla e rifiutarla, se non è d’accordo; produce effetti solo quando –
trascorso un congruo periodo dalla ricezione, senza rifiuto del destinatario – può pensarsi che questi sia
d’accordo.
Le promesse che producono effetti in base al 1334 sono unilaterali; quelle che producono effetti in base
al 1333 sono contrattuali.
La proposta di contratto con obbligazioni del solo proponente è irrevocabile, e trattandosi di atto
ricettizio, l’effetto dell’irrevocabilità scatta nel momento in cui la proposta giunge a conoscenza della
parte alla quale è destinata (1333.1); ovvero nel momento in cui giunge all’indirizzo dell’oblato, per
l’equivalenza posta in generale dal 1335.
La ricezione della proposta determina solo l’effetto di rendere la proposta irrevocabile, ma non ancora
quello di concludere il contratto.
Il contratto si conclude nel momento in cui il termine scade, senza che vi sia stato rifiuto dell’oblato (od
anche prima se l’oblato abbia dichiarato di accettare).
Se il luogo di conclusione del contratto segue il tempo di essa, allora il contratto ex 1333 va localizzato
non presso il proponente, ma presso l’oblato, nel luogo di ricezione della proposta.
Il rifiuto ha l’effetto di bloccare la conclusione del contratto solo se è tempestivo, e cioè rispetta il
termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi.
Un rifiuto tardivo non impedisce la conclusione del contratto, ma per esser tempestivo, il rifiuto deve
essere formato entro il termine, od entro il termine deve giungere alla conoscenza/all’indirizzo del
proponente? La natura ricettizia dell’atto, e l’analogia col regime della revoca dell’accettazione,
inducono a preferire la seconda risposta.
Lo schema del 1333 s’applica anche ai contratti formali.
Può trovare applicazione anche ai contratti con effetti reali ad esclusivo carico del proponente? La
giurisprudenza sembra ammetterlo.
Per il 1321 il contratto può essere accordo fra più di due parti: i contratti con più di due parti si
chiamano usualmente contratti plurilaterali (con esclusione del contratto a favore di terzo, che ha solo
due parti).
Assumiamo come situazione-base quella di un contratto che segue lo schema generale; la proposta
viene inviata da un proponente a più oblati: perché il contratto si concluda è necessario che tutti gli
oblati accettino?
In linea di principio occorre che tutte le parti ricevano notizia dell’accettazione di tutte le altre, perché è
interesse di ciascuna sapere che la fattispecie di conclusione del contratto è perfezionata.
Può ammettersi che se un accettante indirizza l’accettazione ad alcune soltanto delle altre parti,
ciascuna di queste sia legittimata a trasmetterla efficacemente anche alle altre, trascurate dall’accettante
(sempre che l’indirizzamento solo parziale non debba intendersi come accettazione difforme).
La situazione-base può conoscere varianti; ad es.: due proponenti inviano congiuntamente la stessa
proposta ad un oblato, oppure due proponenti la inviano a due oblati; anch’esse sembrano governabili
col criterio sopra esposto.
La situazione-base può essere complicata dal fatto che vengano in gioco contratti cui si applicano
schemi di conclusione particolari: ad es., proposta di contratto unilaterale ex 1333, indirizzata a più
oblati; proposta di contratto con obbligazioni a carico dell’oblato X, ma senza obbligazioni a carico
dell’altro oblato Y.
Nel caso di contratto per la cui conclusione s’intrecciano schemi diversi, il criterio è che il contratto si
conclude solo quando l’ultimo degli schemi implicati è soddisfatto.
Dal contratto plurilaterale va distinto il contratto bilaterale con parte complessa, in cui cioè una parte
sia costituita da più d’un soggetto.
I contratti plurilaterali possono presentarsi come “aperti”: sono quelli conclusi ed operanti fra due o più
parti originarie, ma suscettibili di accogliere anche altri soggetti, che vi aderiscono successivamente, e
con l’adesione diventano anch’essi parti di quel medesimo contratto.
Per la conclusione dei contratti aperti, vale il particolare schema del 1332.
La norma contempla tre ipotesi.
La prima ipotesi è che il contratto contempli particolari modalità per le adesioni successive: ed allora
sono queste modalità a governare la conclusione.
La seconda ipotesi è che modalità del genere non siano previste, ed esista un organo costituito per
l’attuazione del contratto: in tal caso, l’adesione va indirizzata all’organo, ed essendo ricettizia diventa
efficace quando vi perviene.
Se invece, è la terza ipotesi, non esiste organo siffatto, l’adesione va indirizzata (e deve pervenire) a
tutti i contraenti originari: che è lo schema comune di conclusione dei contratti plurilaterali.
Se la clausola di apertura ha valore di proposta, l’adesione ha valore di accettazione, e può da sola
concludere il contratto.
Ma può invece prevedersi che l’adesione passi al vaglio dei contraenti originari o dell’organo di
attuazione del contratto, che si riservano di accoglierla o meno: in tal caso la clausola è invito a
proporre, e l’adesione è proposta che attende un’accettazione.
I principali contratti aperti sono contratti con comunione di scopo: associazioni, consorzi, società
cooperative, ma esistono contratti con comunione di scopo che non sono contratti aperti: le società
lucrative.
E la casistica esibisce contratti aperti senza comunione di scopo: ad es. una transazione.
I contratti reali sono contratti il cui schema di formazione prevede che il contratto si conclude con la
consegna della cosa: senza consegna, il contratto non si forma.
Alla categoria si riconducono figure come il deposito, il comodato, il mutuo, la donazione manuale, il
pegno, il riporto, il contratto estimatorio ed il sequestro convenzionale.
Ai contratti reali si contrappongono i contratti consensuali, che si formano col semplice consenso
(accordo) delle parti, senza bisogno di consegna della cosa che ne forma oggetto: ad es. la vendita, la
locazione, il trasporto di cose.
Nei contratti reali la consegna della cosa non sostituisce il consenso delle parti.
Una convincente giustificazione della realità è che in certi contratti solo la consegna della cosa indica la
volontà di assumere un vincolante impegno giuridico.
Nella donazione ordinaria è la forma solenne a rassicurare circa la volontà del donante di assumere il
vincolo giuridico derivante dal contratto di donazione.
Nella donazione manuale, che non riveste forma solenne, questo ruolo di spia della seria volontà
d’impegnarsi giuridicamente può essere svolto solo da un atto fortemente significativo in tal senso,
come la consegna della cosa.
Consideriamo ora un contratto reale non necessariamente gratuito, come il mutuo (1813).
Se la realità del mutuo fosse da intendersi in modo rigido, ne conseguirebbe che l’accordo fra A e B,
per cui A consegnerà a B una somma di denaro che poi B restituirà ad A con le modalità convenute,
non forma contratto: con la conseguenza che non ne nascono impegni giuridici per nessuno.
Ma lo stesso legislatore ammette la promessa di mutuo, efficace e vincolante a prescindere dalla
consegna del denaro (1822).
La giurisprudenza concepisce il requisito della consegna in termini molto ampi, ravvisandolo anche in
una consegna non materiale ma simbolica.
Nessuna difficoltà ad ammettere il valore vincolante di un accordo di mutuo senza consegna, se si tratta
di mutuo oneroso (con interessi); maggiore difficoltà ad ammetterlo per il mutuo gratuito (senza
interessi).
In linea di principio la causa onerosa è più forte, la causa gratuita più debole.
La consegna della cosa può essere vista come elemento che, nei contratti reali gratuiti, integra la
debolezza della causa.
Torniamo all’accordo di mutuo senza consegna.
Il contratto può configurarsi come definitivo, o come preliminare di mutuo.
Nel primo caso nasce direttamente l’obbligazione di consegna della somma mutuata, che il mutuatario
può azionare in giudizio chiedendo la condanna del mutuante a versargli proprio quella somma.
Nel secondo caso nasce solo l’obbligo di concludere il contratto definitivo di mutuo.
Il mutuo consensuale o la promessa di mutuo, ancorché siano contratti vincolanti, non generano
l’effetto reale dell’acquisto in proprietà della somma (non consegnata) in capo al mutuatario.
Alcuni contratti reali hanno effetti solo obbligatori, come il comodato ed il deposito.
Ma altri hanno effetti reali, come il mutuo ed il riporto (che trasferiscono proprietà di cose) od il pegno
(che costituisce il corrispondente diritto reale).
Rispetto a questi ultimi, bisogna distinguere fra ciò che occorre per la conclusione del contratto e ciò
che occorre per la produzione dell’effetto reale tipico del contratto.
Sintesi: nei contratti appartenenti al tipo della donazione, la realità surroga la forma (donazione
manuale); nei contratti gratuiti (mutuo e deposito gratuiti, comodato), integra la causa; nei contratti ad
effetti reali (mutuo, pegno, riporto), fonda la produzione dell’effetto reale.
Altri schemi particolari di conclusione sono previsti dalla legge per specifici tipi contrattuali: nella
donazione se il contratto si forma in base a proposta del donante ed accettazione non contestuale del
donatario, occorre che l’accettazione pervenga alla conoscenza od all’indirizzo del donante in modo
qualificato, e cioè che sia notificata al donante.
Il contratto può poi concludersi secondo schemi non espressamente previsti dalla legge.
In particolare senza che nel processo di formazione siano identificabili una proposta ed
un’accettazione.
L’esperienza esibisce schemi di conclusione del contratto non legali, bensì giurisprudenziali.
La giurisprudenza applica la regola per cui se B produce in giudizio la proposta non accettata od il testo
non firmato, dicendosi interessato al relativo contratto, il contratto si ritiene concluso (sempre che, nel
frattempo, il proponente non sia morto né sia divenuto incapace né abbia revocato la proposta).
Un contratto può formarsi in modo istantaneo od in modo progressivo.
La formazione progressiva si realizza attraverso il continuum di un dialogo delle parti, la parola che
designa questo processo è “trattativa”; la trattativa può svolgersi su alcuni punti del contratto e non su
altri.
La formazione progressiva del contratto è caratterizzata dal determinarsi di accordi su alcuni punti del
contratto, mentre su altri punti l’accordo non c’è ancora.
In questa progressione di semi-accordi, o accordi parziali, quando si forma l’accordo necessario e
sufficiente per la conclusione del contratto? La soluzione del problema è affidata a due regole.
La prima regola è: per la conclusione del contratto è necessario che si raggiunga l’accordo su tutti i
punti venuti in discussione: questa regola dà torto alla parte che voglia sostenere che il contratto è
concluso perché il residuo disaccordo riguarda un punto non essenziale del contratto.
Ma la distinzione tra punti essenziali e non essenziali è arbitraria: in linea di principio tutti i punti del
contratto su cui le parti abbiano portato la trattativa devono ritenersi essenziali per le parti stesse.
La regola va applicata con ragionevolezza: dovrebbe respingersi la pretesa della parte che neghi la
conclusione di un contratto apparentemente concluso solo perché non risulta raggiunto l’accordo su un
punto marginalissimo e di importanza trascurabile, pur venuto in discussione e poi lasciato in sospeso.
La seconda regola è: per la conclusione del contratto può esser sufficiente l’accordo parziale su alcuni
soltanto dei punti discussi, mentre su altri punti non c’è ancora accordo, purché le parti manifestino la
loro comune volontà in tal senso.
Qualcuno prospetta una terza regola: in caso di accordo solo parziale, che le parti dichiarino sufficiente
per la conclusione del contratto, il contratto tuttavia non si conclude se i punti sui quali resta il
disaccordo non possono essere successivamente definiti con qualche meccanismo d’integrazione del
contratto.
Questa regola va contestata, perché il problema che essa evidenzia non riguarda la conclusione del
contratto, ma la sua invalidità per indeterminabilità dell’oggetto.
Quando l’accordo parziale non conclude il contratto, esso non ha valore vincolante, nel senso che non
vincola come contratto.
Tuttavia può concorrere a determinare una responsabilità (precontrattuale) della parte che
ingiustificatamente lo disattenda.
Nel corso della formazione progressiva del contratto, le parti possono fissare sinteticamente per iscritto
i punti già concordati (puntuazione), o stendere un testo provvisorio del contratto in discussione
(minuta), e firmare o siglare il testo così redatto.
Il valore di un testo siffatto dipende dalle circostanze del caso.
Se la minuta copre solo alcuni dei punti affrontati o da affrontare in trattativa, come regola non c’è
contratto; ma se dalla stessa minuta od altrimenti risulta con chiarezza la volontà delle parti di
considerarsi contrattualmente vincolate dall’accordo pur parziale, il contratto è concluso.
Ugualmente, se il testo copre tutti i punti in discussione, il contratto può ben ritenersi concluso.
Negli ultimi due casi, la conclusione del contratto può non essere esclusa dal fatto che le parti abbiano
programmato la riscrittura del testo “in bella copia”.
Se per qualche ragione ciò non avverrà, il contratto è comunque concluso e la minuta ne costituisce il
testo.
La formula “contenuto minimo dell’accordo” può avere significati diversi a seconda dei contesti in cui
è usata.
La copertura di tutti i punti in discussione è il contenuto “minimo” necessario perché l’accordo
concluda il contratto.
La copertura di tutti i punti non suscettibili di successiva determinazione in via integrativa è il
contenuto “minimo” necessario perché l’accordo concluda un contratto valido, anziché nullo per
indeterminabilità dell’oggetto.
Le lettere (o dichiarazioni) d’intenti sono testi che le parti, d’accordo, si scambiano o firmano, e che
presentano un dato comune: si riferiscono ad una trattativa in corso, ed implicano che il contratto al
quale la trattativa è finalizzata non sia ancora concluso.
Il principale scrupolo di chi forma e sottoscrive lettere d’intenti deve essere evitare d’inserirvi elementi
capaci di far ritenere che esse valgono conclusione del contratto cui si riferiscono.
Se le lettere d’intenti non concludono il contratto cui si riferiscono, nondimeno possono creare fra le
parti qualche diverso vincolo di natura contrattuale; ad es., l’obbligo di rispettare tempi, luoghi e modi
concordati per lo svolgimento della trattativa, oppure, se in esse previsto, l’obbligo di esclusiva, cioè di
non svolgere trattative parallele con altri, o l’obbligo di non modificare certe situazioni (standstill
agreement), o l’obbligo di rivelare all’altra parte certi dati relativi alla propria organizzazione
(disclosure agreement), ed il contro-obbligo per chi li apprende di tenerli riservati (secrecy o
confidentiality agreement).
CAPITOLO VII – VICENDE E CIRCOSTANZE DELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO
Fra il tempo in cui il dichiarante fa la sua dichiarazione contrattuale (proposta od accettazione) ed il
tempo in cui il contratto si conclude, può accadere che il dichiarante muoia o diventi incapace di agire.
La regola è che ciò rende la dichiarazione inefficace, e così impedisce la conclusione del contratto.
La regola si ricava per implicito dagli artt. 1329.2 e 1330, che dettano per alcuni casi particolari la
soluzione contraria, presentandola come derogatoria ad una regola generale data per presupposta.
In questo modo si tutela chi subentra al dichiarante colpito dall’evento, salvaguardandone la sfera
decisionale, e si tutela anche controparte, difendendolo contro sorprese relative al partner del rapporto.
Di fronte ad una prospettiva di contratto non programmato e non gradito, chi subentra al dichiarante
avrebbe teoricamente modo di autotutelarsi: revocando la dichiarazione, e così pure la controparte del
dichiarante colpito dall’evento potrebbe revocare la propria dichiarazione, ma può obiettarsi che non
sempre una revoca tempestiva è praticamente possibile.
Le norme (1329.2 e 1330) parlano di incapacità, senza specificare se intendono solo l’incapacità legale
od anche quella naturale: prevale in dottrina la tesi restrittiva.
A limitare l’ambito all’incapacità legale concorre anche l’esigenza di non far dipendere la mancata
conclusione del contratto da fattori spesso impalpabili e comunque non risultanti in via documentale,
come quelli che danno corpo all’incapacità naturale.
Nell’area dell’incapacità legale, va poi ritagliata una zona d’immunità dalla regola: non c’è ragione di
applicarla alle dichiarazioni contrattuali di soggetto poi inabilitato, che siano finalizzate ad un contratto
di ordinaria amministrazione, per cui egli conserva capacità di agire ex 427.2.
Ci si può anche interrogare sulle conseguenze che la dichiarazione subisce per la morte o l’incapacità
del destinatario di essa.
A fa la proposta a B, che dopo averla ricevuta e prima di averla accettata muore o diventa incapace: la
proposta di A resta efficace o diventa inefficace?
È in discussione la possibilità che accetti l’erede di B od il suo tutore: possibilità che mette a rischio la
posizione del proponente.
Dunque il sopravvenire di morte od incapacità (legale) dell’oblato fa cadere la proposta.
La regola appena descritta subisce due deroghe.
La prima riguarda la proposta irrevocabile: ove la proposta abbia questa natura, morte ed incapacità
sopravvenute del proponente non la rendono inefficace, e se l’oblato accetta il contratto si conclude
(1329.2).
L’oblato ha almeno due rimedi alternativi per allontanare da sé il contratto non gradito: impugnarlo per
errore sulla persona di controparte, o negarne la conclusione, a norma dell’inciso finale del 1329.2.
Il 1329.2 stabilisce una deroga alla deroga, ripristinando la regola generale: anche una proposta
irrevocabile perde efficacia per morte od incapacità del proponente, quando la natura dell’affare od
altre circostanze escludano tale efficacia.
La seconda deroga riguarda sia la proposta sia l’accettazione fatta dall’imprenditore nell’esercizio della
sua impresa: anche essa non perde efficacia per morte od incapacità sopravvenuta del dichiarante
(1330).
Questa deroga conosce a sua volta due deroghe: si ritorna al principio dell’inefficacia se l’imprenditore
è un piccolo imprenditore, e vi si ritorna, anche per l’imprenditore non piccolo, quando la natura
dell’affare od altre circostanze sconsigliano (nell’interesse dell’una o dell’altra parte) che il contratto
sopravviva alla morte od all’incapacità del titolare dell’impresa.
Circola un assunto che porterebbe ad identificare una terza deroga alla regola dell’inefficacia: quello
per cui la dichiarazione contrattuale sopravvive al dichiarante poi morto, quando essa contiene una
siffatta clausola di sopravvivenza; ma la tesi muove da un presupposto erroneo: che la regola
dell’inefficacia tuteli interessi solo sul versante del dichiarante, il quale potrebbe quindi rinunciarvi.
La legge dà al proponente ed all’oblato la possibilità d’impedire la conclusione di un contratto che il
dichiarante non vuole più: ciò si ottiene con la revoca della proposta e rispettivamente
dell’accettazione.
Il potere di revoca può esercitarsi solo fino a che l’impegno contrattuale non sia nato, e cioè fino a che
il contratto non sia concluso: concluso il contratto, questo vincola le parti.
La libertà di revoca va contemperata con la tutela degli affidamenti che la dichiarazione revocata abbia
suscitato nel destinatario.
La legge non disciplina la forma della revoca.
La giurisprudenza dà per scontato che la revoca possa farsi informalmente anche se per le dichiarazioni
contrattuali è richiesta, o comunque s’è usata, una forma particolare.
La tesi è opinabile e va temperata alla stregua del principio di buona fede: dal quale discende l’obbligo
o l’onere, per la parte che revoca informalmente, di confermare subito la revoca con la stessa forma
usata per la dichiarazione revocata.
Per quanto riguarda la revoca dell’accettazione, L’accettazione può essere revocata, purché la revoca
giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione (1328.2).
La norma è conforme in primo luogo al principio che limita il potere di revoca al tempo in cui il
contratto non sia ancora concluso; ed in secondo luogo al principio di ricettizietà.
Più problematica è la regola sulla revoca della proposta: la proposta può essere revocata finché il
contratto non sia concluso (1328.1, prima parte).
Revocata efficacemente la proposta e così impedita la conclusione del contratto, se l’accettante ne ha
intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di aver notizia della revoca, il proponente è tenuto ad
indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto (1328.1, seconda
parte).
L’indennizzo a favore dell’accettante si giustifica con la protezione del suo ragionevole affidamento:
non è quindi dovuto, per mancanza di un tale affidamento, se egli sapeva della revoca, o comunque non
era in buona fede.
Può dubitarsi che sia in buona fede l’accettante il quale abbia elementi per sospettare l’intenzione del
proponente, o l’accettante il quale inizi ad eseguire un minuto dopo aver emesso l’accettazione, senza
neanche un minimo di intervallo che consolidi la prospettiva di conclusione del contratto.
L’obbligo di indennizzo a carico del revocante non discende da responsabilità precontrattuale, perché
egli non ha violato alcuna regola di correttezza: si usa dire che è responsabilità da atto lecito.
Mentre la revoca dell’accettazione è efficace purché giunga a conoscenza del proponente prima della
conclusione del contratto (1328.2), la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso
(1328.1).
Secondo questa lettura, per impedire il contratto è sufficiente che il proponente emetta la revoca prima
di ricevere l’accettazione.
In altre parole, la revoca della proposta è atto non ricettizio, e questa è la soluzione accolta dalla
giurisprudenza e dalla prevalente dottrina.
Ad essa si oppone parte della dottrina, la quale sostiene che anche la revoca della proposta va concepita
come atto ricettizio, che impedisce il contratto solo se giunge a conoscenza dell’accettante prima che
l’accettazione giunga al proponente.
Un argomento a sostegno del carattere ricettizio della revoca della proposta è che esso discende dal
1334; può replicarsi che lex specialis derogat generali: il principio della ricettizietà, affermato dal 1334
per la generalità degli atti unilaterali, può esser derogato dal 1328.1 per quel particolare atto unilaterale
che è la revoca della proposta.
Un argomento più di sostanza è l’esigenza di pari trattamento delle parti: che sarebbe garantita dalla
tesi della ricezione, mentre la tesi dell’emissione privilegerebbe in modo esagerato l’interesse del
proponente penalizzando ingiustamente l’accettante.
Può replicarsi che quanto alla revoca proponente ed accettante sono trattati sì in modo diverso, ma non
ingiustamente discriminatorio, perché la differenza di trattamento è giustificata dalla differenza di
posizioni.
La previsione dell’indennizzo è un ulteriore elemento a favore del carattere non ricettizio della revoca
della proposta, e cioè della sua efficacia già in base all’emissione.
Secondo il modello della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di mobili la revoca
sarebbe efficace solo se giunge all’oblato prima che l’accettazione sia emessa da lui.
Se così dovesse ricostruirsi la fattispecie della prima parte del 1328.1, la fattispecie della seconda parte
non si realizzerebbe mai.
Un altro argomento sostiene la tesi dell’emissione, contro quella della ricezione: è molto più razionale e
praticabile risolvere il dilemma revoca efficace/inefficace in base alla verifica di priorità cronologica
fra due eventi che maturano nella sfera dello stesso soggetto (emissione della revoca della proposta e
ricezione dell’accettazione); darebbe problemi più gravi affidarlo ad una verifica di priorità cronologica
fra due eventi che maturano nella sfera di soggetti diversi.
Per i contratti che si concludono, secondo lo schema particolare del 1327, con l’esecuzione dell’oblato,
la revoca delle relative proposte obbedisce al principio di ricezione.
La revoca impedisce il contratto dal momento in cui è emessa, ma solo se poi segua la ricezione: una
revoca emessa dal proponente ma per qualche ragione non mai giunta all’oblato non è efficace (ovvero,
la ricezione è condizione di efficacia della revoca, verificandosi la quale gli effetti retroagiscono al
momento dell’emissione).
La ricezione deve avvenire, a tutela del destinatario, in un tempo ragionevolmente breve, il che vincola
il revocante ad usare mezzi di trasmissione ragionevolmente veloci: il revocante che in mala fede od
anche solo per negligenza trasmettesse la revoca con mezzi lenti cadrebbe in illecito e risponderebbe
dei danni al di là dell’indennizzo ex 1328.1, seconda parte.
La revoca dell’offerta al pubblico è disciplinata dal 1336.2: la revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa
forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
Se l’onere di forma non viene osservato, l’efficacia della revoca dipende dalla conoscenza che ne
abbiano avuto i controinteressati (ovvero: la revoca non formale dell’offerta al pubblico si configura
come atto ricettizio).
A differenza di quanto previsto per la promessa al pubblico, che può esser revocata solo per giusta
causa (1990.1), la revoca dell’offerta al pubblico può anche essere immotivata.
Il proponente può obbligarsi a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, e cioè a non revocarla
(proposta irrevocabile, o “ferma”): in tal caso l’eventuale revoca è senza effetto (1329.1).
La legge parla di revocabilità sia della proposta sia dell’accettazione (1328): invece quando parla
d’irrevocabilità spezza la simmetria, riferendola solo alla proposta (1329) e non anche all’accettazione.
E una clausola d’irrevocabilità dell’accettazione, che fosse contenuta nella proposta, non avrebbe
valore giuridico: il proponente non può disporre del potere di revoca dell’oblato-accettante.
Si discute sulla natura giuridica della proposta irrevocabile: è un unico atto, o la somma di due atti
distinti (una proposta contrattuale, su cui s’innesta un negozio di rinuncia al potere di revoca)?
Si legge talora nelle sentenze che la volontà di rendere irrevocabile la proposta deve essere espressa.
Il solo fatto che la proposta indichi un termine per l’accettazione non basta di per sé a renderla
irrevocabile fino a quella data: questo avrà piuttosto il senso d’un termine ex 1326.2, diretto a limitare il
potere di accettazione dell’oblato.
Nel dubbio, il criterio del senso meno gravoso per l’obbligato (1371) farà preferire l’interpretazione
contraria all’irrevocabilità.
L’eventuale revoca, fatta prima che scada il termine dell’irrevocabilità, non ha effetto; dunque la
proposta non cade, e la successiva accettazione può concludere il contratto.
Di fronte alla violazione dell’obbligo di non revocare, si dispone così una sorta di riparazione in forma
specifica.
Un margine per revocare efficacemente una proposta irrevocabile esiste: bisogna che la revoca (emessa
dopo la proposta irrevocabile) pervenga all’oblato prima della proposta stessa.
Un’altra conseguenza dell’irrevocabilità è che la proposta sopravvive alla morte ed alla sopravvenuta
incapacità del proponente.
Il rifiuto della proposta irrevocabile certamente fa cadere l’irrevocabilità, e probabilmente la proposta
stessa; la giurisprudenza ricollega le stesse conseguenze all’accettazione difforme.
A tutela della libertà d’azione del proponente, il suo obbligo di non revocare non può essere perpetuo,
né a tempo indeterminato, ma vale solo per un certo tempo.
Una prima questione riguarda le conseguenze della mancata indicazione del termine; questo dovrebbe
essere fissato dallo stesso proponente, che accade se egli trascura di farlo?
Giurisprudenza e dottrina oscillano fra varie tesi.
Una tesi estrema è che, essendo il termine un elemento essenziale della proposta irrevocabile, la
mancanza d’esso travolge completamente la clausola d’irrevocabilità (donde l’ulteriore dilemma se la
proposta cada del tutto o sopravviva come proposta revocabile).
S’è proposto di recuperare il termine per via giudiziale, affidandone la determinazione al giudice in
base alla norma generale del 1183 (Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere
eseguita, il creditore può esigerla immediatamente [1175]. Qualora tuttavia, in virtù degli usi [1340] o
per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un
termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice [1331, 1482.2, 1771.2,
1810, 1817.1]. Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente
al giudice di stabilirlo secondo le circostanze [1817.2]; se è rimesso alla volontà del creditore, il
termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.) o a quella particolare del
1331.2 (sull’opzione: se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito
dal giudice).
L’obiezione immediata è che una sentenza definitiva sul punto potrebbe aversi solo in tempi
incompatibili con l’esigenza di definire la questione secondo ragionevole celerità.
Persuade di più la tesi che recupera il termine mediante il criterio del 1326.2 (ancorché riferito al
termine dell’accettazione): se la proposta irrevocabile non lo indica, il termine è quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell’affare (o secondo gli usi); e dovrà tenersi conto che qui la natura
dell’affare è definita anche dall’irrevocabilità della proposta.
Il termine dell’irrevocabilità solleva un altro problema: che situazione consegue alla scadenza di esso?
Due le alternative: o si considera che la proposta cada, o si ritiene ch’essa continui a vivere come
proposta revocabile.
La scelta deve ricavarsi dalla corretta interpretazione della volontà del dichiarante.
Nella previsione del 1329 l’irrevocabilità nasce da volontaria autoimposizione dello stesso proponente;
ma una proposta può essere irrevocabile a prescindere dalla volontà del suo autore.
In certi casi l’irrevocabilità è stabilita dalla legge: così per le proposte di contratto con obbligazioni del
solo proponente (1333), di assicurazione (1887), di donazione (782.4) e per le opa su azioni quotate.
Una dottrina ritiene irrevocabile la proposta di contratto definitivo attuativo di un preliminare, ma la
tesi è opinabile.
Alla proposta irrevocabile si lega strettamente la figura dell’opzione, che ricorre quando le parti
convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di
accettarla o meno: in tal caso la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile
(1331.1).
Opzione e proposta irrevocabile hanno in comune gli effetti che il 1329 (richiamato dal 1331) ricollega
alla proposta irrevocabile: la revoca fatta dal concedente è inefficace; l’opzione sopravvive alla sua
morte od incapacità sopravvenuta.
Si differenziano per la struttura: la proposta irrevocabile è atto unilaterale del proponente, invece
l’opzione è atto bilaterale delle parti che convengono, è già essa stessa contratto (preparatorio)
strumentale al contratto finale.
Questa schematica distinzione non pone problemi per i casi di opzione onerosa, crea invece difficoltà di
fronte all’ipotesi di opzione gratuita.
S’immagini che A offra a B un’opzione di acquisto senza chiedere corrispettivo; B tace; il contratto di
opzione dovrebbe ritenersi concluso per il mancato rifiuto dell’oblato di fronte a proposta di contratto
con obbligazioni del solo proponente (1333).
Una dottrina afferma che l’opzione gratuita non è opzione ex 1331, ma semplice proposta irrevocabile
ex 1329; l’opzione o è onerosa o non è.
Ma può essere opzione anche quella offerta in cui l’impegno a tenere ferma l’offerta non è direttamente
remunerato da uno specifico corrispettivo: come accade quando l’opzione è contenuta in una clausola
all’interno di un più complesso contesto contrattuale (ad es. il patto di riscatto nel leasing, il call ed il
put nella compravendita di azioni), od anche quando si presenta come negozio (apparentemente)
autonomo, ma in realtà collegato con altri negozi nel quadro di una più complessa operazione: in casi
del genere l’opzione non può dirsi gratuita, perché partecipa della causa (onerosa) della più complessa
operazione negoziale, di cui è elemento.
Nella proposta irrevocabile vi è solo la proposta di un contratto, e nient’altro; invece nell’opzione vi è
la proposta di un contratto, che ne è il contenuto tipico, ma c’è anche qualcos’altro, che possiamo
chiamare contenuto ulteriore: c’è una più ampia regolamentazione d’interessi delle parti, che ne esige
l’accordo.
E nulla vieta che questo accordo si formi, ricorrendo le condizioni del 1333, senza bisogno di
accettazione dell’opzionario.
Anche per l’opzione si prevede che l’impegno abbia un termine, come per la proposta irrevocabile; ma
a differenza di questa, la legge provvede espressamente per il caso di mancata indicazione degli
interessati: se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice
(1331.2).
L’iniziativa di adire il giudice spetta al concedente; la sua inerzia viene sanzionata duramente dalla
giurisprudenza, che in tal caso accorda all’opzionario l’intero termine della prescrizione decennale.
Il contratto (finale) cui l’opzione è strumentalmente preordinata si conclude se l’opzionario la esercita,
o meglio se indirizza a controparte la dichiarazione di esercitarla.
Come la proposta, l’opzione deve presentare il requisito della completezza, e deve rivestire la forma
eventualmente richiesta per il contratto finale; in tal caso, anche l’atto di esercizio dell’opzione richiede
la stessa forma.
Il contenuto ulteriore dell’opzione genera fra le parti crediti ed obbligazioni.
Con riguardo invece al contenuto tipico, la posizione dell’opzionario è di diritto potestativo: il suo
intento di concludere il contratto può realizzarsi a prescindere dalla volontà dell’altra parte.
Si ammette generalmente che un’accettazione difforme non faccia cadere l’opzione, ma lasci aperta
all’opzionario la possibilità di concludere poi il contratto con un’accettazione conforme.
La posizione del concedente implica a suo carico l’obbligo di non ledere l’interesse, anzi il diritto,
dell’opzionario alla conclusione del contratto finale: come accadrebbe se prima della scadenza
dell’opzione di acquisto la cosa che ne forma oggetto fosse da lui distrutta od alienata a terzi (l’opzione
immobiliare non è trascrivibile).
Gli interpreti divergono quanto a natura e conseguenze dell’illecito.
Un indirizzo lo qualifica precontrattuale e limita il risarcimento all’interesse negativo, argomentando
che il contratto finale non è ancora concluso.
Ma esso trascura che è certamente concluso il patto di opzione.
La tesi trova indiretto sostegno nella norma sulla finzione di avveramento della condizione (1359): il
contraente deluso dal mancato avveramento della condizione, imputabile a controparte, ha diritto non al
mero risarcimento, ma a godere della pienezza degli effetti contrattuali.
A sua volta l’opzionario è tenuto, in relazione alla formazione del contratto finale, a comportarsi
secondo buona fede (1337).
L’opzione (il diritto dell’opzionario) è cedibile solo se vi è il consenso del concedente.
Il consenso può essere espresso, come quando la cedibilità è prevista nello stesso patto di opzione, ma
può anche risultare per implicito.
Quanto alla trasmissibilità mortis causa, essa è pacifica per la posizione passiva, cioè del concedente,
ma non v’è ragione di negarla anche dal lato attivo, in favore dell’erede dell’opzionario: salvo che il
contratto finale riguardi prestazioni infungibili.
L’opzione richiede la stessa forma prevista per il contratto finale.
Un meccanismo analogo all’opzione di tipo call opera a favore del venditore nella vendita con patto di
riscatto (1500), ed a favore del compratore nella vendita con riserva di gradimento (1520); un’opzione
di acquisto è legalmente prevista a favore degli azionisti per le azioni di nuova emissione in sede di
aumenti di capitale (2441).
Con la prelazione, la parte che la dà (concedente) si obbliga verso la parte che la riceve (prelazionario)
a preferirla, a parità di condizioni, come partner di un dato contratto, se il concedente deciderà di
concluderlo.
L’opzionario ha nelle sue mani la conclusione del contratto, invece la prelazione non dà al
prelazionario il potere di decidere e determinare la conclusione del contratto; la decisione sul contratto
è del concedente.
È quindi meno vincolata l’azione del concedente rispetto al bene: egli ben potrà distruggerlo, o
trasformarlo e poi cedere a terzi i beni derivati dalla trasformazione.
Quando la prelazione è data a titolo gratuito, il patto si conclude col mancato rifiuto del prelazionario di
fronte alla proposta del concedente (1333).
Si discute se il patto di prelazione abbia forma libera, o richieda la stessa forma del contratto finale; è
preferibile la tesi della libertà di forma: sostenuta fra l’altro dal rilievo che può essere informale il
contratto (come la locazione immobiliare non abitativa) che genera una prelazione munita addirittura di
efficacia reale.
Si discute sulla cedibilità della prelazione, e più in generale sulla sua trasmissibilità dal lato sia attivo
sia passivo, tra vivi ed a causa di morte.
Può richiamarsi quanto osservato circa l’analogo problema che si pone per l’opzione.
Il patto di prelazione esige un termine, scaduto il quale l’obbligo del concedente cade ed egli riacquista
la sua libertà negoziale.
Lo si ricava dal fatto che un termine imperativo (5 anni) è imposto dalla legge alla prelazione pattuita
nell’ambito del contratto di somministrazione (1566), e soprattutto dal principio che esclude la
perpetuità dei vincoli obbligatori, espresso dalla norma (1379) che vuole i divieti convenzionali di
alienazione circoscritti entro convenienti limiti di tempo.
La mancata indicazione del termine non rende necessariamente nullo il patto, che può esser salvato per
via d’integrazione giudiziale.
Sembra invece da escludere (anche se qualcuno la sostiene) la possibilità di riduzione giudiziale del
termine apposto dalle parti.
L’obbligo del concedente è preferire il prelazionario (a parità di condizioni), se decide di fare il
contratto; si chiama denuntiatio la dichiarazione con cui il concedente comunica al prelazionario
l’intento di contrarre, per consentirgli di esercitare la prelazione.
Il problema più discusso è se la denuntiatio abbia valore di proposta.
Se il concedente riceve da un terzo una proposta completa, e la comunica al prelazionario, non è detto
che solo per questo egli si trasformi automaticamente da oblato (rispetto al terzo) in proponente
(rispetto al prelazionario); dipende dal ricostruibile intento che accompagna la comunicazione.
Un obbligo di proposta, o di denuntiatio con valore di proposta, sorge a carico del concedente solo
quando egli sia determinato a concludere il contratto a certe condizioni, offerte o condivise da un terzo.
Non viola l’obbligo il concedente che indirizzi la stessa proposta parallelamente al prelazionario ed al
terzo, precisando a quest’ultimo che la proposta nei suoi confronti è condizionata alla mancata
accettazione della stessa da parte del prelazionario; né il concedente che concluda con un terzo il
preliminare del contratto oggetto di prelazione, subordinandolo alla condizione che il prelazionario non
eserciti la prelazione.
Se nessun contratto con terzi viene fatto, il rifiuto del prelazionario non dissolve la prelazione, che
sopravvive: il concedente non può successivamente contrarre con terzi a condizioni meno gravose di
quelle prospettate a suo tempo al prelazionario, se prima non rivolge a quest’ultimo denuntiatio delle
nuove condizioni.
La prelazione può peraltro estinguersi se il rifiuto del prelazionario abbia il chiaro senso di una rinuncia
alla prelazione, possibile ex 1236.
Contro la violazione del diritto del prelazionario, la tutela di quest’ultimo è tutela obbligatoria e non
reale: la posizione contrattuale del terzo resta in linea di principio intangibile; il prelazionario ha solo
diritto ad ottenere dal concedente il risarcimento del danno.
Il principio conosce un’eccezione, che risulta da costante giurisprudenza.
La vendita di azioni a terzi, in spregio alla prelazione spettante per statuto agli altri soci, non è efficace
(per alcune pronunce è addirittura nulla), ed i soci pretermessi hanno il diritto di riscattare le azioni.
Quanto detto fin qui è riferito alle prelazioni volontarie.
La tutela reale del prelazionario è invece la regola nelle prelazioni legali: quelle che nascono ex lege in
favore di determinati soggetti.
Hanno fra l’altro prelazione legale di acquisto: i collaboratori dell’impresa familiare sulla relativa
azienda (230-bis comma 5), i coeredi sulle quote degli altri coeredi (732), lo Stato sui beni d’interesse
storico od artistico (59 ss. tubca), l’affittuario coltivatore diretto sul fondo (l. 590/1965), il conduttore
sull’immobile urbano destinato ad uso non abitativo (l. 392/1978).
“Prenotazione” è termine generico ed atecnico, che indica varie figure d’impegni relativi alla
conclusione di un futuro contratto, variamente graduati per ampiezza ed intensità.
Esse riguardano contratti per l’acquisto di beni o servizi di massa offerti da operatori professionali,
caratterizzati per un verso dalla normale contestualità fra conclusione del contratto e sua esecuzione, e
per altro verso dalla possibile limitatezza dell’offerta dei beni o servizi in questione.
L’accettazione della prenotazione non è ancora la conclusione del contratto, e tuttavia essa impegna il
fornitore.
Meno definita, e più variabile in relazione al tipo di rapporto ed alle circostanze, la posizione del
prenotante.
Sovente può essere di assoluta libertà nel revocare (“disdire”) la prenotazione, altre volte anche il
prenotante è in qualche misura vincolato, ed il tipico segno del vincolo a suo carico è il pagamento
anticipato, richiestogli all’atto della prenotazione, di parte del prezzo: somma che il fornitore tratterrà
in caso di disdetta, o di disdetta non comunicata entro un certo termine.
In relazione al modo in cui si configurano gli impegni delle parti, muta l’inquadramento della
fattispecie nelle diverse possibili figure: proposta irrevocabile; opzione; contratto preliminare
unilaterale o bilaterale, con o senza diritto di recesso.
Un caso significativo d’inadempimento dell’impegno che il fornitore assume accettando la
prenotazione è il c.d. overbooking, cioè la pratica delle compagnie aeree di accettare, per un certo volo,
prenotazioni in numero superiore alla disponibilità di posti, nella congettura che qualcuno dei
prenotanti disdirà.
Alle modalità della formazione del contratto danno rilevanza anche norme diverse dalle norme sulla
conclusione del contratto.
Se nel corso della formazione del contratto una parte si comporta scorrettamente a danno dell’altra,
incorre in responsabilità precontrattuale.
Se alla conclusione del contratto si giunge perché una parte aderisce al testo contrattuale
unilateralmente predisposto dall’altra per regolare in modo uniforme una pluralità di rapporti
omogenei, s’applica la disciplina dei contratti standard, o condizioni generali di contratto.
Se vi si giunge perché una parte è incorsa in errori od ha subito inganni o minacce, s’applica la
disciplina dei vizi della volontà.
Se vi si giunge perché una parte ha subito la pressione di uno stato di pericolo o di bisogno, s’applica la
disciplina della rescissione.
Se alla conclusione del contratto fra un operatore economico ed un consumatore si giunge senza che le
clausole predisposte dal primo abbiano formato oggetto di trattativa, s’applica la disciplina delle
clausole vessatorie.
Se vi si giunge perché il consumatore è stato sollecitato al contratto in un luogo diverso dai locali
commerciali di pertinenza dell’operatore, o con tecniche di comunicazione a distanza, s’applicano
speciali discipline.
Se al contratto fra un imprenditore dominante ed un imprenditore dipendente si giunge perché il primo
sfrutta la propria superiorità economica, si applica la disciplina dell’abuso di dipendenza economica.
CAPITOLO VIII – TRATTATIVE E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
Comportamenti collegati alla formazione di un contratto possono fare danni e creare responsabilità
verso il danneggiato: questa responsabilità si definisce “precontrattuale”.
Il 1337 prescrive un obbligo di comportamento: le parti, nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
La buona fede è intesa qui in senso oggettivo, come regola di condotta: dunque come sinonimo di
correttezza.
Il dovere di correttezza impone di evitare durante la trattativa comportamenti che implichino intenzione
o consapevolezza d’infliggere a controparte danni ingiusti, ma impone anche di evitare comportamenti,
fonti di danno ingiusto, che prescindano da intenzione e consapevolezza e si riconducano piuttosto a
superficialità, disattenzione, incompetenza.
La violazione della buona fede (oggettiva) non è esclusa dallo stato di buona fede (soggettiva) in cui
versi l’agente.
Importante è che la scorrettezza, ancorché temporalmente preceda la trattativa, sia funzionalmente
mirata a questa ed al relativo contratto.
Il contenuto del dovere di buona fede può precisarsi tramite un doppio riferimento: al tipo di situazioni
dannose che quel dovere intende prevenire, ed al tipo di comportamenti che possono essere strumentali
alla prevenzione di quei danni.
Sotto il secondo profilo, il dovere di buona fede si scompone in una serie di doveri di condotta, la cui
violazione può generare responsabilità precontrattuale.
Vengono in gioco prima di tutto doveri d’informazione.
La parte che conosce (o dovrebbe conoscere) dati rilevanti per la valutazione del contratto dal punto di
vista di controparte, e sa (o dovrebbe sapere) che questa invece li ignora, ha il dovere d’informarne
controparte.
Però non ogni reticenza fra le parti è illecita.
È diffusa l’idea che il dovere riguardi solo gli elementi capaci d’incidere sulla validità o sull’efficacia
del contratto.
Un criterio del genere è troppo rigido, e nella sua rigidità rischia di lasciare impunite condotte
censurabili.
È meglio non irrigidire la selezione fra reticenze lecite ed illecite nel criterio dell’invalidità (od
inefficacia) del contratto, ma lasciarlo affidato alla duttilità del principio di buona fede, da calibrare
sulle particolarità del singolo caso.
Così, la responsabilità per omessa informazione può essere attenuata od esclusa quando l’ignoranza
della parte inconsapevole è ignoranza colposa, perché essa avrebbe dovuto sapere od attivarsi per
sapere.
Può aggravarsi quando la reticenza segue ad una esplicita richiesta di informazioni.
Può inoltre aggravarsi quando la parte reticente sia un operatore professionale, e la reticenza riguardi
elementi della sua professionalità, rilevanti per il contratto: di questo criterio la giurisprudenza fa
volentieri applicazione per affermare la responsabilità della banca verso i clienti.
In certi casi, doveri d’informazione precontrattuale a carico di operatori professionali sono codificati
per legge, in nome del principio di trasparenza.
Tour operators ed agenzie di viaggi intenzionati a vendere pacchetti turistici devono fornire al cliente
svariate informazioni nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto; chi
offre in vendita multiproprietà deve fornire ai potenziali acquirenti un complesso documento
informativo, ed a carico dei commercianti è stato generalizzato l’obbligo d’indicare con chiarezza i
prezzi dei beni offerti, al fine di migliorare l’informazione del consumatore.
Se può esserci un dovere precontrattuale d’informare, c’è a maggior ragione un dovere d’informare
secondo verità: la sua violazione dà luogo a responsabilità per false informazioni.
In essa incorre anche chi dice il falso dando spontaneamente informazioni che non sarebbe tenuto a
dare.
Emerge talora un dovere di chiarezza; esso è imposto di regola alla parte più forte, che predispone
unilateralmente il testo contrattuale.
Ma solo in casi residuali la violazione di questo dovere darà luogo a responsabilità precontrattuale:
scattano per lo più rimedi contrattuali, come l’interpretazione della clausola oscura in senso contrario al
predisponente (1371), o la possibilità di dichiararne la vessatorietà.
Si dice che al dovere precontrattuale di trasparenza possa affiancarsi un dovere di segreto: non
divulgare notizie riservate su controparte, apprese in occasione della trattativa.
Il dovere c’è, ma la sua violazione non dà luogo a responsabilità precontrattuale.
O il riserbo è materia di un’obbligazione specificamente assunta (come nei secrecy agreements delle
lettere d’intenti), ed allora la sua violazione genera responsabilità contrattuale, oppure no: ma in tal
caso la sua violazione è una scorrettezza che non è finalizzata alla trattativa, e siccome la responsabilità
precontrattuale colpisce specificamente le scorrettezze che portano al responsabile ingiusti vantaggi ed
alla vittima danni ingiusti rispetto alla trattativa, questa non è responsabilità precontrattuale, ma
extracontrattuale ex 2043.
Un discorso analogo può farsi per un altro dovere talora evocato fra i doveri precontrattuali: il dovere di
custodia delle cose che una parte riceve dall’altra nell’ambito della trattativa.
Se il detentore sarà responsabile per la perdita od il deterioramento della cosa, lo sarà quasi sempre ex
1218 o 2043, e non ex 1337.
Il dovere di buona fede ex 1337 vuole prevenire tre tipi di situazioni dannose, suscettibili di verificarsi
quando il dovere sia violato: la mancata conclusione del contratto, la conclusione d’un contratto
invalido, la conclusione d’un contratto valido, ma pregiudizievole per la vittima della scorrettezza.
La rottura della trattativa costituisce illecita violazione d’un dovere precontrattuale di buona fede solo
nel concorso di due condizioni.
La prima condizione è che la rottura cada dopo che si sia consolidato il giustificato affidamento di
controparte nella conclusione del contratto.
Nel caso di revoca della proposta che impedisce la conclusione di un contratto di cui l’oblato accettante
aveva addirittura già avviato l’esecuzione, si qualifica la condotta del revocante non come illecita e
fonte di risarcimento, ma come presupposto per un semplice indennizzo, conseguente ad un atto lecito
ancorché dannoso.
La seconda condizione è che la rottura della trattativa sia ingiustificata, ovvero, come dice la
giurisprudenza, priva di “giusta causa”; la giurisprudenza identifica la giusta causa della rottura con una
circostanza esterna alla sfera del recedente, sopravvenuta nel corso della trattativa oppure preesistente
ma da lui ignorata senza colpa, idonea a modificare la valutazione di convenienza del contratto.
Il carattere ingiustificato della rottura non richiede il dolo o la mala fede soggettiva del recedente; la
responsabilità può discendere dalla semplice colpa del recedente.
È ragionevole addossare alla vittima la sola prova del proprio affidamento, ed a controparte la prova
(liberatoria) della giusta causa del proprio ritiro.
Un altro comportamento può determinare responsabilità per mancata conclusione del contratto: dare
causa, per qualche fatto a sé imputabile, al giustificato recesso di controparte.
La seconda situazione di danno precontrattuale è quella in cui il contratto si conclude, ma inutilmente
perché invalido od inefficace; la fattispecie è regolata dal 1338: la parte che, conoscendo o dovendo
conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto [1418 ss.], non ne ha dato notizia all’altra
parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella
validità del contratto.
L’area del dovere d’informazione precontrattuale non coincide con quella del 1338; per un verso è più
ampia, perché il dovere può riguardare anche elementi che non incidono sulla validità (od efficacia) del
contratto; per altro verso, ricadono sotto il 1338 anche illeciti non riducibili ad omessa informazione
sulla causa d’invalidità, ma consistenti nell’aver direttamente realizzato tale causa.
La responsabilità ex 1338 si riferisce, oltre che al contratto invalido, anche al contratto inefficace: la
troviamo infatti trasposta nel 1398, con riguardo alla conclusione di un contratto che, per essere
concluso con un falso rappresentante, è affetto non da invalidità ma da inefficacia.
Con riferimento alla fattispecie del contratto concluso ma inefficace, s’indica fra i doveri
precontrattuali anche quello di attivarsi per creare (o almeno non distruggere) le condizioni di efficacia
del contratto.
La terza situazione di danno precontrattuale è quella in cui la scorrettezza di una parte porta a
concludere un contratto valido ed efficace, ma sconveniente per l’altra parte; così, nel caso d’inganno
non abbastanza grave da portare all’annullamento (dolo incidente), il contratto rimane valido e la
vittima ha diritto al risarcimento; così pure nel caso di omessa o falsa informazione che dia luogo ad
errore non essenziale e quindi non renda il contratto annullabile.
Si discute sulla natura della responsabilità precontrattuale rispetto ai due fondamentali generi di
responsabilità: contrattuale (1218) ed extracontrattuale (2043); la giurisprudenza sposa la seconda tesi.
È vero, come sottolineano i fautori della tesi contrattuale, che fra i protagonisti della trattativa si crea
una relazione qualificata, in ragione della quale gravano su essi speciali doveri a protezione dei
reciproci interessi, ma questo accade in tanti altri contesti di attività e rapporti che nessuno oserebbe
riferire ad un campo diverso da quello della responsabilità ex 2043: esiste una relazione qualificata, per
esempio, fra i protagonisti della circolazione stradale.
L’obbligazione e la responsabilità contrattuale proteggono quello specifico interesse del creditore che è
l’interesse alla prestazione (1174); diversi sono gli interessi della vita di relazione messi a rischio nel
contratto sociale: per esempio la sicurezza della circolazione automobilistica: a protezione di essi
s’impongono doveri di condotta che possono essere non generici, ma non per questo diventano
obbligazioni.
E la loro violazione genera responsabilità extracontrattuale.
Vi è frequente commistione/indistinzione dei due tipi di responsabilità, che tende a sovrapporre od
avvicinare i rispettivi regimi; ciò si manifesta soprattutto per i profili sostanziali della disciplina:
rilevanza della colpa e sua gradazione, contenuto della prova liberatoria (ma anche distribuzione
dell’onere della prova).
La distinzione conserva peso per i profili strumentali: prescrizione, e spazi d’iniziativa nel processo;
sotto questi profili, la riconduzione della responsabilità precontrattuale al genere extracontrattuale
anziché contrattuale non è ininfluente.
Quanto alla prescrizione, ne fissa il termine in 5 anni (2947.1) e non in 10.
E sul piano processuale condiziona le possibilità di mutatio libelli e di domanda nuova in appello: una
pretesa risarcitoria titolata ex 1337 può successivamente titolarsi ex 2043, e viceversa; non è invece
ammissibile il passaggio dal titolo precontrattuale a quello contrattuale, e viceversa.
Il danno precontrattuale può derivare anche dal concorso della scorrettezza di una parte con l’illecito di
un terzo: rispondono entrambi, la parte ex 1337 ed il terzo ex 2043.
L’illecito può essere del solo terzo: sorge allora la sola responsabilità (a seconda dei casi,
extracontrattuale o contrattuale) del terzo.
Nella responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile copre il c.d. interesse negativo, chiamato così
perché lo s’identifica con l’interesse a non intraprendere una trattativa come quella che ha esposto il
soggetto a subire le scorrettezze di controparte, e siccome intraprendere quella trattativa ha gravato il
soggetto di spese inutili e gli ha fatto perdere altre occasioni d’affari, queste sono le voci principali che
lo compongono.
Lo si distingue dall’interesse positivo, che è interesse all’esecuzione del contratto validamente
concluso, ed all’acquisizione dei relativi profitti.
Al contrario l’interesse negativo non comprende la perdita dei profitti (lucro cessante) che il contratto
avrebbe dato se la trattativa non fosse stata turbata dalle scorrettezze.
Quando il danno deriva dalla mancata conclusione del contratto con la scorretta controparte, non vanno
risarciti i profitti che quel contratto avrebbe dato, perché quel contratto non è stato concluso, ma le
spese fatte per una trattativa rivelatasi inutile, il tempo sprecato, la perdita di occasioni alternative
d’affari.
Tutto questo va provato dall’attore in responsabilità; ma se l’attore prova di aver trascurato una
specifica occasione alternativa, e che questa avrebbe portato al contratto, e che questo avrebbe dato
certi profitti, non si vede perché dovrebbero essergli negati, a titolo di risarcimento, i profitti del
contratto perduto.
Tali profitti potranno essere inferiori a quelli del contratto abortito per la scorrettezza precontrattuale,
ma potranno anche pareggiarli (potrebbero anche essere superiori, ma in tal caso è ragionevole che
l’eccedenza non venga riconosciuta, per il principio che impedisce di collocare il danneggiato in una
posizione migliore di quella in cui si sarebbe trovato senza l’illecito).
Quando il danno deriva dalla conclusione di un contratto invalido od inefficace, vale tendenzialmente
lo stesso ragionamento (ma alle spese della trattativa inutile si aggiungeranno le spese inutilmente
sostenute in vista dell’esecuzione).
Quando il danno deriva dalla conclusione di un contratto valido ed efficace, ma sconveniente, il
risarcimento copre l’intero scarto di convenienza.
Anche per il quantum del risarcimento (oltre che per l’an della responsabilità) possono rilevare gli stati
soggettivi delle parti.
Un affidamento non del tutto esente da colpa può non privare del diritto al risarcimento, ma ridurne
l’entità ex 1227.1 (Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate).
CAPITOLO IX – LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ CONTRATTUALE
La volontà non è idonea a formare l’accordo contrattuale finché resta chiusa nel foro interno del
volente, per produrre la fattispecie-contratto essa dev’essere manifestata.
La manifestazione di volontà contrattuale è il complesso dei segni che rendono socialmente conoscibile
la volontà di concludere il contratto.
La manifestazione di volontà contrattuale può essere di due tipi: espressa o tacita; è manifestazione
espressa quella realizzata col mezzo del linguaggio, è manifestazione tacita (o comportamento
concludente) quella realizzata con segni non linguistici.
La manifestazione espressa si definisce abitualmente: dichiarazione.
Le dichiarazioni contrattuali sono le manifestazioni di volontà contrattuale per antonomasia.
Il linguaggio usato per la dichiarazione contrattuale è normalmente il linguaggio verbale: un sistema di
parole (espresse in fonemi o grafemi, a seconda che il linguaggio sia orale o scritto), coordinate fra loro
secondo appropriate connessioni sintattiche.
Ma possono esistere altri linguaggi, come il linguaggio gestuale (quello per cui un cenno del capo può
equivalere alla parola “sì”), od il linguaggio informatico: ciò che conta è che i segni (pur non verbali)
siano intenzionalmente usati per manifestare la volontà.
La legge può richiedere che per la conclusione di determinati contratti la volontà contrattuale sia
manifestata espressamente: ad es. la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa (1937).
Acquisito che una manifestazione di volontà per fatti concludenti non può dar luogo a fideiussione, gli
interpreti ammettono tuttavia che possa costituire un diverso impegno contrattuale di garanzia.
Il testo contrattuale è l’insieme delle parole che formano oggetto o materia della dichiarazione
contrattuale.
Si è portati a sovrapporre dichiarazione contrattuale e testo contrattuale, e a dire che il contratto risulta
da due dichiarazioni contrattuali aventi come oggetto il medesimo testo.
La dichiarazione esprime la soggettività della parte: in questo senso, è realistico dire che le parti del
contratto di compravendita non vogliono la stessa cosa: il compratore vuole comprare, al minor prezzo
possibile e avendo le maggiori garanzie possibili; il venditore vuole vendere, al maggior prezzo
possibile e dando le minori garanzie possibili.
Nel momento in cui le dichiarazioni delle parti concludono il contratto, questa loro dimensione
soggettiva si stempera nell’oggettività del testo contrattuale e del regolamento contrattuale che ne
risulta.
L’interpretazione del contratto è in realtà problema del testo contrattuale, poiché riguarda la comune
intenzione delle parti (1362.1); il problema dell’errore nel contratto è problema della dichiarazione
contrattuale, perché tocca il consenso del singolo contraente che ne è stato vittima (1427).
Non esiste un solo linguaggio verbale, ne esistono tanti diversi: le tante diverse lingue nazionali.
Vale in primo luogo il principio della libertà di lingua: salvo eccezioni tassativamente indicate,
l’ordinamento italiano non impone l’uso della lingua italiana per formulare dichiarazioni e testi
contrattuali.
La legge prevede qualche eccezione: ciò vale per i contratti stipulati per atto di notaio, che possono
farsi in lingua straniera solo se le parti dichiarano d’ignorare la lingua italiana, e vale per la vendita di
multiproprietà: sia il contratto sia il documento informativo che lo precede devono essere in italiano, e
se il compratore è cittadino o residente di un Paese dell’Unione europea, vanno tradotti nella lingua di
quel Paese.
Le parti possono stabilire una convenzionale lingua del contratto, il cui senso è questo: le dichiarazioni
contrattuali vanno espresse in quella lingua, chi le esprime in una lingua diversa non può contare sulla
loro efficacia.
Quando non vi sia una lingua convenzionale del contratto, chi rivolge a controparte dichiarazioni
contrattuali in lingua diversa da quella del destinatario, ed a lui ignota, non può contare sull’efficacia
della propria dichiarazione, che il destinatario non è in grado d’intendere.
Una soluzione diversa può giustificarsi in casi particolari: se l’accettazione consiste in una semplice
parola affermativa, di cui è lecito ritenere che chiunque conosca il senso (O.K.; yes; ja; oui, d’accord);
se A poteva aspettarsi che B rispondesse in altra lingua e la risposta di B era traducibile con uno sforzo
ed un costo minimi; se lo stesso A aveva indotto in B la falsa sensazione di conoscere la lingua in cui B
gli si rivolge.
Se l’uso di una lingua straniera ingenera un clamoroso equivoco fra i contraenti, che pur pensando di
essere d’accordo in realtà non lo sono, il contratto potrà impugnarsi per dissenso.
Se il risultato è che un contraente si forma una falsa rappresentazione dell’oggetto del contratto o di sue
qualità, il contratto potrà impugnarsi per errore.
Se si genera dubbio circa il significato d’una parola o di un’espressione del testo contrattuale, si
applicano le regole legali sull’interpretazione od i criteri convenzionali, se previsti: come la c.d.
controlling language clause, per cui se un testo contrattuale è bilingue, si stabilisce che laddove la
duplicità linguistica crei una duplicità di possibili significati, l’ambiguità si scioglie dando la
prevalenza per es. al testo italiano.
Art. 1327: l’oblato che senza rispondere alla proposta silenziosamente inizia l’esecuzione, con ciò
conclude il contratto, perché pur tacendo rende socialmente conoscibile la propria volontà di accettare
la proposta.
Questo non significa che il silenzio della parte equivalga sempre al suo accordo, né che la sua idoneità
a manifestare l’accordo costituisca la regola.
È vero il contrario: la regola è che il silenzio non vale a manifestare l’accordo di chi lo serba.
Il silenzio vale accordo quando è silenzio circostanziato, o qualificato da circostanze che abbiano l’una
o l’altra di due caratteristiche: o la caratteristica di essere, sul piano empirico, segni della volontà di
accordo, o la caratteristica di generare a carico del soggetto che voglia sfuggire al vincolo contrattuale
un dovere di parlare.
Il meccanismo per cui il silenzio vale accordo suole definirsi “silenzio-assenso”; esso trova importanti
applicazioni nel diritto amministrativo: dove, se il privato richiede ad es. un’autorizzazione alla
pubblica amministrazione e questa non risponde entro un certo termine, scaduto questo l’autorizzazione
può ritenersi accordata.
Le fattispecie in cui, pur nel silenzio della parte, può desumersi il suo accordo, s’identificano con i
comportamenti concludenti.
In molti casi, i comportamenti concludenti sono comportamenti di attuazione del contratto: si parla di
negozi di attuazione, proprio ad indicare quei negozi (in particolare contratti), in cui la volontà di
contrarre è manifestata mediante condotte relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La condotta attuativa può riguardare la prestazione che il contratto impone al soggetto: è il caso
dell’inizio di esecuzione da parte dell’oblato ex 1327, è il caso (ancorché l’atto sia unilaterale e non
contrattuale) della c.d. convalida tacita, che si forma con la volontaria esecuzione del contratto
annullabile.
La condotta concludente di genere attuativo può riguardare anche la prestazione di controparte,
consistendo nel fatto del soggetto che se ne appropria.
I c.d. contratti per automatico si concludono inserendo denaro in una macchina che eroga in cambio il
prodotto od il documento di legittimazione al servizio.
Per avere valore di accordo, il comportamento concludente dev’essere ragionevolmente inequivoco: si
tratterà di quaestio facti, dipendente dalle mille variabili del contesto.
Fuori del campo contrattuale, la manifestazione di volontà per comportamento concludente si ritrova
nelle fattispecie di accettazione tacita dell’eredità: quando il chiamato compie un atto che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di
erede (476), come ad es. un atto di disposizione di diritti ereditari (477).
Il silenzio è circostanziato quando il contesto delle circostanze in cui si inscrive è tale da generare a
carico del soggetto un dovere (o meglio, onere) di parlare in merito al contratto, del quale il silenzio
costituisce violazione.
Sono circostanze nelle quali il silenzio della parte può creare in controparte ragionevoli affidamenti
sull’esistenza dell’accordo, e quindi sulla conclusione del contratto.
In qualche caso, la qualificazione è operata direttamente dalla legge: tipico esempio il 1333, che
impone al destinatario di proposta di contratto unilaterale l’onere di rifiutarla, ed in mancanza (nel
silenzio dell’oblato) considera che il contratto sia concluso.
La qualificazione del silenzio non deriva da una regola legale che riflette un dato di ragionevolezza e
tipicità sociale: la circostanza che il contratto non preveda obblighi a carico dell’oblato, ma solo diritti a
suo favore, rende probabile il suo accordo.
Troviamo un altro caso in materia di donazione di organi post mortem, dove la mancata dichiarazione
di volontà è considerata quale assenso alla donazione.
In altro campo, vi è un caso in cui il silenzio e l’inerzia determinano effetti legali che il soggetto
potrebbe evitare: non però limitandosi a parlare, ma compiendo una specifica attività.
È il caso dell’accettazione dell’eredità, come conseguenza legale del fatto che il chiamato in possesso
dei beni ereditari non compia l’inventario entro 3 mesi (485.2).
Qui più che di silenzio-assenso dovrebbe parlarsi di inerzia-assenso.
In casi più numerosi, la qualificazione del silenzio come silenzio circostanziato discende non da una
norma ad hoc, ma dal principio di buona fede: alla luce del quale determinate circostanze impongono
alla parte coinvolta nella possibile formazione del contratto un dovere di parlare, se non vuole che il
suo silenzio sia percepito e valga quale accordo capace di concludere il contratto.
Situazioni del genere possono verificarsi soprattutto in presenza di due fattori: il primo fattore è la
preesistenza di un rapporto contrattuale, nel cui contesto venga ad inserirsi l’eventuale nuovo contratto
fra le medesime parti; il secondo fattore riguarda lo scopo e gli effetti del nuovo contratto, che per lo
più tende ad incidere su un precedente rapporto contrattuale (modificandolo o sciogliendolo).
Le situazioni riguardano per lo più contratti modificativi e contratti risolutori.
Una questione riguarda l’efficacia della protestatio, ovvero della dichiarazione con cui il soggetto
smentisce un proprio comportamento concludente (o che potrebbe essere percepito come tale); il
problema è: ha la protestatio la forza di privare il comportamento concludente del suo tipico valore, e
quindi d’impedire la conclusione di un contratto che, senza essa, potrebbe concludersi per
manifestazione tacita di volontà?
Il problema non si pone per il silenzio non qualificato da comportamenti attivi del soggetto: infatti un
tale silenzio può valere accordo nella sola misura in cui sia violazione di un dovere di parlare.
Conviene distinguere fra i diversi tipi di comportamento: per i comportamenti attuativi che consistono
nell’appropriarsi della prestazione altrui, la protestatio contraria non ha la forza di neutralizzarne il
valore concludente: una protestatio siffatta equivarrebbe ad un intollerabile venire contra factum
proprium.
La protestatio può riprendere vigore di fronte a comportamenti non attuativi, od attuativi per
esecuzione di un’attività corrispondente alla propria prestazione.
La protestatio può altresì neutralizzare manifestazioni di volontà che non sono comportamenti
concludenti, ma dichiarazioni.
È il problema della dichiarazione contrattuale, che smentisce altra dichiarazione contrattuale dello
stesso soggetto (fuori dell’ipotesi di simulazione); in generale la dichiarazione contraria od
incompatibile può togliere valore ad un’altra dichiarazione: se l’oblato dichiara di accettare
integralmente la proposta, ma dichiara anche di volere alcune modifiche, potrà risultare che questa in
realtà è un’accettazione non conforme bensì difforme.
Anche qui la protestatio funziona, perché la manifestazione di volontà cui toglie effetto non realizza
un’intrusione nella sfera del destinatario.
In linea di principio valgono anche per la manifestazione tacita di volontà i requisiti dell’emissione e
dell’indirizzamento volontari, e della ricezione da parte del destinatario.
Inoltre non va escluso che, come può tacitamente manifestarsi la volontà di fare il contratto, così possa
tacitamente manifestarsi la volontà contraria: ad es., la volontà di revocare la proposta o l’accettazione
già emesse.
La conclusione di contratti per via informatica o telematica è la base giuridica di un fenomeno
economico in velocissima espansione: il c.d. commercio elettronico (e-commerce), nella doppia
variante di commercio fra operatori economici (business-to-business) e di commercio fra operatori
economici e consumatori (business-to-consumer).
Quanto alla conclusione del contratto, il documento informatico trasmesso per via telematica s’intende
inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questo dichiarato.
Quando le parti siano un operatore economico ed un consumatore, vige la disciplina dei contratti
negoziati fuori dei locali commerciali e dei contratti a distanza.
Pone alcuni problemi la dichiarazione sotto falso nome: A si rivolge a B identificandosi falsamente
come X; la fattispecie può ulteriormente articolarsi, a seconda che X sia una semplice identità di
fantasia, non corrispondente ad un particolare soggetto del quale A voglia usurpare l’identità, ovvero
sia l’identità di un determinato soggetto, che A vuole usurpare (usurpazione dell’identità altrui).
Altro caso patologico è la falsa identificazione del destinatario della propria dichiarazione: A si rivolge
a B, identificandolo falsamente con Y, che è il diverso soggetto con cui egli intende contrattare.
Codesti problemi possono ricevere soluzione alla luce di vari principi e regole: in tema di
rappresentanza, di dissenso occulto, di errore sulla persona, di rilevanza processuale della paternità
delle scritture e di documento informatico.
In generale può dirsi che l’autonomia privata qui trova spazio, ma non uno spazio illimitato: lo dice la
materia dei contratti reali, alcuni di essi ammettono varianti consensuali, costruite dalle parti al di là
dello schema legale, mentre per altri lo schema legale basato sulla traditio è inderogabile.
Lo conferma il 1326: esso riconosce all’autonomia privata un certo potere di conformare il
procedimento di conclusione del contratto, integrando gli schemi legali.
In generale, l’autonomia privata ha più spazio quando le sue scelte operano nel senso di rendere più
difficile la formazione del contratto, ed ha meno spazio quando esse rischiano di render troppo facile la
formazione del contratto.
È di ordine pubblico il principio per cui senza accordo non si conclude il contratto.
Il diritto di non cadere nel vincolo contrattuale senza il proprio accordo è, in linea di principio,
indisponibile.
Un indice normativo dello sfavore per i patti che semplificano l’accordo si ricava dal 1469-bis, comma
3, numero 10 (si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per
effetto di […] prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la
possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto).
I patti per la semplificazione dell’accordo vanno considerati con sfavore quando riguardano la futura
conclusione di contratti costitutivi e modificativi a contenuto non predefinito; possono forse guardarsi
con minore prevenzione quando si riferiscono a futuri contratti risolutori, od anche a contratti
costitutivi o modificativi purché i contenuti del nuovo rapporto o le modificazioni di quello esistente
siano ragionevolmente predefiniti.
In particolare, vanno disconosciuti i patti sulla conclusione del contratto che siano mezzo per eludere
norme imperative.
Un altro interrogativo riguarda i limiti in cui l’autonomia privata può incidere sul potere di revoca delle
dichiarazioni contrattuali; la legge consente al proponente di disporre del proprio potere di revoca,
formulando una proposta irrevocabile.
Può il proponente disporre anche del potere di revoca dell’oblato accettante, ad es. prescrivendo nella
proposta che l’eventuale accettazione di controparte sarà irrevocabile? Ed ancora: la contraria
indicazione del proponente vale a rendere revocabile una proposta irrevocabile ex lege?
Sembra giustificata la risposta negativa, perché diversamente si attribuirebbe al proponente il potere
d’incidere con sua decisione unilaterale su posizioni di vantaggio che la legge dà all’oblato.
Peraltro, non sembra trattarsi di posizioni indisponibili: è pertanto possibile che esse siano rinunciate
sull’accordo dell’oblato.
Sul piano sostanziale, la materia della conclusione del contratto è in parte disponibile ed in parte
indisponibile; parrebbe del tutto indisponibile sul piano processuale, secondo la giurisprudenza la
mancata conclusione del contratto è rilevabile dal giudice d’ufficio: sarebbe meglio adottare questa
massima solo nel caso in cui la mancata conclusione del contratto scaturisce da norme imperative o
principi di ordine pubblico.
CAPITOLO X – LA FORMA DEL CONTRATTO
La forma è la tecnica di comunicazione sociale con cui si manifesta la volontà.
Al linguaggio parlato corrisponde la forma orale; al linguaggio scritto corrisponde la forma della
scrittura; al linguaggio informatico corrisponde la forma del documento informatico.
Queste tecniche sono suscettibili di qualificazioni ulteriori, ad es., se il linguaggio scritto è impiegato
direttamente dalle parti, si ha la forma della scrittura privata; se viene impiegato in un più complesso
contesto, che accanto alla presenza delle parti contempla quella di un notaio (od altro pubblico
ufficiale) col ruolo di raccogliere per iscritto, secondo un certo rituale, la volontà delle parti, si ha la
forma dell’atto pubblico.
Ogni contratto ha una forma, perché se non l’avesse non vi sarebbe quella manifestazione di volontà
che è necessaria perché vi sia contratto.
Nel diritto moderno vale il principio di libertà della forma, purché si tratti di tecnica idonea ad
un’effettiva comunicazione sociale.
Il moderno principio di libertà della forma si contrappone al diverso principio del diritto romano
classico, per il quale la volontà contrattuale doveva essere manifestata secondo rigide formule rituali.
Fu soprattutto il pensiero giusnaturalista ad accreditare l’idea che nel contratto (e più in generale nel
negozio) ciò che conta è la volontà dei soggetti.
In casi particolari ed in nome di particolari esigenze, la legge prescrive che determinati contratti (detti
“a forma vincolata”, o “formali” tout court) debbano farsi con questa o con quella ben precisa tecnica
comunicativa.
Spesso le parti spontaneamente impiegano, per i loro contratti, una forma che non sarebbe richiesta
dalla legge, e ciò in ragione dei vantaggi pratici che l’uso di quella forma può comportare.
La forma della scrittura privata è richiesta per una serie di contratti che hanno ad oggetto beni
immobili: in primo luogo i contratti che incidono su diritti reali immobiliari (proprietà, diritti reali
minori di godimento): costituendoli, trasferendoli, modificandoli od estinguendoli (1350 nn. 1-6).
Il vincolo di forma opera anche per i contratti che hanno vocazione a produrre l’effetto reale, pur non
essendo in grado di produrlo immediatamente (come le vendite immobiliari obbligatorie, o sottoposte a
condizione sospensiva).
Poi i contratti che costituiscono diritti personali di godimento su immobili, i quali incidano fortemente
sulla posizione del proprietario, quali l’anticresi, le locazioni ultranovennali, i contratti di società che
conferiscono il godimento di immobili per durata ultranovennale od indeterminata (1350 nn. 7-9);
fanno eccezione i contratti agrari ultranovennali, che la legge dichiara validi anche se conclusi
oralmente.
Poi i contratti di divisione immobiliare (1350, n. 11).
Per connessione o dipendenza, la forma scritta è imposta anche alle transazioni relative ai contratti
sovrammenzionati (1350, n. 12).
Le principali funzioni della forma sono favorire la ponderazione dei contraenti, promuovere la certezza
del rapporto contrattuale fra le parti e garantire la certezza delle situazioni giuridiche nei confronti dei
terzi.
La certezza del rapporto previene le controversie, che l’incertezza può invece stimolare.
Vi è uno stretto rapporto tra forma e pubblicità, di cui la forma è prerequisito: e infatti i contratti
formali della classe appena considerata sono anche contratti soggetti a trascrizione nei registri
immobiliari (2645).
L’effetto “costituzione in garanzia reale” merita agli occhi della legge una speciale considerazione, al
di là del valore socio-economico del bene e delle esigenze pubblicitarie: si spiega così che anche il
contratto costitutivo di pegno debba risultare “da scrittura” (2787.3).
La particolare natura giuridica dell’operazione fonda le esigenze di ponderazione e certezza che si
avvertono per altri contratti soggetti a forma scritta: la rendita perpetua o vitalizia (1350 n. 10), la
vendita di eredità (1543.1), la cessione dei beni ai creditori (1978.1) ed il contratto costitutivo di
consorzio (2603.1).
In tutta un’altra serie di contratti, la forma scritta risponde pure ad esigenze di ponderazione e certezza
del rapporto, ma con una specificità: che tali esigenze sono concepite in funzione dell’interesse di una
delle parti, considerata particolarmente bisognosa e meritevole di tutela o per la natura dell’impegno
assunto o per la sua posizione socio-economica.
Così, chi si obbliga a pagare interessi a tasso ultralegale si carica d’un peso economico del quale
dev’essere ben consapevole: ecco perché la loro determinazione va fatta “per iscritto” (1284.3);
altrettanta consapevolezza si richiede in chi aderisce a condizioni generali predisposte da controparte, e
contenenti clausole onerose: queste vanno da lui specificamente approvate per iscritto (1341.2).
Analoga ratio sottende la forma scritta che si richiede per il patto di non concorrenza che limita
l’attività del dipendente per il periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro (2125).
Il campo in cui questa ratio opera in modo più significativo è quello dei contratti con consumatori,
regolati da leggi di settore.
Vogliono forma scritta: i contratti bancari e quelli di credito al consumo, i contratti per la prestazione di
servizi finanziari, i contratti per la vendita di quote di multiproprietà.
Il subfornitore non è consumatore, ma è pur sempre parte debole rispetto al committente: anche i
contratti fra loro richiedono forma scritta.
Per i contratti con consumatori, negoziati fuori dei locali commerciali, non c’è vincolo di forma scritta,
ma forma necessariamente scritta devono avere le informazioni precontrattuali sul diritto di recesso,
che l’operatore commerciale è tenuto a fornire al consumatore.
Forma scritta richiedono i contratti della pubblica amministrazione.
I contratti soggetti alla forma della scrittura privata tollerano anche una forma diversa, e cioè quella
dell’atto pubblico (l’alternativa è esplicitata dal 1350).
Per alcuni contratti particolarmente delicati l’atto pubblico è l’unica forma praticabile.
Deve farsi per atto pubblico la donazione (782.1): arricchire altri senza corrispettivo è atto grave.
Anche le convenzioni matrimoniali sono soggette alla forma dell’atto pubblico (162.1).
Devono farsi per atto pubblico i contratti costitutivi di associazioni o fondazioni che aspirino alla
personalità giuridica (14.1), di società di capitali e di società cooperative.
Qui non sembra dominante l’esigenza di ponderazione per la portata dei vincoli assunti, ma piuttosto
l’opportunità che la formazione dell’atto sia assistita e filtrata dalla competenza di un professionista del
diritto, in vista del futuro vaglio di legittimità che l’atto è destinato a subire ad opera di autorità
pubbliche.
Una questione è se, dei diversi elementi che compongono un contratto, tutti o solo alcuni devono
presentarsi nella forma vincolata.
La questione implica una premessa: in un contratto sono presenti, in ordine decrescente d’importanza
obiettiva, elementi essenziali, elementi non essenziali che tuttavia condizionano la validità del
contratto, elementi non essenziali che non condizionano la validità del contratto.
Gli elementi essenziali sono quelli che identificano l’operazione; ovvero: l’oggetto, cioè le attribuzioni
patrimoniali dedotte nel contratto, e la causa, cioè la ragione delle attribuzioni.
Non v’è dubbio che tutti gli elementi essenziali debbano rivestirsi della forma prescritta per il contratto.
Il vincolo di forma copre anche gli elementi non essenziali, da cui però dipende la validità del contratto.
Si consideri il patto di non concorrenza del dipendente, che definisca l’obbligo di astensione di
quest’ultimo ed il corrispettivo a suo favore: l’operazione è identificata, perché ne risultano causa ed
oggetto.
Ma se le parti concordano solo a voce i limiti di tempo e di luogo entro cui l’attività del dipendente è
vietata, il vincolo non è osservato.
Diversa soluzione vale per gli elementi non essenziali, la cui mancanza non influisce sulla validità del
contratto: ad es., per le modalità di consegna della cosa venduta o di pagamento del prezzo, che le parti
ben possono omettere di determinare senza che il contratto ne risulti invalido (la lacuna viene colmata
per via d’integrazione).
Questo vale in via generale; ma leggi di settore introducono per determinate classi di contratti criteri
diversi e più stringenti: per un verso prescrivono la forma scritta, per altro verso dispongono che il
contratto contenga tutta una serie di elementi anche non essenziali, la cui mancanza di regola non
determinerebbe nullità.
Possiamo chiamarli requisiti di forma-contenuto.
Il discorso riguarda soprattutto contratti di consumatori, come i contratti bancari, che devono indicare
non solo il tasso d’interesse, ma anche ogni altro prezzo e condizione praticati (117.4 t.u.b.).
I contratti negoziati fuori dei locali commerciali possono farsi anche oralmente, ma alcuni elementi di
essi, e cioè le modalità per l’esercizio del recesso del consumatore, devono comunque risultare per
iscritto.
C’è una seconda questione: posto che un determinato elemento del contratto rientri fra quelli coperti da
forma vincolata, è necessario che la forma rivesta tutti i fatti necessari e sufficienti per l’identificazione
immediata e contestuale di quell’elemento? Od è sufficiente che la forma rivesta i criteri di rinvio
(relatio) a dati che solo successivamente ed in diverso contesto permetteranno d’identificare
quell’elemento?
La questione rimanda ai temi della determinabilità dell’oggetto del contratto e del contratto per
relationem.
Esistono contratti su contratti: cioè contratti (strumentali) che preparano futuri contratti (finali), o
contratti (dipendenti) che agiscono su preesistenti contratti (presupposti).
Ci si domanda se, richiedendo i contratti finali o presupposti una forma vincolata, della stessa forma
debbano rivestirsi i contratti strumentali o dipendenti.
In qualche caso la risposta è già nella legge: così, per il contratto preliminare si richiede la stessa forma
del definitivo (1351); norme analoghe sono dettate per diversi atti unilaterali, strumentali a contratti o
da essi dipendenti: la procura vuole la stessa forma prevista per il contratto affidato al rappresentante
(1392).
Sui casi non coperti da espressa previsione legislativa, le soluzioni possono variare: abbiamo accolto la
tesi formalista per l’opzione, quella antiformalista per la prelazione.
Per il mandato (senza rappresentanza) ad acquistare immobili la dottrina esclude il vincolo di forma,
invece la giurisprudenza è compatta nel ritenerlo un contratto che esige la stessa forma dei contratti con
cui il mandatario attuerà il mandato (acquisto dell’immobile dal terzo, successivo ritrasferimento al
mandante).
Possono sorgere problemi di fronte all’esecuzione del mandato nullo.
L’esecuzione da parte del mandante che fornisca la provvista è facilmente rimediabile: egli può agire in
ripetizione.
Ma se esegue il mandatario, acquistando l’immobile dal terzo, il mandatario non può né impugnare
l’acquisto, perché al terzo non può opporre vicende del suo rapporto interno col mandante, né può
scaricare l’immobile sul mandante che non sia più disposto ad accettarlo.
Per i contratti risolutori, con cui si sciolgono preesistenti contratti formali, pare ragionevole il criterio
per cui esigono la stessa forma del contratto risolto solo i contratti risolutori che determinano effetti
analoghi a quelli di un contratto formale: così il contratto che risolve una vendita immobiliare, perché
ritrasferisce la proprietà dal compratore al venditore.
Possono invece considerarsi informali i contratti risolutori di contratto formale, che non producano
effetti del genere: così il contratto che risolve una locazione ultranovennale.
Applicando la stessa ratio, possono decidersi altre due questioni più specifiche.
È informale l’atto di rinuncia ad avvalersi della risoluzione, per inadempimento di controparte, di una
vendita immobiliare: l’atto non determina nessuna nuova vicenda immobiliare (il ritorno dell’immobile
al venditore); è invece formale l’atto di rinuncia ad avvalersi di una condizione risolutiva apposta ad
una vendita immobiliare, già verificatasi: l’atto determina direttamente una vicenda reale in senso
contrario a quella prodotta in base al contratto.
I contratti modificativi di un precedente contratto formale fra le medesime parti sono formali, se
modificano elementi che devono rivestire la forma richiesta (ad es., non si può concordare a voce la
modifica del prezzo della vendita immobiliare); non lo sono, se modificano elementi che, pur essendo
stati in concreto formalizzati, non richiedevano di esserlo.
Se validi sul piano sostanziale, i contratti informali che sciolgono o modificano precedenti contratti
formali non creano difficoltà processuali: la giurisprudenza rifiuta d’applicare ad essi le limitazioni
probatorie che colpiscono ex 2723 i patti (non documentati) aggiunti o contrari a documento anteriore.
La scrittura privata è il documento relativo al contratto, recante la firma della parte.
Quando il contratto formale si conclude mediante scambio di proposta ed accettazione, ciascuno di
questi atti deve rivestire la forma prescritta: se la proposta scritta è accettata oralmente, il contratto non
ha forma scritta.
Il contratto formale non potrebbe concludersi con un’accettazione informale, per comportamento
concludente, come l’inizio dell’esecuzione contemplata dallo schema del 1327.
La legge fa un’eccezione per i contratti di subfornitura.
Quale natura deve avere il documento relativo al contratto, onde costituire la scrittura privata
formalmente necessaria perché vi sia un valido contratto?
Il criterio ricorrente nelle massime è che il documento dev’essere formato al fine specifico di
manifestare la volontà contrattuale.
Sembra coerente con esso la soluzione che nega valore al documento puramente ricognitivo: e dunque
esclude la validità della vendita immobiliare quando l’unico documento formato al riguardo dal
venditore sia la quietanza con cui egli dà atto di avere ricevuto parte del prezzo della vendita in
questione.
Certa giurisprudenza però aggiunge che è quaestio facti accertare se un documento ricognitivo abbia
anche il senso di manifestare una volontà contrattuale, e che in tal caso esso può soddisfare il requisito
di forma.
Vi è un’incrinatura ancora più seria quando si attribuisce tale valore alla cambiale emessa dal
compratore all’ordine del venditore, con l’indicazione che la sua causa è il pagamento dell’acquisto
immobiliare.
La giurisprudenza non esclude del tutto una manifestazione di volontà in forma scritta, realizzata per
comportamento concludente, e cioè risultante da una scrittura che, ancorché non specificamente diretta
a manifestare la volontà contrattuale, la segnali in via indiretta per essere logicamente incompatibile
con la volontà contraria.
Vi è un cospicuo filone giurisprudenziale da cui questa propensione emerge con intensità: quello
formato dalle numerose pronunce che danno il contratto per validamente concluso in forma scritta,
quando la parte che a suo tempo non aveva sottoscritto il testo contrattuale o non aveva accettato per
iscritto la proposta scritta ricevuta, produce in giudizio il documento firmato dalla sola controparte o la
proposta proveniente da essa, ovvero la menziona nei propri scritti difensivi.
La volontà contrattuale sarebbe manifestata dalla parte attraverso un documento diretto a fini non
contrattuali ma processuali.
Ma posto che l’iniziativa giudiziaria dell’oblato o della parte che non ha sottoscritto il documento vale
in sostanza accettazione, com’è pensabile che essa possa efficacemente concludere il contratto a
distanza di tanto tempo dalla sottoscrizione o dalla proposta di controparte, quando l’accettazione si
dovrebbe considerare tardiva e perciò inefficace ex 1326.2?
E gli effetti della scrittura contrattuale così perfezionata decorrono ex nunc (dalla produzione in
giudizio del documento), o ex tunc, retroagendo al momento della formazione del documento prodotto?
La scrittura è documento contrattuale solo se reca la sottoscrizione (firma) della parte.
Il significato della firma è l’appropriazione del testo, l’affermazione che esso corrisponde alla volontà
contrattuale della parte.
La firma comprende di regola il prenome ed il cognome della parte, corrispondenti alle risultanze
anagrafiche; ma la firma può esser valida anche se consta del solo cognome, od indica un prenome
diverso da quello anagrafico, o si limita alla sigla: l’importante è che sia idonea ad identificare con
sicurezza il sottoscrivente.
Il testo del documento può essere scritto indifferentemente a mano o con mezzi meccanici, dalla parte o
da un terzo: invece la sottoscrizione dev’essere autografa, cioè scritta dalla parte di proprio pugno.
Nel giudizio entro il quale A produce e fa valere contro B una scrittura che reca la firma di B, se B
ritiene che la firma sia falsa, e su questa base vuole neutralizzare la scrittura, ha l’onere di un’iniziativa:
disconoscere la sottoscrizione.
Se lo fa, ribalta su A l’onere di chiederne la verificazione: e solo all’esito di questa risulterà se la firma
è autentica e quindi la scrittura è riferibile a B, oppure no (215-216 c.p.c.); se invece B non disconosce
la sottoscrizione, questa s’intende da lui riconosciuta (215 c.p.c.), anche se in concreto la firma di B
fosse falsa.
L’unico modo per escludere la riferibilità della scrittura a B sarebbe a questo punto attivare il
procedimento della querela di falso (2702; 221 ss. c.p.c.).
La stessa forza della scrittura con sottoscrizione riconosciuta (= non disconosciuta) presenta la scrittura
con sottoscrizione autenticata (comunemente detta “scrittura privata autenticata”): quella firmata
dinnanzi a notaio od altro pubblico ufficiale autorizzato, che previamente accerta l’identità del
sottoscrittore e quindi dà atto della firma da lui apposta in sua presenza (2703).
Con ciò la paternità della scrittura è pienamente provata, col solo limite della querela di falso.
Se risulta che la firma (apparentemente) di B è stata in realtà apposta da X, si porrà questione se sorga
qualche vincolo su X, che ha dichiarato sotto falso nome.
Il problema è più delicato ove risulti che X ha falsificato la firma di B, ma per incarico dello stesso B.
Chi firma il documento si appropria del testo contrattuale, ed assume su di sé tutti i vincoli che ne
derivano: anche se, non avendolo scritto lui, lo ha letto frettolosamente senza comprenderlo a fondo, e
perfino se non lo ha letto per niente.
Il criterio dell’affidamento consente di temperare la regola in casi particolari: s’immagini che A, il
quale ha predisposto il documento contrattuale, disincentivi dalla lettura B, assicurandogli che tutte le
clausole del testo sono “normali” e non gli creeranno alcun problema, mentre il testo contiene
previsioni singolari e penalizzanti per B: questi avrà il rimedio dell’annullamento per dolo (o del
risarcimento per dolo incidente).
Se poi B decide autonomamente di non leggere, perché – come dice ad A – immagina che il testo
contenga le “solite” clausole, mentre A sa che alcune delle previsioni contrattuali non sono proprio
“solite”, ed incidono pesantemente, a svantaggio di B, sullo stesso oggetto del contratto, potrà attivarsi
il rimedio dell’annullamento per errore di B (essenziale, e riconoscibile da A).
Lo stesso rimedio potrà scattare se B, pur avendo letto il testo, non lo ha compreso, e di questa
incomprensione A poteva avvedersi.
Una scrittura privata autenticata indica certamente il luogo e la data della sua formazione: sono quelli
in cui il pubblico ufficiale attesta essere avvenuta la sottoscrizione in sua presenza.
Non è necessariamente così per la scrittura privata non autenticata: questa può non indicare luogo e
data della firma, oppure può indicare luogo e data falsi.
Sul piano sostanziale, né la mancanza né la falsità di questi dati determinano invalidità del contratto;
possono invece creare problemi sul piano processuale, e precisamente probatorio.
Fra le parti, il luogo e la data effettivi di formazione della scrittura possono essere liberamente provati
dalla parte interessata con ogni mezzo di prova.
Quando la data rilevi nei confronti di terzi, la data certa, opponibile ai terzi, della scrittura privata non
autenticata non è quella che la scrittura stessa indichi, bensì è quella in cui si sia verificato un evento
obiettivo necessariamente posteriore alla sottoscrizione del documento.
Più precisamente: la registrazione della scrittura a fini fiscali, la morte o sopravvenuta impossibilità
fisica del sottoscrittore, la riproduzione del contenuto della scrittura in un atto pubblico, qualunque
altro fatto da cui risulti con uguale certezza che la scrittura è anteriore al fatto stesso (2704).
Il biancosegno è la firma apposta non in calce ad un testo contrattuale già scritto, ma ad un foglio
totalmente o parzialmente in bianco: il testo contrattuale viene successivamente scritto o completato da
persona diversa dal firmatario, per incarico di questo.
In linea di principio, questo meccanismo di dichiarazione contrattuale è ammissibile.
Sorgono problemi quando il firmatario contesta la successiva formazione del testo, lamentando che i
criteri del riempimento siano stati traditi.
In primo luogo, il biancosegno può essere il mezzo per realizzare un arbitraggio, cioè la determinazione
del contenuto del contratto ad opera d’un terzo: la firma è di entrambe le parti, ed entrambe affidano ad
un terzo l’incarico di riempimento: la disciplina è allora quella del 1349.
Altri casi non sono codificati.
Se entrambe le parti firmano il documento in bianco, ed affidano al terzo l’incarico di riempire
materialmente il foglio coi contenuti concordati fra le parti, ed il terzo esegue in modo infedele,
inserendo contenuti diversi, ciascuna delle parti può attivare, ricorrendo i requisiti posti dal 1433,
l’annullamento del contratto per errore ostativo.
Altro caso: entrambe le parti firmano il documento in bianco, ed una affida all’altra l’incarico di
riempirlo anche per conto suo.
Qui si deve distinguere: se l’incarico si basa su contenuti concordati, che la parte incaricata tradisce, la
parte incaricante (cui il testo è comunque riferibile) ha il rimedio del 1433; se invece l’incarico implica
la piena discrezionalità della parte incaricata, si porrà la questione pregiudiziale della validità
dell’incarico, e cioè se sia ammissibile che una parte affidi la determinazione dell’oggetto del contratto
alle scelte unilaterali di controparte.
Oppure: una sola parte firma il documento, perché ciò che resta in bianco è la stessa identità di
controparte, che l’incaricato dovrà identificare: anche in questo caso, se l’incaricato esegue
infedelmente, ad es. perché fa firmare il contratto ad una controparte con caratteristiche diverse da
quelle prescritte nell’incarico, potrà applicarsi il 1433.
Ugualmente, se in bianco sono lasciati anche contenuti contrattuali che l’incaricato dovrà negoziare con
la controparte da lui identificata.
Le soluzioni obbediscono ad alcuni principi: primo: il conferimento dell’incarico di riempimento rende
imputabile al firmatario incaricante il testo contrattuale che risulta dal riempimento; secondo: di fronte
al riempimento infedele, il firmatario ha contro il testo a lui imputato qualche rimedio, che consiste
essenzialmente nell’impugnativa per errore ostativo; terzo: il rimedio s’arresta di fronte all’affidamento
di controparte, perché il richiamo alla disciplina dell’errore indica che il contratto non potrà essere
impugnato dal firmatario tradito se l’infedeltà del testo non era conosciuta o conoscibile da controparte.
Resta ferma, per il firmatario tradito, la possibilità di agire in responsabilità contro l’autore del
riempimento abusivo.
La situazione è diversa se il riempimento del biancosegno avviene senza incarico del firmatario: il testo
contrattuale non è imputabile al firmatario: se egli ne dà la prova con la querela di falso, può respingere
da sé gli effetti del documento.
Qui anche l’eventuale affidamento di controparte deve cedere: a sua tutela può ipotizzarsi il
risarcimento del danno ex 1338 se l’abusiva utilizzazione del biancosegno sia stata agevolata da
condotte negligenti del firmatario (smarrimento colposo, custodia inadeguata).
Il telegramma consta di due carte distinte, recanti lo stesso testo: il modulo compilato o fatto compilare
dal mittente, e consegnato all’ufficio telegrafico (telegramma originale), ed il modulo consegnato al
destinatario (telegramma riprodotto).
Il telegramma ha efficacia probatoria di scrittura privata se l’originale è sottoscritto dal mittente, ma
anche se – pur non essendo da lui sottoscritto – è stato da lui consegnato o fatto consegnare all’ufficio
(2705.1); ed il testo del telegramma riprodotto si presume conforme all’originale (2706.1).
Nulla si dice dell’efficacia sostanziale.
Il telegramma riprodotto non ha valore di scrittura privata, né ce l’ha l’originale non firmato di pugno
dal mittente; sembra invece qualificabile come scrittura privata l’originale sottoscritto di pugno dal
mittente, benché non sia questo il documento che sarà ricevuto dal destinatario.
Con il telex, il mittente affida il messaggio non ad un ufficio ma direttamente ad una macchinaterminale; per analogia può ammettersi che ad esso s’applichi la disciplina dell’efficacia probatoria del
telegramma.
Va invece escluso che il telex valga come scrittura privata a fini sostanziali, giacché nella dinamica di
questo mezzo di comunicazione (a differenza di quella telegrafica) non figura un documento
sottoscritto dalla parte.
Al telefax può riconoscersi valore di scrittura privata, a fini non solo probatori, ma anche a fini
sostanziali: il contratto che richiede forma scritta si conclude validamente con proposta ed accettazione
scambiate per telefax.
La legittimazione di questo mezzo formale è esplicita per i contratti di subfornitura.
In campo processuale, la l. 183/1993 consente la trasmissione via telefax degli atti giudiziari.
Anche la fotocopia presuppone un originale: è quest’ultimo che (in quanto firmato, spedito, ricevuto
etc.) determina la conclusione del contratto.
Tuttavia chi deduce pretese contrattuali contro il firmatario d’un documento che possiede in fotocopia
ma non in originale, può appoggiarle sulla fotocopia: questa ha lo stesso valore dell’originale, salvo che
la conformità all’originale venga espressamente disconosciuta dal firmatario (2719), nel qual caso si
apre la verificazione giudiziale.
La forma dell’atto pubblico richiede l’intervento, oltre che delle parti, anche di un terzo soggetto: un
notaio od altro pubblico ufficiale competente.
La sua attività per la formazione dell’atto si definisce col verbo “rogare”, e l’atto risultante si definisce
“rogito”.
Le parti dichiarano la loro volontà contrattuale dinnanzi all’ufficiale rogante: questi la raccoglie e la
riferisce per iscritto; quindi legge alle parti il testo così redatto; infine il rogito viene sottoscritto dalle
parti e dall’ufficiale rogante.
Competenti a rogare atti pubblici sono prima di tutto i notai, ma anche chi abbia veste di pubblico
ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede.
Vi rientrano: i consoli, la cui competenza è parallela a quella dei notai; certi funzionari di pubbliche
amministrazioni, competenti a rogare i contratti delle rispettive amministrazioni; i cancellieri,
competenti a rogare i verbali di conciliazione giudiziale, che sono contratti.
L’autorizzazione vale in relazione al luogo dove l’atto è compiuto: così, ad es., il notaio può rogare atti
pubblici solo nell’ambito del distretto cui appartiene.
Il documento dev’essere redatto con le richieste formalità, quali risultano dalle discipline dedicate ai
diversi ufficiali roganti.
Tra le formalità si segnala la presenza di testimoni, che devono assistere alla formazione dell’atto, e
sottoscriverlo: la loro presenza è indispensabile per le donazioni e le convenzioni matrimoniali; se ne
può fare a meno, se le parti vi rinunciano, per altri tipi di contratto che pure richiedono la forma
dell’atto pubblico.
Un’altra formalità riguarda l’uso della lingua italiana.
L’atto pubblico è dotato di “pubblica fede”: esso fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle
parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
(2700).
La querela di falso è uno speciale procedimento giudiziale, che ha lo scopo di accertare se l’atto
pubblico dice il vero od il falso (221 ss. c.p.c.); se la querela viene rigettata, si ha la conferma che il
documento è genuino, ed il querelante viene punito per la sua ingiusta accusa con una pena pecuniaria;
se invece s’accerta la falsità, il documento viene integrato o cancellato o modificato in modo da
renderlo conforme alla verità accertata (226 c.p.c.); ed il pubblico ufficiale incorre nelle sanzioni penali
previste per il reato di falso in atto pubblico (476 c.p.).
L’atto pubblico fa fede del c.d. “estrinseco” dell’atto, cioè della circostanza che davvero le parti hanno
dichiarato ciò che l’ufficiale rogante attesta di averle sentite dichiarare: non fa fede del c.d.
“intrinseco”, e cioè della corrispondenza al vero di quanto le parti dichiarano, né della genuinità della
volontà dichiarata.
Il fatto che la volontà dichiarata dalle parti sia stata raccolta e rappresentata dal pubblico ufficiale non
garantisce che essa sia immune da turbative: dunque non occorre querela di falso per far valere che essa
era inficiata da un’incapacità naturale o da un errore o da un raggiro.
Peraltro fra i compiti dell’ufficiale rogante c’è quello d’indagare la volontà delle parti, e se tramite
questa indagine il notaio s’avvede che la volontà è inficiata, rifiuterà la stipulazione; inoltre il notaio
non può rogare atti espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o
all’ordine pubblico.
Il notaio, in sostanza, deve garantire la validità dell’atto, il che non toglie che se l’atto è invalido, resta
invalido; semplicemente il notaio ne risponde.
La responsabilità del notaio va oltre, estendendosi a casi in cui il contratto da lui rogato non è invalido,
bensì solo inefficace (inopponibile) nei confronti di qualche terzo, od in cui semplicemente il suo
oggetto riveli una deminutio per esser gravato da vincoli in favore di terzi, e ciò sia imputabile a
negligenza professionale del notaio.
Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
La firma digitale è il risultato della procedura informatica che consente al sottoscrittore e al
destinatario, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un
documento informatico.
La procedura che crea la firma digitale si chiama validazione; essa implica l’impiego di una coppia di
chiavi crittografiche, fra loro correlate ma asimmetriche (l’asimmetria riguardando il grado della
rispettiva conoscibilità): la chiave privata è nota solo al soggetto che la impiega per la propria firma
telematica, mentre la chiave pubblica è generalmente nota, risultando da pubblici registri.
Se al documento informatico è apposta la firma digitale dell’autore, esso soddisfa il requisito legale
della forma scritta.
La firma digitale che risulta apposta sul documento può essere disconosciuta? Si tende a rispondere di
no.
Se il titolare della chiave l’ha affidata all’estraneo con l’incarico di usarla per lui, sopporta il rischio
degli usi impropri, e non può impugnare il documento (salvo provare che l’uso improprio era
conoscibile a controparte); se invece non ha dato alcun incarico può ammettersi che impugni la
riferibilità a sé del documento, mediante querela di falso.
La firma digitale può apporsi solo ad un documento informatico, e dunque lo presuppone; invece può
concepirsi un documento informatico senza firma digitale.
Il documento informatico con firma digitale ha il valore della scrittura privata: la firma digitale è il
necessario surrogato del requisito della sottoscrizione, senza il quale non v’è scrittura privata.
Il documento informatico senza firma digitale non ha valore di scrittura privata, ma è pur sempre
manifestazione di volontà contrattuale: dunque può concludere validamente i contratti che non
richiedono forma scritta.
Le dichiarazioni di volontà espresse all’interno di collegi vengono di regola formalizzate in appositi
documenti, detti “verbali”: esse formano deliberazioni, che non sono atti contrattuali bensì appunto atti
collegiali imputati all’organizzazione e non ai singoli dichiaranti.
Tuttavia non può escludersi che in sedi collegiali vengano emesse dichiarazioni di volontà che siano
idonee a formare contratti.
Quando il contratto è a forma vincolata può porsi il problema se il verbale costituisca forma idonea; la
risposta dipende dalle caratteristiche che in concreto esso presenta: se ad es. porta le firme di tutti i
condomini o di tutti i soci che sono parte del contratto, può valere come scrittura privata.
Un’impostazione scolastica distingue tra forma per la validità (ad substantiam) e forma per la prova (ad
probationem); la distinzione è ambigua, perché la forma per la prova in realtà non è forma del
contratto, ma forma della prova; è anche troppo schematica, perché trascura forme che non incidono né
sulla validità né sulla prova del contratto.
Talora una determinata forma è richiesta dalla legge sotto pena di nullità: in casi del genere la forma è
requisito del contratto, ed alla sua mancanza consegue la nullità del contratto stesso.
La nullità può scattare anche quando non sia espressamente comminata dalla norma che prescrive la
forma, laddove l’interpretazione porti a concludere che questa è richiesta per la validità: è il caso del
contratto preliminare (1351).
Quando la forma è richiesta per la validità, essa deve rivestire le dichiarazioni contrattuali costitutive
del contratto; non è sufficiente che quella forma rivesta altre dichiarazioni pur riferite al contratto.
Con riguardo all’atto pubblico, deve distinguersi fra nullità dell’atto pubblico in sé considerato, e
nullità del contratto concluso per atto pubblico.
La nullità dell’atto pubblico dipende dall’inosservanza di regole che l’ordinamento notarile detta per la
sua formazione, e che possono non toccare la sostanza del contratto concluso in questa forma.
Le conseguenze sul contratto possono essere diverse: se il contratto richiede la forma dell’atto
pubblico, anche il contratto è nullo; se invece il contratto, pur concluso per atto pubblico, non richiede
tale forma, la presenza delle sottoscrizioni delle parti sul documento permette di qualificare questo
quale valida scrittura privata (c.d. conversione dell’atto pubblico).
La legge prevede che certi contratti devono essere provati per iscritto: ad es. l’assicurazione (1888.1):
qui la legge impone non una forma del contratto, ma una forma della prova, perciò l’inosservanza della
forma non comporta alcuna conseguenza sulla validità del contratto, e può esser priva di conseguenze
anche sul piano della prova: della transazione orale può darsi la prova in giudizio.
Ciò che occorre ai fini della prova è che vi sia un documento scritto dal quale risultano esistenza e
contenuto del contratto.
Se poi mancasse anche tale documento, una seria restrizione probatoria scatterebbe: non sarebbe
ammissibile la prova testimoniale (2725.1), né quella per presunzioni (2729.2).
Questa restrizione concerne solo la prova dell’esistenza e del contenuto del contratto, non anche fatti
diversi pur suscettibili d’influenzare il rapporto contrattuale (il luogo della conclusione del contratto
può provarsi liberamente), e poi la parte sfornita del documento è ammessa ugualmente alla prova
testimoniale o presuntiva ove provi di averlo perduto senza sua colpa (2725.1, 2724 n. 3).
La prova può raggiungersi con altri mezzi, non documentali: in particolare, con la confessione di
controparte o col giuramento a lei deferito.
La prova d’un contratto incontra restrizioni in tutti i casi in cui esso disponga qualcosa di diverso o
contrastante rispetto al contenuto di un documento; si deve distinguere, in ragione del rapporto
cronologico fra il contratto da provare ed il documento che ne sarebbe integrato o modificato.
Se il contratto recante patti aggiunti o contrari al documento è presentato come anteriore o
contemporaneo a questo, esso non può provarsi per testimoni (2722), né per presunzioni (2729.2); potrà
provarsi solo con altro documento o, in mancanza, con confessione o giuramento.
Se invece s’assume che i patti aggiunti o contrari al documento sono posteriori a questo, la prova
testimoniale e presuntiva è ristretta meno severamente: il giudice può ammetterla se, avuto riguardo
alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano
state fatte aggiunte o modificazioni verbali (2723).
Esistono vincoli di forma la cui inosservanza non determina la classica nullità del 1418, né restrizioni
probatorie, ma rileva ad altri fini, per es. al fine di precludere adempimenti pubblicitari funzionali a
rendere il contratto opponibile a terzi: possono trascriversi nei registri immobiliari solo i contratti fatti
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (2657).
Oppure al fine di sostituire i contenuti contrattuali non formalizzati con contenuti diversi, che la legge
indica: se gli interessi ultralegali non sono determinati per iscritto, s’applicano interessi al tasso legale
(1284.3).
Oppure al fine di dedurne una nullità relativa ovvero, secondo altra tesi, un’inefficacia od
inopponibilità inter partes: la clausola onerosa contenuta in condizioni generali, non approvata
specificamente per iscritto ex 1341.2, non può farsi valere dal predisponente contro l’aderente.
Oppure al fine di dedurne l’inopponibilità a terzi (in tali casi, al requisito della forma scritta s’associa di
regola quello della data certa): il contratto di locazione non è opponibile al terzo acquirente della cosa
locata, se non è fatto per scrittura con data certa anteriore all’acquisto del terzo (1599.1); il pegno non
dà prelazione al creditore pignoratizio se non risulta da scrittura con data certa (2787.3).
È più problematica la qualificazione di forme prescritte con una locuzione ambigua come quella per cui
il contratto deve “risultare” per iscritto o da atto scritto: il termine ha significati diversi in ragione delle
diverse fattispecie.
Quando indica la forma richiesta per contratti marcatamente caratterizzati dall’esigenza di tutelare una
parte debole del rapporto – come accade con l’assunzione in prova del lavoratore (2096) – è
ragionevole dedurne una forma ad substantiam; quando invece ha di mira rapporti con terzi, la si può
intendere nel senso che basti la documentazione scritta di un contratto pur concluso oralmente (è il caso
del pegno: 2787).
Il documento è la forma del contratto, ma non è il contratto.
Se il contratto fu fatto nella forma dovuta, ed il documento va accidentalmente distrutto, il contratto
continua ad esistere come validamente concluso.
Potrà esserci un problema di sua prova, superabile con la possibilità di provarlo per testi, se si dimostra
la distruzione incolpevole (2724 n. 3), e comunque potrà ovviarsi con la ripetizione.
Diverso il caso della distruzione volontaria ad opera della parte: essa preclude la prova testimoniale, e
potrebbe anche indicare la volontà di sciogliere il contratto.
Il vincolo di forma può derivare, anziché dalla legge, dall’autonomia privata; in primo luogo, da un
esercizio unilaterale di autonomia privata: il proponente può ex 1326.4 vincolare l’efficacia
dell’accettazione all’uso d’una forma determinata.
Ma anche da un suo esercizio consensuale, e cioè da un patto sulla forma (1352).
Il patto sulla forma ha natura di contratto normativo, perché regola un futuro contratto; può esaurire
l’oggetto del contratto, oppure può esser parte di un contratto a contenuto più ampio.
La forma pattizia può identificarsi in una forma legale (segnatamente, atto pubblico o scrittura privata);
ma può anche consistere in una forma ignota alla legge.
Qual è il regime del contratto successivamente stipulato in forma diversa da quella pattuita?
Le parti possono avere convenuto che la forma pattizia (ad es. la scrittura) rilevi sul terreno della prova:
in tal caso il futuro contratto non potrà provarsi per testimoni, ma solo in via documentale; oppure
possono aver convenuto che la forma rilevi sul piano sostanziale e sia costitutiva degli effetti
contrattuali, ed allora il difetto di forma impedirà la produzione degli effetti.
Se la volontà delle parti risulta, non sorge problema: problemi sorgono quando le parti pattuiscono una
forma senza dire a che fine.
In tal caso occorre distinguere a seconda che il patto sulla forma sia stato concluso per iscritto o no: se
il patto riveste forma scritta, si presume che la forma pattizia sia stata voluta per la validità del futuro
contratto (1352).
Si pongono al riguardo due problemi: il primo riguarda il senso da attribuire al termine “validità”.
Gran parte della dottrina nega che il contratto concluso senza la forma pattizia sia nullo tout court,
preferendo qualificarlo volta a volta come solo relativamente nullo, o come inefficace, o addirittura
come non concluso.
La giurisprudenza da un lato dà una lettura forte del patto, deducendone la nullità assoluta, rilevabile
d’ufficio, del contratto difforme; dall’altro, ammette la possibilità di sua revoca anche tacita, con un
comportamento concludente delle parti che potrebbe consistere nel fatto stesso di violarlo stipulando il
futuro contratto senza la forma pattizia.
La tesi della nullità assoluta pare eccessiva: più ragionevole quella di una nullità relativa e sanabile.
Quanto alla sanatoria, è eccessiva la tesi che dà valore di comportamento concludente indicativo della
volontà di revocare il patto alla mera conclusione di quest’ultimo: la volontà di revocare il patto – in
quanto contraria al contenuto di un documento anteriore – richiede in linea di principio prova
documentale: oppure la sanatoria può risultare da un comportamento concludente forte quale
l’esecuzione del contratto difforme.
Il secondo problema riguarda la natura della presunzione posta dalla norma: per qualcuno essa varrebbe
come criterio d’interpretazione oggettiva.
Va obiettato che in tal caso la si potrebbe smentire dimostrando con qualsiasi mezzo una diversa
intenzione delle parti: mentre è più coerente che la presunzione creata dalla scrittura sulla forma possa
vincersi solo in via documentale (o mediante confessione o giuramento), e non per testimoni.
Se il patto non riveste forma scritta, esso non genera la presunzione di cui sopra; i casi allora sono due:
o il futuro contratto è fatto nella forma pattizia: se è così nessun problema; oppure è difforme: in tal
caso, chi ha interesse a dedurne l’invalidità è onerato di provare (e può farlo con ogni mezzo) che il
patto esiste, e che opera sul piano della validità e non della prova; il controinteressato può far valere la
validità del contratto dimostrando (con ogni mezzo) l’inesistenza del patto o la sua operatività sul mero
terreno probatorio.
Un ultimo problema concerne il regime degli atti strumentali al contratto considerato dal patto sulla
forma.
Se A e B pattuiscono la forma convenzionale di scrittura per un loro futuro contratto (cui la legge non
la impone), lo stesso vincolo formale si estende anche alla procura ed al preliminare relativi a quel
contratto? La giurisprudenza risponde di no.
In generale, riproduzione (o ripetizione) del contratto è il fenomeno per cui, concluso un contratto, le
parti successivamente lo rifanno in forma diversa.
Possibili scopi della ripetizione: dare precisione e certezza al contenuto del contratto, consentire la
registrazione del contratto e così munirlo di data certa opponibile ai terzi, consentirne la trascrizione nei
registri immobiliari, permettere a ciascuna parte di disporre del medesimo testo contrattuale in mano
all’altra parte, chiarire qualche punto oscuro od ambiguo del precedente contratto, rimuovere una
possibile ragione d’inefficacia del contratto.
La ripetizione del contratto normalmente è una scelta spontanea delle parti, ma talora costituisce atto
dovuto.
Fonte dell’obbligazione di riprodurre il contratto è di regola il contratto stesso.
Ma l’obbligo può derivare dalla legge.
Non c’è obbligo di ripetere in altra forma un contratto nullo: sia che la nullità dipenda da ragioni di
sostanza, sia che dipenda da difetto di forma.
Il contratto riproduttivo ha valore solo ricognitivo, di mero accertamento di una volontà contrattuale, od
esprime anch’esso un’attuale volontà contrattuale, capace di attribuirle valore costitutivo o addirittura
novativo del rapporto contrattuale?
La risposta cambia, a seconda delle variabili che connotano ciascuna fattispecie concreta: ed in
particolare dall’intento delle parti.
Un problema è: l’invalidità del contratto riprodotto rende invalido anche il contratto riproduttivo?
Dipende: se il primo è nullo per illiceità della causa, lo è anche il secondo, ma se il primo è nullo per un
vizio di forma, che il secondo non presenta, quest’ultimo è valido.
Se il primo è annullabile per incapacità od errore, ed il secondo è concluso a capacità riacquistata o ad
errore scoperto, il secondo è valido.
Se il primo è rescindibile per lesione ed il secondo cade quando lo stato di bisogno è passato, il secondo
sarà valido nei soli limiti in cui non contrasti con la regola (1451) che esclude la convalida del contratto
rescindibile.
Un altro problema è: come trattare le divergenze di contenuto fra contratto riprodotto e contratto
riproduttivo? Anche qui dipende: se risulta che il secondo non riflette una volontà contrattuale attuale
delle parti, ma ha valore meramente ricognitivo del primo, questo comanda e le varianti introdotte nel
documento riproduttivo vanno disattese; se invece anche il contratto riproduttivo esprime un’attuale
volontà contrattuale, occorre indagarne la portata: ove le divergenze siano consapevoli e deliberate,
vale il contenuto del contratto riproduttivo; mentre se le divergenze non sono volute, potrà applicarsi la
disciplina dell’errore.
Nei casi di ripetizione del contratto, in linea di principio sia il contratto riprodotto sia il contratto
riproduttivo possono essere fatti valere come titolo di pretese contrattuali; incombe a chi contrasta
siffatte pretese l’onere di dimostrare elementi capaci di neutralizzare l’efficacia del contratto fatto
valere.
CAPITOLO XI – LA RAPPRESENTANZA: NOZIONE, FUNZIONE, AMBITI
La rappresentanza realizza nell’attività contrattuale un principio di divisione del lavoro.
Vi sono due modi di concepire la rappresentanza: una concezione allargata ed una ristretta.
La concezione allargata è di elaborazione dottrinale ed identifica l’essenza dell’istituto nel fenomeno
della cooperazione: si ha rappresentanza ogniqualvolta taluno agisce per conto e nell’interesse di un
altro.
All’interno di questa categoria si distinguono poi due sottotipi: la rappresentanza diretta, qualificata dal
fatto che il cooperatore agisce, oltre che per conto, anche in nome dell’interessato, con la conseguenza
che gli effetti dell’atto si producono direttamente nella sfera di quest’ultimo, e la rappresentanza
indiretta, che vede il cooperatore agire per conto dell’interessato ma in nome proprio, con la
conseguenza che gli effetti dell’atto si producono nella sfera del cooperatore che lo compie, e solo in un
secondo tempo e per il medio di un ulteriore atto si riversano nella sfera dell’interessato.
La concezione ristretta identifica l’essenza dell’istituto nella sostituzione: si ha rappresentanza solo
quando taluno agisce in nome di un altro, sostituendosi a lui nel compimento di un atto che produce i
suoi effetti direttamente nella sfera dell’interessato.
“Rappresentante” è chi agisce in nome altrui, “rappresentato” è colui in nome del quale il
rappresentante agisce.
Il meccanismo operativo della rappresentanza è descritto nel 1388: il contratto concluso dal
rappresentante, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti del
rappresentato.
È il rappresentante che conclude il contratto, che forma e manifesta la volontà contrattuale.
Il rappresentante è parte in senso strumentale, o procedimentale, è parte del contratto come atto; il
rappresentato è invece parte in senso sostanziale, è parte del contratto come rapporto.
Occorre che il rappresentato abbia legittimazione e capacità giuridica in ordine alle posizioni soggettive
movimentate dal contratto.
L’atto del rappresentante non può produrre, verso il rappresentato, effetti contrattuali superiori a quelli
che produrrebbe l’atto del rappresentato stesso.
Il primo presupposto del potere rappresentativo non ha valore assoluto: le regole sull’estinzione della
rappresentanza e sulla rappresentanza apparente dicono che in certi casi il preteso rappresentato riceve
gli effetti del contratto concluso dal sedicente rappresentante ancorché questi sia privo di poteri
rappresentativi.
Il secondo presupposto è che il rappresentante operi nei limiti delle facoltà conferitegli: la regola è che
il contratto concluso oltre quei limiti non vincola il rappresentato: ma anche qui con qualche deroga,
che emerge dalla disciplina delle modificazioni della procura e da quella della rappresentanza
apparente.
Il terzo presupposto è la finalizzazione dell’atto del rappresentante all’interesse del rappresentato: si
tratta in realtà di un presupposto debole, perché il difetto di esso non impedisce la produzione degli
effetti sul rappresentato.
Inoltre, si danno casi in cui la rappresentanza è conferita per essere esercitata (anche) nell’interesse del
rappresentante.
Il quarto è la spendita del nome: occorre che il contratto sia concluso dal rappresentante in nome del
rappresentato, in caso contrario gli effetti del contratto si producono in capo al rappresentante.
La spiegazione concettuale del meccanismo operativo della rappresentanza si basa sulla categoria del
potere: il rappresentante è in grado di vincolare contrattualmente il rappresentato, in quanto ha il potere
di farlo.
In luogo della categoria del potere, od accanto ad essa, parte della dottrina ne introduce altre: in
particolare quelle della legittimazione e dell’autorizzazione.
Il conferimento di potere rappresentativo non priva il rappresentato del potere di compiere
personalmente gli stessi atti per cui ha dato rappresentanza; di più, il compimento personale dell’atto
può valere revoca del potere conferito.
Si discute se il potere rappresentativo sia trasferibile, mediante un atto con cui il rappresentante lo ceda
in tutto od in parte ad altro soggetto (subrappresentanza); la subrappresentanza sembra in linea di
principio da escludere, perché l’attribuzione del potere rappresentativo si basa normalmente sul
rapporto personale e fiduciario che il rappresentato intrattiene col rappresentante, non c’è invece
ragione di negarla quando sia autorizzata dall’interessato.
Il contratto è, per eccellenza, atto di autonomia: lo è anche il contratto concluso in rappresentanza? E se
sì, è atto di autonomia del rappresentato o del rappresentante?
Alla prima domanda deve rispondersi affermativamente.
Il meccanismo della rappresentanza imputa al rappresentato gli effetti dell’azione del rappresentante.
Per l’azione precontrattuale del rappresentante occorre distinguere: sono senz’altro imputati al
rappresentato gli effetti di quelle azioni del rappresentante definibili precontrattuali solo perché
cronologicamente anteriori alla conclusione del contratto, ma che sotto altro profilo hanno natura
contrattuale, in quanto atti negoziali riferiti al contratto in itinere.
Altro discorso va fatto per gli atti del rappresentante anteriori al contratto, che rilevino non sul piano
contrattuale ma sul piano del danno e del risarcimento: in particolare gli atti generatori di responsabilità
precontrattuale.
Gli effetti di tali atti (responsabilità ed obblighi risarcitori) non sono automaticamente imputati al
rappresentato, perché l’automatismo dell’imputazione rappresentativa riguarda solo gli effetti
contrattuali: saranno imputati in base ai criteri d’imputazione dell’illecito.
A differenza del rappresentante, che forma e manifesta la volontà contrattuale diventando parte del
contratto, il nuncius si limita a trasmettere a controparte la volontà contrattuale già compiutamente
formata dall’interessato.
Se il soggetto nel portare la volontà contrattuale manifesta l’esercizio di qualche margine di
discrezionalità nella formazione di questa, si presenta come rappresentante e tale va considerato; va
considerato come nuncius se si presenta come il portatore di una volontà in nessun modo conformata da
sue scelte discrezionali.
Potrà qualificarsi nuncius anche chi mette per iscritto e reca a controparte la volontà contrattuale
manifestata oralmente dall’interessato (non però se il contratto esige forma scritta: in tal caso occorre la
sottoscrizione o dell’interessato o del suo rappresentante).
Nel momento in cui svolge il suo ruolo, il rappresentante deve avere almeno la capacità naturale;
invece il nuncius può anche esserne privo, essendo sufficiente l’efficienza materiale della sua attività
trasmissiva.
Può rilevare l’errore del nuncius, che mal comprende la volontà dell’interessato e così la trasmette a
controparte in modo distorto: in linea di principio l’interessato è vincolato alla dichiarazione trasmessa
in modo infedele, ma se ricorrono i presupposti richiamati dal 1433 – essenzialità e riconoscibilità della
divergenza – può impugnarla per errore ostativo.
La stessa regola può applicarsi quando l’infedeltà della trasmissione dipende non da errore, ma
dall’alterazione intenzionale compiuta dal nuncius.
Nel caso estremo in cui un sedicente nuncius si presenta come portatore della volontà contrattuale di
qualcuno che non gli ha dato alcun incarico il preteso interessato non è vincolato, e controparte può
chiedere i danni al falsus nuncius, sulla falsariga del 1398.
In astratto, tutti i contratti possono compiersi in rappresentanza, con l’eccezione della donazione (777778), in ragione del suo carattere personale.
La rappresentanza può operare fuori dal campo dei contratti, esclusi i c.d. atti personalissimi:
matrimonio, testamento e sua revoca, separazione consensuale, riconoscimento di figlio naturale,
adozione.
La rappresentanza è ammessa negli atti unilaterali, sia che abbiano natura negoziale (recessi, disdette,
…), sia che non abbiano tale natura (comunicazioni, intimazioni, …).
È ammessa la rappresentanza nella ricezione di atti (c.d. rappresentanza passiva).
Posto che un determinato atto sia astrattamente suscettibile di compiersi in rappresentanza, si tratta poi
di sapere se esso rientri in concreto fra gli atti che quel rappresentante ha il potere di compiere in
sostituzione di quel rappresentato: qui la risposta sta nella fonte della rappresentanza.
La rappresentanza processuale è il potere di agire in giudizio in nome dell’interessato, che riceve gli
effetti delle iniziative processuali del rappresentante.
Si contrappone alla rappresentanza nel compimento di atti non processuali, che si definisce
rappresentanza sostanziale.
La regola in materia è la necessaria (o almeno tendenziale) coincidenza fra rappresentante processuale
e sostanziale.
Nella rappresentanza legale ed in quella organica la legge fa discendere quasi automaticamente la
rappresentanza processuale da quella sostanziale (75.2-4 c.p.c.).
Invece affinché il rappresentante sostanziale (e solo lui) sia anche rappresentante processuale occorre
che il relativo potere gli sia stato conferito espressamente per iscritto (76.1 c.p.c.).
Anche nel campo processuale trova applicazione il meccanismo della rappresentanza passiva: se A
rappresenta processualmente l’interessato B, A può essere convenuto in giudizio al posto di B (ovvero
B può essere convenuto “in persona” del suo rappresentante A).
Altra cosa dalla rappresentanza processuale è la rappresentanza tecnica nel processo: questa spetta al
difensore (avvocato) munito della c.d. procura alle liti (83 c.p.c.); egli può compiere e ricevere,
nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente
riservati; ma per gli atti che implicano disposizione del diritto controverso (come la rinuncia alla
domanda) occorre che il relativo potere sia stato conferito dalla parte in modo specifico e espresso (84
c.p.c.).
Il potere di rappresentanza esiste in quanto generato da una fonte.
Nella formula del 1387, la fonte può essere duplice: o la legge, o (la volontà de) l’interessato.
Vi sono così due tipi di rappresentanza: la rappresentanza volontaria, basata sulla procura che
l’interessato liberamente conferisce ad un rappresentante da lui prescelto, e la rappresentanza legale –
esemplificata dalla rappresentanza dei soggetti totalmente o parzialmente incapaci di agire (quali
minori, interdetti, inabilitati, falliti) – in cui è la legge ad imporre il meccanismo rappresentativo.
La distinzione è però turbata dal fenomeno della rappresentanza delle organizzazioni (c.d.
rappresentanza organica); per inquadrarlo, taluno ricorre alla categoria della rappresentanza necessaria,
di cui la rappresentanza organica sarebbe sottospecie, e quella legale altra sottospecie: sua caratteristica
sarebbe l’indispensabilità del meccanismo rappresentativo.
Si propone la tipologia seguente: da un lato c’è la rappresentanza volontaria in senso pieno, creata,
tramite la procura, dalla decisione discrezionale del rappresentato: essa si caratterizza per l’ampia
possibilità di controllo del rappresentato sul rappresentante; dal lato opposto v’è la rappresentanza degli
incapaci, in cui il ruolo decisionale del rappresentato è nullo: egli né sceglie il rappresentante, né
conforma i suoi poteri, né ha la possibilità di revocarli o modificarli successivamente, né condiziona il
suo agire, né può spiegare un’attività alternativa alla sua: questa è rappresentanza legale nel senso più
pieno, ed è necessaria perché senza essa gli incapaci non parteciperebbero al traffico negoziale.
Ulteriore sua caratteristica è il sistema dei controlli pubblici (giudiziali) che – per lo più nella forma
dell’autorizzazione preventiva – circondano l’operato del rappresentante.
Fra l’una e l’altra si collocano poi altre fattispecie.
C’è la rappresentanza organica: anch’essa per un verso necessaria in quanto le organizzazioni non
potrebbero agire negozialmente se non fossero rappresentate da persone fisiche, e legale perché la legge
dà indicazioni sul contenuto dei relativi poteri; ma per altro verso fortemente colorata di volontarietà,
perché le indicazioni normative sono per lo più derogabili dalla diversa volontà dell’organizzazione, e
soprattutto perché è l’organizzazione interessata, e non la legge, a scegliere le persone fisiche da
investire della rappresentanza.
C’è poi la rappresentanza nell’impresa commerciale: non necessaria, bensì del tutto volontaria nella sua
genesi, perché l’imprenditore è libero di agire personalmente senza avvalersi di institori, procuratori o
commessi che lo rappresentino, eppure con qualche sfumatura legale, perché la legge si cura di definire
(ancorché con norme derogabili) l’ampiezza dei loro poteri.
C’è infine la rappresentanza connessa alla gestione di affari altrui (2031.1): certamente legale nella sua
genesi, e tuttavia sensibile all’iniziativa dell’interessato che se può e vuole – prohibente domino – è in
grado di bloccarne l’operatività; e in ogni caso non necessaria, perché essa interviene in modo
eventuale ed accidentale.
Ogni tipo di rappresentanza ha la sua disciplina: che solo in parte coincide con la disciplina degli altri
tipi.
Il paradigma legislativo di base (1387 ss.) è quello della rappresentanza volontaria e non necessaria, da
procura.
Può riproporsi la domanda: fermo che il contratto concluso in rappresentanza è atto di autonomia, esso
è da riferire all’autonomia del rappresentato od a quella del rappresentante? Mentre nella
rappresentanza volontaria da procura la radice dell’atto sta nell’autonomia del rappresentato, non
altrettanto può dirsi per la rappresentanza degli incapaci, la cui incapacità è incapacità di scelte
autonome.
L’atto del rappresentante legale esprime l’autonomia di quest’ultimo.
I tipi di rappresentanza diversi dalla rappresentanza volontaria da procura hanno questo in comune: in
essi la fonte del potere attribuito al rappresentante è al tempo stesso fonte di obblighi di condotta.
Non è sempre così nella rappresentanza volontaria pura, questa può presentarsi associata a (od
incorporata in) un rapporto di gestione, come quando nel contratto di mandato si prevede che il
mandatario rappresenti il mandante.
Ma il potere rappresentativo può presentarsi anche dissociato dal rapporto di gestione, come accade col
negozio di procura che semplicemente conferisce ad A il potere di rappresentare B, senza dar vita né
fare riferimento ad alcun rapporto di gestione fra i due.
Vi sono due problemi: l’estinzione o la modifica del rapporto di gestione estingue o modifica il potere
rappresentativo? E poi: un esercizio del potere rappresentativo, che sia conforme alla propria fonte ma
difforme dagli obblighi del rapporto di gestione, pregiudica gli effetti che normalmente ne derivano
(ossia il sorgere di vincoli contrattuali sul rappresentato)?
I quesiti meritano risposte diverse a seconda delle molte variabili che i casi in concreto presentano.
In generale, chi nella rappresentanza valorizza l’aspetto della cooperazione sarà più propenso ad
attribuire rilievo al rapporto di gestione, a tutela del rappresentato; sarà invece più incline a negargli
rilievo – così salvaguardando il terzo – chi nella rappresentanza considera centrale il profilo della
sostituzione.
La procura è il negozio con cui l’interessato conferisce il potere rappresentativo al soggetto che diventa
così suo rappresentante.
La si presenta abitualmente come negozio unilaterale che non richiede accettazione del rappresentante,
perché con la procura questi acquista un potere, senza subire altre modificazioni della propria sfera.
Non così il negozio fonte dell’eventuale rapporto di gestione, che imponendo obblighi al
rappresentante-gestore esige il suo accordo.
Al destinatario che non voglia accettare la procura devono riconoscersi il potere di rifiutarla, e la
pretesa che il conferente controinformi i terzi per evitarne le intrusioni nella propria sfera.
La procura è un negozio ricettizio, che produce l’effetto d’investire il rappresentante del potere
rappresentativo, in quanto il rappresentato la faccia pervenire al rappresentante stesso.
La procura è un atto a forma eventualmente vincolata: richiede le forme prescritte per il contratto che il
rappresentante deve concludere, ed in mancanza non ha effetto (1392).
Se il contratto da concludere in rappresentanza è informale, informale può essere la procura: sarà
efficace una procura orale od anche una c.d. procura tacita, conferita per fatti concludenti.
L’oggetto della procura si definisce con l’estensione del potere conferito: cioè con l’atto o la serie di
atti che il rappresentante è autorizzato a compiere in nome del rappresentato.
In relazione all’oggetto, si usa contrapporre procura speciale e procura generale.
Si usa dire che la procura speciale ha per oggetto il compimento di uno o più atti determinati.
In questa prospettiva, si ritiene che la procura per un dato contratto s’estenda al relativo preliminare; si
considera applicabile la regola – scritta per il mandato (1708.1) – secondo cui la procura speciale
riferita ad un certo atto copre anche gli altri atti, pur non espressamente indicati, che siano necessari per
il compimento di quello autorizzato.
La procura generale sarebbe invece quella che ha per oggetto il compimento di tutti gli atti relativi alla
generalità degli affari del rappresentato, ovvero ad un gruppo di suoi affari.
Il problema è restringere l’area degli atti autorizzati: si invoca a tal fine la regola – anch’essa scritta per
il mandato (1708.2) – per cui la procura generale non comprenderebbe gli atti che eccedono l’ordinaria
amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Vi sono determinati atti, o clausole di atto, che non risultano coperti dalla procura se questa non li
contempla in modo specifico: la procura per una vendita non consente la vendita a sé stesso, che
dev’essere specificamente autorizzata (1395).
Spesso la procura viene qualificata coi caratteri dell’autonomia e dell’astrattezza; autonomia dal
rapporto di gestione: volendosi dire che, quando questo c’è, non influenza il potere rappresentativo
creato dalla procura.
Ed astrattezza rispetto al medesimo, visto come causa del conferimento di potere rappresentativo:
intendendosi che la procura può reggersi a prescindere da tale causa.
Qualificazioni siffatte rischiano di essere fuorvianti: il potere rappresentativo può essere insensibile al
rapporto di gestione, ma può anche subirne l’influenza.
Ed è vero che la procura può astrarre dal rapporto di gestione: ma solo nel senso che se il rapporto c’è,
la procura può non menzionarlo, od anche che essa può non essere affiancata da nessun rapporto
gestorio in senso proprio.
Ciò non significa che la procura sia priva di causa.
La spendita del nome (contemplatio domini) è un elemento strutturale dell’agire rappresentativo, in
mancanza del quale non si producono gli effetti tipici della rappresentanza: se nel compiere l’atto per il
rappresentato il rappresentante non spende il suo nome, l’atto non tocca la sfera del rappresentato ma
vincola il rappresentante.
L’atto del rappresentante senza potere può in molti casi produrre effetti sul (falso) rappresentato; effetti
che invece non può mai produrre l’atto del rappresentante che non spende il nome del rappresentato.
È evidente, in ciò, un fine di tutela del terzo contraente.
La spendita del nome implica due dati: la manifestazione che l’atto non è compiuto per il suo autore,
ma per un diverso interessato, e la manifestazione dell’identità del diverso interessato; entrambi sono
necessari.
Regna incertezza circa i modi di tali manifestazioni: alcune sentenze delineano un indirizzo molto
restrittivo: la spendita del nome non richiede l’uso di formule sacramentali, ma dev’essere rivolta al
terzo contraente in modo esplicito ed univoco, e non può ricavarsi da elementi presuntivi, e se il
contratto è formale, la spendita del nome deve rivestire la stessa forma e risultare dal contesto
documentale dell’atto.
Altre pronunce si mostrano più aperte: ammettono (almeno per i contratti non formali) una spendita del
nome tacita, manifestata per comportamenti concludenti o ricavabile dalla stessa struttura del negozio.
L’onere di provare l’avvenuta spendita del nome incombe su chi fa valere effetti contrattuali in capo al
rappresentato.
Nella rappresentanza passiva la spendita del nome va concepita con gli opportuni aggiustamenti: di
essa deve farsi carico non il rappresentante, ma il terzo autore dell’atto, cui spetta manifestare che
questo viene rivolto al rappresentante per il rappresentato, destinatario sostanziale degli effetti.
CAPITOLO XII – L’ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA
Il 1389.1 detta la disciplina dell’incapacità di agire nella rappresentanza volontaria.
Il rappresentato dev’essere legalmente capace, e dev’esserlo per l’intero corso della vicenda
rappresentativa: se egli è incapace nel momento in cui conferisce la procura, ne segue l’annullabilità di
questa, che a sua volta travolge il contratto concluso in base ad essa; se lo diventa in seguito, questa
sopravvenuta incapacità estingue la procura pur validamente conferita.
Il rappresentato deve avere altresì la capacità naturale nel momento in cui conferisce la procura, che in
caso contrario è annullabile secondo la regola scritta per gli atti unilaterali dell’incapace d’intendere e
di volere (428).
È invece irrilevante una sua incapacità naturale sopravvenuta.
Per quanto riguarda il rappresentante, si prevede l’irrilevanza della sua incapacità legale: anche minori
ed interdetti possono validamente ricevere ed esercitare il potere rappresentativo, concludendo contratti
pienamente efficaci per il rappresentato.
La ragione è che il contratto, pur concluso da un incapace legale, mette in gioco interessi che essendo
non suoi ma di altro soggetto legalmente capace, non soggiacciono al regime di rigore della tutela degli
incapaci.
Al rappresentante si richiede invece la capacità naturale nel momento in cui compie l’atto per il
rappresentato.
Si segnalano tuttavia due specificità: il livello rilevante d’incapacità può non essere uniforme nei
diversi casi concreti, perché va commisurato alla natura ed al contenuto del contratto; e mentre
l’incapacità (come pure la buona o la mala fede dell’altro contraente rispetto ad essa) va riferita al
rappresentante, il requisito del grave pregiudizio deve accertarsi nei confronti del rappresentato.
S’è affermato che l’incapacità naturale del rappresentante non vizia il contratto quando gli elementi di
questo sono predeterminati dal rappresentato, ma la posizione del rappresentato non è pienamente
assimilabile a quella del nuncius; e l’incapacità naturale può impedirgli di cogliere un’eventuale
sopravvenuta sconvenienza.
Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante (1390): se quest’ultimo (e non il
rappresentato) sia vittima di errore, inganno o minaccia.
La stessa ratio fonda la regola sulla rilevanza degli stati soggettivi: buona o mala fede, conoscenza od
ignoranza di determinati fatti vanno accertate con riferimento alla persona del rappresentante, e non del
rappresentato (1391.1).
Quando però il vizio della volontà o lo stato soggettivo riguardano elementi predeterminati dal
rappresentato, è a questo che deve farsi riferimento (1390; 1391.1).
Riguardo alla rappresentanza organica, rileva in linea di principio la condizione soggettiva della
persona fisica che rappresenta l’ente, ma la precedente, interna deliberazione del contratto (o di suoi
elementi) da parte di un diverso organo deliberativo dell’ente stesso può configurare quella
predeterminazione ad opera del rappresentato che mette fuori gioco la condizione del rappresentante.
Il 1391.2 detta infine una norma di salvaguardia contro frodi od elusioni: in nessun caso il
rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del
rappresentante: e ciò anche se la mala fede verte su elementi non predeterminati da lui; la norma non
s’applica alla rappresentanza legale degli incapaci (mentre la si applica a quella organica ed alla
gestione d’affari rappresentativa).
Alla condizione del rappresentato deve poi guardarsi quando venga in gioco l’interesse sostanziale
dedotto nel contratto: perciò il contratto è rescindibile se il rappresentato (non il rappresentante) si trova
in stato di bisogno; e, posto che il contratto sia annullabile per vizio della volontà del rappresentante,
non questi bensì il rappresentato è legittimato ad agire per l’annullamento.
Nell’esercizio del potere rappresentativo il rappresentante deve perseguire l’interesse del rappresentato.
Se opera in modo difforme da quell’interesse, abusa della rappresentanza (abuso di rappresentanza).
L’abuso di rappresentanza va distinto dal difetto di rappresentanza, che invece implica l’inesistenza del
potere esercitato.
Mentre il difetto di rappresentanza in linea di principio rende inefficace il contratto del falso
rappresentante, l’abuso di rappresentanza ha altre conseguenze, modulate in ragione della qualità
dell’abuso: se questo presenta connotati del conflitto d’interessi, è comunque un illecito del
rappresentante a danno del rappresentato, che dà luogo a responsabilità e risarcimento (senza toccare
validità ed efficacia del contratto col terzo).
Può a volte esservi difficoltà di distinguere fra abuso e difetto di rappresentanza (specie nel c.d. eccesso
di rappresentanza).
Può il rappresentato respingere gli effetti del contratto in quanto inefficace, allegando un difetto di
rappresentanza per il superamento di limiti ai poteri del rappresentante, ricavabili dal rapporto di
gestione? Od in quanto annullabile, allegando un conflitto d’interessi che emerge dal rapporto di
gestione?
Agli occhi dei terzi i limiti ed i modi di esercizio rilevanti del potere rappresentativo sono quelli che
emergono dalla procura, e ad essi non sono opponibili limiti e modi desumibili da un separato rapporto
di gestione, che i terzi non hanno l’obbligo e spesso nemmeno la possibilità di conoscere.
Fermo questo principio, potranno ben darsi casi in cui attribuire rilevanza al rapporto di gestione è
ammissibile, perché non implica ingiusta lesione di posizioni dei terzi, meritevoli di tutela.
Il rappresentante deve operare nell’interesse del rappresentato (1388): se non lo fa, e conclude un
contratto in conflitto d’interessi col rappresentato, a tutela di quest’ultimo il contratto è annullabile
(1394).
Per integrare il conflitto d’interessi, fattispecie qualificata di abuso di rappresentanza, non è sufficiente
che il rappresentante operi in contrasto con l’interesse del rappresentato; occorre che lo faccia in quanto
portatore di un interesse alieno, incompatibile con quello del rappresentato.
L’interesse alieno è incompatibile, quando non è perseguibile senza sacrificare l’interesse del
rappresentato.
L’interesse alieno può essere un diretto interesse del rappresentante, ma può essere anche l’interesse di
un altro soggetto, con cui il rappresentante abbia legami qualificati, ad es. di famiglia o d’affari (c.d.
conflitto indiretto).
L’interesse in conflitto normalmente è patrimoniale, ma in linea di principio potrebbe essere anche non
patrimoniale.
Il conflitto deve sussistere al tempo del contratto: non rileva un conflitto esistente prima del contratto
ma venuto meno al tempo di questo, né un conflitto che, inesistente alla conclusione del contratto, sia
insorto dopo, nel corso della sua esecuzione.
Si dibatte in dottrina se ulteriore requisito per la rilevanza del conflitto d’interessi ex 1394 sia il danno
effettivo subito dal rappresentato, o se basti il mero rischio di danno insito nel conflitto d’interessi.
È ragionevole che il conflitto perda rilevanza se il rappresentato abbia ugualmente autorizzato il
contratto (arg. ex 1395.1); la giurisprudenza che lo ammette però pretende che l’autorizzazione non sia
generica, ma specificamente riferita ai contenuti del contratto da concludere.
Il contratto è annullabile solo se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo contraente.
L’onere probatorio è sul rappresentato, ma potranno agevolarlo elementi obiettivi attinenti il contenuto
e gli effetti dell’atto.
L’azione di annullamento spetta al solo rappresentato, e su lui grava l’onere di provare sia l’esistenza
del conflitto, sia la sua conoscenza o conoscibilità da parte del terzo.
Si discute sull’inizio della prescrizione: la tesi che fa decorrere il termine dalla conclusione del
contratto è preferibile a quella che lo fa scattare solo quando il rappresentato abbia preso conoscenza
del conflitto.
Se la scorrettezza del rappresentante danneggia il rappresentato, questi ha diritto al risarcimento.
Non può escludersi che l’azione di risarcimento concorra con quella di annullamento.
Quanto alla natura della responsabilità, non sembra dubbia la qualificazione contrattuale: sia che il
rappresentante abbia violato qualche specifica obbligazione del rapporto di gestione, sia che abbia
semplicemente violato il generico obbligo di cura fedele dell’interesse del rappresentato.
Il 1394 è applicabile alla rappresentanza organica.
Il conflitto d’interessi ha una particolare manifestazione nel contratto con se stesso (1395).
La figura ricorre in due casi; nel primo si ha il c.d. autocontratto: il rappresentante entra come
controparte sostanziale nel contratto che conclude per la parte da lui rappresentata.
Il secondo caso è la c.d. doppia rappresentanza: il rappresentante fa il contratto in rappresentanza di
entrambe le parti.
Nel contratto con se stesso il conflitto d’interessi è in re ipsa: per questo il contratto è senz’altro
annullabile.
La conseguenza scatta anche se il rappresentante contratta in realtà con se stesso sotto l’apparenza di
contrattare con altro soggetto, fittiziamente interposto (simulazione); mentre in caso d’interposizione
reale (mandato, fiducia) potrà applicarsi il 1394.
L’azione di annullamento ex 1395 segue il regime di quella ex 1394, peraltro con onere probatorio
alleggerito per l’attore: al rappresentato basta provare che il rappresentante ha concluso un
autocontratto od agito in doppia rappresentanza.
Il 1395 indica due circostanze capaci di salvare dall’invalidità il contratto con se stesso: una è
l’autorizzazione del rappresentato; questa deve però essere specifica: l’autorizzante deve anche
precisare i contenuti del contratto autorizzato.
In alternativa, il contratto è salvo se il suo contenuto sia determinato in modo da escludere la possibilità
di conflitto d’interessi: il requisito non coincide con la predeterminazione ad opera del rappresentato.
E viceversa, il conflitto può essere escluso in casi nei quali il contenuto non è predeterminato dal
rappresentato.
La figura e la disciplina del 1395 trovano applicazione anche alla rappresentanza organica.
La revoca della procura è il negozio unilaterale con cui il rappresentato toglie al rappresentante il
potere rappresentativo che in precedenza gli aveva conferito.
Essa non tocca l’efficacia degli atti compiuti prima della revoca, quando il potere sussisteva.
In generale, la revoca della procura rientra nei poteri del rappresentato, che può disporla liberamente
(salvi i casi d’irrevocabilità).
Non richiede forme, anche se la procura revocata fosse un atto formale.
Si discute se la revoca sia ricettizia.
Rispetto ai terzi non rileva che il rappresentato abbia loro comunicato la revoca, ma solo che questa sia
stata resa pubblica con mezzi idonei o che comunque sia venuta a loro conoscenza.
Il revocante ha un onere: portare la revoca a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (1396.1).
I mezzi idonei con cui dar conoscenza della revoca possono essere i più vari, a seconda dell’oggetto
della procura.
Se il revocante assolve quest’onere, la revoca produce pienamente il suo effetto ed è opponibile al terzo
(ancorché ignaro) con cui il rappresentante abbia contrattato; il contratto è inefficace, ed il terzo può
agire per il risarcimento contro il falso rappresentante.
Se invece il revocante non assolve l’onere di pubblicizzazione, la revoca è inopponibile al terzo, salvo
che il revocante riesca a provare che questi per qualche altra via la conosceva al momento della
conclusione del contratto: se tale prova manca, il contratto è efficace.
Tutto quanto s’è detto per la revoca della procura vale, per l’espresso disposto del 1396, anche per le
modificazioni di essa.
Che la procura sia revocabile risulta espressamente dal 1396 (Le modificazioni e la revoca della
procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono
opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del
contratto.
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non
sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.).
La disciplina del mandato contempla la fattispecie in cui la revocabilità incontra limiti (mandato
irrevocabile): ad esse s’ispira – nel silenzio della legge – anche la ricostruzione dei casi di procura
irrevocabile.
La procura è irrevocabile: quando è stata conferita (anche) nell’interesse del rappresentante o d’un
terzo; quando è procura collettiva; quando il rappresentato s’è impegnato a non revocarla.
Nella procura conferita anche nell’interesse del rappresentante (e/o di un terzo) deve trattarsi non di un
interesse generico ed amorfo, ma di un interesse qualificato, fondativo di una posizione giuridica
soggettiva.
Tuttavia la procura resta revocabile in due casi: quando il rappresentato abbia fatto espressa riserva di
revoca, e quando ricorra una giusta causa (come ad es. la negligenza o l’imperizia di cui il
rappresentante abbia dato prova).
La procura collettiva è quella conferita da più persone per un affare d’interesse comune, quando la
comunanza dell’interesse è tale per cui la sua realizzazione implica necessariamente la spendita del
nome di tutti.
Essa può venir revocata solo se tutti i rappresentanti concordano; non è invece ammissibile la revoca
del singolo rappresentato, perché l’estinzione del potere rappresentativo da lui conferito impedirebbe il
compimento dell’affare e così pregiudicherebbe l’interesse degli altri (1726).
La procura è irrevocabile se il rappresentato vi appone la clausola d’irrevocabilità (salvo che ricorra
giusta causa di revoca: 1723.1).
In realtà, la presenza della clausola sembra operare sul terreno della prova più che su quello della
sostanza: infatti essa fa presumere che la procura sia stata data anche nell’interesse del rappresentante o
di un terzo, e così esonera chi è interessato all’irrevocabilità dalla relativa prova.
La revoca di una procura irrevocabile è inefficace, e quindi lascia intatto il potere rappresentativo che
vorrebbe cancellare.
Non sembra che l’irrevocabilità della procura privi il rappresentato del potere di compiere
personalmente l’atto.
In ogni caso il rapporto di gestione può influenzare i margini di revocabilità della procura che vi
acceda, e le conseguenze della revoca.
Oltre che per revoca della procura, la rappresentanza si estingue anche per altre cause, cui il 1396.2
allude senza precisarle.
Alcune non pongono particolari problemi: scadenza del termine, avveramento di condizione risolutiva,
compimento senza residui dell’atto autorizzato; altre meritano qualche attenzione in più: rinuncia del
rappresentante, morte od incapacità sopravvenuta del rappresentante o del rappresentato, fallimento del
rappresentante o del rappresentato, estinzione del rapporto di gestione.
La rinuncia è atto unilaterale ricettizio: estingue il potere in quanto sia comunicata al rappresentato.
Si discute di altre conseguenze: sembra certo che se la rinuncia crea danni ingiusti a carico del
rappresentato, può scattare la responsabilità del rinunciante.
Anche qui dipenderà da come si configura il rapporto di gestione.
La rappresentanza si estingue per morte del rappresentato (estinzione, se è un ente), e per sua
sopravvenuta incapacità legale.
Non, però, se è conferita anche nell’interesse del rappresentante o di terzi (1723.2): in tal caso, morto il
rappresentato, il successivo atto del rappresentante potrà impegnare i suoi eredi.
Si estingue anche per morte del rappresentante, che ha ricevuto il potere sulla base di una fiducia del
rappresentato, che potrebbe non estendersi all’erede; e per sua incapacità sopravvenuta.
Certamente estingue la rappresentanza il fallimento del rappresentato, il cui patrimonio entra nella
gestione degli organi fallimentari.
È meno certo che lo stesso effetto derivi automaticamente dal fallimento del rappresentante, il cui
patrimonio non sarebbe toccato dall’esercizio della rappresentanza.
Vi è infine la possibilità che la rappresentanza si estingua per l’estinguersi del rapporto di gestione che
la sorregge: questa conseguenza è certa quando potere rappresentativo e rapporto di gestione derivino
dalla stessa, unitaria fonte negoziale; o quando ne sia evidente il collegamento.
Quanto meno intenso e netto si faccia il collegamento, tanto più la bilancia penderà verso l’esigenza di
proteggere l’affidamento dei terzi.
Il 1396.2 disciplina le conseguenze, verso i terzi, dell’estinzione della rappresentanza per cause diverse
dalla revoca: tali cause non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate, e la non
opponibilità fa sì che il contratto concluso dal rappresentante pur privato del potere sia efficace nei
rapporti fra rappresentato e terzo.
Per i più grava sul rappresentato l’onere di provare la mala fede del terzo o la colposità della sua
ignoranza.
Il 1396 è dettato per la rappresentanza volontaria; non s’applica alla rappresentanza legale degli
incapaci.
Quando la rappresentanza s’estingue, il rappresentante deve restituire al rappresentato l’eventuale
documento dal quale risultino i suoi poteri (1397).
In via di principio, il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce
direttamente effetto nei confronti del rappresentato solo se concluso nei limiti delle facoltà conferite al
rappresentante (1388); invece non produce tale effetto il contratto concluso al di fuori di tali limiti.
A maggior ragione non produce tale effetto il contratto concluso da un sedicente rappresentante, che in
realtà non ha alcun potere rappresentativo (difetto di rappresentanza in senso stretto).
Il difetto di rappresentanza ricorre quando il potere rappresentativo non è mai stato conferito, o quando
è stato conferito invalidamente (invalidità della procura); l’eccesso di rappresentanza implica
superamento dei limiti di un potere rappresentativo esistente.
Sia il difetto sia l’eccesso di rappresentanza sono assimilati sotto la categoria della rappresentanza
senza potere: in entrambe le ipotesi chi spende il nome altrui è un falso rappresentante, il titolare del
nome speso è un falso rappresentato.
Il contratto del falso rappresentante non vincola il falso rappresentato verso il terzo, né vincola il falso
rappresentante verso il terzo, perché il contratto è fatto in nome del falso rappresentato (il falso
rappresentante può essere vincolato verso il terzo, ma in via extracontrattuale, come responsabile per
danni).
Invece il contratto vincola il terzo contraente, come si ricava dalla previsione per cui il terzo ed il falso
rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica (1399.3).
Il contratto produce effetti vincolanti per il terzo, che di essi non può liberarsi per decisione unilaterale.
La natura del vincolo è propriamente di soggezione: il terzo non è obbligato ad eseguire la prestazione
contrattuale, ma è esposto a subire le decisioni del falso rappresentato sulla sorte del contratto.
Il contratto del falso rappresentante è, per le posizioni minoritarie, invalido; un’altra tesi lo considera
non perfezionato, evocando una fattispecie contrattuale a formazione progressiva che potrà
eventualmente completarsi solo con la ratifica del rappresentato.
L’inefficacia del contratto tutela il falso rappresentato.
Per questo può farsi valere solo da lui: non può rilevarsi d’ufficio; l’onere della prova segue lo schema
del 2697 (Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o
estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.).
Il principio dell’inefficacia del contratto conosce due ordini di eccezioni.
Un primo ordine comprende casi in cui il contratto produce effetti sul falso rappresentato: questi è
contrattualmente vincolato.
Vi rientrano tre fattispecie: due di fonte legale ed una di fonte giurisprudenziale.
La prima fattispecie di fonte legale riguarda i casi in cui l’estinzione o la riduzione del potere
rappresentativo non è opponibile ai terzi ex 1396; la seconda concerne la rappresentanza organica: gli
atti compiuti dagli amministratori in nome della società, al di là dei loro poteri rappresentativi,
vincolano la società; la fattispecie di matrice giurisprudenziale si fonda sul principio di apparenza: il
falso rappresentato è vincolato al contratto concluso dal suo rappresentante (falso ma) apparente.
In un altro ordine di eccezioni, l’atto produce effetti sul falso rappresentante; un caso riguarda negozi
unilaterali, e cioè l’emissione, la girata, l’avallo di una cambiale o di un assegno: chi appone la firma
sulla cambiale quale rappresentante d’una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato
cambiarmente come se avesse firmato in proprio; analogamente per l’assegno.
Un altro caso tocca il contratto di assicurazione: se un contraente stipula l’assicurazione in nome altrui
senza averne il potere, egli è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto nei
limiti indicati dal 1890 (Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere,
l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.
Il
contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in
cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa. Egli deve all’assicuratore i
premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica).
La ratifica (1399) è il negozio unilaterale del falso rappresentato – o del suo erede (1399.5) – con cui si
attribuisce efficacia al contratto (di per sé inefficace) concluso dal falso rappresentante.
La situazione è trattata come se il falso rappresentante fosse legittimato: il contratto vincola il
rappresentato.
La ratifica è atto ricettizio nei confronti del terzo contraente: produce il suo effetto in quanto a lui
comunicata dal falso rappresentante.
L’effetto specifico della ratifica, che ne rende necessaria la comunicazione al terzo contraente, non è
vincolarlo al contratto, perché il terzo è già vincolato; bensì è rendere il vincolo irrevocabile,
precludendo le possibilità di scioglimento del vincolo – per risoluzione concordata col falso
rappresentante, o per inutile decorso del termine assegnato in via interrogatoria al falso rappresentato –
che si danno prima della ratifica.
La ratifica è atto eventualmente formale, perché deve farsi con l’osservanza delle forme prescritte per
la conclusione del contratto da ratificare (1399.1).
Se la ratifica non ha forma vincolata, la relativa volontà negoziale può essere manifestata anche per
comportamenti concludenti (c.d. ratifica tacita).
Se ha forma vincolata – ad es. la scrittura – può essere sufficiente che la volontà di ratificare risulti da
un documento dell’interessato, ancorché non specificamente espressivo di tale volontà.
Nel periodo che precede la ratifica il falso rappresentato non è vincolato dal contratto, ed in questa
situazione può fare tre cose: rifiutare la ratifica: e in tal caso il contratto diventa definitivamente
inefficace per lui, ma anche non più vincolante per il terzo; o al contrario ratificare: così rendendo il
contratto vincolante per sé, e definitivamente vincolante per il terzo contraente; od infine una cosa
intermedia, e cioè né ratificare, né rifiutare la ratifica.
Il protrarsi di un siffatto attendismo del falso rappresentato pregiudica il terzo contraente: egli è
unilateralmente vincolato al contratto; a ciò si rimedia con il potere interrogatorio (o d’interpello)
offerto dal 1399.4: il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica
assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata.
L’essenzialità dell’assegnazione del termine rende molto problematico, se non impossibile, configurare
un interpello tacito, per fatti concludenti.
Di regola, la ratifica ha effetto retroattivo (1399.2): gli effetti del contratto ratificato si considerano
prodotti dal tempo della sua conclusione.
La retroattività non si spinge però ad azzerare posizioni del terzo contraente, legate ad un termine di
decadenza: se dal contratto ratificato nasce a favore del terzo contraente un’obbligazione principale
immediatamente esigibile, garantita da fideiussione, il termine semestrale ex 1957 decorre a suo carico
non dal tempo del contratto ma dal tempo della ratifica.
La retroattività della ratifica incontra un limite generale: restano comunque salvi i diritti dei terzi
(1399.2).
I terzi tutelati sono essenzialmente gli aventi causa a titolo particolare dal falso rappresentato.
La giurisprudenza vi comprende anche terzi i cui diritti verso il falso rappresentato si basino su un
titolo extranegoziale.
Terzi tutelati ex 1399.2 non sono né il falso rappresentato né il terzo contraente, e nemmeno chi
complessivamente subentri nella loro sfera giuridica, come gli eredi od il curatore fallimentare.
Devono anche escludersi gli aventi causa dal terzo contraente.
La ratifica può rendere efficaci anche gli atti unilaterali compiuti da un rappresentante senza poteri;
rispetto ad essi si pone soprattutto un problema: quando un atto del genere deve compiersi – nei
confronti di un controinteressato – entro un certo termine a pena di decadenza di un diritto
dell’interessato, quid se l’atto è compiuto (senza potere) entro il termine, ma la ratifica interviene fuori
termine?
La giurisprudenza oscilla.
La ratifica opera anche nel campo della rappresentanza organica, ma vi opera in un ambito reso limitato
dalla frequenza con cui atti compiuti senza potere in nome della società vincolano la società stessa, per
essere il difetto di rappresentanza inopponibile al terzo contraente ex 2384.
Nel caso di contratto concluso da rappresentante senza poteri, il terzo contraente può subire danni di
vario genere; il falso rappresentante ne risponde (1398): la sua responsabilità è extracontrattuale, e più
precisamente precontrattuale.
Il risarcimento riflette non l’interesse positivo del terzo contraente all’operazione inattuata, ma il suo
interesse negativo a non cadere in affidamenti fallaci sull’efficacia di un contratto che risulta invece
inefficace.
S’è deciso che non ricorre la responsabilità in discorso se il contratto presenta anche un altro vizio che,
non essendo sanabile con la ratifica, assorbe la mancanza di potere rappresentativo; comunque potrebbe
trovare spazio una responsabilità ex 1338.
Certamente la responsabilità non ricorre, per mancanza del danno considerato, se interviene la ratifica
ed il contratto diventa efficace (potrà ipotizzarsi, nel caso, un danno per il ritardo nell’operatività del
contratto).
La responsabilità del falso rappresentante implica il dolo o la colpa, ravvisabili quando egli sapeva o
doveva sapere di essere privo del potere rappresentativo.
La responsabilità del falso rappresentante scatta in relazione al danno che il terzo contraente ha sofferto
per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (1398: Colui che ha contrattato come
rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del
danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del
contratto, dove la “validità” evocata dal legislatore può leggersi come “efficacia”).
Cade in colpa il terzo che non si accorge della mancanza di poteri in capo a controparte quando
potrebbe e dovrebbe avvedersene con l’ordinaria diligenza.
A tal fine, il terzo ha un mezzo codificato: il potere di esigere, durante la trattativa col rappresentante,
che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una
copia da lui firmata (1393).
Ma la giurisprudenza svalorizza questo dato, così che l’omessa richiesta di giustificazione dei poteri
non configura di per sé colpa.
La massima giurisprudenziale – unita all’altra, per cui il dolo del falso rappresentante assorbe e rende
superfluo il requisito della mancanza di colpa del terzo – finisce per riscrivere la regola del 1398,
sostituendola con la diversa regola per cui il terzo ha sempre diritto al pieno risarcimento, a prescindere
dalla sua incolpevolezza.
In relazione alle circostanze, una responsabilità del falso rappresentante può ravvisarsi anche quando,
dopo una fase di trattative, il contratto non si concluda per il rifiuto del terzo, avvedutosi che il suo
interlocutore è senza poteri.
La rappresentanza apparente è una sottocategoria specifica e qualificata di rappresentanza senza potere,
e si caratterizza per questo: alla realtà della mancanza di poteri rappresentativi si sovrappone
un’apparenza creata da indici obiettivi (ancorché ingannevoli) che fanno apparire come esistenti i poteri
inesistenti.
Per indiscussa regola giurisprudenziale il contratto concluso dal falso rappresentante, che sia
qualificabile come rappresentante apparente, può essere efficace verso il falso rappresentato e
vincolarlo: l’apparenza qui surroga la legittimazione mancante.
È la stessa ratio per cui il pagamento al creditore apparente ha lo stesso effetto liberatorio che se fosse
fatto al vero creditore, legittimo destinatario del pagamento (1189.1), e per cui chi acquista da un
soggetto non legittimato a trasferire, ma apparentemente fornito della legittimazione in quanto erede
apparente (534.2) o titolare apparente per avere il possesso del bene mobile non registrato (1153.1) o
per averlo ricevuto in base a contratto simulato (1415.1), fa un acquisto efficace come se avesse
acquistato da soggetto legittimato.
La stessa disciplina positiva della rappresentanza ha una regola che riflette il principio di apparenza:
quella sull’efficacia del contratto concluso dopo l’estinzione dei poteri rappresentativi dall’ex
rappresentante, il quale tuttavia appaia ancora munito dei vecchi poteri (1396).
La regola sulla rappresentanza apparente opera nel concorso di due condizioni: in primo luogo occorre
che il falso rappresentato sia responsabile dell’apparenza che ha ingannato il terzo (apparenza colposa):
non avrebbe rilevanza la c.d. apparenza pura, creatasi senza colpa dell’interessato.
L’apparenza pura opera per il vero creditore, il vero erede, il vero proprietario nei casi regolati dagli
artt. 1189.1, 534.2, 1153.1.
Se è ravvisabile procura tacita, la rappresentanza poggia su un potere esistente, e dunque non ha senso
parlare di apparenza.
Occorre poi l’affidamento ragionevole ed incolpevole del terzo contraente; il criterio è quello
dell’ordinaria diligenza.
Dal fenomeno della rappresentanza vanno distinte alcune situazioni in cui la parte non dichiara di agire
per un altro soggetto, e tuttavia emette una dichiarazione contrattuale sotto nome altrui.
Un altro caso è l’atto di chi, in nome proprio, dispone del diritto altrui.
CAPITOLO XIII – FIGURE SPECIALI DI RAPPRESENTANZA
La rappresentanza organica è quella esercitata per gli enti, dalle persone fisiche che ne costituiscono gli
organi.
La disciplina della rappresentanza organica varia, in relazione al tipo di ente interessato.
In passato si dubitava che potesse parlarsi di vera e propria rappresentanza, perché quest’ultima sarebbe
caratterizzata dall’alterità soggettiva del rappresentante rispetto al rappresentato, mentre l’organo
dell’ente è un elemento costitutivo dell’ente stesso (c.d. teoria dell’immedesimazione organica); oggi si
dice che la rappresentanza organica è vera rappresentanza, e ad essa si applicano gli artt. 1387 ss.
Tuttavia in qualche misura il regime della rappresentanza organica si differenzia da quello della
rappresentanza volontaria di diritto comune: ad es., mentre in quest’ultima l’illecito del rappresentante
non è di per sé imputabile al rappresentato, l’illecito dell’organo è per ciò stesso illecito dell’ente.
Negli enti, accanto ai poteri di rappresentanza, esistono poteri di amministrazione: i due ordini di poteri
sono distinti e non necessariamente coincidenti.
L’amministrazione ha rilevanza interna, riguarda la formazione della volontà dell’ente; la
rappresentanza ha rilevanza esterna, riguarda la manifestazione della volontà dell’ente verso i terzi.
Gli enti, ed in particolare le società, hanno – scritto nell’atto costitutivo – un oggetto sociale che
definisce l’ambito della loro attività, e dunque dei contratti che possono farsi in loro nome.
Se la nomina di un amministratore-rappresentante è invalida, il soggetto è privo di poteri
rappresentativi, e gli atti da lui compiuti per la società dovrebbero essere inefficaci: ma l’invalidità
della nomina è inopponibile ai terzi di cui non si provi la mala fede (2383.5).
Se l’atto costitutivo limita i poteri rappresentativi degli amministratori-rappresentanti, gli atti compiuti
oltre i limiti sono compiuti senza potere: e tuttavia i limiti sono inopponibili ai terzi, salvo che si provi
qualcosa di più della loro mala fede, e cioè che abbiano intenzionalmente agito a danno della società
(2384.2: Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione
degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi
abbiano intenzionalmente agito a danno della società).
Se è invalida la delibera necessaria per autorizzare un determinato atto, l’atto successivamente
compiuto dall’organo che rappresenta la società è compiuto senza poteri: ciononostante sono salvi i
diritti acquistati in buona fede dai terzi per effetto dell’atto stesso (2377.6).
S’è ravvisata una deroga all’ordinario meccanismo rappresentativo anche nel fenomeno della società
occulta, sotto il profilo che il socio occulto sarebbe impegnato dall’agire dell’altro pur in assenza di
spendita del nome sociale.
Ma proprio la mancanza di spendita del nome impedisce di ricondurre la fattispecie all’area della
rappresentanza.
Un ente può, attraverso la deliberazione e l’atto dei suoi organi competenti, attribuire poteri
rappresentativi a soggetti diversi da quelli che ne impersonano gli organi (c.d. procuratori della
società); con due precisazioni: che i poteri non possono riguardare la generalità degli affari sociali, e
che si tratta di rappresentanza non organica, ma di diritto comune.
Ulteriori e diverse specificità connotano il regime della rappresentanza organica quando questa
riguarda non enti privati (quali le società), ma enti pubblici.
Un fenomeno analogo ricorre nelle organizzazioni non entificate: si pensi alla rappresentanza del
condominio da parte dell’amministratore (1131).
Apposita disciplina è dettata per la rappresentanza dell’imprenditore commerciale da parte di suoi
collaboratori aziendali: institori, procuratori e commessi (2203-2213); anche la rappresentanza in
esame è, come quella organica, rappresentanza gestoria.
L’institore è la figura coi poteri più ampi: al potere gestorio generale, proprio di chi è preposto
all’esercizio dell’intera impresa o di un ramo o di una sede di questa (2203), la legge automaticamente
associa il potere rappresentativo sostanziale di compiere tutti gli atti dell’impresa a cui è preposto, con
la sola esclusione degli atti diretti ad alienare od ipotecare immobili; nonché la relativa rappresentanza
processuale (2204).
L’interessato può limitare tali poteri (2204, che parla di “limitazioni contenute nella procura”: formula
impropria, perché fonte dei poteri rappresentativi dell’institore non è un’apposita procura, ma lo stesso
atto di attribuzione dell’incarico institorio); così come può successivamente ridurli o revocarli.
Ma le limitazioni e la revoca sono opponibili ai terzi solo se osservano precisi requisiti formali e
pubblicitari, ed in particolare se vengono iscritte nel registro delle imprese; in mancanza di
pubblicazione, non sono opponibili se l’imprenditore non prova che i terzi le conoscevano al momento
del contratto (2206.2; 2207.2).
Se l’institore non spende il nome dell’imprenditore interessato, secondo i principi si obbliga in proprio
verso il terzo contraente.
Ma se l’atto è pertinente all’esercizio dell’impresa, anche l’imprenditore è vincolato (2208).
I procuratori, in base ad un rapporto continuativo con l’imprenditore, hanno il potere di gestirne gli
affari, agendo in suo nome.
Le limitazioni e la revoca dei loro poteri rappresentativi sono opponibili ai terzi negli stessi limiti già
visti per l’institore (2210).
I commessi hanno rapporti con l’ordinaria clientela dell’impresa (commessi di negozio, sportellisti
bancari, etc.).
I loro poteri rappresentativi sono definiti dagli artt. 2210-2213.
La gestione di affari altrui crea gli effetti giuridici di cui agli artt. 2028 ss., nel concorso di alcuni
requisiti; essi sono: l’impedimento dell’interessato ad intervenire; la consapevolezza del gestore di
operare non nel proprio interesse, ma di curare un interesse altrui; la spontaneità dell’intervento, e cioè
la consapevolezza che questo non è legalmente dovuto; l’utilità iniziale della gestione.
La compresenza di tali requisiti fa scattare gli effetti giuridici, che essenzialmente consistono nella
nascita di obbligazioni reciproche fra gestore ed interessato: infatti la gestione di affari altrui si
annovera fra le fonti di obbligazioni comprese nella formula che il 1173 indica in via negativa e
residuale (Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a
produrle in conformità dell’ordinamento giuridico).
Se la fattispecie comprende la spendita del nome dell’interessato da parte del gestore, si produce un
effetto ulteriore: nascono direttamente obbligazioni dell’interessato verso il terzo con cui il gestore ha
contrattato in nome dell’interessato stesso (2031.1).
La fonte del potere rappresentativo non è la volontà dell’interessato, ma la legge.
Se i requisiti non fossero tutti presenti, l’agire del gestore in nome dell’interessato sarebbe un caso di
falsa rappresentanza.
La norma parla solo di obbligazioni assunte dal gestore in nome dell’interessato, ma si ammette che il
meccanismo della gestione di affari rappresentativa possa produrre anche effetti di altra natura, ed in
particolare effetti reali.
Il contratto per persona da nominare è il contratto in cui una parte (detta stipulante) si riserva la facoltà
di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi del
contratto stesso (1401).
Dopodiché i casi sono due: o la nomina non viene fatta, ed allora gli effetti del contratto si producono
in capo allo stipulante, od al contrario viene fatta, ed allora gli effetti contrattuali si producono in capo
al nominato.
La situazione nel secondo caso è quella di un contratto concluso dal rappresentante in nome del
rappresentato.
L’impiego di questo strumento è precluso nei contratti i cui effetti non possono prodursi se non nei
confronti delle parti che li concludono: così non potrebbe concludersi per persona da nominare il
contratto fra X ed Y, diretto a sciogliere o modificare un precedente contratto fra X ed Y.
La riserva di nomina può contenere limiti soggettivi: ad es., la società H contrae con K, riservandosi di
nominare al proprio posto altra società del medesimo gruppo.
Ed anche limiti oggettivi: ad es. prevedendo che all’eventuale nominato s’imputeranno solo alcuni
effetti del contratto, e non altri (che resteranno in capo allo stipulante).
Concluso il contratto con la riserva di nomina, esso è immediatamente efficace fra lo stipulante e
controparte: durante la pendenza del termine gli effetti non sono definitivamente consolidati in capo
allo stipulante, restando aperta l’eventualità che – con la nomina di altro soggetto – gli effetti si
spostino in capo a questo.
Secondo un’altra tesi gli effetti, che si producono subito verso lo stipulante, sono soggetti alla
condizione risolutiva della nomina: intervenuta la quale, l’originario contratto fra stipulante e
controparte diventerebbe inefficace per essere sostituito da un secondo contratto fra l’originaria
controparte ed il nominato.
Coglie nel segno la dottrina che parla di rappresentanza eventuale in incertam personam,
rappresentanza perché ricorrono tutti gli elementi essenziali del meccanismo rappresentativo,
rappresentanza solo eventuale perché non è sicuro che la nomina ci sarà.
Lo stipulante è parte del contratto: la sua incapacità od il vizio della sua volontà invalidano il contratto,
che potrà essere per questo impugnato da lui prima della nomina, e dopo questa dal nominato.
La nomina è l’atto (negozio) unilaterale con cui lo stipulante indica il diverso soggetto a cui vengono
imputati gli effetti del contratto.
È atto ricettizio: produce effetti in quanto comunicata a controparte (1402.1).
È atto (eventualmente) formale: deve rivestire “la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto,
anche se non prescritta dalla legge” (1403.1).
È atto il cui compimento soggiace ad un termine: la nomina va comunicata entro il termine previsto
dalle parti; o, in mancanza di previsione convenzionale, nel termine legale di tre giorni (1402.1).
La nomina tardiva non sposta gli effetti contrattuali sul nominato.
La nomina non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non
esiste una procura anteriore al contratto (1402.2).
L’accettazione non può essere in bianco, ma deve fare puntuale riferimento al contratto già concluso, e
deve accompagnare la nomina (si ammette anche la comunicazione separata dei due atti, purché per
entrambi tempestiva).
Si discute se possa essere parziale.
Se si tratta di atto anteriore al contratto, e si presenta come procura allo stipulante, l’oggetto di questa
deve comprendere, a pena d’inefficacia, il contratto successivamente stipulato.
Se si presenta come accettazione o come procura, l’atto deve avere la stessa forma della nomina, e cioè
la forma usata per il contratto (1403.1).
La persona nominata acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal
momento in cui questo fu stipulato (1404).
Prima della nomina titolare delle posizioni contrattuali era lo stipulante, che potrebbe averne disposto o
potrebbe averne subito l’aggressione.
Il conseguente conflitto fra terzi acquirenti o creditori da una parte, e nominato dall’altra, si risolve in
base al 1155 (se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse
che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data
posteriore) se sono in gioco mobili non registrati; in base all’operare dei meccanismi pubblicitari se si
tratta di immobili o mobili registrati.
Può accadere che la posizione contrattuale che il nominato acquisisce per effetto della nomina non lo
soddisfi: se egli lamenta una violazione del contratto, imputabile a controparte, agisce nei confronti di
questa.
Se il contratto in cui il nominato subentra risulta difforme da quello prefigurato nell’ambito del
rapporto fra lui e lo stipulante, su tale rapporto il nominato può fondare un’azione contro lo stesso
stipulante.
Se la nomina non interviene tempestivamente, il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari
(1405).
Lo stesso accade se, pur fatta tempestivamente, manca di qualche altra condizione di efficacia; oppure
se è invalida: in quest’ultimo caso, lo stipulante impugnerà la nomina (convenendo il nominato e
controparte) per riappropriarsi degli effetti contrattuali.
Può accadere l’inverso, quando invalida sia l’accettazione del nominato: in tal caso, il risultato finale è
pur sempre che gli effetti del contratto si fissano sullo stipulante, ma questa volta per iniziativa del
nominato che impugna la propria accettazione nei confronti di controparte e dello stipulante.
Il contratto per conto di chi spetta è quello concluso da un soggetto (stipulante) che dichiara di
contrarre non per sé, ma per altro soggetto attualmente non identificato ma che risulterà identificabile
in quanto titolare di una determinata situazione giuridica, al momento incerta.
Alcune figure sono legislativamente previste.
Quando fra compratore e venditore si litiga su vizi della cosa che potrebbero determinare la risoluzione
della vendita, è incerto se la proprietà tornerà al venditore (in caso di risoluzione) o resterà al
compratore (nel caso di mancata risoluzione): laddove necessario il giudice può disporne la vendita, e
questa sarà fatta “per conto di chi spetta”.
Se in un trasporto di cose sorge controversia fra diversi soggetti che affermano il proprio diritto alla
riconsegna, e si tratta di cose deperibili, il vettore può farle vendere “per conto dell’avente diritto”, cioè
per chi poi risulterà il vero destinatario (1690.2).
Qui la rappresentanza non è eventuale, inoltre l’identità del rappresentato è indeterminata ed
indeterminabile nel contratto per persona da nominare, mentre qui indeterminata ma determinabile.
È inammissibile (al di fuori di una riserva di nomina ex 1401) la rappresentanza di soggetto
indeterminato ed indeterminabile.
La legge prevede l’assicurazione per conto di chi spetta (1891), ma la figura è diversa: infatti parte del
contratto è e resta lo stipulante, personalmente vincolato agli obblighi contrattuali.
Ad essere indeterminato (ma determinabile) è il beneficiario del contratto, che peraltro non ne diventa
parte (secondo lo schema del contratto a favore di terzo).
Parte degli interpreti riconduce al concetto di rappresentanza indiretta le fattispecie in cui un soggetto
agisce per conto e nell’interesse di un altro, che l’ha incaricato di farlo – ma in nome proprio.
Ne è prototipo il contratto di mandato senza rappresentanza (1705: il mandatario che agisce in proprio
nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi
hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il
mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del
mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli
articoli che seguono).
Se il mandato è con rappresentanza, all’obbligo del mandatario di compiere atti per il mandante
s’accompagna il suo potere di compierli in nome dello stesso.
Se il mandato è senza rappresentanza il mandatario non è autorizzato ad agire in nome del mandante,
ma può agire solo in nome proprio (i terzi non hanno alcun rapporto col mandante: 1705.2); è il
mandatario che acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi (1705.1).
Ciò si verifica anche se i terzi hanno avuto conoscenza del mandato.
In caso d’inadempimento il mandante può conseguire il risultato atteso mediante il rimedio della
sentenza costitutiva ex 2392, con cui si realizza l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di
contrarre (1706.2).
È ragionevole che questa obbligazione sia reciproca: il mandatario ha anche diritto di spogliarsi dei
beni che ha acquistato, senza avervi personale interesse, per conto del mandante, il quale è perciò
obbligato a prestarsi all’atto di trasferimento; se non vi si presta, il mandatario può azionare contro di
lui il 2392.
L’atto di ritrasferimento implica che i beni non escano dal patrimonio del mandatario per entrare in
quello di terzi diversi dal mandante: a tutela di quest’ultimo la legge li sottrae alle pretese dei creditori
del mandatario, nei limiti ed alle condizioni di cui al 1707 (I creditori del mandatario non possono far
valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome
proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa
anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici
registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda
giudiziale diretta a conseguirlo).
Il mandante pare invece senza difese contro il terzo acquirente, cui il mandatario infedele abbia
trasferito il bene destinato a lui.
Per i mobili non registrati e per i crediti opera un meccanismo diverso che deroga al principio
dell’assenza di rapporti diretti fra mandante e terzi.
Quanto ai diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, il mandante, sostituendosi al
mandatario, può esercitarli contro i terzi debitori (1705.2).
Quanto ai mobili non registrati, acquistati dal mandatario in proprio nome, la legge dice che il
mandante può direttamente rivendicarli (1706.1).
Gli interpreti si affaticano a spiegare questi effetti diretti del mandato senza rappresentanza, prevale la
teoria del c.d. doppio trasferimento automatico, secondo cui per effetto dell’atto del mandatario beni e
crediti entrano nel suo patrimonio, per immediatamente uscirne ed entrare nel patrimonio del mandante.
Presupposto della disciplina illustrata è che il mandatario (senza rappresentanza) agisca in nome
proprio; se invece egli, arrogandosi poteri che non ha, agisce in nome del mandante, ricorre un caso di
falsa rappresentanza.
PARTE TERZA – IL REGOLAMENTO
CAPITOLO XIV – IL REGOLAMENTO CONTRATTUALE
Il contratto ha la funzione di creare regole che i privati contraenti impongono a sé medesimi.
Il complesso delle regole create dal contratto è il regolamento contrattuale: il 1321 indica fra gli scopi
del contratto proprio quello di regolare rapporti fra le parti.
La formula “regolamento contrattuale” porta a sintesi una serie di elementi, essenzialmente quelli che il
1325 chiama i requisiti del contratto: accordo, causa, oggetto e forma; e poi gli effetti del contratto.
L’essenza del contratto è la sistemazione degli interessi delle parti.
L’oggetto del contratto è costituito dalle prestazioni contrattuali.
La causa del contratto è la ragione giustificativa delle prestazioni contrattuali.
Gli effetti del contratto sono le trasformazioni che il contratto determina nelle posizioni giuridiche delle
parti.
Conformemente alla sua patrimonialità, il contratto serve a realizzare spostamenti di ricchezza.
Gli spostamenti di ricchezza parlano al tempo stesso di oggetto del contratto, perché corrispondono alle
prestazioni contrattuali; poi di causa del contratto, che è precisamente la ragione giustificativa degli
spostamenti di ricchezza determinati da questo; ed infine di effetti del contratto.
L’accordo è il fatto che costituisce il contratto.
Il regolamento contrattuale è vincolo: con esso le parti si vincolano reciprocamente.
Ma il vincolo non sarebbe conforme all’autonomia privata se non fosse voluto da chi viene a subirlo.
È dunque l’accordo che definisce il regolamento contrattuale come meccanismo dell’autonomia
privata.
Il testo contrattuale è la fonte di cognizione del regolamento contrattuale.
CAPITOLO XV – L’OGGETTO DEL CONTRATTO
La legge indica l’oggetto fra i requisiti del contratto (1325 n. 3); precisa quali requisiti esso deve a sua
volta presentare (1346), ma non lo definisce.
È forte, in prima battuta, la tentazione d’identificare l’oggetto del contratto col bene toccato dagli effetti
contrattuali.
Ciò sembra ricevere qualche avallo dal legislatore: che per es. parla di alberi o frutti di un fondo come
di un possibile oggetto della vendita (1472.1).
Ma nessun bene, per es., è coinvolto in un contratto di lavoro subordinato, od in un patto di non
concorrenza.
Inoltre è fuorviante una nozione che porterebbe a concludere che l’oggetto del contratto è il medesimo
in una vendita, in una costituzione di usufrutto ed in una locazione.
Per cogliere a fondo il senso del contratto rispetto al bene occorre andare oltre il nudo bene per
afferrare il bene dovuto: cioè il bene per come è dovuto in base al contratto, per come è dedotto nella
prestazione contrattuale.
Così concepito, l’oggetto del contratto s’identifica con le prestazioni contrattuali, identificazione che
trova sostegno nel linguaggio del legislatore: il 1347 è rubricato “Possibilità sopravvenuta
dell’oggetto”, e nel testo parla di “prestazione di cose future”; la rubrica del 1349 è “Determinazione
dell’oggetto”, ma il testo parla di “determinazione della prestazione”.
Il linguaggio legislativo evoca la prestazione anche a proposito dell’obbligazione, presentandola come
oggetto di questa (1174); l’impiego dello stesso termine per definire l’oggetto dell’obbligazione e
l’oggetto del contratto è probabilmente retaggio della fase in cui il contratto era concepito
essenzialmente come fonte di obbligazioni, e non di altri effetti giuridici.
Ma i due concetti di prestazione non coincidono: la prestazione contrattuale è una realtà più ampia
rispetto alla prestazione dedotta in obbligazione.
O meglio: se un contratto ha effetti solo obbligatori, può ammettersi che l’una assorba l’altra.
Non così tutte le volte che il contratto abbia effetti costitutivi di diritti reali o traslativi di diritti:
l’attribuzione della proprietà non è materia di obbligazione, non è prestazione ex 1174, ma prestazione
contrattuale, ed è oggetto della vendita.
Nei contratti a prestazioni corrispettive può accadere che una prestazione sia materia di obbligazione,
mentre la controprestazione esula dal campo obbligatorio: nondimeno entrambe sono prestazioni
contrattuali, formanti oggetto del contratto.
Il discorso sull’oggetto del contratto incrocia problematiche relative alla teoria dei beni, come quelle
delle nuove proprietà (ad es., l’informazione come bene), e della dematerializzazione di beni
tradizionalmente materiali.
C’è un’altra nozione, che tutti avvicinano a quella di oggetto, e molti identificano con essa: la nozione
di contenuto del contratto.
La si ritrova in alcuni luoghi del codice: ad es. nel 1322.1 (dove si dice che le parti possono
liberamente determinare il contenuto del contratto), e nel 1419 (dove si regola l’ipotesi che la nullità
colpisca parte del contenuto contrattuale).
Ma le due nozioni meritano di essere distinte.
Il contenuto del contratto è l’oggetto del contratto qualificato dalla causa, è la prestazione contrattuale
illuminata dalla ragione che la giustifica.
Se si considerano la vendita e la donazione di uno stesso bene, può dirsi che esse hanno identico
oggetto, perché identica è in esse la prestazione contrattuale (l’attribuzione in proprietà del bene).
Ma diverso è il contenuto contrattuale: nella vendita è l’attribuzione in quanto onerosa, nella donazione
è l’attribuzione in quanto gratuita.
Il 1346 indica che la prestazione contrattuale dev’essere possibile, lecita, determinata o determinabile.
Sono gli stessi requisiti che la teoria dell’obbligazione riferisce alla prestazione dedotta ad oggetto di
questa (aggiungendovi il requisito della patrimonialità ex 1174).
La rilevanza dei requisiti dell’oggetto del contratto è essenzialmente negativa: chi è interessato alla
nullità del contratto può ottenerla provando che il suo oggetto è impossibile, illecito, indeterminato e
indeterminabile.
La “possibilità” come requisito dell’oggetto contrattuale è solo la possibilità originaria; dunque solo
l’impossibilità originaria rende il contratto nullo.
Se la prestazione contrattuale, originariamente possibile, diventa impossibile in seguito, il contratto
nato valido resta valido, e l’impossibilità sopravvenuta potrà se mai determinarne la risoluzione: con
l’ulteriore conseguenza eventuale – se l’impossibilità sopravvenuta sia imputabile al contraente tenuto
alla prestazione – della sua responsabilità per inadempimento.
Per determinare nullità deve trattarsi d’impossibilità oggettiva ed assoluta, non sarebbe invece
sufficiente una impossibilità soggettiva e relativa, ovvero dipendente dall’inadeguatezza delle qualità e
dei mezzi del contraente impegnato o dalle particolari condizioni in cui si trova ad operare.
Ratio: o i contraenti conoscevano la situazione, ed allora non hanno inteso impegnarsi seriamente; o
non la conoscevano, ma se l’avessero conosciuta non avrebbero fatto il contratto.
Alla nullità può seguire una responsabilità precontrattuale ex 1338: a carico della parte che conosceva o
doveva conoscere l’impossibilità, ed a favore dell’altra, purché questa per contro non la conoscesse né
dovesse conoscerla.
Se l’impossibilità è soggettiva e relativa, per il suo trattamento si deve distinguere a seconda che sia
originaria o sopravvenuta.
Se è sopravvenuta e non era prevedibile al tempo del contratto, le moderne teorie della responsabilità
contrattuale insegnano che essa libera la parte impegnata tutte le volte che per porvi rimedio questa
avrebbe dovuto caricarsi d’uno sforzo eccedente quello che – secondo ragionevolezza e buona fede – si
poteva esigere da lei.
Se invece quella stessa impossibilità esisteva già al tempo del contratto, il metro per valutare la
posizione della parte tenuta alla prestazione (originariamente) impossibile dev’essere più severo.
L’impossibilità è oggettiva ed assoluta, se risale a cause fisiche o tecniche.
Ma può essere anche impossibilità giuridica, se la prestazione è ostacolata da una norma.
Non è giuridicamente impossibile la prestazione di attribuire la proprietà di un bene di cui il disponente
non ha la proprietà: la vendita di cosa altrui è valida e genera un’obbligazione od una garanzia a carico
del disponente (1478 ss.).
Per rendere nullo il contratto, l’impossibilità dell’oggetto deve non solo esistere al tempo del contratto,
ma anche persistere fino a quando il contratto – inizialmente inefficace per essere sottoposto a termine
o condizione sospensiva – acquisti efficacia: se la prestazione inizialmente impossibile diventa
possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine, il contratto è valido
(1347).
Anche nel caso inverso (prestazione inizialmente possibile, che diventa impossibile in pendenza
d’inefficacia del contratto), il contratto resta valido: ma naturalmente è risolubile.
Il contratto è nullo quando le parti contrattano l’attribuzione di un bene la cui esistenza si dà per
scontata, ma che in realtà non esiste.
Ne consegue la restituzione del prezzo eventualmente già pagato all’alienante e, se questi sapeva
dell’inesistenza, la sua responsabilità precontrattaule ex 1338.
Quando però il bene da attribuire sia un credito che risulta poi inesistente, allo schema della nullità si
sovrappone la diversa disciplina del 1266 (Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a
garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma
il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia
è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione.).
Non così quando il contratto ha ad oggetto la prestazione di beni futuri.
Prestare un bene futuro non è una prestazione impossibile, perciò i casi di esclusione legale del
contratto su beni futuri (ad es. della donazione ex 771.1) danno luogo a nullità non per impossibilità,
ma per illiceità dell’oggetto.
Il problema fondamentale è individuare il trattamento dei casi in cui il bene non viene ad esistenza (o
viene ad esistenza in termini quantitativamente o qualitativamente inferiori alle aspettative): esso è
affrontato, per la vendita, dal 1472 (Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della
proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i
frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la
cosa non viene ad esistenza.).
Il contratto può contemplare l’obbligo del promittente di operare positivamente per la produzione del
bene futuro da prestare; in un caso del genere, si fa molta fatica ad applicare la regola per cui la vendita
è nulla, se la cosa non viene ad esistenza (1472.2): è difficile non ravvisare nel fattore in esame un vero
e proprio inadempimento, di fronte al quale il rimedio tipico è la risoluzione congiunta al risarcimento
del danno contrattuale (o la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, senza risarcimento, se la
mancata produzione del bene non sia imputabile all’obbligato).
Il 1472.2 distingue fra due ipotesi: la prima è che le parti abbiano inteso concludere un contratto non
aleatorio, che definisca con certezza il diritto alla prestazione, e l’entità di questa (c.d. emptio rei
speratae): in tal caso, la mancata produzione del bene determina la nullità del contratto; la seconda
ipotesi è che invece le parti abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, affidando alla sorte
l’esistenza e la consistenza del diritto alla prestazione (emptio spei): la mancata produzione del bene da
prestare lascia valido il contratto, e non v’è luogo a ripetizioni e risarcimenti.
Il 1346 dice che l’oggetto del contratto dev’essere lecito, ma non indica i criteri della qualificazione.
Vi provvede il 1343 con una norma dedicata alla causa, ma certamente applicabile anche all’oggetto:
ne risulta che l’oggetto è illecito quando è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico od al buon
costume.
I tre parametri dell’illiceità esprimono un giudizio di riprovazione od indesiderabilità sociale.
Può esservi incertezza di confini fra illiceità ed impossibilità giuridica dell’oggetto.
Possono fissarsi questi criteri di massima: l’oggetto è illecito quando la prestazione dedotta in contratto
è direttamente vietata per sé stessa (da norme penali o non penali) o quando la prestazione, pur non
vietata in sé, è direttamente strumentale ad un risultato vietato.
Invece l’oggetto è giuridicamente impossibile quando non è la prestazione ad essere strumentale al
risultato proibito dalla legge, ma è il risultato proibito ad essere strumentale alla prestazione, che ne
dipende.
L’oggetto del contratto è determinato quando la prestazione contrattuale è definita in modo sufficiente
affinché il destinatario sappia cosa può pretendere, e la parte tenuta sappia cosa deve prestare.
L’oggetto è indeterminato quando la prestazione non è definita in qualche suo aspetto rilevante.
Il requisito della determinatezza può essere surrogato da quello della determinabilità; i modi per
determinare la prestazione non determinata al tempo del contratto sono essenzialmente tre: può esserci
determinabilità convenzionale: le parti, nello stesso contratto ad oggetto indeterminato, indicano gli
elementi da cui ricavare la successiva determinazione (si parla, al riguardo, di determinazione per
relationem).
Quando il termine della relatio è la valutazione di un terzo appositamente incaricato, ricorre la figura
dell’arbitraggio.
Può esservi determinabilità legale: di essa deve propriamente parlarsi solo quando la legge indica criteri
esterni, come il “prezzo normalmente praticato dal venditore” o i “listini” del 1474.
Quando invece la prestazione, lasciata indefinita dalle parti, è definita direttamente dalla legge stessa –
come nel caso del luogo di consegna ex 1510.1 – allora l’oggetto non è determinabile, ma senz’altro
determinato.
Può esservi determinabilità legale/giudiziale: mancando gli elementi cui in prima battuta la legge affida
la determinazione dell’oggetto, lasciato indeterminato dalle parti, la legge stessa rimette la
determinazione al giudice.
Il contratto con oggetto determinabile per relationem è quello che non determina la prestazione
contrattuale, ma indica gli elementi che la rendono determinabile.
Si presuppone che tali elementi siano esterni al contratto, perché se appartenessero al contratto questo
determinerebbe direttamente il proprio oggetto.
Gli elementi – esterni al contratto – cui il contratto per relationem rinvia possono essere eventi naturali
o comunque obiettivi; oppure fatti umani, ed in tal caso comportamenti materiali, od atti giuridici, o
veri e propri negozi.
Il problema più dibattuto circa il contratto per relationem riguarda la forma: se il contratto è a forma
vincolata, è ammissibile che il suo oggetto sia determinato in base ad elementi che, in quanto esterni al
contratto, non ne condividono la forma?
Questa possibilità deve ammettersi.
Dato un contratto formale, sottoscritto dalle parti, anche gli allegati che esso richiama devono essere
autonomamente sottoscritti se questi sono necessari per definire sostanzialmente la prestazione, che il
contratto non identifica nemmeno nelle linee essenziali; non devono esserlo se invece l’essenza della
prestazione è già determinata nel contratto, e gli allegati si limitano a precisarne qualche aspetto.
Quando il contratto per relationem indica nella valutazione di un terzo, appositamente incaricato,
l’elemento che renderà determinato l’oggetto attualmente solo determinabile, si ha l’arbitraggio.
Occorre che il terzo (detto arbitratore) abbia ricevuto dalle parti l’incarico di determinare la prestazione
contrattuale, e che ciò egli faccia proprio in relazione all’incarico.
La possibilità di affidare la determinazione dell’oggetto ad un terzo arbitratore incontra limiti.
Limiti specifici, come quelli posti in tema di donazione (778); e limiti più generali, discendenti dal
senso stesso dell’atto di autonomia privata.
Così, non sembra ammissibile che sia un terzo a determinare totalmente la prestazione contrattuale, di
cui le parti non abbiano indicato almeno qualche elemento d’identificazione.
La natura giuridica dell’atto di arbitraggio è discussa.
Secondo una tesi, sarebbe un atto negoziale, compiuto dall’arbitratore in rappresentanza delle parti che
l’hanno incaricato; la tesi non persuade: l’arbitratore non sostituisce le parti nella creazione del vincolo
contrattuale, ed il suo atto non è negoziale, perché non lo sorregge l’intento di disporre né della sfera
delle parti né tanto meno della propria.
Secondo una tesi diametralmente opposta, l’atto rileverebbe come semplice fatto o comportamento del
terzo, nella sua materialità: ma anche questa tesi è debole, perché non si concilia con l’impugnabilità
dell’atto (non essendo impugnabile un fatto o comportamento materiale).
Sembra preferibile la tesi per cui l’atto di arbitraggio non è un negozio, ma un mero atto giuridico.
L’arbitraggio non va confuso con l’arbitrato: quest’ultimo può essere rituale (ed allora è un vero e
proprio giudizio, attraverso cui gli arbitri decidono una lite con un lodo che ha valore sostanziale di
sentenza); oppure irrituale.
Con l’arbitrato irrituale gli arbitri, incaricati dalle parti di definire una lite sorta fra esse, vi provvedono
mediante un lodo che determina le posizioni delle parti.
La natura sostanziale del lodo irrituale non è di sentenza, ma di negozio transattivo posto in essere dagli
arbitri ma vincolante per le parti.
All’arbitraggio ed all’arbitrato irrituale si accosta una terza figura, che la giurisprudenza denomina
perizia contrattuale.
Essa ricorre quando le parti incaricano uno o più terzi, qualificati da specifica competenza, di formulare
una valutazione tecnica il cui risultato le parti s’impegnano ad accettare quale fonte di regolazione del
loro rapporto.
L’incarico all’arbitratore può basarsi su due logiche diverse, relative al modo in cui le parti chiedono al
terzo di svolgere la sua valutazione: la logica dell’equo apprezzamento e la logica del mero arbitrio.
La determinazione secondo equo apprezzamento è quella per cui il terzo deve determinarsi mediante
l’equilibrato e razionale impiego di criteri obiettivi, tenendo conto delle circostanze rilevanti che
specificamente connotano il caso concreto; e deve rendere controllabile il rispetto di questo modo di
procedere, esplicitando le motivazioni della propria scelta.
È il genere di determinazione considerato normale dalla legge, che lo presume in mancanza di diversa
statuizione delle parti (1349.1).
La determinazione secondo mero arbitrio significa che le parti – in ragione della speciale fiducia che
ripongono nel terzo – lo esonerano dal seguire un iter logico rigorosamente fondato su criteri obiettivi e
razionali; e lo autorizzano a scelte che possono anche apparire razionalmente non motivate.
Nel caso in cui manca la determinazione del terzo, se il terzo doveva procedere con equo
apprezzamento, la determinazione non fatta da lui viene fatta dal giudice (1349.1, secondo periodo); se
invece l’arbitratore era autorizzato a procedere secondo mero arbitrio, la sostituzione ad opera del
giudice non è possibile.
Ed allora i casi sono due: o le parti si accordano per sostituirlo con un altro arbitratore, ed il contratto
resiste, oppure non si accordano, ed il contratto è nullo perché il suo oggetto risulta indeterminabile
(1349.2).
La seconda ipotesi è che la determinazione del terzo vi sia, ma risulti affetta da un vizio: in tal caso, la
parte insoddisfatta di essa può impugnarla.
Rileva anche qui la natura della determinazione: se è determinazione da farsi con equo apprezzamento,
la si può impugnare ove sia manifestamente iniqua o erronea; accolta l’impugnativa, la determinazione
del terzo è resa inefficace e sostituita da quella del giudice, immune da vizi (1349.1, secondo periodo).
Se la determinazione è invece affidata al mero arbitrio del terzo, la possibilità d’impugnativa è
circoscritta: non può farsi se non provando la sua mala fede (1349.2).
Azzerata la sleale determinazione del terzo, l’impossibilità che il suo mero arbitrio sia surrogato dalla
valutazione giudiziale porta seco la nullità del contratto.
Si discute se la determinazione del terzo sia attaccabile per le stesse cause che consentono d’impugnare
i negozi (incapacità, vizi del volere).
La risposta è tendenzialmente negativa: la specifica disciplina del 1349, quanto ai presupposti
dell’impugnativa, assorbe e neutralizza quella più generale degli artt. 1425 ss.
Quanto alla forma dell’atto di arbitraggio, una vecchia giurisprudenza e parte della dottrina lo ritengono
soggetto alla stessa forma imposta al contratto da completare; altra dottrina lo ritiene in generale a
forma libera; altra dottrina ancora distingue, a seconda delle ragioni per cui è richiesta la forma.
Quid, se il contratto lascia indeterminato l’oggetto, rinviandone la determinazione al successivo
accordo delle parti?
Presupposto della questione è che il contratto sia da ritenere concluso.
Si prospettano diverse alternative: prima di tutto, dovrà vedersi se le parti trovano l’accordo per
determinare la prestazione: se sì, il problema è risolto; se invece non s’accordano, dovrà vedersi se la
prestazione è determinabile, mediante qualche elemento d’integrazione che supplisca la volontà
mancante delle parti.
Se nessun elemento del genere esiste, il contratto è nullo per indeterminabilità dell’oggetto.
Se invece è possibile ricorrere ad un siffatto elemento d’integrazione, l’oggetto viene determinato per
questa via, ed il contratto si salva.
Diverso è se il contratto rimette la determinazione dell’oggetto ad una sola delle parti.
La fattispecie va guardata con sospetto.
Non mancano gli indici normativi di apertura a questa possibilità: l’entità della somministrazione può
essere stabilita dal somministrato, entro limiti minimi e massimi indicati in contratto (1560.2);
nell’obbligazione alternativa, la scelta della prestazione è rimessa all’obbligato (1285).
La determinazione rimessa ad una parte può essere ammissibile anche quando si muove entro un
orizzonte di ragionevole prevedibilità, sulla base di parametri obiettivi (non importa se esplicitati in
contratto, od impliciti nella natura di questo o nelle circostanze): la determinazione fatta in spregio ad
essi potrà essere impugnata da controparte in base alle norme sull’impugnativa dell’arbitraggio rimesso
all’equo apprezzamento del terzo od al suo mero arbitrio.
La determinazione rimessa alla parte è invece inammissibile – e rende nullo il contratto per
indeterminabilità dell’oggetto – quando l’interesse di controparte a non subire sorprese lesive non sia
adeguatamente presidiato da limiti posti alla discrezionalità di chi sceglie.
CAPITOLO XVI – LA CAUSA DEL CONTRATTO
La causa è – con l’accordo, l’oggetto e la forma per la validità – uno dei requisiti del contratto (1325
n.2), perciò la sua mancanza determina nullità del contratto (1418.2: producono nullità del contratto la
mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa, la illiceità dei motivi
nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo
1346.).
La causa è la ragione giustificativa del contratto, la sua ratio, l’elemento che lo spiega razionalmente.
Nell’evoluzione storica il principio della causa non ha sempre avuto il medesimo significato e valore.
Storicamente, il problema della causa s’è posto come problema di sapere se un nudo patto od una nuda
promessa – cioè la nuda manifestazione della volontà d’impegnarsi legalmente – siano sufficienti a
creare l’impegno legale.
Secondo il diritto romano classico vale il principio che il nudo patto non genera obbligazione: ma
“nudo” significa non rivestito delle formalità o non corrispondente agli schemi tipici cui i contratti
dovevano conformarsi per ottenere il riconoscimento del diritto.
Secondo Grozio (Huigh de Groot, 1583-1645), una promessa, anche se fatta senza causa, è vincolante
per natura.
La svalutazione della causa, propria del giusnaturalismo estremo, viene superata nei successivi sviluppi
del pensiero giuridico europeo-continentale, che vedono protagonisti Jean Domat (1635-1696) e
Robert-Joseph Pothier (1699-1772).
Per i grandi progenitori del code Napoléon, il nudo patto non basta a creare l’impegno legale.
Questo deve avere un distinto fondement: s’afferma così il principio causalista: quello per cui
l’attribuzione di un diritto e l’assunzione di un obbligo non sono ammissibili se non risultano
giustificati da una causa.
Nel panorama delle teorie della causa, si distinguono dottrine soggettive e dottrine oggettive.
Le prime identificano la causa in un dato psicologico: causa sarebbe lo scopo che, oggetto di
rappresentazione psichica della parte, spinge questa a prestare il consenso contrattuale.
Ma oggi le teorie soggettive non hanno seguito.
Domina la diversa impostazione per cui la causa va ricercata in qualche elemento obiettivo, esterno ed
autonomo rispetto alle rappresentazioni mentali dei contraenti.
Le varie teorie oggettive della causa si presentano animate da differenti ispirazioni di fondo, in ragione
delle quali le teorie possono qualificarsi: astratte o concrete; dirigistico-paternalistiche o liberali;
analitiche od unitarie.
Il prototipo delle teorie astratte è la teoria – elaborata da Emilio Betti (1890-1968) – che definisce la
causa come funzione economico-sociale tipica del contratto.
Alla stregua di essa, causa della compravendita è lo scambio fra cosa e prezzo.
Ma se la causa è la funzione tipica, laddove questa sia in generale approvata dal legislatore che nomina
e regola il corrispondente tipo contrattuale, ne deriverebbe l’improponibile conseguenza che i contratti
legalmente tipici hanno sempre, per definizione, causa lecita, e che la possibile illiceità della causa
riguarda solo i contratti innominati.
Oggi si ritiene più aderente alle esigenze di una evoluta teoria e disciplina del contratto concepire la
causa come causa concreta: non come ragione che astrattamente giustifica ogni contratto appartenente
al tipo del contratto in esame, ma come ragione che concretamente giustifica il particolare contratto in
esame.
“Concreto” non s’identifica con “soggettivo”: la concretezza può (e qui deve) declinarsi in termini di
oggettività.
Il dibattito dottrinale sulla causa assume una dimensione ideologica quando affronta un punto, se la
causa sia strumento di controllo sociale, o pubblico, dell’autonomia privata.
Che in una certa misura lo sia, è dato che scaturisce positivamente dalle norme.
Se per il 1418.2 è nullo il contratto che abbia causa illecita, ciò significa che il giudizio di riprovazione
dell’ordinamento verso l’operazione di autonomia privata passa attraverso il concetto di causa.
Il punto sta nel vedere se l’ordinamento disapprovi non solo i contratti socialmente dannosi, ma anche i
contratti socialmente indifferenti, come i c.d. contratti con causa futile: quelli che perseguono interessi
puramente individuali.
Le diverse teorie della causa danno risposte diverse.
Per la teoria della causa come funzione economico-sociale la causa non esiste o non è approvata
dall’ordinamento se non corrisponde ad una funzione di utilità sociale; la causa dei contratti nominati
ha per definizione questa caratteristica; quanto ai contratti innominati, essi soddisfano il requisito
causale se risultano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico
(1322.2).
L’idea che il contratto privo di una positiva, specifica utilità sociale vada disapprovato e represso è
un’idea illiberale.
La ragione giustificativa (causa) del contratto non è la sua funzione economico-sociale tipica, ma è la
funzione od il senso che le parti gli assegnano nelle loro scelte di autonomia privata: in questa logica
sono interessi meritevoli di tutela ex 1322.2 tutti quelli che l’ordinamento non disapprova come
socialmente dannosi.
Il codice civile del 1865, sul modello del code Napoléon, parlava di causa del contratto e di causa
dell’obbligazione.
Questo linguaggio sottintendeva una teoria analitica della causa: quella che riferisce la causa non al
contratto unitariamente considerato, ma alle singole prestazioni contrattuali, considerate isolatamente.
Questa visione è superata dal codice vigente, in pro di una teoria unitaria della causa.
Non si parla più di causa dell’obbligazione, ma solo di causa del contratto.
L’obbligazione non ha propriamente una causa, ma un titolo; e se l’obbligazione è contrattuale il titolo
è il contratto.
Rispetto ai contratti gratuiti, che esauriscono il loro oggetto nella prestazione di una sola parte, non è
imperdonabile sovrapporre causa del contratto e causa dell’unica prestazione contrattuale.
Inoltre, c’è almeno un luogo in cui la stessa legge ancor oggi parla di “causa” non a proposito del
contratto, ma di qualcos’altro: si allude alla norma sull’arricchimento “senza causa” o “senza giusta
causa” (2041): essa riferisce la causa (o meglio, la mancanza di causa) ad un arricchimento che può
derivare da una prestazione resa all’arricchito.
Si pone un problema di causa della prestazione arricchente, che non coincide col problema della causa
del contratto che la prevede.
Un’altra zona in cui viene in gioco la causa della prestazione distinta rispetto alla causa del contratto, è
la zona degli atti di adempimento (atti solutori).
L’atto di adempimento può essere un contratto, necessario o comunque idoneo ad adempiere una
precedente obbligazione: la sua causa – causa solvendi – è la preesistente obbligazione.
Ma più spesso l’atto solutorio non è un contratto, bensì una mera prestazione: rispetto alla quale non
sembra improprio chiedersi se sia sostenuto da un’adeguata causa solvendi.
Vi è un unico, fondamentale principio immanente al sistema: il principio di razionalità degli
spostamenti di ricchezza, per cui nessuno spostamento patrimoniale può prodursi, e comunque tenersi
fermo, se non sia sostenuto da un’adeguata ragione giustificativa.
In un contesto socio-culturale come il nostro, la prima ragione giustificativa degli spostamenti di
ricchezza creati dal contratto è la reciprocità dei vantaggi e dei sacrifici giuridici che il contratto reca
alle parti.
È quanto accade nei contratti di scambio, dove ciascuna parte attribuisce diritti od assume obblighi a
favore dell’altra perché l’altra attribuisce diritti od assume obblighi a suo favore: prestazione e
controprestazione si giustificano a vicenda; lo scambio fra esse giustifica il contratto, ne è la causa.
Vale lo stesso per quei contratti onerosi che non sono propriamente di scambio, perché la prestazione di
una parte non è rivolta direttamente a favore dell’altra, in vista di una controprestazione che
quest’ultima direttamente renda alla prima; bensì si dicono associativi, perché la prestazione di
ciascuna parte concorre alla creazione ed al funzionamento di una struttura comune, che risponde
all’interesse di tutte.
Ancorché mediata, questa correlazione di sacrifici e vantaggi è un’idonea ragione giustificativa del
contratto.
Un discorso analogo può farsi per i contratti normativi, coi quali le parti vincolano reciprocamente
modi e contenuti dei propri futuri contratti.
Vi sono contratti in cui manca la reciprocità di cui sopra, perché solo una parte sopporta sacrifici
giuridici e solo l’altra ne riceve vantaggi giuridici: sono i contratti gratuiti.
Può esservi tuttavia un diverso tipo di scambio, che chiamiamo “empirico”: chi sopporta il sacrificio
giuridico non ha in cambio alcun vantaggio giuridico, ma ne ha un vantaggio empirico, fattuale,
apprezzabile sul piano economico.
Così, il socio che dà fideiussione per il debito della sua società verso la banca, o s’impegna a
sottoscrivere un aumento di capitale, ha il vantaggio che la sua società possa aver credito bancario, o
sia più adeguatamente capitalizzata.
Se viene data fideiussione onerosa, contro un corrispettivo per il fideiussore, il contratto ha una causa,
che è lo scambio giuridico.
Ha una causa – lo scambio empirico – anche la fideiussione gratuita ma interessata, che il fideiussore
dà per un proprio vantaggio fattuale.
Ma che dire della fideiussione gratuita e disinteressata?
Di sicuro la fideiussione è valida.
Qual è la causa?
È il rafforzamento del credito, attraverso la garanzia personale apprestata dalla fideiussione.
Oltre al rafforzamento del credito, un’altra buona ragione per giustificare un contratto che non abbia
causa di scambio è la realizzazione del credito stesso: svolgono questa funzione i contratti solutori,
come l’atto con cui il mandatario (ri)trasferisce senza corrispettivo il bene acquistato per il mandante
(la sua causa è l’adempimento dell’obbligo di (ri)trasferimento a carico del mandatario).
Vi sono contratti che non realizzano alcuno scambio, né giuridico né empirico, e che non servono a
garantire né a soddisfare crediti.
Qui però la causa non riesce a ravvisarsi in nessun elemento oggettivo.
Questi contratti sono sostenuti da un elemento potentemente soggettivo, che appartiene alla sfera
interiore di chi s’impegna in modo gratuito e disinteressato, con inevitabili effetti d’indistinzione fra
causa e volontà contrattuale, o di tautologia: essendo tautologiche le definizioni correnti, per cui causa
della donazione è lo spirito di liberalità del donante, ovvero il suo animus donandi.
Il soggettivo interesse altruistico della parte è un elemento causalmente fragile, esso ha bisogno di
elementi di sostegno; e di elementi massimamente oggettivi, per bilanciare la soggettività dell’elemento
causale.
L’oggettività sta nella solennità, quando l’elemento di sostegno è la forma.
L’oggettività sta nella materialità, quando l’elemento di sostegno è la consegna della cosa: nei contratti
reali gratuiti (mutuo, deposito, comodato) la debolezza della causa è compensata da un fatto al tempo
stesso fortemente fisico e fortemente simbolico, quale la traditio.
La sua indispensabilità, per sostenere il contratto, ha come riflesso l’inammissibilità di varianti
obbligatorie dei citati contratti, se gratuiti: laddove varianti consensuali possono ammettersi per i
medesimi contratti, se onerosi.
Ci sono contratti che sono gratuiti, non recano nessun percepibile vantaggio empirico a chi s’impegna
unilateralmente, non realizzano né rafforzano il preesistente credito del beneficiario, e sono validi senza
forma solenne e senza consegna della cosa.
Bisogna individuare un elemento che, rinvigorendo una causa di per sé debole come quella
rappresentata dal mero interesse soggettivo di chi s’impegna, le dia la forza di sostenere il contratto.
Tale elemento può essere costituito dalla circostanza che il contratto incida su un preesistente rapporto
fra le parti.
Questo vale prima di tutto per le rinunce, totali o parziali, a diritti preesistenti.
È valida anche senza forma solenne la remissione, che pure arricchisce il debitore senza portare, in
ipotesi, alcun vantaggio al creditore, perché le parti giungono al contratto non da estranee, ma essendo
già legate fra loro da un rapporto su cui il contratto va ad incidere.
Al di fuori di un rapporto preesistente fra le parti, la ragione giustificativa di contratti gratuiti non
altrimenti giustificati o causalmente rafforzati può stare solo nella tenuità delle conseguenze
economico-giuridiche a carico di chi s’impegna: si pensi al mandato gratuito.
Se un impegno gratuito non riesce a giustificarsi nemmeno per questa via, la conclusione più probabile
è che non sia materia di un contratto, e non valga come impegno giuridico.
Si pensi al trasporto: se è oneroso, è un contratto con causa di scambio giuridico; se è gratuito ma dà un
vantaggio al vettore, è un contratto con causa di scambio empirico; se è gratuito e disinteressato, non è
un contratto ma un mero atto di cortesia.
Il contratto è, prima di tutto, terreno di confronto e scontro di egoismi privati; ma il contratto è anche,
infine, terreno d’incontro degli egoismi privati: le parti trovano un punto di equilibrio accettabile da
entrambe delle iniziali posizioni antagoniste.
Il raggiungimento di questo punto di equilibrio è l’accordo delle parti, dunque è il contratto.
In questo modo accade che alcuni interessi individuali dell’una e dell’altra parte entrino nel contratto,
mentre altri restano fuori del contratto.
Entrano nel contratto gli interessi delle parti che le parti abbiano espressamente preso in
considerazione, dedicando ad essi una specifica regola del regolamento contrattuale.
Quando l’interesse della parte non è espressamente contemplato da una regola contrattuale compresa
nell’accordo, può darsi che sia contemplato da una regola contrattuale stabilita dalla legge: ed anche in
tal caso entra nel contratto.
Quando l’interesse della parte non è contemplato né dall’accordo contrattuale né da una specifica
norma applicabile al contratto, viene in gioco la distinzione fra causa e motivi del contratto.
La causa del contratto comprende gli interessi della parte che il contratto deve assicurarle, perché
formano la ragione giustificativa del contratto stesso.
Motivi sono invece gli interessi (bisogni, impulsi, fini) della parte, che restano fuori del contratto
perché non fanno parte della sua ragione giustificativa.
Per questo sono irrilevanti, salvo che siano chiamati nel contratto dalla volontà delle parti: se nessuna
condizione o clausola contrattuale li contempla, la loro frustrazione non incide sulla sorte del contratto.
Mentre la frustrazione degli interessi compresi nella causa suscita rimedi contrattuali, la frustrazione
degli interessi che sono semplici motivi non suscita rimedi contrattuali.
La ragione dell’irrilevanza dei motivi di parte è la difesa della stabilità del contratto.
Il criterio non è se l’interesse della parte sia noto a controparte, e nemmeno se la parte che ne è
portatrice l’abbia appositamente esternato all’altra.
Questo dato soggettivo può essere rilevante, ma da solo non è decisivo: deve esservi qualche altro dato
che dia dimensione oggettiva all’interesse invocato dalla parte, ed al rilievo che esso ha per la posizione
contrattuale della parte stessa.
Nelle motivazioni delle sentenze, la causa viene talora definita come lo scopo comune alle parti.
Motivo è lo scopo non comune alle parti, ma individuale di una di esse.
I motivi sono una variabile dipendente dalla causa: l’area di essi si disegna in via residuale, per
differenza dall’area della causa.
Il principio dell’irrilevanza dei motivi conosce alcune deroghe: queste riguardano il motivo illecito
nella donazione e nei contratti diversi dalla donazione; il motivo erroneo nella donazione.
CAPITOLO XVII – LA RILEVANZA DELLA CAUSA:
CONTRATTI SENZA RAGIONE E CONTRATTI ILLECITI
La causa rileva quando non c’è: mancanza di causa; inoltre essa rileva quando non è lecita: illiceità
della causa.
Causa illecita significa che la ragione del contratto, il senso dell’operazione che con esso le parti
perseguono, sono disapprovati dall’ordinamento perché socialmente dannosi o pericolosi.
Il problema della mancanza di causa può porsi in fattispecie diverse, non tutte da trattare allo stesso
modo.
Una prima fattispecie è quella in cui il contratto non indica la propria causa.
Potrebbe obiettarsi che la causa, ancorché non rivelata nel contratto, può in realtà esistere, ma questa
distinzione fra obiettiva inesistenza e mancata menzione della causa introduce il problema del contratto
astratto.
Una diversa fattispecie è quella in cui il contratto dice la propria causa, ma questa causa non può
realizzarsi: anche qui abbiamo un contratto senza ragione.
L’esempio tradizionale è la vendita di cosa già in proprietà del compratore.
La problematica della mancanza di causa, nella prospettiva della causa concreta, può utilmente
affrontarsi considerando due sottotemi del tema causale: l’adeguatezza del corrispettivo, ed i contratti
collegati.
Dato un contratto che dispone il trasferimento di un bene, consideriamo alcune possibili varianti.
Prima variante: il contratto non menziona alcun corrispettivo: allora non ha causa di scambio, e se non
risulta per esso nessun’altra causa, è un contratto nullo per mancanza di causa.
Seconda variante: il contratto enuncia una causa di scambio menzionando un prezzo corrispettivo
dell’attribuzione, ma non ne indica l’ammontare limitandosi a dire che esso viene contestualmente
pagato, od è stato prima d’ora pagato al venditore, che ne dà quietanza.
La fattispecie non pone un problema di causa, ma di oggetto, e precisamente di sua determinabilità.
Terza variante: il contratto enuncia causa di scambio ed indica con precisione un corrispettivo, che è
però obiettivamente inadeguato rispetto al valore del bene con cui viene scambiato.
Punto di partenza è il principio di libertà contrattuale, da cui consegue la tendenziale incompetenza
dell’autorità pubblica a sindacare le scelte dei privati contraenti.
L’arricchimento inconsapevole od interessato non intacca la causa di scambio, che resta pura; se invece
l’arricchimento è consapevole e disinteressato, la causa di scambio s’integra con quella di liberalità,
dando luogo alla c.d. donazione indiretta, o negotium mixtum cum donatione: l’atto è soggetto allora
alle regole sulla donazione indicate dall’809 (fra cui non è compresa la regola sulla forma).
La giurisprudenza distingue fra prezzo irrisorio e prezzo puramente simbolico: il prezzo irrisorio è pur
sempre un prezzo, e la sua irrisorietà non è rilevante perché essa si colloca nell’area dei motivi e non
sul terreno della causa; invece il prezzo simbolico è un “non prezzo” che dissolve la causa di scambio e
rende nullo il contratto.
Il principio della causa concreta può imporre di riconoscere che la causa non è semplicemente lo
scambio fra il prezzo ed il bene, ma è lo scambio fra il bene da una parte e dall’altra parte il prezzo più
l’ulteriore elemento di convenienza che il venditore si attende dalla vendita.
Può, ma non necessariamente deve: tutto dipende dal vedere se – in base ai criteri di distinzione fra
causa e motivi – quell’elemento di convenienza entri anch’esso a comporre l’obiettiva ragione
giustificativa del contratto, o ne resti fuori, come mero desiderio o speranza individuale del contraente.
In analoga prospettiva, va riconsiderata l’affermazione per cui il contratto che attribuisce un bene senza
indicare alcun corrispettivo (e non sia donazione) è senza causa; la causa può stare altrove: ad es. in un
altro contratto, collegato con quello apparentemente senza causa; oppure in un vantaggio per il
disponente, diverso dalla percezione di un formale corrispettivo.
Nella stessa logica possono spiegarsi figure apparentemente paradossali, come le attribuzioni di beni a
prezzo negativo: cioè quelle con corrispettivo a carico del cedente, che oltre a privarsi del bene paga un
prezzo.
Il principio per cui l’adeguatezza del corrispettivo contrattuale è irrilevante conosce deroghe: ad es., è
messo fuori gioco per il contratto di lavoro, dove il vincolo di un corrispettivo adeguato – una
retribuzione proporzionata e sufficiente – ha addirittura rango costituzionale (36.1 Cost.: il lavoratore
ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.).
Nei contratti fra professionisti e consumatori sono vietate, in quanto vessatorie, le clausole che
determinano un significativo squilibrio fra le posizioni delle parti (1469-bis comma 1).
Lo squilibrio vietato non è lo squilibrio economico, relativo al prezzo.
Due o più contratti sono collegati quando, per qualche ragione, l’uno dipende dall’altro: con la
conseguenza che il trattamento giuridico dell’uno è influenzato dall’esistenza e dalle vicende dell’altro.
Ciò accade con il collegamento sostanziale, e non con quello solo formale (o documentale, o
materiale), che si ha quando i diversi contratti sono semplicemente riuniti in uno stesso contesto.
Può distinguersi un collegamento necessario (o tipico), ed un collegamento volontario.
Sono necessariamente collegati il contratto definitivo rispetto al preliminare; il subcontratto –
sublocazione, subappalto, ecc. – rispetto al contratto-base.
Invece il collegamento volontario ricorre quando due contratti, che in astratto potrebbero essere fra loro
indipendenti, sono in concreto programmati dalle parti come elementi di una stessa operazione.
Il collegamento volontario può presentarsi innanzitutto come collegamento espressamente dichiarato
dalle parti.
Di fronte a contratti che non esplicitano il proprio collegamento, esso emerge di solito come materia di
lite fra le parti: una lo nega, per trarre dalla sua inesistenza conseguenze a sé favorevoli, e l’altra invoca
conseguenze opposte, fondate sull’esistenza del collegamento.
I profili di possibile rilevanza del collegamento riguardano essenzialmente due questioni: la prima
questione è se un contratto – apparentemente privo di causa, od apparentemente dotato di una certa
causa – in realtà trovi causa, od un’integrazione della causa, in altro contratto con esso collegato.
La seconda questione è se un contratto, di per sé immune da vizi capaci di pregiudicarne la validità e
l’efficacia, possa venire toccato e travolto dall’invalidità e dall’inefficacia che colpiscono un altro
contratto, sulla base del collegamento esistente fra i due.
La risposta è sì, se il collegamento fra i due contratti è così rilevante, che l’uno trova almeno in parte
nell’altro la propria ragione giustificativa.
Quid se in un caso in cui i contratti sono obiettivamente collegati, i contratti stessi negano in modo
espresso il collegamento?
In un certo senso, s’introduce un elemento di astrazione dalla causa.
Il problema è di limiti dell’autonomia privata, ed è suscettibile di soluzioni diverse a seconda delle
concrete peculiarità della fattispecie.
Il collegamento è concepibile anche fra contratti conclusi da parti diverse.
Il collegamento può essere biunivoco, quando un contratto influenza l’altro, e viceversa; oppure solo
univoco, quando un contratto influenza l’altro, mentre quest’ultimo non influenza il primo.
Concettualmente, il fenomeno dei contratti collegati presuppone la pluralità dei contratti.
Esso si distingue perciò dalla figura del contratto complesso o misto, che è un unico contratto nel quale
si combinano schemi contrattuali diversi.
La distinzione si basa generalmente sul criterio della causa.
Parte della dottrina evoca la causa sia quando essa presenta problemi fin dall’origine, sia anche quando
è toccata da eventi successivi alla conclusione del contratto.
Nel primo caso si avrebbe difetto genetico della causa, nel secondo caso si avrebbe difetto funzionale
della causa.
Altra dottrina giudica improprio questo impiego del concetto.
Per essa, la causa rileva solo nella prospettiva (statica) della struttura del contratto-atto, solo in quanto
difetti all’origine.
Immaginiamo che esista un principio d’irrilevanza della causa: lo chiamiamo principio di astrazione; e
chiamiamo contratto astratto il contratto per il quale sia irrilevante la causa.
In generale il nostro sistema accoglie il principio della causa e respinge il contrapposto principio di
astrazione: dunque rifiuta il contratto astratto.
In Germania fra le parti, l’atto opera anche se non menziona la causa.
Supponiamo che emerga poi la mancanza di causa dell’atto: opera anche in Germania il principio della
causa, sia pure ex post per rimettere in discussione un effetto già prodotto, anziché (come in Italia) ex
ante per impedire la produzione dell’effetto.
La dimostrata mancanza di causa è rilevante solo fra le parti, non è invece rilevante verso il terzo, ed in
ciò torna a manifestarsi il principio di astrazione.
A differenza che in Germania, in Italia gli atti che trasferiscono diritti (o comunque incidono su diritti
reali) senza menzionare la propria causa sono prima facie nulli per mancanza di causa.
La causa non menzionata si presume inesistente.
Se la causa resta non provata, il suo difetto è rilevante anche verso i terzi.
Ma il regime duramente causalista appena descritto opera solo quando sono in gioco atti costitutivi di
diritti reali, o traslativi di diritti.
Nel diverso campo delle promesse o comunque degli atti con effetti obbligatori il principio
dell’astrazione trova qualche spazio anche in Italia.
Negli atti obbligatori la causa si presume
Un contratto generatore di sole obbligazioni, che non menzioni la propria causa, è prima facie valido.
Opera il principio di astrazione: ma opera come astrazione solo processuale, ai fini di un’inversione
dell’onere della prova circa la causa: questa dovrebbe ex 2697.1 far carico all’attore promissario che
agisce per conseguirla; viene invece messa a carico del convenuto promittente, che rifiuti la
prestazione, la prova del difetto di causa.
L’astrazione non è sostanziale, perché se risulta il difetto di causa, la promessa è invalidata.
Tutto ciò si ricava dal 1988, in tema di promessa di pagamento (e ricognizione di debito): se il
destinatario della promessa senza menzione di causa è esonerato dal provarla quando la promessa è
unilaterale, non ha senso onerarlo della prova quando la promessa derivi da un atto cui egli ha
partecipato col suo accordo.
La menzione di una causa insufficiente crea un’evidenza prima facie di difetto di causa, e così rigetta
sul promissario l’onere di provare elementi capaci di integrarla e renderla sufficiente?
Si discute se il 1988 sia applicabile alle dichiarazione ricognitive di diritti reali in capo ad altri: la
giurisprudenza lo nega, mentre la dottrina manifesta maggiori aperture.
Una marcata apertura all’astrazione si ha con la disciplina della delegazione pura (o, appunto, astratta),
in cui il delegato promette al delegatario senza menzionare il rapporto di provvista ed il rapporto di
valuta, che sono la causa della sua promessa.
La promessa del delegato si considera valida ed efficace, e ciò non sorprende dato che in materia di
obbligazioni la causa si presume.
Ma qui l’irrilevanza della causa si spinge fin sul terreno sostanziale: il delegatario non solo è esonerato
dal provare la causa della promessa ricevuta, ma è immune da eccezioni del delegato relative al difetto
di causa: infatti il delegato non può invalidare la sua promessa eccependo la (parziale) mancanza di
causa.
Il principio della causa riprende vigore solo nel caso in cui la causa manchi totalmente, per essere
inesistenti o viziati sia il rapporto di provvista sia quello di valuta (1271).
L’astrazione ha spazio ancora maggiore in tema di cambiale.
L’emittente non può disconoscere la promessa cambiaria opponendo al portatore ch’essa è priva di
causa per inesistenza o vizio del rapporto fondamentale; ciò vale, tuttavia, solo se il portatore sia un
terzo estraneo al rapporto fondamentale; fra le parti di questo il principio della causa mantiene vigore.
Parte degli interpreti riconducono all’area dell’astrazione alcune figure: si dice che sia (o possa essere)
un atto astratto la procura, nella misura in cui non indichi il sottostante rapporto (di gestione) che la
giustifica, e non senza ripercussioni dalle vicende di questo.
Si dice che sia astratto il contratto autonomo di garanzia: in base al quale il garante è tenuto a pagare,
senza poter opporre eccezioni basate sul rapporto da cui nasce il credito garantito (che pure è la causa
della garanzia).
Potrebbe parlarsi di astrazione causale, perché l’astrazione che ricorre qui è, paradossalmente, essa
stessa causa del contratto: infatti la ragione giustificativa di questo è proprio dare al creditore una
garanzia particolarmente forte e sicura.
Il debitore che abbia dovuto rifondere il garante può invocare il difetto del credito garantito per
recuperare dal creditore quanto questi ha incassato senza causa.
Inoltre, l’astrazione non giunge a conservare l’operatività del contratto in presenza di fattori
radicalmente e palesemente distruttivi della sua ragione di garanzia.
Si dice che sia astratta la cessione di credito, perché di per sé non è sostenuta da nessuna causa che
giustifichi il sacrificio del cedente.
Oppure si dice che abbia causa variabile, perché a seconda dei casi può risultare sostenuta da ragioni
giustificative diverse (scambio, garanzia, liberalità).
Queste tesi muovono da una premessa sbagliata: che la cessione di credito sia un contratto: la cessione
di credito non è un contratto, ma una possibile prestazione contrattuale.
Infine, non appartengono all’area dell’astrazione i meccanismi che possono realizzare per altra via
risultati pratici equivalenti a quelli che deriverebbero dall’irrilevanza della causa.
Nel campo delle attribuzioni di beni, questi meccanismi sono soprattutto gli acquisti originari: se il
beneficiario trasferisce ad un terzo il bene mobile ricevuto senza causa, la regola “possesso vale titolo”
impedisce al disponente senza causa di recuperarlo (residuandogli un’azione personale risarcitoria
contro il beneficiario senza causa).
Nel campo delle obbligazioni, il principio della causa può essere messo in scacco da remissioni e
prescrizioni.
Il contratto ha causa illecita quando la sua “ragione”, il “senso” dell’operazione che con esso le parti
perseguono, sono riprovati dall’ordinamento giuridico.
Il contratto con causa illecita può dirsi contratto illecito.
Peraltro le due categorie coincidono solo in parte: la seconda contiene la prima ma è più ampia, perché
contiene anche altre figure.
Oltre che i contratti con causa illecita, sono contratti illeciti: i contratti con oggetto illecito, i contratti
con motivo illecito comune, ed i contratti sottoposti a condizione illecita.
L’illiceità della causa si distingue concettualmente dall’illiceità dell’oggetto: l’oggetto è illecito quando
la prestazione contrattuale in sé e per sé considerata viola una norma imperativa o l’ordine pubblico od
il buon costume.
È illecita la causa quando – pur essendo la prestazione di per sé lecita – illecita risulta la sua deduzione
in contratto, in quel particolare contratto.
L’illiceità della causa può dipendere dalla qualità della parte.
Dovrebbe allora riconoscersi che la qualità della parte in un certo senso entra nella ragione
giustificativa del contratto, ma una constatazione del genere è compatibile solo con un’idea della causa
che valorizzi gli elementi rilevanti della singola fattispecie.
In primo luogo, la causa è illecita quando è contraria a norme imperative (1343).
Le norme imperative di cui parla il 1343 sono quelle che proibiscono direttamente e specificamente ciò
che il contratto vuole realizzare, in nome di interessi pubblici o generali prevalenti, che il contratto
metterebbe a rischio.
Non tutte le norme che regolano la deduzione in contratto di beni o comportamenti sono imperative:
norma imperativa è quella che proibisce determinati comportamenti o risultati, perché ritenuti dannosi
o pericolosi per l’interesse generale.
La qualifica d’imperatività può ricavarsi da indici testuali, ma può anche ricavarsi da dati extratestuali,
o dal giudizio di rilevanza sociale degli interessi che la norma protegge.
Un tale giudizio può, a sua volta, dedursi dalla gravità della sanzione con cui la norma presidia gli
interessi tutelati: si considerano tendenzialmente imperative tutte le norme penali.
La causa è illecita anche quando è contraria all’ordine pubblico (1343).
La categoria dell’ordine pubblico consente di colpire contratti socialmente dannosi o pericolosi, anche
se non corrispondenti ad alcuna fattispecie precisamente descritta da norme imperative.
L’ordine pubblico è la serie dei principi politici, sociali, economici che sono a base dell’ordinamento
giuridico in un determinato momento storico.
Non sono necessariamente enunciati in modo espresso.
Si ricavano per lo più da norme o complessi di norme che, pur senza enunciarli, li presuppongono.
L’ordine pubblico politico comprende i principi che riguardano l’esistenza e il funzionamento dello
Stato e in generale dei poteri pubblici, nonché le libertà e i diritti fondamentali delle persone sia come
singoli sia in relazione ai gruppi sociali cui appartengono.
L’ordine pubblico economico comprende i principi che presiedono alla produzione ed alla circolazione
della ricchezza.
Nell’ambito dell’ordine pubblico economico, cresce l’importanza di quello che si usa chiamare ordine
pubblico di protezione.
Esso implica il confronto fra le posizioni e gli interessi di categorie economico-sociali contrapposte sul
mercato, e suggerisce politiche di protezione della categoria debole (alla categoria possono per es.
ricondursi i principi di protezione dei lavoratori verso i datori di lavoro; dei conduttori verso i locatori).
Infine la causa è illecita quando è contraria al buon costume (1343): il buon costume è la serie dei
principi etici condivisi dalla gran parte del corpo sociale in un dato momento storico.
Il buon costume condivide con l’ordine pubblico la natura di clausola generale.
L’ordine pubblico esprime (al pari delle norme imperative) scelte politiche del legislatore, mentre i
principi del buon costume sono extralegali.
Appartiene al buon costume il rispetto della dignità e della sensibilità della persona umana.
Appartengono al buon costume i principi della morale sessuale, che portano a considerare riprovevole
la mercificazione del sesso.
Appartiene al buon costume l’etica professionale, quanto meno nelle sue basi minime rappresentate da
un dovere di fedeltà.
Un contratto può essere illecito per contrarietà al buon costume, ed insieme ad una norma imperativa
od all’ordine pubblico: un contratto di corruzione del pubblico funzionario ripugna al buon costume, ed
al tempo stesso viola il 319 c.p. (fenomeno della doppia illiceità).
Il contratto illecito è nullo, ma le conseguenze sono diverse a seconda che l’illiceità dipenda da
violazione di norme imperative o dell’ordine pubblico, o invece da contrasto col buon costume.
Nel primo caso la nullità produce la ripetibilità di tutte le prestazioni eseguite in base al contratto nullo,
mentre nel caso di contratto immorale chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da
parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato (2035).
Ciò vale solo se chi ha fatto la prestazione è partecipe dell’immoralità (“anche da parte sua”), non se è
rimasto estraneo ad essa.
La causa del contratto è illecita non solo quando è contraria a norme imperative (1343), ma anche
quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa (1344): è il
contratto in frode alla legge.
L’obiettivo di piegare un contratto normalmente lecito a risultati illeciti può perseguirsi dando al
contratto contenuti particolari, od anche collegando fra loro due contratti – ciascuno in sé tipicamente
lecito – che nella loro particolare combinazione realizzano il risultato aborrito dalla norma imperativa.
Un campo fertile è quello dei divieti di acquisto, eludibili per via d’interposizione.
Può porsi il problema di distinguere la frode alla legge dall’ordine pubblico e dall’applicazione
analogica della norma imperativa: anziché dire che la vendita con patto di riscatto avente funzione di
garanzia è illecita (ex 1344) per frode al 2744 (È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza
del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al
creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.), potrebbe dirsi
che lo è (ex 1343) per diretto contrasto col 2744, applicato per analogia? Ovvero con il principio di
ordine pubblico che esclude l’impiego della proprietà a scopo di garanzia del credito?
Più rilevante è un’altra questione: il contratto froda la legge quando realizza un risultato equivalente a
quello che la norma imperativa vuole impedire.
Resta da spiegare quando il risultato prodotto deve ritenersi equivalente a quello proibito, e quando
invece, pur essendo simile, non può dirsi equivalente.
La frode alla legge non va confusa con la simulazione (il contratto in frode alla legge non è simulato
ma realmente voluto), né con la frode ai creditori, colpita dall’azione revocatoria (2901 ss.; il contratto
revocabile non elude nessuna norma imperativa, ma semplicemente pregiudica le ragioni dei creditori
del disponente; non è colpito da nullità, ma da inefficacia relativa).
Il 1345 individua un terzo caso di contratto illecito, oltre ai casi d’illiceità dell’oggetto e della causa:
quello in cui è illecito il motivo che ha spinto le parti a contrarre, purché il motivo abbia la doppia
caratteristica d’essere esclusivo e comune ad entrambe le parti.
A differenza della causa, il motivo (anche illecito) di regola non è rilevante, anche se il motivo illecito
di una parte è noto a controparte: il discorso cambia se il motivo illecito d’una parte è non
semplicemente noto all’altra, ma condiviso da questa: ciò accade quando controparte aderisce
soggettivamente al motivo, o quando il motivo di una parte risulta obiettivamente rilevante per l’altra,
nel senso di fondare un suo obiettivo vantaggio contrattuale.
Perché la donazione sia illecita basta invece che il motivo abbia spinto all’atto il donante; deve però
essere esclusivo e deve risultare dall’atto (788).
CAPITOLO XVIII – TIPI E STRUTTURE CONTRATTUALI
Il tipo contrattuale è un modello di operazione economica, attuata mediante contratto, nota e diffusa
nella vita di relazione.
La disciplina legale dei tipi si trova prevalentemente nel titolo III del IV libro del codice, dedicati ai
“singoli contratti”, ma si trova anche in altri libri del codice, od in altri codici, ed anche nella
legislazione speciale extracodicistica.
Il senso fondamentale del tipo sta nel determinare le regole applicabili ai rapporti contrattuali
appartenenti al tipo.
Il tipo contrattuale si definisce in relazione al contratto in genere: un contratto di compravendita è
tipico, se guardato sullo sfondo della figura generale del contratto, cui pure appartiene.
Questo si riflette sull’identificazione delle discipline applicabili: un contratto di compravendita è prima
di tutto un contratto: dunque gli si applicano le regole sul contratto in genere (artt. 1321-1469-sexies);
ma poi è anche una compravendita: dunque gli si applicano anche le regole dettate per il tipo
“compravendita” (1470 ss.).
Se i due ordini di regole sono per qualche aspetto incompatibili, prevale la disciplina del tipo.
A sua volta, il fenomeno del tipo si presenta a diversi livelli di generalità: cui corrisponde una possibile
articolazione del tipo in sottotipi; e di questi, ulteriormente, in sotto-sottotipi.
Così, la vendita a rate con riserva della proprietà è tipica rispetto alla vendita, di cui è sottotipo.
C’è varietà degli elementi d’identificazione del tipo: la locazione s’identifica per la natura della
prestazione di una parte; la locazione d’immobili urbani per la natura del bene che forma oggetto della
prestazione; la locazione di immobili urbani ad uso abitativo per la funzione del bene oggetto della
prestazione.
Un altro elemento può consistere nelle modalità di esecuzione della prestazione, collegate alla qualità
della parte: a identità di prestazione – compiere un’opera od un servizio – se chi l’assume è un
imprenditore che opera con propria organizzazione e a proprio rischio, il tipo è l’appalto (1655); se non
è imprenditore, e provvede con lavoro prevalentemente proprio, il tipo è il contratto d’opera (2222).
Dato un singolo contratto (fattispecie concreta), esso si dice contratto tipico se corrisponde alla
fattispecie astratta di qualcuno dei tipi contrattuali definiti e regolati dalla legge; si dice atipico se non
corrisponde a nessun tipo siffatto.
Sinonimo di tipico/atipico è nominato/innominato; quando si dice “tipo” s’intende normalmente “tipo
legale”, ma ai tipi legali s’affiancano tipi social-giurisprudenziali.
Le parti possono […] concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina
particolare (1322.2).
Ci si distacca così dal diritto romano, che costruiva il sistema contrattuale essenzialmente come sistema
di contratti tipici (emptio, locatio, etc.), ed affidava la tutela dei contraenti all’esercizio delle
corrispondenti azioni in giudizio, a loro volta tipiche (actio ex emptio, ex locato, etc.).
Oggi la parte che intende azionare diritti contrattuali può limitarsi ad affermare di avere concluso un
contratto, ed a chiedere la tutela dei diritti conseguenti sulla base di un’atipica ed innominata azione da
contratto.
La libertà di fare contratti atipici consente ai privati di organizzare le proprie operazioni contrattuali nei
modi più conformi alle proprie esigenze, e quindi più idonei a garantire l’efficienza della loro azione.
Il leasing è diventato uno schema di contratto molto diffuso nella prassi: spesso i giudici decidono su
diritti ed obblighi che il contratto crea per le parti, secondo regole che consolidandosi danno luogo alla
disciplina (giurisprudenziale) del leasing: esso ha conquistato una sua tipicità, non legale ma socialgiurisprudenziale.
I patti parasociali hanno ricevuto una tipizzazione sui generis: la legge li prevede non tanto per
disciplinare diritti ed obblighi reciproci delle parti, ma essenzialmente per porre in relazione ad essi
limiti di contenuto ed obblighi di condotta, rilevanti verso l’autorità pubblica (122 t.u.f.).
La libertà di fare contratti atipici può incontrare limiti: ciò accade quando – in relazione a determinati
generi di beni, attività od interessi – la legge definisce alcuni tipi contrattuali, e vieta di fare contratti
non riconducibili ad essi.
Ha questa ragione il divieto dei contratti agrari atipici (l. 756/1964) e delle convenzioni matrimoniali
atipiche (160).
Non deve confondersi fra tipicità del diritto reale e tipicità del contratto che lo crea.
Il contratto che crea un diritto reale atipico non è necessariamente un contratto atipico: se il beneficiario
del diritto reale atipico si obbliga, in cambio, a far godere una propria cosa al disponente od a
trasportare sue cose, questo è un tipico contratto di locazione o di trasporto.
È certo un contratto nullo, ma non per violazione di un vincolo di tipicità contrattuale, bensì per illiceità
dell’oggetto: che è illecito per violazione del principio di ordine pubblico della tipicità dei diritti reali.
Sarebbe un errore pensare che ulteriori limiti alla libertà di concludere contratti atipici derivino dalla
norma che li ammette solo se diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento
giuridico (1322.2): questa è la tesi che considera la causa strumento per garantire l’utilità sociale del
contratto.
Un contratto – tipico od atipico che sia – merita disapprovazione non in quanto socialmente
indifferente, ma solo in quanto socialmente dannoso o pericoloso: cioè in quanto illecito.
Si obietterà che in questo modo il 1322.2 diventa un inutile doppione del 1343, ma muovendo dal
presupposto che le norme imperative e le regole di ordine pubblico e di buon costume di solito sono
riferite in prima battuta ai contratti tipici, la norma ha il senso di avvertire che la loro osservanza non
può essere elusa solo perché le parti concludono un contratto atipico.
La definizione del tipo può essere più o meno stringente.
È molto stringente, quando abbraccia tutti gli elementi che compongono l’oggetto (od il contenuto) del
contratto: definisce la prestazione, stabilisce che dev’esserci una controprestazione, definisce anche
questa controprestazione.
Vi sono poi tipi a bassa definizione, che si definiscono sulla base di due elementi, o di uno soltanto:
quanto più bassa è la definizione del tipo, tanto maggiore è la sua elasticità.
La locazione, per es., è definita dalla natura della prestazione del locatore e dalla necessaria presenza di
un corrispettivo a carico del conduttore: ma quest’ultimo resta indefinito.
Il mandato è un tipo a definizione ancora più bassa: decisiva è la sola natura della prestazione del
mandatario; il corrispettivo può esserci (mandato oneroso) o non esserci (mandato gratuito), ed in
entrambi i casi si rimane nel tipo.
Più che il contratto di mandato, il legislatore definisce e disciplina la prestazione del mandatario: più
che un contratto tipico, si ha qui una prestazione tipica.
Si parla di prestazioni transtipiche in relazione a quelle suscettibili di figurare in tipi contrattuali
diversi.
I contratti misti (detti anche “complessi”) sono contratti in cui figurano elementi di tipi contrattuali
diversi.
Se A concede in godimento temporaneo a B un immobile per ricoverarvi il proprio camioncino, ed in
cambio B s’impegna a trasportare periodicamente merci per conto di A, si ha un contratto misto di
locazione e trasporto.
Il trattamento dei contratti misti si determina in base a due criteri: il criterio della combinazione e
quello dell’assorbimento (o della prevalenza).
Il criterio della combinazione significa che al contratto s’applicano congiuntamente le discipline di
entrambi i tipi contrattuali; il criterio dell’assorbimento (o della prevalenza) opera in via eventuale,
quando le discipline dei due tipi risultino incompatibili fra loro: e fa sì che al contratto si applichi la
disciplina del tipo prevalente.
La qualificazione del contratto è l’operazione logica con cui l’interprete – di fronte ad un concreto
contratto – ne afferma o nega la riconducibilità ad un determinato tipo contrattuale.
La sua funzione principale è stabilire se al contratto sia applicabile la disciplina di qualche tipo, e se sì,
di quale tipo.
La giurisprudenza ripete che la qualificazione è questione di diritto, come tale deducibile in sede di
legittimità; aggiunge che si tratta di questione affidata al giudicante e sottratta alla competenza delle
parti: infatti il giudice non è vincolato al nomen iuris dato dalle parti al loro contratto, ma può
correggere la loro autoqualificazione.
La causa non s’identifica (meglio: non s’esaurisce) nel tipo cui il contratto appartiene, come vorrebbe
la teoria della causa quale funzione economico-sociale tipica.
Questa teoria impedisce di cogliere la causa nella sua dimensione di causa concreta: due contratti del
medesimo tipo – poniamo due vendite – possono avere differenti cause (concrete).
In sintesi: la causa di un contratto tipico ha sempre elementi tipici, ricavabili dall’astratta
configurazione del tipo, ma può avere anche elementi atipici (concreti); il tipo cui il concreto contratto
appartiene dice molto sulla causa di questo, ma non dice tutto.
Se il contratto non è facilmente inquadrabile in un tipo, la giurisprudenza conclude spesso che
appartiene a due tipi, ovverosia è un contratto misto: e finisce quindi per applicargli la corrispondente
disciplina legale.
Se poi il contratto è schiettamente atipico, i giudici lo dichiarano tale, ma aggiungono volentieri che
esso “presenta elementi” di questo o di quell’altro tipo: con la conseguenza di applicargli, almeno in
parte, la disciplina legale di un tipo.
Questa forzosa riduzione dei contratti atipici ai tipi risolve il problema d’individuare la disciplina
applicabile al contratto; tuttavia essa presenta un rischio: disattendere la volontà delle parti.
La tendenza alla tipizzazione giurisprudenziale è affiancata da una recente tendenza alla tipizzazione
legale.
Esistono classificazioni dei contratti diverse dalle classificazioni per tipi; esse si basano sulle strutture
contrattuali (altri preferisce chiamarle “tipi contrattuali generali”).
Le strutture contrattuali definiscono classi di contratti più ampie rispetto ai tipi, talora una categoria si
articola in sottocategorie.
Un contratto sopporta, dal punto di vista della sua riferibilità a strutture contrattuali, qualificazioni
multiple: può essere consensuale ed oneroso; un altro può essere consensuale e gratuito; un altro ancora
oneroso e reale; etc.
Come i tipi, anche le strutture contrattuali servono a definire la disciplina applicabile.
I contratti onerosi sono quelli in cui ciascuna parte fa una prestazione a favore dell’altra, e la
prestazione è il sacrificio che la parte sopporta per il vantaggio rappresentato dal ricevere la prestazione
di controparte.
La prestazione che la parte riceve in base al contratto rende questo oneroso solo se soddisfa un bisogno
della parte destinataria, che sia anteriore ed esterno al contratto; non invece se si pone (come può
accadere in un contratto gratuito) quale normale conseguenza del contratto, quale modo per delimitare
il sacrificio che la parte destinataria sopporta con la propria prestazione.
Nel comodato e nel mutuo senza interessi la prestazione di restituzione non avvantaggia il destinatario
rispetto alla posizione che egli aveva prima del contratto, ma lo rimette in quella posizione e così
circoscrive il sacrificio che egli sopporta col contratto.
Ai contratti onerosi si contrappongono i contratti gratuiti: quelli che attribuiscono una prestazione senza
addossare al beneficiario nessuna controprestazione, di modo che il beneficiario della prestazione
s’avvantaggia senza sacrificio, e l’autore della prestazione si sacrifica senza vantaggio.
Il prototipo del contratto gratuito è la donazione.
Altro contratto essenzialmente gratuito è il comodato.
La gratuità è determinata dall’assenza di un vero e proprio corrispettivo (in senso giuridico).
Donazione e comodato restano gratuiti anche quando sono modali, e cioè prevedono una prestazione a
carico del beneficiario imponendogli un onere (o modo).
Infatti tale prestazione non soddisfa un bisogno od interesse anteriore ed esterno al contratto, ma
costituisce una semplice limitazione del vantaggio che il contratto attribuisce al beneficiario: non
diventa oneroso il comodato di un immobile, che imponga al comodatario di ridipingere pareti e soffitti
ogni 5 anni.
Il contratto diventa oneroso quando il modo assorbe ed azzera il vantaggio che il beneficiario riceve
dalla prestazione, o risulta per altra via che l’autore della prestazione nominalmente gratuita intende la
prestazione modale imposta al beneficiario come mezzo per soddisfare un proprio interesse,
preesistente ed autonomo rispetto alla prestazione che rappresenta il suo sacrificio.
La natura onerosa o gratuita di un contratto è fondamentale per definirne la causa: si parla di contratti
con causa onerosa o gratuita.
La posizione contrattuale di chi s’impegna ad una prestazione gratuita viene considerata con
benevolenza od indulgenza maggiori, rispetto a quella di chi presta dietro corrispettivo: nel dubbio, il
contratto s’interpreta a suo favore (1371), inoltre la sua responsabilità per inadempimento è valutata
con minor rigore: così in tema di donazione (789 e 798), mandato (1710.1), deposito (1768.2),
comodato (1812), mutuo (1821.2).
Fa eccezione il trasporto gratuito di persone (1681.3), a tutela dei superiori valori della vita e
dell’integrità fisica.
Chi riceve un acquisto a titolo gratuito è tutelato, nel suo affidamento sulla stabilità di esso, meno
intensamente di chi acquista a titolo oneroso: l’acquisto dall’erede apparente è salvo, di fronte alla
petizione ereditaria del vero erede, solo se oneroso, non se gratuito (534.2).
Quando il contratto è trilatero, o produce effetti su terzi, esso può presentare al tempo stesso profili di
onerosità e gratuità: la datio in solutum per debito altrui è onerosa dal punto di vista del creditore
accipiens, è gratuita nel rapporto fra solvens e terzo debitore.
La donazione è un contratto gratuito, perché non prevede corrispettivo a carico del donatario, ma è
anche un contratto liberale, perché si caratterizza per lo spirito di liberalità.
Sono liberali, oltre alla donazione, tutti i contratti che presentano nella loro ragione giustificativa
l’intento di arricchire un altro disinteressatamente: qui il concetto di interesse va inteso in senso
economico.
S’impone la ricerca della causa concreta, che farà trapelare – dietro il disinteresse economico del
donante – qualche altro interesse: interessi del genere hanno un alto tasso di soggettività: in questo
senso sono motivi.
Peraltro essi qualificano, dandogli un contenuto, lo spirito di liberalità che sostiene ciascuna donazione:
in questo senso, finiscono per colorarne la causa (concreta).
Se un motivo siffatto ha quella particolare forza che gli deriva dall’essere l’unico che ha determinato la
liberalità, ed ha quell’oggettivazione che gli deriva dal risultare dall’atto, può dirsi che esso s’incorpora
nella causa, ed acquista la corrispondente rilevanza.
La categoria della gratuità non coincide perfettamente con quella della liberalità.
I contratti gratuiti si contrappongono ai contratti onerosi.
I contratti liberali si contrappongono ai contratti interessati.
Esistono contratti gratuiti ma non liberali, perché interessati: il trasporto offerto per incentivare la
presenza turistica; la copia omaggio della rivista, inviata per sollecitare l’abbonamento; etc.
Esistono anche contratti liberali ma non gratuiti: se pure il prezzo della vendita è molto inferiore al
valore del bene, nondimeno un corrispettivo esiste, e questo rende il contratto oneroso.
Sicché esistono atti liberali diversi dalla donazione: atti che normalmente sono gratuiti, come ad es. (se
disinteressati) un comodato od una rinuncia senza corrispettivo od il pagamento del debito altrui; ma
possono anche presentarsi come onerosi, come la vendita a basso prezzo, fatta per arricchire il
compratore.
Queste liberalità diverse dalla donazione sono considerate dagli artt. 737.1 (che suggerisce per esse la
qualifica di donazioni “indirette”) e 809.
Esse non richiedono la forma della donazione, ma soggiacciono ad altre norme dettate per questa.
Entro la categoria dei contratti onerosi si enuclea la più ristretta classe dei contratti con prestazioni
corrispettive (o sinallagmatici, o di scambio).
Sono quelli in cui la prestazione di una parte è scambiata con la prestazione dell’altra
(controprestazione).
Le due prestazioni sono in rapporto di reciprocità, nel senso che ciascuna è fatta in ragione dell’altra,
per contraccambiarla; ed in rapporto d’interdipendenza, nel senso che ciascuna si regge sull’altra.
La causa dei contratti sinallagmatici è dunque lo scambio giuridico fra le prestazioni.
Sono ad es. contratti sinallagmatici: la vendita, la permuta, la locazione, il contratto di lavoro.
Ai contratti con prestazioni corrispettive si applicano i rimedi detti appunto sinallagmatici, e cioè i
rimedi offerti ad un contraente, in relazione alla prestazione da lui fatta o dovuta, di fronte ad eventi
che lo privano o rischiano di privarlo della controprestazione da lui attesa: le risoluzioni, e gli altri
rimedi sinallagmatici.
Tutti i contratti con prestazioni corrispettive sono onerosi, ma non tutti i contratti onerosi sono con
prestazioni corrispettive: non lo sono i contratti con comunione di scopo, il cui prototipo è
rappresentato dai contratti associativi.
Le prestazioni dei diversi soci non sono fra loro corrispettive: ciascun socio esegue il proprio
conferimento non per ottenere in cambio un’utilità diretta dagli altri soci, ma per ottenere che,
attraverso i conferimenti di tutti i soci, si realizzi la struttura comune destinata a soddisfarne gli
interessi.
La struttura comune, e non lo scambio, è la causa del contratto.
Nei contratti sinallagmatici l’evento che colpisce la prestazione colpisce per ciò stesso, direttamente, la
causa del contratto: ecco perché, se la prestazione di una parte diventa impossibile, automaticamente il
contratto si risolve e la controprestazione viene senz’altro meno.
Invece nei contratti non sinallagmatici l’evento che colpisce ciascuna prestazione colpisce la causa (se
la colpisce) solo in modo eventuale e mediato: qui l’impossibilità sopravvenuta di una prestazione non
scioglie automaticamente il contratto e non fa automaticamente cadere le altre prestazioni: questo
effetto si verifica solo se la prestazione mancata era, in concreto, “essenziale” (1466).
Nel contratto plurilaterale, la ragione per cui la parte fa la sua prestazione di solito non si esaurisce nel
ricevere in cambio una controprestazione, ma è un elemento più complesso: è quello che la legge
chiama “scopo comune” a tutte le parti.
Possono darsi contratti plurilaterali con comunione di scopo, che non sono associativi (per converso, si
danno contratti associativi che non sono plurilaterali: ad es. società fra due soli soci).
La comunione di scopo può essere più o meno intensa; in relazione all’intensità, varia il grado in cui la
prestazione di una parte può influenzare le posizioni contrattuali delle altre, e quindi il contratto nel suo
insieme.
Il criterio risolve il problema principale dei contratti plurilaterali: il venir meno della partecipazione di
una singola parte lascia vivo il contratto per le altre, o lo travolge per tutte?
“Alea” significa sorte (profilo oggettivo); e significa rischio (profilo soggettivo); i contratti aleatori
sono quelli in cui l’entità della prestazione dipende da fatti incerti od ignoti alle parti.
Il rischio che rende un contratto aleatorio è il rischio giuridico-economico, inerente alla prestazione.
Non è il rischio puramente economico, relativo al costo della prestazione dovuta od al valore od
all’utilità della prestazione attesa.
Il contratto non è aleatorio nemmeno quando presenta un rischio economico altissimo, come nel caso
dell’acquisto, in tempo di guerra, di immobili in città soggetta a bombardamenti (vi è incertezza sul
costo, ma non sulla prestazione in quanto tale).
Possiamo invece chiamare rischio giuridico quello che ricorre quando è la prestazione in sé e per sé a
dipendere dal corso degli eventi; ma per rendere il contratto aleatorio non basta nemmeno il rischio
puramente giuridico.
Nel contratto condizionato ed in quello esposto a recesso unilaterale la prestazione è giuridicamente a
rischio, ma il contratto non è aleatorio, perché il rischio investe ugualmente entrambe le prestazioni che
seguono la stessa sorte.
Il rischio del contratto aleatorio è rischio al tempo stesso giuridico ed economico: è il rischio che tocca
la prestazione in sé e per sé; e la tocca in modo unilaterale e squilibrante, così da avvantaggiare una
parte e penalizzare l’altra sul piano economico.
Ciò accade per es. con l’assicurazione, col gioco e la scommessa, con la rendita vitalizia.
La distinzione fra rischio giuridico-economico e rischio puramente economico può essere sottile; la
rendita vitalizia contro cessione d’immobile è aleatoria, ma per la giurisprudenza non è aleatoria la
vendita d’immobile con riserva di usufrutto.
Se, per l’andamento dell’alea, una parte si trova gravata della propria prestazione ma privata della
controprestazione a suo favore, non per questo il contratto diventa gratuito: onerosità o gratuità vanno
misurate ex ante, al momento della conclusione del contratto.
Si chiamano contratti commutativi i contratti non aleatori, le cui prestazioni non corrono rischio
giuridico-economico.
La categoria non coincide con quella del contratto a prestazioni corrispettive: il contratto commutativo
può essere a prestazioni corrispettive (ad es. una vendita che faccia salve le garanzie del compratore),
ma un contratto commutativo può anche essere non a prestazioni corrispettive (ad es. un contratto di
società).
Ed un contratto a prestazioni corrispettive può essere non commutativo, ma aleatorio.
La legge suggerisce che un contratto può essere aleatorio o “per sua natura” o “per volontà delle parti”
(1469).
Nel primo caso, abbiamo contratti aleatori tipici (assicurazione, gioco e scommessa, rendita vitalizia).
Quando l’alea dipende dalla volontà delle parti, abbiamo contratti aleatori atipici: ad es. la vendita di
cosa futura è tipicamente non aleatoria, ma se le parti si accordano per addossare al compratore, tenuto
comunque a pagare il prezzo, il rischio che la cosa non venga ad esistenza, il contratto è aleatorio
(emptio spei).
In generale, un contratto aleatorio atipico può essere costruito essenzialmente con tre mezzi: la rinuncia
a far valere responsabilità o garanzie di legge; la deduzione in contratto di un oggetto non determinato
ma determinabile per relationem a dati futuri ed incerti, di cui una parte si prende tutto il rischio: la
condizione apposta non all’intero contratto, ma alla sola prestazione dovuta da una parte all’altra.
Il rischio giuridico-economico qualifica la causa del contratto aleatorio.
Ecco perché l’inesistenza del rischio può rendere nullo il contratto per mancanza di causa: si pensi
all’assicurazione per i danni a cosa già andata distrutta.
La qualificazione del contratto come aleatorio ha altri importanti riflessi normativi: ad esso non si
applicano i rimedi delle rescissioni per lesione (1448.4) e della risoluzione per eccessiva onerosità
sopravvenuta (1469).
Spesso la qualità (socio-economica) delle parti è elemento rilevante per l’ascrizione del contratto ad
una determinata classe, in vista dell’applicazione ad esso di una disciplina particolare.
Può rilevare una specifica qualità imprenditoriale, riferita all’esercizio di una specifica attività
d’impresa: i contratti bancari e quelli assicurativi si qualificano per avere come parte un’impresa
bancaria e rispettivamente un’impresa assicurativa.
Oppure può rilevare la generica qualità d’imprenditore: questo accade per l’identificazione di un tipo
contrattuale, come l’appalto.
Talora rileva solo la qualità di una parte: i contratti turistici s’identificano per avere una parte
qualificata dall’essere “organizzatore di viaggio”, o “venditore”, mentre controparte è “consumatore”.
A volte rilevano le qualità di entrambe le parti, come nei contratti fra “consumatori” e “professionisti”,
soggetti ad una disciplina speciale, o nei contratti di subfornitura, tra un’impresa “committente” ed una
“subfornitrice”.
CAPITOLO XIX – LA COSTRUZIONE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE:
VOLONTÀ DELLE PARTI E FONTI ESTERNE
Il regolamento contrattuale è l’insieme dei mutamenti che le posizioni giuridiche delle parti subiscono
per effetto del contratto: nascita, estinzione, trasferimento, modificazione di diritti e di obblighi.
Più in breve, è l’insieme degli effetti contrattuali.
In prima battuta, le fonti del regolamento contrattuale possono ricondursi a due categorie: fonti
autonome, e fonti eteronome.
Le fonti autonome si sintetizzano nella volontà delle parti, le fonti eteronome sono essenzialmente due:
la legge e la decisione del giudice.
L’abilitazione delle parti a determinare in modo autonomo il regolamento del loro contratto è sancita
dalla norma che si rubrica “Autonomia contrattuale” (1322.1): le parti possono liberamente
determinare il contenuto del contratto.
La volontà delle parti è fonte necessaria, mentre le fonti eteronome sono solo eventuali.
La volontà delle parti che, nel ruolo di fonte autonoma, opera per la costruzione del regolamento
contrattuale è la stessa volontà che opera per la formazione dell’accordo necessario a concludere il
contratto; inoltre è volontà manifestata.
Tuttavia non c’è sempre piena coincidenza fra i segni capaci di significare accordo per la conclusione
del contratto e segni capaci di significare concorde volontà su questo e quel punto del regolamento
contrattuale.
La volontà edificatrice del regolamento contrattuale è quella manifestata nel testo, piuttosto che quella
manifestata nella dichiarazione.
Il testo contrattuale è un insieme di proposizioni, che esprimono clausole.
La clausola è l’unità elementare del testo (e dunque del regolamento) contrattuale: è una disposizione
omogenea, con cui le parti regolano un determinato aspetto del loro rapporto.
Di regola le clausole sono organizzate in articoli con numerazione e talora sottonumerazione
progressiva, e talora con una rubrica che ne designa l’oggetto.
Non sempre, però, ad un articolo del testo corrisponde una clausola, ed una sola.
L’articolo, in quanto articolazione del testo, è una proposizione linguistica (od un insieme di
proposizioni).
Invece la clausola non è una proposizione, ma una disposizione: non ha valore linguistico, ma
precettivo.
Può essere importante distinguere fra clausole non autosufficienti, che non sarebbero concepibili se non
all’interno di un contratto (ad es. la clausola che determina il prezzo); e clausole autosufficienti, dette
anche clausole-contratto: queste potrebbero anche vivere di vita autonoma, costituendo da sole un
autonomo contratto: ad es. una clausola compromissoria, un patto di non concorrenza.
Può accadere che il testo contrattuale contenga proposizioni sfornite del valore di vero precetto
contrattuale: ciò può accadere con le c.d. clausole di stile (per es., la clausola con cui si dice che
l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali darà luogo a risoluzione del contratto, conseguenza già
prevista dalla legge).
Nella prospettiva dell’analisi economica del diritto le regole dedicate ai problemi dell’incompletezza
contrattuale si chiamano abitualmente default-rules.
Inoltre può accadere che la volontà delle parti non sia lacunosa, ma esprima contenuti disapprovati
dall’ordinamento.
In tal caso la regola volontaria non può stare nel regolamento contrattuale: ne viene espulsa, ed in luogo
di essa nel regolamento si insedia la diversa regola che l’ordinamento gradisce (1339).
Il meccanismo di costruzione del regolamento contrattuale ad opera di fonti eteronome si chiama
integrazione del contratto.
Vi sono vari passaggi attraverso i quali si giunge a definirne il regolamento.
Il primo passaggio è l’interpretazione, l’operazione che individua il giusto significato dei segni con cui
le parti hanno manifestato la volontà contrattuale.
Il secondo passaggio è la qualificazione: con essa si confronta il contratto coi tipi contrattuali, ed in
base al confronto si stabilisce se il contratto appartiene ad un tipo, oppure ad un altro tipo, oppure a due
tipi insieme, oppure a nessun tipo.
Il terzo passaggio è l’integrazione: qualificare il contratto significa identificare le norme che
concorrono a costruirne il regolamento.
L’interpretazione – in quanto diretta ad accertare un fatto storico, la comune volontà delle parti
ricostruita sulla base dei segni che la manifestano – produce giudizi di fatto; mentre la
qualificazione/integrazione – in quanto applicazione di norme giuridiche al fatto storico accertato in via
interpretativa – produce valutazioni di diritto: nel primo caso l’errore del giudicante è errore di merito,
insindacabile in sede di legittimità; nel secondo caso è errore di diritto, contro il quale si può insorgere
in Cassazione.
CAPITOLO XX – L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
L’interpretazione è l’attribuzione di un significato ai segni che manifestano la volontà contrattuale:
trovare il giusto significato del contratto è lo scopo dell’interpretazione.
L’interpretazione è sempre necessaria.
Oltre che determinare il significato del contratto, l’interpretazione delle dichiarazioni contrattuali può
avere anche un altro compito: accertare se il contratto s’è concluso.
L’interpretazione è soggetta a regole, che vincolano l’attività dell’interprete: quelle contenute negli artt.
1362-1371.
Se il giudice viola le regole legali d’interpretazione, incorre in errore di diritto: e la parte che si ritiene
penalizzata dall’ingiusta interpretazione può dolersene in sede di legittimità.
Da questo caso va distinto quello dell’interpretazione ingiusta per erroneo accertamento di un fatto
rilevante a fini interpretativi.
Inoltre le regole interpretative vincolano le parti.
L’interpretazione del contratto è materia disponibile dalle parti: esse possono concordare che la
clausola del loro contratto debba interpretarsi secondo un certo significato.
Per questo deve ritenersi che se le parti litiganti adducono in causa la stessa interpretazione del
contratto, il giudice non può disattenderla in favore di altra, da lui ritenuta più conforme agli artt. 1362
ss.
Se invece le parti adducono due interpretazioni divergenti, il giudice può decidere e motivare sulla base
di una terza interpretazione del contratto, non coincidente con nessuna delle due.
Vincolati alle regole interpretative possono essere anche terzi, variamente interessati al contratto.
Si ritiene che gli artt. 1362 ss. siano applicabili anche all’interpretazione di atti diversi dai contratti: atti
unilaterali; statuti, deliberazioni, regolamenti di organizzazioni; provvedimenti amministrativi.
L’interpretazione del contratto è operazione diversa dall’interpretazione della legge (12 prel.:
nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se
una
controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi
generali dell’ordinamento giuridico dello Stato), e sorge il problema se debbano applicarsi i criteri
dell’una o dell’altra per interpretare la clausola contrattuale che riproduca una norma legislativa;
conviene distinguere: ove la norma riprodotta sia imperativa, essa opera nel regolamento contrattuale
come fonte normativa d’integrazione, ove invece sia dispositiva, si può e si deve indagare – coi criteri
d’interpretazione del contratto – se la volontà delle parti fosse nel senso di attirarla nel regolamento con
un significato per avventura diverso da quello che le assegnerebbe l’interpretazione della legge; se sì,
questo diverso significato prevale.
Le regole d’interpretazione soggettiva cercano il significato corrispondente alla comune intenzione
delle parti (1362.1); le regole d’interpretazione oggettiva attribuiscono al contratto invece un significato
che la legge reputa obiettivamente congruo.
Prima si applicano le regole d’interpretazione soggettiva.
Base dell’interpretazione soggettiva è la regola che impone di indagare quale sia stata la comune
intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (1362.1).
Il 1364 suggerisce significati più ridotti di quelli che risulterebbero dal testo: anche se il contratto usa
espressioni generali, esso copre solo gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
Il 1365 ha invece una logica estensiva, perché suggerisce significati più ampi di quelli letterali: quando
una clausola indica il proprio oggetto od i propri effetti facendo specifico riferimento ad uno o più casi,
non si presumono esclusi i casi non espressi.
La norma si limita ad escludere qualsiasi presunzione di tassatività, senza creare alcuna
contropresunzione d’illimitata estensione oltre i casi non espressi: i casi non espressi sono coperti dalla
clausola solo se vi si possono ricondurre secondo ragione, e solo se da elementi extratestuali non
emerga che la comune intenzione delle parti era nel senso di escluderli.
Extratestuale per definizione è il criterio che il 1362.2 offre all’interprete: quello basato sulla
valutazione del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto
(1362.2.).
In quanto funzionale ad accertare la comune intenzione delle parti, il comportamento rilevante è quello
riferibile all’una ed all’altra, non il comportamento unilaterale di una sola di esse.
Il comportamento di una sola parte può però rilevare se manifesta un significato contrario all’interesse
di chi lo tiene.
Anche la protestatio è un comportamento della parte, di cui tener conto.
Il 2723 limita la prova testimoniale dei patti successivi al contratto scritto (Qualora si alleghi che, dopo
la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso,
l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità
delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte
aggiunte o modificazioni verbali), mentre nessun limite incontra chi vuole provare per testi una certa
interpretazione del contratto scritto.
Il 1362.2 dà rilevanza al comportamento “anche” successivo delle parti: se ne deduce che rileva pure
quello anteriore al contratto.
Di fronte ad un testo chiaro, prima facie dovrà pensarsi che il testo posteriore sia, per la sua stessa
posteriorità, più aderente alla comune intenzione delle parti di quanto lo siano gli anteriori elementi
extratestuali.
Non è escluso che risulti il contrario: ma dovrà risultare da elementi particolarmente forti.
Un significato antiletterale, conforme alla volontà delle parti, può scaturire dall’impiego del criterio di
globalità, che dà luogo alla c.d. interpretazione sistematica: le clausole del contratto si interpretano le
une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto (1363).
L’invalidità della clausola non ne esclude l’impiego come mezzo per interpretarne un’altra.
Il criterio della globalità riguarda anche i rapporti fra elementi di una stessa clausola, ed anche elementi
che non sono clausole in senso proprio, come le eventuali premesse al contratto, ed i suoi allegati.
Può estendersi, infine, ai rapporti fra il contratto da interpretare ed un contratto collegato.
L’applicazione delle regole d’interpretazione oggettiva è circoscritta da due condizioni d’uso.
La prima è l’oscurità del testo.
La seconda è l’impotenza dell’interpretazione soggettiva a chiarire il testo oscuro.
La prima regola che l’opinione comune riconduce all’interpretazione oggettiva è quella per cui il
contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1366) (peraltro qualche autore la colloca
nell’area dell’interpretazione soggettiva).
L’interpretazione secondo buona fede attribuisce al contratto il significato su cui una parte aveva fatto
legittimo affidamento.
La regola della coerenza dice che le espressioni polisense vanno intese nel senso più conveniente alla
natura e all’oggetto del contratto (1369); qualche autore la riconduce all’interpretazione oggettiva.
Esso impone di valorizzare “oggetto” e “natura” del contratto; quest’ultima allude alla causa del
contratto.
Un’altra regola d’interpretazione oggettiva, il 1368, dice d’interpretare il contratto secondo ciò che si
pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso; o, se una parte è imprenditore, nel
luogo in cui è la sede dell’impresa: emerge così la nozione di uso interpretativo.
Come mezzo d’interpretazione oggettiva, gli usi determinano il significato contrattuale a prescindere
dalla prova che le parti li conoscessero e li volessero; per contro, il loro impiego è escluso dalla
contraria volontà delle parti.
Le regole d’interpretazione oggettiva viste fin qui sono regole aperte: danno criteri per scegliere fra una
serie indefinita di possibili significati.
Invece le altre regole sono regole finalizzate: ipotizzano l’alternativa fra due possibili significati, e ne
impongono uno dei due in nome di una precisa politica legislativa: la legge preferisce che il contratto
sia efficace, anziché privo di effetti: di qui il criterio della conservazione, per cui nel dubbio, il
contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto,
anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1367).
L’interpretazione conservativa non deve essere smentita dall’effettiva volontà delle parti, e dev’essere
compatibile col testo (ambiguo) del contratto.
Il criterio s’applica anche alle singole clausole.
Può accadere che l’efficacia di una clausola ambigua (ad es. una condizione) determini l’inefficacia del
contratto cui accede, mentre se la clausola fosse neutralizzata il resto del contratto vivrebbe: in tal caso
si preferisce l’interpretazione che uccide la clausola, salvando il contratto.
La legge preferisce che il dubbio del testo sia sciolto in favore della parte che al testo ha solo aderito
senza partecipare alla sua redazione, e dunque contro la parte che lo ha predisposto: di qui la regola
dell’interpretazione contro il predisponente (contra stipulatorem: 1370).
La regola s’applica solo quando la predisposizione unilaterale riguardi clausole inserite nelle condizioni
generali di contratto o in moduli o formulari; ciò impedisce di applicarla ai testi predisposti
unilateralmente, ma in vista di un singolo affare.
La sua ratio è tutelare l’aderente nella contrattazione standardizzata.
La clausola dubbia del contratto fra professionista e consumatore s’interpreta a favore del consumatore
(1469-quater, comma 2), anche se il testo è stato predisposto per quel singolo affare.
Le regole finali (1371), che hanno un ruolo sussidiario, si basano sul principio di equità, e distinguono
fra contratto gratuito ed oneroso.
Il contratto gratuito deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato: la regola s’applica ai
contratti gratuiti, anche se non liberali.
Invece il contratto oneroso va inteso nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi
delle parti.
La regola non deve ridursi a doppione del criterio di coerenza alla causa concreta (1369): essa affida
alla prudente discrezionalità dell’interprete la ricerca del significato più conforme alla giustizia del caso
singolo, tenendo conto di motivi, aspettative, esigenze, interessi delle parti anche estranei alla causa del
contratto (ad es. perché sopravvenuti).
Ove l’ambiguità del testo si presenti nella forma estrema di un’inesorabile contradditorietà, non potrà
escludersi l’ipotesi che il contratto sia nullo per mancanza di accordo.
CAPITOLO XXI – L’INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
L’integrazione del contratto è la costruzione del regolamento contrattuale ad opera di fonti eteronome.
In ragione dei fini che persegue, si distingue fra integrazione suppletiva ed integrazione cogente: la
prima è amica dell’autonomia privata, la seconda le è antagonista.
In ragione dei modi in cui procede, si distingue fra integrazione legale ed integrazione giudiziale.
La principale base normativa dell’integrazione è il 1374: il contratto obbliga le parti non solo a quanto
è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in
mancanza, secondo gli usi e l’equità.
L’integrazione suppletiva “supplisce” alle lacune della determinazione volontaria.
La volontà delle parti è libera di regolare essa stessa i punti su cui solo in suo difetto opererebbe
l’integrazione suppletiva: e di regolarli in modo divergente da come questa li regolerebbe.
L’integrazione suppletiva opera in due modi: o con puntuali previsioni normative, o con la valutazione
del giudice.
Le puntuali previsioni normative possono scaturire da due fonti: norme dispositive di legge ed usi.
La valutazione del giudice si forma sulla base di due criteri di giudizio o di condotta: equità e buona
fede.
La legge che realizza l’integrazione suppletiva è l’insieme delle norme dispositive applicabili al
contratto.
Tempo e luogo del pagamento del prezzo nella vendita possono essere fissati liberamente dalle parti
(1498.1), ma se queste non lo fanno, li fissa la norma dispositiva (1498.2).
Le norme dispositive si chiamano anche suppletive: perché scattano solo in mancanza di
determinazione volontaria, alle cui lacune suppliscono.
Si chiamano anche derogabili.
Le norme dispositive possono avere posizioni e ruoli diversi.
Possono riguardare aspetti secondari dell’operazione (tempo e luogo del pagamento del prezzo); ma
anche aspetti che toccano il cuore dell’oggetto contrattuale, o comunque qualificano fortemente
l’impegno di una parte verso l’altra (si pensi alla disciplina delle garanzie nella vendita).
Norme come quelle su pagamento del prezzo e consegna della cosa sono recessive: è normale che i
punti da esse considerati trovino regola nell’accordo delle parti: il loro intervento suppletivo è
l’eccezione.
Invece norme come quelle sulle garanzie nella vendita sono dominanti: è normale che il venditore
garantisca per i vizi e l’evizione secondo la disciplina legale (è vero che questa è dispositiva e può
essere derogata dal contrario accordo delle parti, ma un siffatto intervento di determinazione volontaria
è visto come l’eccezione e non come la regola).
Il contratto è integrato dagli usi (1374); gli usi richiamati dal 1374 sono gli usi normativi, cioè le
consuetudini di cui all’8 prel., relative alla materia del contratto.
In caso di divergenza fra un uso ed una norma dispositiva, prevale l’uso.
Il richiamo da parte della legge, posto dall’8 prel. (Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti
gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.
Le norme corporative prevalgono
sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente
disposto.) è quello fatto dal 1374.
Nessun dubbio che l’uso possa in generale essere derogato dalla volontà delle parti.
Dagli usi normativi si distinguono gli usi contrattuali: sono le clausole d’uso, che s’intendono inserite
nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti (1340).
La distinzione rispetto agli usi normativi riguarda prevalentemente i requisiti che l’uso deve presentare,
per le clausole d’uso è sufficiente la pratica diffusa in una cerchia ristretta, per l’uso normativo occorre
la generalità della condotta uniforme.
Chi invoca l’uso – sia normativo sia contrattuale – ha l’onere di provarne l’esistenza.
È chiara, infine, la distinzione fra gli usi integrativi ex 1340 e 1374, e gli usi interpretativi ex 1368: gli
usi integrativi presuppongono una lacuna del testo contrattuale, gli usi interpretativi presuppongono che
la disposizione del testo contrattuale esista (oscura od ambigua).
La prima fonte dell’integrazione giudiziale è l’equità, richiamata (insieme con la legge e gli usi) dal
1374; tradizionalmente l’equità si definisce come la giustizia del caso singolo.
Applicata al contratto, essa autorizza il giudice a determinare aspetti del regolamento non contemplati
nell’accordo delle parti, né puntualmente definiti da leggi od usi.
L’equità è richiamata anche in altre norme della disciplina del contratto: come criterio per la
determinazione dell’oggetto ad opera dell’arbitratore, tenuto a procedere con equo apprezzamento; o
per l’impugnativa di essa, quando risulti manifestamente iniqua od erronea (1349.1); come criterio
offerto al giudice per decidere se accordare la liberazione dal vincolo (rescissione del contratto
concluso, in stato di pericolo, a condizioni inique: 1447.1); e, in caso di rescissione, come criterio per
assegnare a controparte un compenso che deve essere equo (1347.2).
Nello stesso contesto, viene in gioco a fini di salvataggio, mediante riequilibrio, del contratto
squilibrato: riduzione a equità del contratto rescindibile (1450) o risolubile per eccessiva onerosità
(1467.3 e 1468).
L’equità è anche regola (finale) d’interpretazione del contratto (1371).
Inoltre l’equità è richiamata, come fonte d’integrazione del regolamento, in relazione a singoli tipi
contrattuali (es.: “equo compenso” per il venditore se si risolve la vendita con riserva della proprietà,
1526.1; “equa indennità” per l’appaltatore che receda di fronte a variazioni progettuali eccedenti il
sesto, 1660.2).
L’equità è fonte d’integrazione suppletiva, e non cogente; la giustizia e l’equilibrio del contratto sono
decisi fondamentalmente dalle parti stesse.
Nella disciplina del contratto in genere, un controllo del giudice sull’equità del singolo scambio
contrattuale è ammesso solo in presenza di una condizione, quando l’accettazione del regolamento
iniquo dipende da circostanze oppressive.
Il principio ha comunque un’eccezione: la clausola penale “manifestamente eccessiva” può essere
“diminuita equamente dal giudice” ex 1384: è un caso d’integrazione (giudiziale) non suppletiva, ma
cogente.
Fuori della disciplina del contratto, l’equità è richiamata in tema di riparazione del danno (1226;
2047.2).
Dottrina e giurisprudenza riconoscono nella buona fede (oggettiva) un’importantissima fonte
d’integrazione del contratto.
La norma sull’integrazione (1374) richiama la legge, ed è legge il 1375, secondo cui il contratto deve
essere eseguito secondo buona fede.
Buona fede (oggettiva) è sostanzialmente sinonimo di correttezza; secondo il 1175 il debitore e il
creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
In contesti diversi dall’esecuzione del contratto, alla buona fede si richiamano norme sulle trattative
(1337) e sull’interpretazione (1366).
I differenti ruoli distinguono la buona fede dalla diligenza: la buona fede è criterio d’integrazione del
contratto, serve a determinare contenuti e modalità delle prestazioni o dei comportamenti
contrattualmente dovuti o vietati; la diligenza è criterio d’imputazione della responsabilità: serve a
stabilire se nell’eseguire la prestazione dovuta il contraente debitore abbia impiegato la cura,
l’attenzione, la competenza necessarie a renderlo irresponsabile dell’inadempimento.
Il principio di buona fede è derogabile dalle parti, od ha una natura imperativa che lo rende
inderogabile?
In linea di principio, le parti sono libere di concordare una regola opposta a quella che – in assenza di
accordo – scaturirebbe dall’integrazione secondo buona fede.
Sarebbe invece illecito, per contrarietà all’ordine pubblico, l’accordo con cui le parti escludano una
volta per tutte, in modo indifferenziato, che al loro rapporto s’applichi il principio di buona fede.
La buona fede obbliga la parte, che riceve una prestazione affetta da inesattezza rimediabile, a mettere
controparte in condizione di rimediare.
La buona fede obbliga la parte a cooperare con controparte per consentirle di adempiere.
La buona fede obbliga la parte a prestarsi per correggere errori o chiarire equivoci che potrebbero
gettare il rapporto nell’incertezza.
La buona fede obbliga la parte a modificare la prestazione a suo carico, quando ciò permetta – senza
suo sacrificio o con suo minimo sacrificio – di realizzare l’interesse di controparte, altrimenti frustrato.
In analoga prospettiva, dalla buona fede può discendere un obbligo di rinegoziare le condizioni
contrattuali, squilibrate da sopravvenienze.
La buona fede obbliga la parte alla coerenza dei propri comportamenti, per non deludere gli affidamenti
che questi hanno generato in controparte: la buona fede vieta alla parte di esercitare i propri diritti
contrattuali in modo formalmente lecito, ma sostanzialmente sleale e dannoso per controparte.
La buona fede vieta alla parte di trattare controparte in modo ingiustamente discriminatorio rispetto ad
altre controparti in circostanze analoghe.
Vi sono settori della dottrina propensi ad adibire il principio a funzioni di controllo dell’autonomia
privata e d’integrazione cogente, che la tradizione riserverebbe a strumenti diversi (norme imperative,
ordine pubblico, buon costume).
Segnali vengono dalla legislazione: la nuova disciplina dei contratti dei consumatori indica la buona
fede tra i criteri per stabilire la vessatorietà delle clausole, che in tal caso sono nulle.
Singole norme chiamano il giudice ad integrare singoli contratti tipici, o qualunque contratto in
relazione a singole vicende, espressamente impartendogli come criterio di giudizio l’equità; altre norme
fanno lo stesso, con la differenza che non gli impartiscono alcun espresso criterio di giudizio, ma
rinviano alla sua “determinazione” non altrimenti qualificata (può riguardare, per es., la fissazione di un
termine: per l’adempimento della prestazione, 1183.1).
Il giudice non può determinarsi in modo arbitrario, e nemmeno seguire un suo personale senso di
giustizia: deve decidere – e motivare – sulla base di tutte le circostanze rilevanti.
In sintesi: deve decidere e motivare in base ai principi di equità e/o buona fede.
L’integrazione cogente non supplisce un accordo mancante, ma si sovrappone ad un accordo esistente,
ma disapprovato dall’ordinamento giuridico perché violatore di interessi o valori preminenti.
Fonte dell’integrazione cogente sono, essenzialmente, le norme imperative.
Conviene distinguere fra i diversi modi – meramente proibitivi, o conformativi – in cui le norme
imperative possono incidere sul regolamento contrattuale.
La norma può vietare il contratto, complessivamente considerato: in tal caso l’intero contratto è nullo;
dunque non si pone alcun problema d’integrazione; diverso è quando la norma vieta un singolo,
determinato contenuto contrattuale: ad es., il 1681.2 vieta, nel trasporto di persone, le clausole che
limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
La norma ha una funzione conformativa rispetto al complessivo regolamento contrattuale, che ne esce
trasformato.
Norme come quelle appena considerate possono dirsi indirettamente conformative, ma esistono anche
norme direttamente conformative, che integrano non già il regolamento tramite cancellazione della
clausola, ma la clausola stessa nei suoi contenuti.
Il meccanismo con cui norme del genere integrano il regolamento contrattuale è la sostituzione
automatica prevista dal 1339.
La norma dispositiva per lo più s’apre dicendosi applicabile solo in mancanza di patto contrario, o salva
diversa volontà delle parti, o si chiude dicendosi derogabile dal diverso accordo delle parti.
La norma imperativa spesso è corredata dall’espressa dichiarazione di nullità dei patti contrari; oppure
disciplina le conseguenze del patto contrario in termini incompatibili con la sua validità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono
sostituite di diritto da norme imperative (1419.2).
La fonte della nuova conformazione del regolamento può essere direttamente la norma imperativa; ma
la norma può anche essere conformativa solo per relationem, limitandosi a rinviare ad un’altra fonte da
cui si ricavano i contenuti da inserire nel regolamento.
La disciplina della sostituzione automatica pone un problema teorico, e vari problemi applicativi.
Il problema teorico è: il contratto sottoposto ad integrazione cogente conserva natura di contratto, cioè
di atto negoziale di autonomia privata?
La risposta è: il contratto integrato resta un atto di autonomia privata.
È la conclusione già scelta per il contratto imposto, frutto di obbligo legale a contrarre.
Veniamo ai problemi applicativi.
La sostituzione automatica opera senza bisogno di espressa previsione della singola norma
conformativa, violata dall’accordo: ad attivare il meccanismo è sufficiente la previsione generale del
1339.
La fonte integratrice può anche non essere una norma primaria, ma un atto amministrativo o perfino un
atto non proveniente da una pubblica autorità, purché fatto oggetto di rinvio da parte della norma che
prefigura il meccanismo integrativo.
La norma prefiguratrice deve essere invece – essa sì – norma primaria, od almeno norma secondaria
autorizzata o delegata da una norma primaria.
Oggetto di sostituzione è la clausola vietata: cioè solo la parte del regolamento concordato che
confligge con la norma imperativa.
Il meccanismo dell’integrazione cogente opera già sulla proposta confliggente con la norma imperativa.
La parte che vede il proprio contratto integrato in senso svantaggioso per sé non può invocarne
l’annullamento per errore (di diritto), allegando la propria ignoranza della norma integratrice.
Vi sono norme imperative che proteggono non un interesse generale trascendente gli interessi
particolari dei contraenti, ma l’interesse di uno dei contraenti.
Sono le norme che possono essere derogare solo in una direzione: quella di un maggior favore per il
contraente protetto.
Talora l’unilateralità risulta per implicito dalla struttura stessa della norma, che impone il rispetto di un
minimo o di un massimo.
Altre volte l’unilateralità è sancita con formule diverse.
Ma alla stessa famiglia appartengono tutte le norme che disciplinano un contratto nella prospettiva di
tutelare una parte contro l’altra, anche se non contengono un’espressa autoqualificazione di
(unilaterale) imperatività.
Fondamento politico-ideologico delle norme unilateralmente imperative è la concezione che intende
libertà ed uguaglianza in senso sostanziale, e non solo formale.
La differenza di trattamento non realizza una discriminazione anticostituzionale (violatrice del 3.1
Cost.: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.), nella
misura in cui persegua – secondo ragionevolezza – obiettivi di uguaglianza sostanziale (3.2 Cost.: È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.).
CAPITOLO XXII – GLI EFFETTI DEL CONTRATTO
Gli effetti del contratto sono essenzialmente le modificazioni che il contratto determina nelle posizioni
giuridiche delle parti.
Di “rapporto giuridico” parla il 1321, per indicare la realtà su cui il contratto incide coi suoi effetti.
Dato che le posizioni giuridiche sono, essenzialmente, diritti ed obblighi, gli effetti giuridici possono
consistere: nel creare fra le parti diritti ed obblighi che prima non esistevano; nel modificare diritti ed
obblighi preesistenti; nel trasferire ad una parte diritti ed obblighi che prima non le appartenevano;
nell’estinguere diritti ed obblighi che in precedenza esistevano fra le parti.
C’è un nesso tra effetti del contratto ed accordo delle parti: senza accordo delle parti non c’è contratto,
e senza contratto non ci sono effetti contrattuali.
Ma il fenomeno dell’integrazione apre la strada ad effetti del contratto che non corrispondono
all’accordo delle parti.
La volontà delle parti è abilitata (anche se non in esclusiva) a disporre degli effetti contrattuali.
“Efficacia” è la qualità che il contratto possiede, in quanto produce i suoi effetti: il contratto produttivo
dei suoi effetti si dice “efficace”.
L’efficacia del contratto non va confusa con la sua vincolatività: quest’ultima è la caratteristica per cui
il contratto, una volta validamente concluso, vincola le parti a tenere comportamenti e subire risultati
coerenti con l’attuazione del programma contrattuale; sicché anche un contratto inefficace può essere
vincolante (è il caso del contratto sottoposto a condizione sospensiva).
Effetti obbligatori sono la nascita di nuove obbligazioni e dei corrispondenti diritti di credito; nonché la
modificazione od estinzione di obbligazioni e crediti preesistenti.
Effetti reali sono: la costituzione di un nuovo diritto reale, prima inesistente; il trasferimento della
proprietà o di un altro diritto reale; il trasferimento di qualsiasi altro diritto, diverso dai diritti reali.
Può considerarsi effetto reale anche l’estinzione del diritto reale minore, perché riattribuisce al
proprietario il diritto di proprietà nella sua originaria pienezza.
Il riconoscimento generale del contratto come fonte di effetti reali è nella norma sui modi di acquisto
della proprietà, dove si legge che la proprietà si acquista […] per effetto di contratti (922).
In relazione al tipo di effetti che producono, i contratti si distinguono in contratti con effetti obbligatori
e contratti con effetti reali.
Contratti con effetti reali sono quelli che producono effetti reali: ad es. donazione, vendita, permuta,
cessione di credito.
Un superficiale parallelismo potrebbe suggerire che siano contratti con effetti obbligatori quelli che
producono effetti obbligatori, ma non è così: sono tali i contratti che producono esclusivamente effetti
obbligatori (e nessun effetto reale).
Il contratto che produca insieme effetti obbligatori e reali sfugge alla categoria, per cadere in quella dei
contratti con effetti reali.
Anche i contratti che tipicamente producono effetti reali producono insieme qualche effetto
obbligatorio: la vendita, oltre al trasferimento della proprietà della cosa venduta, genera l’obbligo del
compratore di pagare il prezzo e quello del venditore di consegnare la cosa; non è ad effetti reali la
locazione: a favore del conduttore non viene trasferito un diritto preesistente nel patrimonio del
locatore, ma costituito un diritto nuovo, che è un diritto di credito.
Problema fondamentale dei contratti con effetti reali è il tempo ed il modo in cui si producono tali
effetti; lo risolve il 1376: la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso
delle parti legittimamente manifestato.
S’afferma così il principio consensualistico, o del consenso traslativo, o dell’effetto traslativo del
consenso.
Consenso legittimamente manifestato significa manifestato nei modi e nelle forme richiesti dalla legge
per la valida conclusione del contratto.
L’effetto reale si produce dunque nel momento stesso in cui si conclude il contratto (la formalità
pubblicitaria non produce l’effetto reale, già prodotto dal contratto, ma solo la sua opponibilità ai terzi).
La giurisprudenza precisa che con la conclusione del contratto passa al compratore non solo la
proprietà, ma anche il possesso della cosa, e ciò a prescindere dalla consegna: prima della consegna il
compratore, proprietario, possiede la cosa mediatamente, tramite il venditore che la detiene come
custode.
I terzi sono tutelati con regole che, proprio per tutelarli, finiscono per limitare la portata del principio
consensualistico: la regola “possesso vale titolo” per i mobili; la regola che, fra più acquirenti dello
stesso immobile, privilegia non il primo acquirente ma il primo trascrivente.
Il principio consensualistico è figlio del giusnaturalismo illuminista, portatore di una concezione che
valorizza la volontà umana come diretta produttrice di effetti giuridici.
Il principio diverge dal diritto romano, che legava il passaggio di proprietà della cosa alla sua traditio.
Il 1376 non è norma imperativa, ed il principio consensualistico non è di ordine pubblico: le parti
possono derogarvi.
Il 1465.1 afferma che la distruzione accidentale della cosa dopo la produzione dell’effetto traslativo
non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia
stata consegnata.
Per quanto riguarda i terzi:
danneggiati dalla cosa, le regole che imputano la responsabilità al proprietario (2052-2054) danno al
danneggiato azione contro il dante causa se il fatto dannoso è anteriore al contratto traslativo; contro
l’avente causa se il fatto è posteriore;
creditori del dante causa: solo fino al momento del contratto traslativo possono aggredire il bene che
ne forma oggetto (salvo il posteriore, vittorioso esercizio di azione revocatoria contro il contratto);
aventi causa dal dante causa di un precedente contratto traslativo: appena concluso quest’ultimo, il
dante causa perde il diritto trasferito, e così la legittimazione a disporne; se ciononostante dispone
ulteriormente del diritto a favore di un terzo, questi acquista a non domino, e perciò in linea di
principio inefficacemente.
Ma a favore del terzo soccorrono regole (“possesso vale titolo”; priorità delle trascrizioni) che
limitano dall’esterno l’operare del consenso traslativo.
Non sempre il contratto ad effetti reali obbedisce al principio consensualistico: può accadere che
l’effetto traslativo (od in genere reale) scatti solo in un momento successivo alla conclusione del
contratto.
Ciò può accadere per volontà delle parti, o per necessità imposta dalla peculiare natura del bene che
forma oggetto del contratto traslativo (cosa generica, futura, altrui).
Nell’uno e nell’altro caso, dal contratto sorge a carico dell’alienante un’obbligazione: quella di fare
acquistare all’avente causa la cosa o il diritto (cfr. il 1476 n. 2: tra le obbligazioni principali del
venditore v’è quella di far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non
è effetto immediato del contratto).
Il contratto non cessa per questo di essere contratto ad effetti reali.
Il contratto che trasferisce cose generiche non produce effetto reale immediato: ciò risulta dal 1376, ove
si riferisce tale effetto al trasferimento della proprietà di una “cosa determinata”, implicitamente
escludendolo per il trasferimento di cose generiche: quelle determinate solo per la loro appartenenza ad
un dato genere merceologico, e per la quantità da trasferire.
L’effetto traslativo si produce dopo il contratto, con l’individuazione (1378): questa è l’atto con cui si
enucleano – all’interno del genere previsto, e nella quantità concordata – le entità concrete da trasferirsi
all’acquirente per diventare sua proprietà.
L’individuazione è prestazione dovuta dall’alienante.
Se il contratto non ne prevede le modalità, l’individuazione si fa “d’accordo fra le parti”.
L’individuazione può essere rifiutata quando l’alienante pretenda di farla in violazione del contratto: in
tal caso l’alienante è inadempiente.
Se invece il rifiuto dell’acquirente è ingiustificato, il rimedio è la mora del creditore (1206 ss.); ma può
ipotizzarsi anche la diretta inefficacia del rifiuto, e la conseguente efficacia dell’individuazione.
Per le cose che devono essere trasportate, l’individuazione può anche coincidere con la consegna di
esse al vettore od allo spedizioniere (1378).
Dal trasferimento di cose generiche va distinto il trasferimento di una massa di cose: questo ricorre
quando le cose sono considerate dalle parti come un’unica entità; ad esso s’applica il principio del
consenso traslativo.
Il bene futuro non è un oggetto impossibile, ma in questo caso è impossibile l’effetto traslativo
immediato.
L’effetto traslativo è differito ad un momento successivo: quello in cui la cosa viene ad esistenza (cfr. il
1472.1: nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non
appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la
proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati); ma in questo momento
l’effetto si produce immediatamente ed automaticamente.
Nel caso di trasferimento di beni altrui, in luogo dell’effetto reale, si produce immediatamente un
effetto obbligatorio: a carico del venditore di bene altrui nasce l’obbligazione di procurarne l’acquisto
al compratore (1478.1).
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare
originario del bene (1478.2).
Può esservi anche trasferimento diretto dal terzo proprietario al compratore: in tal caso l’effetto
traslativo non deriva dalla vendita, ma dall’atto del proprietario, che si configura quale adempimento
del terzo; la vendita continua a restare fonte dell’impegno traslativo del venditore, contro il quale il
compratore può esercitare i rimedi per l’inattuazione di tale impegno (garanzie per evizione e per vizi).
Accanto ai limiti interni, necessitati dalla natura del bene, il principio consensualistico conosce limiti
esterni, convenzionalmente imposti per scelte di politica legislativa.
Un caso è la costituzione di garanzie reali: per produrre l’effetto reale, consistente nel far nascere pegno
od ipoteca, non basta l’accordo fra costituente e beneficiario, che è titulus dell’attribuzione del diritto:
occorre in più un modus, rappresentato dallo spossessamento per il pegno di beni mobili (2786), dalla
notificazione al debitore o dalla sua accettazione per il pegno di crediti (2800), dall’iscrizione nei
registri immobiliari per l’ipoteca (2808.2).
Queste varianti del modus svolgono tutte una funzione pubblicitaria.
L’indirizzo consensualista sostiene che anche i titoli di credito si trasferiscono secondo il principio del
1376, e dunque col solo accordo delle parti: le ulteriori formalità darebbero all’acquirente non la
titolarità del diritto, già trasferito col consenso, ma la legittimazione al suo esercizio.
Oggi però sembra prevalere l’opposto indirizzo anticonsensualista.
Il principio consensualista è poi ridimensionato dalle regole che proteggono i terzi acquirenti a non
domino: esse parzialmente sterilizzano gli effetti reali prodotti dal consenso, rendendoli inopponibili ai
terzi protetti.
Se A trasferisce a B un mobile non registrato senza consegnarglielo, certo il 1376 rende B proprietario,
ma se A poi cede ad X lo stesso bene, e ricorrono tutti gli elementi della regola “possesso vale titolo”,
proprietario diventa X (1153).
I contratti di accertamento sono quelli che, data una situazione d’incertezza sull’esistenza o sul
contenuto di posizioni soggettive delle parti, la eliminano chiarendo se la posizione esiste, e che
contenuto ha.
Il contratto di accertamento è titolo in base a cui la parte può agire contro l’altra per attuare il proprio
diritto, in esso accertato: il diritto si presume.
Qui la causa è la semplificazione probatoria di una posizione soggettiva preesistente.
Emerge così la differenza rispetto alla transazione: anche questa implica l’incertezza di posizioni
preesistenti; ma la risolve non accertando quale sia la situazione reale, ma mediante concessioni
reciproche delle parti, suscettibili (a differenza del contratto di accertamento) di modificare le
precedenti posizioni delle parti.
La confessione invece è atto unilaterale, e soprattutto non è un negozio, ma una dichiarazione di
scienza, il che ne circoscrive le possibili ragioni d’impugnativa (2732: La confessione non può essere
revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza).
La differenza rispetto alla ricognizione unilaterale sta nella maggior ampiezza con cui opera l’effetto di
semplificazione probatoria: anche su diritti reali, e non solo su rapporti obbligatori.
I contratti normativi sono i contratti con cui le parti definiscono le clausole di futuri contratti.
Da essi nasce l’obbligo di inserire tali clausole nei futuri contratti.
Possono essere contratti autonomi; ma anche parte di più ampi contratti, con oggetti ulteriori.
Quando il contratto non si limita a fissare determinate clausole dei contratti futuri, ma prevede l’intero
regolamento di questi, il cui contenuto coinciderà col contenuto del contratto normativo, questo prende
il nome di contratto tipo.
I contratti normativi interni sono quelli in cui le parti coincidono con le parti dei futuri contratti, da essi
regolati.
I contratti normativi esterni sono quelli che definiscono le clausole di futuri contratti che saranno
conclusi fra una delle parti e qualche terzo.
Se la parte impegnata è inadempiente (cioè inserisce nel contratto clausole diverse da quelle previste
nel contratto normativo), ne risponde all’altra parte del contratto normativo; invece il contratto col terzo
non dovrebbe restarne toccato nella sua validità ed efficacia, ma se le clausole disattese fossero più
vantaggiose per il terzo di quelle effettivamente inserite, anche il terzo avrebbe forse una pretesa contro
la parte inadempiente.
Nella figura del contratto normativo di fonte associativa non v’è coincidenza nemmeno parziale fra le
parti di esso e le parti dei futuri contratti regolati: queste ultime sono soggetti appartenenti a certe
categorie economico-sociali, mentre le parti del contratto normativo sono le organizzazioni
rappresentative di esse (es.: il contratto collettivo di lavoro).
I contratti normativi sono contratti su contratti (futuri).
CAPITOLO XXIII – IL VINCOLO CONTRATTUALE
Il 1372.1 dice che il contratto ha forza di legge tra le parti: il contratto vincola le parti, così come la
legge vincola i suoi destinatari.
Il vincolo contrattuale è la soggezione delle parti agli effetti del loro contratto.
Peraltro può – temporaneamente – non esservi coincidenza tra vincolo ed effetti.
Secondo la teoria del c.d. inadempimento efficiente, l’inadempimento va approvato ed incoraggiato
ogni volta che la sua conseguenza economica, e cioè il risarcimento per equivalente a carico
dell’obbligato, determini un’allocazione delle risorse più efficienti di quella che deriverebbe dal fedele
adempimento.
Il vincolo contrattuale si giustifica in quanto figlio della libertà contrattuale.
Il vincolo non si scioglie per volontà del singolo contraente, che non lo gradisca più.
Un altro significato del vincolo è l’immodificabilità del regolamento contrattuale ad opera del singolo
contraente.
Un significato ancora diverso è l’irretrattabilità degli effetti contrattuali consumati: il comodante può
chiedere quando vuole la restituzione della cosa, ma è pur sempre vincolato a sopportare che il
comodatario abbia, fino a quel momento, usato la cosa senza corrispettivo.
A volte invece appaiono discutibili ulteriori significati: si dice che vincolo contrattuale significa
obbligo del contraente di adempiere il contratto, e, in caso d’inadempimento, sua soggezione
all’esecuzione in forma specifica e/o al risarcimento del danno.
Questo è vero, ma sembra da riferire alla forza non tanto del contratto, quanto dell’obbligazione.
Si dice, ancora, che un altro senso del 1372.1 consista nell’attribuire la forza di legge, che il contratto
ha fra le parti, al contratto stesso, e non alla legge né al giudice: e si vede una deviazione dal principio
del vincolo contrattuale nei casi in cui il regolamento vincolante per le parti deriva da norme o da
decisioni giudiziali.
Il principio del vincolo contrattuale incontra limiti di varia natura ed intensità.
Il mutuo consenso allo scioglimento del contratto (o risoluzione convenzionale, o mutuo dissenso) non
intacca in nessun modo il valore del vincolo contrattuale; anzi lo conferma.
Esso è un contratto, diretto ad estinguere un rapporto giuridico patrimoniale: il rapporto creato dal
precedente contratto.
La legge ammette che in presenza di determinate cause il vincolo contrattuale possa sciogliersi (o
modificarsi nei contenuti) per iniziativa di una parte.
Ad esempio vi sono molti casi in cui una norma riconosce a ciascuna parte (o ad una sola fra esse) il
potere di recedere unilateralmente dal contratto (recesso legale), inoltre vi sono eventi in presenza dei
quali la legge attribuisce ad una parte il potere di chiedere la risoluzione del contratto.
In breve: possono considerarsi cause ammesse dalla legge per lo scioglimento del vincolo tutte quelle
che legittimano la parte, contro cui l’altra rivolga una pretesa fondata sul vincolo contrattuale, a
respingerla eccependo la propria liberazione dal vincolo per fatti che privano il contratto dell’idoneità a
produrre o mantenere il vincolo stesso.
Le parti sono libere di pattuire una clausola che renda possibile ad una parte sciogliere o modificare il
contratto.
Quanto alle modifiche al contenuto del contratto, vi sono norme che prevedono clausole attributive di
ius variandi a favore di una parte.
Quanto allo scioglimento, ricordiamo le norme sulle clausole di recesso (recesso convenzionale); sulla
clausola risolutiva espressa; sulla condizione risolutiva.
Ci si può domandare se l’autonomia privata sia libera di derogare, per accordo delle parti, al rigore del
vincolo contrattuale anche in campi non coperti da previsioni legali.
Si può porre anche il problema inverso: se, ed in che limiti, l’autonomia privata possa derogare alle
previsioni legali che attribuiscono alla parte poteri di liberazione dal vincolo o di modifica del suo
contenuto.
Il problema va risolto in modi diversi, a seconda che le norme che nei singoli casi attribuiscono alla
parte tali poteri siano imperative o meno.
CAPITOLO XXIV – SCIOGLIMENTO E MODIFICAZIONE DEL VINCOLO:
RISOLUZIONI, RECESSI, IUS VARIANDI
Il mutuo dissenso – più comunemente risoluzione consensuale, o convenzionale – è il contratto con cui
le parti sciolgono un precedente contratto fra loro, liberandosi dal relativo vincolo (contratto
risolutorio); lo menziona il 1372.1.
Il mutuo dissenso solleva principalmente due problemi.
Il più discusso riguarda la forma: il contratto di scioglimento ha forma libera, od esige la stessa forma
richiesta per il contratto da sciogliere?
Sembrano da preferire soluzioni che esonerino dal vincolo di forma almeno i mutui dissensi non
implicanti vicende reali immobiliari.
La giurisprudenza affranca la risoluzione consensuale dai vincoli probatori del 2723 (divieto di provare
per testi patti aggiunti o contrari ad un documento).
Il contratto modificativo vuole la stessa forma richiesta per il contratto da modificare, e subisce i limiti
probatori del 2723.
Si domanda poi se il mutuo dissenso sciolga il contratto retroattivamente; o se invece incida solo sul
rapporto, sciogliendolo ex nunc: la risposta va cercata innanzitutto nello stesso contratto risolutorio, in
cui le parti sono libere di concordare l’una o l’altra soluzione; nel silenzio delle parti si applicherà il
regime legalmente previsto per recessi e risoluzioni.
Il recesso è il negozio unilaterale con cui la parte di un contratto ne dispone lo scioglimento.
Applicato a singoli tipi, prende nomi particolari: il recesso del lavoratore si chiama dimissioni e quello
del datore licenziamento; il recesso del mittente di merci si chiama contrordine; il recesso
dell’organizzatore o venditore di pacchetti turistici si chiama annullamento del viaggio o cancellazione
del pacchetto; il recesso del mandatario si chiama rinunzia e quello del mandante revoca.
“Revoca” è, più propriamente, l’atto unilaterale con cui l’autore di un precedente atto unilaterale gli
toglie efficacia.
Il recesso è materia di un diritto potestativo della parte, attribuito o direttamente dalla legge (recesso
legale) o da una clausola del contratto (recesso convenzionale); può spettare ad entrambe le parti, o ad
una sola di esse.
L’atto di recesso è ricettizio: va indirizzato a controparte, e produce effetto nel momento in cui le
perviene.
La forma può essere vincolata, se così prevede la fonte attributiva del diritto; in mancanza di vincolo
formale espresso, occorre comunque la stessa forma richiesta per il contratto da cui si recede.
L’esercizio del recesso può avere effetto immediato (recesso in tronco, o ad nutum), oppure richiedere
un termine di preavviso.
Può essere affiancato da ogni limite di tempo, o soggiacere ad un termine: finale o iniziale e finale.
Una volta esercitato e reso produttivo di effetti dalla comunicazione al destinatario, il recesso è
irrevocabile.
Il recesso si distingue dalla c.d. disdetta, che è la dichiarazione con cui si esclude il rinnovo del
contratto dopo la scadenza.
L’esecuzione (od attuazione) del contratto è l’esecuzione (od attuazione) delle prestazioni contrattuali.
Là dove il contratto produce effetti obbligatori, le prestazioni contrattuali sono le prestazioni dedotte
nelle obbligazioni che ne nascono: e l’esecuzione del contratto coincide con l’adempimento di esse.
Là dove produce effetti reali, le prestazioni contrattuali s’identificano con l’attuazione dell’effetto
reale.
I contratti ad esecuzione istantanea sono quelli in cui l’esecuzione del contratto si concentra, per
ciascuna delle parti, in un’unica operazione od in un unico effetto.
Nell’ambito di essi, distinguiamo contratti ad esecuzione immediata e ad esecuzione differita.
Sono contratti ad esecuzione immediata quelli in cui le prestazioni devono attuarsi contestualmente alla
conclusione.
Sono contratti ad esecuzione differita quelli in cui almeno una delle prestazioni (adempimento
dell’obbligazione, produzione dell’effetto reale) deve attuarsi in tempo successivo alla conclusione del
contratto.
Ai contratti ad esecuzione istantanea si contrappongono i contratti di durata, in cui almeno una delle
prestazioni non si esaurisce in un’operazione od in un effetto istantaneo.
Essi si distinguono ulteriormente in due categorie: contratti ad esecuzione continuata e periodica.
Nei contratti ad esecuzione continuata la prestazione si attua nel tempo, senza soluzione di continuità
(ad es.: la locazione, per la prestazione del locatore).
Nei contratti ad esecuzione periodica la prestazione si attua con erogazioni di beni od attività ripetute
ad intervalli di tempo (ad es.: i canoni mensili dovuti dal conduttore).
Un contratto può essere ad esecuzione continuata per una prestazione, e periodica per la
controprestazione: se una prestazione è ad esecuzione istantanea, mentre la controprestazione è ad
esecuzione continuata o periodica, si applica il regime dei contratti di durata.
Per l’appalto d’opera si suggerisce la qualifica di contratto ad esecuzione prolungata.
Il recesso convenzionale è quello non previsto dalla legge, ma autorizzato da una clausola del contratto.
La libertà delle parti di pattuire clausole di recesso è riconosciuta in via generale dal 1373.
Il 1373 detta anche una disciplina del recesso convenzionale, differenziandola a seconda della categoria
di contratti cui si applica.
Questa disciplina ha natura solo dispositiva: il 1373.4 fa salvo in ogni caso il patto contrario.
Nei contratti ad esecuzione istantanea, la facoltà di recesso può essere esercitata finché il contratto non
abbia avuto un principio di esecuzione (1373.1).
Secondo la giurisprudenza, quando il titolare del diritto di recesso è inadempiente, non può più recedere
se controparte abbia chiesto la risoluzione del contratto; può ancora farlo, se controparte abbia chiesto
l’adempimento.
Un problema discusso è se sia concepibile il recesso nei contratti ad effetti reali.
Che la possibilità di recesso nei contratti ad effetti reali non ripugni al sistema, trova conferma
nell’espressa previsione di meccanismi quali la condizione risolutiva potestativa ed il patto di riscatto
nella vendita.
Le parti sono libere di conformare il recesso come retroattivo o non retroattivo.
La giurisprudenza esclude che sia vero e proprio recesso quello previsto come esercitabile quando
l’esecuzione del contratto sia già completamente esaurita.
Al recesso convenzionale nei contratti ad esecuzione continuata o periodica è dedicata una norma
specifica (1373.2), che contiene due regole.
La prima è che qui, a differenza che nei contratti ad esecuzione istantanea, il recesso è esercitabile
anche dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione.
La seconda regola è che il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguire od in corso di
esecuzione.
Il problema si pone per i contratti ad esecuzione continuata: qui la prestazione – unica, indifferenziata,
non soggetta a soluzioni di continuità – è sempre in corso di esecuzione: per le prestazioni continuate,
in corso di esecuzione, il recesso non ha effetto limitatamente alla porzione di prestazione eseguita e
goduta prima del recesso.
Anche la disciplina del 1373.2 è derogabile.
Le parti possono prevedere che il recesso non sia gratuito per il recedente: possono cioè pattuire la
prestazione di un corrispettivo per il recesso, che si chiama multa penitenziale.
Se è così, l’eventuale recesso ha effetto solo quando la prestazione è eseguita (1373.3).
Resta ferma la disciplina generale del recesso, ed in particolare la regola che lo preclude quando vi sia
un principio di esecuzione.
Se la prestazione per il recesso consiste in denaro o cose fungibili, e – anziché solo promessa – viene
data al momento della conclusione del contratto, si ha caparra penitenziale (1386): in tal caso il
recedente perde la caparra data e deve restituire il doppio di quella ricevuta (1386.2).
La caparra penitenziale ha la sola funzione di corrispettivo del recesso (1386.1), invece la caparra
confirmatoria ha una funzione diversa, che prescinde dalla pattuizione di un recesso convenzionale;
essa opera come rimedio contro l’inadempimento, collegandosi con la previsione (legale) di un recesso
di autotutela.
Non è la caparra che crea il diritto di recesso: è piuttosto il recesso pattuito che, se si prevede una
caparra, qualifica questa come penitenziale.
Di fronte alla pattuizione di una generica caparra, deve prima facie presumersi che essa sia
confirmatoria.
Recesso legale è quello previsto dalla legge, a favore d’una parte o di entrambe.
Recessi legali sono previsti nella disciplina di molti contratti tipici (o di situazioni contrattuali tipiche),
con logiche e funzioni diverse fra loro.
Si pongono due questioni: la prima è se sia applicabile al recesso legale la disciplina del 1373,
nominalmente rivolta al recesso convenzionale: le regole del 1373 potranno considerarsi utile punto di
riferimento, nella misura in cui la loro ratio non sia contraddetta dalla specifica, e divergente, ratio
della singola norma fondativa del recesso legale.
La seconda questione è se la disciplina del recesso legale sia imperativa, o derogabile dalle parti: la
risposta dipende dalla qualità degli interessi protetti dal recesso legale.
Chiamiamo recessi di liberazione quelli dati alla parte per consentirle di sottrarsi ad un vincolo
contrattuale che diversamente peserebbe in modo intollerabile sulla sua libertà: come accade,
tipicamente, con i contratti di durata a tempo indeterminato (es.: somministrazione, locazione, deposito,
comodato).
Quasi sempre (tranne i casi del deposito e del comodato, ove il recesso è “a vista”), il recedente è
tenuto al preavviso.
In alcuni casi la legge dà alla parte facoltà di recesso, per consentirle di reagire contro eventi
sopravvenuti che minacciano i suoi interessi contrattuali: definiamo questi recessi come recessi di
autotutela.
I recessi di autotutela (a differenza di quelli di liberazione) non sono rimessi alla pura valutazione del
recedente, ma sono esercitabili solo in presenza di determinati presupposti.
Presupposto giustificante può essere l’inadempimento di controparte.
Il danno per l’inadempimento viene liquidato forfetariamente nella misura della caparra.
Ma se chi subisce l’inadempimento preferisce, può chiedere la liquidazione del danno secondo i criteri
generali: in tal caso non recederà, ma chiederà la risoluzione per inadempimento.
Presupposto può essere qualunque fatto che integri giusta causa o giustificato motivo o gravi motivi:
formule ampie ed elastiche, che ricomprendono sia inadempimento di controparte, sia fatti oggettivi
non imputabili.
Talora la giusta causa non è condizione di efficacia del recesso, ma solo di esonero del recedente da
obblighi che dovrebbe sopportare se recedesse senza giusta causa: in particolare, l’onere di dare
preavviso o d’indennizzare controparte per il mancato preavviso.
La legislazione speciale prevede il recesso come autotutela di chi subisce il ius variandi di controparte:
il cliente, di fronte alle modifiche di prezzo o condizioni apportate, pur legittimamente, dalla banca,
può recedere.
I recessi di pentimento sono quelli che la legge dà ad una parte, senza vincolarli ad alcun presupposto,
perché ritiene opportuno – in una logica di speciale protezione della parte – consentire a questa di
cambiare idea rispetto al contratto già concluso.
Ne offre esempi il codice, ad es.: in favore del committente nell’appalto (1671), del mittente nel
trasporto di cose (1685.1), del committente nella commissione (1734).
Fra le previsioni del codice e quelle della legislazione speciale di protezione dei consumatori c’è una
sostanziale differenza: le prime consentono sì il recesso immotivato, ma obbligano il recedente ad
indennizzare o risarcire l’altra parte; invece le seconde precisano imperativamente che il consumatore
non è tenuto a pagare alcunché a fronte del suo recesso.
Forma un capitolo a sé il recesso dai contratti associativi, che creano un’organizzazione: associazioni,
società, consorzi.
Il recesso del singolo membro conserva questo nome, mentre il recesso dell’organizzazione (che
espelle il membro) si chiama esclusione (dell’associato, del socio, del consorziato).
La disciplina varia a seconda del tipo di organizzazione.
Si dice ius variandi il potere della parte di modificare unilateralmente, senza il consenso di controparte,
uno o più punti del regolamento contrattuale concordato.
Le fattispecie legali di ius variandi sono rare: ricordiamo il potere dato dal 1661 al committente di
introdurre unilateralmente variazioni al progetto, dunque alla prestazione dell’appaltatore; il potere del
datore di lavoro di mutare le mansioni del dipendente, cioè i contenuti della sua prestazione lavorativa
(2103).
I poteri così attribuiti sono poteri circoscritti da criteri legali che riducono drasticamente la
discrezionalità di chi li esercita: le variazioni del committente non possono superare, per valore, il sesto
del prezzo complessivo, e non devono importare notevoli modificazioni (1661); le nuove mansioni
assegnate dal datore al dipendente devono essere equivalenti alle ultime effettivamente svolte (2103).
Un ius variandi molto speciale è la possibilità, data alla parte convenuta in rescissione o risoluzione per
eccessiva onerosità, di offrire la riduzione ad equità del contratto per evitarne la cancellazione.
Al di là dei casi in cui la legge lo prevede, deve riconoscersi l’ammissibilità di clausole che
attribuiscono ad una parte il potere di modificare unilateralmente, in modo efficace e vincolante per
l’altra, l’originario contenuto del contratto?
Mentre le clausole di recesso, che consentono di sciogliere unilateralmente il contratto, sono ammesse
in via generale (1373), nessuna norma analogamente legittima clausole che ne consentono l’unilaterale
modifica.
Se ne potrebbe dedurre l’illiceità per contrasto con l’ordine pubblico.
L’ordinamento conosce la nullità di protezione, che travolge clausole pur volute dalla parte
pregiudicata.
Un ulteriore indizio può ricavarsi dall’elenco del 1341.2: data l’indiscutibile onerosità della clausola di
ius variandi, la sua mancata inclusione tra quelle inefficaci se non approvate specificamente per iscritto
può spiegarsi solo sul presupposto che essa sia comunque nulla.
Ma indizi contrari risultano dalle discipline speciali: clausole di ius variandi nei contratti dei
consumatori sono indicate come presuntivamente vessatorie, e quindi inefficaci, se presentano certi
contenuti.
Ma ciò ha senso solo sul presupposto che tali clausole siano in linea di principio lecite.
Conviene distinguere, in relazione all’interesse cui il ius variandi risulta finalizzato: se è attribuito ad
una parte nel prevalente interesse di controparte, è certamente lecito: si configura allora come poteredovere.
Se invece è attribuito nel prevalente interesse della parte abilitata ad esercitarlo, conviene verificarne la
formulazione concreta. Se questa fissa criteri e limiti idonei ad imbrigliare l’arbitrio del titolare e così a
garantire controparte da irragionevoli e pregiudizievoli sorprese, la clausola è lecita.
Se invece la clausola consegna un ius variandi illimitato, senza preventivi argini alla discrezionalità del
titolare, s’aprono due vie: una più rigida: nullità della clausola per contrasto coi valori (di ordine
pubblico) dell’accordo e del vincolo contrattuale; una più flessibile: la clausola non è nulla, ma il suo
contenuto è integrato secondo il criterio della buona fede, che limita l’arbitrio della parte abilitata a
variare.
CAPITOLO XXV – GLI EFFETTI DEL CONTRATTO ED I TERZI
Il principio di relatività degli effetti contrattuali è espresso nel 1372.2: il contratto non produce effetto
rispetto ai terzi.
Questo risulta per implicito già da altre norme: dal 1372.1, perché dice che il contratto ha forza di legge
tra le parti, e dalla definizione del 1321, dove si dice che il rapporto contemplato dal contratto le parti
lo costituiscono, lo regolano o lo estinguono “tra loro”.
La relatività degli effetti contrattuali è proiezione del principio dell’accordo.
Nella formula per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, “effetto” va inteso come effetto
giuridico, non come effetto empirico.
Il principio di relatività nemmeno impedisce che il contratto leda veri e propri diritti o comunque
posizioni giuridicamente protette del terzo: l’alienazione di un bene del debitore toglie al creditore,
terzo rispetto al contratto, parte della sua garanzia patrimoniale.
Ciò non significa che le parti possano impunemente concludere contratti che danneggiano terzi: in
molti casi il terzo ha rimedi contro il contratto che lo danneggia, ma rimedi siffatti non costituiscono
applicazione del principio di relatività (il creditore danneggiato dall’alienazione del bene del debitore
può agire per revocarla: ma così egli reagisce appunto, ex post, contro il pregiudizio recatogli dal
contratto altrui, pregiudizio che il principio di relatività non impedisce).
Il principio, poi, non impedisce che il contratto crei (a favore delle parti) situazioni giuridiche che i
terzi son tenuti a rispettare, a pena di subire reazioni legali del contraente leso: si pensi al terzo
acquirente che viola il diritto del prelazionario, nato dal contratto attributivo della prelazione.
Contratti conclusi per pregiudicare ingiustamente terzi possono risultare nulli per illiceità della causa
(si pensi agli accordi di boicottaggio contro un concorrente): sono i c.d. contratti a danno di terzi.
Ma siamo fuori dal campo del 1372.2: la nullità non dipende da violazione del principio di relatività,
ma dalla violazione di altri principi di ordine pubblico o buon costume.
Vediamo adesso, in positivo, i significati del principio di relatività: il primo significato è che il
contratto non può imporre obbligazioni a terzi (lo conferma la regola del 1381 sulla promessa del fatto
del terzo); il secondo è che il contratto non può sottrarre al terzo i suoi diritti (ne dà conferma la
disciplina della vendita di cosa altrui).
Una cosa è togliere al terzo la titolarità del suo diritto (ciò che il contratto non è in grado di fare); altra
cosa è violare il diritto del terzo: ciò che il contratto, fattualmente, può ben determinare.
Ulteriore significato è che il contratto non può impedire al terzo di acquistare un suo diritto.
Ci si può interrogare se esista un quarto significato del principio: quello per cui il contratto non può
attribuire diritti ad un terzo.
In generale: il contratto non può attribuire al terzo un diritto reale; invece può far nascere in suo favore
diritti di credito.
Eccezioni al principio di relatività non sono le fattispecie estranee al suo raggio d’azione, ma le
fattispecie che vi rientrerebbero, se non valesse per esse una ratio contraria e superiore, in nome della
quale il principio di relatività è messo occasionalmente fuori gioco.
Ampie eccezioni intaccano il principio nel significato per cui esso impedisce al contratto di sottrarre al
terzo il suo diritto.
Le eccezioni si situano essenzialmente nell’area degli acquisti a non domino, e delle doppie alienazioni
di un medesimo diritto: qui la ratio di protezione dell’affidamento dell’acquirente e di sicurezza degli
acquisti prevale sulla ratio del 1372.2.
Il contratto di acquisto a non domino del mobile non registrato attribuisce la proprietà all’acquirente
che in buona fede ne consegue il possesso, privandone il terzo titolare (1153); in caso di doppia
alienazione immobiliare, il primo acquirente – divenuto proprietario ex 1376 – si vede sottrarre il diritto
dal successivo contratto di acquisto in capo a diverso acquirente, che abbia trascritto prima di lui
(2644); la successiva cessione dello stesso credito già ceduto a cessionario anteriore può privare questo
del credito da lui acquistato, in ragione dell’anteriorità della notificazione al debitore o della sua
accettazione (1265).
La promessa gratuita sorretta da una causa è di regola vincolante, e quindi può attribuire al beneficiario
un diritto di credito senza bisogno della sua accettazione (ma fatta salva la possibilità di rifiuto), mentre
ciò non può accadere per le attribuzioni reali, impensabili senza accettazione del beneficiario:
coordinato con questo principio, il principio di relatività assumerebbe allora il senso di precludere non
già l’attribuzione al terzo di qualsivoglia diritto, ma solo l’attribuzione di proprietà o diritti reali
assimilabili, ovvero l’attribuzione di diritti di credito insuscettibile di essere paralizzata dal rifiuto del
terzo.
Generalmente parlando, un contratto può dirsi opponibile a terzi quando produce qualche effetto
suscettibile di avere qualche rilevanza giuridica verso i terzi.
Si riserva la nozione di opponibilità degli effetti contrattuali ai casi in cui il principio di relatività,
altrimenti idoneo a rendere il terzo insensibile al contratto altrui, viene neutralizzato da un
controprincipio di forza superiore.
Il 1381 applica pienamente il principio di relatività; se A contrae con B promettendogli che il terzo X
farà qualcosa a suo vantaggio, non ne nasce alcuna obbligazione di X, ne consegue solo che il
promittente è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo non compie il fatto promesso.
Il fatto promesso può essere un fatto materiale del terzo, od un suo atto giuridico.
La figura non è compatibile col fatto che il terzo fosse già obbligato verso il promissario: in tal caso
l’impegno di A verso B non è promessa del fatto del terzo X, ma fideiussione di A a garanzia del debito
di X, debitore principale di B.
Se il fatto o l’impegno del terzo sono illeciti, illecita (e nulla) è anche la loro promessa; se sono
impossibili, l’impossibilità si comunica all’oggetto della promessa, che sarà pertanto nulla.
La natura dell’impegno del promittente è discussa; la risposta oscilla fra due modelli: il modello
dell’obbligazione, per cui il promittente è tenuto ad adoperarsi affinché il terzo presti; ed il modello
della garanzia, per cui il promittente è obbligato ad indennizzare il promissario se il terzo non presterà.
Il modello dell’obbligazione porta a ricostruire la responsabilità del promittente secondo il regime del
1218.
All’opposto, il modello della garanzia implica che il promittente si assume tutto il rischio della mancata
prestazione del terzo, di fronte alla quale – non importa se imputabile a lui o meno – egli è tenuto ad
indennizzare il promissario.
Al promittente si dovrebbe comunque consentire di liberarsi provando che il rifiuto del terzo di
obbligarsi od il mancato compimento della sua prestazione sono obiettivamente giustificati (al limite
perché l’obbligazione o la prestazione sono diventate impossibili), e tanto più se dipendono dal fatto
del promissario.
Inoltre il 1381 è norma dispositiva: non impedisce all’autonomia privata di derogare al modello della
garanzia.
Chi promette l’obbligazione del terzo può esser chiamato a rispondere del rifiuto del terzo di obbligarsi
verso il promissario; ma non del suo successivo inadempimento all’obbligazione assunta.
Il 1381 dice “indennizzare” e non “risarcire”: su questa base si è sostenuto che il promittente non
dovrebbe al promissario l’intero danno causatogli dalla mancata prestazione del terzo, bensì
risponderebbe solo nei limiti del valore della prestazione mancata.
La disciplina dei divieti contrattuali di alienazione (1379) considera due profili: la validità del patti, e
l’efficacia del patto.
Il 1379 riflette una posizione non ostile ai divieti contrattuali di alienazione: ne ammette la validità,
solo condizionandola a due requisiti non particolarmente stringenti: l’interesse della parte, e la
temporaneità.
Il patto che non rispetti i requisiti di legge è illecito e quindi nullo.
Non occorre un interesse sociale; basta l’interesse individuale della parte, e può essere anche non
patrimoniale, ma solo morale: l’importante è che sia un interesse apprezzabile in termini obiettivi.
Per quanto riguarda il secondo requisito (che il divieto sia contenuto entro convenienti limiti di tempo),
la convenienza del termine è sindacata dal giudice caso per caso, e si misura anche sul genere di
interesse che sostiene il divieto.
Se la durata del vincolo eccede il limite della convenienza, non pare ammissibile una riduzione
giudiziale: il patto è nullo, e potrà convertirsi in un patto di prelazione (sempre che il termine non sia
eccessivo anche rispetto a questo).
Se manca qualsiasi termine, può chiedersi al giudice di fissarlo.
Il patto di non alienare ha effetto solo tra le parti.
Se il promittente viola il divieto contrattuale ed aliena il bene ad un terzo, questi acquista regolarmente:
il promissario può chiedere il risarcimento al promittente, ma non può toccare l’acquisto del terzo.
Ciò vale anche se il contratto contenente il divieto di alienazione (riguardante un immobile) sia stato
trascritto.
In alcune fattispecie il patto di non alienare è opponibile ai terzi acquirenti: è il caso del divieto di
cessione dell’usufrutto (980.1), del divieto convenzionale di cessione del credito, opponibile ai terzi
che lo conoscevano (1260.2), dei limiti alla circolazione delle azioni scritti negli statuti societari, dei
divieti di alienazione posti a carico dei condomini nei regolamenti condominiali, purché trascritti.
Fuori di questi casi, ci si chiede se l’efficacia solo obbligatoria del patto possa essere neutralizzata –
almeno nei casi in cui il divieto (di ritrasferimento) accede al previo trasferimento del bene dal
promissario al promittente, con l’espediente di dedurre la violazione di esso, e cioè il successivo
trasferimento ad un terzo, a condizione risolutiva del primo trasferimento.
CAPITOLO XXVI – CONTRATTO A FAVORE DI TERZO,
CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBCONTRATTO
Il contratto a favore di terzo ricorre quando le parti – stipulante e promittente – concordano che la
prestazione dovuta dal promittente sia fatta a favore non dello stipulante, ma di un terzo (beneficiario):
1411 ss.
Presupposto è che lo stipulante agisca in nome proprio e non del terzo.
Il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione (1411.2) cui egli è
estraneo, senza bisogno di manifestare la sua accettazione.
Ci si domanda se debba vedersi nella figura una deroga al principio di relatività degli effetti contrattuali
(1372.2).
C’è il principio per cui a nessuno possono attribuirsi, senza la sua accettazione, né posizioni di
svantaggio né posizioni astrattamente di vantaggio, ma implicanti pesi almeno potenziali (come
proprietà, usufrutto, o altri diritti reali che comportino custodia, manutenzione, oneri fiscali,
responsabilità…) e c’è il principio per cui il soggetto può ricevere anche senza la sua accettazione
posizioni vantaggiose consistenti in diritti di credito, od anche in diritti reali non implicanti pesi.
Ne derivano due conseguenze.
La prima è che il contratto a favore di terzo non deroga al principio di relatività, ma applica l’altro
(compatibile) principio appena enunciato.
La seconda è che il meccanismo del 1411 può attribuire al terzo solo diritti di crediti e diritti reali non
portatori di alcun peso per il titolare.
Dal contratto a favore di terzo si distingue il contratto con effetti protettivi per i terzi: la figura ricorre
quando la prestazione contrattuale, pur essendo pattuita a favore della parte, è destinata a toccare la
sfera di terzi; si ammette che l’azione risarcitoria di questi terzi, lesi dal mancato o difettoso
adempimento della prestazione, segua il regime dell’azione non aquiliana ma contrattuale.
Un’applicazione giurisprudenziale riguarda il bambino nato con lesioni per l’inadeguata assistenza
medica prestata alla madre partoriente: il contratto è fra la madre ed il medico (o la struttura sanitaria),
e rispetto ad esso il bambino è terzo.
La validità della stipulazione in favore di terzo è subordinata ad un requisito: che lo stipulante vi abbia
interesse (1411.1).
I casi sono due: o l’interesse dello stipulante emerge in modo corposo ed inequivoco da dati obiettivi,
ed allora il requisito è in re ipsa, o un interesse siffatto non è obiettivamente percepibile, ed allora
dovrà dirsi che c’è un interesse, magari solo morale, desumibile dal fatto stesso che lo stipulante ha
voluto stipulare a favore del terzo.
Il richiamo all’interesse dello stipulante riceve senso, se lo si collega alla causa.
Per cogliere il valore del requisito causale, conviene distinguere fra due ordini di rapporti: il rapporto
fra stipulante e promittente, parti del contratto, ed il rapporto fra stipulante e terzo, beneficiario degli
effetti contrattuali.
Chiamiamo le parti del contratto A (stipulante) e B (promittente); ed X il terzo.
Il contratto A-B può essere oneroso o gratuito, se è oneroso la sua causa è lo scambio fra l’impegno
assunto da B in favore di X, e la prestazione data o promessa da A a B
La causa potrà mancare, ad es. se risulta che B aveva già, da altra fonte, quell’obbligo verso C; od
essere illecita: il contratto allora è nullo.
Ma A contrae con B, sobbarcandosi il corrispettivo a suo favore, perché interessato a che X consegua la
prestazione di B; e ciò sulla base di un qualche rapporto A-X.
È questo rapporto fra stipulante e terzo, che identifica l’interesse dello stipulante a contrarre in favore
del terzo.
Rispetto al contratto A-B, l’interesse di A radicato nel suo rapporto con X in linea di principio non è
causa, ma motivo irrilevante.
Non possono tuttavia escludersi casi di eccezionale rilevanza, sul contratto A-B, dell’interesse di A a
stipulare in favore di X: se questo interesse si lega a fini vietati dalla legge, esso configura motivo
illecito; e se a quegli stessi fini B è controinteressato, si ha motivo illecito comune che rende nullo il
contratto.
E al di fuori dell’illiceità, se B non solo conosceva l’interesse di A verso X, ma in qualche modo lo ha
fatto proprio, di modo che il contratto A-B si spiega, dal punto di vista di entrambe le parti, solo in base
al rapporto A-X, allora potrà dirsi che questo fa parte della ragione giustificativa del contratto, e ne
condiziona la sorte.
Un discorso diverso concerne il rapporto (non il contratto, che non c’è) fra A ed X.
Col contratto fatto con B, A procura ad X una prestazione: il suo interesse a ciò colora la causa
dell’attribuzione in favore di X.
Può darsi che A lo faccia perché aveva verso X l’obbligo di procurargli quella prestazione, ed il
contratto con B è il modo per adempierlo: qui la stipulazione a favore di terzo ha causa solvendi.
Oppure perché procurare la prestazione ad X serve per metterlo in condizione di svolgere un’attività
utile ad A, già concordata fra A ed X: qui la causa dell’attribuzione ad X è l’attuazione di tale accordo.
Oppure perché deve concludersi che A ha voluto compiere una pura liberalità ad X: nel rapporto fra A
ed X si configura allora una donazione indiretta.
S’immagini che l’interesse dello stipulante risulti infondato o venga frustrato (ad es. perché l’obbligo di
A verso X, al cui adempimento la stipulazione a favore di X era funzionale, si scopre inesistente).
Se A non ha ancora perso il potere di revoca, che gli spetta in via generale, si tutelerà revocando la
stipulazione, con l’effetto che X perde il diritto alla prestazione.
Il problema si pone quando tale potere è consumato: A non può impedire, di regola, di adempiere nelle
mani di X, e quindi non può impedire ad X di conseguire la prestazione: potrà però successivamente
rivolgere contro X azione di arricchimento (2041), sotto il profilo che X ha conseguito a spese di A una
prestazione senza causa.
Il terzo può non essere determinato nel contratto, può anche essere un soggetto inesistente al tempo del
contratto; in attesa che il beneficiario sia determinato o venga ad esistenza, il diritto stipulato spetta allo
stipulante.
Il terzo acquista il diritto (ed è legittimato ad azionarlo in giudizio) verso il promittente: lo acquista
immediatamente per effetto del contratto, senza bisogno che dichiari di volerne profittare (breve: senza
bisogno di accettazione); è però salvo il patto contrario: stipulante e promittente possono pattuire che
l’acquisto del terzo sia subordinato alla sua accettazione (1411.2).
Il diritto del terzo è soggetto a tre fattori di condizionamento che in vario modo possono metterlo in
discussione; tali fattori sono: la volontà del terzo, la volontà dello stipulante, le vicende del contratto.
Il terzo può rifiutare il diritto stipulato a suo favore (1411.3), ed allora non acquista il diritto.
La conseguenza del rifiuto è che la prestazione rimane a beneficio dello stipulante (1411.3).
Il rifiuto si configura come atto ricettizio, sia verso lo stipulante sia verso il promittente.
La possibilità di rifiuto del terzo espone le parti ad una situazione d’incertezza, per questo, pur nel
silenzio della legge, sembra conveniente sottoporre il potere di rifiuto ad un termine, identificabile col
tempo richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi (in analogia con quanto previsto dal 1333.2: il
destinatario [del contratto con obbligazioni del solo proponente] può rifiutare la proposta nel termine
richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso).
La regola della devoluzione allo stipulante della prestazione rifiutata dal terzo può essere derogata, se
diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto (1411.3).
In caso di rifiuto del terzo, il contratto si risolve anche senza pattuizione in tal senso se la prestazione,
per sua natura, non può farsi ad altri se non al terzo che l’ha rifiutata.
Il senso del mancato rifiuto del terzo è, in generale, tranquillizzare sul fatto che l’attribuzione del diritto
a suo favore non realizza un’intrusione nella sua sfera, a lui sgradita.
Il suo mancato rifiuto non manifesta, propriamente, accordo verso il contratto che lo riguarda;
diversamente, egli diverrebbe parte di un contratto trilatero, e non avrebbe più senso parlare di contratto
a favore di terzo.
Per l’attribuzione del diritto non occorre che passi il termine entro cui il beneficiario può rifiutare;
l’acquisto è immediato ed avviene comunque, salvo essere posto nel nulla dal rifiuto.
Questo non impedisce l’acquisto del diritto, ma vale rinuncia al diritto già acquisito.
Non siamo nell’area della remissione (1236): qui il debitore non viene liberato dall’obbligazione (che
deve eseguire in favore di altro soggetto), e non può neutralizzare, col suo rifiuto, l’abdicazione del
terzo.
La stipulazione può essere revocata o modificata dallo stipulante (1411.2).
La revoca ha, come il rifiuto, l’effetto di attribuire il diritto allo stipulante.
Anche la revoca dello stipulante, così come il rifiuto del terzo, tocca entrambi gli altri soggetti
coinvolti, per cui è opportuno che ad entrambi sia comunicata: dunque si configura come atto ricettizio
sia verso il terzo (cui toglie il diritto), sia verso il promittente (cui cambia il creditore di riferimento).
Un discorso analogo può farsi per la modifica.
Il potere di revoca o modifica dello stipulante ha un limite: può esercitarsi solo finché il terzo
beneficiario della stipulazione non l’abbia accettata, o più precisamente abbia dichiarato di volerne
profittare (1411.2).
Dunque l’accettazione del terzo non serve a fargli acquistare il diritto, ma solo a consolidare l’acquisto,
rendendolo non più revocabile né modificabile.
L’accettazione va dichiarata anche in confronto del promittente: è dunque atto ricettizio sia verso il
promittente (cui segnala d’essere definitivamente il suo creditore), sia verso lo stipulante (cui fa sapere
che il suo potere di revoca o modifica è consumato).
La regola sul limite temporale del potere di revoca dello stipulante è derogata per i casi in cui la
prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante: si pensi all’assicurazione sulla
propria vita, a beneficio di un terzo.
I profili di deroga sono due: la revoca può farsi anche con disposizione testamentaria, dunque con atto
non ricettizio; e soprattutto può farsi anche dopo l’accettazione del terzo (1412.1).
Lo stipulante può autoprivarsi di questa ultrattività del suo potere di revoca: se egli ha rinunciato per
iscritto alla facoltà offertagli dalla legge, si ripristina la regola ordinaria: è inefficace la sua revoca, fatta
dopo l’accettazione del terzo.
Lo stipulante può rinunciare del tutto al suo potere di revoca.
Il 1412.2 dispone per il caso che il terzo, beneficiario della prestazione da farsi dopo la morte dello
stipulante, gli premuoia: nel diritto alla prestazione gli subentrano i suoi eredi, esposti allo stesso potere
di revoca che lo stipulante aveva verso l’iniziale beneficiario.
La prestazione può essere rivolta ad un altro terzo indicato dallo stipulante (se prestare a questo diverso
terzo non è più gravoso per il promittente).
Dopo il rifiuto del terzo e la revoca dello stipulante, altro fattore che può mettere in discussione il
diritto del terzo sono le vicende del contratto da cui è nato.
Lo dice il 1413, a norma del quale il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto
(non, invece, quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante, estranei al fatto generatore del
diritto del terzo).
Il diritto del terzo è esposto a rischio non solo per dirette eccezioni del promittente, ma anche, in via
mediata, per iniziative dello stipulante.
Si tratta di vedere fino a che punto.
Lo stipulante non può considerarsi legittimato a qualsiasi iniziativa astrattamente deducibile dal suo
contratto col promittente.
In caso di mancato adempimento del promittente, oltre all’ovvia legittimazione del terzo titolare del
diritto c’è anche una legittimazione dello stipulante ad agire contro il promittente.
Sembra da escludere la legittimazione dello stipulante a chiedere la risoluzione, perché ciò frustrerebbe
l’interesse del terzo che preferisca mantenere il contratto e sperare nell’adempimento, ancorché tardivo.
Potrà essere legittimazione a chiedere l’adempimento, concorrente con analoga legittimazione del
terzo.
La cessione del contratto può intendersi in due sensi: come atto e come effetto.
La cessione intesa come atto è il contratto con cui il cedente, parte di un altro contratto già in corso con
altro soggetto (ceduto), trasferisce la relativa posizione contrattuale (nelle sue componenti sia attive che
passive) al cessionario, il quale gli subentra nel rapporto col ceduto.
La cessione intesa come effetto è il trasferimento della posizione contrattuale di un contraente ad un
altro soggetto, che gli subentra nel rapporto con controparte.
La cessione-effetto può essere conseguenza di una cessione-atto: ed allora si parla di cessione
volontaria.
Ma può essere anche conseguenza di una diversa fattispecie, a cui la legge ricollega l’effetto di
trasferire ad X la posizione contrattuale di A, derivante da un suo precedente contratto con B: si parla
allora di cessione legale del contratto.
Controversie permangono circa l’oggetto della cessione.
Da un primo punto di vista, la questione è: che cosa, precisamente, il cedente cede ed il cessionario
acquista?
Si fronteggiano al riguardo una teoria unitaria ed una teoria atomistica: secondo quest’ultima la
cessione del contratto è la somma dei trasferimenti delle singole situazioni soggettive elementari (debiti
e crediti) create dal contratto.
La specificità della cessione del contratto, rispetto alla cessione di crediti ed all’accollo di debiti,
starebbe nello scambio contestuale di situazioni attive e passive nate dal medesimo contratto.
Riscuote maggiore consenso la teoria unitaria: ciò che si cede è l’intera posizione contrattuale del
cedente, ovvero il complesso delle situazioni soggettive che facevano capo a lui in quanto parte del
contratto ceduto (e non in quanto titolare dei singoli debiti e dei singoli crediti da esso creati).
Ciò ha una conseguenza notevole: il cessionario acquista e può esercitare contro il ceduto anche i
rimedi contrattuali inerenti il contratto oggetto di cessione – azioni (od eccezioni) di nullità,
annullamento, risoluzione, etc. – così come avrebbe potuto esercitarli il cedente.
Da un altro punto di vista ci si domanda: su quali presupposti, relativi alla struttura ed al grado di
attuazione del contratto, può questo formare oggetto di cessione?
La norma indica l’oggetto della cessione in un contratto con prestazioni corrispettive, non ancora
eseguite (1406).
Deve riconoscersi ammissibile anche la cessione di contratti unilaterali, di contratti già eseguiti da una
parte, di contratti con effetti reali.
Il 1406.1 non vi fa ostacolo: esso prefigura quella che agli occhi del legislatore è la tipica cessione di
contratto: ma non esclude che l’autonomia privata possa, ex 1322, costruire cessioni atipiche,
divergenti dallo schema legale.
Il rispetto delle lecite scelte di autonomia privata induce poi a ritenere ammissibile una cessione
parziale del contratto, ed una cessione modificativa, che nel momento in cui trasferisce la posizione
contrattuale ne innova qualche contenuto.
Se la cessione del contratto è a sua volta un contratto, deve avere una causa.
La posizione contrattuale è un bene sui generis, perché comprende insieme elementi attivi e passivi, il
cui mix può renderne il valore netto poco afferrabile.
Inoltre, la cessione può contemplare un corrispettivo del cessionario in favore del cedente (ma anche
viceversa!), o nessun corrispettivo.
Tutto questo incide sulla causa.
Sorge così la tentazione di parlare di causa variabile: ma conviene piuttosto dire che la cessione del
contratto non ha propriamente una causa tipica, perché non è propriamente un contratto tipico: bensì è
una prestazione tipica che potrà formare oggetto di tanti contratti causalmente diversi.
La cessione del contratto è un contratto su un altro contratto, un contratto di secondo grado.
Si pone il problema della forma: forma libera, in assenza di espresso vincolo legale?
O forma vincolata a quella del contratto ceduto? Quest’ultima posizione sembra prevalente.
Altro discorso riguarda la forma vincolata non già per eventuale attrazione da quella del contratto
ceduto, ma per l’intrinseca natura del contratto di cessione: se ad es. questo si qualifica come
donazione, richiede l’atto pubblico anche se il contratto ceduto non è formale.
La parte può cedere il suo contratto ad un terzo, ma su un presupposto: che l’altra parte vi consenta
(1406).
Il consenso del contraente ceduto è necessario perché gli effetti della cessione toccano in modo
significativo le sue posizioni.
Nelle massime della giurisprudenza il necessario consenso del ceduto è consenso contrattuale, che
definisce la cessione come contratto trilatero, di cui il ceduto è parte insieme con cedente e cessionario.
Si raccomanda una visione meno rigida, alla cui stregua il consenso del contraente ceduto ha valore
diverso, a seconda dei casi.
Possono distinguersi due situazioni.
Il consenso del ceduto può presentarsi come manifestazione di volontà che integra il suo accordo sulla
cessione: in tal caso la cessione si configura come contratto plurilaterale, e precisamente come contratto
trilatero: parti di esso sono il cedente ed il cessionario, ma anche il ceduto (ciò si verifica ad es. quando
quest’ultimo interviene a garantire la validità del contratto ceduto, o quando si prevede per lui un
autonomo corrispettivo che remuneri il suo consenso alla cessione).
Quando invece la cessione non innova la posizione del ceduto nei suoi contenuti obiettivi, il consenso
del ceduto è pur sempre necessario, ma può esser meno pesante di un vero e proprio consenso
contrattuale: si configura allora come semplice autorizzazione (se dato prima della cessione) od
approvazione (se dato dopo): in tal caso la cessione è contratto a due sole parti (cedente e cessionario),
mentre il ceduto non ne è parte.
Se la cessione ha i caratteri del contratto trilatero, il mancato consenso del ceduto fa venir meno un
elemento costitutivo della fattispecie: la cessione non si perfeziona, ed i suoi effetti non si producono.
Se invece la cessione è contratto solo fra cedente e cessionario, il mancato consenso autorizzativo od
approvativo del ceduto impedisce che a lui si applichi la disciplina della cessione del contratto; ma non
preclude che il negozio perfezionato fra cedente e cessionario produca almeno gli effetti di una
cessione di crediti e di un accollo interno di debiti.
Il consenso del ceduto può essere dato preventivamente, e più o meno in bianco.
In tal caso il ceduto non è parte della cessione.
Se dopo la cessione, ma prima dell’accettazione o notificazione, si producono fatti incompatibili con la
cessione e favorevoli al ceduto (ad es. questi fa la prestazione contrattuale al cedente) tali fatti restano
efficaci nonostante la cessione, che non è opponibile al ceduto (il quale perciò è liberato e non deve più
prestare al cessionario).
Ci sono contratti la cui attitudine alla circolazione è connaturata alla loro funzione in modo così
intenso, che nella percezione comune essi si presentano come beni in commercio.
Si pensi al mercato del software: chi compra un pacchetto dalla software-house in realtà stipula con
questa un contratto di licenza; se poi lo rivende in realtà cede all’acquirente tale contratto.
Si compra un contratto: ma l’operazione è presentata e percepita come se si comprasse una cosa: il
giurista americano parla appunto di contract as thing.
Per contratti del genere si richiedono modalità di cessione ancora più semplici e snelle di quelle
prefigurate dal 1407.1.
Ciò può ottenersi, a norma del 1407.2, formalizzando il contratto in un documento che ne indichi tutti
gli elementi, e contenga la clausola all’ordine (od equivalente): si hanno allora i c.d. contratti all’ordine,
o stabiliti di contratto.
Ne costituisce esempio la polizza assicurativa all’ordine (1889: se la polizza di assicurazione è
all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore,
con gli effetti della cessione. Tuttavia l’assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la
prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni
relative all'ammortamento dei titoli all’ordine).
La caratteristica saliente dei contratti all’ordine è che la girata del documento produce la sostituzione
del giratario nei confronti del girante (1407.2) (non occorre la notificazione al ceduto).
Se il ceduto pagherà a chi appare legittimato in quanto possessore del documento contenente la girata a
suo favore, pagherà comunque bene: dunque la notificazione è superflua.
È generalmente condiviso l’inquadramento dei contratti all’ordine fra i documenti di legittimazione od i
titoli impropri (2002).
Nel modello legale tipico (1408.1), la cessione è liberatoria: il cedente è liberato dalle sue obbligazioni
verso il ceduto; e l’effetto liberatorio si produce dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei
confronti del ceduto.
Ma la cessione può essere resa non liberatoria con apposita dichiarazione del ceduto: in tal caso il
cedente non è liberato, infatti il ceduto può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le
obbligazioni assunte (1408.2).
Il ceduto che voglia azionare la responsabilità del cedente ha però l’onere di comunicargli entro 15
giorni l’insorgere del suo presupposto, e cioè l’inadempimento del cessionario.
In mancanza è tenuto al risarcimento del danno: 1408.3.
Se vuole che la cessione non liberi il cedente, il ceduto ha l’onere di dichiararlo: l’inverso dell’accollo,
che – normalmente non liberatorio – lo diventa solo per l’espressa dichiarazione degli interessati
(1273.2).
Nei rapporti fra cedente e ceduto si verifica poi un altro effetto, anche se la legge non lo esplicita: la
perdita di legittimazione del cedente a far valere la posizione contrattuale ch’egli aveva contro il
ceduto.
Passiamo ai rapporti fra cessionario e ceduto (1409): con la cessione, le pretese contrattuali già del
cedente passano nella titolarità e nella legittimazione del cessionario.
Il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto; invece il ceduto non può
opporre al cessionario le eccezioni fondate su altri rapporti col cedente (salvo che ne abbia fatto riserva
nel momento di consentire alla cessione).
In certi casi, il ceduto che oppone un’eccezione al cessionario potrebbe incombere in responsabilità
precontrattuale: per aver creato, col proprio consenso alla cessione, l’affidamento del cessionario sulla
bontà della posizione contrattuale ceduta, e per averlo poi deluso facendo valere un’eccezione.
Il 1409 non lo dice, ma il ceduto che chiede la prestazione contrattuale al cessionario può sentirsi
opporre da lui tutte le eccezioni fondate sul contratto ceduto, comprese nella posizione contrattuale che
il cessionario ha acquistato.
Veniamo infine ai rapporti fra cedente e cessionario (1410): il loro contratto ha effetto reale: trasferisce
al secondo la posizione contrattuale del primo, secondo il principio del consenso immediatamente
traslativo (1376: nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa
determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro
diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti
legittimamente manifestato).
Bisogna distinguere fra due possibili situazioni.
La situazione legalmente tipica è quella di una cessione pro solvendo, in cui il cedente garantisce solo
l’esistenza e l’integrità della posizione contrattuale ceduta, dunque la validità del contratto, e non anche
l’adempimento del ceduto (1410.1).
Ma la volontà delle parti può derogare allo schema tipico, costruendo una cessione pro soluto che
addossa al cedente anche la garanzia di adempimento: in tal caso il cedente risponde come un
fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto (1410.2).
Fra cedente e ceduto, il venir meno degli effetti del contratto di cessione riporta la posizione
contrattuale in capo al cedente, ripristinando i suoi obblighi e le sue pretese contrattuali verso il ceduto.
Se la cessione risulta impugnabile e tanto più se viene impugnata, ciò giustifica che il cessionario si
astenga dal prestare al ceduto, e dal chiedere la prestazione al ceduto.
Le controversie originate da cessione di contratto danno luogo a litisconsorzio necessario fra i tre
soggetti coinvolti? La risposta dipende da numerose variabili: se la lite riguardi il contratto di cessione
od il contratto ceduto; nel primo caso, se la cessione sia a due parti o trilatera; e comunque, quali siano
petitum e causa petendi.
Dalla cessione volontaria del contratto vanno distinte le cessioni legali: per esse, il trasferimento della
posizione contrattuale avviene ope legis: il fenomeno si definisce anche successione nel contratto.
Esso riguarda per lo più contratti relativi a beni: in presenza di determinate vicende del bene, la legge
dispone che il contratto ad esso pertinente si trasferisca ad altro soggetto, interessato alla vicenda (per
es., la vendita della cosa assicurata trasferisce l’assicurazione all’acquirente, come dispone il 1918).
Il subcontratto implica un preesistente diverso contratto (contratto base): questa figura ricorre quando la
parte del contratto base usa la posizione contrattuale che questo le dà, per concludere con un terzo un
contratto dello stesso tipo del contratto base, ed avente in tutto od in parte lo stesso oggetto.
Ad es.: il conduttore riceve dalla locazione una posizione di godimento del bene: può riattribuirla in
tutto od in parte ad un terzo, col quale stipuli una sublocazione, in cui il conduttore ha veste di
sublocatore, ed il terzo di subconduttore: il subcontratto ha la stessa sostanza economica del contratto
base, perché vi è dedotta la medesima prestazione: ma la parte del contratto base che fa il subcontratto
vi assume il ruolo inverso rispetto a quello che ha nel contratto base: il conduttore diventa
(sub)locatore.
La sostanza economica porta a distinguere due varianti del subcontratto: questo può traslare sul terzo
subcontraente il diritto a ricevere la prestazione tipica del contratto base (ad es. sublocazione), o
l’obbligo di eseguire tale prestazione tipica.
Nel primo caso il terzo subcontraente è di regola creditore di attività e debitore di denaro; nel secondo
caso debitore di attività e creditore di denaro.
Il subcontratto non è cessione del contratto: questa trasferisce la medesima posizione contrattuale
derivante dal contratto ceduto, mentre il subcontratto non sposta le posizioni contrattuali derivanti dal
contratto base, ma crea fra le parti subcontraenti una posizione contrattuale nuova.
Nemmeno s’identifica col contratto a favore di terzo: questo crea per definizione un rapporto diretto fra
promittente e terzo, mentre un tale rapporto non necessariamente si crea fra il terzo subcontraente e la
parte (non subcontraente) del contratto base.
L’estinzione del contratto base mette in crisi anche il subcontratto.
Non esiste una disciplina generale ed unitaria del subcontratto, si hanno piuttosto discipline
differenziate in relazione ai vari tipi di contratto base su cui s’innesti un subcontratto.
Vi sono due problemi fondamentali.
Il primo riguarda i limiti di ammissibilità del subcontratto.
In alcuni casi il subcontratto è consentito senza limiti: riassicurazione (1929), fideiussione del
fideiussore (1940; 1948); in altri è vietato: enfiteusi (968), lavoro a cottimo (2127); in altri ancora è
ammesso solo col consenso dell’altra parte del contratto base: sublocazione di mobili (1594.2).
Il secondo problema riguarda i rapporti fra i soggetti coinvolti: in linea di principio si hanno due ordini
di rapporti, distinti e separati, fra parti del contratto base e parti del subcontratto.
Se il subappaltatore esegue male l’opera, il vizio è fatto valere dal committente contro l’appaltatore
(che potrà poi agire in regresso contro il subappaltatore: 1670); e per ricevere il corrispettivo della sua
attività il subappaltatore può agire solo contro l’appaltatore subcommittente.
In qualche caso la legge prevede un’azione diretta fra terzo subcontraente e parte non subcontraente del
contratto base: così a favore del locatore contro il subconduttore (1595.1), a favore del mandante contro
il submandatario (1717.4).
Non ha senso parlare di subcontratto per i contratti traslativi, ma solo per contratti obbligatori di durata.
CAPITOLO XXVII – LA CONDIZIONE
Le parti possono inserire nel contratto una condizione, ed in questo modo subordinare l’efficacia o la
risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto (1353).
La condizione è uno strumento della libertà contrattuale.
Per certi atti la legge vieta di condizionarne gli effetti, perché vuole che questi si producano senz’altro
secondo lo schema legale; si chiamano actus legitimi e sono o negozi familiari, come il matrimonio
(108) ed il riconoscimento del figlio naturale (257); o negozi unilaterali, come l’accettazione di eredità
(475.2) e la girata dei titoli all’ordine (2010).
Più in generale, sono vietate e colpite le condizioni illecite.
La condizione incide sull’efficacia del contratto; non sulla sua esistenza, né sulla sua vincolatività, né
sulla sua validità.
L’affermazione che la condizione non incide sull’esistenza del contratto vale per la condizione interna,
cioè quella inserita nel regolamento contrattuale per condizionare l’efficacia di questo.
Discorso diverso vale per la condizione che sia esterna al regolamento contrattuale, perché apposta ad
un atto precontrattuale: proposta od accettazione.
L’accettazione può contenere una condizione, nel senso di rendere condizionato il contratto di cui alla
proposta: in tal caso è accettazione difforme che vale controproposta.
Ma può contenerla anche nel diverso senso di essere conforme alla proposta, e tuttavia condizionata
essa accettazione: col risultato che il contratto si conclude o no, a seconda che, in base a tale
condizione, l’accettazione risulti efficace o no.
La condizione può riferirsi all’intero contratto: in tal caso è in gioco la totalità degli effetti contrattuali.
Oppure può riferirsi ad un singolo patto (1353), ed in tal caso solo gli effetti di questo sono subordinati
al fatto condizionante.
“Condizione” può avere due significati diversi: clausola condizionale, e fatto condizionante: quando si
dice che la condizione si è o non si è avverata, “condizione” indica il fatto futuro ed incerto cui la
clausola subordina gli effetti del contratto.
La condizione può essere sospensiva o risolutiva, a seconda che dall’avveramento dipenda l’efficacia
od invece la risoluzione del contratto (1353).
La condizione sospensiva tutela contro il rischio che un evento, atteso dalle parti (o da una parte) come
di proprio interesse, non si avveri o si avveri troppo tardi.
Il contratto con condizione risolutiva è efficace, ma solo fino a che il fatto condizionante avverrà, se
avverrà.
Se il fatto avverrà, il contratto diventerà inefficace: si risolverà.
La condizione risolutiva tutela contro il rischio che un evento, temuto dalle parti (o da una parte) come
contrario ai propri interessi, si avveri.
Sapere se una condizione è sospensiva o risolutiva è cosa non sempre facile, perché le formule usate
dalle parti per condizionare il contratto possono essere ambigue.
Per qualche autore, nel dubbio dovrebbe propendersi per la sospensiva; secondo altri, tutto all’opposto,
per la risolutiva.
La ricerca va condotta con l’impiego spassionato delle buone tecniche d’interpretazione/qualificazione.
Particolare rilevanza assume il criterio della globalità (1363: le clausole del contratto si interpretano le
une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto).
La condizione può essere semplice, quando vi è dedotto un singolo fatto; o plurima, quando vi sono
dedotti due o più fatti.
Se è plurima, la pluralità di fatti può essere dedotta in via alternativa, quando basta che ne accada uno
solo perché la condizione sia avverata; od in via cumulativa, quando l’avveramento della condizione
richiede che tutti accadano.
La condizione può riferirsi a fatti naturali, od a fatti umani (sociali od individuali).
Se concerne fatti umani, questi possono essere comportamenti materiali od atti giuridici; possono
essere fatti od atti di una parte, o di qualche terzo.
Si distingue poi fra condizione positiva, ove si deduce il verificarsi di un fatto, e condizione negativa,
ove si deduce il non verificarsi di un fatto: la distinzione non riesce ad essere netta.
Perché il meccanismo della condizione operi regolarmente, il fatto condizionante deve presentare
alcune caratteristiche: deve essere futuro ed incerto; deve essere possibile, e tale da non rendere la
condizione illecita.
Il fatto condizionante deve essere futuro ed incerto ex 1353.
È incerto il fatto del quale – con gli strumenti di conoscenza ed i dati di esperienza ragionevolmente
disponibili alle parti – non si è in grado di dire con sicurezza se avverrà o meno.
Inoltre l’incertezza può riguardare non l’accadimento del fatto (in sé certo), ma modi o misure di esso.
La norma vuole che il fatto sia, ancora prima che incerto, futuro.
Ma anche questo requisito non va inteso in modo rigido.
La clausola che condiziona il contratto ad un fatto presente o passato quasi sempre ha un senso, potrà
essere il senso di una garanzia, che una parte dà all’altra su un determinato stato delle cose; o quello di
un presupposto del contratto, esplicitato dalle parti; o quello di una vera e propria condizione (l’esito
cui perverrà l’accertamento futuro del fatto presente o passato).
Essendo subordinati dalla condizione ad un fatto incerto, gli effetti contrattuali sono nell’incertezza.
Il problema non si pone quando, per la natura stessa del fatto dedotto, l’incertezza è destinata a
sciogliersi in un tempo definito, o indefinito ma ragionevolmente breve; oppure quando le parti stesse
collegano la condizione ad un termine.
Il problema sorge quando le parti non corredano la condizione di alcun termine.
Non va esclusa la possibilità che, per eliminare l’incertezza ex ante e non solo ex post, la parte chieda al
giudice di fissare egli tale congruo termine.
Se le parti legano la condizione ad un termine esageratamente lungo, sembra da escludere la possibilità
di riduzione giudiziale, e da considerare piuttosto un’illiceità per contrasto con l’ordine pubblico.
La condizione è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico od al buon costume.
Essa rende nullo il contratto, tanto se sospensiva quanto se risolutiva (1354.1).
L’illiceità della condizione dipende dal fatto condizionante: ma non s’identifica con l’illiceità del fatto.
La condizione può contemplare un fatto illecito, ed essere tuttavia lecita; per converso, accade che sia
illecita la condizione ove si deduce un fatto lecito.
L’illiceità della condizione dipende non dal fatto condizionante in sé e per sé, ma dall’influenza che il
fatto esercita sugli effetti contrattuali.
Tale influenza è illecita, e determina l’illiceità della condizione, in tre ordini di casi.
La condizione è illecita quando costituisce incentivo per la parte a commettere un illecito, o quando la
parte trae diretto vantaggio da un illecito anche altrui.
La condizione è illecita quando coarta libertà fondamentali della persona (ad es.: il fatto condizionante
è il matrimonio della parte, o le sue dimissioni dal partito in cui milita: non così quando la condizione
riferisca queste scelte ad un terzo).
L’illiceità scatta solo quando il meccanismo condizionale incentiva o disincentiva impropriamente
l’atto di libertà; non quando serve a risolvere un problema o soddisfare un’esigenza, che conseguano
all’atto di libertà spontaneamente compiuto.
La condizione è illecita quando il modo in cui influenza gli effetti del contratto viola o elude norme o
principi di ordine pubblico, od è moralmente ripugnante.
L’illiceità non si limita a rendere nulla la clausola condizionale: essa rende nullo l’intero contratto
(1354.1).
La condizione è impossibile quando il fatto condizionante non può accadere.
Diversamente dall’illiceità, l’impossibilità della condizione ha conseguenze diverse, a seconda che
questa sia sospensiva o risolutiva (1354.2): la condizione sospensiva impossibile rende nullo il
contratto, la condizione risolutiva impossibile si ha come non apposta: il contratto vale come contratto
non condizionato.
Potrebbe pensarsi che la regola non aggiunga nulla ad un risultato che comunque si produrrebbe, di
fatto, anche in sua mancanza; in realtà essa non è superflua: ad es. preclude all’alienante di compiere
gli atti conservativi del 1356.2.
Il 1354.3 regola il caso che la condizione illecita od impossibile sia apposta non all’intero contratto, ma
ad una singola clausola.
Il trattamento della fattispecie risulta allora da due passaggi: col primo passaggio si verifica la sorte
della clausola, la clausola potrà vivere, depurata della condizione (se questa è risolutiva od
impossibile), o risultare nulla (se la condizione è illecita, o risolutiva impossibile, o meramente
potestativa): in quest’ultimo caso s’apre il secondo passaggio: il risultato potrà essere che il contratto
vive anche senza la clausola nulla, od invece che l’intero contratto è travolto, in base alle regole sulla
nullità parziale.
Il 634 dice che nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e
quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito
dall’articolo 626.
È controverso se le condizioni illecite ed impossibili nella donazione seguano la disciplina del contratto
o quella del testamento.
Si dice condizione casuale quella in cui il fatto condizionante è del tutto indipendente dalla volontà
delle parti.
Quando invece il fatto dipende da tale volontà, si distingue ulteriormente: si ha condizione mista, se la
volontà dei contraenti concorre solo in parte all’avveramento del fatto, mentre per altra parte questo
dipende da fattori esterni.
Si ha condizione potestativa, se il fatto dipende solo dalla volontà dei contraenti.
Si dicono condizioni meramente potestative quelle che fanno dipendere gli effetti contrattuali dalla
mera volontà della parte.
Il 1355 qualifica come nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una
condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da
quella del debitore.
La condizione meramente potestativa ricorre quando il compimento o non compimento del fatto
volontario risponde ad interessi del tutto estranei a quelli regolati o presupposti dal contratto, o non
corrisponde a nessun interesse che non sia quello di liberarsi del vincolo contrattuale a costo zero.
La tipica condizione meramente potestativa è “se vorrò” (si volam).
Il 1355 si applica quando la condizione per un verso consiste nella mera volontà di A, e per altro verso
influenza solo l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo dello stesso A, e nessun altro
effetto contrattuale.
Ben diverso sarebbe se il trasferimento o la fideiussione fossero subordinati alla mera volontà non già
di chi deve la prestazione, ma del beneficiario.
Immaginiamo che la condizione sia applicata ad una compravendita, i cui effetti sono subordinati a che
l’alienante dica che vuole alienare.
Un contratto del genere non fa scandalo, perché corrisponde in sostanza ad un’opzione di vendita (put);
qui la scelta fra volere e non volere condiziona non la sola alienazione, ma anche altri effetti
contrattuali, ed in particolare l’obbligazione del compratore per il prezzo: perciò far mancare la
condizione non ha costo zero per l’alienante, che si libera sì dall’impegno traslativo, ma
correlativamente perde il diritto al prezzo.
Uguale ragionamento, rovesciati i termini, può farsi laddove il “se vorrò” sia riferito al compratore: si
ha un’opzione di acquisto (call).
L’identità fra compravendita sotto condizione potestativa ed opzione non è perfetta: l’esercizio
dell’opzione determina il trasferimento ex nunc, la retroattività della condizione fa sì che il suo
avveramento determini il trasferimento ex tunc.
Il 1355 reprime le condizioni sospensive meramente potestative; non parla di quelle risolutive: ci si
domanda se il divieto valga anche per queste.
Il principio della serietà dell’impegno contrattuale può condurre alla nullità degli impegni assunti sotto
condizione risolutiva meramente potestativa.
Ma il principio che consente alle parti di pattuire a favore di una di esse la facoltà di recesso (anche
immotivato ed arbitrario) dice che al sistema non ripugna la possibilità di legare lo scioglimento del
contratto alla mera volontà di una parte.
Il recesso si distingue dall’avveramento della condizione risolutiva meramente potestativa sul piano
delle conseguenze, in ragione della normale retroattività della condizione e della normale irretroattività
del recesso.
La prestazione è attività dovuta dalla parte, materia di sua obbligazione e del corrispondente credito di
controparte; invece la condizione non obbliga la parte al comportamento in essa dedotto.
Nel primo caso ricorre lo schema della promessa scambiata con una (contropromessa di) prestazione:
se quest’ultima non viene adempiuta, scatta la responsabilità contrattuale dell’inadempiente.
Nel secondo caso lo schema può essere quello della promessa condizionata ad una prestazione: se
questa non viene eseguita, la parte da cui era attesa non incorre in responsabilità per inadempimento.
Lo schema della promessa condizionata ad una prestazione può identificarsi col modello del contratto
con obbligazioni del solo proponente: in cui la condizione assurge ad elemento della causa.
Per altro verso, esso aggira il requisito di patrimonialità della prestazione: la prestazione che condiziona
la promessa può anche non essere suscettibile di valutazione economica.
La distinzione fra condizione e prestazione dovuta non esclude che esse possano talora interferire, o
addirittura coincidere, per volontà delle parti.
Inoltre, è ammissibile la condizione di adempimento: l’adempimento di una parte è condizione
(sospensiva) degli effetti contrattuali, sicché questi si produrranno solo se la parte eseguirà la
prestazione prevista a suo carico dal contratto.
Si chiama condizione d’inadempimento la condizione (risolutiva) che all’inadempimento della parte fa
seguire lo scioglimento del contratto.
L’incertezza finisce o con l’avveramento o col mancamento della condizione.
Si ha avveramento quando il fatto condizionante avviene.
L’avveramento modifica la situazione preesistente: se si avvera la condizione sospensiva, il contratto
diventa efficace e comincia a produrre i suoi effetti; se si avvera la condizione risolutiva, il contratto
(fino a quel momento efficace) cessa di produrre effetti perché si risolve.
Si ha mancamento quando all’originaria incertezza subentra la certezza che il fatto condizionante non si
produrrà.
Il mancamento consolida la situazione preesistente: se manca la condizione sospensiva, il contratto è
definitivamente inefficace; se manca la condizione risolutiva, il contratto è definitivamente efficace.
Stabilire se una condizione si è avverata od è mancata significa formulare un giudizio di
corrispondenza fra gli accadimenti reali e la descrizione degli accadimenti, fatta nella clausola.
Può accadere che il fatto condizionante si produca, ma un successivo controfatto lo cancelli: la
condizione è avverata o mancata?
La risposta varia, a seconda dei casi.
Il criterio è se il controfatto realizzi proprio il rischio contemplato dal condizionamento, od un rischio
diverso ancorché parallelo.
Se il condizionamento investe tutti gli effetti del contratto, avveramento o mancamento della
condizione non incidono sull’equilibrio contrattuale: il contratto sarà del tutto efficace o del tutto
inefficace.
Idem se il condizionamento riguarda una singola clausola equilibrata al suo interno.
Si produce invece squilibrio quando il condizionamento riguardi una singola clausola, la quale dia
vantaggi esclusivamente (o prevalentemente) ad una parte, ed imponga sacrifici esclusivamente (o
prevalentemente) all’altra.
Può dirsi che il condizionamento rende il contratto aleatorio.
Chi fa valere una pretesa legata all’avveramento della condizione, ha l’onere di provarlo, trattandosi di
fatto costitutivo del diritto.
Di fronte ad una pretesa siffatta, il mancamento della condizione può essere rilevato d’ufficio dal
giudice, cui compete rilevare la carenza di fatti costitutivi del diritto azionato.
L’azione diretta a far dichiarare che il contratto è inefficace per mancamento della condizione
sospensiva è imprescrittibile.
Le conseguenze dell’avveramento o del mancamento della condizione si producono in modo
automatico ed inevitabile, o sono nella disponibilità delle parti?
La risposta si lega ad una distinzione: fra condizione bilaterale, che è quella posta nell’interesse di
entrambe le parti, e condizione unilaterale, che è quella posta nell’interesse esclusivo di una delle parti.
In caso di condizione unilaterale, la parte, nel cui esclusivo interesse la condizione è posta, è libera di
decidere se avvalersene o non avvalersene (con una sorta di “rinuncia” alla condizione).
L’accertamento del carattere “unilaterale” della condizione deve essere molto scrupoloso.
Se non è enunciato esplicitamente dalla clausola, ciò deve risultare da elementi che non lascino alcun
dubbio sul fatto che la condizione interessa esclusivamente una parte.
Una cosa è interesse prevalente, altra cosa è interesse esclusivo.
In secondo luogo, occorre contenere al minimo il sovrappiù d’incertezza generato dall’affermazione del
potere decisionale della parte, in luogo del normale automatismo delle conseguenze.
Può ammettersi che la rinuncia alla condizione venga fatta sia prima sia anche dopo il suo mancamento
od avveramento: ma in quest’ultimo caso entro un tempo breve.
Inoltre, conviene nutrire qui speciale diffidenza verso rinunce implicite, tacite o per fatti concludenti.
Infine, incidendo sulle conseguenze dell’avveramento o del mancamento, la rinuncia alla condizione
incide anche sugli acquisti fatti da terzi in pendenza della condizione: non è ammissibile una rinuncia
che alteri grado e qualità del rischio assunto da questi terzi con l’acquisto.
La condizione opera retroattivamente: gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al
tempo in cui è stato concluso il contratto (1360.1).
Se l’avveramento opera retroattivamente, la proprietà del bene trasferito sotto condizione sospensiva
appartiene all’acquirente fin dal momento del contratto: tutto ciò che tocca il bene, in senso favorevole
o sfavorevole, dovrebbe giovare o nuocere all’acquirente.
Lo stesso dicasi, nei confronti dell’alienante, per l’avveramento della condizione risolutiva: retroattività
del riacquisto significa che il bene si considera dell’alienante dal momento del contratto.
La regola della retroattività conosce molte deroghe.
Gli atti di amministrazione del bene, anteriori all’avveramento, non sono travolti se questo sottrae il
bene all’autore degli atti (1361.1).
I frutti percepiti sono dovuti a chi risulta titolare del bene in seguito all’avveramento della condizione
non dal momento del contratto, ma solo a partire dall’avveramento (1361.2).
Il rischio del perimento fortuito della cosa, sopravvenuto in pendenza di condizione sospensiva, non è
accollato all’acquirente: questi è liberato dalla sua obbligazione anche se poi la condizione si avvera
(1465.4).
L’avveramento della condizione risolutiva apposta a contratti di durata non ha effetti riguardo alle
prestazioni già eseguite; ma è fatto salvo l’eventuale patto contrario (1360.2).
In generale, la condizione non retroagisce, e l’efficacia o risoluzione del contratto decorrono solo
dall’avveramento, quando ciò corrisponda alla volontà delle parti od alla natura del rapporto (1360.1).
La regola di retroattività della condizione esclude la risoluzione per inadempimento del contratto
risolutivamente condizionato, che l’avveramento della condizione porta a considerare risolto fin
dall’inizio.
Esclude così che al contratto sospensivamente condizionato si applichi una legge sopravvenuta
ancorché anteriore all’avveramento.
Avverata la condizione, i danni recati da terzi al bene prima dell’avveramento legittimano l’azione
risarcitoria dell’acquirente sotto condizione sospensiva e dell’alienante sotto condizione risolutiva.
Con lo stesso criterio s’imputeranno le responsabilità legate alla proprietà del bene, come quella per
rovina di edificio ex 2053 (Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni
cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio
di costruzione).
Rispetto ai terzi, la retroattività della condizione opera come retroattività reale: gli effetti
dell’avveramento sono opponibili ai terzi ancorché protagonisti di vicende anteriori all’avveramento.
La pendenza della condizione è il periodo compreso fra la conclusione del contratto e l’avveramento od
il mancamento della condizione.
Sua caratteristica dominante è l’incertezza.
Durante la pendenza le posizioni soggettive delle parti si configurano così: una parte ha un’aspettativa,
l’altra parte ha un diritto precario.
Con riguardo a queste loro posizioni, le parti possono compiere tre tipi di atti: atti conservativi a tutela
dell’aspettativa, atti di esercizio del diritto precario, atti di disposizione dell’una o dell’altro.
L’aspettativa è la posizione di chi non ha il diritto, ma forse lo avrà con l’avveramento della
condizione.
Non avendo ancora il diritto, il titolare dell’aspettativa non può esercitarlo: perciò nei suoi confronti la
prescrizione non corre.
L’interesse dominante del titolare dell’aspettativa è preservare l’integrità degli elementi da cui
dipenderà l’utile esercizio del diritto.
Per questo il titolare dell’aspettativa può compiere atti conservativi: possibilità data sia all’acquirente
sotto condizione sospensiva (1356.1), sia all’alienante sotto condizione risolutiva (1356.2).
Se l’aspettativa riguarda un bene a rischio di danneggiamento o sottrazione, il titolare di essa può
svolgere azioni possessorie o chiedere provvedimenti cautelari atipici per preservarne l’integrità; se
riguarda un credito pecuniario, può attivare mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; se
riguarda crediti di fare o non fare, può attivare inibitorie od altri provvedimenti ex 700 c.p.c. (Fuori dei
casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il
tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio
imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che
appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione
sul merito).
Il diritto precario è la posizione di chi attualmente ha il diritto, ma forse lo perderà con l’avveramento
della condizione.
Titolare del diritto precario è la controparte del titolare dell’aspettativa, e dunque: l’alienante del diritto
sotto condizione sospensiva; l’acquirente del diritto sotto condizione risolutiva.
Il titolare del diritto precario può esercitarlo, ad es., usando il bene per sé: 1356.2
Con la precisazione che tale potere di esercizio è riconosciuto solo all’acquirente sotto condizione
risolutiva, non anche all’alienante sotto condizione sospensiva.
Chi ha l’esercizio del diritto può compiere atti di amministrazione del bene, che restano validi anche se
il successivo avveramento della condizione attribuisce il diritto stesso ad altra parte (1361.1): in altre
parole, non subiscono il principio di retroattività.
Aspettative e diritti precari sono posizioni soggettive, di cui il titolare può disporre: chi ha un diritto
subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa (1357), ma la
stessa norma delimita gli effetti: gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa
condizione.
In pendenza della condizione, ogni parte deve comportarsi secondo buona fede per conservare integre
le ragioni dell’altra parte (1358).
La buona fede indica qui ragionevole sensibilità agli interessi di controparte, leale cooperazione per
massimizzare i vantaggi e minimizzare gli oneri ed i rischi che le derivano dal contratto, anche al di là
di quanto esplicitato nelle clausole.
La violazione dell’obbligo di buona fede fa scattare rimedi a favore della parte che la subisce.
Un rimedio tipico, specificamente previsto per le situazioni di pendenza condizionale, è costituito dagli
atti conservativi a tutela dell’aspettativa.
Un altro rimedio tipico è la finzione di avveramento della condizione: esso reagisce contro la più grave
delle lesioni concepibili a danno della parte del contratto condizionato: attivarsi per realizzare quello
stesso rischio contro il quale la parte ha voluto cautelarsi, condizionando il contratto.
A metà fra i due estremi si collocano risoluzione del contratto per inadempimento, e risarcimento del
danno.
La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva
interesse contrario all’avveramento di essa (1359).
Criterio: il mancamento realizza od invece neutralizza il rischio contemplato dal condizionamento?
Un altro limite all’operatività del 1359 deriva dalla regola per cui la norma non si applica alle
condizioni potestative (od alla dimensione potestativa delle condizioni miste).
Un ulteriore filtro è dato da ciò, che la condizione deve mancare per causa imputabile alla parte.
Ciò richiama un ragionevole criterio di causalità, che porta ad escludere la finzione di avveramento
quando la parte abbia operato sì per il mancamento, ma la condizione sarebbe mancata anche senza il
suo intervento.
Dato un contratto condizionato, non c’è a priori una sola parte identificabile come l’unica portatrice di
interesse contrario all’avveramento.
La norma sulla finzione di avveramento della condizione fatta scorrettamente mancare, può giustificare
anche una finzione di mancamento della condizione fatta scorrettamente avverare.
I criteri selettivi sono quelli già visti: in particolare, coerenza od antagonismo dell’avveramento rispetto
al piano d’interessi sotteso al condizionamento.
Perché scatti la finzione, la causa dell’improprio mancamento (od avveramento) deve essere imputabile
alla parte.
Talora occorre il dolo: sono i casi in cui la condotta della parte, rilevante ex 1359, s’identifica con una
violazione dell’obbligo di buona fede ex 1358.
Altre volte basterà la colpa.
E non è escluso che la finzione possa scattare a titolo d’imputabilità oggettiva, per fatti non colposi
della parte.
Fin qui si è considerata la c.d. condizione volontaria (condicio facti): quella introdotta in contratto per
libera decisione delle parti; ad essa usa contrapporsi la c.d. condizione legale (condicio iuris): e cioè
l’elemento a cui una norma subordina l’efficacia del contratto, che – ancorché perfezionato – è per
legge inefficace fino al prodursi dell’elemento condizionante.
L’esempio tipico riguarda i contratti degli enti pubblici.
Concluso il contratto fra il privato e l’ente, esso è vincolante per le parti, ma non ancora produttivo di
effetti: questi si produrranno solo se il contratto riceverà l’autorizzazione (o l’approvazione, od il visto)
della competente autorità di controllo.
Può accadere che le parti riproducano in una clausola contrattuale la previsione legale condizionante,
ma la clausola potrebbe dire qualcosa di più e di diverso rispetto alla norma, ed allora ha rilevanza
autonoma.
La questione teorica più dibattuta è se la condizione legale sia accomunabile alla condizione volontaria
entro una categoria unitaria che le comprende entrambe; o se invece costituisca figura aliena ed
irriducibile alla condizione degli artt. 1353 ss.
La principale questione pratica è se alle condizioni legali sia applicabile la disciplina delle condizioni
volontarie.
Certo non si applica la regola sulla rinunciabilità della condizione unilaterale.
Non ha spazio la finzione di avveramento: la legge vuole che senza autorizzazione il contratto
comunque non operi.
La parte danneggiata non ha rimedio in forma specifica, ma solo per equivalente: il risarcimento del
danno.
In che misura, dipende da come si ricostruisce la vicenda.
Si può dire che il 1359 è del tutto fuori gioco, e che il contratto resta perciò radicalmente inefficace:
l’azione della parte lesa si fonda allora sul 1338, ed il suo risarcimento è parametrato all’interesse
negativo.
Ma si potrebbe anche dire che l’inapplicabilità del 1359 è solo parziale: in base alla norma, ciò che non
può farsi è portare il contratto ad esecuzione: ma, al netto di ciò, il contratto è reso operante sotto ogni
altro profilo.
Avremo allora un contratto operante, ma la cui attuazione risulta impossibile per causa imputabile alla
parte che ha impedito il rilascio dell’autorizzazione: questa ne risponde contrattualmente ex 1218, e
deve perciò il danno positivo (Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile).
Infine, non c’è difficoltà ad ammettere che la condizione legale operi retroattivamente, negli stessi
limiti in cui vale la retroattività della condizione volontaria.
Pare opinabile la teoria che assimila a condicio iuris la ratifica del contratto concluso dal rappresentante
senza poteri.
Sul terreno normativo la retroattività reale della ratifica è esclusa dal 1399.2, che salva i diritti dei terzi.
Sul piano concettuale, l’efficacia del contratto ratificato rimonta ad un atto di autonomia privata,
portatore di interessi interni al contratto: siamo in una dimensione che non è quella tipica delle
condizioni legali.
CAPITOLO 28 – IL TERMINE
Il termine è l’indicazione del tempo nel quale si collocano gli effetti del contratto.
Il termine iniziale indica il tempo a partire dal quale gli effetti si producono.
Nondimeno, anche prima del termine le parti sono vincolate: il contratto ha già forza di legge.
Il termine iniziale è compatibile con la previsione che taluni effetti contrattuali scattino prima.
Il termine iniziale del contratto non va confuso col termine di adempimento dell’obbligazione:
quest’ultimo indica il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita (1183.1), e quindi il momento in
cui il credito diventa esigibile: momento che può non coincidere con quello in cui il credito sorge per
l’avvento del termine iniziale del contratto.
Il termine finale indica il tempo in cui il contratto cesserà di produrre i suoi effetti.
Il termine finale può indicarsi con una data di calendario (ad es.: 30-9-2160), o per rinvio ad un fatto
futuro certus an ma incertus quando (ad es.: alla morte di Tizio), o con la previsione di durata del
contratto (ad es.: 19 mesi).
Durata del contratto è il tempo compreso fra la produzione e la cessazione degli effetti contrattuali.
Il termine ha qualcosa in comune con la condizione: sono entrambi strumenti di autonomia: per questo
vengono ricondotti, insieme con l’onere, alla categoria degli elementi accidentali (contrapposti ad
essenziali) del contratto.
La condizione, legata ad un fatto incerto, crea incertezza assoluta sugli effetti del contratto; invece il
termine esclude ogni incertezza; oppure crea un’incertezza limitata, che investe non il “se” degli effetti,
ma solo il “quando” della loro produzione o cessazione.
Mentre la condizione riceve una disciplina organica in sede di parte generale del contratto, non c’è una
disciplina generale del termine (o meglio, c’è ma riguarda il termine dell’adempimento, non del
contratto).
La disciplina legale della condizione si preoccupa essenzialmente di regolare il meccanismo per
garantirne l’efficiente e corretta funzionalità.
Invece la disciplina legale del termine, là dove frammentariamente si esprime, è quasi sempre
disciplina imperativa o proibitiva, o talora integrativa di lacune del regolamento volontario.
Essa riflette una tensione fra legge ed autonomia privata.
L’apposizione di un termine iniziale attira il contratto nella classe dei contratti ad esecuzione differita
(che sono contratti ad esecuzione istantanea, come tali contrapposti ai contratti di durata).
Il 1465.2 riguarda i soli contratti con effetti reali, e regola le conseguenze dell’impossibilità
sopravvenuta della prestazione, dipendente da perimento della cosa, quando l’effetto traslativo o
costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
Il 1467.1 colloca i contratti ad esecuzione differita, insieme con quelli di durata, nel novero dei contratti
cui è riservato il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità.
Le discipline evocate si applicano solo in presenza di un termine per l’adempimento di una qualsiasi
prestazione da esso prevista.
La giurisprudenza precisa che per aversi contratto ad esecuzione differita (sottoposto a termine iniziale)
non è necessario il differimento di tutti gli effetti contrattuali, cioè dell’intera prestazione e dell’intera
controprestazione: è sufficiente che sia differita una delle due prestazioni.
A questo stesso criterio può ricondursi la distinzione concettuale fra termine del contratto e termine
dell’adempimento: il primo differisce almeno una parte sostanziale della prestazione; il secondo
differisce solo una parte marginale della prestazione.
Il preliminare è, per definizione, contratto ad esecuzione differita: se non reca il termine per la
conclusione del definitivo, la giurisprudenza ammette che possa essere fissato dal giudice ex 1183.
Il problema del termine finale si pone nei contratti di durata, cioè ad esecuzione continuata o periodica.
Una prima opzione del legislatore consiste nel valutare se possa ammettersi un contratto di durata senza
termine: se sì, può aversi contratto a tempo indeterminato; se no, si aprono due opzioni.
Con l’una si valuta se nella fissazione del termine l’autonomia privata possa essere sovrana, od invece
debba sottostare a limiti; l’altra presuppone che, nel campo ad essa disponibile, l’autonomia privata non
abbia espresso alcuna scelta: e consiste nello scegliere lo strumento d’integrazione per colmare la
lacuna: norma di legge, o determinazione giudiziale.
Per alcuni contratti di durata, la legge ammette che il contratto non contenga alcun termine: esso è
allora a tempo indeterminato, e produce i suoi effetti ad oltranza, fino a che non sopravvenga una causa
di cessazione degli effetti medesimi.
Tale causa può essere ad es. una risoluzione, od un recesso unilaterale; quest’ultimo è per lo più recesso
legale, perché è la legge che lo attribuisce, anche in assenza di previsione delle parti.
Questo recesso di liberazione risponde a principi di ordine pubblico, sicché le parti non possono
accordarsi per escluderlo.
Possono però concordare varianti allo schema base.
Diverso dal contratto a tempo indeterminato è il contratto perpetuo: caratterizzato non dal semplice
dato negativo della mancanza di termine, ma dal dato positivo della precisa volontà delle parti di
vincolarsi per sempre.
Un tale contratto è nullo, per il principio di ordine pubblico cui ripugnano le autolimitazioni eccessive
della propria libertà: salvo che la legge gli assegni d’autorità un termine (1573); o che, per il
meccanismo della conversione, si converta in contratto a tempo indeterminato (con facoltà di recesso).
Per alcuni tipi di contratto, la legge esige che il contratto abbia un termine.
È normale che – ferma la validità del contratto – la lacuna venga colmata per via d’integrazione
suppletiva.
È anche normale che la legge non lasci alle parti piena libertà di determinazione del termine, ma ponga
limiti inderogabili: la loro eventuale violazione ad opera delle parti fa scattare meccanismi
d’integrazione cogente.
Il termine inderogabile nel massimo segnala che il legislatore ritiene socialmente od economicamente
dannosa una durata troppo lunga del rapporto (es.: 30 anni per la locazione, ex 1574).
Il termine inderogabile nel minimo esprime, al contrario, un giudizio d’indesiderabilità di rapporti
troppo brevi.
Ad es.: la locazione d’immobili non abitativa non può avere un termine inferiore a 6 o 9 anni.
L’integrazione del regolamento contrattuale quanto al termine normalmente si compie in via legale.
Più di rado segue la via giudiziale: se le parti non fissano il termine del mutuo, vi provvede il giudice
(1817).
Se il termine concordato è esageratamente lungo, il contratto si considera senza termine.
Un termine molto lungo è tollerato (anzi, considerato normale) nei contratti costitutivi di certi diritti
reali: ad es., contratto costitutivo di superficie per 99 anni.
Le locazioni immobiliari ultranovennali devono farsi per iscritto a pena di nullità (1350, n. 8), e sono
soggette a trascrizione (2643, n. 8): qui la misura del termine pattizio incide sul regime di circolazione
del bene dedotto in contratto, nonché sulla validità di questo.
Alla scadenza del termine finale, il contratto si dice “scaduto”.
Il contratto rinnovato o prorogato continua a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza del termine.
Talora è la legge a disporre che alla scadenza il contratto sia prorogato (proroga legale).
Può farlo con norma imperativa, che non lascia spazio alla diversa volontà delle parti.
Fuori delle fattispecie di proroga legale, le parti possono convenire proroghe convenzionali.
Nel linguaggio delle clausole, spesso si dice che in mancanza di disdetta il contratto sarà rinnovato
tacitamente: formula impropria, perché avendo il rinnovo fonte nell’esplicita previsione pattizia, esso
merita di qualificarsi espresso.
Di rinnovo tacito può propriamente parlarsi quando il contratto non contiene alcuna clausola di rinnovo
alla scadenza, e la volontà delle parti di rinnovarlo viene desunta da comportamenti concludenti.
La disdetta si distingue concettualmente dal recesso: il recesso scioglie un contratto ancora in corso, la
disdetta interviene su un contratto scaduto del quale impedisce la proroga.
CAPITOLO XXIX – IL CONTRATTO PRELIMINARE
Il contratto preliminare è il contratto che obbliga le parti a concludere in futuro un determinato
contratto (contratto definitivo).
Il contratto preliminare si chiama, nella pratica, “compromesso”.
La figura realizza una sfasatura degli effetti contrattuali: prima gli effetti (obbligatori) del preliminare,
e solo dopo gli effetti (eventualmente reali) del definitivo.
La funzione prevalente è una funzione di controllo sulla conformità del bene o della prestazione al
programma contrattuale.
Il contratto preliminare richiede, a pena di nullità, la stessa forma che la legge prescrive per il contratto
definitivo (1351).
La regola è necessaria perché gli effetti del definitivo possono prodursi anche senza la valida
conclusione di esso, grazie a sentenza costitutiva ex 2932 (Se colui che è obbligato a concludere un
contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo,
può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti
che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il
trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non
esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia
ancora esigibile.).
L’oggetto immediato del preliminare è la conclusione del definitivo; ma in via mediata esso ha per
oggetto le stesse prestazioni dedotte nel definitivo.
L’oggetto del preliminare deve essere determinato o determinabile.
La causa del preliminare è la stessa del definitivo, cui il preliminare punta.
Il contratto preliminare va distinto dalle minute, che documentano accordi parziali, e dalle lettere
d’intenti: queste implicano la non avvenuta conclusione del contratto, e sono presidiate da rimedi non
contrattuali; invece il preliminare è un contratto concluso.
Va distinto dal contratto cui accede un accordo di riproduzione in altra forma: questo è un contratto già
definitivo, ed immediatamente produttivo degli effetti.
Va distinto dall’opzione.
Infine, il contratto preliminare va distinto dal corrispondente contratto definitivo; non può attribuirsi
valore dirimente alla circostanza che il contratto già produca anticipatamente alcuni effetti che
sarebbero propri del definitivo (ricorre in tal caso la figura del preliminare con effetti anticipati).
Il preliminare può applicarsi a varianti obbligatorie di contratti normalmente ad effetti reali immediati:
vendita di cosa futura o di cosa altrui.
Può applicarsi a contratti con effetti obbligatori; può applicarsi a contratti associativi (la prassi conosce
preliminari di società e di consorzio).
È dibattuta la configurabilità del preliminare di contratti reali.
Chi la nega pone l’alternativa: o alla conclusione del contratto c’è consegna della cosa, ed allora,
producendosi tutti i suoi effetti, il contratto è già definitivo; oppure non c’è consegna, ed allora il
contratto è nullo ex 1351.
Il ragionamento trascura che a determinate condizioni (sostanzialmente coincidenti con l’onerosità del
contratto) possono ammettersi varianti consensuali dei contratti tipicamente reali.
Un’altra area problematica è quella della donazione.
Giurisprudenza e parte della dottrina negano l’ammissibilità del preliminare di donazione, per
incompatibilità fra lo spirito di liberalità, essenziale al tipo del definitivo, e la natura di atto dovuto che
questo assumerebbe alla luce del preliminare.
Qualche pronuncia nega l’ammissibilità del preliminare di preliminare.
Lo schema del contratto preliminare può combinarsi con altri particolari schemi contrattuali.
Può combinarsi con lo schema del contratto a favore di terzo in modi diversi, che danno luogo a due
diverse combinazioni: una è il contratto preliminare a favore di terzo (A e B stipulano che B è
obbligato a concludere il definitivo con X); l’altra è il preliminare di contratto a favore di terzo.
Può combinarsi con lo schema del contratto per persona da nominare, dando luogo anche qui a due
sottoschemi: contratto preliminare per persona da nominare (il terzo nominato subentra nel
diritto/obbligo al contratto definitivo), e preliminare di contratto per persona da nominare.
Può combinarsi con lo schema del contratto unilaterale (con obbligazioni di una sola parte), dando
luogo alla figura del preliminare unilaterale: questa ricorre quando l’obbligo di concludere il definitivo
è assunto non in via reciproca da ogni contraente verso l’altro, ma da uno solo dei due verso l’altro,
così che quest’ultimo ha diritto al contratto ma non obbligo di contrarre.
La funzione tipica del preliminare unilaterale sostanzialmente coincide con quella dell’opzione, ed
infatti è diffusa l’idea che le due figure coincidano.
La principale differenza riguarda il modo per giungere al contratto-obiettivo: l’opzionario ha il potere
di costituire il contratto finale mediante negozio unilaterale, con la dichiarazione di esercizio
dell’opzione.
Invece nel preliminare unilaterale il contratto definitivo si costituisce o mediante negozio bilaterale, o
per via giudiziale.
Un’altra differenza è che la posizione del promittente nel preliminare unilaterale è di obbligo, mentre
quella dell’opzionante è di soggezione.
Quanto al regime di opponibilità ai terzi, il preliminare (unilaterale) è trascrivibile, mentre la tesi
tradizionale esclude la trascrivibilità dell’opzione.
Altra notevole variante della figura base è il preliminare ad esecuzione anticipata, o con effetti
anticipati: la figura ricorre quando si conviene che alcuni effetti del definitivo si producano ancora
prima della conclusione di esso.
Fino a che punto le prestazioni o gli effetti possono essere anticipati, senza che il preliminare perda la
propria natura?
In un preliminare di vendita si può anticipare la consegna della cosa; si può anticipare il pagamento
anche integrale del prezzo; ciò che non può anticiparsi è il trasferimento della proprietà.
Un altro problema riguarda la natura del definitivo, alla luce del fatto che parte delle sue prestazioni
tipiche si sono consumate prima di esso: non restando più alcun prezzo da pagare, quale causa regge un
definitivo che si limiti a trasferire la proprietà dal promittente venditore al promissario compratore, il
quale non dà nulla in cambio?
Una causa c’è, ravvisabile o nello scambio col prezzo già pagato (causa praeterita), o
nell’adempimento dell’obbligazione di trasferire, creata dal preliminare (causa solvendi).
In generale il definitivo è caratterizzato da doppiezza della causa.
Per un verso ha causa solvendi: le parti lo concludono per adempiere l’obbligo assunto col preliminare.
Ma al tempo stesso ha causa sua propria: le parti lo concludono per scambiarsi bene contro prezzo.
Il preliminare e il definitivo sono due contratti distinti, e separati nel tempo; ma sono anche due
contratti legati fra loro in una sequenza concepita come operazione unitaria.
Nei casi di divergenza prevalgono le previsioni del preliminare, o le diverse previsioni del definitivo?
Vanno escluse le soluzioni pregiudizialmente estreme: sia quelle dell’intangibilità del preliminare ad
opera del definitivo, sia l’opposta tesi dell’assorbimento del preliminare nel definitivo.
Si tratta di valutare caso per caso, ricostruendo volontà delle parti e senso dell’operazione.
Se il definitivo regola un punto trascurato del tutto dal preliminare, non c’è ragione di negare valore
alla nuova previsione del definitivo.
Se il definitivo regola diversamente un punto già regolato dal preliminare, in prima battuta potrà
pensarsi che le parti abbiano concordato la modifica, ma resta aperto uno spiraglio alla prova che la
variazione in sede di definitivo è in realtà un refuso.
Le maggiori incertezze sorgono quando il definitivo non ripete una previsione del preliminare.
Il definitivo concluso dal contraente incapace è annullabile?
Il definitivo è valido perché atto dovuto in base al preliminare, insensibile all’incapacità di chi,
concludendolo, adempie (cfr. il 1191: Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può
impugnare il pagamento a causa della propria incapacità).
La risposta vale nei soli limiti in cui il definitivo sia atto necessitato dal preliminare: non, quindi,
laddove modifichi contenuti del preliminare: in tal caso, l’annullabilità può circoscriversi alle
modifiche.
Consideriamo la situazione in cui vizi e sopravvenienze affliggano un preliminare non ancora seguito
dal corrispondente definitivo; il contraente può invocare dei rimedi al fine di annientare il contratto: sia
in via di azione, agendo per la cancellazione del preliminare e degli obblighi che ne derivano; sia in via
di eccezione, onde respingere la pretesa di controparte.
Una linea di pensiero pone ostacoli all’attivazione dei rimedi contro il preliminare, sotto il profilo che
questo non causerebbe ancora al contraente il pregiudizio in vista del quale i rimedi sono concessi;
l’attualità del pregiudizio scatterebbe solo col definitivo, e quindi solo contro questo – una volta che sia
stato concluso – la parte protetta potrebbe invocare i rimedi.
La tesi va respinta: essa implica che le prestazioni oggetto del preliminare si riducano alla
manifestazione del consenso necessario per concludere il definitivo, ma non è così, perché oggetto del
preliminare sono le stesse prestazioni dedotte nel definitivo.
Vizi e sopravvenienze che, ancor prima del definitivo, colpiscono o mettono a rischio la prestazione
dedotta in questo, deludono direttamente l’interesse contrattuale della parte del preliminare.
Morta la parte, i suoi eredi subentrano nell’obbligo di concludere il definitivo (che non sia intuitu
personae).
Fallita la parte, il curatore ha facoltà di decidere se subentrare nell’obbligo e concludere il definitivo,
od invece sciogliersi dal rapporto senza dovere alcunché a controparte (72.2 l.f.).
Acquisito che vizi e sopravvenienze danno alla parte delusa i corrispondenti rimedi di annientamento
(quelli che puntano alla distruzione del contratto), ci si domanda adesso se aprano anche la via ai
rimedi di adeguamento (quelli che salvano il contratto, modificandolo): è preferibile una risposta
affermativa.
Esaminiamo adesso in che modo i rimedi contrattuali siano influenzati dalla circostanza che al
preliminare segua la conclusione del definitivo fra le parti.
Il problema non si pone quando il vizio colpisce non il preliminare ma solo il definitivo, o quando la
sopravvenienza interviene solo dopo il definitivo.
Determinati rimedi, applicabili al definitivo se questo fosse un contratto isolato, sono resi inapplicabili
dal suo inserimento nella sequenza aperta dal preliminare, entro la quale il definitivo prende i colori
dell’atto dovuto.
Il problema si complica nei casi in cui il definitivo segua un preliminare affetto da vizi o
sopravvenienze (dunque nullo od annullabile o rescindibile o risolubile), ma non impugnato dalla parte
legittimata, che conclude il definitivo.
È decisivo il fattore prescrizione: in relazione ad esso, conviene distinguere fra due situazioni: la prima
è quella in cui il rimedio contro il preliminare è imprescrittibile, o non ancora prescritto al tempo del
definitivo.
Ciascun caso va valutato e deciso alla luce delle circostanze concrete.
Se la parte legittimata sapeva di poter attaccare il preliminare, ed ha concluso il definitivo, può pensarsi
alla sua volontà di rinunciare al rimedio; se invece la parte ignorava il difetto del preliminare, la
conclusione del definitivo prende il colore prevalente dell’atto compiuto perché dovuto, la sua
autonomia si attenua e si rafforza la dipendenza dal preliminare: il definitivo è attaccabile.
Su che basi? Il preliminare per il vizio suo proprio, il definitivo per errore di diritto.
La seconda situazione è quella in cui il rimedio contro il preliminare è prescrittibile, e risulta prescritto
al tempo del definitivo: preliminare annullabile o rescindibile o risolubile, seguito da definitivo
concluso oltre il termine di prescrizione delle relative azioni.
Qui il definitivo è stato concluso quando la parte non poteva più legittimamente rifiutarlo: esso è perciò
inattaccabile.
Lo stesso risultato pratico deve affermarsi per il caso di preliminare annullabile.
La soluzione dell’inattaccabilità del definitivo è disattesa dalla giurisprudenza di fronte ad un
preliminare rescindibile: le massime dicono che la conclusione del definitivo rigenera un’azione di
rescissione contro quest’ultimo, dal quale decorre un nuovo termine di prescrizione.
L’inadempimento del preliminare è l’inadempimento delle prestazioni che ne formano l’oggetto.
Queste s’identificano, immediatamente, nella prestazione di concludere il definitivo; ma anche, in via
mediata, nelle stesse prestazioni dedotte nel definitivo.
Perciò ogni comportamento che pregiudichi o metta a rischio le prestazioni attese, è inadempimento del
preliminare, che scatena i rimedi generali contro l’inadempimento.
L’inadempimento più tipico è la mancata conclusione del definitivo entro il termine dovuto: anche qui
la parte adempiente ha la scelta fra domanda di risoluzione e domanda di attuazione del contratto.
Se sceglie l’attuazione, ha un rimedio particolare, previsto e regolato dal 2932: la costituzione – per
sentenza – degli effetti del definitivo non concluso.
La parte può ottenere il rimedio se ricorrono alcuni presupposti: che vi sia inadempimento di
controparte; che l’effetto costitutivo sia possibile e non sia escluso dal titolo; che la parte abbia eseguito
od offerto la propria prestazione.
Quando il rimedio costitutivo è impossibile, alla parte adempiente non resta che risoluzione del
preliminare e risarcimento del danno.
L’ultimo presupposto è riferito dalla norma ai soli contratti con effetti reali: l’attore che chiede la
sentenza costitutiva di tali effetti deve eseguire od offrire la prestazione a suo carico, sempre che questa
sia già esigibile (2932.2); c’è da chiarire in che tempi ed in che modi.
I tempi dipendono dal titolo, cioè dalle previsioni del preliminare.
Per garantire contestualità fra costituzione degli effetti richiesti ed effettività del pagamento dovuto, la
creatività giurisprudenziale ricorre al meccanismo della pronuncia condizionata, con sentenze che
dispongono gli effetti subordinatamente alla condizione sospensiva dell’effettivo pagamento di quanto
dovuto dall’attore.
Quanto ai modi dell’offerta, la legge richiede di farla nei modi di legge: sembra un rinvio all’offerta
formale ex 1208-1209, ma la giurisprudenza s’accontenta di un’offerta “secondo gli usi” (1214).
Il 2932 è invocabile anche dal promittente alienante contro il promissario acquirente che rifiuti il
definitivo.
È invocabile di fronte all’inadempimento di un preliminare che riguardi un definitivo con effetti solo
obbligatori.
È invocabile dal terzo in favore del quale il preliminare sia stato stipulato.
Il giudice che emana la sentenza costitutiva contro la Pubblica Amministrazione non invade
indebitamente la sfera della sua discrezionalità, ma applica un rimedio contrattuale a carico di un
contraente che rifiutando di adempiere non fa uso legittimo di discrezionalità amministrativa, ma
commette un illecito civile.
Ancora, il meccanismo del 2932 trova applicazione contro l’inadempimento di obblighi di contrarre,
che hanno fonte in un contratto, ma non in un contratto preliminare: può ricorrervi il mandante ad
acquistare, di fronte al rifiuto del mandatario di trasferire il bene.
La sentenza costitutiva del 2932 ha una doppia natura: è, come sentenza, un atto giurisdizionale; ma al
tempo stesso, costituendo gli effetti di un contratto, è fonte di un rapporto contrattuale.
La natura di sentenza ne determina il regime d’impugnabilità, di sospensione dell’efficacia, e
soprattutto le preclusioni legate alla forza del giudicato.
Per altro, essa è fonte (immediata, ma formale) di effetti contrattuali, la cui fonte (mediata, ma
sostanziale) è il contratto preliminare.
Essa, dunque, attiva un rapporto contrattuale.
Nei confronti di tale rapporto sono esperibili gli ordinari rimedi contrattuali.
La trascrizione del preliminare (immobiliare) è prevista dal 2645-bis.
Non tutti i preliminari di contratti trascrivibili possono trascriversi: sono trascrivibili solo i preliminari
dei contratti di cui ai numeri 1-4 del 2643 (1: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2: i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il
diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta; 3: i contratti che costituiscono la
comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4: i contratti che costituiscono o modificano
servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione): in pratica, solo i
preliminari dei contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano diritti reali immobiliari.
La norma precisa poi che sono trascrivibili i preliminari aventi ad oggetto edifici da costruire o in corso
di costruzione.
Ripete infine la regola generale per cui la trascrizione può riguardare i soli contratti preliminari che
risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata
giudizialmente.
Seppur la norma usi il verbo “dovere”, la trascrizione è solo un onere e non un obbligo della parte.
La tutela del promissario acquirente si realizza con un effetto prenotativo della trascrizione, che scatta
sulla base di due presupposti.
Il primo presupposto è una sequenza di trascrizioni: oltre al preliminare, e dopo il preliminare, deve
trascriversi un atto ulteriore, e cioè quello che produce gli effetti reali.
Tale ulteriore atto può presentarsi sotto tre figure (2645-bis comma 2):
se le cose procedono fisiologicamente, sarà il contratto definitivo;
nell’ipotesi patologica d’inadempimento del preliminare, sarà la sentenza costitutiva (anzi, ancor
prima, si trascriverà la relativa domanda giudiziale);
in alternativa, può anche essere ogni altro atto che costituisca comunque esecuzione del preliminare:
questo atto di esecuzione atipica del preliminare deve presentare un collegamento certo col
preliminare stesso, occorre che l’atto menzioni il preliminare quale elemento della propria causa
(solvendi) o quantomeno deve risultare in modo univoco che esso ha (anche) la funzione di attuare il
preliminare.
Il secondo presupposto è cronologico: le trascrizioni di cui sopra devono farsi entro un anno dalla data
stabilita per la conclusione del definitivo, e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare;
se la trascrizione dell’atto produttivo degli effetti finali non segue entro questi termini, gli effetti della
trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti (2645-bis comma 3).
Realizzatosi il doppio presupposto, scatta l’effetto prenotativo: la trascrizione dell’atto produttivo degli
effetti finali prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la
trascrizione del contratto preliminare (2645-bis comma 2), secondo lo stesso schema per cui, trascritta
la domanda giudiziale, gli effetti della successiva sentenza di accoglimento, a sua volta trascritta,
retroagiscono alla trascrizione della domanda.
Pacifico che la tempestiva sequenza di trascrizioni consente al promissario acquirente di prevalere sugli
aventi causa dal promittente alienante, si discute se gli dia analoga prevalenza anche sui creditori di
costui, che dopo la trascrizione del preliminare abbiano trascritto atti di pignoramento: entrambe le tesi
sono autorevolmente sostenute.
In ogni caso, per quanto riguarda l’azione revocatoria, per valutare buona o mala fede rilevanti ex
2901.1 (Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano
dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi
pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse
il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere
del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che,
inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto
anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione), deve farsi riferimento
alla conclusione del preliminare, perché solo quest’atto è libero, mentre il definitivo è dovuto (se c’era
buona fede al tempo preliminare, non può nuocere la mala fede sopravvenuta al tempo del definitivo).
La trascrizione del preliminare dà al promissario acquirente una tutela reale, garantendogli la proprietà
dell’immobile contro terzi concorrenti.
Ma può darsi che questa tutela non operi: ad es. perché egli – di fronte al rifiuto del definitivo da parte
del promittente venditore, che abbia nel frattempo alienato il bene ad un terzo – non ha voglia di agire
ex 2932, ed opta per la risoluzione del preliminare: in questo caso l’interesse del promissario acquirente
si concentra sul recupero degli anticipi per avventura versati a controparte (oltre che dei danni).
In situazioni del genere, i crediti del promissario acquirente sono rafforzati dal 2775-bis: la norma li
assiste, subordinatamente alla trascrizione del preliminare, con privilegio speciale sull’immobile che ne
formava oggetto.
Tale privilegio, però, cede di fronte alle ipoteche che garantiscono i crediti derivanti da finanziamenti
concessi per l’acquisto o la costruzione dell’immobile (2775-bis comma 2; 2825-bis).
CAPITOLO XXX – IL CONTRATTO FIDUCIARIO
Il contratto fiduciario è quello con cui il fiduciante trasferisce un bene al fiduciario, che si obbliga a
conservarlo e/o amministrarlo secondo certi criteri, e a ritrasferirlo successivamente allo stesso
fiduciante o ad un terzo.
Caratteristica immediata del contratto fiduciario è la produzione combinata di effetti reali in capo al
fiduciario, e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante: più precisamente, la combinazione di un
effetto reale con due effetti obbligatori.
L’effetto reale è il trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario; gli effetti obbligatori sono:
l’obbligo del fiduciario verso il fiduciante di ritrasferire a suo tempo il bene; ed osservare modalità
vincolate nell’amministrazione del bene per il tempo in cui resterà proprietà del fiduciario.
Anche contratti non fiduciari (come ad es. la vendita) possono combinare effetti reali a vantaggio
dell’acquirente ed effetti obbligatori a vantaggio dell’alienante.
Ed allora la nozione di contratto fiduciario può precisarsi meglio, osservando che in esso gli effetti
obbligatori vertono sullo stesso bene che forma oggetto degli effetti reali, e sono precisamente diretti a
correggere o limitare questi.
Il contratto fiduciario non ha nulla a che fare coi contratti basati sulla fiducia che una parte ripone
nell’altra (intuitus personae); “fiducia” in senso tecnico (effetto traslativo combinato a vincolo
personale di ritrasferimento) ricorre invece nella fiducia testamentaria di cui al 627 (Non è ammessa
azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento
sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento
possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.
Tuttavia
la
persona
dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni
alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace. Le
disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l’istituzione o il legato sono impugnati
come fatti per interposta persona a favore d’incapaci a ricevere).
Il contratto fiduciario non produce semplici impegni morali, d’onore o di cortesia, ma veri e propri
effetti giuridici, azionabili e coercibili secondo i meccanismi della legge: in particolare, i suoi effetti
obbligatori danno luogo ad obbligazioni legali e non ad obbligazioni naturali (salvo che per le
disposizioni fiduciarie mortis causa, cui s’applica lo schema dell’obbligazione naturale: 627 commi I e
II).
Gli effetti sono veri e reali, e non fittizi: il contratto fiduciario non è un contratto simulato, e non dà
luogo all’interposizione fittizia (con quest’ultima il simulato acquirente del bene ne diventa titolare solo
apparente e non effettivo).
Il contratto fiduciario, come ogni contratto, obbedisce al principio della causa, che non s’identifica in
una “causa fiduciaria”.
Il combinarsi di effetti reali ed obbligatori, tipico del contratto fiduciario, di per sé non dà luogo a causa
di scambio, perché non c’è qui l’incrocio fra una prestazione ed una corrispettiva controprestazione.
La causa del contratto fiduciario va cercata fuori del meccanismo fiduciario (nel caso di fiducia cum
creditore è causa di garanzia).
L’impegno, assunto da un fiduciario del tutto disinteressato, a ricevere il bene dal fiduciante assumendo
gli obblighi connessi è perciò nullo: il fiduciario può rifiutare l’intestazione.
Se l’intestazione avviene comunque, il fiduciario può chiedere che venga azzerata.
Ma dato che l’avvenuta intestazione può aver creato l’affidamento del fiduciante sul regolare sviluppo
dell’operazione, la giusta pretesa del fiduciario di dismettere gli effetti del contratto deve essere da lui
coltivata in modo da non ledere ingiustamente tale affidamento.
La causa del contratto fiduciario può – come in ogni contratto – essere lecita od illecita.
È illecita quando il contratto viola o froda norme imperative o principi di ordine pubblico: si pensi alla
fiducia cum creditore, facile a cadere nell’illiceità per contrasto col divieto del patto commissorio
(2744).
La peculiare conformazione degli effetti del contratto fiduciario crea un particolare rischio di abuso del
fiduciario, che è l’essenza del fenomeno.
Si vede nel contratto fiduciario un caso di c.d. negozio indiretto: quel negozio con cui le parti
perseguono risultati diversi da quelli tipicamente propri del negozio impiegato, e corrispondenti ai
risultati tipicamente propri di un altro negozio.
Alla categoria del negozio indiretto si riconduce anche il contratto in frode alla legge.
Si parla di divergenza fra intento empirico delle parti ed effetto giuridico da esse disposto: il bene non è
destinato al fiduciario, ma allo stesso fiduciante o ad un terzo; eppure lo si trasferisce al fiduciario.
Si parla di eccedenza del mezzo rispetto al fine: se si vuole che il bene del fiduciante passi ad un terzo,
sarebbe più semplice un passaggio diretto al terzo, senza il medium del trasferimento al fiduciario e del
suo obbligo di ritrasferire.
Si parla anche di dissociazione fra titolarità ed interesse: titolare del bene è il fiduciario, ma l’interesse
sostanziale rispetto al bene continua ad essere del fiduciante.
L’abuso tipico del fiduciario è la violazione dell’obbligo di ritrasferire il bene allo stesso fiduciante od
al beneficiario da lui indicato.
In relazione all’intensità dei rimedi si distinguono i due contrapposti modelli di fiducia: fiducia romana
e fiducia germanica.
La fiducia germanica dà al fiduciante una tutela più forte, perché è tutela reale: il patto fiduciario è
opponibile dal fiduciante ai terzi che abbiano acquistato dal fiduciario.
Un altro modo di rappresentare il regime della fiducia germanica è dire che essa scompone il diritto di
proprietà in una proprietà formale ed in una proprietà sostanziale: la prima passa al fiduciario, i cui
poteri dominicali sono definiti e circoscritti dai vincoli fiduciari assunti; la seconda resta al fiduciante,
attribuendogli sul bene prerogative anche reali.
La fiducia romana si basa sull’unità del dominium, di cui aborre la frantumazione; per questo la
proprietà passa tutta intera al fiduciario, ed il fiduciante si spoglia completamente del diritto reale.
La sua tutela ne esce più debole, perché è tutela solo obbligatoria.
Ciò significa che se il fiduciario cede ad un terzo in violazione del patto, questo non è opponibile al
terzo anche se lo conosceva (mala fede).
Il fiduciante non ha altro rimedio che il risarcimento del danno, da chiedere al fiduciario infedele (e
forse anche al terzo acquirente in mala fede).
Il diritto italiano conosce tuttavia specifici meccanismi normativi che rafforzano la tutela del fiduciante,
colorandola di realità, sul presupposto che il pactum fiduciae generi un obbligo a contrarre (sotto specie
di obbligo a ritrasferire).
Quest’obbligo è sanzionato con esecuzione in forma specifica mediante sentenza costitutiva.
Ammesso che il patto fiduciario sia assimilabile ad un atto trascrivibile ex 2645-bis comma 1, e sia
effettivamente trascritto, l’effetto prenotativo del 2645-bis comma 2 consente al fiduciario di prevalere
sui terzi che abbiano trascritto successivamente il loro acquisto.
Oltre alla posizione dei terzi aventi causa, merita attenzione quella dei creditori: il bene trasferito
fiduciariamente è garanzia patrimoniale dei creditori del fiduciario o di quelli del fiduciante? L’effetto
reale pieno del trasferimento fiduciario, tipico della fiducia romana, porterebbe a dire che il bene
garantisce i creditori del fiduciario.
Ma si propongono attenuazioni, basate sulla norma relativa ai beni acquistati dal mandatario (1707: I
creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del
mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il
mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni
immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione
dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo): quanto ai mobili,
l’iniziativa dei creditori del fiduciario può essere bloccata se il pactum fiduciae ha data certa anteriore
al pignoramento; quanto ad immobili e mobili registrati, se prima del pignoramento il fiduciante
trascrive domanda ex 2932.
Per parte loro, i creditori del fiduciante possono agire contro il fiduciario in via surrogatoria (2900: Il
creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le
azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare [81 c.p.c.],
purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per
loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il
creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi).
Nel campo dell’intermediazione finanziaria si verifica spesso la situazione seguente: l’intermediario
finanziario (società d’investimento, banca, società di gestione del risparmio, etc.) ha nel proprio
controllo strumenti finanziari – quali azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni, etc. – che
sostanzialmente non gli appartengono, perché sono acquistati coi denari che l’investitore ha affidato
all’intermediario: e questi li ha nel proprio controllo perché deve gestirli nell’interesse dell’investitore.
L’intermediario finanziario può svolgere la gestione secondo due schemi: in nome del cliente (e questo
significa che gli strumenti finanziari restano anche formalmente di proprietà dell’investitore); oppure
“in nome proprio e per conto del cliente” (21 t.u.f.), ed allora vuol dire che la proprietà dei valori è
formalmente in capo all’intermediario.
Vale una generale regola di condotta: senza consenso scritto dei clienti, gli intermediari finanziari “non
possono utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da
essi detenuti a qualsiasi titolo”.
Ma soprattutto vale il principio di separazione patrimoniale: gli strumenti finanziari a qualunque titolo
detenuti dall’intermediario costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello
dell’intermediario e da quello degli altri clienti.
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario (22.1 t.u.f.).
La formula con cui sinteticamente si designa questo regime dei beni è “proprietà fiduciaria”.
Presenta molti punti di contatto col fenomeno della fiducia un istituto appartenente alla tradizione del
common law: il trust.
Un bene o complesso di beni è costituito in trust quando il suo titolare lo trasferisce o comunque lo
affida ad un soggetto, il quale è vincolato ad esercitare i suoi poteri di titolare non nell’interesse
proprio, ma a vantaggio di uno o più beneficiari, od in funzione di un determinato scopo.
Chi costituisce il trust sul proprio bene si chiama settlor, chi lo riceve fiduciariamente è detto trustee.
Il trust può costituirsi anche con atto unilaterale del settlor, ed il trustee può identificarsi col settlor
medesimo.
Per i beni costituiti in trust vale un principio di segregation dal resto del patrimonio del trustee,
corrispondente grosso modo al principio di separazione patrimoniale che il nostro diritto conosce specie
nel campo dell’intermediazione finanziaria.
CAPITOLO XXXI – LA SIMULAZIONE
Simulazione significa finzione: c’è simulazione quando le parti fanno un contratto finto: un contratto
che fingono di volere ma in realtà non vogliono, e dichiarano fra loro di non volere.
L’interesse delle parti a simulare è l’interesse a creare un’apparenza contrattuale difforme dalla realtà
contrattuale effettivamente voluta.
La legge non ha pregiudizi moralistici contro la simulazione: essa semplicemente constata che il
fenomeno esiste, e si preoccupa di regolarne le conseguenze.
La struttura della simulazione comprende due elementi: il contratto simulato, e l’accordo simulatorio
risultante dalla controdichiarazione.
Il contratto simulato è quello che le parti fanno per creare la situazione apparente.
Con l’accordo simulatorio le parti convengono che il contratto simulato non ha valore, perché non
vogliono i suoi effetti; e convengono quali sono gli effetti realmente voluti.
Le manifestazioni di volontà che costituiscono l’accordo simulatorio si definiscono
“controdichiarazioni”.
L’accordo simulatorio ha natura contrattuale, in quanto riguarda la simulazione di un contratto.
La sua funzione è conformare in un certo modo gli effetti del contratto simulato.
L’accordo simulatorio non è il contratto, ma un elemento del contratto, soggetto perciò al regime
contrattuale.
Può essere impugnato per vizio della volontà, essere revocato (sciolto) per mutuo dissenso delle parti.
Per produrre l’effetto suo proprio (attribuire carattere solo fittizio al contratto simulato), l’accordo
simulatorio richiede il consenso di tutti i soggetti che sono parti del contratto simulato.
La simulazione si distingue dalla riserva mentale, che ricorre quando la parte dichiara una volontà
contrattuale che smentisce nel suo foro interno.
Di fronte alla dichiarazione, la riserva mentale dell’autore è irrilevante, anche se nota al destinatario
della dichiarazione.
Se poi la riserva è esplicitata, non abbiamo accordo simulatorio (che presuppone la comune volontà di
entrambe le parti), ma due dichiarazioni incompatibili della stessa parte: se emesse in successione, la
seconda potrà valere revoca della prima (nei limiti di efficacia della revoca); se contemporanee, ne
risulta una dichiarazione probabilmente inidonea a manifestare la volontà contrattuale.
La simulazione si distingue poi dall’errore ostativo: nell’errore ostativo la divergenza è involontaria, e
riguarda dichiarazione e volontà di una sola delle parti; invece nella simulazione la divergenza è
intenzionale, ed oppone le dichiarazioni di entrambe le parti alla volontà controdichiarata da entrambe.
C’è il problema del tempo dell’accordo simulatorio: questo normalmente è contemporaneo al contratto
simulato; può essere anche anteriore: si conviene tra le parti che il contratto che esse andranno
prossimamente a concludere sarà solo fittizio.
Non può ammettersi che sia posteriore.
C’è infine il problema della forma dell’accordo simulatorio: se il contratto simulato è soggetto a forma
solenne, si raccomandano soluzioni articolate come quelle proposte per la forma dei contratti risolutori.
Ogni volta che il contratto simulato sia formalizzato, la forma della controdichiarazione rileva ai fini
della prova.
In relazione al contenuto dell’accordo simulatorio, la simulazione può essere assoluta o relativa.
Ricorre simulazione assoluta quando l’accordo simulatorio prevede che, in luogo del rapporto derivante
dal contratto simulato, non si costituisca fra le parti nessun rapporto contrattuale.
Si ha simulazione relativa quando l’accordo simulatorio prevede che, in luogo del rapporto derivante
dal contratto simulato, si costituisca fra le parti un rapporto contrattuale diverso.
Il rapporto realmente voluto si definisce contratto dissimulato.
La simulazione relativa può toccare il tipo o la causa, l’oggetto del contratto (ovvero le prestazioni
contrattuali), o l’identità di una parte del contratto (ricorre allora interposizione fittizia).
La simulazione può investire una singola clausola del contratto: si dice allora “parziale”, e nella sua
parzialità può essere assoluta o relativa.
L’interposizione fittizia è la fattispecie di simulazione relativa per cui si finge la conclusione ad es. di
una vendita da A a B, mentre l’accordo simulatorio dice che dietro questo contratto simulato si
nasconde in realtà una vendita (dissimulata) da A ad X.
Il meccanismo presuppone che all’accordo simulatorio partecipino tutti e tre i soggetti coinvolti.
Non è necessaria la contestualità delle tre manifestazioni di consenso; non basta la semplice
conoscenza che uno abbia dell’accordo intercorso fra gli altri due.
L’interposizione fittizia si distingue dall’interposizione reale, quale si realizza ad es. con l’acquisto del
mandatario per conto del mandante: il mandatario interposto è destinatario reale (ancorché non
definitivo) degli effetti del contratto.
Si distingue dall’intestazione fiduciaria, perché anche questa realizza un’interposizione reale e non
fittizia.
Si distingue dal contratto concluso in nome altrui, perché il prestanome non spende il nome altrui (del
vero interessato), ma (fittiziamente) il proprio.
Si distingue dal contratto concluso sotto falso nome, che ricorre quando un contraente falsifica la
propria identità: il prestanome non falsifica la propria identità, ma il proprio ruolo contrattuale.
Fra le parti, le conseguenze della simulazione sono regolate in base al criterio per cui la realtà prevale
sull’apparenza: il contratto simulato non produce effetto tra le parti (1414.1).
Ciascuna parte può attivare contro l’altra la regola del 1414.1 semplicemente facendo valere l’accordo
simulatorio, sia in via di azione sia in via di eccezione.
Per avvalersi della regola del 1414.1, la parte del contratto relativamente simulato spesso non può
limitarsi a far valere l’accordo simulatorio nella sua dimensione negativa, di fattore che esclude la
verità di quel certo elemento contrattuale; ha bensì l’onere di allegarlo e provarlo nella sua dimensione
positiva, di fattore che conforma quell’elemento in modo diverso.
Il fenomeno della simulazione è l’unitario intreccio di contratto simulato, accordo simulatorio,
contratto dissimulato, fra loro non distinguibili.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il
contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma (1414.2) (sono i requisiti
la cui mancanza determina nullità del contratto ex 1418.2).
Ciò significa in primo luogo che la controdichiarazione deve manifestare non solo la volontà di fare un
contratto diverso da quello simulato, ma anche gli elementi essenziali del diverso contratto (che devono
essere possibili, determinati o determinabili).
Requisiti di sostanza significa poi che il contratto dissimulato non deve essere illecito, o comunque
precluso da una norma.
Si discute se la forma debba rivestire il contratto simulato, o l’accordo simulatorio indicante l’elemento
contrattuale dissimulato, od entrambi.
Il criterio generale in tema di forma solenne è che questa deve rivestire tutti gli elementi essenziali per
identificare l’operazione, o comunque decisivi per la validità.
Ma la giurisprudenza è meno rigorosa: stabilisce che la donazione ha effetto anche se la sola vendita
simulata, e non pure la controdichiarazione, è fatta per atto pubblico.
In ogni caso di simulazione relativa, in cui il contratto dissimulato non produce effetto per mancanza
dei requisiti di sostanza o di forma, non produce effetto nemmeno il contratto simulato, perché le parti
hanno controdichiarato di non volerlo: è come se la simulazione fosse assoluta.
Rispetto ai terzi i problemi si riconducono a tre dati:
la simulazione crea un’apparenza contrattuale, diversa dalla realtà contrattuale operante fra le parti;
i terzi normalmente conoscono l’apparenza e non la realtà;
alcuni terzi sono pregiudicati dall’apparenza, e quindi interessati a far prevalere la realtà; altri terzi
sono invece pregiudicati dalla realtà, e quindi interessati a far prevalere l’apparenza.
I terzi pregiudicati dalla simulazione possono far valere la simulazione in confronto delle parti
(1415.2).
Non si considera terzo il successore a titolo universale (ad es. l’erede) della parte simulante.
I terzi aventi causa dal simulato acquirente sono quelli che in buona fede hanno acquistato diritti dal
titolare apparente: contro di essi la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né
dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante (1415.1).
Il titolare apparente è il simulato acquirente, che il contratto simulato fa apparire come l’attuale titolare
del diritto.
I possibili antagonisti del terzo protetto sono essenzialmente tre.
Prima di tutto, la parte dell’accordo simulatorio, che in base a questo risulta l’effettivo titolare del
diritto.
Poi l’altro terzo che abbia acquistato il bene dal vero titolare (dal simulato alienante, dall’acquirente
reale).
Egli può far valere la simulazione contro le parti, ex 1415.2, ma ex 1415.1 non può farla valere contro i
terzi della classe in esame (aventi causa dal simulato acquirente).
Infine il terzo creditore del simulato alienante: anch’egli interessato a far emergere la realtà, cioè che il
bene è del suo debitore, e pertanto aggredibile, ed anche costui è sacrificato al terzo che abbia
acquistato dal finto titolare.
Precisiamo chi sono i terzi protetti dal 1415.1: terzi protetti sono solo quei particolari terzi che abbiano
acquistato diritti dal titolare apparente, essendo in buona fede al momento dell’acquisto, e non tutti
indistintamente i terzi che risultino in buona fede in quanto ignari della simulazione: la legge non tutela
una generica posizione di soggetto in buona fede, ma la più qualificata posizione di soggetto, che in
buona fede acquista un diritto.
Per altro verso, la norma parla di terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparente; essa non limita
la protezione del terzo al caso in cui egli acquista lo stesso diritto che fu oggetto dell’atto simulato, ma
l’estende a tutti i casi in cui il terzo acquista una posizione di vantaggio dipendente dall’atto simulato,
anche se consistente in una semplice qualità del diritto acquistato.
Si considera applicabile qui la regola, dettata in tema di possesso, per cui la buona fede si presume
(1147.3).
Sono fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione: questi segnano il limite della
protezione del terzo acquirente in buona fede dal titolare apparente: la sua posizione cede di fronte a
quella del vero titolare, o dell’avente causa dal vero titolare, che abbia proposto domanda di
simulazione, e l’abbia trascritta prima che il nostro terzo abbia trascritto il suo acquisto.
Ugualmente, trattandosi di mobili, la regola incontra il limite del 1153: se l’avente causa dal simulato
alienante ha conseguito il possesso in buona fede, egli prevale sul terzo protetto dal 1415.1.
I creditori del simulato alienante (1416.2) sono interessati al prevalere della realtà; essi possono
confliggere con le parti, e qui prevale la realtà, perché gli è dato far valere la simulazione che
pregiudica i loro diritti, cioè far emergere la realtà ad essi favorevole.
Possono confliggere con gli aventi causa dal simulato acquirente (titolare apparente): qui prevale
l’apparenza, perché essi soccombono di fronte a questi aventi causa ex 1415.1.
Possono infine confliggere coi creditori del simulato acquirente, sui quali vincono solo a due condizioni
congiunte: che il loro credito sia anteriore all’atto simulato, e che i creditori della classe contrapposta
siano chirografari.
Invece cedono ai creditori del simulato acquirente, in favore dei quali prevale l’apparenza: se questi
ultimi sono muniti di causa di prelazione, e così pure se il loro credito sia posteriore all’atto simulato.
Passiamo ai creditori del simulato acquirente, cioè del titolare apparente e non reale: quindi interessati
al prevalere dell’apparenza: essi possono confliggere coi creditori del simulato alienante, ed abbiamo
appena visto i criteri per stabilire chi prevale.
Possono poi confliggere con le parti della simulazione, e segnatamente con quella che, per l’accordo
simulatorio, risulta il vero titolare del bene.
Se il loro credito è assistito da garanzia reale, prevalgono in quanto aventi causa dal titolare apparente;
se sono chirografari, prevalgono se in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono
oggetto del contratto simulato (1416.1): ma dovrà distinguersi a seconda che gli atti esecutivi incidano
su mobili non registrati, o su immobili o mobili registrati (per la rilevanza delle formalità pubblicitarie).
Quando taluno può far valere od opporre la simulazione contro qualcun altro, la sua corrispondente
iniziativa processuale si definisce azione di simulazione.
Legittimato attivo è chiunque riceva dalla legge il potere di far prevalere la realtà, nascosta dal
contratto simulato, e vi abbia interesse.
Prima di tutto le parti stesse dell’accordo simulatorio, e segnatamente il vero titolare del diritto
negoziato simulatamente; poi i terzi pregiudicati dalla simulazione: in particolare, aventi causa e
creditori del vero titolare.
Così configurata, l’azione di simulazione è azione di mero accertamento, tesa alla declaratoria che il
contratto simulato è privo di effetti.
Spesso la simulazione è fatta valere dal legittimato in via non di azione, ma di eccezione: per difendersi
da pretese fondate sul contratto simulato.
Si statuisce in giurisprudenza che la simulazione, non fatta valere in primo grado dall’attore (o dal
convenuto in via riconvenzionale), non può farsi valere per la prima volta in appello.
E che invece può sollevarsi per la prima anche in appello, se invocata in via di eccezione.
La ragione sembra questa: la simulazione fatta valere come fondamento del diritto azionato è materia di
un accertamento principale, destinato ad acquistare forza di giudicato; mentre se viene opposta come
eccezione, può essere accertata incidenter tantum.
In tema d’integrità del contraddittorio, chi agisce in simulazione chiede un accertamento destinato a
fare stato fra tutte le parti della simulazione stessa: dunque tutte devono partecipare al contraddittorio,
come litisconsorti necessari.
Si afferma invece che non ricorre litisconsorzio necessario di tutti i partecipi quando la simulazione si
fa valere in via di eccezione.
Quanto alla prescrizione, le massime giurisprudenziali sembrano distinguere fra domanda di
simulazione assoluta, che si qualifica imprescrittibile, e domanda di simulazione relativa, soggetta
all’ordinaria prescrizione decennale.
La distinzione è malposta.
La domanda può puntare alla mera declaratoria che il contratto simulato non produce effetti, ed essa è
imprescrittibile in quanto domanda di accertamento; oppure può puntare alla realizzazione di un diritto
costituito dal contratto dissimulato, ed allora – trattandosi di azione di condanna o costitutiva –
soggiace alla prescrizione dettata per il diritto in questione.
Per provare la simulazione, occorre provare una controdichiarazione che smentisca il contratto
simulato.
Se il contratto simulato risulta da scrittura, la relativa controdichiarazione non può provarsi per
testimoni: lo vieta il 2722, che preclude la prova testimoniale su patti aggiunti o contrari al contenuto di
un documento, la cui stipulazione si assuma contemporanea od anteriore al documento stesso.
Al rigore del divieto si deroga nei tre casi del 2724 (La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto,
proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia
apparire verosimile il fatto allegato; 2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o
materiale di procurarsi una prova scritta; 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il
documento che gli forniva la prova), ricorrendo i quali la prova testimoniale è eccezionalmente
ammessa contro la scrittura.
Ma fuori di questi casi-limite, chi vuole provare la simulazione deve esibire la controscrittura (o
deferire giuramento o sperare nella confessione di controparte).
Nel caso che il contratto simulato sia verbale, la prova della simulazione non conosce limiti.
Il 1417 dispone in primo luogo che la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti,
se la domanda è proposta da creditori o da terzi.
La norma dispone poi che la prova per testimoni è ammissibile senza limiti, anche se la domanda di
simulazione è proposta dalle parti, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato.
Il legittimario del simulato alienante è considerato dalla giurisprudenza quale terzo (con libertà di
prova), laddove faccia valere la simulazione per reintegrare la legittima lesa, ad es. sotto il profilo che
la finta vendita era in realtà una donazione del de cuius.
Lo considera parte (con le note restrizioni probatorie), quando invochi la simulazione ad altro fine, ad
es. per recuperare all’asse un bene simulatamente alienato.
Una volta che la prova sia acquisita, il giudice può rilevare d’ufficio la simulazione, in assenza di
specifica richiesta della parte, purché l’accertamento della simulazione determini conseguenze
comprese nella domanda o nell’eccezione della parte.
La legge dice che il contratto simulato non produce effetto (1414.1): partendo di qui, si discute come
esso debba qualificarsi: inesistente, nullo, annullabile o semplicemente inefficace?
È preferibile la qualifica d’inefficacia, piuttosto che di nullità.
La norma non parla di contratto nullo, ma di contratto che “non produce effetto”, inoltre l’elenco delle
cause di nullità contenuto nel 1418 omette qualsiasi riferimento alla simulazione.
Né il contratto simulato può ricondursi a qualcuna delle fattispecie di contratto nullo, descritte in quella
norma: non al contratto cui manchi il requisito della causa, non al contratto cui manchi il requisito
dell’accordo.
Non devono infine trascurarsi le differenze di disciplina: al contrario della nullità, la simulazione è in
larga misura inopponibile ai terzi.
È rilevabile d’ufficio entro limiti più ridotti rispetto alla nullità.
Infine, il contratto simulato è recuperabile: la revoca dell’accordo simulatorio lo rende produttivo di
effetti.
Se il contratto simulato è plurilaterale, all’accordo simulatorio devono partecipare tutti i contraenti:
quello che non vi partecipi ha in sostanza posizione di terzo.
Problemi specifici sorgono per il contratto di società: il contratto, oltre a creare rapporti giuridici fra le
parti, crea un’organizzazione con veste di autonomo soggetto del diritto.
Sarà importante distinguere a seconda che la simulazione riguardi società di persone o di capitali;
società soggette o non soggette a registrazione; inoltre, a seconda che sia assoluta (non si vuole
costituire nessuna società) o relativa (si simulano solo le quote rispettive dei soci, o l’oggetto sociale).
Il meccanismo simulatorio, e la relativa disciplina, possono trovare applicazione anche fuori dal campo
dei contratti.
Può simularsi un atto unilaterale: lo dice il 1414.3, dichiarando che i commi precedenti si applicano
anche agli atti unilaterali destinati ad una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il
dichiarante ed il destinatario.
Il 1414.3 sembra alludere agli atti unilaterali ricettizi, ma è applicabile (se non ex 1414.3, quanto meno
ex 1324, il quale dice che salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si
osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale) anche
ad atti formalmente non ricettizi, che però producano effetti nella sfera di un soggetto determinato (es.:
rinuncia all’usufrutto).
Si discute sulla simulazione degli atti non negoziali, costituiti da dichiarazioni di scienza: in particolare
della confessione, o di quello speciale sottotipo di confessione che è la quietanza.
Qualcuno esclude che qui possa farsi valere la simulazione, e svelarsi la realtà: si richiama
l’autoresponsabilità del dichiarante, o la norma che limita l’impugnativa della confessione ai casi di
errore di fatto e violenza (2732); ma la tesi non è condivisibile: in caso contrario si determinerebbero
risultati indesiderabili e contrari al sistema.
È concepibile altresì la simulazione della data del contratto: in presenza di una data simulata per
accordo fra le parti, le regole sulla simulazione rispetto ai terzi devono coordinarsi con le regole sulla
data certa della scrittura privata nei confronti dei terzi, di cui al 2704 (La data della scrittura privata
della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal
giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità
fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura
è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo
egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che
contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con
qualsiasi mezzo di prova.
Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto
delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.).
La simulazione si distingue dalla falsa qualificazione del contratto, per cui le parti danno al loro
contratto un nomen che non corrisponde alla sostanza del contratto, voluta dalle parti stesse.
La falsità della qualificazione può essere inconsapevole, ed allora dipende: se riflette una falsa
rappresentazione della parte sulla natura del contratto, si applica la disciplina dell’errore; se invece non
c’è errore delle parti, si tratta semplicemente di riqualificare il contratto in modo più coerente con la
sua sostanza – cosa che il giudice può fare.
La falsità della qualificazione può essere consapevole e deliberata: per provare a lucrare un più
vantaggioso regime fiscale.
Manca anche qui la struttura della simulazione: non c’è quella scissione/contrapposizione fra
dichiarazione e controdichiarazione, effetti apparenti ed effetti reali, che costituisce l’essenza del
fenomeno.
Al fine di negare alle parti i benefici ingiustamente pretesi, non occorre impugnare di simulazione il
loro contratto: basta dire che il contratto, alla luce della sua giusta qualificazione, non merita i benefici.
La simulazione è altra cosa dal semplice contratto occulto, che si ha quando le parti, fatto il contratto
che esse realmente vogliono, si limitano a tenerlo nascosto.
Nondimeno, ricorre anche qui una certa dissociazione fra apparenza e realtà contrattuale.
Potranno allora eventualmente applicarsi le regole che, in base al principio di apparenza, tutelano chi
abbia fatto affidamento su falsi indici.
La simulazione, infine, può non coincidere col fenomeno delle dichiarazioni contrattuali incompatibili
fra loro.
Non ricorre simulazione se la seconda dichiarazione è posteriore al contratto, mentre se è
contemporanea od anteriore bisogna distinguere: abbiamo simulazione solo se dall’insieme delle
dichiarazioni contrattuali emerge che le parti hanno inteso creare un’apparenza difforme dalla realtà, ed
emerge quale sia l’apparenza, e quale la realtà.
Se questi dati non emergono, e l’incompatibilità non riesce a sanarsi per via d’interpretazione, il
contratto non è simulato, ma nullo per mancanza di accordo o per indeterminatezza ed intederminabilità
dell’oggetto.
CAPITOLO XXXII – I RIMEDI CONTRATTUALI
Di fronte alla lesione attuale o potenziale degli interessi meritevoli di tutela, che sarebbero vulnerati
dalla normale produzione degli effetti del contratto difettoso, la legge offre strumenti per prevenire o
rimuovere la lesione stessa.
Il rimedio consiste nel liberare le parti dal vincolo contrattuale, o comunque nel rimettere in
discussione gli effetti del contratto.
Alla base delle norme che dispongono rimedi contrattuali c’è una ponderazione comparativa di valori
ed interessi: all’operare del vincolo contrattuale corrispondono il valore etico e gli interessi sociali
sottesi al principio pacta sunt servanda; in relazione ai difetti, che un contratto presenti, possono venire
in gioco altri valori ed interessi.
La storia dei rimedi contrattuali nell’ultimo secolo esibisce due macrotendenze: c’è una tendenza alla
restrizione dei rimedi contrattuali, e correlativamente all’indurimento del vincolo, che si manifesta
soprattutto nell’affermarsi della teoria della dichiarazione; e c’è per contro una tendenza all’estensione
dei rimedi, che si collega a due principali fattori: da un lato, all’imporsi del principio di buona fede
contrattuale, e dall’altro giocano le politiche di protezione dei contraenti deboli.
I rimedi contrattuali s’articolano in alcune tipologie elementari, basate su quattro fondamentali criteri di
differenziazione.
Un primo criterio riguarda il modo della loro attivazione: negoziale, giudiziale (processuale) o legale.
Alcuni rimedi possono attivarsi mediante un’iniziativa della parte, consistente in una manifestazione di
volontà negoziale.
È il caso di alcuni recessi remediali, accordati ad una parte per reagire contro vicende lato sensu
anomale del rapporto contrattuale, e pregiudizievoli per la parte stessa: si pensi al recesso accordato
alla parte che sia vittima dell’inadempimento di controparte, o che subisca modifiche contrattuali
introdotte unilateralmente dall’altra, titolare di ius variandi.
È il caso, ancora, della diffida ad adempiere, o della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva
espressa.
Altri rimedi presuppongono anch’essi un’iniziativa della parte: ma nella forma dell’azione in giudizio.
È il caso delle risoluzioni giudiziali, dell’annullamento, della rescissione.
Altri rimedi infine operano ipso iure: la cancellazione degli effetti contrattuali si produce
automaticamente, per il verificarsi delle circostanze cui la legge la ricollega.
Si pensi alla risoluzione di diritto per scadenza del termine essenziale, o per impossibilità sopravvenuta;
si pensi alla nullità.
Anche in relazione a questi rimedi può aversi pronuncia del giudice: ma sarà una pronuncia
dichiarativa, di mero accertamento.
Un secondo criterio di differenziazione e classificazione riguarda la natura del difetto contro cui il
rimedio opera, e precisamente la natura dell’interesse che il difetto pregiudica o mette a rischio.
Alcuni rimedi reagiscono contro difetti che toccano direttamente l’interesse particolare di una delle
parti.
È tendenzialmente il caso dei recessi, delle risoluzioni, degli annullamenti, delle rescissioni.
Altri rimedi reagiscono contro difetti che toccano l’interesse generale, a causa del quale la
cancellazione degli effetti contrattuali è desiderabile dal punto di vista della società: ha questa
caratteristica, tendenzialmente, il rimedio della nullità.
S’è usato l’avverbio “tendenzialmente” poiché vi sono i casi di nullità relativa in cui la ratio del
rimedio risiede in un intreccio molto stretto fra interesse particolare di una delle parti ed interesse
generale.
Anche il terzo criterio riguarda la natura del difetto contro cui il rimedio reagisce, sotto il profilo del
tempo in cui il difetto si manifesta.
Alcuni rimedi reagiscono contro difetti originari, già esistenti al tempo della conclusione del contratto:
rimedi come la nullità, l’annullamento, la rescissione.
Altri rimedi reagiscono contro difetti che, inesistenti al tempo della conclusione del contratto,
sopravvengono in epoca successiva: ne sono prototipo le risoluzioni.
Possono esservi casi in cui è preferibile correggere il contratto piuttosto che annientarlo: in relazione a
questi casi, si prevedono rimedi non estintivi, che possiamo chiamare manutentivi (o di adeguamento).
I rimedi contrattuali implicano la ponderazione comparativa di interessi in conflitto, che conduce a
sacrificarne alcuni per privilegiarne altri: dunque implicano scelte politiche del legislatore.
La discrezionalità del legislatore nel campo dei rimedi può emergere nell’alternativa fra un rimedio ed
un altro, ma può emergere anche nell’alternativa fra assoggettare il contratto ad un rimedio o non
assoggettarlo a nessun rimedio.
La situazione standard considerata dalle norme sui rimedi è quella in cui il difetto colpisce un atto
positivo avente effetti positivi: una positiva manifestazione di volontà contrattuale, il cui effetto è la
costituzione del vincolo contrattuale.
Ma difetti possono colpire anche atti di genere diverso: atti negativi, o se si vuole “non atti”, suscettibili
d’influenzare le situazioni contrattuali del soggetto; oppure atti (positivi ma) aventi effetti negativi.
Questi atti hanno una caratteristica comune: al loro eventuale difetto pare impossibile rispondere col
tipico rimedio della cancellazione degli effetti.
Possiamo immaginare atti negativi con effetti positivi: ad es., il mancato rifiuto dell’oblato ex 1333
determina la conclusione del contratto.
Possiamo immaginare atti negativi con effetti negativi: l’opzionario non esercita l’opzione entro il
termine, e così il contratto non si conclude.
Possiamo immaginare, infine, atti positivi con effetti negativi: la revoca della proposta o
dell’accettazione, il rifiuto della proposta impediscono la conclusione del contratto.
In generale, è difficile pensare che l’atto con effetti negativi possa rimediarsi con la diretta costituzione
degli effetti, ma almeno è ipotizzabile che si ripristini la possibilità di tale costituzione: per il resto,
sussistendone i presupposti, potrà scattare il rimedio risarcitorio.
CAPITOLO XXXIII – L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO: NULLITÀ E ANNULLABILITÀ
La categoria dell’invalidità del contratto non può dirsi a pieno titolo una categoria legislativa: il
legislatore non la definisce né la regola, ma si limita a presupporla come un dato implicito nel sistema.
L’invalidità è una categoria dottrinale.
Mentre definisce l’invalidità in rapporto alla teoria del negozio giuridico, la dottrina ne elabora
possibili applicazioni fuori dell’area dei negozi.
Per un verso, in direzione di atti non negoziali: adempimenti, confessioni, ricognizioni, etc.
Per altro verso in direzione di atti non governati dal diritto privato: formulando teorie sull’invalidità
degli atti normativi, degli atti amministrativi, degli atti processuali.
In positivo, nessuno dubita che all’area dell’invalidità appartengano i casi del contratto nullo e del
contratto annullabile.
In negativo, pacificamente si escludono da quell’area i casi del contratto risolubile, revocabile,
riducibile, inopponibile, o comunque semplicemente inefficace.
Fra questi territori certi, s’interpone una zona popolata di dubbi: così per la simulazione, che alcuni
riconducono all’invalidità ed altri all’inefficacia; così per la rescissione, che l’opinione prevalente
ritiene estranea all’invalidità; così per le condizioni generali di contratto in difetto dei requisiti ex 1341
commi I e II, la cui qualificazione oscilla fra invalidità ed inefficacia; così per le clausole vessatorie nei
contratti dei consumatori (1469-bis ss.), cui l’esplicita qualificazione legislativa di “inefficacia” non
impedisce agli interpreti una riqualificazione correttiva in termini d’invalidità.
Nel sistema normativo la categoria dell’invalidità si definisce anche in relazione alla categoria
dell’inefficacia, e viceversa.
L’inefficacia è la qualità che il contratto presenta, in quanto non sia produttivo degli effetti che
normalmente dovrebbe produrre.
L’invalidità designa una qualità del contratto, in quanto esposto a rimedi contrattuali (come la nullità e
l’annullamento).
L’invalidità punta all’inefficacia del contratto ed ha come conseguenza l’inefficacia del contratto,
perché è attraverso l’inefficacia che l’invalidità può svolgere la sua funzione remediale.
Oltre all’inefficacia con funzione remediale, esistono forme d’inefficacia con funzione non remediale;
ed anche nell’ambito dell’inefficacia remediale, oltre ai casi in cui l’inefficacia consegue all’invalidità
si danno casi in cui l’inefficacia prescinde dalla validità, e tocca contratti validi.
Si distingue tra inefficacia in senso ampio, che comprende l’inefficacia dipendente da invalidità; ed
inefficacia in senso stretto, che è l’inefficacia del contratto valido.
L’inefficacia ha funzione remediale quando risponde ad un difetto o disturbo del contratto.
L’inefficacia remediale si collega all’invalidità quando il difetto o disturbo del contratto sono tali da
renderlo invalido: il contratto con causa mancante od illecita è inefficace in quanto invalido (nullo).
Ma l’inefficacia remediale può anche prescindere dall’invalidità, e ciò accade quando risponde ad un
difetto o disturbo del contratto, che non lo rende tuttavia invalido: le risoluzioni ed i recessi dati come
rimedio rendono il contratto inefficace, ma il contratto, nondimeno, è valido.
Accanto all’inefficacia remediale, può esservi inefficacia non remediale: quella che non costituisce
rimedio ad un difetto del contratto, perché il contratto non presenta difetti cui debba rimediarsi.
È tale l’inefficacia collegata ad una condizione, ed all’esercizio della revocatoria.
Si ha inefficacia originaria quando il fattore che la determina è già esistente al tempo della conclusione
del contratto, onde questo nasce inefficace sin dall’inizio.
Sono originariamente inefficaci: il contratto invalido (nullo, annullabile, rescindibile); il contratto
sottoposto a condizione sospensiva; il contratto del falso rappresentante.
Si ha inefficacia sopravvenuta quando il fattore che la determina, inesistente al tempo della conclusione
del contratto, sopravviene in seguito, rendendo inefficace un contratto che all’inizio era efficace.
È il caso del contratto reso risolubile dal sopravvenire di un inadempimento, di un’impossibilità od
eccessiva onerosità della prestazione; o del contratto sciolto da un recesso, o dal verificarsi della
condizione risolutiva; o del contratto reso inefficace dall’esercizio vittorioso di un’azione revocatoria.
Verificatasi l’inefficacia sopravvenuta, un problema è se essa operi solo per il futuro, o retroagisca:
anche in quest’ultimo caso, l’inefficacia resta sopravvenuta e non si converte in originaria.
È inefficacia assoluta (in senso pieno) quella che può generalmente farsi valere sia fra le parti, sia dai
terzi, sia contro i terzi.
Sono affetti da inefficacia assoluta solo il contratto nullo ed il contratto condizionato.
Residualmente, ricadono nell’inefficacia relativa tutti i casi in cui l’inefficacia non può farsi valere da
entrambe le parti; o non da tutti i terzi, o non contro tutti i terzi.
Consideriamo l’invocabilità dell’inefficacia tra le parti: talora l’inefficacia può farsi valere da ciascuna
parte contro l’altra: così per l’inefficacia da nullità, da condizionamento, da simulazione, da
impossibilità sopravvenuta.
Altre volte la causa d’inefficacia può essere invocata solo da una parte, ma non dall’altra: annullabilità;
risoluzione per inadempimento od eccessiva onerosità (sopravvenuta).
Altre volte ancora l’inefficacia non è invocabile da nessuna parte contro l’altra, ma solo da qualche
terzo: il falso rappresentato per il contratto del falso rappresentante; il legittimario per la donazione
soggetta a riduzione (555); il creditore per l’atto di disposizione attaccato con revocatoria (2901.1).
Quanto alla posizione dei terzi, c’è prima di tutto il problema dell’inefficacia fatta valere contro il
terzo.
L’inefficacia da nullità o condizionamento travolge l’acquisto, fatto dal terzo, della posizione
dipendente da contratto nullo o condizionato.
Invece l’inefficacia da risoluzione o recesso di regola non pregiudica le posizioni in precedenza
acquistate dai terzi sulla base del contratto poi divenuto inefficace (ma in questi casi l’inefficacia opera
contro i terzi almeno per il futuro).
Ci sono poi situazioni intermedie: l’inefficacia può farsi valere (talora si dirà: retroagisce) non contro
tutti i terzi, ma solo contro determinate classi di terzi: l’inefficacia da annullamento, da simulazione, da
revoca degli atti di disposizione lesivi del credito (2901.4) può farsi valere solo contro i terzi il cui
acquisto non abbia determinate caratteristiche (non sia oneroso e/o fatto in buona fede).
Ma c’è anche il problema inverso, e cioè se l’inefficacia possa farsi valere dal terzo, cui giovi.
L’inefficacia da nullità può farsi valere dai terzi che vi abbiano interesse, così pure quella da
simulazione, ma non in modo indifferenziato: ferma la possibilità di farla valere contro le parti, certi
terzi non possono farla valere contro certi altri terzi.
L’inefficacia dell’atto di disposizione revocabile può farsi valere solo da certi terzi (i creditori); ma non
contro tutti i terzi (non, ad es., contro i terzi che abbiano acquistato in buona fede a titolo oneroso): qui
l’inefficacia è doppiamente relativa.
L’inefficacia del contratto, la quale operi solo a vantaggio di determinati terzi, si dice anche
inopponibilità (a detti terzi) del contratto stesso, ovvero dei suoi effetti: ad es. l’atto di disposizione in
frode ai creditori è, una volta revocato, inopponibile al creditore revocante.
Il 1418 s’intitola “Cause di nullità del contratto”, e consta di tre commi:
il comma I dispone che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative;
il II che producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325
[l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma quando prescritta dalla legge sotto pena di nullità],
l’illiceità della causa [1343: la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine
pubblico o al buon costume], la illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 [Il contratto è
illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito
comune ad entrambe] e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346 [L’oggetto
del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile];
il III dispone che il contratto è nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
Il 1418.3 allude alle nullità testuali, che ricorrono quando un contratto od una singola regola
contrattuale sono testualmente dichiarati nulli da una norma.
Talora l’espressa qualificazione legislativa può apparire superflua: ciò accade tutte le volte che, se
anche nessuna norma l’esplicitasse, la nullità del contratto o della regola contrattuale risulterebbe con
evidenza dal difetto di un elemento essenziale ex 1418.2, o dalla contrarietà ad una norma imperativa
ex 1418.1.
La previsione testuale di nullità acquista un reale valore operativo nei casi in cui la previsione di legge
determina una qualificazione ed un trattamento della fattispecie, che in sua mancanza non vi sarebbero.
Possono indicarsi tre ordini di casi.
In un primo senso, la previsione testuale serve a rendere nulli contratti o regole contrattuali che, in sua
assenza, probabilmente non lo sarebbero: perché lega la nullità a contenuti contrattuali molto specifici e
circostanziati, che riflettono scelte politiche del legislatore tanto puntuali quanto discrezionali, non
surrogabili per via interpretativa.
Si consideri il 1229.1, che dice nulle le clausole che escludono o limitano la responsabilità del debitore
dipendente da dolo o colpa grave: in mancanza di essa, forse l’interprete potrebbe congetturare una
nullità per contrasto con l’ordine pubblico, ma non avrebbe strumenti per calibrarne la portata, e cioè
per decidere se restringerla al solo inadempimento doloso, od allargarla ad ogni inadempimento
colpevole o addirittura alle ipotesi di responsabilità oggettiva.
In un secondo senso, la previsione testuale serve a rendere certa una nullità, che diversamente sarebbe
dubbia e controversa.
Se il 2744 non dichiarasse espressamente nullo il patto commissorio, qualche interprete potrebbe
sostenerne la nullità per contrasto con un principio di ordine pubblico, ma altri interpreti potrebbero
confutare.
In un terzo caso, la previsione testuale serve ad introdurre un trattamento del contratto nullo, divergente
dalla disciplina comune.
Alle nullità testuali si contrappongono le nullità virtuali: fattispecie in cui l’interprete ricava che il
contratto è nullo, pur in assenza di una norma che lo dichiari espressamente tale, applicando taluno dei
criteri di cui ai primi due commi del 1418.
I criteri della nullità virtuale sono riconducibili all’una od all’altra di due diverse rationes politiche del
rimedio: abbiamo la famiglia delle nullità strutturali, cui si riconducono i contratti nulli perché insensati
od incompleti; e la famiglia delle nullità politiche, cui si riconducono i contratti nulli perché
disapprovati.
Il 1418.2 identifica una serie di nullità, che chiamiamo strutturali perché riguardano difetti relativi agli
elementi che compongono la struttura del contratto.
Sono difetti che, in generale, rendono il contratto un contratto insensato, che riflette un’operazione
giuridicamente ed economicamente assurda, incomprensibile.
Il 1418.2 rileva qui nella parte in cui dispone che producono nullità del contratto, fra l’altro, la
mancanza di uno dei requisiti indicati dal 1325, e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dal
1346.
I requisiti del contratto ex 1325 sono l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma, se richiesta a
pena di nullità: a loro volta i requisiti dell’oggetto ex 1346 indicano ch’esso deve essere possibile,
lecito, determinato o determinabile.
Il contratto con oggetto illecito si colloca meglio nella famiglia dei contratti disapprovati, affetti da
nullità politica.
Quando manca la forma, più che di contratto insensato conviene parlare di contratto incompleto.
Alla ratio delle nullità strutturali sembrano riconducibili altre due fattispecie: quella del contratto con
condizione sospensiva impossibile, e quella del contratto subordinato a condizione meramente
potestativa.
La nullità per mancanza di accordo non riguarda i casi in cui manca qualsiasi manifestazione di
volontà, che appaia diretta a formare l’accordo contrattuale: questi sono casi d’inesistenza del contratto.
Né riguarda i casi in cui una siffatta manifestazione di volontà esiste, è riferibile alla parte, ed è
semplicemente viziata da un fattore soggettivo che tocca la parte stessa: questi sono casi di
annullabilità.
La mancanza di accordo riguarda casi in cui una manifestazione di volontà contrattuale appare esistere,
ma, appunto, esiste solo in apparenza; oppure solo in apparenza è riferibile a chi ne appare l’autore.
Vi rientrano le dichiarazioni rese per costrizione fisica, od in stato di totale annientamento psichico,
come in casi estremi di ipnosi.
Poi le dichiarazioni rese da soggetti che non possono concepirsi come autori di dichiarazioni
contrattuali: si pensi al contratto fatto sottoscrivere al bambino di 7 anni.
Poi gli esempi scolastici delle dichiarazioni rese in modo palesemente scherzoso, o per finzione
scenica, od a scopo didattico.
Poi ancora il caso della dichiarazione contrattuale formata dalla parte, ma pervenuta al destinatario
contro la volontà dell’autore.
Inoltre i casi di falsificazione di firma, e di contratto fatto, per rappresentanza, in nome di una persona
inesistente.
Infine i casi di dissenso occulto: quando le dichiarazioni contrattuali delle parti sono apparentemente
conformi, ma ogni parte intende la propria in un senso diverso da quello inteso dall’altra, senza che sia
possibile identificare un significato oggettivo del contratto.
Diverso è se dalle dichiarazioni sia ricavabile un significato oggettivo del contratto: qui il
fraintendimento è solo di una parte, e dà luogo ad un suo errore sull’oggetto del contratto.
Ancora diverso, se la divergenza fra i significati intesi dalle due parti emerge testualmente dalle loro
dichiarazioni (dissenso palese): qui c’è inesistenza del contratto, che non s’è concluso per difformità
dell’accettazione rispetto alla proposta.
Chiamiamo nullità politiche quelle che colpiscono i contratti disapprovati dall’ordinamento, perché
contrastanti con norme o principi che incorporano scelte politiche dell’ordinamento stesso.
Appartengono a questa famiglia quasi tutte le nullità testuali ex 1418.3 (eccezion fatta per quelle
dipendenti da vizi di forma).
Vi appartengono poi tutte le fattispecie di contratto illecito.
Infine, vi appartengono i casi in cui il contratto è nullo perché contrario a norme imperative ex 1418.1.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente
(1418.1).
Contrapponendo il 1418.1 al 1418.2 (laddove parla d’illiceità della causa o dell’oggetto), si afferma la
distinzione fra contratto illecito e contratto illegale: il contratto è illecito quando il contrasto con la
norma imperativa, o l’ordine pubblico, o il buon costume, investe la causa o l’oggetto o il motivo
comune o la condizione; è illegale, quando viola la norma imperativa sotto profili diversi da quelli
appena richiamati.
L’identificazione dei contratti illegali, nulli per contrasto con norme imperative, passa attraverso due
livelli di giudizio.
Il primo livello riguarda la natura della norma violata dal contratto: si tratta di valutare se sia imperativa
(inderogabile) o dispositiva (derogabile), in quest’ultimo caso non c’è nullità: un problema di nullità si
pone solo quando la norma è imperativa, e cioè definisce posizioni o tutela interessi non disponibili dai
privati.
Ma anche in questo caso la nullità non è automatica ed inevitabile: in alcuni casi il contratto contrario a
norma imperativa non è nullo.
Questo secondo livello di giudizio si affida a due criteri.
La nullità può escludesi in base ad un criterio testuale: vi allude il 1418.1, che enunciata la regola della
nullità del contratto contrario a norma imperativa, fa salva l’ipotesi che la legge disponga diversamente.
La nullità può escludersi anche in base a criteri extratestuali, legati alla ratio della norma imperativa
violata, e più precisamente al modo in cui il contratto incide sugli interessi protetti dalla norma.
Il contratto illegale è nullo quando i suoi effetti andrebbero a ledere direttamente gli interessi protetti
dalla norma, la quale ha precisamente lo scopo d’impedire quegli effetti; invece il contratto è
semplicemente irregolare, e non nullo, quando viola sì la norma, e tuttavia non sono propriamente i
suoi effetti a ledere l’interesse protetto da questa.
Per i fattori che la determinano, la nullità (ed in genere l’invalidità) si lega alla situazione fattuale e
normativa esistente alla conclusione del contratto.
Lo schema sembrerebbe incrinato da figure come quelle della nullità sospesa e della nullità
sopravvenuta.
Un’antica dottrina parlava di nullità sospesa (o pendente) ad indicare la previsione per cui un contratto
risulterà nullo, se si verificherà un evento (per lo più nella forma negativa di mancanza di un evento)
successivo alla conclusione del contratto: al fenomeno parrebbe riconducibile qualche fattispecie
prevista dal codice: ad es. quella per cui è nullo il contratto con determinazione dell’oggetto affidata al
mero arbitrio del terzo, se poi il terzo non provvede e le parti non lo sostituiscono (1349.2).
La nullità sopravvenuta è il fenomeno per cui il contratto, valido alla luce della situazione fattuale e
normativa esistente al tempo della conclusione, sia reso successivamente nullo da fatti o norme
sopraggiunti dopo la conclusione.
In molti casi la c.d. nullità sopravvenuta consegue alla retroattività della norma proibitiva sopraggiunta:
la quale, in deroga al principio dell’11.1 prel. (La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha
effetto retroattivo), può disporre la propria applicazione anche ai contratti conclusi in precedenza.
La nullità sopravvenuta incide non tanto sul contratto come atto, quanto piuttosto sul contratto come
rapporto: ma se la c.d. nullità sopravvenuta opera sugli effetti e non sull’atto, essa non ha natura di vera
nullità, e deve piuttosto assimilarsi ad una risoluzione.
Il nuovo 1938 vieta le fideiussioni per debiti futuri, le quali non indichino il massimale della garanzia
assunta dal fideiussore: nell’interpretazione della Corte costituzionale, la norma per un verso è non
retroattiva, donde la persistente validità delle fideiussioni senza massimale stipulate prima di essa; ma
per altro verso impedisce a tali fideiussioni di coprire anche i debiti sorti dopo la sua entrata in vigore.
L’evoluzione legislativa avviata nell’ultimo decennio del secolo XX introduce molti nuovi casi di
nullità del contratto, che la dottrina chiama nullità speciali: sono nullità speciali prima di tutto in
ragione delle fonti normative da cui derivano, e del contesto politico-economico di riferimento.
Da un secondo punto di vista, queste nullità sono speciali per i fattori da cui dipende la qualificazione
del contratto come nullo: tradizionalmente la nullità dipende da elementi intrinseci del contratto, cioè
dalla sua struttura e dal suo contenuto, invece molto spesso le nullità speciali si legano ad elementi
estrinseci al contratto.
Essi riguardano piuttosto il contesto di circostanze che fa da cornice alla conclusione del contratto: la
qualità di consumatore e professionista delle parti (1469-bis comma I), o riguardano l’impatto che il
contratto potrà avere su una certa realtà esterna.
La categoria della nullità derivata riguarda la nullità di un contratto a valle, determinata dalla nullità di
un precedente contratto a monte, da cui il contratto a valle dipende sul piano pratico-economico.
Infine, le nullità in discorso sono speciali per il peculiare trattamento riservato al contratto nullo: ciò
dipende dal loro prevalente scopo politico, che è la protezione di una classe di contraenti contro
un’altra.
Uno schema tradizionale riconduce la nullità alla lesione di un interesse generale, in contrapposizione
all’annullabilità, ispirata alla protezione dell’interesse particolare di un contraente.
Lo schema può apparire in crisi, di fronte al moltiplicarsi delle nullità comminate a carico di contratti
che ledono l’interesse non della generalità dei consociati, ma di ben definite classi di contraenti
(conduttori, assicurati, clienti di banche, etc.).
In realtà, attraverso la protezione di quelle categorie sociali, si perseguono valori ed interessi generali:
il corretto funzionamento del mercato, ed ancor prima l’uguaglianza sostanziale (3.2 Cost.: È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese) fra
contraenti forti e deboli.
Ancor più lo schema vacilla di fronte ai casi di nullità strutturale e di annullabilità che protegge
l’incapace o la vittima di un vizio del volere.
Sia l’annullabilità sia le nullità strutturali proteggono una parte, ed in questo senso può dirsi che
entrambe proteggono l’interesse ad un esercizio dell’autonomia privata che sia corretto e ragionevole:
un interesse generale.
Una differenza esiste: l’annullabilità scatta in casi nei quali il normale svolgimento dell’autonomia
privata è turbato da fattori interni alla sfera di coscienza e volontà della parte protetta; invece le nullità
strutturali salvaguardano le condizioni oggettive di esercizio dell’autonomia privata.
L’inesistenza del contratto è categoria totalmente dottrinale (e giurisprudenziale).
Il problema del contratto inesistente è il problema della sua distinzione dal contratto nullo.
Sul piano operativo, la categoria del contratto inesistente svolge due diverse funzioni.
La prima funzione è delimitare i confini entro cui possono prodursi quei limitati effetti che talora la
legge ricollega al contratto nullo.
Il contratto nullo in generale può ex 1424 produrre gli effetti di un contratto diverso, compatibili con la
ragione di nullità (conversione): ma un contratto inesistente non può produrre nemmeno questi diversi e
minori effetti.
La categoria dell’inesistenza serve dunque ad impedire che si producano gli effetti dell’atto nullo.
Ma la funzione più notevole della categoria è d’impedire che si producano addirittura gli effetti di un
atto valido.
L’esigenza sorge essenzialmente per gli atti le cui nullità sono configurate in termini per un verso
molto ristretti e per altro verso tassativamente tipizzati.
Sono per lo più atti diversi dai contratti: matrimonio, testamento, deliberazioni assembleari.
Per impedire gli effetti del matrimonio tra persone del medesimo sesso, nella difficoltà di dire che il
matrimonio era nullo (giacché nessuna norma contemplava l’identità di sesso fra le invalidità
matrimoniali), si escogitò di dire che non esisteva alcun matrimonio.
Si considerino deliberazioni non verbalizzate, od assunte senza la regolare convocazione di qualche
socio: esse non possono a rigore dirsi nulle, posto che il loro oggetto non è né impossibile, né illecito;
potrebbero facilmente dirsi annullabili, perché non prese in conformità della legge, ma in tal caso
diventerebbero inattaccabili se non impugnate entro tre mesi (2377.5: L’impugnazione o la domanda di
risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione,
ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall’iscrizione o, se
è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro tre mesi dalla data di
questo).
L’inesistenza va distinta dalle nullità strutturali (ad es. per mancanza di accordo): nelle nullità
strutturali c’è un’apparenza di dichiarazione contrattuale riferibile alla parte, invece può parlarsi di
contratto inesistente quando c’è sì un’apparenza di contratto, un fatto materiale sotto qualche profilo
riconducibile ad una fattispecie di contratto, ma che sotto un altro profilo già prima facie risulta non
sussumibile nella fattispecie del contratto: si pensi all’attore che a fondamento della sua domanda
esibisce in giudizio un contratto sul quale manca qualsiasi firma del convenuto.
Questa configurazione identifica il contratto inesistente sì, ma pur sempre nel senso di un’inesistenza
significativa.
Perché si dia inesistenza significativa occorre che il contratto sia invocato da qualcuno contro qualcun
altro e che l’invocazione sia sostenuta da un minimo di evidenza materiale dell’esistenza del contratto
stesso (ancorché si tratti di evidenza smentibile già prima facie).
Una dottrina del passato affermava che la nullità dipende dalla mancanza di un elemento essenziale del
contratto, mentre s’avrebbe annullabilità quando un elemento essenziale (segnatamente la volontà)
esiste, ma è viziato.
La schematizzazione è inappagante: sono altri i criteri per differenziare il sistema delle cause di
annullabilità rispetto a quelle di nullità.
C’è un criterio di ratio politica dei rimedi, relativo alla diversa natura degli interessi che questi
proteggono: la nullità protegge interessi tendenzialmente generali, l’annullabilità interessi più
particolari.
Un altro criterio attiene allo statuto sistematico delle cause di nullità ed annullabilità: il sistema delle
cause di nullità è più flessibile, è un sistema non tipizzato e non tassativo; invece il sistema delle cause
di annullabilità è più rigido, è un sistema tendenzialmente tipico e tassativo: non esiste una ragione
generale (o virtuale) di annullabilità, capace di aprire spazi per l’identificazione di contratti annullabili,
al di là delle fattispecie puntualmente previste dalla legge.
Il sistema delle cause di annullabilità comprende prima di tutto le diverse ipotesi d’incapacità di agire.
Comprende poi i vizi della volontà: errore, dolo e violenza.
Comprende infine una serie di fattispecie particolari, previste dalla legge: il conflitto d’interessi del
rappresentante e la contrattazione del rappresentante con se stesso; l’atto di straordinaria
amministrazione su bene della comunione (immobile o mobile registrato), compiuto da un coniuge
senza il consenso dell’altro (184.1: Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso
dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni
mobili elencati nell’art. 2683 [le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della
navigazione; gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice; gli autoveicoli iscritti nel
pubblico registro automobilistico]).
Con riferimento ai contratti della Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza identifica altre ragioni
di annullabilità, al di fuori di un’espressa previsione legale: i vizi del procedimento amministrativo che
precede la stipulazione del contratto.
Altre volte la giurisprudenza parla, anziché di annullabilità, d’inefficacia relativa: ciò che preme,
comunque, è la regola per cui il difetto può farsi valere solo dalla Pubblica Amministrazione e non dal
privato contraente.
Invece la mancanza di un atto amministrativo procedimentalmente necessario, ma successivo alla
conclusione del contratto (controllo, approvazione, visto) ne determina la temporanea inefficacia: l’atto
è condicio iuris di efficacia del contratto.
Diversa è la configurazione delle cause di annullabilità, con riferimento ad altri generi di atti, diversi
dal contratto: matrimonio, testamento, deliberazioni di assemblea.
Per queste ultime il rapporto sistematico si presenta rovesciato: l’annullabilità è virtuale, la nullità è
tipizzata.
CAPITOLO XXXIV – LE INCAPACITÀ DI AGIRE
Il 1425.1 dispone che il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di
contrattare.
L’incapacità di contrattare indicata dal 1425.1 come causa di annullabilità identifica quella che
abitualmente si designa incapacità di agire: ovvero l’incapacità di compiere atti di autonomia privata,
stabilita dalla legge essenzialmente in presenza di uno stato fisio-psichico del soggetto, che fa venire
meno le condizioni soggettive di un corretto e ragionevole esercizio dell’autonomia.
Essa ricorre nelle figure dell’incapacità legale (minore età, interdizione, inabilitazione); e nei casi
d’incapacità naturale (1425.2).
Presenta due caratteristiche.
La prima riguarda il fine, e si esprime nell’idea di protezione: la legge non vuole impedire al soggetto
l’acquisto di posizioni e rapporti, ma solo il compimento degli atti funzionali al loro acquisto; la
seconda riguarda il mezzo, e s’esprime nell’idea di sostituzione: l’incapace può essere sostituito da altri
(col meccanismo della rappresentanza) nel compimento degli atti a lui preclusi, onde consentirgli di
acquistare le posizioni ed i rapporti che non gli sono preclusi.
Più precisamente, sostituzione sorvegliata: l’azione del rappresentante è sottoposta a controlli
preventivi e successivi, per garantirne la conformità all’interesse dell’incapace.
Accanto a queste incapacità si situa quella derivante dall’interdizione legale che colpisce il condannato
penale: qui la preclusione degli atti non vuole proteggere l’incapace, ma affliggerlo con la pena
accessoria consistente nell’impedirgli di partecipare direttamente al traffico giuridico patrimoniale.
Abbiamo poi un gruppo di casi, per i quali abitualmente non si evoca la categoria dell’incapacità, ma
che sotto vari profili si accostano alle incapacità di protezione: il contratto concluso dal rappresentante
con se stesso od in conflitto d’interessi; l’atto di straordinaria amministrazione compiuto dal singolo
coniuge su bene in comunione; gli acquisti di beni in violazione dei divieti ex 1471.1 n. 3 e 4 [Non
possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona: […]
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai
beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il
disposto dell’articolo 1395.].
L’atto è vietato per proteggere non già una parte di esso, ma il soggetto, estraneo all’atto, che questo
potenzialmente pregiudica.
Appartengono ad un campo diverso una serie di fattispecie in cui si vuole precludere non il semplice
compimento di atti, ma il risultato di questi, e cioè l’acquisto delle situazioni e dei rapporti cui gli atti
sono preordinati: e ciò non per l’interesse particolare di un soggetto, ma per un interesse più generale.
Siamo nel campo delle incapacità giuridiche dette “speciali” perché precludono ai soggetti non la
generalità delle situazioni e dei rapporti, ma solo alcuni specifici rapporti e situazioni.
Va sottolineata la differenza del rimedio contro gli atti compiuti in violazione dell’incapacità giuridica:
non l’annullabilità, ma la nullità (che colpisce i contratti contrari a norme imperative ex 1418.1).
Un esempio di incapacità giuridiche speciali: quelle che precludono la carica di amministratore di
società a soggetti incorsi in una causa di ineleggibilità ex 2382 (Non può essere nominato
amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato
condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi).
Con riguardo alle incapacità giuridiche speciali, talora si evoca la categoria del difetto di legittimazione
(dell’autore dell’atto); ma è preferibile collegarla al principio per cui l’atto di disposizione delle altrui
situazioni giuridiche non produce effetto verso il titolare di queste; e sottolineare che il difetto di
legittimazione non crea invalidità ma inefficacia.
Le incapacità di agire si distinguono in legale e naturale.
Le incapacità legali (cui allude il 1425.1) derivano da: minore età, interdizione (giudiziale e legale),
inabilitazione.
Hanno in comune una duplice caratteristica: per un verso, si legano a stati del soggetto definiti od
accertati in base a criteri sostanziali e/o procedimentali, con la clausola per cui la definizione o
l’accertamento assorbono l’eventuale falsità in concreto del presupposto, e dunque assorbono e rendono
irrilevante qualsiasi indagine sulle concrete condizioni fisio-psichiche dell’incapace che lo abbia
compiuto: l’atto è annullabile anche se l’incapace legale fosse, in concreto, pienamente capace
d’intendere e di volere nel momento in cui lo ha compiuto.
Per altro verso, sono conoscibili dai terzi interessati, per il fatto di risultare da registri pubblici (dello
stato civile): di qui la tendenziale irrilevanza dell’affidamento dei terzi che le ignorino.
Le incapacità legali si distinguono in assolute e relative.
In relazione ad esse, l’annullabilità colpisce non solo gli atti compiuti dall’incapace legale che non
potrebbe compierli, o compierli da solo; ma anche quelli compiuti secondo i meccanismi di
rappresentanza od assistenza, ma in violazione dei requisiti procedimentali posti ad ulteriore garanzia
degli interessi dell’incapace.
L’incapacità naturale è quella cui la legge allude con la formula dell’incapacità “d’intendere o di
volere”.
Postula un’indagine caso per caso sulle effettive e concrete condizioni del soggetto.
Non emerge documentalmente da risultanze ufficiali.
Si definiscono incapacità assolute le incapacità di agire riferite ai soggetti che si suppongono più
radicalmente inidonei a curare i propri interessi, cioè a comprendere il senso e valutare la convenienza
dei propri atti.
Conseguentemente, esse precludono al soggetto il compimento della generalità degli atti.
Sono incapaci assoluti i minori (non emancipati), cioè coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni.
Età diverse per l’acquisto della capacità sono previste ad es. in tema di lavoro subordinato (vi allude lo
stesso art. 2: La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si
acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono
salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio
lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal
contratto di lavoro) e per gli atti di disposizione del diritto d’autore, consentiti a chi abbia almeno 16
anni (108 l. aut.).
La regola dell’annullabilità di qualunque contratto concluso da un incapace assoluto soffre, riguardo al
minore, la deroga del 1426: il contratto del minore non è annullabile se il minore ha con raggiri
occultato la sua minore età.
La semplice dichiarazione di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto.
Inoltre sono incapaci assoluti gli interdetti per infermità di mente (interdetti giudiziali): coloro che,
trovandosi in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri
interessi (414), siano stati sottoposti ad apposito procedimento (417-419), concluso con una sentenza
d’interdizione debitamente pubblicata (421).
Gli atti compiuti dall’interdetto sono sempre annullabili.
Al compimento degli atti che lo riguardano provvede, come rappresentante legale, il tutore
giudizialmente nominatogli (424).
Un’incapacità legale di agire colpisce infine, gli interdetti legali: sono automaticamente tali, per effetto
di pena accessoria, i condannati all’ergastolo od a reclusione non inferiore a 5 anni (32 c.p.).
Il regime degli atti dell’interdetto legale è definito per rinvio a quello degli atti dell’interdetto giudiziale
(32.4 c.p.), ma in realtà l’incapacità da interdizione legale è diversa e più limitata: riguarda solo gli atti
patrimoniali, e non gli atti personali e familiari, per cui l’interdetto legale conserva capacità.
È anche diversa la legittimazione ad impugnare gli atti preclusi, che sono colpiti da annullabilità
assoluta, invocabile da chiunque vi abbia interesse.
Si definiscono incapacità relative le incapacità di agire di soggetti che si presuppongono non
pienamente idonei, ma nemmeno radicalmente inidonei, a curare da sé i propri interessi.
È relativamente incapace il minore emancipato: il minore ultrasedicenne che, essendovi stato
giudizialmente autorizzato ex 84.2, abbia contratto matrimonio (390).
Al minore emancipato s’affianca un curatore (392).
Il minore emancipato si basa sulla distinzione fra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Egli è capace di agire personalmente, e da solo, per gli atti di ordinaria amministrazione.
Quanto a quelli di straordinaria amministrazione, può compierli solo con l’assistenza del curatore e con
l’autorizzazione del giudice (394).
Anche rispetto a questi atti, il curatore non sostituisce il minore emancipato: si limita ad unire la
propria volontà contrattuale a quella del minore emancipato.
Il minore emancipato che sia stato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale acquista la
capacità di compiere da solo anche gli atti di straordinaria amministrazione, e non solo quelli inerenti
l’impresa, ma anche quelli estranei all’impresa (397.3).
L’altra figura d’incapace relativo è l’inabilitato: la persona affetta da handicap psico-fisici o patologie
comportamentali che, pur pregiudicandone l’idoneità a provvedere ai propri interessi, non la escludono
completamente (415); più precisamente la persona che, in ragione di tali patologie, sia stata sottoposta a
procedimento giudiziale concluso con sentenza d’inabilitazione (417-421).
Il regime degli atti dell’inabilitato è ricalcato sul regime degli atti del minore emancipato (424.1): piena
capacità per gli atti di ordinaria amministrazione; assistenza del curatore (ed autorizzazione giudiziale)
per quelli di amministrazione straordinaria.
Ci sono tuttavia due differenze che segnalano la minore fiducia del legislatore nelle capacità di
autodeterminazione dell’inabilitato: l’autorizzazione ad operare come imprenditore può essergli data
solo per la continuazione di un’impresa già esistente, e non lo abilita agli atti di straordinaria
amministrazione estranei all’impresa (425).
È incapace naturale l’autore di atti giuridici che risulti per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace
d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono compiuti: la conseguenza dell’incapacità naturale
è l’annullabilità degli atti.
La disciplina dell’incapacità naturale si applica essenzialmente ai soggetti che non siano incapaci
legali.
Uno spazio di applicazione può individuarsi per gli incapaci relativi: l’atto del minore emancipato o
dell’inabilitato, che sarebbe valido in base all’ordinario regime dell’incapacità legale relativa, può
essere annullabile ex 428 se l’autore lo compie in stato d’incapacità d’intendere o di volere.
Sono annullabili ex 428 gli atti dei soggetti colpiti da abituale infermità di mente, ma non interdetti
(427.3); ovvero dei soggetti colpiti da uno degli handicap psichici o fisici del 415 (Il maggiore di età
infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere
inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di
bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se
non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell'articolo 414 quando risulta che
essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi), ma non inabilitati.
Ma l’incapacità naturale può dipendere anche da fattori che non giustificherebbero un provvedimento
d’interdizione od inabilitazione.
La giurisprudenza considera rilevante ex 428 ogni stato psichico abnorme, ogni perturbamento psichico
che alteri gravemente, pur senza annientarle, le capacità intellettive e volitive del soggetto.
L’accertamento va condotto caso per caso, e deve tener conto anche del genere di contratto che è stato
concluso.
Mentre l’atto dell’incapace legale, che rientri fra quelli a lui preclusi, è annullabile ex se, l’atto
dell’incapace naturale è annullabile solo se ricorrono due condizioni ulteriori: grave pregiudizio recato
dall’atto all’incapace; e, per i contratti, mala fede dell’altro contraente.
Il requisito del grave pregiudizio è posto dal 428.1.
Si discute sulle condizioni di rilevanza del pregiudizio.
Sembra preferibile la tesi più larga: il pregiudizio può essere patrimoniale, ma anche non patrimoniale;
inoltre può essere non attuale, ma anche solo potenziale.
Si discute poi sull’ambito di applicazione del requisito.
La giurisprudenza prevalente ritiene che esso valga solo per gli atti unilaterali, e non per i contratti.
Che il 428.1 disciplini i soli atti unilaterali è un pregiudizio confutato già dalla lettera della norma:
questa parla non di atti unilaterali, ma di atti tout court.
La mala fede dell’altro contraente è, in linea di principio, la consapevolezza di contrattare con un
incapace naturale.
La mala fede può risultare per il pregiudizio che il contratto reca o può recare all’incapace, o per la
qualità del contratto o altrimenti (428.2).
A questa disciplina sfugge il contratto di donazione dell’incapace naturale: sempre annullabile, a
prescindere dal grave pregiudizio, e dalla mala fede del donatario (775).
Vi sono tendenze che si sviluppano in due direzioni divergenti: da un lato a favore di un rimedio più
radicale, perché l’area dell’annullabilità ex 1425 si contrae per lasciare spazio ad un’annullabilità con
più ampio raggio d’incidenza, od addirittura per lasciare spazio alla nullità; dal lato opposto a favore
della validità del contratto.
Così, quando il perturbamento psichico deriva da un fattore peculiare come la minaccia, il contratto è
annullabile non nei limiti di cui al 428, ma con la superiore larghezza risultante dalla disciplina della
violenza psichica.
CAPITOLO XXXV – L’ERRORE
I vizi della volontà sono tre: errore, dolo e violenza.
Il codice li indica congiuntamente, come cause di annullabilità del contratto (1427).
Al tempo stesso li accosta ad un’altra causa generale di annullabilità: l’incapacità di agire.
Sia l’incapacità di agire sia i vizi della volontà pregiudicano le condizioni soggettive di un corretto e
ragionevole esercizio dell’autonomia privata.
L’errore è ignoranza o falsa conoscenza di un dato relativo al contratto.
Non può dirsi consapevole e davvero volontaria l’assunzione del vincolo, quando il processo valutativo
e decisionale che la precede sia inquinato da un errore.
Ma la legge non può limitarsi a stabilire l’annullabilità del contratto ogni volta che questo sia viziato
dall’errore di un contraente: l’interesse dell’altro contraente sarebbe deluso e nessuno potrebbe contare
sulla stabilità degli impegni altrui.
La legge concilia i due contrapposti interessi mediante la regola del 1428: l’errore determina
annullabilità del contratto solo quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.
Non esistono altri requisiti cui sia subordinata la tutela dell’errante; in particolare, non c’è il requisito
della scusabilità dell’errore: l’errante può chiedere l’annullamento, anche se il suo errore si sarebbe
potuto evitare con la normale diligenza.
Il rimedio tipico per il contratto viziato da errore essenziale e riconoscibile è l’annullamento.
Ma c’è anche un rimedio alternativo: il mantenimento del contratto rettificato (1432).
Per verificare se sussiste o meno errore, occorre preliminarmente interpretare il contratto per chiarirne
il significato, su cui misurare falsità o verità della rappresentazione di parte.
Ed ove debba ricorrersi all’interpretazione oggettiva, il principio di conservazione imporrà di scegliere,
nel dubbio, il significato che esclude l’errore.
La legge costruisce il requisito dell’essenzialità con una elencazione analitica di elementi su cui cada
l’errore (1429: L’errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto;
2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello
stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi
determinante del consenso; 3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro
contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi
di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto).
Per questo è inappropriato dire che l’errore è essenziale quando risulta determinante del consenso.
Gli elementi su cui l’errore deve cadere, per potersi dire essenziale, sono: la natura del contratto;
l’oggetto del contratto (nella sua identità e nelle sue qualità); l’identità e le qualità di controparte;
qualche norma giuridica che incida sulla materia del contratto.
Essi vanno però distinti in due classi.
L’errore che cade su alcuni elementi è essenziale ex se: è tale l’errore sulla natura del contratto e
sull’identità dell’oggetto.
Invece l’errore che cade sugli altri non è automaticamente essenziale: lo sarà solo se risulti essere stato
determinante del consenso di chi l’ha commesso.
Possono darsi errori determinanti del consenso, che non sono errori essenziali: tutti quelli, senza i quali
l’errante non avrebbe concluso il contratto, ma che non cadono su taluno degli elementi elencati ai nn.
1-4 del 1429.
Una massima di giurisprudenza afferma che l’elenco del 1429 non è tassativo, ma solo esemplificativo.
I vari tipi di errore essenziale sono accomunati da un dato: cadono su elementi obiettivi del contratto, e
quindi si situano in una sfera cui l’altro contraente, in quanto parte del contratto, non può dirsi estraneo.
Il dato vale a differenziare errori essenziali ed errori sui motivi.
L’errore sui motivi è quello che cade non su elementi obiettivi del contratto, ma su elementi esterni al
contratto, e che al contratto si collegano solo per un nesso soggettivo, e cioè in quanto semplici motivi
del contratto; esso non determina annullabilità del contratto nemmeno se l’errore sul motivo sia stato
determinante del consenso, e nemmeno se noto a controparte.
In quest’ultimo caso – fermo che il contratto non è annullabile – può ipotizzarsi una responsabilità ex
1337 a carico di controparte, laddove si possa pensare che questa, secondo buona fede precontrattuale,
avrebbe dovuto avvisare l’errante.
L’irrilevanza del motivo erroneo subisce un’eccezione per il contratto di donazione: annullabile per
errore sul motivo, alla doppia condizione che il motivo erroneo risulti dall’atto, e sia l’unico
determinante la decisione di donare (787).
S’indica come tipico errore sui motivi l’errore di previsione, che cade su circostanze future; per
risultare essenziale, l’errore deve comunque cadere su elementi passati o presenti al tempo del
contratto.
Può essere in concreto difficile distinguere fra errore su sviluppi futuri ed errore su dati presenti.
Alcune almeno delle fattispecie astrattamente riconducibili ad errori di previsione possono ottenere
rilevanza mediante la figura della presupposizione.
È essenziale l’errore sulla natura del contratto (1429, n. 1, prima parte).
Vi si deve ricondurre certamente l’errore sul tipo o sottotipo contrattuale: per es., si fa un leasing
nell’erronea convinzione di concludere una compravendita con effetti reali immediati.
Altra cosa è l’erronea denominazione del contratto ad opera di una parte o di entrambe: errore che il
giudice può correggere.
L’errore sulla natura del contratto confina per un verso con l’errore sull’oggetto; per altro verso con
l’errore di diritto.
Fra i diversi tipi di errore che riguardano l’oggetto del contratto, è importante distinguere: alcuni sono
essenziali ex se, altri sono essenziali solo se, in concreto, determinanti del consenso.
È essenziale tout court l’errore sull’oggetto del contratto (1429, n. 1, seconda parte): si tratta dell’errore
sull’insieme delle prestazioni dedotte in contratto, o sulle più qualificanti fra esse, o sul modo in cui
s’interrelano fra di loro.
Il 1429, n. 2, parla di errore sull’identità dell’oggetto della prestazione, e poi di errore sopra una qualità
dello stesso: entrambe le formule alludono all’oggetto inteso come bene su cui incidono gli effetti
prodotti dal contratto; i due tipi di errore hanno comunque diverse condizioni di operatività.
Questo genere di errore è configurabile, in linea di principio, solo quando l’oggetto erroneamente
identificato sia infungibile.
Altra cosa è l’erronea indicazione in contratto dei dati che convenzionalmente identificano l’oggetto,
che, nella sua identità materiale, le parti si rappresentano in modo corretto: qui è solo problema
d’interpretazione del contratto, per far emergere la reale volontà delle parti.
A differenza dell’errore sull’identità dell’oggetto, l’errore su una qualità dell’oggetto non è essenziale
ex se, ma solo quando riguardi una qualità che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle
circostanze, deve ritenersi determinante del consenso (1429, n. 2, seconda parte).
I criteri posti dalla norma per stabilire se la qualità erroneamente rappresentata sia determinante sono
due, alternativi fra loro.
Il primo criterio identifica le qualità oggettivamente determinanti: quelle che risultino tali secondo il
comune apprezzamento: quando la qualità è oggettivamente determinante, l’errore che la tocca è
senz’altro essenziale, a prescindere che abbia o meno, in concreto, determinato il consenso di chi l’ha
commesso.
Ove la qualità toccata dall’errore non possa dirsi oggettivamente determinante, essa può tuttavia dare
luogo ad errore essenziale quando risulti soggettivamente determinante, in base al secondo criterio:
quello che impone di valutare in relazione alle circostanze.
L’errore sull’oggetto o sulle sue qualità può risolversi in errore sul valore (economico) di esso; l’errore
sul valore non rileva di per sé, non essendo di per sé essenziale.
Ogniqualvolta l’errore sul valore è riconducibile all’inganno di controparte, chi vi cade può annullare il
contratto od almeno ottenere un risarcimento.
E, anche fuori dell’inganno, nella disciplina della responsabilità precontrattuale: se controparte ha
riconosciuto l’errore ed ha mancato di avvertire l’errante, questa sua condotta può (almeno in casi
estremi) configurare violazione del dovere di buona fede ex 1337.
L’errore sul valore va distinto dall’errore sul prezzo, che risulta essenziale nella stessa misura in cui il
prezzo è oggetto del contratto.
È essenziale l’errore che cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre
che l’una o le altre siano state determinanti del consenso (1429, n. 3).
Sotto un certo profilo, il contratto può essere personale nel senso che esprime valutazioni e decisioni
molto soggettive ed opinabili della parte, più che non standard di azione contrattuale neutri e
generalmente condivisibili.
Qui l’esigenza è che scelte così idiosincratiche non vengano imposte a soggetti diversi da chi le ha
concepite (risponde a questa ratio per es. la norma che ricollega l’estinzione del mandato alla morte del
mandante).
Sotto altro profilo, il carattere personale del contratto può discendere dalla rilevanza che la persona di
un contraente tipicamente riveste, alla luce della tipica prestazione dedotta in contratto: qui l’esigenza è
tutelare non più un terzo subentrante, ma la controparte contraente.
Sovviene allora una disciplina che, per il caso di morte della parte impegnata alla prestazione tipica,
esclude o limita la trasmissione del rapporto in capo al suo erede, stabilendo l’estinzione del rapporto
stesso od attribuendo a controparte la facoltà di recederne: è quanto previsto ad es. per la morte del
mandatario (1722, n. 4).
La disciplina dell’errore sulla persona ha presupposti ed obiettivi diversi: non è disciplina speciale di
determinati contratti, ma è disciplina generalmente dedicata a tutti i contratti.
Essa vuole tutelare la parte in quanto originariamente vittima di un errore sulla persona di controparte.
Il problema fondamentale è valutare se, ai fini dell’essenzialità, l’errore deve riguardare aspetti della
persona di controparte legati a dati obiettivi del contratto, o se invece possa rilevare anche un errore
legato a specifiche idiosincrasie dell’errante.
L’ipotesi d’errore sulla stessa identità di controparte è un caso di falsa identificazione del destinatario
della propria dichiarazione contrattuale.
Infine l’errore è essenziale quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale
del contratto (1429, n. 4).
L’errore di diritto è ignoranza o falsa conoscenza di una norma giuridica, rilevante in relazione al
contratto.
La rilevanza dell’errore di diritto non smentisce il principio ignorantia legis non excusat: questo
significa che il soggetto non può evitare l’applicazione a sé di norme giuridiche, allegando che egli non
le conosceva quando ha preso l’iniziativa che lo rende destinatario delle norme.
È utile distinguere fra errori che sono solo di diritto ed errori che sono anche di diritto.
Un errore di diritto (n. 4) può rientrare in una delle tipologie precedenti (nn. 1-3): ad es., un equivoco
sulla disciplina urbanistica fa ritenere edificabile il terreno acquistato, che invece non lo è (errore su
qualità dell’oggetto).
In casi del genere l’errore concorrente assorbe l’errore di diritto: prima ancora che ex n. 4, l’errore è
rilevante ex nn. 1 o 2 o 3 del 1429.
Consideriamo ora gli errori di puro diritto: la lettera della norma suggerisce che l’errore di puro diritto è
sempre rilevante, purché costituisca ragione unica o principale del contratto: ma ciò significherebbe
ammettere la rilevanza di errori su motivi resi erronei da ignoranza o falsa conoscenza di norme.
Bisogna dire che l’errore di puro diritto, oltre ad essere determinante del consenso, deve presentare
qualche altro requisito oggettivante, tale da non ricondurre l’errore ad uno dei tipi dei nn. 1-3 del 1429
(si pensi ad X, che acquista un’azienda sul presupposto di gestirla personalmente, ignorando che la
gestione è normativamente preclusa a chi sia privo di specifici requisiti, che X non possiede).
Gli interpreti segnalano l’irrilevanza dell’errore interno, caduto cioè sulla disciplina del rapporto
contrattuale.
Tale errore è irrilevante, in quanto la sua rilevanza precluderebbe l’operatività della norma ignorata,
contro il principio ignorantia legis non excusat.
La rilevanza dell’errore di diritto non dipende dalla natura della norma ignorata o mal conosciuta: può
rilevare sia l’errore su norma dispositiva, sia l’errore su norma imperativa.
Si considera rilevante come errore di diritto non sapere che una norma di legge ordinaria è
incostituzionale: non solo quando il contratto sorga dopo la già intervenuta dichiarazione
d’incostituzionalità; ma anche quando questa intervenga dopo il contratto, con l’argomento che la
pronuncia di accoglimento è retroattiva.
L’argomento è debole: a quest’ultimo caso sembra più appropriato applicare il regime delle
sopravvenienze.
L’errore di diritto può cadere non solo su esistenza o contenuto della norma, ma anche sulla sua
interpretazione: ma solo nei limiti in cui la parte faccia erroneamente conto su un’interpretazione
difforme da quella generalmente condivisa.
Non è di diritto, ma di fatto, l’errore sull’appartenenza del bene che forma oggetto del contratto: esso
può rilevare nei casi in cui l’appartenenza si presenta come qualità determinante del consenso di una
parte.
Non stiamo parlando di quel particolare errore sull’appartenenza, che consiste nell’ignoranza di
acquistare dal non proprietario: la fattispecie è espressamente sottratta alla disciplina dell’errore, per
essere trattata col rimedio della risoluzione (1479.1).
Infine, la rilevanza dell’errore di diritto è espressamente esclusa per due tipi di atto: la transazione
(1969) e la revoca della confessione (2732).
L’errore confina e può interferire con l’inadempimento (ed in particolare con le fattispecie che fanno
scattare le garanzie dovute all’acquirente di beni).
Sorgono allora due problemi: il primo è separare i casi in cui le fattispecie effettivamente si
sovrappongono (perché c’è al tempo stesso l’errore di una parte e l’inadempimento di controparte), dai
casi in cui non c’è nessuna sovrapposizione (perché c’è solo errore ma non inadempimento).
Per selezionare gli uni dagli altri occorre chiarire qual è l’impegno che il regolamento contrattuale
mette a carico della parte.
A questo fine soccorrono: l’interpretazione, che serve a chiarire l’entità degli impegni concordati; e
l’integrazione, che può imporre impegni anche non contemplati dalla volontà delle parti.
Quando la fattispecie esibisce al tempo stesso l’errore di una parte e l’inadempimento dell’altra, sembra
preferibile la tesi che i regimi si cumulino fra loro, cosicché la vittima possa scegliere se invocare i
rimedi contro l’errore o quelli contro l’inadempimento.
La conforta il dato di sistema, evidenziato da altri casi in cui il cumulo è pacificamente ammesso:
azione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, azione di rivendicazione e di restituzione.
È vero però che qui le azioni differiscono solo per causa petendi ma hanno identico petitum, mentre i
rimedi per l’errore e per l’inadempimento hanno anche petita diversi.
Il 1430 dispone che l’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica,
tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.
La giurisprudenza vede nella norma due fattispecie distinte e reciprocamente escludentisi.
La prima riguarderebbe l’errore di calcolo, concepito come errore puramente materiale: esso sarebbe
rimediabile con la sola rettifica (che è cosa diversa dalla rettifica che consente il mantenimento del
contratto viziato da qualsiasi errore rilevante, ex 1432).
Vi si contrapporrebbe l’errore sulla quantità, caduto non sul calcolo ma sui termini del calcolo: esso
renderebbe il contratto annullabile se determinante del consenso; mentre se non fosse determinante non
darebbe alcun rimedio.
Questa ricostruzione è contestata dalla dottrina, che osserva come la seconda figura sia una specie
qualificata della prima.
L’errore di calcolo può non essere errore di quantità: i termini dell’operazione aritmetica sono
rappresentati correttamente, ma per uno sbaglio nella moltiplicazione s’indica un prezzo complessivo
diverso da quello giusto.
L’errore di calcolo può risolversi in errore di quantità: il contratto indica il prezzo complessivo di
120.000 euro per la merce contenuta nel magazzino del venditore, prezzo su cui il compratore consente
presupponendo che vi siano 1000 pezzi e che ciascun pezzo costi 120 euro, mentre il magazzino
contiene solo 900 pezzi, il cui costo unitario risulta perciò di oltre 130 euro.
S’apre allora un’alternativa: o l’errore è determinante del consenso (l’errore è essenziale e, se è anche
riconoscibile, porta all’annullamento), o l’errore di quantità non è determinante (in tal caso il
compratore non può chiedere l’annullamento; ci si domanda se possa chiedere la rettifica).
Quando l’oggetto è un immobile, il regime dell’errore di quantità deve armonizzarsi con le norme che
regolano gli specifici casi della vendita a misura e della vendita a corpo (1537-1538).
Il requisito della riconoscibilità è posto, insieme con quello dell’essenzialità, dal 1428.
Lo definisce il 1431: l’errore è riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del
contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
Irrilevante di per sé, la scusabilità dell’errore può tuttavia influire sulla sua riconoscibilità: quanto più
un errore è inescusabile, tanto più può apparire incredibile, e tanto meno riconoscibile come errore.
L’errore è riconoscibile se sussistono adeguati indici di riconoscibilità valutati in modo concreto, cioè
con riferimento al contesto specifico del singolo contratto.
Ciò risulta con chiarezza dagli elementi a cui il 1431 impone di legare il giudizio di riconoscibilità.
Un elemento è il contenuto del contratto (un errore sul tipo di materiale acquistato può esser
riconoscibile se in una clausola si riferisce dell’uso che l’acquirente ne farà); altro elemento è la qualità
dei contraenti (sesso, età, conformazione fisica, posizione socio-economica del dichiarante in errore);
ulteriore elemento sono le “circostanze” del contratto (espressione in grado di dar rilievo ad infiniti
particolari).
La riconoscibilità, indotta dagli indici di cui sopra, deve parametrarsi su un osservatore “di normale
diligenza”.
Il richiamo al parametro della diligenza mette in gioco il criterio che impone di calibrarlo sullo
specifico contesto professionale in cui s’inscrive il rapporto (1176.2: Nell’adempimento delle
obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo
alla natura dell’attività esercitata).
Il giudizio di riconoscibilità non deve tenere in considerazione fattori che appartengono alla sfera
puramente soggettiva della parte.
Chi invoca rimedi contro l’errore ha l’onere di provarne la riconoscibilità: il relativo giudizio – siccome
di fatto e non di diritto – non è censurabile in Cassazione.
Per la dottrina prevalente l’errore effettivamente riconosciuto è rilevante anche se sia non riconoscibile.
In giurisprudenza è rilevante, nonostante l’obiettiva non riconoscibilità,l’errore in cui siano caduti
entrambi i contraenti (c.d. errore comune).
Vanno prima di tutto isolati i casi in cui le parti hanno, sul punto in relazione al quale entrambe si sono
sbagliate, una reale volontà comune: si tratta allora di farla emergere con l’interpretazione, e di farla
prevalere sull’espressione erronea, ex 1362 ss.
Vanno ulteriormente isolati i casi in cui entrambe le parti cadono in errore, ma non nello stesso errore.
I due errori vanno trattati separatamente: ciascuna parte può invocare il proprio, se essenziale e
riconoscibile da controparte.
Ci si deve concentrare sui casi in cui le parti cadono nel medesimo errore, che non si limita a velare una
comune volontà delle parti; per trattarli, si raccomandano soluzioni articolate.
La chiave sta nel ricordare che la riconoscibilità ha due componenti: riconoscibilità del fatto che la
realtà è diversa da come controparte se la rappresenta; e riconoscibilità del fatto che controparte se la
rappresenta falsamente.
Ci sono errori comuni che escludono entrambi i profili della riconoscibilità: in tal caso non ha senso
esigere il requisito; e ci sono errori comuni che escludono il primo ma non il secondo profilo: rispetto a
questi il requisito va mantenuto.
L’errore ostativo è l’erronea manifestazione della volontà contrattuale, che si forma correttamente ma
viene dichiarata o trasmessa al destinatario in modo difforme dall’intenzione della parte.
Le fattispecie di errore ostativo sono due, identificate nel 1433 (Le disposizioni degli articoli precedenti
si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata
inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato): la prima è l’errore
nella dichiarazione; la seconda è l’errore nella trasmissione.
La disciplina è la stessa dell’errore-vizio, che il 1433 espressamente dice applicabile all’errore ostativo:
annullabilità del contratto, ove l’errore sia essenziale e riconoscibile.
Il 1433 copre sia le alterazioni colposamente introdotte dall’addetto alla trasmissione, sia anche le
alterazioni dolose (es.: riempimento infedele del biancosegno).
Infine, il 1433 deve misurarsi col fenomeno del “dissenso”.
Quando l’errore nella dichiarazione o trasmissione determina l’obiettiva incongruenza delle
dichiarazioni contrattuali, ricorre dissenso palese.
I casi allora sono due: o l’equivoco riesce a sciogliersi in via interpretativa, ed allora c’è un valido
contratto; oppure no, ed allora non c’è un contratto annullabile ex 1433, bensì non c’è nessun contratto.
Altra cosa è il dissenso occulto (malinteso), che ricorre quando il destinatario della dichiarazione
contrattuale la intende in un senso diverso dal senso attribuitogli dal dichiarante, e sul presupposto di
questo diverso senso emette la propria dichiarazione contrattuale, sicché i segni scambiati fra le parti
sono congruenti, ma divergono i significati che ciascuna parte vi ricollega: in tal caso è impossibile far
emergere con l’interpretazione una comune volontà che non esiste, e non sembra esserci alternativa alla
nullità per mancanza di accordo.
CAPITOLO XXXVI – IL DOLO
“Dolo” ha due significati: nel primo significato, è qualificazione soggettiva dell’illecito contrattuale od
extracontrattuale, è la coscienza e volontà di danneggiare la vittima, che animi l’autore dell’illecito; nel
secondo significato, è l’inganno che induce una parte a concludere il contratto: sono i raggiri esercitati
su una parte, in assenza dei quali la vittima non avrebbe contrattato (1439.1).
Il dolo-inganno dà luogo ad un vizio della volontà: come tale espone il contratto al rimedio
dell’annullamento (1439.1); al tempo stesso è un illecito (precontrattuale): come tale, dà alla vittima il
rimedio del risarcimento del danno.
I due rimedi possono operare in via cumulativa od in via alternativa, a scelta della vittima.
Il risarcimento si calcola in modo diverso nell’uno e nell’altro caso.
Il dolo si sovrappone parzialmente all’errore: esso rileva in quanto induce in errore la vittima
dell’inganno.
L’errore causa annullamento solo in quanto sia essenziale.
Il dolo causa annullamento anche quando l’errore indotto da esso non abbia il requisito
dell’essenzialità: ciò che si richiede all’errore portato da inganno è solo che risulti determinante del
consenso: infatti il dolo rileva, ai fini dell’annullamento, quando i raggiri sono stati tali che, senza di
essi, la parte raggirata “non avrebbe contrattato”.
La prova del carattere determinante dell’inganno incombe alla vittima.
Tuttavia non sembra che tale prova debba esigersi, quando l’inganno determina uno di quegli errori
che, a norma del 1429, rilevano ex se.
Nell’area in cui il dolo induce un errore essenziale, la vittima può scegliere se chiedere l’annullamento
per dolo o per errore: sarà indotta a scegliere l’una o l’altra via, a seconda che per lei sia più agevole
dimostrare l’altrui inganno o la riconoscibilità del proprio errore.
Vanno precisate le caratteristiche della condotta ingannevole.
La condotta ingannevole al più alto grado d’intensità è la macchinazione, cioè l’artificiosa
predisposizione di segni esteriori che offrono una falsa rappresentazione della realtà.
La macchinazione è rilevante, in quanto induca nella vittima un errore determinante del consenso, e che
vi sia un ragionevole nesso causale fra macchinazione e decisione di contrattare.
Ferma l’idoneità della macchinazione a costituire raggiro, si domanda se analoga idoneità abbia la
semplice menzogna: cioè l’affermazione del falso o la negazione del vero, non qualificate da ulteriori
artifici diretti ad ingannare.
È utile il criterio della sfera cui appartiene l’oggetto della menzogna.
Sono di massima irrilevanti le menzogne su dati che toccano la sfera propria (o di altri soggetti), e non
hanno alcun significativo riflesso al di là di questa.
Invece sono di massima rilevanti le menzogne su dati che direttamente od indirettamente toccano la
sfera di controparte.
La reticenza è la condotta della parte che omette d’informare controparte su dati, la cui conoscenza
avrebbe indotto quest’ultima a non contrattare.
La reticenza si dice anche dolo omissivo, o negativo.
Son fuori della reticenza i casi in cui la parte, dopo aver creato indici di apparenza idonei ad ingannare
controparte, tace a questa gli elementi che le permetterebbero di dissipare la falsa rappresentazione;
come pure i casi in cui la parte, di fronte ad indici siffatti pur non creati da lei, opera per impedire a
controparte di scoprirne la falsità: qui siamo nel campo del dolo commissivo.
Possiamo stralciare dal discorso anche i casi in cui la reticenza è il silenzio della parte che tace di fronte
all’errore essenziale di controparte, da lei riconosciuto.
Qui non occorre invocare il dolo: basta la disciplina dell’errore.
Il problema se la reticenza possa costituire raggiro rilevante per l’annullamento del contratto ex 1439 si
pone nei casi in cui non sia decisiva da sola la disciplina dell’errore: cioè quando la falsa
rappresentazione di una parte, di fronte alla quale controparte tace, non presenta i requisiti del 1428
(L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale [1429] ed è riconoscibile
dall’altro contraente [1431]).
Gli indici normativi dai quali l’interprete può partire non sono univoci.
Il 1892 rende annullabile il contratto di assicurazione per le reticenze dell’assicurato; ha portata
generale il 1338, che rende responsabile la parte che tace all’altra cause d’invalidità del contratto: ma
esso pone una regola sulla responsabilità del contraente, non sull’invalidità del contratto.
La formula corrente per cui la reticenza è dolo quando costituisce violazione di un dovere
d’informazione non chiude il problema, perché costringe a domandarsi quando sussista dovere
d’informare.
Per l’opinione tradizionale il raggiro determina annullabilità del contratto solo se intenzionale, cioè
sostenuto da coscienza e volontà d’ingannare controparte per indurla al contratto.
Il 1892 dice rilevanti per l’annullamento del contratto di assicurazione inesattezze e reticenze
dell’assicurato dipendenti non solo da dolo ma anche da colpa (sia pure grave).
Un’antica opinione esclude che causi annullamento il dolus bonus, consistente nelle generiche vanterie
o nell’iperbolica esaltazione della propria prestazione, cui il contraente s’abbandoni nel rivolgersi a
controparte.
La ragione starebbe in un principio ripetuto nelle massime: rileva come dolo soltanto la condotta
obiettivamente idonea ad ingannare una persona di normale avvedutezza.
Il principio però contrasta frontalmente con la ratio della regola (1428) che, nel fissare i requisiti di
rilevanza dell’errore, non contempla fra essi la scusabilità.
Non conta l’obiettiva idoneità dell’inganno, parametrata su un destinatario di media accortezza; conta
solo che il destinatario risulti concretamente ingannato.
Il 1439.2 regola il caso in cui il raggiro che inganna la parte non proviene da controparte ma da un
terzo: quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al
contraente che ne ha tratto vantaggio.
Certo non è terzo il rappresentante che è parte (ancorché formale) del contratto.
Siamo fuori della fattispecie anche quando l’inganno materialmente esercitato dal terzo è istigato dalla
parte: questo va trattato come dolo di parte.
Il dolo del terzo rende il contratto annullabile solo se conosciuto dalla parte che se ne avvantaggia.
Il “vantaggio” è semplicemente l’avvenuta conclusione del contratto, a prescindere da contenuto ed
effetti di questo.
Il dolo che rende il contratto annullabile è il dolo determinante, che ricorre quando senza inganno la
vittima non avrebbe contrattato.
Diverso è il dolo incidente, cioè l’inganno senza il quale la vittima avrebbe sì accettato di contrarre, ma
a condizioni diverse: in tal caso il contratto è valido, ma la parte in mala fede risponde dei danni
(1440).
Il dolo determinante rende il contratto annullabile; il dolo incidente lo lascia valido.
Nel caso di dolo determinante, la vittima dell’inganno ha diritto (oltre che all’annullamento, o, se
preferisce, in alternativa all’annullamento) al risarcimento del danno, commisurato all’interesse
negativo: ovvero il danno che la vittima ha risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità
del contratto (1338).
La vittima di dolo incidente ha come unico rimedio il risarcimento: ma questo non si determina sul
parametro dell’interesse negativo, bensì deve comprendere tutte le utilità perse dalla vittima per avere
contrattato alle condizioni suggerite dall’inganno.
Il dolo incidente non produce, di per sé, annullabilità.
Potrebbe indirettamente produrla, se inducesse nella vittima un errore essenziale.
CAPITOLO XXXVII – LA VIOLENZA
La norma per cui la violenza è causa di annullamento del contratto (1434) intende la violenza nel senso
di minaccia.
La minaccia è causa di annullamento in quanto vizia la volontà contrattuale senza escluderla del tutto.
L’impostazione tradizionale la definiva violenza “morale” (o “psichica”); e la contrapponeva alla
violenza “fisica”, che sarebbe invece causa di nullità in quanto esclude radicalmente il consenso.
Possono esserci casi in cui la violenza dà luogo ad una dichiarazione contrattuale solo apparentemente
riferibile alla parte (la sottoscrizione di chi “firma” perché altri ne forza e conduce la mano non è in
realtà la sua dichiarazione): qui il contratto è nullo per mancanza di accordo.
A differenza del dolo, la violenza del terzo rende il contratto annullabile anche se ignota alla parte che
se ne giova (1434).
La minaccia è causa di annullamento se ha i requisiti descritti dal 1435 e seguenti: la prospettazione del
male deve essere credibile; il male prospettato deve essere esterno al contratto, notevole ed ingiusto.
Il primo requisito è la credibilità della minaccia: la violenza deve essere di tal natura da far
impressione sopra una persona sensata (1435).
La credibilità della minaccia va valutata avendo riguardo all’età, al sesso e alla condizione delle
persone (1435).
Occorre cautela di fronte alla condizione personale che incida sulla capacità d’intendere o di volere: il
rimedio del 1434 non deve sovrapporsi indebitamente a quello del 428.
La legge lega poi il giudizio sulla credibilità della minaccia ad un altro criterio: il bersaglio del male
minacciato.
Essa distingue due livelli di credibilità, collegati a due ordini di soggetti esposti al male.
Il livello è più alto se il male minacciato colpirà lo stesso contraente od i suoi familiari (ritenuti) più
stretti, e cioè coniuge, discendenti ed ascendenti (1436.1).
È più basso se il male colpirà qualunque altra persona: in tal caso l’annullamento del contratto è
rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice (1436.2).
La minaccia può essere esplicitata a parole, ma può anche risultare per implicito: da gesti silenziosi,
allusioni indirette, segnali obliqui.
Ci si domanda se rilevi la violenza putativa: ovvero se rilevi la condizione della parte che erroneamente
percepisce una minaccia inesistente.
Se la condotta intimidente presenta i tratti esteriori della minaccia obiettivamente credibile, e non
costituisce una reale minaccia solo perché chi ne appare l’autore non intendeva affatto minacciare,
rileva.
Non basta che la prospettazione del male sia credibile: occorre anche che il male prospettato abbia certi
caratteri: esso deve essere esterno al contratto, notevole, ingiusto.
Anche se la norma non lo dice, è ovvio che il male debba essere esterno al contratto: più precisamente,
non può identificarsi nella privazione della prestazione attesa in base al contratto.
Il secondo, necessario carattere del male prospettato è di essere un male notevole (1435); il male
minacciato può avere come bersaglio persone umane, o beni (1435).
Spetta all’interprete valutare in concreto l’efficienza intimidatrice della minaccia, incrociando il criterio
della qualità del valore bersagliato con il criterio della gravità del male che lo minaccia.
A questi criteri dovranno poi sovrapporsi gli altri considerati a proposito del giudizio di credibilità della
minaccia, ed applicabili ugualmente nel giudizio sulla notevole entità del male minacciato: età, sesso,
condizione delle persone.
Ancora prima che notevole, il male minacciato deve essere ingiusto (1435).
Un’altra norma considera poi quella particolare minaccia che consiste nel minacciare l’esercizio di un
proprio diritto: e dice che essa causa annullamento solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti
(1438).
In prima approssimazione, può così dirsi che è ingiusto il male minacciato, quando quel male, se
attuato, farebbe sorgere la responsabilità civile di chi lo infligge e la pretesa risarcitoria di chi lo
subisce, ex
2043 (o 1218).
Quando il male minacciato non è ex se ingiusto, il contratto resta valido, senza che vi sia spazio per
sindacarne il contenuto onde verificare il genere di vantaggi che esso reca all’autore della minaccia.
Un tale sindacato si rende invece necessario ex 1438 quando il male minacciato per un verso è
qualificabile come ingiusto, e per altro verso ha la particolarità di scaturire dall’esercizio di un diritto
del minacciante.
Per identificare se i vantaggi siano ingiusti o meno, si ricorre a due criteri – qualitativo e quantitativo –
da combinare in sequenza eventuale.
Il criterio qualitativo è la strumentalità od inerenza del contratto al contenuto ed alla funzione tipica del
diritto fatto valere.
Se il contratto non ha nessuna connessione col diritto fatto valere, perché soddisfa interessi della parte
affatto estranei all’interesse cui il suo diritto è tipicamente dedicato, allora l’ingiustizia del vantaggio
contrattuale strappato con la minaccia è in re ipsa, ed il contratto è annullabile.
Può darsi invece che il nesso di strumentalità/inerenza sussista, allora si deve vedere se, per i suoi
concreti e specifici contenuti, il contratto dà alla parte vantaggi normali, o vantaggi spropositati: nel
primo caso il vantaggio non è ingiusto, ed il contratto resta valido.
Tendenzialmente cadono sotto il 1435 i casi in cui la minaccia riguarda l’esercizio di una libertà o di un
diritto assoluto del minacciante, fuori di uno specifico rapporto col minacciato.
Cadono invece sotto il 1438 le minacce di far valere diritti relativi, pretese specifiche che il minacciante
ha verso il minacciato in forza di una relazione che preesiste fra loro.
Infine, quid della minaccia di esercitare un diritto inesistente?
Se l’inesistenza del diritto è palese, la minaccia sarà irrilevante per mancanza di credibilità; se però la
minaccia è materialmente attuabile anche nella palese inesistenza del diritto invocato dal minacciate,
può dare luogo a violenza.
Si discute se, per la rilevanza della minaccia, debba sussistere nesso di causalità fra questa ed il
contratto concluso dal minacciato.
Il nesso deve sussistere, in questo senso: occorre che la parte faccia il contratto, perché bersaglio di una
minaccia specificamente rivolta ad ottenere la conclusione di quel contratto.
Non è configurabile una violenza incidente.
Il 1437 delimita, in negativo, i confini del vizio di violenza: ne chiama fuori il timore reverenziale, che
è la soggezione psicologica di un soggetto verso un altro, determinata dalle rispettive posizioni nel
contesto familiare, professionale o più genericamente sociale.
Se chi incute timore reverenziale v’innesta ulteriori, più specifici atteggiamenti intimidatori, questi
possono costituire minaccia; e per valutarne la credibilità agli occhi della vittima può tenersi conto del
suo timore reverenziale, siccome condizione delle persone rilevante ex 1435.
Di norma irrilevante è anche il timore di circostanze esterne minacciose.
Se la minaccia proviene da circostanze oggettive, manca il requisito della condotta umana; se proviene
dalla condotta di terzi, manca il nesso di causalità con la conclusione del contratto (se invece la
condotta minacciosa di terzi fosse diretta alla conclusione del contratto, ricadrebbe sotto il 1434).
Quando però le circostanze esterne minacciose, sotto il cui timore la parte contratta, assumono i
connotati estremi del pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447.1), allora il contratto – nel
concorso di ulteriori presupposti – diventa impugnabile col mezzo della rescissione.
Rileva lo stato di bisogno della parte, suscettibile di aprire la strada alla rescissione per lesione laddove
sussistano i presupposti del 1448.
Rileva la dipendenza economica della parte, di cui l’altra parte abusi, che può determinare nullità del
contratto ex l. 192/1998.
CAPITOLO XXXVIII – I REGIMI DEL CONTRATTO INVALIDO:
LEGITTIMAZIONE, PRESCRIZIONE, RECUPERO
La distinzione fra contratto nullo ed annullabile conosce ai suoi margini incrinature in cui le due figure
tendono all’indistinzione.
La nullità genera una legittimazione allargata: può farla valere chiunque vi abbia interesse; invece
l’annullabilità genera una legittimazione ristretta, poiché l’annullamento del contratto può essere
domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (1441.1).
Per i contratti degli incapaci relativi, la legittimazione spetta allo stesso incapace (396.1, 427.2); quanto
agli incapaci assoluti, se l’annullabilità dipende da interdizione, la legittimazione spetta sia all’incapace
sia al rappresentante legale (tutore: 427.1).
La stessa soluzione non è esplicitata per il contratto del minore, ma s’impone.
Se la parte legittimata premuore, la legittimazione passa agli eredi; se gli eredi sono più, la
legittimazione spetta individualmente a ciascuno: ma il singolo erede che ottiene l’annullamento può
agire per la restituzione solo nei limiti della quota.
Se la parte è complessa, la legittimazione spetta individualmente ad ognuno dei soggetti che la
compongono; ma il risultato potrà essere la distruzione dell’intero contratto.
Nei contratti plurilaterali, ogni parte può impugnare la propria dichiarazione contrattuale, e così uscire
dal contratto; la sorte del contratto complessivamente considerato dipende dall’essenzialità della
partecipazione venuta meno (1446).
Oltre la parte colpita dal vizio (ed il suo successore universale), per i contratti degli incapaci di agire,
l’annullabilità può farsi valere anche dagli aventi causa (a titolo particolare) dell’incapace (322: Gli atti
compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo [Della potestà dei
genitori] possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi
eredi o aventi causa; 377: Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono
essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa; 396.1: Gli atti
compiuti senza osservare le norme stabilite nell’art. 394 [L’emancipazione conferisce al minore la
capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione.
Il minore emancipato
può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può
stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Per
gli atti indicati nell’art. 375 l’autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal
tribunale su parere del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il
curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell’art. 320.] possono essere
annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa; 427 commi 1 e 2: Gli atti compiuti
dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore,
dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto
dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d’interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte
formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla
nomina sia seguita l’inabilitazione.).
Un più significativo allargamento della legittimazione riguarda i contratti dell’interdetto legale per
condanna penale, che possono essere impegnati da chiunque vi abbia interesse (1441.2): la
corrispondente annullabilità si definisce annullabilità assoluta.
Casi di legittimazione allargata a chiunque vi abbia interesse si danno poi in materia di testamento
annullabile per incapacità di agire, naturale e legale (591), per vizio di forma (606.2), per vizio della
volontà (624.1).
A differenza dell’annullabilità, la nullità obbedisce ad una regola di legittimazione allargata: può farla
valere chiunque vi ha interesse (1421); ratio: il contratto nullo è generalmente lesivo di interessi
generali.
L’interesse va apprezzato a norma del 100 c.p.c. (Per proporre una domanda o per contraddire alla
stessa è necessario avervi interesse).
Si pone il problema della legittimazione passiva, specie nei casi di azione promossa da un terzo:
devono convenirsi entrambe le parti, come protagoniste di un litisconsorzio necessario, od il giudizio
può svolgersi nei confronti di una sola di esse?
Si fa preferire una soluzione articolata: se la nullità serve solo a difendere un diritto messo in dubbio od
a rischio dall’atto nullo, allora può invocarsi nei confronti della sola parte da cui viene la minaccia al
diritto dell’attore; se invece occorre una decisione che faccia stato per entrambe le parti dell’atto nullo,
allora entrambe vanno chiamate in giudizio come litisconsorti necessari.
Sono nullità relative quelle che, contro la regola del 1421, possono farsi valere non da chiunque vi
abbia interesse, ma solo da una delle parti: dalla sola parte protetta dalla previsione di nullità.
S’identificano in genere con le c.d. nullità di protezione, disposte nell’interesse di una parte in quanto
esponente di una categoria sociale meritevole di particolare tutela nei confronti dell’altra.
Un problema è: perché distinguere la nullità relativa dall’annullabilità, da cui mutua il più forte
connotato di regime? La risposta è sia concettuale sia pratica.
Concettuale: mentre l’annullabilità persegue l’interesse particolare della parte protetta in relazione alla
condizione soggettiva in cui la stessa versa, la nullità relativa persegue un interesse della parte protetta
che non è il suo interesse particolare, ma è un interesse di serie o di massa.
Ma la risposta è anche pratica: conservando la qualifica di nullità, si escludono elementi del regime
dell’annullabilità che sarebbero indesiderabili.
Ciò vale soprattutto per la convalida, specie tacita: la protezione sarebbe debole, se la parte protetta
perdesse l’impugnativa del contratto solo per aver compiuto qualche atto di esecuzione.
C’è poi il problema d’identificare le fattispecie di nullità relativa in mancanza di previsione espressa.
Il problema va risolto nel senso di considerare la nullità come relativa, anche in mancanza di espressa
qualificazione in tal senso.
Un’altra nullità relativa non esplicitata è quella prevista dal 1419.1 in tema di nullità parziale.
A differenza dell’annullabilità, che può farsi valere solo ad istanza di parte, la nullità può essere
rilevata d’ufficio dal giudice (1421).
Il principio dispositivo, per cui il giudice non può sostituirsi alle parti nella ricerca delle prove,
suggerisce che la nullità può rilevarsi d’ufficio nella sola misura in cui risulti da elementi già acquisiti
al giudizio.
I principi della domanda e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato suggeriscono un ulteriore
limite: perché la nullità possa rilevarsi d’ufficio non basta che il contratto sia comunque dedotto in
giudizio, occorre una domanda che presupponga la validità (o più precisamente la non nullità) del
contratto stesso.
Anche domande dirette all’opposto risultato di cancellare il contratto, come quelle di risoluzione o
rescissione od annullamento, possono suscitare una pronuncia di nullità resa ex officio.
Altro caso è la domanda di nullità espressamente formulata dalla parte: se il giudice non condivide la
ragione cui la parte riferisce la nullità, ma ne individua un’altra, può pronunciare la nullità per la
diversa ragione da lui ritenuta, e non prospettata dalla parte?
La risposta negativa, offerta in giurisprudenza, può condividersi solo per i casi in cui la nullità sia
chiesta in via di azione, mentre non convince laddove la nullità sia proposta in via di eccezione.
Un altro limite risulta dal principio della cosa giudicata.
I giudicati “impliciti” in materia non meritano spazio: se in primo grado la domanda di esecuzione è
stata accolta, ciò non significa che il giudice, che avrebbe potuto respingerla se avesse rilevato d’ufficio
la nullità, non facendolo abbia implicitamente pronunciato che il contratto non è nullo.
È rilevabile d’ufficio la nullità relativa?
È inammissibile la rilevazione d’ufficio della nullità relativa quando vi sia una domanda della parte
protetta sostanzialmente incompatibile col risultato derivante dalla rilevata nullità; la nullità relativa è
rilevabile d’ufficio, quando conduca ad accogliere il petitum della parte protetta (ancorché per una
causa petendi diversa da quella esposta).
Mentre l’azione di nullità è imprescrittibile (1422), l’azione di annullamento si prescrive in cinque anni
(1442.1).
Il termine di decorrenza è diverso, a seconda della causa di annullabilità.
Se questa dipende da incapacità legale o vizio della volontà, la prescrizione decorre solo dal momento
in cui il fattore invalidante è superato: compimento della maggiore età; revoca dell’interdizione od
inabilitazione; scoperta dell’errore o del dolo; cessazione della violenza (1442.2).
In ogni altro caso la prescrizione comincia a decorrere dalla conclusione del contratto (1442.3).
La disciplina della sospensione è quella ordinaria.
Quanto all’interruzione, forse è esagerata la tesi, pur prevalente, che l’interruzione può realizzarsi solo
con l’esercizio dell’azione.
Se l’azione si prescrive, imprescrittibile è invece l’eccezione: l’annullabilità può essere opposta dalla
parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere (1442.4).
Dalla locuzione “parte convenuta per l’esecuzione del contratto” la giurisprudenza ricava la massima
per cui la possibilità d’invocare l’eccezione una volta prescritta l’azione presuppone che il contratto
non sia stato ancora eseguito.
È più appropriato dire che l’ultrattività dell’eccezione presuppone che contro la parte protetta sia rivolta
una domanda implicante l’attuazione del contratto.
Il risultato pratico dell’eccezione non è diverso da quello dell’azione, e cioè la cancellazione degli
effetti contrattuali.
L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione (1422).
L’imprescrittibilità lascia comunque salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di
ripetizione.
La ripetizione dell’indebito si prescrive in 10 anni.
Per ampliare le possibilità di recupero del solvens, si prospetta una stretta connessione fra azioni di
nullità e di ripetizione: ad es. concependo l’azione di ripetizione come essa stessa azione di nullità, o
convertendola in imprescrittibile azione di rivendicazione del bene trasferito col contratto nullo.
Alle esplicite riserve del 1422 ne va aggiunta un’altra.
La nullità del contratto può dare alla parte diritto a risarcimento ex 1338: ma la sopravvivenza
dell’azione di nullità non salva l’azione di risarcimento dalla prescrizione, cui è soggetta.
E c’è un caso ulteriore in cui l’imprescrittibilità dell’azione non impedisce che il decorso del tempo
frustri un risultato pratico normalmente collegato alla nullità: il caso della c.d. trascrizione sanante
(2652, n. 6: Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’art. 2643, le
domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti […] le
domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l’annullamento di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.).
Se la domanda di nullità di un contratto soggetto a trascrizione è trascritta oltre 5 anni dopo la
trascrizione del contratto nullo, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base ad un titolo trascritto prima della trascrizione della domanda di nullità.
La pubblicità sanante si applica anche alla trascrizione delle domande di annullamento.
In certi casi ed a certe condizioni, il contratto invalido può essere recuperato.
Il dato di partenza è che il contratto invalido non produce effetti, o produce effetti non stabili:
recuperarlo significa salvare o stabilizzare i suoi effetti.
Il recupero può avvenire in misure e forme molto varie.
Nel recupero dei contratti annullabili il mezzo principe è la convalida; un particolare mezzo di
recupero, applicabile ai soli contratti annullabili per errore, è la rettifica.
I contratti nulli possono risultare produttivi di effetti diversi da quelli originariamente perseguiti, col
meccanismo della conversione.
Alla categoria dell’invalidità può in definitiva ricondursi, oltre al contratto nullo ed a quello
annullabile, anche il contratto soggetto a rescissione.
In questa prospettiva, ulteriore mezzo di recupero del contratto invalido è la riduzione ad equità del
contratto rescindibile.
Il contratto annullabile può essere convalidato (1444.1) con un atto che si chiama convalida.
Il senso proprio della convalida non è rendere il contratto produttivo di effetti, ma piuttosto di
stabilizzare gli effetti del contratto.
Il fondamentale risultato pratico della convalida è che, intervenuta questa, il contratto non può più
essere annullato (né l’annullabilità può più farsi valere in via di eccezione).
La convalida non rimuove il vizio del contratto, ma fissa il valore del contratto stesso, ancorché viziato.
La convalida è atto unilaterale della parte legittimata.
Legittimato a convalidare il contratto è il solo contraente al quale spetta l’azione di annullamento
(1444.1).
Nella pluralità di soggetti legittimati, quando ciascun legittimato ha rispetto al contratto posizione ed
interesse autonomi, la convalida di uno preclude l’annullamento solo a lui, mentre gli altri conservano
l’azione.
Non così quando l’interesse in gioco è unico, e ciascuna legittimazione è strumentale ad esso: se
l’interdetto convalida, il tutore non può più annullare.
Si distingue una convalida espressa ed una convalida tacita.
La convalida espressa è l’atto con cui la parte dichiara di convalidare il contratto annullabile.
È un atto negoziale, unilaterale e (secondo l’opinione prevalente) non ricettizio.
La sua normale unilateralità non esclude che la convalida possa inserirsi in un contratto, come parte del
suo contenuto.
Nella tesi più accreditata, la convalida espressa ha forma libera.
Essa esige piuttosto due requisiti di forma/contenuto: deve contenere la menzione del contratto e del
motivo di annullabilità (1444.1).
Se il contratto è annullabile per due distinti motivi, la convalida che ne menzioni uno non preclude
l’annullamento in base all’altro.
Ulteriore requisito per l’operare della convalida è che il convalidante sia in condizione di concludere
validamente il contratto (1444.3).
Ciò significa che non deve più sussistere il vizio determinante l’annullabilità: occorre che la parte sia
uscita dall’incapacità di agire, abbia scoperto l’errore o l’inganno, non tema più per la minaccia.
Se così non è, la convalida non ha effetto (1444.3).
La formula è stata variamente interpretata: nel senso della nullità, dell’annullabilità, dell’inefficacia in
senso stretto.
Alla convalida tacita si dedica il 1444.2: il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale
spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di
annullabilità.
La figura pone due problemi: cosa significhi “dare esecuzione” al contratto, e quale sia la natura
(negoziale o non negoziale?) dell’atto.
Per la giurisprudenza, la convalida tacita è un negozio compiuto mediante comportamento concludente:
il dare esecuzione al contratto rileverebbe in quanto indice della volontà di convalidarlo.
Sono idonei a manifestare tale volontà non solo l’esecuzione in senso stretto, cioè l’adempimento della
prestazione, ma anche atti che non sono adempimento, bensì esercizio di diritti dipendenti dal contratto.
Questa impostazione ha due conseguenze divergenti: una estende l’operare del meccanismo, l’altra lo
restringe.
La conseguenza estensiva è la larghezza con cui s’intende il dare esecuzione: ciò che conta è solo
l’attitudine dell’atto a significare la volontà di convalida.
Proprio su questo s’innesta la conseguenza restrittiva.
Se la convalida tacita è un negozio, non può operare ove non sia sorretta da volontà consapevole ed
integra di produrre l’effetto convalidante.
In dottrina prevale un’impostazione diversa.
L’esecuzione del 1444.2 è solo l’adempimento: essa convalida il contratto ope legis e non come effetto
di volontà negoziale; in questa prospettiva, la convalida tacita non è un negozio ma piuttosto un atto
giuridico in senso stretto ad effetto legale.
Con rilevanti conseguenze pratiche: non è soggetta alle impugnative che presidiano consapevolezza ed
integrità del volere negoziale; non può facilmente essere neutralizzata da una protestatio contraria.
Gli atti diversi dall’esecuzione in senso stretto possono dare luogo a convalida solo se hanno valore di
comportamenti concludenti.
Anche per la convalida tacita vale il requisito del 1444.3: il convalidante deve essere in condizione di
concludere validamente il contratto, cioè libero dal vizio che aveva causato l’annullabilità.
La rettifica è un particolare mezzo di recupero del contratto annullabile per errore; essa consiste
nell’offerta, fatta all’errante dalla parte non in errore, di eseguire il contratto in modo conforme al
contenuto e alle modalità secondo cui l’errante intendeva contrarre.
Dinnanzi all’offerta di controparte l’errante non può domandare l’annullamento del contratto: effetto
dell’offerta è dunque, come recita la rubrica del 1432, il mantenimento del contratto rettificato.
L’offerta di rettifica è un negozio unilaterale ricettizio.
Compierlo è un diritto potestativo della parte non in errore, non può essere pretesa dall’errante, né
disposta d’ufficio dal giudice.
Per impedire l’annullamento la parte non in errore ha l’onere di rimodellare il regolamento contrattuale
in termini conformi al programma dell’errante.
Il diritto al mantenimento del contratto rettificato incontra un altro limite, coincidente col pregiudizio
che possa derivarne alla parte in errore: parametro che attiene essenzialmente al tempo in cui viene
offerta la rettifica.
In linea di principio il potere di rettifica può esercitarsi senza limiti di tempo, come potere uguale e
contrario a quello di far valere l’annullabilità.
Entro il termine di prescrizione dell’azione d’annullamento, può impedire o contrastare questa.
Ma può farsi valere anche oltre tale termine: di fronte all’eccezione di annullabilità, opposta senza
limiti di tempo dalla parte in errore convenuta per l’esecuzione del contratto, l’attore può neutralizzarla
offrendo la rettifica.
Mentre il contratto annullabile può essere pienamente recuperato tramite convalida, il contratto nullo
non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente (1423).
La non convalidabilità del contratto nullo è suggerita intanto dalla legittimazione allargata a far valere
il vizio, che implicherebbe una legittimazione alla convalida allargata e dispersa; ma la ratio sta
soprattutto nell’interesse generale che presiede al regime delle nullità, e che suggerisce di sottrarre il
rimedio alla libera disponibilità delle parti interessate.
Il 1423 rende impraticabile anche la rinuncia all’azione di nullità.
Una notevole eccezione riguarda la c.d. sanatoria della donazione nulla: la nullità della donazione, da
qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che,
conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno
dato volontaria esecuzione (799).
Protagonista della convalida è la parte (protetta) del contratto annullabile; invece la sanatoria della
donazione nulla può essere compiuta solo da soggetti estranei al contratto, e cioè eredi od aventi causa
del donante, mentre è preclusa al donante e tanto più al donatario.
Nondimanco, molti elementi l’avvicinano alla convalida: intanto la doppia versione in cui può
presentarsi (espressa quando avviene per conferma, e tacita quando avviene per esecuzione), poi la
consapevolezza e l’intenzionalità dell’atto.
Si discute se la sanatoria abbia il senso – positivo di rendere l’atto efficace nei propri confronti, o
quello – solo negativo – di una mera rinuncia all’azione di nullità.
Possono discenderne conseguenze diverse per il caso di pluralità di eredi, dei quali uno solo confermi.
Escludere i contratti nulli dalla possibilità di convalida lascia aperta la possibilità di applicare ad essi
altri mezzi di recupero, si tratta di meccanismi che prescindono da qualsiasi volontà negoziale e
consistono in atti o fatti cui la legge ricollega in modo obiettivo il consolidamento degli effetti
programmati col contratto nullo, od almeno di alcuni fra essi.
Un fattore di recupero può risultare da dispositivi processuali: il contratto risultante da scrittura con
firma falsa è nullo, ma se l’apparente sottoscrittore, contro cui la scrittura è prodotta, non disconosce
tempestivamente la firma ex 214-215 c.p.c., il contratto opera.
Sul piano sostanziale operano due importanti fattori di recupero: l’esecuzione e la pubblicità.
L’esecuzione opera da sola come fattore di recupero nel caso del contratto di lavoro nullo, ex 2126.1: la
nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha
avuto esecuzione.
Tuttavia il contratto non si recupera nemmeno con l’esecuzione, se la nullità derivi dall’illiceità
dell’oggetto o della causa.
Un altro caso risulta dalla legislazione speciale: nullo per vizio di forma il contratto di subfornitura, il
subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate.
Talora l’esecuzione è fattore di recupero solo in combinazione col fattore tempo.
Usucapione e prescrizione possono, nel tempo, consolidare definitivamente gli effetti programmati col
contratto nullo.
Anche la pubblicità opera in vari casi come fattore di recupero del contratto nullo.
A norma del 2332, l’iscrizione della società nulla nel registro delle imprese preclude la dichiarazione di
nullità per motivi diversi da quelli del c. I e fa salvi gli atti sociali compiuti in epoca successiva.
Inoltre, la successiva iscrizione di una modifica che elimini la causa di nullità presente nell’atto
costitutivo impedisce che questo sia dichiarato nullo (c. III).
Talora il contratto nullo si recupera associando pubblicità e decorso del tempo, così con la trascrizione
ex 2652, n. 6.
Un modo realistico per spiegare tutti questi fenomeni di recupero è la categoria della fattispecie
complessa, a formazione progressiva: gli effetti che infine si producono derivano da una fattispecie
composta dal contratto nullo e, in più, da un ulteriore elemento (di volta in volta la conferma,
l’esecuzione, la pubblicità, il decorso del tempo).
La conversione è un mezzo di recupero del contratto nullo, che salva i suoi effetti trasformandoli in
effetti diversi.
La prevede il 1424: il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, ove risulti che le
parti lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
Il patto di non alienare è nullo perché la sua durata eccede convenienti limiti di tempo (1379): ma può
convertirsi in patto che vincola l’obbligato per un tempo ridotto entro limiti convenienti.
Perché il meccanismo operi, è necessario che il contratto di partenza (nullo) abbia i requisiti di sostanza
e di forma previsti per il contratto di arrivo (frutto della conversione): è la stessa formula usata per il
contratto dissimulato.
Una formula tralaticia vede ratio e fondamento della conversione nel principio di conservazione del
contratto.
Ma questo principio è neutro rispetto all’equa e razionale sistemazione degli interessi in gioco.
Se la regola serve a sistemare gli interessi delle parti secondo giustizia ed efficienza, meglio ancorarla
al principio di buona fede.
I soggettivisti riconducono la conversione alla volontà delle parti, e sia pure alla loro volontà ipotetica.
Gli oggettivisti spinti riducono la figura ad un automatismo di fonte legale.
Fondare la conversione sul principio di buona fede consente di sfuggire a queste posizioni estreme.
Il risultato della conversione non è predeterminato, sicché ci si può trovare a scegliere fra varie
possibili conversioni.
Il patto di non alienare, nullo per durata eccessiva, potrebbe convertirsi sia in un patto di non alienare
per durata più breve, sia – ferma la durata pattizia – in un patto di prelazione.
La conversione non è rilevabile d’ufficio: il 1424 dice che il contratto nullo “può produrre” i diversi
effetti della conversione, non che li produce senz’altro.
La tesi della conversione come frutto di volontà ipotetica invece può suggerire ch’essa presupponga
l’ignoranza delle parti circa la nullità.
Pure questa idea va respinta.
La consapevolezza delle parti di avere concluso un contratto nullo non esclude che, secondo buona
fede, possano e debbano restare fermi tra loro effetti contrattuali diversi da quelli programmati,
compatibili con l’originario programma comune.
Si afferma che la conversione è impossibile quando il contratto è (nullo perché) illecito.
Ciò può essere vero, ma non sempre.
La conversione va esclusa quando è illecito lo scopo perseguito dalle parti, come dire la causa od il
motivo comune del contratto.
Se il contratto è nullo perché una norma imperativa vieta di dedurvi la prestazione concordata, perché
escluderne la conversione in contratto per una prestazione rimodellata?
Va invece esclusa senz’altro la conversione di contratto inesistente.
Fenomeno diverso da quello del 1424 è la c.d. conversione formale, che si ha quando il contratto,
concluso in una forma cui difetti qualche requisito, vale come contratto concluso in una forma diversa,
i cui requisiti siano tutti presenti: se le parti contraggono per atto pubblico, e questo può non valere
come tale perché manca la sottoscrizione del notaio, il contratto (che sia almeno sottoscritto dalle parti)
si considera fatto per scrittura privata (2701).
Sfugge alla logica del 1424 anche la c.d. conversione legale, che ricorre quando – di fronte ad un
negozio nullo, o comunque incapace di produrre gli effetti programmati – è la legge stessa che dispone
la produzione di altri effetti, corrispondenti ad un diverso negozio.
Ad es. la girata cambiaria successiva al protesto vale come ordinaria cessione di credito; la concessione
di servitù da parte del singolo comproprietario del fondo vale come promessa obbligatoria di consentire
l’attività corrispondente alla servitù (1059.1).
CAPITOLO XXXIX – IL TRATTAMENTO DEI CONTRATTI INVALIDI: ALTRI PROFILI
La nullità può colpire il contratto come un tutt’uno, ma può anche colpire singole parti o clausole del
contratto.
La regola del 1419.1 è che la nullità di una parte del contratto determina la nullità dell’intero contratto
se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita
dalla nullità.
Il 1419.1 si basa sul principio della causa, e sulla buona fede contrattuale.
La nullità che cancella una parte del contratto altera l’equilibrio di questo, facendo sopravvivere un
contratto diverso da quello che le parti avevano concluso.
Questo diverso contratto potrebbe favorire una parte, e penalizzare l’altra, in modo ingiusto e contrario
a buona fede: la nullità totale, spazzando via anche il contratto residuo, è il rimedio capace di evitare un
risultato così indesiderabile.
Il confronto fra i due assetti contrattuali, ed il conseguente giudizio di compatibilità, va condotto su
elementi obiettivi.
La nullità totale non può essere rilevata d’ufficio dal giudice; la nullità totale può farsi valere solo dalla
parte colpita dallo squilibrio indotto dalla nullità parziale, e non dall’altra.
Provare i presupposti della nullità totale è onere della parte legittimata a far valere.
Il rimedio della nullità totale non è surrogabile da un adeguamento giudiziale del contratto residuo.
Ci si può invece domandare se non sia ipotizzabile un’offerta di riequilibrio ad opera della parte contro
cui si fa valere la nullità totale, in analogia alla rettifica del contratto annullabile per errore ed alla
riduzione ad equità del contratto rescindibile e risolubile.
Il rimedio del 1419.1 opera oltre i confini segnati dalla formulazione letterale della norma.
Può distruggere un intero contratto, in cui una clausola sia annullabile (e venga annullata).
Può distruggere un contratto in sé valido, collegato ad altro contratto nullo od annullato.
Il 1419.1 è messo fuori gioco in una serie di casi nei quali si valuta che la nullità di una parte del
contratto non debba implicarne la nullità totale.
Il caso principale è indicato dal 1419.2: la nullità di singole clausole non importa la nullità del
contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
L’esclusione della nullità totale dev’essere espressa: dichiarare nulla una clausola non significa dire che
è nulla solo la clausola, e che il resto del contratto vive: questo si decide in base al 1419.1.
Nei contratti plurilaterali l’invalidità può colpire la partecipazione di una singola parte.
Secondo gli artt. 1420 (per la nullità) e 1446 (per l’annullamento) in linea di principio le altre
partecipazioni si salvano; ma possono cadere anch’esse, quando la partecipazione viziata debba,
secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
La regola è riferita ai contratti plurilaterali con comunione di scopo: la categoria non va intesa come
limitata ai soli contratti associativi, bensì come comprensiva di tutti i contratti (anche non associativi)
in cui ciascuna parte ricavi una significativa convenienza dalla partecipazione delle altre.
Le differenze di trattamento fra contratti nulli ed annullabili si manifestano anche su un altro terreno:
modi di operare e conseguenze dell’invalidità.
Il modo di operare della nullità è automatico: dunque la sentenza che la pronuncia è dichiarativa,
perché si limita a riconoscere e dichiarare una situazione giuridica preesistente.
Il 1422 parla di azione per far dichiarare la nullità.
Ciò ha un’ulteriore conseguenza: la nullità opera retroattivamente.
La retroattività fra le parti azzera ex tunc i trasferimenti programmati col contratto; e soprattutto rende
oggettivamente indebite ex 2033, quindi ripetibili, le prestazioni eseguite in base ad esso.
Verso i terzi, distrugge gli acquisti che costoro abbiano compiuto contrattando con chi aveva a sua
volta acquistato in base a contratto nullo: anche se i terzi abbiano acquistato in buona fede, anche se i
terzi abbiano trascritto il loro acquisto prima della trascrizione della domanda di accertamento della
nullità.
Fra le parti, la ripetibilità delle prestazioni eseguite in base a contratto nullo è paralizzata in una serie di
casi.
Per iniziare, quando l’accipiens abbia nel frattempo usucapito; poi quando l’azione di ripetizione sia
prescritta.
Può essere poi paralizzata o almeno depotenziata, sostanzialmente se non formalmente, quando il
contratto si caratterizzi per la materiale irripetibilità della prestazione resa da una parte: dichiarata nulla
la locazione, il locatore deve restituire i canoni percepiti ma non può a sua volta riottenere il godimento
della cosa locata, definitivamente incamerato dal conduttore.
Egli può chiedere ex 2041 (Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è
tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione
patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha
ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda) il valore di cui il
conduttore s’è ingiustamente arricchito godendo della cosa sine titulo.
Ma il caso principale è quello del contratto nullo perché contrario al buon costume: a norma del 2035,
la parte che lo esegue condividendo l’immoralità (per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca
offesa al buon costume) non può ripetere quanto prestato.
Quanto ai terzi subacquirenti, anch’essi possono salvare il loro acquisto grazie all’usucapione; oppure,
se abbiano acquistato in buona fede un mobile non registrato, in virtù della regola “possesso vale titolo”
(1153); o, in caso di acquisto immobiliare, col meccanismo della trascrizione sanante, alle condizioni
del 2652, n. 6.
Inoltre: nel caso di danno causato da aeromobile sulla superficie, il terzo danneggiato ha azione diretta
contro l’assicuratore, che non può opporgli alcuna causa di nullità del contratto avente effetto
retroattivo (1015 c.n.).
In linea di principio l’annullabilità non opera in modo automatico, ma solo per effetto di sentenza che,
annullando il contratto (sentenza costitutiva), ne rimuova gli effetti.
L’annullamento è retroattivo fra le parti: di regola obbliga dunque le parti a restituire, per il principio
dell’indebito oggettivo (2033: Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che
ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto
era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.), le prestazioni già
eseguite in base al contratto poi annullato.
Invece, di regola, l’annullamento non retroagisce nei confronti dei terzi: i quali perciò salvano gli
acquisti fatti contrattando con chi aveva in precedenza acquistato in base al contratto annullato.
La regola della ripetibilità, fra le parti, delle prestazioni eseguite in base al contratto annullato trova
deroga quando l’annullamento sia dipeso da incapacità di agire (legale od anche naturale): l’incapace
non è tenuto a restituire la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio
(1443).
Appare preferibile l’interpretazione secondo la quale l’irripetibilità non scatti comunque a favore della
parte per la cui incapacità il contratto è annullato, anche se la prestazione le viene fatta dopo il recupero
della capacità ma scatti solo se l’incapace è ancora tale nel momento in cui riceve la prestazione.
Il 1445 indica tre casi in cui l’annullamento è opponibile ai terzi: quando il terzo abbia acquistato in
mala fede (cioè sapendo che il titolo del suo dante causa è annullabile); quando l’annullamento del
contratto a monte dipenda da incapacità legale; quando il terzo abbia acquistato a titolo gratuito.
Lo stesso 1445 fa però salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento, indicati dal
2652, n. 6.
Questa norma esclude che il meccanismo della trascrizione possa giovare ai terzi acquirenti in mala
fede.
Quanto ai terzi acquirenti in buona fede, l’annullamento gli è comunque opponibile se la relativa
domanda è trascritta prima che essi trascrivano il loro acquisto.
Se invece la trascrizione dell’acquisto del terzo è anteriore alla trascrizione della domanda di
annullamento, il regime dell’opponibilità dipende dalla causa di annullamento.
Se l’annullamento dipende da qualsiasi causa diversa dall’incapacità legale, esso è opponibile al terzo
acquirente a titolo gratuito, ed inopponibile se l’acquisto del terzo è oneroso.
Ove dipenda invece da incapacità legale, l’annullamento è opponibile solo se la domanda risulti
trascritta entro 5 anni dalla trascrizione dell’atto annullabile, mentre resta inopponibile se la
trascrizione della domanda giudiziale intervenga dopo il quinquennio.
Non è vero che il contratto nullo sia radicalmente improduttivo di effetti: è vero invece che esso può
produrre alcuni effetti (anche al di là di quelli fiscali, comunque legati alla conclusione del contratto).
Ed è alla luce di questi effetti del contratto nullo che si apprezza la sua distinzione dal contratto
inesistente (questo sì improduttivo di qualsiasi effetto).
In generale, il contratto nullo: produce gli effetti del contratto in cui si converta (1424); in quanto sia
nullo per immoralità, e sia stato eseguito, produce l’effetto di rendere irripetibili le prestazioni fatte
(2035); in quanto risulti trascritto almeno 5 anni prima della trascrizione della domanda di nullità,
produce l’effetto di rendere inattaccabile il diritto del terzo subacquirente (2652, n. 6).
Inoltre, il contratto affetto da nullità relativa produce l’effetto di vincolare al suo regolamento la parte
diversa dalla parte protetta, in quanto questa non s’avvalga della nullità.
Per converso, non è vero che il contratto annullabile sia, prima della sentenza di annullamento,
pienamente produttivo di effetti.
Esso è senz’altro efficace contro la parte non protetta, la quale non può respingerne gli effetti, che la
parte protetta intenda far valere.
Di contro, non produce l’effetto di vincolare la parte protetta, che non desideri essere vincolata.
Il contratto nullo e quello annullabile non sono dunque fattispecie nettamente differenziate: è realistico
leggere la serie delle tante, diverse figure di contratto invalido come un continuum di fattispecie non
radicalmente separate e contrapposte, ma contigue e parzialmente sovrapposte.
E identificare il filo in un elemento che può chiamarsi la forza di titolo del contratto invalido.
Questo elemento accomuna tutte le fattispecie d’invalidità, posto che in tutte si registra una
minorazione della forza di titolo del contratto invalido; ed al tempo stesso le differenzia fra loro, in
ragione del diverso grado della minorazione.
La conclusione di un contratto invalido può generare responsabilità precontrattuale ex 1338.
Gli elementi costitutivi della responsabilità ex 1338 sono tre: la conclusione di un contratto invalido; la
colpa di una parte nell’avere determinato la conclusione del contratto invalido; l’affidamento
incolpevole dell’altra parte nella validità del contratto.
La giurisprudenza esclude dall’area della risarcibilità le fattispecie di contratto invalido per violazione
di norme imperative, argomentando che l’ignoranza di esse – per definizione colpevole – non dà luogo
ad affidamenti meritevoli di protezione.
Si discute dell’applicabilità del 1338 al caso di contratto del minore.
Per lo più il minore riceve il massimo di protezione: è legittimato all’annullamento, ed esonerato dal
risponderne.
Ma altre volte è trattato con severità: se raggira controparte spacciandosi per maggiorenne perde il
diritto all’annullamento (1426).
Il problema non si pone per il contratto dell’incapace naturale: l’annullabilità implica la mala fede di
controparte, che a sua volta ne esclude l’affidamento incolpevole.
Nel campo dei contratti invalidi per vizi della volontà, conviene distinguere a seconda che il vizio
origini nella sfera della parte protetta (errore), ovvero nella sfera di controparte (dolo, violenza).
In questi ultimi casi, la vittima ha diritto non solo all’annullamento, ma anche al risarcimento.
La scorrettezza che qui si sanziona non è il tacere la causa d’invalidità, ma il determinarla.
La logica del 1338 torna in campo nei casi di errore spontaneo.
Se il contratto è annullabile, vuol dire che l’errore è riconoscibile od addirittura riconosciuto dalla parte
non in errore: può allora ipotizzarsi una responsabilità di questa.
Ma la sua responsabilità può ipotizzarsi anche in caso di contratto valido: quando l’errore, pur
determinante del consenso, non è essenziale, ed è riconoscibile o riconosciuto da lei.
Peraltro, il risarcimento va escluso quando l’errore sia inescusabile, e così rimonti a colpa della vittima.
L’errore colpevole non genera invece responsabilità di questa: o l’errore non è riconoscibile né
riconosciuto dalla parte non in errore, ed allora la validità del contratto esclude ogni suo danno; oppure
è riconoscibile o riconosciuto, ed allora manca l’affidamento incolpevole.
Quando l’invalidità è invocabile da una parte, deve tenersi conto dell’iniziativa di questa: essa ha diritto
alla minor somma fra quella che rappresenta il danno da esecuzione e quella che esprime il danno da
cancellazione del contratto.
CAPITOLO XL – LA RESCISSIONE
La rescissione (1447 ss.) è rimedio applicabile ai contratti che risultano difettosi per determinati
elementi anomali o riprovevoli, presenti in essi.
Gli elementi sono tre: il primo è l’anomala condizione soggettiva che spinge una parte al contatto: uno
stato di pericolo, oppure uno stato di bisogno: in questo senso la rescissione, che permette al contraente
di cancellare il contratto subito e non desiderato, è rimedio contro le minorazioni della libertà
contrattuale.
Il secondo elemento riguarda il contenuto oggettivo del contratto: è la sua ingiustizia rispetto ai valori
di mercato, lo squilibrio fra la prestazione data e la prestazione ricevuta: in questo senso, la rescissione
è rimedio contro l’inadeguatezza dello scambio contrattuale.
Il terzo dato è l’atteggiamento soggettivo dell’altra parte, che sfrutta l’inferiorità di chi si trova in stato
di pericolo o di bisogno: in questo senso, la rescissione è rimedio contro l’approfittamento della
debolezza contrattuale altrui.
La rescissione scatta solo se ricorrono insieme i tre requisiti, che insieme la giustificano.
Non scatta, se anche un solo requisito manca.
I fattori di pressione contro cui può attivarsi il rimedio della rescissione sono due: lo stato di pericolo e
lo stato di bisogno.
Lo stato di pericolo della parte è, più precisamente, la necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale
di un danno grave alla persona.
Dev’esserci un nesso di causalità fra il pericolo ed il contratto: occorre che questo sia concluso come
strumento per neutralizzare il pericolo.
Il pericolo deve minacciare la persona, indifferentemente della parte o di terzi: non è rescindibile ex
1447 il contratto concluso per salvare valori patrimoniali (il pericolo di danno al patrimonio potrebbe se
mai integrare stato di bisogno ex 1448).
È irrilevante che il pericolo non sia stato volontariamente causato da chi lo subisce, e così pure che non
sia altrimenti evitabile, come invece si richiede per lo stato di necessità esimente da responsabilità
aquiliana (2045).
Il pericolo deve però essere attuale: ciò esclude che un pericolo solo putativo giustifichi la rescissione
(ma non che il profittatore si esponga a responsabilità precontrattuale ex 1337).
Il secondo requisito è che il contratto sia stato concluso a condizioni inique per la parte esposta al
pericolo.
La norma parla solo di obbligazioni assunte a tali condizioni: ma va ragionevolmente riferita ad ogni
altro genere di prestazione contrattuale (trasferimento o costituzione di diritti, rinuncia a diritti).
L’iniquità delle condizioni è tendenzialmente lo squilibrio fra i valori economici scambiati: squilibrio
non predeterminato in una misura legale, come avviene con la rescissione per lesione, ma rimesso a
valutazioni che il giudice deve compiere caso per caso, tenendo conto delle circostanze concrete.
L’iniquità potrà però risultare anche da elementi contrattuali non monetizzabili (termini troppo lunghi,
altre condizioni normative troppo pesanti).
Occorre infine la mala fede dell’altra parte, cioè che questa sappia di contrattare con una persona che
negozia per sfuggire al pericolo.
Il 1448 (Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è
dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la
parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L’azione non è ammissibile se la
lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata
aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
Sono
salve
le
disposizioni relative alla rescissione della divisione.) regola quella che la sua rubrica chiama azione
generale di rescissione per lesione, configurando così i tre requisiti del rimedio: stato di bisogno del
contraente leso; lesione ultra dimidium; approfittamento dell’altra parte.
La norma implica un bisogno qualificato da un elemento oggettivo, socialmente apprezzabile: il
bisogno di qualcosa che serva ad evitare un significativo pregiudizio, cui in mancanza la parte sarebbe
esposta.
Il 1447 (Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità,
nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può
essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la
rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera
prestata.) implica un pregiudizio puntualmente qualificato tramite il doppio requisito dell’esser grave e
rivolto alla persona.
Il pregiudizio del 1448 si determina in via residuale, per differenza: è il pregiudizio diretto non contro
la persona, ma contro il patrimonio; è il pregiudizio rivolto contro la persona, ma non “grave” come
richiesto dal 1447.
Quando il bisogno implica un pregiudizio patrimoniale, questo normalmente si configura come danno
emergente, ma non è escluso che possa presentarsi anche come lucro cessante.
Non importa che lo stato di bisogno sia imputabile al contraente leso, cadutovi volontariamente o per
colpa.
Quando il contratto lesivo è concluso da un rappresentante, lo stato di bisogno deve valutarsi riguardo
al rappresentato.
Si ripete che il bisogno può anche non essere del contraente ma di un terzo.
È meglio dire che il bisogno del terzo deve diventare – mediatamente, in qualche misura – bisogno del
contraente, in ragione di legami affettivi o d’interesse che leghino i due soggetti.
La lesione consiste nella sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra (1448.1).
Non però una sproporzione qualunque, ma una sproporzione corrispondente ad un preciso parametro
quantitativo, fissato dalla legge: più della metà (ultra dimidium).
La sproporzione deve valutarsi in base a valori oggettivi e non soggettivi: dunque non si tiene conto del
plusvalore d’affezione che il bene abbia per chi lo vende.
Valori oggettivi significa valori di mercato.
Il mercato rilevante ex 1448 è quello del tempo e del luogo in cui concretamente le parti hanno
contrattato.
Il calcolo del valore delle prestazioni deve tener conto di tutti gli elementi accessori, monetizzabili
ancorché non direttamente monetizzati in contratto: al valore del bene in sé considerato deve
aggiungersi il valore del servizio di manutenzione cui il fornitore si sia impegnato; il valore del prezzo
va depurato del beneficio finanziario che il compratore riceva da una lunga dilazione di pagamento.
I valori da confrontare sono i valori che le prestazioni hanno al tempo del contratto (1448.2).
Peraltro, la lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta (1448.3).
Prevale la tesi secondo la quale per bloccare la rescissione occorre che si ripristini il pieno equilibrio fra
i valori delle prestazioni, e non basta un recupero che porti lo squilibrio sotto la soglia della metà.
Il terzo requisito della rescissione per lesione è espresso col dire che dello stato di bisogno della parte
lesa, l’altra ha approfittato per trarne vantaggio (1448.1).
In passato si esigeva un qualche comportamento attivo della parte avvantaggiata, ma da tempo tutto ciò
che si richiede è, in definitiva, che controparte sia consapevole della lesione e dello stato di bisogno che
la determina.
Di più: anche questo requisito conoscitivo finisce per dissolversi, nel momento in cui si afferma che
può ricavarsi presuntivamente dal fatto obiettivo della lesione.
La rescissione è rimedio a protezione della parte lesa: dunque può farsi valere – in via di azione, o di
eccezione – solo da questa parte; e non è rilevabile d’ufficio.
Il rimedio è soggetto ad un termine di prescrizione molto breve: un anno dalla conclusione del contratto
(1449.1).
Inoltre, a differenza di quanto vale per il contratto annullabile, l’eccezione non sopravvive alla
prescrizione dell’azione (1449.2).
La legge (1449.1) dice che se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’art. 2947: ovvero,
si applica anche all’azione civile la più lunga prescrizione disposta per il reato (che sarà essenzialmente
il reato di usura).
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere (2935).
La prescrizione s’interrompe con l’esercizio dell’azione, e non con la semplice costituzione in mora.
Ma s’interrompe anche col riconoscimento del controinteressato.
La sentenza di rescissione è costitutiva: rimuove gli effetti del contratto.
Fra le parti, obbliga alle restituzioni delle prestazioni di dare, secondo la disciplina dell’indebito
oggettivo.
Le prestazioni di fare, sottratte al regime della ripetizione, ricadono sotto quello dell’arricchimento
(2041).
Tuttavia, nel caso di rescissione di contratto concluso in stato di pericolo, la legge definisce ciò cui può
aspirare la parte che ha reso il servizio facendoselo remunerare a condizioni inique: non la minor
somma fra il proprio impoverimento e l’arricchimento di chi ha ricevuto il servizio, ma un equo
compenso per l’opera prestata (1447.2).
Inoltre essa non vi ha senz’altro diritto: secondo le circostanze il giudice può riconoscerlo, ma anche
negarlo.
Dei terzi si occupa il 1452 (La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi,
salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione).
La rescissione non gli è opponibile e non pregiudica i diritti acquistati da essi.
Se però sono in gioco immobili e mobili registrati, comandano le regole sulla trascrizione: il terzo è
pregiudicato, se il suo acquisto risulta trascritto dopo la trascrizione della domanda di rescissione (2652
n.1; 2690 n. 1).
Il contratto rescindibile non può essere convalidato (1451); il divieto di convalida non esclude però
un’altra forma di recupero: la riduzione ad equità ex 1450.
È discussa l’ammissibilità della transazione su contratto rescindibile.
Il contratto rescindibile non è soggetto a convalida, ma è recuperabile con un meccanismo diverso che
ne implica la modifica, detto riduzione ad equità: il contraente contro il quale è domandata la
rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo a equità
(1450).
L’offerta di riduzione ad equità è un diritto che spetta solo alla parte profittatrice.
Di fronte ad un’offerta adeguata della parte profittatrice, la parte lesa non ha il potere di respingerne gli
effetti, consistenti nel rendere il contratto non più rescindibile, e di conformare il rapporto contrattuale
sul contenuto dell’offerta.
Per essere adeguata, l’offerta deve ricondurre il contratto ad equità, e cioè deve ristabilire l’equivalenza
delle prestazioni sproporzionate.
L’adeguatezza del riequilibrio offerto va calcolata sui valori attuali: dunque con riferimento al tempo
dell’offerta.
La parte lesa, destinataria dell’offerta extraprocessuale, può rispondere che vi aderisce: l’atto vale come
riconoscimento dell’adeguatezza dell’offerta; o, in alternativa, come accettazione dell’offerta
nonostante la sua obiettiva inadeguatezza.
Se di fronte all’offerta la parte lesa non risponde, o risponde che la rifiuta perché la trova inadeguata, i
casi sono due: o l’offerta è obiettivamente adeguata, ed allora produce l’effetto di rendere il contratto
non più rescindibile e di conformare il rapporto contrattuale ai contenuti dell’offerta; oppure è
inadeguata, ed allora è inefficace, lasciando il contratto rescindibile.
Se sul punto si apre lite, decide il giudice con sentenza dichiarativa.
Una variante è che la parte legittimata, anziché formulare direttamente l’offerta, rimetta al giudice la
sua determinazione.
Nella misura in cui ciò si ritenga ammissibile, la pronuncia assume allora natura costitutiva.
Potrà essere impugnata dalla parte insoddisfatta, per difformità dai criteri del 1450.
L’area di applicazione del rimedio è variamente limitata.
Il limite più rilevante riguarderebbe la rescissione per lesione, che il 1448.4 dice inapplicabile ai
contratti aleatori.
Anche un contratto aleatorio è rescindibile quando la lesione risulta ex ante, come sproporzione fra la
misura della prestazione a carico del contraente in stato di bisogno e la misura del rischio dedotto in
contratto.
Parrebbe ovvio escludere la rescindibilità dei contratti gratuiti, ma il rimedio può recuperarsi nel quadro
di un collegamento negoziale.
Per la transazione la deroga opera in modo restrittivo, anzi preclusivo: il rimedio è escluso (1970).
Invece per la divisione cade il requisito soggettivo del bisogno; e si attenua quello oggettivo della
lesione, che rileva se solo eccede la misura di un quarto (763.1).
La fattispecie del contratto rescindibile interferisce col fenomeno dell’usura, per cui taluno si fa dare o
promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi od altri vantaggi
usurari (644.1 c.p.).
La legge sull’usura (108/1996) prefigura un parametro numerico, in relazione al quale accertare il
carattere usurario degli interessi o degli altri vantaggi pattuiti: il c.d. tasso soglia, fissato
periodicamente dall’autorità monetaria.
Ciò premesso, occorre distinguere a seconda che il contratto usurario sia un mutuo od un altro
contratto.
Se nel mutuo sono pattuiti interessi usurari, la disciplina è quella del 1815.2, che mette fuori gioco gli
articoli 1447 e seguenti: la clausola sugli interessi è nulla, e non rescindibile (a prescindere dallo stato
di pericolo o di bisogno del mutuatario): più che un riequilibrio a favore della vittima, si persegue così
una sanzione a carico dell’usuraio.
Quando il contratto usurario è diverso dal mutuo, si fa problematico il rapporto fra rimedio civile della
rescissione e regime penale dell’usura.
La fattispecie penale non presuppone lo stato di bisogno della vittima: lo stato di bisogno costituisce
solo un’aggravante (644.5 n. 3 c.p.).
Se il reato di usura integra anche gli estremi della rescissione, il contratto è rescindibile.
Ma può anche accadere che la fattispecie costituisca reato di usura, senza integrare gli estremi della
rescissione.
Potrebbe dirsi che tutti i contratti integranti reato di usura sono nulli, e non mai rescindibili: ma ciò
equivarrebbe in pratica ad abrogare il rimedio della rescissione.
CAPITOLO XLI - REGOLAZIONE DEL MERCATO
E PROTEZIONE DEI CONTRAENTI DEBOLI
I contratti sono un fattore che costituisce e definisce il mercato, inteso come luogo in cui si scambiano
beni e servizi economici.
Da tempo, nelle società evolute, la regolazione del mercato è un compito primario del legislatore.
Gli obiettivi di questa regolazione sono essenzialmente due, fra loro connessi: giustizia ed efficienza.
Si regolano i rapporti contrattuali delle imprese e dei consumatori tenendo conto, prima di tutto, che
sono spesso rapporti fra parti con potere economico diverso, sicché all’interno di essi un contraente
forte ha la possibilità di prevaricare un contraente debole.
Al tempo stesso, impedire le prevaricazioni dei contraenti forti sui deboli consente di selezionare fra
imprese più efficienti ed imprese meno efficienti: significa far prevalere sul mercato le imprese che per
il loro successo puntano non sull’abuso di posizioni dominanti ma sul miglioramento della qualità e sul
contenimento dei prezzi.
La regolazione dei contratti delle imprese e dei consumatori si realizza, essenzialmente, con una certa
disciplina di rimedi contrattuali.
La standardizzazione dei beni e dei servizi porta seco la standardizzazione dei relativi contratti.
Il fenomeno della standardizzazione implica gli ulteriori fenomeni della predisposizione unilaterale e
dell’adesione.
Il testo del contratto non esce da una trattativa col cliente, ma viene elaborato dalla stessa impresa
interessata, od anche dall’organizzazione di categoria delle imprese di un certo settore, che lo mette a
disposizione delle imprese associate, ciascuna delle quali lo usa poi nei rapporti coi propri clienti (ad
es. le banche abitualmente impiegano, per la prestazione dei servizi bancari, contratti standard
predisposti dall’Abi; le imprese assicuratrici polizze standard predisposte dall’Ania; etc.).
Il cliente può solo aderire al contratto standard.
L’impresa che predispone il testo o comunque usa un testo già predisposto si chiama predisponente; il
cliente che aderisce al testo predisposto da altri si chiama aderente.
Il contratto concluso in tal modo si chiama anche contratto per adesione.
Le condizioni generali predisposte sono efficaci nei confronti dell’aderente se al momento della
conclusione del contratto questi le ha conosciute od avrebbe dovuto conoscerle secondo l’ordinaria
diligenza (1341.1).
Il predisponente interessato a che gli aderenti siano vincolati alle sue condizioni generali ha perciò un
onere multiplo: dare chiara notizia della loro esistenza; renderle facilmente disponibili agli aderenti;
scriverle in termini comprensibili per un cliente medio.
Tutto questo con riferimento al tempo del contratto, e non ad un momento successivo: non vincolano
l’aderente le condizioni che egli può conoscere solo dopo la conclusione del contratto, ad es. perché
scritte sulla fattura.
Il 1341.1 non si applica quando le condizioni standard siano diventate, per il loro impiego generalizzato
e costante, clausole d’uso ex 1340 (Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta
che non sono state volute dalle parti): in tal caso entrano in contratto per integrazione legale, anche se
non conoscibili dall’aderente con l’ordinaria diligenza.
La più significativa tutela dell’aderente riguarda alcune particolari clausole, dette onerose: perché
vincolino l’aderente, non basta che siano da lui conosciute o conoscibili, occorre un requisito di forma,
e cioè che egli le abbia specificamente approvate per iscritto (1341.2).
Le clausole onerose aggravano la posizione contrattuale dell’aderente, privandolo di diritti o poteri che
egli avrebbe in base alla disciplina comune del rapporto contrattuale, od imponendogli obblighi o
soggezioni che in base a quella disciplina egli non avrebbe.
L’elenco delle clausole onerose è tassativo e non allargabile per analogia, sicché non può applicarsi il
requisito di forma a clausole che non vi sono comprese, solo perché gravose per l’aderente: si esclude,
ad es., che possa trattarsi come onerosa la clausola penale.
Peraltro, s’ammette l’interpretazione estensiva delle formule che indicano le singole clausole
dell’elenco.
L’onerosità non è purgata solo perché la clausola si presenta con effetti simmetricamente bilaterali.
Figura in elenco la clausola di recesso del predisponente: è pur sempre onerosa la clausola che,
prevedendo il recesso del predisponente, dà analogo potere all’aderente.
La sola firma dell’aderente in calce al testo del contratto contenente le condizioni generali non basta,
perché l’approvazione sarebbe generica e non specifica: occorre un’ulteriore sottoscrizione riferita
specificamente alle clausole onerose.
Non è necessaria una firma per ogni clausola; basta firmare un’unica dichiarazione con cui si
approvano le clausole onerose, richiamate col numero che assumono nel testo del contratto (tesi meno
rigorosa) o col richiamo numerico integrato da sintetica indicazione del loro contenuto (tesi più
rigorosa).
Il requisito del 1341.2 (In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per
iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di
responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a
carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole
compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria) si aggiunge a quello del 1341.1
(Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti
dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto
conoscerle usando l’ordinaria diligenza), ma non lo elimina: una clausola onerosa, anche approvata per
iscritto nel modo visto, non vincola l’aderente se da lui non conoscibile con l’ordinaria diligenza (ad es.
perché il suo tecnicismo la rende incomprensibile al cliente medio).
La clausola standard onerosa senza specifica approvazione scritta non vincola l’aderente.
Qualificazione e regime della clausola sono controversi.
Un punto condiviso in dottrina è l’inapplicabilità del 1419.1: nell’interesse dell’aderente l’inoperatività
delle clausole onerose non dovrebbe mai travolgere il contratto, che resta in vita senza le clausole (al
posto delle quali si applica la disciplina dispositiva di legge).
È escluso che clausole onerose non approvate possano entrare in contratto come clausole d’uso ex
1340.
Nel definire l’ambito coperto dal 1341.2, si afferma che il requisito non opera quando la clausola
onerosa sia stata negoziata con l’aderente; non è certo che possa dirsi lo stesso in altri casi: quelli di
clausole onerose contenute in condizioni standard negoziate fra contrapposte associazioni di categoria,
od in testi contrattuali stipulati per atto di notaio, od in atti al limite fra il contrattuale ed il normativo
(statuti di organizzazioni, regolamenti condominiali).
In passato la giurisprudenza sottraeva al 1341.2 le condizioni generali contenute in testi contrattuali
predisposti dalla pubblica amministrazione, col debolissimo argomento della presunzione di legittimità
e correttezza dell’operato dei soggetti pubblici.
Ai contratti standard il 1370 dedica una regola d’interpretazione oggettiva: in caso di dubbio sul
significato, le condizioni generali s’interpretano contro il predisponente (contra stipulatorem), e cioè
nel senso più favorevole all’aderente.
Altre regole riguardano il caso in cui le condizioni generali predisposte sono incorporate nei moduli e
formulari usati come documenti contrattuali, anziché essere scritte su supporti esterni al documento
contrattuale.
Si applicano allora tutte le regole viste sopra, con gli opportuni aggiustamenti.
Il 1342.1 introduce poi un’altra regola: le clausole aggiunte al modulo o formulario, ed incompatibili
con le clausole di questo, prevalgono sulle clausole originarie anche se queste non vengono cancellate.
Il 1342.2 dice che ai contratti conclusi con moduli o formulari si applica il 1341.2 (specifica
approvazione scritta delle clausole onerose).
Quella del 1341 è una protezione formale e non sostanziale: non impedisce che nei contratti predisposti
entrino clausole svantaggiose per gli aderenti, parte debole del rapporto.
Per effetto della direttiva europea 93/13, le clausole unilateralmente predisposte che, per il loro
contenuto, aggravano in modo notevole la posizione dell’aderente, sono senz’altro non vincolanti per
l’aderente stesso, a prescindere da qualsiasi dato formale.
Il 1341 copre qualsiasi contratto standard fra qualsiasi predisponente e qualsiasi aderente; invece la
nuova disciplina copre solo i contratti in cui aderente sia un consumatore, e predisponente un
professionista (1469-bis).
Le due figure sono definite dal 1469-bis comma II: il professionista è la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto
predisposto.
Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta.
Ci si domanda se la disciplina si applichi solo ai contratti di cui sia parte fin dall’origine un
consumatore, od anche a quelli che, conclusi da un professionista, finiscano in capo ad un consumatore
come terzo beneficiario della posizione contrattuale, o per effetto di successiva circolazione della
posizione contrattuale.
Va preferita la tesi più larga: gli artt. 1469-bis e seguenti proteggono il consumatore come parte di un
rapporto contrattuale, e non come semplice autore di un atto.
Il 1341 riguarda solo i contratti standard, invece la nuova disciplina si applica anche ai contratti
predisposti per un singolo affare con un singolo cliente (purché predisposti unilateralmente dal
professionista, e non negoziati col cliente).
Il 1469-bis definisce vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Questa definizione dà i criteri generali della vessatorietà: il significativo squilibrio, e la contrarietà a
buona fede (oggettiva).
La clausola crea squilibrio quando modifica, a danno del consumatore, le reciproche posizioni
contrattuali delle parti come definite dal diritto dispositivo.
Non basta un qualunque squilibrio, ma occorre uno squilibrio significativo: misura da rimettere caso
per caso alla prudente discrezionalità del giudicante.
La legge offre poi all’interprete altri criteri complementari.
Due sono criteri negativi (1469-ter comma II).
La vessatorietà non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, e non riguarda l’adeguatezza
del corrispettivo dei beni e dei servizi.
Il 1469-ter comma I indica poi, in positivo, altri tre criteri da applicarsi nel giudizio di vessatorietà.
L’interprete deve tenere conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto; inoltre deve
fare riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto; infine deve
considerare le altre clausole del contratto o di un altro collegato o da cui dipende.
Il 1469-bis comma III indica una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria.
Possono convenzionalmente classificarsi in due categorie: clausole di sbilanciamento e clausole di
sorpresa.
Nelle clausole di sbilanciamento il significativo squilibrio si manifesta come asimmetria delle posizioni
sostanziali o processuali delle parti: esse prevedono determinati pesi o limiti a carico del consumatore e
non anche del professionista, o determinati vantaggi od agevolazioni per il professionista e non anche
per il consumatore.
Lo sbilanciamento può consistere in un aggravamento delle responsabilità del consumatore; in un
alleggerimento delle responsabilità del professionista; in una minorazione delle possibilità del
consumatore di far valere pretese contro il professionista o difendersi dalle di lui pretese.
Qui il valore perseguito è l’uguaglianza fra le parti, o meglio la reciprocità.
Nelle clausole di sorpresa, lo squilibrio si manifesta in ciò, che il consumatore è esposto a subire –
dopo la conclusione del contratto – situazioni contrattuali imprevedibilmente diverse da quelle che,
secondo ragionevolezza, egli poteva attendersi.
La sorpresa può riguardare la formazione o la permanenza del vincolo contrattuale; il contenuto del
regolamento contrattuale; l’identità di controparte.
La presunzione è relativa, perché fa espressamente salva la prova contraria: è dunque possibile che una
clausola dell’elenco sia giudicata non vessatoria (ciò qualifica l’elenco del 1469-bis comma III come
lista “grigia”).
Per converso, può esser giudicata vessatoria, in base al criterio generale, una clausola estranea
all’elenco.
Una clausola può presentare gli elementi costitutivi della vessatorietà, e tuttavia non essere vessatoria,
per la presenza di elementi impeditivi della vessatorietà.
Il primo è la coincidenza fra contenuto della clausola e contenuto di certi atti normativi: leggi e
convenzioni internazionali (1469-ter comma III).
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge.
Il secondo fattore impeditivo è la trattativa sulla clausola: non sono vessatorie le clausole oggetto di
trattativa individuale (1469-ter comma IV).
L’onere della prova grava sul professionista: per salvare la clausola, spetta a lui dimostrare che la
clausola contestata ha formato oggetto di trattativa col consumatore.
La regola probatoria è esplicitata dal 1469-ter comma V: ma si ricaverebbe comunque dal rilievo che la
prova di elementi impeditivi della pretesa (qui, della pretesa alla declaratoria di vessatorietà) è prova di
un’eccezione, il cui onere grava sulla parte contro cui la pretesa è rivolta ex 2697.2. (il 2697, per intero,
recita che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o
estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.).
La regola per cui la trattativa esclude la vessatorietà della clausola negoziata non vale per le clausole
numero 1 (clausole che hanno per oggetto o per effetto di escludere o limitare la responsabilità del
professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da
un’omissione del professionista), 2 (clausole che hanno per oggetto o per effetto di escludere o limitare
le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista) e 10 (clausole
che hanno per oggetto o per effetto di prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole
che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto) dell’elenco,
reputate particolarmente pesanti per il consumatore (1469-quinquies comma II).
Le clausole vessatorie sono inefficaci (1469-quinques comma I).
La c.d. inefficacia delle clausole vessatorie va sostanzialmente considerata e trattata come una nullità.
L’inefficacia (nullità) delle clausole vessatorie è solo parziale: le clausole vessatorie cadono dal
contratto, o comunque non vincolano il consumatore, ma il contratto rimane efficace per il resto (1469quinquies comma I).
L’inefficacia (nullità) delle clausole vessatorie è relativa: opera soltanto a vantaggio del consumatore
(1469-quinquies comma III).
La regola va letta come una regola di legittimazione: solo la parte protetta può prendere l’iniziativa di
far valere il rimedio, in base all’autonoma valutazione del proprio interesse; inoltre l’inefficacia può
essere rilevata d’ufficio dal giudice (1469-quinquies comma III).
La previsione va coordinata con la natura di un rimedio nell’interesse si parte; quindi il giudice,
chiamato a decidere su pretese del professionista fondate sulla clausola vessatoria, può respingerle
rilevandone l’inefficacia ancorché non eccepita dal consumatore; ma di fronte ad una domanda del
consumatore fondata sulla clausola, non può farlo.
Altri problemi di trattamento delle clausole vessatorie, non affrontati esplicitamente dalle norme, vanno
risolti richiamandosi al regime della nullità: la clausola vessatoria non è convalidabile, il rimedio nei
loro confronti può farsi valere senza limiti di prescrizione.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza
della declaratoria d’inefficacia delle clausole (1469-quinquies comma IV).
Le clausole predisposte per iscritto dal professionista devono sempre essere redatte in modo chiaro e
comprensibile (1469-quater comma I).
Il 1469-ter comma II dispone che la vessatorietà non può dipendere né dall’oggetto del contratto né dal
prezzo, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore
(1469-quater comma II): è il canone d’interpretazione contro il predisponente, già dettato dal 1370 per
le condizioni generali di contratto.
Differenza dei rispettivi campi d’applicazione: il 1469-quater comma II si applica anche ai contratti di
adesione predisposti per un singolo affare, ma non ai contratti di cui non sia parte un consumatore: il
1370 si applica anche ai contratti fra operatori economici, purché predisposti per una serie indefinita di
rapporti.
L’inefficacia delle clausole vessatorie è rimedio individuale e successivo: successivo perché interviene
su clausole vessatorie contenute in contratti già conclusi; individuale perché interviene sul singolo
contratto fra singolo consumatore e singolo professionista, cui si riferisce il singolo giudizio: questo
opera solo inter partes.
Ma contro le clausole vessatorie è disponibile anche un rimedio giudiziale collettivo e preventivo:
l’azione inibitoria (1469-sexies).
Il rimedio può essere azionato dalle associazioni rappresentative di consumatori, o dalle Camere di
commercio.
Si rivolge contro un professionista od un’associazione di professionisti che utilizzino condizioni
generali di contratto nei rapporti coi consumatori.
Punta a far accertare dal giudice l’eventuale vessatorietà delle clausole che vi sono contenute.
Accertata la vessatorietà, il giudice emana un provvedimento che inibisce l’uso delle clausole, cioè
proibisce di inserirle nei futuri contratti fra professionisti e consumatori; il provvedimento può essere
concesso anche in via cautelare, quando ricorrono giusti motivi di urgenza.
La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori rende più generale una
tendenza alla protezione contrattuale dei consumatori, già presente in leggi speciali relative a singoli
settori di mercato.
Specifiche norme sono state emanate in materia di: contratti bancari e di credito al consumo; contratti
finanziari; contratti turistici; acquisti in multiproprietà; contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
contratti a distanza.
Le norme del d.lgs. 50/1992 si applicano ai contratti fra operatori economici e consumatori, i quali
siano stati negoziati fuori dei locali commerciali: quindi a casa del consumatore, o nel luogo di lavoro,
studio, vacanza, cura, o nel corso di un’escursione organizzata dall’operatore, od in uno spazio
pubblico, o per corrispondenza in base a catalogo fornito dall’operatore, od infine sulla base di offerte
televisive.
Esse proteggono il consumatore, consentendogli (entro 7 giorni) di pentirsi e cancellare l’acquisto
mediante recesso unilaterale dal contratto concluso: con conseguente restituzione del bene o rinuncia al
servizio, e liberazione dall’obbligo di pagare il prezzo, o recupero di quanto già pagato.
L’impresa, nel momento in cui avvia la trattativa col consumatore, deve informarlo del suo diritto di
recesso dal contratto che eventualmente concluderà.
Concluso il contratto, il consumatore che voglia recedere deve comunicarlo all’operatore entro 7 giorni
(che salgono a 60 in mancanza dell’informazione di cui sopra).
L’unico fattore che può impedire il recesso è la già avvenuta consumazione del bene od utilizzazione
del servizio.
Il diritto di recesso è irrinunciabile, e tutte le disposizioni del decreto sono inderogabili: i patti in
contrasto sono nulli.
La legge consente di recedere sia dai contratti, sia dalle proposte contrattuali (ma dalle proposte
contrattuali si può recedere già per diritto comune, revocandole).
Norme più recenti (d.lgs. 185/1999) regolano i contratti a distanza fra consumatori e fornitori: si
avverte rispetto ad essi un’analoga esigenza di protezione del consumatore contro l’effetto sorpresa.
Punti salienti della disciplina: informazione del consumatore; suo irrinunciabile diritto di recesso (entro
10 giorni, o 3 mesi in difetto d’informazione); termine di 30 giorni per l’esecuzione della prestazione
del fornitore, il cui mancato rispetto risolve il contratto.
Il fenomeno della subfornitura riguarda i rapporti fra un’impresa forte (committente) ed un’impresa
debole (subfornitrice).
La definizione di subfornitura, data dalla l. 192/1998, individua due varianti possibili del fenomeno: la
subfornitura di lavorazioni, e la subfornitura di beni o servizi.
La subfornitura di lavorazioni è quella per cui l’impresa subfornitrice si impegna ad effettuare per
conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla
committente medesima.
La subfornitura di beni o servizi è quella per cui l’impresa subfornitrice s’impegna a fornire all’impresa
committente prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o utilizzati nell’ambito dell’attività
economica del committente o nella produzione di un bene complesso.
Le due varianti hanno un elemento comune: le lavorazioni o forniture del subfornitore sono eseguite in
conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti
dall’impresa committente.
Emergono di qui i dati essenziali della subfornitura: la dipendenza tecnologico-organizzativa, cui
consegue la dipendenza economica del subfornitore dal committente.
La disciplina dei contratti di subfornitura riguarda essenzialmente: la forma e la formazione; la
trasparenza del prezzo e degli altri elementi contrattuali; i termini di pagamento del prezzo dovuto al
subfornitore; la nullità di clausole vessatorie per il subfornitore.
Suo obiettivo è proteggere il subfornitore.
Il contratto richiede forma scritta, cui si equiparano la comunicazione per telefax o altra via telematica,
e l’inizio dell’esecuzione da parte del subfornitore, che abbia ricevuto la proposta scritta del
committente.
Il contratto informale è nullo, ma si prevede un recupero di suoi effetti: il subfornitore ha diritto al
pagamento delle prestazioni già effettuate ed al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini
dell’esecuzione.
Il contratto deve specificare con precisione tutti i termini dell’operazione: requisiti del bene o servizio
da fornire; termini e modalità di consegna, collaudo e pagamento; prezzo, che deve essere determinato
o determinabile in modo chiaro e preciso.
Si fissano inderogabilmente i termini per il pagamento di quanto dovuto al subfornitore (di regola 60
giorni), nonché le conseguenze del loro mancato rispetto.
Infine si stabilisce la nullità di alcune clausole, considerate particolarmente vessatorie per il
subfornitore: quelle che danno al committente ius variandi, od il diritto di recedere senza congruo
preavviso, o scaricano sul subfornitore responsabilità dipendenti da difetti di materiali od attrezzi
forniti dal committente.
La l. 192/1998 vieta anche l’abuso di dipendenza economica: è vietato l’abuso da parte di una o più
imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una
impresa cliente o fornitrice.
La dipendenza economica è definita come la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare,
nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.
La subfornitura è un particolare caso di dipendenza economica.
Il comportamento di abuso non è definito, ma esemplificato: può consistere nel rifiuto di vendere o nel
rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o
discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo.
La nullità può colpire un intero contratto o singole clausole di esso.
La norma parla di patti, ma non possono escludersi abusi realizzati con negozi unilaterali, come una
diffida ad adempiere od un recesso esercitato dall’impresa dominante in base alla disciplina legale del
tipo.
Pur in mancanza di espressa indicazione legislativa, è difficile pensare che la legittimazione ad
invocare la nullità non sia riservata in esclusiva alla parte dipendente, che subisce l’abuso.
Si accentua la propensione a controlli sostanziali sul contenuto del contratto, per reagire agli elementi
di ingiustizia o squilibrio che esso presenti: in controtendenza rispetto al principio tradizionale per cui i
contraenti sono gli unici arbitri della sua giustizia o del suo equilibrio.
La propensione si avverte nel significativo squilibrio preso a criterio generale di vessatorietà delle
clausole nei contratti dei consumatori; nell’eccessivo squilibrio assunto come indicatore di una
dipendenza economica, cui possono applicarsi rimedi contrattuali; nella nullità degli atti dispositivi, fra
subfornitore e committente, di diritti di privativa senza congruo corrispettivo.
I vantaggi legalmente attribuiti alla parte debole sono spesso qualificati irrinunciabili: in deroga alla
normale disponibilità dei diritti patrimoniali.
Si appesantiscono gli obblighi d’informazione cui il contraente più forte ed esperto è tenuto verso il
contraente debole ed inesperto; ben al di là di quanto implicato dal 1337 (le parti, nello svolgimento
delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede).
Si allarga enormemente il campo delle nullità relative.
Si moltiplicano i vincoli di forma scritta, instaurando un nuovo formalismo che mette in crisi il
declamato principio di libertà delle forme.
CAPITOLO XLII – LA RISOLUZIONE: CAUSE E REGIMI
Risoluzione significa scioglimento.
L’invalidità colpisce il contratto, per un vizio che questo porta in sé, e l’inefficacia – cioè la
cancellazione degli effetti contrattuali – ne è la conseguenza.
Invece la risoluzione colpisce non il contratto, ma direttamente e solo i suoi effetti: rende il contratto
inefficace, senza toccarne la validità.
La risoluzione è estinzione degli effetti del contratto complessivamente considerati, per un evento che
riguarda il contratto nel suo insieme.
Non necessariamente la risoluzione estingue proprio tutti i singoli effetti del contratto.
È estranea all’area della risoluzione l’estinzione degli effetti contrattuali, conseguente al
sopraggiungere del termine finale.
Qui il contratto si estingue perché compiutamente attuato.
Al contrario la risoluzione scioglie il contratto, estinguendone gli effetti, per un evento che ne
impedisce l’attuazione.
La prima macroclassificazione distingue risoluzioni volontarie e legali, in base alla fonte cui risale la
possibilità di sciogliere il contratto.
I meccanismi di risoluzione volontaria estinguono il contratto in forza di una volontà negoziale delle
parti del contratto stesso.
Questa volontà può essere del tutto esterna al contratto oggetto di risoluzione, come nel mutuo
dissenso, che è un contratto ulteriore e diverso da quello che si scioglie.
Può essere del tutto interna al contratto, come nella condizione risolutiva: dove il fattore estintivo è
contenuto nello stesso contratto che subisce l’estinzione.
Può essere per parte interna e per parte esterna, come nel recesso convenzionale: che scioglie il
contratto grazie ad una volontà negoziale interna al contratto congiuntamente ad una volontà negoziale
esterna ad esso.
I meccanismi di risoluzione legale consentono l’estinzione del contratto, solo perché una norma
dispone che, in presenza di determinati presupposti, il contratto si risolve o può risolversi.
Le risoluzioni possono operare in modo del tutto automatico: cioè per il semplice verificarsi dei
presupposti di fatto cui la legge collega lo scioglimento del contratto, senza bisogno né di pronuncia
giudiziale né di manifestazioni di volontà negoziale della parte.
È il caso della risoluzione per avveramento di condizione risolutiva; per impossibilità sopravvenuta; per
infruttuosa scadenza del termine essenziale di adempimento.
Oppure per sentenza: quando la risoluzione avviene solo in forza di una pronuncia del giudice
(sollecitato dall’iniziativa processuale di parte): è il caso del modello normale di risoluzione per
inadempimento; della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta; della risoluzione prevista
nell’ambito della garanzia per vizi nell’appalto e nella vendita; e, con riguardo a quest’ultima, della
risoluzione prevista per i vari casi d’inattuazione dell’impegno traslativo.
Infine, la risoluzione può operare per negozio: quando il contratto si scioglie per una manifestazione di
volontà della parte legittimata allo scioglimento, senza bisogno di pronuncia giudiziale: è il caso delle
risoluzioni (per inadempimento) determinate da diffida ad adempiere e dalla dichiarazione di avvalersi
della clausola risolutiva espressa.
Poi dei recessi: in relazione ai quali il modo della risoluzione è sempre negoziale; mentre la fonte della
risolubilità può essere volontaria (recesso convenzionale) o legale (recesso legale).
Infine del mutuo dissenso.
Le risoluzioni legali possono poi classificarsi in base alla ragione dello scioglimento del vincolo
contrattuale.
La risoluzione può non avere natura di rimedio, e cioè rispondere ad una logica diversa dall’esigenza di
dare ad una parte la possibilità di liberarsi dal vincolo contrattuale, di fronte a circostanze che rendono
ingiustificato il suo mantenimento.
La ragione per lo scioglimento non remediale può essere l’attuazione di un punto del programma
contrattuale elaborato dalle parti: avveramento di condizione risolutiva, recesso convenzionale.
Oppure un potere dato alla parte dalla legge, per ragioni diverse dalla necessità di reagire ad un
malfunzionamento del rapporto contrattuale: recessi di tipo non remediale, come quelli di liberazione e
gran parte di quelli di pentimento.
Oppure un’autonoma manifestazione di libertà contrattuale: mutuo dissenso.
Hanno invece natura di rimedio le risoluzioni che operano di fronte a circostanze che determinano un
malfunzionamento del contratto, pregiudizievole per una parte; esse sono, per definizione, di fonte
legale.
Possono operare per automatismo: risoluzione per impossibilità sopravvenuta, o per infruttuosa
scadenza del termine essenziale dell’adempimento.
Possono operare per sentenza: risoluzione giudiziale per inadempimento: risoluzione per eccessiva
onerosità sopravvenuta; risoluzione dell’appalto e della vendita per vizi o per inattuazione
dell’impegno traslativo.
Possono operare per negozio: diffida ad adempiere; recessi legali di autotutela.
Quando la risoluzione ha natura di rimedio, in generale essa si qualifica più propriamente come rimedio
sinallagmatico.
Ed infatti le tre figure generali di risoluzione-rimedio (per inadempimento, per impossibilità
sopravvenuta, per eccessiva onerosità sopravvenuta) espressamente definiscono il proprio campo di
applicazione parlando di contratti con prestazioni corrispettive.
Questi contratti si connotano per l’interdipendenza reciproca delle prestazioni delle parti, ciascuna delle
quali è prevista in relazione all’altra: la giustifica e ne è giustificata.
Gli eventi che danno luogo a risoluzione-rimedio hanno la caratteristica comune di determinare un
malfunzionamento del contratto, in quanto colpiscono una delle prestazioni e così perturbano il
rapporto contrattuale proprio nella sua dimensione di sinallagma, di scambio fra prestazione e
controprestazione.
Gli interpreti si sono sforzati di cercare il fondamento della risoluzione come rimedio sinallagmatico: e
l’hanno trovato volta a volta in un’implicita volontà delle parti (che avrebbero tacitamente subordinato
le prestazioni di ciascuna alla condizione risolutiva di eventi capaci d’incidere in un certo modo sullo
scambio contrattuale); in un difetto funzionale della causa, in quanto causa di scambio; nell’esigenza di
prevenire arricchimenti ed impoverimenti ingiustificati.
Oltre alla logica di rimedio sinallagmatico, le cause generali di risoluzione (inadempimento,
impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione) hanno un altro
elemento comune: esse reagiscono, in genere, contro fattori di malfunzionamento del rapporto
contrattuale sopravvenuti dopo la conclusione del contratto, in fase di esecuzione.
La risoluzione è rimedio dato nell’interesse particolare di un contraente: quello che subisce
l’inadempimento di controparte, l’impossibilità della prestazione attesa, o l’eccessivo aggravio della
prestazione dovuta, od i vizi materiali o giuridici della cosa comprata, od i difetti o difformità
dell’opera appaltata, etc.
Dalle norme che limitano la possibilità di escludere convenzionalmente le garanzie nella vendita
(1487.2: Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per
l’evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario; 1490.2: Il patto con cui si
esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i
vizi della cosa) si ricava che una rinuncia preventiva al rimedio risolutorio sarebbe ammissibile nei soli
limiti in cui il fatto idoneo ad attivarlo non sia un fatto proprio della stessa controparte, beneficiaria
della rinuncia; conclusione rafforzata dal più generale principio di sfavore per la resa alle altrui
decisioni meramente potestative (cfr. 1355: È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un
obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà
dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore).
Se ognuno dei due contraenti rinuncia preventivamente alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta
della prestazione dell’altro, è come se si sciogliesse il nesso di corrispettività fra le due obbligazioni; è
come se, anziché aversi un’obbligazione promessa ed un’obbligazione contropromessa in cambio
nell’ambito del contratto, si avessero due promesse indipendenti fra loro: ma allora si sfiorerebbe
pericolosamente la violazione del principio di tipicità delle promesse unilaterali (1987: La promessa
unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge):
principio con valore di ordine pubblico.
Mentre c’è una norma generale sulle conseguenze dell’annullamento (1445), apparentemente non esiste
una norma generale sulle conseguenze della risoluzione.
C’è una norma che fissa le conseguenze di una particolare figura di risoluzione: quella per
inadempimento (1458): questa norma è il prototipo cui tendenzialmente riferirsi per individuare la
disciplina di ogni risoluzione; ad essa si fa espresso rinvio per le conseguenze della risoluzione per
eccessiva onerosità sopravvenuta (1467.1).
Quanto alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta, il richiamo al regime dell’indebito (1463)
esplicita un dato già implicito nella previsione del 1458.
Norme particolari sono dettate per singoli tipi: ad es. appalto (1662.2: Quando, nel corso dell’opera, si
accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola
d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a
tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del
committente al risarcimento del danno) ed assicurazione (1901.3: il 1901 dice, per intero, che se il
contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta
sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle
scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi
precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il
premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al
pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La
presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita).
Come per l’invalidità, anche per la risoluzione è utile distinguere fra conseguenze che si producono fra
le parti, e conseguenze rispetto ai terzi.
Si usa dire che la risoluzione non è retroattiva rispetto ai terzi, ovvero che non ha retroattività reale:
modo abbreviato per indicare ch’essa non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (1458.2).
La regola è esattamente opposta a quella dettata per la risoluzione conseguente ad avveramento della
condizione risolutiva.
La regola incontra però qualche limite: un limite, relativo alla risoluzione di contratti aventi ad oggetto
immobili, è esplicitato dallo stesso 1458.2, che fa salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
risoluzione: la risoluzione diventa comunque opponibile al terzo, se egli trascrive il suo acquisto dopo
che sia stata trascritta la domanda di risoluzione.
Un limite più generale risulta dai principi processuali in tema di efficacia delle sentenze nei confronti
dei terzi: l’inopponibilità della risoluzione ai terzi vale solo a favore dei terzi che abbiano acquistato
prima dell’avvio del giudizio che l’ha determinata (ciò non toglie che il terzo possa comunque salvare
il suo acquisto in base a qualche regola speciale, come “possesso vale titolo” ex 1153).
Nei contratti ad esecuzione istantanea la risoluzione ha effetto retroattivo fra le parti (1458.1).
Se, risolto l’atto traslativo, il bene trasferito non può essere restituito perché alienato, trasformato o
distrutto, si restituisce l’equivalente in denaro; se la prestazione non è materialmente restituibile perché
è un servizio reso, si applica la disciplina dell’arricchimento.
Solo in casi particolari la risoluzione è preclusa: quando lo dispone una norma ad hoc (come il 1492.1,
che preclude la risoluzione della vendita per vizi se la cosa risulta distrutta, alienata o trasformata);
oppure quando l’impossibilità di restituire dipende da un atto del legittimato, che valga rinuncia alla
risoluzione.
Nei contratti di durata (ad esecuzione continuata o periodica) la risoluzione opera per il futuro; invece
non opera retroattivamente, nel senso che il suo effetto non si estende alle prestazioni già eseguite
(1458.1).
La risoluzione del rapporto di durata non può comunque travolgere la frazione di esso, anteriore al fatto
risolutorio; per altro verso, non può escludersi un’ultrattività del rapporto contrattuale anche dopo il
fatto risolutorio, o dopo la stessa pronuncia di risoluzione: dato un rapporto di locazione iniziato nel
2000, se nel 2002 si manifesta inadempimento del conduttore, per il quale il locatore ottiene nel 2003 la
risoluzione, ma solo nel 2004 consegue con esecuzione forzata la restituzione della cosa, i canoni
contrattuali gli sono dovuti fino al 2004 (cfr. il 1591: Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto
a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il
maggior danno.).
Deve ancora precisarsi che la risoluzione del contratto non ne cancella completamente i contenuti
nemmeno per il futuro: si salvano i contenuti strumentali, come la clausola compromissoria e le
garanzie.
Risolto il contratto, le prestazioni anteriormente eseguite (e non fatte salve dalla norma sui contratti di
durata) devono restituirsi perché private del loro titolo.
La restituzione poggia perciò sul principio dell’indebito oggettivo.
La restituzione di somme di denaro dà luogo a debito di valuta (ma quando la risoluzione dipende da un
fatto imputabile all’accipiens, alla rivalutazione può giungersi indirettamente, a titolo di risarcimento
del danno da mancata disponibilità della somma).
La restituzione può essere impossibile perché la prestazione era di fare: si applicano allora le regole
sull’arricchimento; o perché la cosa è distrutta, trasformata od alienata: ed allora si restituisce il
tantundem.
La restituzione consegue alla risoluzione: la prescrizione del corrispondente diritto decorre perciò da
quest’ultima.
Ma non s’identifica con essa, e le relative azioni vanno tenute distinte.
Proposta in primo grado la sola domanda di risoluzione, quella di restituzione non può proporsi per la
prima volta in appello.
La parte che ottiene la risoluzione può aver diritto, oltre che alle restituzioni, al risarcimento del danno.
Ciò accade quando la risoluzione dipende da un fatto del quale controparte debba rispondere,
tipicamente dal suo inadempimento: la parte che lo subisce, infatti, può chiedere la risoluzione del
contratto, salvo il risarcimento del danno (1453.1).
Il risarcimento si fonda su una responsabilità contrattuale ex 1218 e seguenti.
Alla risoluzione può conseguire un risarcimento del solo interesse negativo, versandosi in ipotesi di
responsabilità precontrattuale: si pensi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione,
non imputabile alla parte obbligata, che questa conosceva come probabile, ma di cui non ha avvertito
controparte.
Può immaginarsi che un contratto sia invalido (ad es. perché illecito, o viziato da errore) ed al tempo
stesso risolubile (ad es. perché inadempiuto).
In linea di principio l’invalidità assorbe la risolubilità.
Se il contratto è annullabile, e la parte legittimata è K, K può benissimo (rinunciare all’annullamento e)
chiedere la risoluzione contro H (senza che questa possa eccepire l’invalidità).
Se il contratto invalido è già stato risolto, la parte interessata e legittimata può successivamente
chiedere che ne sia accertata la nullità o pronunciato l’annullamento: dall’una o dall’altro possono
infatti derivare conseguenze diverse rispetto alle conseguenze della risoluzione.
CAPITOLO XLIII – LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
L’inadempimento può presentarsi con mille volti diversi, nello specifico contesto del rapporto
contrattuale litigioso.
Può essere inadempimento radicale e definitivo, adempimento parziale, ritardo nell’adempiere,
adempimento qualitativamente difettoso.
Può essere inadempimento che si consuma una volta per tutte, od inadempimento che continua nel
tempo.
Può essere inadempimento rimediabile in futuro, od inadempimento irrimediabile.
La situazione della parte che subisce inadempimento è definita da tre dati normativi.
Col primo le si attribuisce un potere di scelta: la vittima può a sua scelta chiedere l’adempimento o la
risoluzione del contratto (1453.1).
La risoluzione è rimedio atto a distruggere il contratto, la domanda di adempimento punta
all’attuazione del contratto sul presupposto del suo mantenimento: tramite una citazione con domanda
di condanna; od un ricorso per decreto ingiuntivo; o, se il contratto è titolo esecutivo, direttamente
attraverso l’esecuzione forzata.
Il secondo dato normativo attiene ai presupposti dell’uno e dell’altro rimedio: essi non sono
necessariamente coincidenti: per chiedere l’adempimento, occorre solo che il contratto risulti
inadempiuto, per chiedere la risoluzione occorre un inadempimento qualificato da un certo livello di
gravità, od in alternativa dalla presenza in contratto di una clausola risolutiva espressa o di un termine
essenziale.
Chi agisce per la risoluzione deve provare l’inadempimento di controparte, mentre chi agisce per
l’adempimento deve provare solo il contratto: spetterà al convenuto eccepire, e provare, che non vi è
inadempimento perché il contratto è già stato adempiuto.
Il terzo dato normativo riguarda la reversibilità od irreversibilità della scelta compiuta: la risoluzione
può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non
può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione (1453.2).
L’attore può, come la giurisprudenza ammette, chiedere in via principale la risoluzione, ed in subordine
l’adempimento.
Chieda l’adempimento o chieda la risoluzione, la vittima dell’inadempimento può chiedere anche, in
ogni caso, il risarcimento del danno (1453.2).
La risoluzione è rimedio nell’interesse di parte: legittimata ad attivarlo è la parte protetta, cioè quella
che subisce l’inadempimento; è dubbio che essa possa disporne preventivamente.
Quando l’avente diritto alla prestazione non coincide con la parte del contratto che ne costituisce il
titolo, le soluzioni possono essere diverse.
In caso di cessione del contratto, l’azione di risoluzione spetta al cessionario, che subentra anche nei
rimedi contrattuali.
In caso di contratto a favore di terzo, è certo che lo stipulante ha l’azione di adempimento,
condividendola col terzo beneficiario; è discutibile che abbia anche l’azione di risoluzione.
Quando la parte legittimata è una parte complessa, nonché quando vi sia una pluralità di parti, si
adottano gli stessi criteri considerati in tema di legittimazione all’annullamento (cap. XXXVIII).
Il primo presupposto della risoluzione è l’inadempimento, cioè l’obiettiva inattuazione o difettosa
attuazione della prestazione contrattuale.
Non occorre provare che dall’inadempimento sia derivato danno alla parte legittimata: prova
necessaria, invece, per la domanda di risarcimento.
Possono rilevare situazioni prossime all’inadempimento, anche se non propriamente coincidenti con la
mancata o difettosa attuazione della prestazione.
Una è quella del debitore che prima della scadenza del termine per l’adempimento si mette in
condizioni che rendono certa la sua impossibilità di adempiere alla scadenza: questa situazione va
equiparata ad inadempimento.
Un’altra situazione è quella del debitore che preannuncia che alla scadenza non adempirà: qui la
questione è meno semplice: per un verso, può darsi che il debitore prima della scadenza si ravveda ed
alla scadenza sia disposto ad adempiere, sicché impedirglielo con una risoluzione precipitosa potrebbe
essere inopportuno; per altro verso, il creditore potrebbe trovarsi in gravi difficoltà se alla scadenza non
ricevesse la prestazione, il che renderebbe giusto metterlo in condizione di prevenirle risolvendo il
contratto e procurandosi la prestazione altrimenti.
Ci s’interroga, ancora, se la risoluzione consegua all’inadempimento di qualsiasi obbligazione
contrattuale.
Lo si dubita per l’obbligazione finale di restituire la cosa altrui, detenuta in base al contratto, sul rilievo
che la cosa dovrebbe comunque essere restituita: può obiettarsi che la risoluzione servirebbe a liberare
dall’obbligo del corrispettivo chi subisce la mancata consegna.
L’inadempimento risolutorio è solo l’inadempimento ingiustificato: il convenuto può eccepire una
causa di giustificazione del suo inadempimento, e se l’eccezione è provata la risoluzione è negata.
Causa giustificativa dell’inadempimento, che fa ostacolo alla risoluzione, è di regola un fatto riferibile
alla stessa vittima dell’inadempimento.
Può essere la mancata cooperazione al debitore (cfr. 1206 e seguenti); può essere la tolleranza verso
l’inadempimento (rilevante soprattutto nei rapporti di durata).
Rispetto a quest’ultima, occorre distinguere in base alle circostanze del caso concreto.
Causa giustificativa dell’inadempimento può essere un fatto che dà luogo ad un’eccezione sospensiva
del debitore, ed in particolare all’eccezione d’inadempimento: la domanda di risoluzione viene respinta,
se il convenuto inadempiente eccepisce che l’attore a sua volta non ha adempiuto la prestazione a suo
carico.
Ci si domanda se la risoluzione vada esclusa altresì tutte le volte che l’inadempimento sia non
imputabile al debitore, alla stregua dei criteri d’imputazione della responsabilità variamente costruiti
intorno agli artt. 1176 (Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon
padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un’attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata), 1218 (Il
debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non
prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante
da causa a lui non imputabile) ed alle norme speciali sui singoli tipi di prestazione.
Quel che è certo è che è inammissibile irrigidire il requisito dell’inadempimento imputabile nel più
ristretto requisito dell’inadempimento colposo.
Il contratto è risolubile per sopravvenuta impossibilità della prestazione, non imputabile al debitore.
Tutti gli inadempimenti ingiustificati (ed imputabili all’inadempiente) sono fonte di responsabilità e
risarcimento.
Invece non tutti gli inadempimenti ingiustificati sono causa di risoluzione: il contratto non si può
risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse
dell’altra (1455).
Accertare se l’inadempimento invocato per la risoluzione abbia scarsa importanza richiede la
valutazione del singolo rapporto e delle concrete circostanze di esso, alla luce di due criteri da applicare
congiuntamente.
Vale prima di tutto un criterio oggettivo: riferito, però, non a qualificazioni astratte (prestazione
principale od accessoria; materia di obbligazione volontaria o legale), ma alla funzione ed al peso che
la prestazione inadempiuta ha nel quadro dell’economia complessiva del contratto, valutata in concreto.
Se si danno più inadempimenti, essi si cumulano ai fini di una valutazione complessiva.
Ma vale anche un criterio soggettivo, fondato sull’interesse della vittima dell’inadempimento: cioè
sullo specifico interesse che questa portava alla prestazione inadempiuta.
La scarsa importanza dell’adempimento è elemento impeditivo della risoluzione: dunque l’onere di
provarla spetta all’inadempiente convenuto (che però potrà limitarsi a provare la scarsa importanza
secondo il criterio oggettivo).
Lascia perplessi l’affermazione, contenuta in qualche sentenza, della sua rilevabilità d’ufficio.
Nella visione dominante, alla risoluzione del contratto può giungersi per due vie alternative fra loro, cui
corrispondono due tipi diversi di risoluzione: risoluzione giudiziale e risoluzione di diritto.
La risoluzione giudiziale si attua mediante la sentenza del giudice.
Essa implica un processo, aperto dalla domanda del legittimato: vi allude chiaramente il 1453, che parla
di giudizio e domanda.
La risoluzione è determinata dalla sentenza, cui si attribuisce comunemente natura costitutiva.
La risoluzione di diritto opera in tre situazioni: quando la vittima rivolge all’inadempiente una diffida
ad adempiere, e nonostante questa l’inadempimento persiste; quando nel contratto c’è una clausola
risolutiva espressa, e l’inadempimento corrisponde alla previsione di questa; quando l’inadempimento
consiste nel ritardo per inosservanza di un termine essenziale.
Un caso speciale di risoluzione di diritto è previsto per l’assicurazione (1901.3).
Anche in presenza di una risoluzione di diritto il ricorso al giudice e l’apertura di un processo sulla
fattispecie risolutoria sono frequenti.
Di fronte all’inadempimento, la parte che lo subisce può diffidare l’altra ad adempiere entro congruo
termine; se l’inadempiente non lo fa, il contratto è risolto di diritto (1454).
Il rimedio implica la presenza di tutti i requisiti previsti in generale per la risoluzione: inadempimento
ingiustificato, d’importanza non scarsa.
La parte diffidata può adempiere, ed in tal caso il contratto si salva; invece l’inadempiente citato per la
risoluzione giudiziale perde la possibilità di adempiere.
La diffida ad adempiere è un negozio unilaterale ricettizio e formale: consiste in un’intimazione ed in
un avvertimento che la parte legittimata rivolge all’inadempiente per iscritto (1454.1).
Il contenuto della diffida comprende due elementi: il primo è l’intimazione ad adempiere in un congruo
termine (1454.1); il termine di regola non può essere inferiore a 15 giorni (1454.2), ma si fa salva la
possibilità che per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore; essendo
l’atto ricettizio, il termine decorre dalla conoscenza del destinatario (salvo il 1335: la proposta,
l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano
conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere
stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia).
Il secondo elemento è la dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà
senz’altro risoluto (1454.1).
Gli effetti della diffida sono indicati dal 1454.3: decorso il termine senza che il contratto sia stato
adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Ci si può domandare se l’effetto risolutorio è precluso da un adempimento solo parziale, e tuttavia
idoneo a riportare l’inadempienza sotto la soglia della scarsa importanza: si raccomandano risposte
flessibili, suggerite nei diversi casi concreti dall’applicazione del principio di buona fede.
Scaduto il termine, l’inadempiente non può salvare il contratto adempiendo tardivamente; ed il
diffidante non può prorogarlo (come avrebbe potuto fare prima della scadenza), od in altro modo
rinunciare all’effetto risolutorio.
Un indirizzo giurisprudenziale sostiene una tesi diversa: sarebbe in potere del diffidante scegliere se
avvalersi o meno dell’intervenuta risoluzione.
Un caso speciale di diffida ad adempiere è previsto per l’appalto (1662.2).
Con la clausola risolutiva espressa, eventualmente inserita nel contratto, si conviene che questo si
risolverà se una determinata obbligazione contrattuale risulterà inadempiuta (1456).
La clausola non richiede forme; esige invece due requisiti di contenuto.
La previsione che l’inadempimento sarà automaticamente risolutorio deve risultare espressamente,
inoltre, essa deve legare la risoluzione all’inadempimento di una determinata obbligazione (od anche di
più obbligazioni), da indicare in modo specifico.
L’inadempimento previsto dalla clausola risolve il contratto solo se è ingiustificato, secondo la regola
comune.
Non occorre invece che abbia l’entità (l’importanza non scarsa) richiesta in generale dal 1455.
È escluso il sindacato giudiziale sull’importanza che l’obbligazione inadempiuta ha nell’economia del
contratto, ma non anche quello sull’entità della lesione che l’obbligazione abbia ricevuto.
L’inadempimento non determina automaticamente la risoluzione, ma fa scattare un potere di scelta
della vittima (a differenza di quanto deve ritenersi per la diffida ad adempiere): se la vittima vuole la
risoluzione, ha l’onere di dichiarare all’inadempiente che intende valersi della clausola risolutiva, e solo
per effetto di tale dichiarazione la risoluzione si verifica di diritto (1456.2); in mancanza di
dichiarazione, il contratto non si risolve.
Non è previsto termine entro cui la parte legittimata debba rendere la dichiarazione: la giurisprudenza
consente all’inadempiente di adempiere, salvando il rapporto, fino a che l’altra parte non abbia
dichiarato di avvalersi della clausola.
La dichiarazione di avvalersi della clausola è un negozio unilaterale.
È ricettizia e non è formale, sicché può risultare per implicito, da fatti concludenti.
La dichiarazione è preclusa dalla rinuncia della parte legittimata; questa può essere espressa, ma anche
tacita, per atti incompatibili con la volontà di risolvere.
La possibilità di risolvere il contratto di diritto, mediante invocazione della clausola risolutiva espressa,
coesiste con la possibilità di risolverlo giudizialmente.
Quest’ultima riguarda ovviamente i casi in cui si verifichi un inadempimento diverso da quello dedotto
nella clausola.
Proposta domanda ex 1453, la parte legittimata può, in qualunque momento successivo, invocare la
clausola come produttiva di risoluzione di diritto.
Non vale l’inverso: proposta domanda di accertamento della risoluzione di diritto ex 1456, sarebbe
domanda nuova, improponibile per la prima volta in appello, quella di risoluzione giudiziale ex 1453.
Se si deducesse l’inadempimento di una parte a condizione risolutiva del contratto, l’effetto risolutorio
sarebbe automatico (anche se evitabile con la rinuncia della parte interessata alla condizione,
certamente unilaterale), ed opererebbe con retroattività reale anche in odio ai terzi.
Il contratto si risolve di diritto quando scade infruttuosamente il termine stabilito per l’esecuzione della
prestazione, se si tratta di termine essenziale nell’interesse della parte che l’attende.
Questa può però evitare la risoluzione se, conservando interesse alla prestazione, dichiara entro 3 giorni
che vuole ancora averla (1457).
Il criterio dell’essenzialità va definito prima di tutto su un piano oggettivo: il termine è essenziale, se
dopo la scadenza la prestazione non avrebbe più utilità per il creditore.
Si dice però che il criterio dell’essenzialità possa essere anche soggettivo: cioè legato alla previsione
delle parti, che qualifichino esse stesse il termine della prestazione come essenziale, o stabiliscano che
la sua infruttuosa scadenza risolverà automaticamente il contratto.
La previsione dev’essere chiara ed univoca: non basterebbero formule come “perentoriamente”,
“improrogabilmente”, etc.
La clausola che qualifica essenziale il termine di una certa obbligazione implica anche un giudizio di
essenzialità dell’obbligazione stessa, precludendo al giudice di attribuire scarsa importanza al relativo
inadempimento: dunque è una clausola risolutiva espressa.
L’area del termine essenziale si riduce così ai casi di obiettiva essenzialità del termine, non pattuita fra
le parti (ed in quest’area è possibile il sindacato ex 1455).
Lo conferma il 1457.2, dicendo che, scaduto il termine essenziale, il contratto è risoluto di diritto anche
se non è stata espressamente pattuita la risoluzione: se fosse stata pattuita, si ricadrebbe nel campo del
1456.
Se il termine non è essenziale, il contratto può ugualmente risolversi – non solo giudizialmente, ma
anche di diritto, in forza di diffida ad adempiere.
La proposizione della domanda giudiziale di risoluzione non risolve il contratto: la risoluzione si
produrrà con la sentenza che accolga la domanda dell’attore, e proprio in quanto l’effetto risolutorio
deriva dalla sentenza, a questa si attribuisce natura costitutiva.
Una preclusione è posta a carico dell’attore, vittima dell’inadempimento, nell’interesse
dell’inadempiente convenuto: dopo la proposizione della domanda di risoluzione l’attore non può
mutarla in domanda di adempimento (1453.2); una preclusione reciproca scatta a carico
dell’inadempiente: ricevuta la citazione, egli non può più adempiere la propria obbligazione (1453.3).
Va fatta salva l’ipotesi che attore e convenuto in corso di lite si accordino per l’adempimento,
rinunciando il primo al diritto di respingerlo ed il secondo al diritto di non eseguirlo.
Inoltre, partendo dal presupposto che solo con la sentenza si produce l’effetto risolutorio, la
giurisprudenza ammette che quando il giudizio non sfocia in siffatta sentenza l’effetto preclusivo viene
meno e si riapre la via all’adempimento.
Se la sentenza non risolve, il contratto resta vivo e può/deve essere adempiuto, il problema è che questo
si sa a distanza di molto tempo dalla domanda: quando, con tutta probabilità, la prestazione è diventata
inutile per l’attore, e difficile da eseguire per il convenuto.
Per uscirne, si dà alla citazione il valore di una diffida ad adempiere, cui seguirebbe entro brevissimo
tempo l’automatica risoluzione del contratto; con una conseguenza teorica: la sentenza che accogliesse
la domanda proposta ex 1453 accerterebbe una risoluzione già maturata, e quindi avrebbe anch’essa
natura dichiarativa e non costitutiva.
Ma dal punto di vista pratico resterebbe pur sempre l’incertezza sull’esito della lite, che spetterà
comunque al giudice dirimere con la sua sentenza.
Leggere la domanda di risoluzione come diffida ad adempiere può avere un altro apprezzabile senso
pratico: attenua il rigore della preclusione a carico del convenuto, consentendogli di adempiere (e così
salvare il contratto) anche dopo la domanda di risoluzione, purché lo faccia entro un tempo non più
lungo di quello corrispondente ad un termine congruo.
Si sa che dopo la domanda l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione (1453.3):
leggendo a contrario questa regola legale, molti interpreti ne ricavano un’altra regola non scritta: prima
della domanda l’inadempiente può sempre adempiere, precludendo la domanda stessa.
Ma è più appagante la linea interpretativa che suggerisce di distinguere, a seconda del modo in cui
l’inadempimento verificatosi incide sulla residua utilità che l’adempimento successivo può avere per il
creditore.
La vittima dell’inadempimento ha un modo sicuro per precludere all’inadempiente il successivo
adempimento: proporre domanda giudiziale di risoluzione.
Se invece egli si limita a comunicare stragiudizialmente che non è più interessato al contratto ed
intende risolverlo, la giurisprudenza tende a negare qualsiasi rilevanza a siffatta dichiarazione
stragiudiziale.
Talora la prestazione è unitaria ed indivisibile: il suo inadempimento determina allora la risoluzione
totale del contratto, anche se il debitore abbia eseguito attività preparatorie e strumentali ad essa.
Altre volte la prestazione è divisibile, e viene eseguita solo in parte: la prestazione solo parziale è
inadempimento (inadempimento parziale, ma pur sempre inadempimento): si potrà chiedere la
risoluzione dell’intero contratto, oppure il contratto potrà essere parzialmente risolto, per la frazione
non adempiuta.
Accade spesso che le parti si contestino inadempimenti reciproci.
Se il giudice accerta che solo una delle parti è inadempiente e l’altra no, accoglie la domanda della
parte non inadempiente.
Se invece accerta che in effetti entrambe sono inadempienti, procede ad una valutazione comparativa
dei rispettivi adempimenti, nel quadro di una considerazione globale dell’andamento del rapporto.
La valutazione poggia su vari criteri.
Un criterio cronologico: chi dei due ha cominciato a non adempiere, o ad adempiere male?
Un criterio di causalità: l’inadempimento di B consegue a quello di A, verso cui rappresenta una
precisa reazione e risposta, oppure ne è del tutto slegato?
Un criterio di adeguatezza: ammesso che l’inadempimento di B reagisca causalmente a quello di A, si
tratta di una reazione proporzionata o sproporzionata?
Combinando questi criteri, il giudice decide a chi risale in definitiva la responsabilità (o la maggiore
responsabilità) per il fallimento del rapporto contrattuale: respinge la domanda di questa parte, ed
accoglie la domanda dell’altra.
Ma il giudice può accertare che entrambe le parti sono inadempienti in ugual grado: se entrambe
chiedono la risoluzione, non c’è nessun ostacolo a pronunciarla per inadempimento di entrambe; se una
chiede la risoluzione e l’altra l’adempimento, prevale la domanda della prima.
Le simmetriche domande risolutorie delle parti possono configurarsi come dichiarazioni costitutive di
un mutuo dissenso.
La formula che riferisce il rimedio ai casi in cui una parte non adempie le sue obbligazioni (1453.1)
non va intesa in senso rigidamente letterale.
Il richiamo all’inadempimento di obbligazioni non significa che il rimedio si applichi ai soli contratti
con effetti obbligatori; esso trova applicazione anche ai contratti con effetti costitutivi, traslativi,
estintivi.
Sorgono problemi riguardo ai contratti che all’effetto traslativo o costitutivo (ad es. di servitù)
associano obblighi accessori o strumentali (ad es. diretti a rendere possibile e comunque non impedire
l’esercizio della servitù).
L’effetto traslativo o costitutivo si produce in modo istantaneo ma tende a durare indefinitamente; e
così pure il suo corredo obbligatorio.
L’inadempimento di quest’ultimo potrebbe verificarsi a distanza di moltissimo tempo dal contratto:
sembra sensato accordare alla vittima solo azioni di adempimento e di risarcimento.
La risoluzione per inadempimento non si applica ai contratti gratuiti.
Di fronte all’inadempimento della prestazione promessa, il beneficiario non ha interesse alla
risoluzione; il suo unico interesse è interesse alla prestazione promessa: per servirlo, occorrono azioni
di adempimento e di risarcimento.
Il contratto gratuito può prevedere qualche prestazione a carico del beneficiario: ma questa non si
presenta mai come corrispettivo dell’arricchimento ricevuto, ed il suo inadempimento non porta alla
risoluzione.
Nel mandato gratuito il mandante deve fornire al mandatario i mezzi per eseguire il mandato: ove non
lo faccia, il mandatario è esonerato dall’adempiere (può opporre al mandante l’eccezione
d’inadempimento); ma non può chiedere la risoluzione del mandato.
Nell’area dei contratti generalmente soggetti a risoluzione per inadempimento, il 1976 ritaglia una
piccola porzione sottratta al rimedio: di regola, questo non si applica alla transazione per effetto della
quale il rapporto preesistente è stato estinto per novazione (transazione novativa); tuttavia, anche la
transazione novativa può risolversi quando il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.
Si risolvono per inadempimento solo i contratti onerosi.
Ma la categoria comprende diverse classi: in particolare, al suo interno si contrappongono i contratti
con prestazioni corrispettive ed i contratti con comunione di scopo.
Il 1453.1 si riferisce ai contratti con prestazioni corrispettive; il 1459 si riferisce ai contratti
(plurilaterali) con comunione di scopo.
Il rimedio risolutorio deve subire gli adattamenti richiesti dalla peculiarità del contratto.
Prima di tutto dall’eventuale presenza della struttura comune: accade così che, nei contratti associativi,
la risoluzione a carico del socio inadempiente si chiami esclusione del socio, esiga particolari
presupposti e segua una particolare procedura.
Nei casi in cui il contratto con comunione di scopo sia anche un contratto plurilaterale il problema è se
lo scioglimento del rapporto contrattuale rispetto all’inadempiente si esaurisca nei confronti di
quest’ultimo, lasciando in vita il rapporto contrattuale fra le altre parti, o se invece trascini seco la
risoluzione del contratto anche nei confronti di tutte le altre parti.
La norma offre il criterio: di regola lo scioglimento opera limitatamente alla parte inadempiente;
coinvolge anche le altre (l’intero contratto) solo quando la prestazione mancata per l’inadempimento
debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
CAPITOLO XLIV – INADEMPIMENTO E RIMEDI: ALTRI PROFILI
Le eccezioni sospensive sono le difese con cui una parte, cui l’altra chieda l’adempimento e/o imputi
l’inadempimento, può nell’immediato bloccare le pretese rivolte contro di lei, opponendo fatti che
giustificano, almeno temporaneamente, il suo rifiuto di adempiere.
L’eccezione d’inadempimento è la principale eccezione sospensiva: con essa la parte, cui l’altra parte
contesti di non avere adempiuto la sua prestazione, replica che non ha adempiuto perché l’altra parte a
sua volta non ha adempiuto la prestazione da lei dovuta.
La prevede il 1460: ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro
non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che vi siano termini
diversi per l’adempimento dell’uno e dell’altro.
L’eccezione d’inadempimento è un rimedio sinallagmatico, come la risoluzione: entrambe impediscono
l’attuazione squilibrata del contratto, in cui una parte adempie e l’altra no.
Presupposto della risoluzione per inadempimento è che questo sia ingiustificato: ma non è ingiustificato
l’inadempimento che sia giustificato dall’inadempimento di controparte.
È fondamentale qui il principio di buona fede: la parte che subisce l’inadempimento di controparte non
può avvalersi dell’eccezione per rifiutare il proprio adempimento se, avuto riguardo alle circostanze, il
rifiuto è contrario alla buona fede (1460.2).
Ci si domanda se, per essere giustificante, l’inadempimento di controparte debba esserle imputabile: in
vista di un rimedio leggero qual è l’eccezione, si rafforza la tesi che l’eccezione possa opporsi anche
contro inadempimenti inidonei a generare responsabilità dell’inadempiente.
All’inadempimento vero e proprio può equipararsi la dichiarazione di non voler adempiere, resa prima
della scadenza; o la condotta del debitore che si mette in condizione di non poter adempiere alla
scadenza: sempre che l’equiparazione sia conforme a buona fede (cioè che la dichiarazione o la
condotta rendano praticamente certo il futuro inadempimento).
Non sembra da condividere la tesi per cui la tolleranza preclude senz’altro la possibilità d’invocare
l’altrui inadempimento tollerato, per giustificare il proprio.
Se l’inadempimento giustificante è radicale ed irreversibile, sicché non potrà essere rimediato da un
futuro adempimento (violazione di obbligazione negativa, volontaria distruzione della cosa promessa),
si dice che la vittima non dovrebbe opporre l’eccezione, ma agire per la risoluzione.
Ma se non ha nulla da ripetere e non vuole risarcimenti, perché onerarla di un’iniziativa giudiziaria
semplicemente per farsi dichiarare in sentenza che nulla deve a controparte?
Non c’è motivo di negarle l’uso dell’eccezione in via stragiudiziale.
La questione se l’inadempimento giustificante debba avere il livello minimo di gravità (l’importanza
non scarsa) che si richiede come presupposto per la risoluzione può affrontarsi solo mettendo in
correlazione l’inadempimento giustificante con l’inadempimento giustificabile, che reagisce al primo:
se A commette contro B un inadempimento di scarsa importanza, pare giustificato che B risponda con
un inadempimento anch’esso di scarsa importanza.
Il principio di proporzionalità in generale deve illuminare la valutazione dell’inadempimento
giustificato.
Contano tutte le circostanze cui deve aversi riguardo per valutare se l’inadempimento-rispsota è
contrario alla buona fede (1460.2).
In generale, l’eccezione d’inadempimento giustifica la sospensione del proprio adempimento: ma non il
cattivo adempimento, né tanto meno l’inadempimento radicale e definitivo.
Quando il primo inadempimento è sanato con l’adempimento successivo ancorché tardivo, l’eccezione
viene meno, e la parte che se n’era avvalsa deve adempiere: nei tempi ragionevolmente compatibili con
la necessità di riorganizzare la prestazione sospesa.
L’eccezione del 1460 è di parte: il giudice adito con domanda di adempimento o di risoluzione non può
respingerla rilevando d’ufficio che l’attore è a sua volta inadempiente.
Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni
patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della
controprestazione (1461).
È un altro rimedio sinallagmatico, reagisce non contro una lesione del sinallagma già consumata, ma
contro il pericolo di una lesione futura: può essere utilizzato dalla parte il cui credito contrattuale non è
ancora esigibile.
Siamo in un’area contigua a quella in cui opera l’eccezione d’inadempimento, specie se
all’inadempimento si equipara la situazione del debitore che anche prima del termine si mette in
condizione di non poter adempiere.
Il mutamento delle condizioni patrimoniali rileva nella sua oggettività, sia o non sia imputabile alla
parte.
A rigore, occorre che il mutamento sia sopravvenuto dopo la conclusione del contratto: se la situazione
che minaccia la controprestazione fosse anteriore al contratto, la parte che la ignorava, e ne viene a
conoscenza dopo il contratto, avrebbe il rimedio dell’annullabilità per errore.
La parte che deve la controprestazione non ancora scaduta ma in evidente pericolo ha due modi per
impedire che l’altra si avvalga del rimedio: eseguire in anticipo la controprestazione pericolante, o
prestare idonea garanzia (1461).
In generale, chi ha una pretesa rischia sempre di vedersi opporre un’eccezione.
Proposta l’eccezione, spetta al giudice accertarne la fondatezza: questo richiede tempo, ed intanto la
pretesa resta paralizzata.
C’è un modo per evitare al titolare della pretesa questo rischio: la clausola con cui si stabilisce che una
delle parti non può opporre eccezioni al fine di ritardare od evitare la prestazione dovuta (1462).
La clausola è comunemente detta solve et repete.
Il 1462 riconosce l’ammissibilità della clausola, ma con due limiti: il primo è che la clausola non ha
effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione; inoltre la clausola non può
sospendere eccezioni che derivino direttamente dal regolamento contrattuale: se fra le parti si è
convenuto un beneficio di escussione od un pactum de non petendo, sarebbe assurdo che il beneficiario
non potesse invocarli di fronte alla pretesa di controparte.
Il secondo limite è che nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se concorrono gravi motivi, può
sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.
La regola evoca il principio di buona fede, consentendo al giudice di disapplicare la clausola quando ne
deriverebbero risultati irragionevoli e scorretti, ad es. per la palese fondatezza dell’eccezione.
È lo stesso principio che, sotto veste di exceptio doli, consente di disapplicare la clausola “a prima
richiesta” del contratto autonomo di garanzia.
Se contenuta in contratti standard, la clausola richiede specifica approvazione scritta dell’aderente
(1341.2); se pattuita a carico del consumatore nel contratto col professionista, è vessatoria (1469-bis
comma III numeri 16 e 18).
La clausola penale è la clausola con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo
nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione (1382.1).
Gli effetti sono essenzialmente due: il primo è limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se
non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (1382.1); il secondo è obbligare
l’inadempiente a pagarla, indipendentemente dalla prova del danno (1382.2).
La penale attribuisce al creditore il diritto alla prestazione prevista anche se il danno effettivo risulta
inferiore al valore di questa, e perfino se risulta che l’inadempimento non ha causato nessun danno.
La penale può giocare anche nell’interesse del debitore, perché limita la sua esposizione risarcitoria:
come regola egli deve solo la penale, anche se il danno causato dal suo inadempimento superi
l’ammontare di questa.
Questa funzione avvicina la clausola penale alle clausole di limitazione della responsabilità, che hanno
una specifica disciplina: questa dovrà applicarsi alle clausole che, pur presentandosi nominalmente
come penali a carico del debitore, in concreto abbiano la funzione prevalente di limitarne la
responsabilità.
L’effetto di limitare l’entità del risarcimento è escluso, quando le parti pattuiscono, insieme con la
penale, la risarcibilità del danno ulteriore: il creditore può allora chiedere la penale (anche senza prova
del danno) ed in più il danno ulteriore (che però ha l’onere di provare).
Si discute se la clausola penale abbia natura risarcitoria o natura sanzionatoria (inserendosi tra le c.d.
pene private).
Si dibatte anche su accessorietà od autonomia: la penale è solo una clausola inserita in un contratto del
quale regola un particolare profilo, e fuori del quale non sarebbe neppure concepibile? Oppure è un
negozio autonomo, che si regge su una sua propria causa?
Il dibattito è d’interesse pratico per due profili.
Uno è il collegamento col problema del campo di azione della penale, e cioè se questa possa fissare
convenzionalmente quanto dovuto non solo in caso d’inadempimento contrattuale, ma anche d’illecito
extracontrattuale: alla soluzione estensiva è coerente la tesi dell’autonomia, mentre la tesi
dell’accessorietà parla per la soluzione restrittiva.
Un altro senso pratico dell’autonomia della penale è questo: essa sopravvive, come regolazione
convenzionale delle conseguenze dell’inadempimento, anche se questo porti alla risoluzione del
contratto.
La penale scatta quando si verifica l’inadempimento.
L’inadempimento deve essere imputabile al debitore; mentre non occorre che abbia un livello di gravità
superiore alla soglia della scarsa importanza.
Verificatosi l’inadempimento definitivo per cui si era pattuita la penale, il creditore ha un’alternativa:
può chiedere l’esatto adempimento, oppure può chiedere la penale: non può chiedere insieme l’uno e
l’altra (c.d. divieto di cumulo, 1383: Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale
e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo).
L’alternativa data al creditore può svolgersi secondo la logica del 1453.2: se il creditore chiede la
penale, non può cambiare idea e chiedere l’adempimento; se invece chiede l’adempimento, in linea di
massima può cambiare idea e chiedere la penale.
La richiesta della penale può essere accompagnata dalla domanda di risoluzione.
Altro problema è se, chiesta dal creditore la penale, il debitore possa evitare di pagarla rimediando al
proprio inadempimento con un successivo adempimento esatto: questione da risolvere caso per caso,
alla luce del principio di buona fede.
Se la penale è prevista per il ritardo, ed il ritardo si verifica, non vale il divieto di cumulo (1383).
Prolungandosi, il semplice ritardo può trasformarsi in inadempimento definitivo: in tal caso il creditore
può chiedere sia la penale per il ritardo, sia il risarcimento del danno che provi di avere subito (non per
il ritardo, ma) per il mancato conseguimento della prestazione.
La penale può essere ridotta equamente dal giudice (1384).
La riduzione giudiziale secondo equità può avvenire su due distinti presupposti.
Il primo riguarda la sola penale per l’inadempimento: è che l’obbligazione principale risulti non
completamente ineseguita, ma eseguita in parte.
Il secondo presupposto può riguardare sia la penale per l’inadempimento sia quella per il ritardo: è che
la penale sia di ammontare manifestamente eccessivo.
In entrambi i casi il giudice deve decidere sul se e sul quanto della riduzione, avuto riguardo
all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.
Possono le parti pattuire, in deroga al divieto di cumulo, che il creditore avrà diritto sia alla prestazione
inadempiuta sia alla penale per l’inadempimento? Possono escludere convenzionalmente la riduzione
equitativa ex 1384? La risposta negativa, data ad entrambe le domande, non appaga.
Può il giudice ridurre d’ufficio la penale, anche senza domanda della parte che la deve? Può applicare
la penale d’ufficio, commisurando e limitando ad essa il risarcimento richiesto dall’attore, senza che
questi l’abbia invocata (per esonerarsi dalla prova del danno), e senza che per parte sua l’abbia invocata
il convenuto (per limitare il risarcimento dovuto)?
Sentenze di Cassazione rispondono sì alla prima domanda, e no alla seconda.
Vi sono discipline speciali: se contenuta in contratti di consumatori, la clausola penale d’importo
manifestamente eccessivo si presume vessatoria, ex 1469-bis comma III n. 6: quindi non è riducibile,
bensì del tutto inefficace.
Previsioni specifiche riguardano poi quelle particolari penali (rispettivamente per il ritardo e per
l’inadempimento) che sono la pattuizione d’interessi moratori (1224.2: Nelle obbligazioni pecuniarie,
al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non
è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori) e la clausola della vendita a rate che,
nel caso di risoluzione per inadempimento del compratore, autorizza il venditore a trattenere le rate già
riscosse (1526.2: Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo
d’indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta).
Il 1229 regola le clausole per cui, laddove una parte commetta verso l’altra inadempimenti idonei a far
scattare responsabilità ed obblighi risarcitori, l’inadempiente non dovrà alla vittima nessun risarcimento
(clausole di esonero) oppure gli dovrà un risarcimento limitato ad un tetto prestabilito, anche se il
danno risarcibile in base ai criteri legali sia superiore (clausole di limitazione).
La disciplina generale è contenuta nel 1229, e comprende due regole.
La prima regola è contenuta nel 1229.1, il quale stabilisce che è nullo qualsiasi patto che esclude o
limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave: sono valide solo le
clausole che escludono o limitano la responsabilità per colpa lieve.
La seconda regola è espressa dal 1229.2, che recita: è nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero
o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca
violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Una clausola nulla ex 1229.2 è radicalmente priva di effetti.
Invece una clausola nulla ex 1229.1, come ad es. quella che escluda qualsiasi genere di responsabilità,
può salvarsi parzialmente, riducendo la propria portata: non esonera il debitore da rispondere per dolo o
colpa grave, ma lo esonera, se il suo inadempimento dipenda da colpa lieve.
Le discipline specifiche aggravano la disciplina generale, in questo senso: le regole restrittive
colpiscono anche le clausole che escludono o limitano la responsabilità per colpa lieve, o senza colpa.
Ciò accade in ragione del tipo di prestazione, e dei valori messi a rischio: nel trasporto di persone,
anche gratuito, sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che
colpiscono il viaggiatore (1681.3).
Oppure per le modalità della contrattazione: se contenute in contratti standard unilateralmente
predisposti, le clausole richiedono specifica approvazione scritta, siccome onerose (1341.2).
Oppure per la condizione delle parti: sono presuntivamente vessatorie, e quindi inefficaci, le clausole
di esonero o limitazione contenute nei contratti fra professionisti e consumatori (1469-bis comma III
numeri 1 e 2); di più, lo sono anche se negoziate fra le parti (1469-quinquies comma II).
Le clausole sono soggette alle restrizioni appena viste, in quanto escludano o limitino preventivamente
la responsabilità, cioè in quanto pattuite prima dell’insorgere dei presupposti di questa: se fossero
successive, riceverebbero la diversa disciplina delle rinunce o delle transazioni.
Le clausole confinano e possono interferire con altre figure, assoggettate a regole meno severe: con la
clausola di recesso immotivato, con la clausola penale, con le clausole che definiscono oggetto e
modalità della prestazione: l’interprete deve capire quando queste diverse figure mascherino in realtà
una clausola del 1229.
Si discute se siano ammissibili patti che escludono o limitano una responsabilità extracontrattuale,
suscettibile di sorgere in futuro tra gli stipulanti.
CAPITOLO XLV – LA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione è regolata agli articoli 1463 e seguenti,
ma nessuna norma dice esplicitamente che, divenuta impossibile la prestazione contrattuale, il contratto
si risolve.
Che il contratto si risolva risulta da come sono disciplinate le conseguenze dell’impossibilità
sopravvenuta.
In primo luogo si dà per scontato che, per effetto di essa, la parte tenuta alla prestazione sia liberata; la
parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto,
secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito (1463).
Il campo di applicazione è sostanzialmente lo stesso già identificato con riguardo alla risoluzione per
inadempimento: contratti onerosi, e non gratuiti; contratti con prestazioni corrispettive, ma anche
contratti con comunione di scopo.
Per questi ultimi, vale altresì la peculiare disciplina dettata in relazione alla possibile pluralità di parti
(contratti plurilaterali con comunione di scopo): divenuta impossibile la prestazione di una singola
parte, si apre l’alternativa fra scioglimento limitato alla singola posizione direttamente colpita e
scioglimento esteso a tutte le altre parti: si decide, ex 1466 (Nei contratti indicati dall’articolo 1420
[Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di
uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del
contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale]
l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle
altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.), in
base al criterio dell’essenzialità della prestazione venuta meno.
Sopravvenuta l’impossibilità, la risoluzione opera di diritto, senza bisogno di un atto di parte né di
provvedimento del giudice: la sentenza che la pronuncia è dichiarativa.
Non è rilevabile d’ufficio.
Può invocarla sia la parte che doveva ricevere la prestazione divenuta impossibile, per liberarsi
all’obbligo di controprestare o per ripetere la controprestazione già fatta, sia la parte impossibilitata,
che la farà valere soprattutto in via di eccezione, quando convenuta per l’adempimento o per la
risoluzione ex 1453 (Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non
adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del
contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche
quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi
l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione
l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.).
L’impossibilità della prestazione, che risolve il contratto ex 1463, è la stessa che estingue
l’obbligazione e libera l’obbligato ex 1256 (L’obbligazione si estingue quando, per una causa non
imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il
debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia
l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo
dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a
eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla).
L’impossibilità dev’essere sopravvenuta dopo la conclusione del contratto: se fosse anteriore o coeva,
darebbe luogo non a risoluzione ma a nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto.
L’impossibilità, per essere sicuramente risolutoria, dev’essere definitiva, cioè irreversibile.
Se è solo temporanea – cioè suscettibile di cessare, così che la prestazione potrà tornare possibile – si
crea una situazione regolata dal 1256.2.
L’impossibilità temporanea di per sé non risolve il contratto, e lascia vive le obbligazioni delle parti:
ma la parte impossibilitata ad adempiere non è responsabile del ritardo nell’adempimento.
Ci si può chiedere se l’altra parte debba la controprestazione: sembra ragionevole rispondere che può a
sua volta sospenderla opponendo un’eccezione d’inadempimento.
Ma col tempo anche l’impossibilità temporanea può diventare risolutoria.
Se infatti essa perdura fino a quando il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la
prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla, allora l’obbligazione si estingue: e
quindi, per via del sinallagma, si risolve il contratto.
Il momento in cui l’impossibilità temporanea da sospensiva si trasforma in risolutoria dipende dal titolo
della obbligazione e dalla natura dell’oggetto.
L’impossibilità deve dipendere da causa non imputabile al debitore (1256.1): i criteri dell’imputabilità
appartengono al diritto delle obbligazioni, e segnatamente al tema della responsabilità del debitore
inadempiente (1218: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile).
Se l’impossibilità fosse imputabile al debitore, si qualificherebbe come inadempimento: il contratto
sarebbe allora risolubile ex 1453 e seguenti.
Non sempre l’impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto, ancorché non
imputabile al debitore, ha effetto liberatorio e risolutorio.
Ha tale effetto quando la prestazione è dedotta in contratto come promessa di una condotta od impegno
ad uno sforzo, perché allora il rischio dell’impossibilità della prestazione grava sul creditore.
Se invece la prestazione vi è dedotta come mezzo per conseguire il risultato che il debitore garantisce al
creditore, l’impossibilità di essa è un rischio del debitore e quindi non produce effetto liberatorio né
risolutorio: il contratto resta in piedi.
L’effetto liberatorio e risolutorio della sopravvenuta impossibilità non imputabile può essere bloccato
dalla disciplina della mora accipiendi: se l’impossibilità della prestazione sopravviene durante la mora
del creditore, egli perde la prestazione ma resta obbligato alla controprestazione ex contractu (1207.1),
e quindi il contratto non si risolve.
Non può dirsi lo stesso per l’impossibilità sopravvenuta durante la mora del debitore: il creditore non
riceve la prestazione, ed è quindi giusto che sia liberato dalla controprestazione.
La regola per cui il debitore non è liberato (salva la prova liberatoria del 1220: Il debitore non può
essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza
osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia
rifiutata per un motivo legittimo) significa solo che egli è responsabile verso il creditore di tutto il
danno contrattuale.
Talora la prestazione non può essere adempiuta, per cause che si producono nella sfera del creditore.
Devono prima di tutto isolarsi i casi in cui viene in gioco non tanto l’impossibilità per il debitore di
eseguire la prestazione, quanto piuttosto la soggettiva impossibilità per il creditore di utilizzare la
prestazione: il contratto resta fermo; il creditore impossibilitato deve la sua controprestazione per
intero, e se l’ha già eseguita non può ripeterla (salvi diritti di recesso legali o convenzionali).
All’estremo opposto stanno i casi in cui la causa dell’impossibilità si produce nella sfera del creditore,
ma – oltre a non essergli imputabile – travalica la sua sfera soggettiva per investire la prestazione del
debitore, nella sua oggettiva fattibilità.
Qui deve parlarsi d’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (e
nemmeno al creditore): il contratto si risolve.
Più problematici sono i casi che si caratterizzano per un doppio elemento: l’impossibilità ha una
connotazione oggettiva, perché tocca la prestazione come tale; ed è imputabile al creditore che deve
riceverla (ad es. l’appaltatore non può ristrutturare l’immobile perché il committente continua ad
abitarlo): l’alternativa è fra due ordini di rimedi, di diversa intensità protettiva.
Il debitore come minimo può invocare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione: può quindi
chiedere la risoluzione, ma probabilmente con un limite: l’impossibilità è molto spesso temporanea;
sicché egli, prima di chiederla, dovrà attendere che maturi il termine del 1256.2, ed intanto resta
vincolato al contratto.
Può chiedere anche il risarcimento del danno: ma solo se ha previamente costituito il committente in
mora del creditore (1207 commi II e III: Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua
mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della
mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza
passata in giudicato o se è accettata dal creditore.).
La sua tutela è più forte, se ci si porta sul terreno dell’inadempimento: qualificando la prestazione non
come semplice onere di cooperazione del creditore (il committente) all’adempimento del debitore
(l’appaltatore), ma come vero e proprio obbligo contrattuale.
Se la qualificazione passa, i vantaggi sono evidenti: la risoluzione può chiedersi (o procurarsi con
diffida ad adempiere) non appena il ritardo del creditore raggiunga la soglia dell’importanza non scarsa,
senza bisogno di attendere la più impegnativa soglia temporale del 1256.2; e per il risarcimento non
occorre previa costituzione in mora.
Se l’impossibilità è parziale, si apre un’alternativa, regolata dal 1464 (Quando la prestazione di una
parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione
della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse
apprezzabile all’adempimento parziale).
Se la parte creditrice conserva interesse alla prestazione ancorché ridotta, il contratto resta fermo ed
essa ha diritto alla corrispondente riduzione della controprestazione a suo carico; se invece il creditore
non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale, può recedere dal contratto: tipico
recesso di autotutela.
La mancanza di interesse apprezzabile non dipende dall’arbitrio soggettivo del creditore, ma s’inscrive
in una dimensione di oggettività, riconducibile alla regola della buona fede.
Il 1465 si occupa dei casi in cui – dato un contratto traslativo o costitutivo di diritti reali – la cosa che
ne forma oggetto perisce per causa non imputabile all’alienante.
L’articolo contiene due ordini di regole.
La prima regola afferma che nei contratti traslativi o costitutivi, la prestazione dell’alienante si
considera sostanzialmente esaurita con il trasferimento o la costituzione del diritto, a prescindere dalla
consegna della cosa; per conseguenza, se la cosa perisce dopo che si è prodotto l’effetto traslativo o
costitutivo, il contratto resta ferma e l’acquirente è tenuto alla controprestazione anche se la cosa non
gli è stata ancora consegnata (res perit domino).
La regola si applica ai contratti costitutivi ed a quelli traslativi di una cosa determinata (1465.1: Nei
contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono
diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente
dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.), dove
l’effetto reale si produce col semplice consenso.
E si applica anche ai contratti traslativi di cose determinate solo nel genere, dove l’effetto reale si
produce con l’individuazione.
Un secondo ordine di regole riguarda la possibile incidenza di termine e condizione.
Quando l’effetto traslativo o costitutivo è differito ad un termine, ed il perimento avviene prima della
scadenza, continua ad applicarsi la regola per cui il contratto non si risolve: l’acquirente è tenuto alla
controprestazione (1465.2: La stessa disposizione [del 1465.1] si applica nel caso in cui l’effetto
traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.).
Diversamente accade quando l’effetto traslativo o costitutivo è sottoposto a condizione sospensiva: se
trasferimento o costituzione del diritto diventano impossibili prima dell’avveramento della condizione,
l’acquirente è liberato dalla sua obbligazione (1465.4: L’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua
obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è
sopravvenuta prima che si verifichi la condizione), dunque il contratto si risolve.
C’è dunque un certo rovesciamento dei normali concetti e principi: il termine, normalmente non
retroattivo, qui è come se operasse retroattivamente; la condizione, normalmente retroattiva, qui è
privata della sua retroattività: la legge fa prevalere un altro dato: la certezza del termine e l’incertezza
della condizione.
CAPITOLO XLVI – LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA
Quasi sempre i contratti impegnano il futuro, sicché il programma contrattuale si trova ad essere attuato
in un contesto diverso da quello esistente al momento in cui le parti lo hanno concordato.
I fatti che, intervenendo dopo la conclusione del contratto e prima della sua completa attuazione,
mutano il contesto in cui il contratto si attua, usano dirsi “sopravvenienze”.
Le parti possono considerare nel contratto stesso che determinate sopravvenienze potrebbero
intervenire a mutare il contesto in cui il rapporto si troverà ad attuarsi; e regolarne le conseguenze con
apposite clausole.
La condizione risolutiva sconta il sopravvenire dell’evento dedotto, e ne ricava lo scioglimento del
contratto; la clausola d’indicizzazione sconta il sopravvenire di un più ridotto potere d’acquisto della
moneta, e ne ricava l’aumento della quantità di moneta dovuta; etc.
I problemi sorgono, quando la sopravvenienza non è contemplata da nessuna clausola del contratto.
Occorre allora vedere se sia contemplata dalla legge; le sopravvenienze rilevanti come generatrici di
problemi non sono quelle neutre per l’interesse delle parti, ma sono quelle che pregiudicano l’interesse
di una parte.
Ciò che si tratta di vedere è essenzialmente se la legge dà alla parte gravata qualche rimedio.
Il più notevole blocco di rimedi contro le sopravveniente è previsto dalla legge a proposito
dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (1467 e seguenti).
Specifiche discipline della sopravvenienza sono dedicate a singoli tipi contrattuali: per es., appalto
(1664: Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel
costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori
al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una
revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che
eccede il decimo.
Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause
geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la
prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso) ed assicurazione (1897: Se il
contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che,
se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione
di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio
successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di
recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La
dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese; 1898: Il contraente ha l’obbligo di dare
immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo
stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del
contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio
più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto
all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza
dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se
l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo
quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un
premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al
momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano
trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde
qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il
nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta,
tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il
maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso).
I rimedi contro l’eccessiva onerosità sopravvenuta scattano in presenza di quattro presupposti.
Il primo è che almeno una delle prestazioni sia differita rispetto al tempo della conclusione del
contratto: questo deve essere cioè a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita
(1467.1).
Il secondo è che la prestazione non sia ancora esaurita, nel momento in cui viene colpita dall’onerosità.
Il terzo è che l’onerosità sopravvenuta sia eccessiva: il parametro dell’eccessività è dato dalla nozione
di alea normale del contratto (1467.2).
Il quarto è che l’onerosità dipenda dal verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili (1467.1).
Quando ricorrono tutti questi presupposti, il contratto si risolve o subisce un adeguamento
nell’interesse della parte gravata.
L’indagine sulla ratio del rimedio generalmente oscilla fra una concezione soggettivistica, propensa a
fondarlo sull’implicita o presunta volontà delle parti di condizionare la stabilità dell’impegno
contrattuale alla stabilità del contesto in cui questo si attuerà, e l’idea più oggettiva di reagire ad un
difetto della causa, perturbata dallo squilibrio che l’onerosità induce nella ragione di scambio fra
prestazione e controprestazione.
Occorre che il contratto preveda un lasso di tempo (anche breve) fra la conclusione e la completa
attuazione della prestazione.
Ciò avviene con i contratti di durata, siano ad esecuzione continuata oppure periodica; e con i contratti
ad esecuzione istantanea ma differita.
Per prestazione deve intendersi sia il comportamento o risultato dedotti in obbligazione, sia la
realizzazione di una vicenda giuridica (traslativa, costitutiva di un diritto reale, estintiva).
Una vendita con effetto reale immediato ma pagamento dilazionato è soggetta al rimedio, per il
differimento della prestazione relativa al prezzo; così pure una vendita con pagamento immediato ed
effetto reale differito; così pure una permuta fra cosa presente e cosa futura.
Se la consegna della cosa immediatamente trasferita è rinviata ad un momento successivo, ciò non
differisce la prestazione dell’alienante nel senso che qui rileva.
La prestazione è differita anche se il differimento riguarda solo parte di essa.
Si discute se la prestazione traslativa debba considerarsi differita, se sottoposta a termine o condizione
sospensiva: il 1465 sull’impossibilità sopravvenuta suggerisce di escludere dal rimedio i contratti sotto
termine, e di includervi quelli condizionati.
Nessun dubbio che il presupposto del differimento della prestazione dovuta sia presente nel contratto di
opzione: qui la prestazione non si esaurisce con l’attribuzione del diritto all’opzionario, effetto
immediato della conclusione del contratto; la prestazione è la soggezione del concedente alla scelta
potestativa dell’opzionario, e questa dura nel tempo fino alla scadenza dell’opzione.
Il secondo presupposto riguarda il tempo in cui sopravviene l’onerosità: questa deve sopravvenire
prima che la prestazione risulti esaurita.
Che accade se l’onerosità colpisce la prestazione in un momento nel quale questa non è esaurita, ma
sarebbe dovuta esserlo?
Occorre distinguere, a seconda che il ritardo nell’adempimento della prestazione sia legittimo od
illegittimo.
Il ritardo può essere legittimo perché autorizzato in base alla volontà delle parti (il creditore accorda
una proroga al debitore), o perché assistito da una giustificazione di legge (eccezione d’inadempimento,
impossibilità temporanea): in tal caso l’onerosità sopravvenuta dopo il termine originario lascia aperta
la via al rimedio.
Non così quando il ritardo è illegittimo, e cioè si configura come inadempimento imputabile.
In cosa consiste l’onerosità rilevante? La legge parla di prestazione divenuta eccessivamente onerosa
per il verificarsi…: in questo modo sembra riferirsi all’onerosità come ad una condizione che tocca
direttamente la prestazione dovuta da chi invoca il rimedio (onerosità diretta).
Ciò che importa è il mancato esaurimento della prestazione direttamente colpita dall’onerosità, e
dovuta da chi invoca il corrispondente rimedio.
Invece è irrilevante che sia o meno esaurita la controprestazione.
L’onerosità deve colpire la prestazione nella sua oggettività, non nelle condizioni soggettive del
debitore.
Ma la giurisprudenza estende il concetto di onerosità rilevante includendovi quella che potrebbe
definirsi onerosità indiretta: ovvero l’onerosità determinata, a carico della parte che deve la prestazione
non ancora esaurita, dallo svilimento della controprestazione attesa.
Deve comunque trattarsi di svilimento oggettivo, cioè di perdita di valore di mercato della
controprestazione.
Non rileva la minore costosità di questa, intervenuta nella sfera soggettiva di chi la deve.
La rilevanza dell’onerosità indiretta è subordinata alla condizione che anche la controprestazione svilita
non sia ancora esaurita al tempo dell’evento che la svilisce.
In sintesi: per attivare il rimedio, occorre sempre e comunque che la prestazione della parte che
l’invoca sia non esaurita al tempo della sopravvenienza; quanto alla controprestazione, bisogna
distinguere: nel caso di onerosità diretta (la prestazione diventa più costosa o preziosa) la
controprestazione può anche essere esaurita al tempo della sopravvenienza, invece nel caso di onerosità
indiretta (si svilisce la controprestazione) anche la controprestazione dev’essere ancora in itinere.
Il 1277 riguarda la liberazione del debitore: dice che, anche in presenza di svalutazione, il debitore si
libera pagando il nominale; ovvero, che il creditore non può pretendere l’adeguamento della
prestazione per tenere conto del ridotto valore d’acquisto della moneta che attende.
Il 1467 riguarda una più complessa serie di fenomeni.
Se la svalutazione è svalutazione della moneta nazionale rispetto alla moneta estera in cui deve farsi il
pagamento, colpito dall’onerosità (diretta) non è il creditore, ma il debitore di moneta; se invece la
svalutazione determina un’onerosità indiretta, da svilimento della controprestazione, onerato è il
creditore di moneta, come nella logica del 1277 (I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente
corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta
era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi
in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.).
Il creditore ha un’altra pretesa, datagli da un’altra norma (1467) che non riguarda la liberazione del
debitore di moneta, ma la liberazione del creditore di moneta, in quanto a sua volta debitore di una
controprestazione contrattuale: la pretesa a liberarsi dall’obbligo di controprestare, con la risoluzione
del contratto.
Per evitare la quale, è semmai il debitore a poter offrire (se vuole: ma non è obbligato) la somma
rivalutata.
La sopravvenuta onerosità può essere parziale: può colpire parte della prestazione dovuta; oppure una
clausola del contratto.
A seconda dei casi, il rimedio potrà limitarsi all’elemento direttamente colpito, oppure investire l’intero
contratto: dipende dall’autonomia dell’elemento colpito rispetto al resto del negozio.
La soglia entro la quale la sopravvenuta onerosità non è eccessiva è identificata dalla legge nel concetto
di alea normale del contratto: se l’onerosità vi rientra, la risoluzione non può essere domandata
(1467.2).
Ogni contratto espone le parti a qualche rischio: alea normale del contratto è la tipologia e la misura del
rischio che la parte implicitamente si assume col contratto.
Essa dipende in primo luogo dal tipo contrattuale, giacché ogni tipo incorpora un diverso piano di
ripartizione dei rischi fra i contraenti.
Ma alla considerazione del tipo deve aggiungersi l’apprezzamento di ogni altro dato personalizzante
che concorra a disegnare il piano di ripartizione dei rischi concretamente adottato dalle parti (il
particolare oggetto del contratto; clausole estranee alla disciplina del tipo, negoziate ad hoc; etc.).
Il tempo al quale riferirsi per misurare il valore delle prestazioni da mettere a confronto è quello del
giudizio.
Il quarto presupposto è che l’onerosità sopravvenuta si determini per il verificarsi di avvenimenti
straordinari e imprevedibili (1467.1).
L’avvenimento può essere naturale o umano.
Può essere tecnico, economico, politico, normativo: anche una nuova legge è valutabile come fonte di
onerosità sopravvenuta (non, però, se contempla e regola essa stesa gli aggravi che possono derivarne
sulle parti di rapporti contrattuali in corso).
È prevedibile – dice la giurisprudenza – ciò che un uomo medio potrebbe prevedere al tempo del
contratto.
Ma aggiunge: alla luce della natura del contratto, delle qualità dei contraenti, delle condizioni del
mercato, ed in definitiva di ogni significativo elemento individualizzante.
Sulla base di questi criteri, spetta al giudice identificare, in relazione al caso singolo, la soglia della
prevedibilità: giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione.
Il giudizio si gioca essenzialmente su due dati: il grado di specificità ed il grado di probabilità del fatto
sopravvenuto, cui riferire la possibilità di prevederlo.
Più alto il grado di specificità che si assume, più facilmente il fatto dovrà considerarsi imprevedibile.
Che vi sia un po’ d’inflazione è scontato, e dunque prevedibile; ma può essere imprevedibile l’abnorme
impennata del tasso d’inflazione.
Può avere notevole rilievo la durata del contratto: più questa è lunga, più aumenta il grado di
probabilità, e dunque di prevedibilità, di certi eventi.
I rimedi legali contro le sopravvenienze non hanno spazio quando la sopravvenienza è stata
contemplata e regolata dalle parti con una clausola del contratto, ma ciò vale solo quando la
sopravvenienza realizza esattamente il rischio dedotto nella clausola, e non un rischio diverso o
maggiore.
Se si realizzano i presupposti, la parte incisa dalla sopravvenienza può domandare la risoluzione del
contratto (1467.1).
Il rimedio si attiva, normalmente, proponendo in giudizio domanda di risoluzione: dunque facendo
valere l’onerosità in via di azione.
Ci s’interroga se la si possa far valere anche in via di eccezione.
Se in un contratto di durata A conviene B per l’adempimento, B può certo difendersi eccependo
l’eccessiva onerosità.
Altra questione è se l’onerosità dia alla parte gravata una ragione per respingere legittimamente, prima
e al di fuori di un giudizio, la pretesa di adempimento di controparte; la legge non ha codificato nessuna
eccezione di onerosità.
L’inadempimento anteriore alla sopravvenienza preclude all’inadempiente il rimedio.
L’inadempimento posteriore alla sopravvenienza non preclude il rimedio, ma non è giustificato (da
un’eccezione di onerosità sopravvenuta, che non esiste).
Quindi l’inadempiente risponde del danno prodotto dall’inadempimento fino alla domanda di
risoluzione per eccessiva onerosità, che egli abbia tardivamente proposto (e che venga poi accolta).
Si domanda se, al fine di giustificare il proprio inadempimento, la parte gravata debba necessariamente
proporre domanda giudiziale di risoluzione, o possa limitarsi ad una dichiarazione stragiudiziale con
cui lamenti l’onerosità ed indichi il proprio intento risolutorio.
Dipende: se controparte non risponde o addirittura contesta, la parte gravata ha l’onere di passare
all’iniziativa giudiziale; ma se la risposta di controparte è tale, da suscitare affidamento circa la sua
comprensione per la situazione dell’onerato, alla successiva pretesa di adempimento e/o risarcimento
potrà opporsi un’eccezione di dolo generale.
La risoluzione per eccessiva onerosità consegue alla sentenza che la pronuncia: si tratta di sentenza
costitutiva.
Secondo il modello comune, la risoluzione non retroagisce contro i terzi, ma è retroattiva fra le parti,
generando obblighi di restituzione.
Peraltro la retroattività rimonta al momento del contratto solo per i contratti ad esecuzione differita.
Invece nei contratti di durata essa non pregiudica le prestazioni già eseguite, o più precisamente
eseguite prima della sopravvenienza onerosa.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le
condizioni del contratto (1467.3).
La riduzione ad equità è un diritto potestativo del convenuto in risoluzione.
La riduzione ad equità non può essere pretesa dal gravato, e tanto meno applicata dal giudice d’ufficio.
Sappiamo che, rispetto al contratto rescindibile, la riduzione ad equità deve recuperare l’intero
squilibrio di valori.
Per il contratto risolubile, può invece pensarsi che basti offrire quanto sufficiente a riportare lo
squilibrio entro i limiti dell’alea normale del contratto.
Ciò si ricava dalla diversa natura dei difetti del contratto, contro cui si reagisce.
Il 1468 si occupa del caso in cui l’onerosità colpisce la prestazione dovuta in base a contratto nel quale
una sola delle parti ha assunto obbligazioni: qui il rimedio per la parte gravata non è la risoluzione, ma
il diritto di chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di
esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
La formula dei contratti in cui una sola delle parti ha assunto obbligazioni riecheggia quella del 1333,
relativa ai contratti con obbligazioni del solo proponente, che si concludono senza accettazione.
Il 1333 non copre la donazione, il cui formalismo richiede un diverso procedimento di conclusione; né i
contratti reali gratuiti, che esigono la consegna; né forse il mandato gratuito, perché implica obblighi di
provvista o rimborso a carico del mandante, ed un’intrusione del mandatario nella sua sfera: invece tutti
questi contratti sono aperti al rimedio del 1468.
I rispettivi campi di applicazione degli artt. 1467 e 1468 non sempre sono distinti; si consideri
un’opzione: se a fronte del diritto concesso è previsto un corrispettivo per il concedente, si applica il
1467; se non è previsto un corrispettivo si applica solo il 1468.
Sono soggetti al rimedio i contratti di durata e quelli ad esecuzione differita; ne sono esclusi i contratti
ad esecuzione istantanea ed immediata.
Ai contratti gratuiti (con obbligazioni di una sola parte) s’applica esclusivamente la riduzione ad equità;
ai contratti onerosi si applica in via primaria la risoluzione, ed in via eventuale la riduzione ad equità.
Secondo il 1469 i rimedi non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle
parti.
I contratti aleatori sfuggono ai rimedi contro l’onerosità sopravvenuta, solo in quanto la sopravvenienza
realizzi esattamente il rischio giuridico-economico che – nel disegno legale del tipo, o nell’assetto
voluto dalle parti – costituisce l’alea di quel determinato contratto; ma se realizza un rischio maggiore o
diverso, i rimedi operano.
Per quanto riguarda i contratti associativi, se il rischio imprevedibile colpisce l’insieme delle
prestazioni di tutti i soci in quanto destinate all’organizzazione sociale, allora si tratta di un rischio
sociale che ogni socio ha scelto di correre e deve sopportare; ma se invece colpisce in modo
differenziato la prestazione del singolo socio, contro questo rischio individuale non c’è ragione di
negare i rimedi.
S’è anche sostenuto che i rimedi siano inapplicabili ai contratti preliminari, perché l’onerosità
colpirebbe non la prestazione propria di questi (concludere il definitivo), ma la prestazione dedotta nel
definitivo.
La tesi va respinta: la parte colpita dalla sopravvenienza dovrebbe concludere il definitivo, salvo
chiederne poi la risoluzione per l’onerosità sopravvenuta già in pendenza del preliminare.
Dal campo del 1467 restano fuori le prestazioni conformate da norme imperative: la tesi può
condividersi, limitatamente ai casi in cui l’onerosità lamentata colpisca proprio l’interesse che la
politica del legislatore ha voluto sacrificare; non, invece, se l’onerosità colpisce un interesse diverso.
CAPITOLO XLVII – PRESUPPOSIZIONE,
E RIMEDI MANUTENTIVI (DI ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO)
L’inadeguatezza del sistema dei rimedi codificati può manifestarsi sotto un duplice profilo.
Può essere inadeguatezza nella descrizione delle fattispecie che danno luogo ad un qualche rimedio.
Occorre allora escogitare qualche rimedio nuovo, non codificato: risponde a questa esigenza la figura
della presupposizione, creata praeter legem dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
A compra da B un terreno edificabile, pagandolo al prezzo di un terreno edificabile, perché vuole
edificarvi; ma poco dopo il piano regolatore cambia, ed il terreno diventa inedificabile: il contratto
diventa così pesantemente dannoso per A.
Se si fosse pattuita la condizione risolutiva della sopravvenuta inedificabilità, A potrebbe invocare lo
scioglimento del contratto; A non può chiedere l’annullamento per errore, allegando che ignorava la
prospettiva dell’inedificabilità, poi verificatasi: l’errore di previsione, che cada su eventi futuri, non è
rilevante perché si considera errore sui motivi, non essenziale.
Non può chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità, ad es. perché le prestazioni non erano differite,
o comunque sono esaurite.
A può invocare il principio della presupposizione, ed il giudice accoglie la sua domanda di liberarsi del
contratto, rilevando che è venuto meno un presupposto del contratto stesso (l’edificabilità del terreno).
Il presupposto può essere una situazione di fatto o di diritto.
Può riguardare una situazione presente o futura.
Deve essere obiettivo ed esterno al contratto: cioè indipendente dalla volontà e dall’attività dei
contraenti, e non dedotto a materia di un’obbligazione contrattuale.
Deve essere non contemplato dal contratto.
Deve essere condiviso da entrambe le parti; o, se assunto da una sola di esse, quanto meno noto
all’altra.
Deve essere inteso dalle parti (o da una parte, nella consapevolezza dell’altra) come dotato di valore
determinante per la costituzione o la permanenza del vincolo contrattuale.
Deve essere percepito come certo: se le parti lo percepissero come incerto, tale percezione
autorizzerebbe a pensare ch’esse hanno accettato il rischio della sua inesistenza o del suo venir meno.
La giurisprudenza non è univoca nel fissare il rimedio applicabile quando la situazione presupposta
come presente al tempo del contratto risulta invece inesistente; o quando la situazione presupposta
come destinata a crearsi o permanere in futuro non si crea o viene meno successivamente.
Spesso parla, indistintamente, d’invalidità o di risoluzione.
Può pensarsi di riferire l’invalidità ai casi di difetto originario, e la risoluzione ai casi di difetto
sopravvenuto.
Il fondamento della figura viene indicato nel principio di buona fede (oggettiva).
La buona fede precontrattuale (1337: Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto, devono comportarsi secondo buona fede) indica come è giusto distribuire fra le parti obblighi
d’informare ed oneri d’informarsi su presupposti e rischi dell’operazione; la buona fede ermeneutica
(1366: Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede) aiuta a trovare il senso del testo
contrattuale in ordine al piano di ripartizione dei rischi; la buona fede esecutiva (1375: Il contratto deve
essere eseguito secondo buona fede), fonte d’integrazione del contratto, può fondare o bloccare pretese
delle parti, in relazione al venir meno del presupposto.
I rimedi contrattuali sono tendenzialmente ablativi: contro i difetti del contratto, essi per lo più
reagiscono con la cancellazione dei suoi effetti.
Ciò vale in particolare per i rimedi sinallagmatici.
In generale, la risoluzione si presenta inidonea nei casi in cui il contratto serve a realizzare operazioni
di lunga durata, tecnicamente complesse ed economicamente impegnative, che sono difficilmente
reversibili.
Contratti del genere hanno la caratteristica d’implicare una relazione molto intensa fra le parti, ognuna
delle quali organizza la propria sfera proprio in funzione di quel rapporto con l’altra: essi si definiscono
relazionali (relational contracts).
Occorrono dunque rimedi non ablativi, ed in particolare non risolutori: bensì rimedi che chiamiamo
manutentivi, perché puntano a mantenere in vita il contratto; o di adeguamento, perché salvano il
contratto adeguandolo alle circostanze ed esigenze sopravvenute.
La propensione a salvare, mediante adeguamento, contratti altrimenti votati alla cancellazione, è
presente in modo diffuso nel sistema legale.
L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento, ma a rettifica.
Ed il contratto viziato da ogni genere d’errore non è annullabile se viene rettificato.
Il contratto rescindibile per lesione e quello risolubile per eccessiva onerosità non si risolvono se
interviene riduzione ad equità.
La sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione può determinare lo scioglimento del contratto
mediante recesso del creditore; ma il contratto può anche mantenersi, riducendosi la controprestazione
a suo carico.
La vendita di cosa affetta da vizi può risolversi; ma in alternativa può mantenersi, previa riduzione del
prezzo (1492.1: Nei casi indicati dall’articolo 1490 [Il venditore è tenuto a garantire che la cosa
venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in
modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il
venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa] il compratore può domandare a sua
scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi
escludano la risoluzione.).
Talora l’adeguamento è un risultato voluto dalla legge come modalità di buon funzionamento del
rapporto, a prescindere dalla prospettiva della sua cancellazione: il mandatario deve informare il
mandante delle sopravvenienze che possono richiedere modificazioni dell’incarico (1710.2), ed il
mandante è legittimato ad introdurre tali modificazioni.
Talora l’adeguamento scatta in modo automatico; talora è collegato ad un’iniziativa di parte.
La parte legittimata ad introdurlo può essere la parte a cui favore esso opera; ma in qualche caso può
essere controparte.
Qualche volta i contenuti dell’adeguamento sono predeterminati; altre volte sono determinati dalla
parte legittimata; altre volte ancora sono determinati dal giudice.
Ancor prima della legge, è lo stesso contratto che deve preoccuparsi del proprio futuro, dotandosi di
elementi di flessibilità; il contratto può far ciò avvalendosi di schemi legali tipici.
In generale, risponde all’obiettivo di un rapporto flessibile la possibilità di lasciare indeterminato
l’oggetto del contratto, ovvero l’adozione dello schema del contratto per relationem.
Con la fideiussione per debiti futuri (1938: La fideiussione può essere prestata anche per
un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo
garantito.), si può commisurare l’impegno di garanzia ad un’entità del credito che, non nota al tempo
del contratto, lo sarà solo in seguito.
Con le clausole di ius variandi si consente al titolare d’introdurre le modifiche del rapporto che gli
paiano di tempo in tempo convenienti.
Nel momento stesso in cui la legge mette questi schemi a disposizione dell’autonomia privata, li
circonda di limiti e cautele: la fideiussione per debiti futuri deve indicare la somma massima garantita;
le clausole di determinazione unilaterale e di ius variandi sono trattate con rigore.
Le clausole che in presenza di determinate sopravvenienze fanno scattare meccanismi di adeguamento
sono note come clausole di hardship (onerosità).
Esse mettono in campo tecniche adeguatrici.
Queste possono essere diverse, a seconda del fattore cui si affida l’operazione di adeguamento.
Il fattore può essere un dato obiettivo della realtà (un tasso, un corso dei prezzi): qui l’adeguamento è
automatico, sul modello delle clausole d’indicizzazione.
Può essere la determinazione di un terzo, cui si affida un arbitraggio eventuale ex post, di natura
modificativa.
Può essere la determinazione di una delle parti.
Può essere infine – e più spesso è – l’accordo delle parti, da cercare rinegoziando sui punti del rapporto
investiti dalla sopravvenienza: clausole di rinegoziazione.
Se la rinegoziazione fallisce perché una parte rifiuta tout court di rinegoziare, questa è violazione della
clausola, dunque inadempimento contrattuale.
Pur se la clausola non lo precisa, l’obbligo di rinegoziare va inteso come obbligo di rinegoziare
secondo buona fede.
Può darsi che le parti non abbiano pattuito alcun rimedio di adeguamento alle sopravvenienze.
Interviene anche qui il principio di buona fede.
Esso può generare a carico delle parti, che pur non lo abbiano previsto, un obbligo di rinegoziare.
Il meccanismo che lo inserisce ex lege nel regolamento contrattuale è l’integrazione.
Posto che chi rifiuta di rinegoziare, o rinegozia contro buona fede, è inadempiente, qual è il rimedio
contro il suo inadempimento?
Vien da rispondere: risoluzione e risarcimento: ma così si regredisce al risultato che la clausola voleva
evitare (la distruzione del contratto).
Qualcuno pensa al 2932: l’obbligo di rinegoziare è obbligo di contrarre le modifiche del contratto-base,
suggerite da ragionevolezza e buona fede; la parte che per inadempimento dell’altra non ottiene questo
contratto modificativo, cui ha diritto, può chiedere al giudice che lo costituisca con sua sentenza.