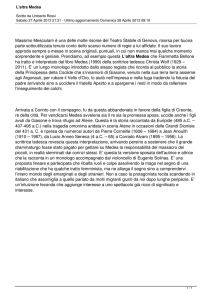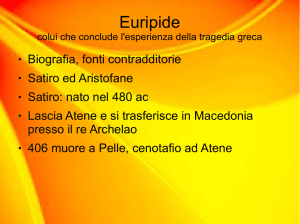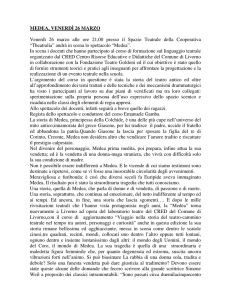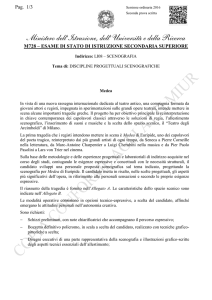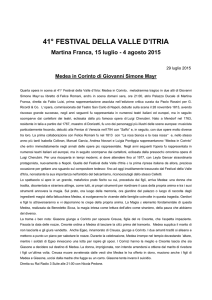EURIPIDE E LA CRISI DELLA RAGIONE
Euripide portò il linguaggio tragico all' estremo limite, oltre il quale la tragedia cessa di essere una
tragedia nel senso greco del termine e diviene teatro moderno: è in questa prospettiva appunto che
Nietzsche definì Euripide il distruttore della tragedia. Di questo aspetto anche i contemporanei si
avvedevano: Aristofane, che amava deridere Euripide e il suo teatro, scherniva i suoi «eroi pezzenti»
che parlano come uomini e donnette qualsiasi, hanno pensieri comuni e sono presentati come un
concentrato di vizi, meschinità, miserie. Nessuno degli eroi euripidei è infatti grande nel senso morale
del termine - nel senso, per esempio, in cui sono grandi gli eroi sofoclei, soli davanti al destino ma
consapevoli della propria natura eccezionale. In cambio, nessuno dei tre tragici ha portato così in
profondità lo studio dei caratteri e la psicologia dei personaggi. Questi cessano di essere eroi ritagliati
nella stoffa esemplare del mito e divengono straordinariamente vicini al sentire comune: non di rado
Euripide trova un posto nella trama a personaggi di condizione sociale inferiore (nutrici, pedagoghi,
schiavi, contadini) che recitano fianco a fianco con i personaggi principali e talvolta hanno un ruolo
importante nell' azione drammatica.
Appiattendo la distanza tra il mito (inteso come contenitore di valori culturali, religiosi e sociali) ed
esperienza quotidiana, Euripide contribuisce quindi al suo smantellamento o quantomeno esprime in
maniera esemplare l'atteggiamento scettico e razionalista di molti intellettuali del tempo nei confronti
della tradizione precedente (egli è il tragediografo su cui più forte si è fatto sentire l'influsso sofistico).
Il dato più evidente e più nuovo di Euripide è la sua capacità di penetrare con acutezza straordinaria nei
labirinti delle emozioni e delle angosce dei suoi eroi. I suoi personaggi infatti sono mossi da impulsi
profondi di cui tuttavia non sono padroni; così, anch'essi appaiono sovradeterminati, non però dagli dèi
o dal destino (come aveva insegnato la tragedia precedente) bensì dalle forze irrazionali, che si agitano
dentro di loro e li spingono ad agire oltre ogni regola e anche oltre la loro stessa volontà: «io so che sto
agendo male - dice Medea - ma il mio animo (thymòs) è più forte della mia volontà». Così, il teatro di
Euripide esprime attraverso i suoi eroi la grandezza e la crisi della ragione umana: i suoi personaggi
sono capaci di analizzare lucidamente i moventi e le cause vicine e lontane dei fatti, discutono,
sottilizzano, ma restano impigliati nel loro stesso raziocinare e divengono vittime di forze oscure e
profonde che operano dentro di loro. Rinunciando a trovare un movente esterno e superiore all'uomo (gli
dèi, il destino), che giustifichi il groviglio delle azioni e delle passioni, lasciando completamente soli i
suoi eroi con le loro azioni di cui neppure essi sanno controllare gli sviluppi, Euripide smaschera
l'aspetto più brutale, ma anche più crudelmente autentico, della realtà sia umana che sociale: la feroce
insensatezza della guerra (nelle Troiane), il cinismo del politico che sacrifica la vita di sua figlia per il
potere (nell'Ifigenia in Aulide), l'aridità di chi utilizza affetti e sentimenti per un proprio egoistico
progetto di vita (in Medea e Andromaca); e poi ancora, in modo inquietante, la crisi della famiglia e
quella della convivenza cittadina che compaiono quasi ovunque nel suo teatro e sono il motivo di fondo
della crisi dei suoi personaggi. Euripide fu quindi un grande provocatore per la massa del pubblico
ateniese che assisteva agli spettacoli tragici ed era legato ai valori tradizionali, e ciò spiega il numero
tanto esiguo di vittorie (appena cinque) che egli conseguì, soccombendo anche a rivali di molto inferiori
per abilità.
In Euripide si fa nettamente sentire l'influsso dei sofisti, con la loro critica al mito e la loro visione laica
della realtà. Gli antichi accusavano infatti Euripide di «ateismo», e in effetti gli dèi sono
contemporaneamente assai lontani e assai vicini al suo mondo. Sono vicini sulla scena: essi compaiono
spesso nel prologo o nell'esodo dell'azione (con l'espediente del deus ex machina) ma operano solo
come personaggi teatrali. La loro lontananza è una distanza morale: infatti, il teatro euripideo cessa di
essere un fatto «religioso» (nel senso greco del termine) per diventare un luogo dove solo l'uomo e la
società operano, con le loro pulsioni e i loro intrecci di passioni e di potere. Euripide ritaglia le sue
azioni contro un cielo vuoto: il mondo divino gli appare muto di risposte e popolato da forze
incomprensibili se non ostili. Gli dèi vi si stagliano perfino meschini, nella 1oro assoluta indifferenza
verso la giustizia e la vita umana. Euripide non dà né cerca alcuna spiegazione per l'incomprensibile e
doloroso destino riservato a tutti gli uomini, soprattutto ai buoni e nobili che appaiono tanto più indifesi
davanti al gioco dei potenti e ai capricci del destino, una coltre scura a cui manca la trama
dell'insondabile intervento divino.
La polemica contro la religione tradizionale non è il solo aspetto in cui Euripide esprime la sua lucida e
sovvertitrice analisi e anche se le radici della tragedia stanno nelle contraddizioni e nelle passioni dei
personaggi, il dramma euripideo non rinuncia a trasferire i conflitti individuali su un piano sociale: lo
scontro di potere all'interno di una città o di una famiglia, in cui ogni norma morale appare sovvertita o
dimenticata; le forme possenti e distruttrici che assume i1 desiderio amoroso trasformato in un'energia
rovinosa e incontenibile; il conflitto tra sentimenti e pulsioni contrapposti; la follia che si scatena
all'interno di una mente e che trasforma una vita calma e felice in un deserto di rovine. Sono soprattutto
i personaggi femminili - come Fedra e Medea - a esprimere pienamente questo nuovo universo di
sensibilità; le donne, escluse dalla vita politica, non inibite da modelli pubblici di comportamento,
possono meglio esprimere sulla scena tragica quell'immediatezza di sentimenti, quella dimensione
istintiva ma profondamente vera della passione e della sofferenza, che Euripide sa tradurre in momenti
d'intenso e lucido patetismo.
I grandi personaggi femminili: Medea e Ippolito
MEDEA
A pochi anni di distanza tra il 431 e il 428, Euripide compose due delle sue tragedie più importanti, due
capolavori del teatro mondiale: Medea e Ippolito. Esse presentano il pieno sviluppo del personaggio
come centro dell'azione drammatica; ne emergono due figure femminili che costituiscono una specie di
contraltare alla dolce Alcesti: due donne ciascuna a suo modo ribelle alle leggi della famiglia,
perturbatrici, inquietanti, portatrici di sciagura.
Dopo averlo aiutato nella conquista del vello d'oro, abbandonando per lui la propria patria, e avergli dato dei figli,
Medea viene ripudiata da Giasone, che le preferisce la figlia del re di Corinto, Creonte. Disperata e furibonda, Medea si
lamenta della propria sorte davanti alle donne corinzie e medita vendetta contro lo sposo. Ottenuta da Creonte la
possibilità di rimanere a Corinto ancora un giorno, ella innanzitutto affronta Giasone rinfacciandogli la sua ipocrisia e la
sua viltà; quindi, dopo aver ottenuto dal re di Atene Egeo (che si trovava a Corinto di passaggio) la promessa di venire
un giorno ospitata da lui, finge di essersi rappacificata con Giasone e, tramite i figli, invia una ghirlanda e una veste
avvelenate alla nuova sposa come doni nuziali. Quando giunge la notizia dell'atroce fine della donna e di suo padre, che
ha invano tentato di salvarla ed è rimasto vittima dello stesso veleno, Medea porta a compimento la vendetta contro
Giasone, a lungo meditata: pur con il cuore straziato, uccide i propri figli e lascia Giasone annientato dal dolore
allontanandosi sul carro alato del Sole.
La tragedia è costruita attorno alla vendetta di Medea che dapprima elimina la rivale e poi, in un
parossismo di ferocia, uccide i propri figli per infliggere a Giasone il dolore e 1'offesa più atroci. Medea
è dunque un grande personaggio, che domina il dramma dall'inizio alla fine: grande alla maniera di
Euripide, però; il che significa in primo luogo eccessiva, passionale, mossa da istinti elementari e capace
di una gamma vastissima di manifestazioni psicologiche. Quando la tragedia si apre, la protagonista
appare rabbiosa e smarrita mentre maledice il suo destino, in frasi spezzate e grida, in una monodia
recitata da fuori scena. Poi, riacquista il controllo della mente ed elabora lucidamente il suo piano: così,
con il procedere dell'azione, la vediamo mentre analizza davanti al coro le ragioni della propria
sofferenza; mentre affronta lo sposo smascherando il suo tradimento e la sua ipocrisia; mentre simula
sottomissione per ingannare i nemici; mentre prepara astutamente la sua fuga da Corinto; mentre
ripercorre in un disperato monologo le ragioni del suo agire, scissa tra l'affetto materno e il desiderio di
vendetta; mentre uccide i figli e infine, al sicuro sopra un carro alato, mentre degusta la sua vendetta
davanti a un Giasone affranto e impotente, nuovamente selvaggia e libera come quando Giasone l'aveva
conosciuta nella lontana terra dei Colchi. È caratteristico della visione tragica di Euripide mostrare il
personaggio in bilico tra irrazionalità e ragione, diviso tra pulsioni opposte; Medea sa analizzare
lucidamente il suo stato d'animo, ma non può impedirsi di rimanere vittima delle forze oscure e
irrazionali che si agitano dentro di lei. Così, in Euripide la persona è una e molteplice nello stesso
tempo, e questo è un tratto del tutto nuovo all'interno del genere tragico. Chi è infatti Medea? Una donna
gelosa, una folle, un'assassina e infanticida, una vittima di se stessa? Forse tutto questo, e altro ancora,
nello stesso tempo: con questo personaggio il teatro di Euripide rivela quanto sia complessa e
contraddittoria l'identità di una persona e nello stesso tempo sottrae questa percezione a un giudizio
morale. Questo mondo interiore cosi psicologicamente evoluto (e anche così ricco di possibilità
artistiche) appare per la prima volta con impressionante forza appunto nella Medea. Il personaggio della
protagonista è straordinario nella sua mescolanza di primitiva pulsione al possesso, di sentimenti
calpestati, di efferatezza: ma certamente essa è - per usare un termine della drammaturgia moderna - un
«eroe negativo», che suscita solidarietà e insieme sconcerto ed orrore.
La personalità primordiale e barbara di questa figura femminile sembra aver affascinato non poco la
mente di Euripide; ancora Medea infatti, con i suoi filtri e la sua astuzia crudele, la sua natura di maga e
di straniera, così lontana dalla psicologia ateniese, così diversa dai consueti modelli femminili, ritornava
in due altre tragedie, perdute, di Euripide (le Peliadi, con cui il tragediografo iniziò la sua carriera
teatrale nel 455 a.c. e l'Egeo).
Sarebbe però limitativo vedere nella Medea solo una storia personale di gelosia e di vendetta; alle sue
spalle si delinea una critica al modello tradizionale di famiglia. Quel Giasone che arriva sulla scena
stupito per la gelosia di Medea e che ragiona in termini di ordine familiare, affermando che la cosa più
importante è dare figli legittimi alla città; quel Giasone, il quale è seriamente convinto che Medea non
possa chiedere niente di più che essere strappata alla barbarie del suo mondo marginale, agli occhi del
pubblico non era un puro e semplice fellone: rappresentava anzi le idee del cittadino medio ateniese, e
aveva, dal punto di vista del diritto cittadino, ragione: infatti le leggi della polis escludevano dalla
cittadinanza i figli di un coniuge straniero, e chi non dava figli alla città era socialmente biasimato.
Senonché, Medea viene da un altro mondo: quello barbaro, appunto, dominato da altre leggi. Quello tra
Giasone e Medea non è solo il conflitto tra un uomo infedele e una donna gelosa: è anche uno scontro
antropologico tra culture e mentalità diverse, tra la cultura barbara e quella greca, tra la cultura maschile
della famiglia patriarcale e quella femminile delle passioni, tra la legge (nomos) della città e la natura
(physis) che opera nella possente emotività di Medea - un dibattito questo fondamentale nell'Atene del
secolo v. È appunto questa distanza antropologica a rendere impossibile la vera comprensione fra i due
personaggi, e il risultato è una deflagrazione di ferocia e di violenza, da entrambe le parti: quella fredda
e in apparenza legalitaria di Giasone e quella selvaggia ed efferata di Medea.
La tragedia si chiude con una totale frattura: dietro queste stragi non c'è alcun progetto divino, alcuna
giustizia che interviene a equilibrare, e probabilmente non c'è alcun senso in quello che si è consumato.
Tutti in modi diversi hanno perduto qualcosa, e sono in particolare i più deboli e i più innocenti (i figli
di Medea, la giovane principessa di Corinto) a essere immolati. Giasone, dal canto suo, non è certo un
personaggio esemplare: appare evidente anzi l'intento di presentarlo in tono minore, poco più che un
omuncolo opportunista. Così la Medea vive soprattutto della sua protagonista - una parte che da sempre,
nella storia del teatro, richiede un attore di superiori qualità artistiche - e della trama di vendetta che sa
costruire.
IPPOLITO
Il prologo è recitato da Afrodite, che riferisce di sentirsi offesa da Ippolito, figlio di Teseo, perché questi, devoto ad
Artemide, rifiuta l'amore e si dedica soltanto alla caccia, conservandosi ostinatamente casto: perciò la dea ha infuso in
Fedra, matrigna di Ippolito, un amore furioso e colpevole per il figliastro. Per non disonorare se stessa e lo sposo, Fedra
appare decisa a lasciarsi morire senza fare parola della propria passione. La nutrice però riesce a farsi confidare la
cagione del suo male e, convinta di operare per il meglio, lo riferisce a Ippolito, che reagisce con sdegno e pronuncia
una violenta requisitoria contro la stirpe femminile. Vedendosi tradita e svergognata, Fedra si uccide. In quel momento
arriva Teseo; tra le mani della morta viene trovata una lettera in cui Fedra accusa il figliastro di averle fatto violenza.
Malgrado le proteste d'innocenza d'Ippolito, Teseo lo maledice e lo bandisce da Trezene, pregando Posidone di
accordargli una delle tre grazie che un tempo gli aveva promesso, punendo il figliolo. Poco dopo, un messaggero
racconta come i cavalli di Ippolito, imbizzarriti alla vista di un mostro marino suscitato da Posidone, abbiano sbalzato il
giovane dal carro, trascinandone il corpo sugli scogli. Condotto in scena ormai morente, Ippolito si congeda dall' amata
Artemide, che appare ex machina, e grazie all'intervento chiarificatore della dea può, prima di morire, convincere il
padre della propria innocenza.
Una prima versione di questa tragedia (l'Ippolito velato) andò incontro a un insuccesso, a causa
probabilmente della scabrosità dell'argomento agli occhi dei benpensanti. Qualche anno dopo Euripide
rimaneggiò l'opera e la ripresentò ai concorsi teatrali del 428 a.c. ottenendo il primo premio (questa
seconda versione era nota come Ippolito coronato).
Ippolito era un eroe venerato ad Atene e nella vicina città di Trezene, dove è ambientato il dramma
euripideo: il suo culto vi si celebrava ancora nel secolo II d.C., quando Pausania (Periegesi della Grecia
II, 32, 1-4) poté osservare un tempio e un recinto sacro dedicati a Ippolito; qui ogni anno venivano
celebrati sacrifici in suo onore e le ragazze di Trezene, prima del matrimonio, si tagliavano i capelli e
andavano a offrirli sulla tomba dell'eroe. Secondo il mito, Ippolito morì travolto dai cavalli (come rivela
il nome, da ippos, "cavallo", e lyo, "sciogliere"). Egli, dunque, rappresenta l'eroe che muore giovane e
viene divinizzato, secondo uno schema culturale che trova molti altri paralleli nel mito antico. Tra
l'altro, un culto di Ippolito si celebrava anche in Italia: secondo una variante del mito, Artemide (dai
latini identificata con Diana) aveva resuscitato il suo prediletto e lo aveva trasportato tra i boschi del
Lazio affidandolo alla ninfa Egeria. Qui egli visse in incognito e dedicò alla dea protettrice un bosco
sacro: il bosco di Nemi, da dove Enea staccò il magico ramo d'oro che gli dischiuse le porte dell'
oltretomba e dove sino alla tarda antichità si celebrava il truce sacrificio umano del «re del bosco».
Nella tragedia euripidea, Ippolito è solo il protagonista di un dramma familiare. Il motivo trattato
nell'Ippolito ricorre in vari racconti folklorici, ed è detto della «moglie di Putifar» (dall'episodio biblico
della donna che, respinta da Giuseppe, gli mosse la falsa accusa di aver tentato di sedurla); tuttavia
Euripide sviluppa un aspetto originale di questo tema tradizionale, spostando l'accento non
sulla seduzione ma sul tormento psicologico della protagonista.
Il prologo è recitato da Afrodite: prerogativa di questa dea è di infondere l'amore in chiunque e ora,
capricciosamente, ha deciso di destare una passione incestuosa tra una matrigna e un figliastro. Con
questo, il problema della colpa è eliminato: Fedra non è un'immorale, ma la vittima di una forza
possente e irresistibile; ciò consente di focalizzare il dramma sull'anatomia di una passione e sulle
sofferenze di Fedra, scissa nel conflitto tra i doveri della famiglia e la pulsione irresistibile che la agita,
un personaggio eccezionalmente «moderno» nel suo tormento psicologico. Anche Fedra, al pari di
Medea, porta alla rovina la sua casa, ma la sua non è una consapevole volontà di vendetta bensì una
forza oscura e possente che travolge e annienta la ragione: anche in lei quindi è presente il conflitto
culturale tra le leggi che regolano la convivenza civile e le forze istintive e primordiali presenti da
qualche parte negli abissi della mente umana (nella physis, dunque). Fedra è uno dei grandi personaggi
del teatro mondiale: entra in scena fuori di sé, abbandonandosi alle proprie fantasie, incapace perfino di
confessare il suo segreto; poi, lo fa emergere tra mille reticenze, passando dalla vergogna alla speranza;
infine, respinta, tutto questo amore si trasforma nella sua altra faccia, in una forza autodistruttiva che la
porta al suicidio e causa la rovina di chi le sta attorno.
In tutto questo, l'eroina non è mai pienamente padrona di se stessa; al contrario, Ippolito in nessun
momento smarrisce la sua gelida e dura rigidità; egli è l'immagine dell'efebo perennemente chiuso nel
suo mondo di cacciatore (dunque, una dimensione anch'essa «selvaggia» e precittadina) che non si
risolve a entrare nel gruppo degli adulti. Egli è troppo lontano dal sentire comune, inaccessibile nel suo
mondo marginale dove trova conforto solo nella caccia e nel rapporto con l'aspra natura del monte.
Ippolito infatti non respinge solo la matrigna, ma in generale l'amore; egli è vergine, fiero della sua
condizione e si rifiuta di accettare ogni legame. Come Fedra è prigioniera del suo desiderio impossibile,
Ippolito è in qualche modo amputato di un istinto primario dell'uomo. Per comprendere la ragione del
suo errore bisogna porsi nella prospettiva dell'antropologia ateniese del tempo: la sua non è una colpa
morale ma un atto di hybris, il rifiuto di accettare una componente della cultura comune. Fedra e
Ippolito sono due figure di «peccatori», poiché in modi diversi violano una legge culturale della polis:
l'uno e l'altra infatti con il proprio atteggiamento corrodono la cellula fondamentale della vita sociale,
vale a dire la famiglia. Due ciechi, dunque; e un terzo cieco è l'inflessibile Teseo che condanna a morte
suo figlio in nome dell'onore offeso, ma anche lui in preda agli eventi, senza ben rendersi conto di
quello che sta succedendo. Nessuno dei tre è malvagio o colpevole nel senso della piena responsabilità
morale, eppure tutti e tre vanno incontro a un destino infelice. Non c'è ragione o teologia che giustifichi
questi fatti, ma solo la consapevolezza che le radici della sofferenza e della follia stanno dentro l'uomo,
nelle sue passioni e nella sua incapacità di padroneggiare gli eventi.