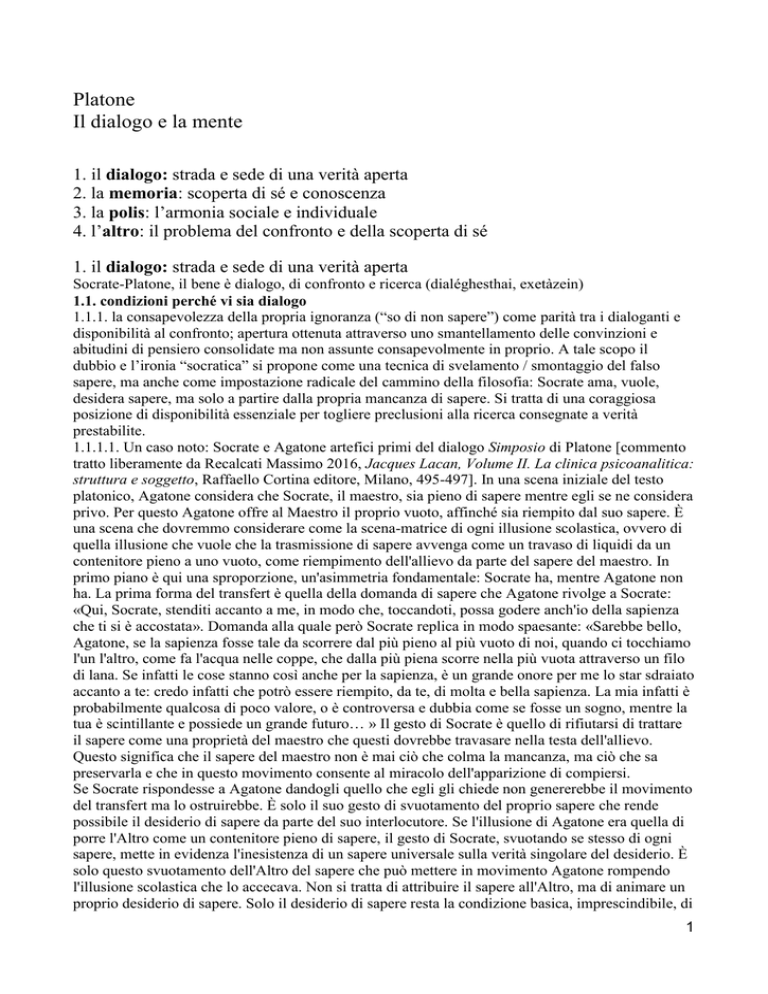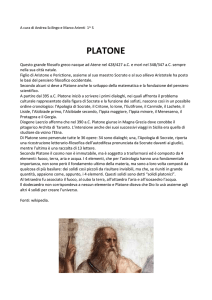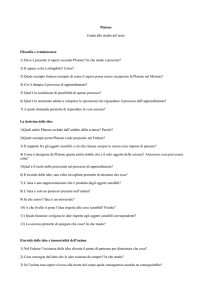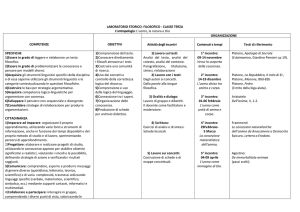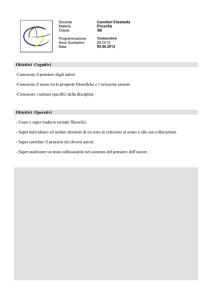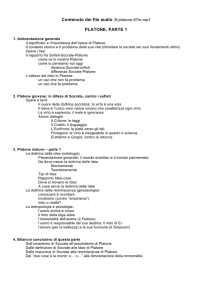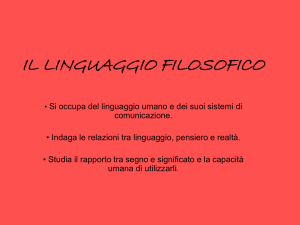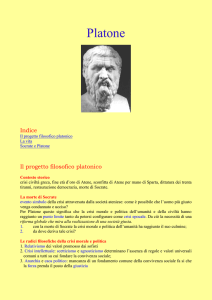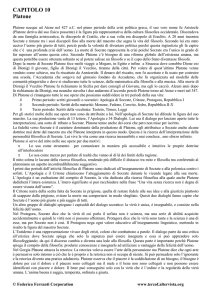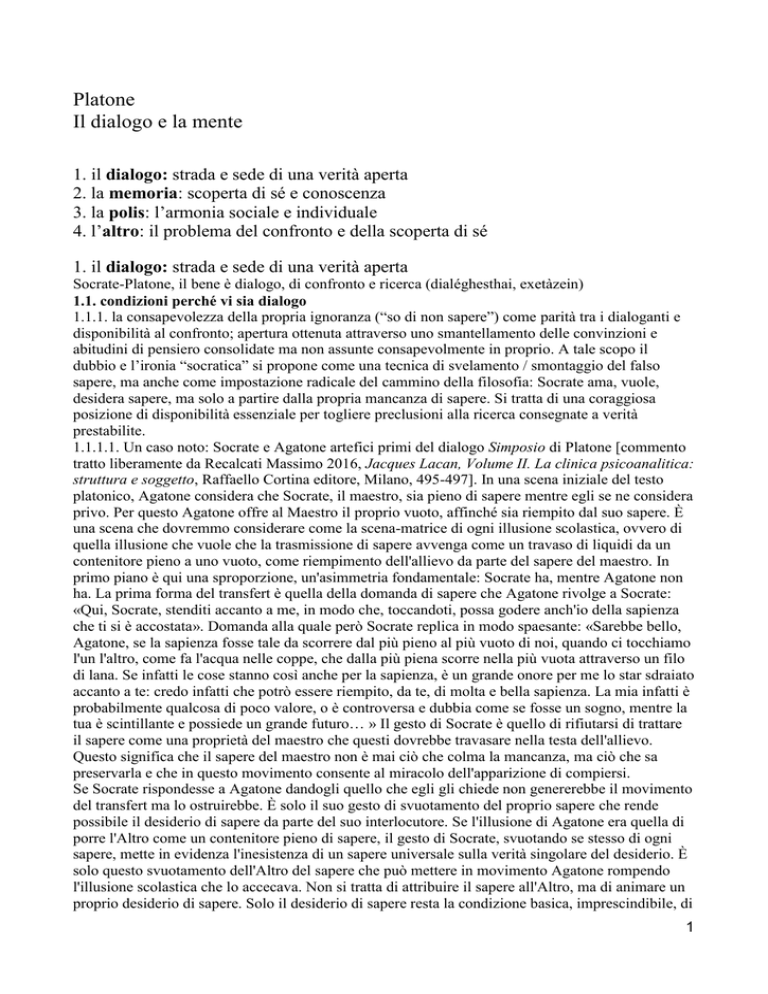
Platone
Il dialogo e la mente
1. il dialogo: strada e sede di una verità aperta
2. la memoria: scoperta di sé e conoscenza
3. la polis: l’armonia sociale e individuale
4. l’altro: il problema del confronto e della scoperta di sé
1. il dialogo: strada e sede di una verità aperta
Socrate-Platone, il bene è dialogo, di confronto e ricerca (dialéghesthai, exetàzein)
1.1. condizioni perché vi sia dialogo
1.1.1. la consapevolezza della propria ignoranza (“so di non sapere”) come parità tra i dialoganti e
disponibilità al confronto; apertura ottenuta attraverso uno smantellamento delle convinzioni e
abitudini di pensiero consolidate ma non assunte consapevolmente in proprio. A tale scopo il
dubbio e l’ironia “socratica” si propone come una tecnica di svelamento / smontaggio del falso
sapere, ma anche come impostazione radicale del cammino della filosofia: Socrate ama, vuole,
desidera sapere, ma solo a partire dalla propria mancanza di sapere. Si tratta di una coraggiosa
posizione di disponibilità essenziale per togliere preclusioni alla ricerca consegnate a verità
prestabilite.
1.1.1.1. Un caso noto: Socrate e Agatone artefici primi del dialogo Simposio di Platone [commento
tratto liberamente da Recalcati Massimo 2016, Jacques Lacan, Volume II. La clinica psicoanalitica:
struttura e soggetto, Raffaello Cortina editore, Milano, 495-497]. In una scena iniziale del testo
platonico, Agatone considera che Socrate, il maestro, sia pieno di sapere mentre egli se ne considera
privo. Per questo Agatone offre al Maestro il proprio vuoto, affinché sia riempito dal suo sapere. È
una scena che dovremmo considerare come la scena-matrice di ogni illusione scolastica, ovvero di
quella illusione che vuole che la trasmissione di sapere avvenga come un travaso di liquidi da un
contenitore pieno a uno vuoto, come riempimento dell'allievo da parte del sapere del maestro. In
primo piano è qui una sproporzione, un'asimmetria fondamentale: Socrate ha, mentre Agatone non
ha. La prima forma del transfert è quella della domanda di sapere che Agatone rivolge a Socrate:
«Qui, Socrate, stenditi accanto a me, in modo che, toccandoti, possa godere anch'io della sapienza
che ti si è accostata». Domanda alla quale però Socrate replica in modo spaesante: «Sarebbe bello,
Agatone, se la sapienza fosse tale da scorrere dal più pieno al più vuoto di noi, quando ci tocchiamo
l'un l'altro, come fa l'acqua nelle coppe, che dalla più piena scorre nella più vuota attraverso un filo
di lana. Se infatti le cose stanno così anche per la sapienza, è un grande onore per me lo star sdraiato
accanto a te: credo infatti che potrò essere riempito, da te, di molta e bella sapienza. La mia infatti è
probabilmente qualcosa di poco valore, o è controversa e dubbia come se fosse un sogno, mentre la
tua è scintillante e possiede un grande futuro… » Il gesto di Socrate è quello di rifiutarsi di trattare
il sapere come una proprietà del maestro che questi dovrebbe travasare nella testa dell'allievo.
Questo significa che il sapere del maestro non è mai ciò che colma la mancanza, ma ciò che sa
preservarla e che in questo movimento consente al miracolo dell'apparizione di compiersi.
Se Socrate rispondesse a Agatone dandogli quello che egli gli chiede non genererebbe il movimento
del transfert ma lo ostruirebbe. È solo il suo gesto di svuotamento del proprio sapere che rende
possibile il desiderio di sapere da parte del suo interlocutore. Se l'illusione di Agatone era quella di
porre l'Altro come un contenitore pieno di sapere, il gesto di Socrate, svuotando se stesso di ogni
sapere, mette in evidenza l'inesistenza di un sapere universale sulla verità singolare del desiderio. È
solo questo svuotamento dell'Altro del sapere che può mettere in movimento Agatone rompendo
l'illusione scolastica che lo accecava. Non si tratta di attribuire il sapere all'Altro, ma di animare un
proprio desiderio di sapere. Solo il desiderio di sapere resta la condizione basica, imprescindibile, di
1
ogni assimilazione del sapere. Non c'è assimilazione soggettiva del sapere se non a partire da un
desiderio di sapere. È proprio tale desiderio che il gesto di Socrate fa nascere nel suo allievo.
Agatone non pone più l'oggetto del proprio desiderio nel sapere dell'Altro, ma gli diventa adesso
possibile fare esistere un proprio singolare desiderio di sapere. È questa la situazione filosofica per
etimologia e per essenza. Questo accade in ogni forma di trasmissione efficace del sapere.
Facendosi vuoto di sapere Socrate indica l'esistenza di un altrove, mobilita il soggetto verso il
sapere di cui manca. È una cerimonia, non rituale, di iniziazione, con osservatore esterno.
1.1.1.2. Il “non sapere” di Socrate, accompagnato dalla consapevolezza del “so di non sapere”,
ironicamente si capovolge in sapienza, o per lo meno saggezza, e avvia un fondamentale cammino
di ricerca filosofica: la possibilità di trovare un punto di fondazione che possa giustificare
l’affermazione sia di conoscenza che di sapere (di conoscenza come traguardo soggettivo, di sapere
come enunciazione che oltre a dire si legittima in quanto è capace di esibire il proprio fondamento e
non solo per ricezione esterna).
1.1.1.3. Il “so di non sapere” di Socrate non è il vuoto, il nulla, ma, al contrario, una consapevolezza
assoluta. «Questo punto privilegiato è il solo al quale possiamo riconoscere il carattere di un punto
assoluto senza alcun sapere. È assoluto, precisamente, per il fatto di non essere nessun sapere, ma
piuttosto l'attaccatura che collega il suo stesso desiderio alla risoluzione di ciò che si tratta di
rivelare. Il soggetto entra nel gioco a partire da questo supporto fondamentale.» (Lacan Jacques
1964, Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi 1964, Einaudi,
Torino 2003, 248; osservazione espressa da Lacan per ben altri contesti). Quella consapevolezza è
qui disponibilità fondativa.
1.1.2. la brachilogia contro la macrologhìa: procedere per brevi domande e risposte e non per lunghi
discorsi; la prima strada è fare filosofia, la seconda è fare retorica; la prima è volontà di confronto e
di ricerca, la seconda è volontà di persuasione e di dominio. La brachilogia è contro lo scritto,
quella è disponibilità alla confutazione e al cambiamento, questo resta immutato, silenzioso,
indifeso… La brachilogia è la tecnica dell’arte maieutica e il ruolo maieutico della filosofia è un
ruolo etico pedagogico. (Socrate e l’arte della levatrice; filosofi “maestri del risveglio”… alla
propria mente).
Contro lo scritto «... l’arte dello scrivere, per il fatto che verrà trascurata la memoria, produrrà
l’oblio nelle anime di chi l’apprenderà, poiché ci si ricorderà delle cose sulla fede dello scritto, dal
di fuori, per caratteri a noi estranei, non da noi stessi, interiormente. Non si è, dunque, trovato una
medicina per la memoria, ma solamente un mezzo per evocare i ricordi. Agli scolari si darà una
parvenza di sapere, non la verità...» (Platone, Fedro 275a ss).
1.2. la verità del dialogo (dialogica); l’accordo raggiunto è accettato come vero. La concordia è
considerata (nel campo della filosofia pratica) condizione di verità. È la verità di cui l’uomo dispone
(a meno di credere di poter contare su altre fonti di verità, esterne, accettate come fonti, e certe). È
la verità che permette l’apertura alla possibilità dell’incontro contingente con l’altro, in opposizione
ad una pretesa di verità assoluta e definitiva che di fatto coincide con un porsi del soggetto come
un'identità chiusa in se stessa, monolitica, assoluta, che respinge ogni forma di contaminazione e di
transito con l'Altro. Una pietrificazione soggettiva può declinarsi in modi differenti, con svariate e
imprevedibili strategie di negazione di rappoto con l’altro, con il reale, con il vero.
«Hai ragione, disse Simmia: e io ti dirò il mio dubbio; e così questo amico, a sua volta ti dirà dov’è
che non accetta le tue parole. Perché su tali questioni a me pare, o Socrate, come forse anche a te,
che avere in questa nostra vita una idea sicura, sia o impossibile o molto difficile; ma d’altra parte
non tentare ogni modo per mettere alla prova quello che se ne dice, e cessare di insistervi prima di
aver esaurita ogni indagine da ogni punto di vista, questo, o Socrate, non mi par degno di uno
spirito saldo e sano. Perché insomma, trattandosi di tali argomenti, non c’è che una cosa sola da
fare di queste tre: o apprendere da altri dove sia la soluzione; o trovarla da sé; oppure, se questo
non è possibile, accogliere quello dei ragionamenti umani che sia se non altro il migliore e il meno
confutabile, e, lasciandosi trarre su codesto come sopra una zattera, attraversare così, a proprio
rischio, il mare della vita: salvo che uno non sia in grado di fare il tragitto più sicuramente e meno
2
pericolosamente su più solida barca, affidandosi a una divina rivelazione. E così dunque, anche
ora, io non avrò scrupolo a interrogarti, dal momento che tu stesso me lo dici; e tanto meno avrò
da incolparmi in seguito di non averti detto ora quello che avevo nel cuore. Perché veramente, o
Socrate, le ragioni dette fin qui, da che io sto indagando meco medesimo e con questo nostro
amico, non mi pare che soddisfino del tutto.» (Platone, Fedone, 85 c,d)
I tratti dell’accordo - verità:
1.2.1. è la verità che nasce dalla ricerca (dialéghesthai come exetàzein) e dal confronto,
1.2.2. resta provvisoria per la sua fonte (nasce dall’apporto dei dialoganti) e per la sua apertura
(resta nella sede del dialogo)
1.2.3. è contesto di etica: sommo bene per l’uomo e per la società è sia la verità raggiunta, sia lo
stare nelle condizioni di poterla sempre maieuticamente raggiungere. Nell’etica come impegno
dialogico per la verità vengono a coincidere virtù (privata e pubblica), giustizia, sommo bene,
felicità (eu-daimonìa)
1.2.4. nel dialogo e nell’accordo che genera si attua la coincidenza di bene e sapere: non tanto (non
solo) nel senso che il sapere sia il vero bene (in senso contenutistico; ricorda il monito di Eraclito:
sapere molte cose non aiuta ad essere intelligenti), né nel senso che l’ignoranza è fonte di male (o
che l’uomo compie il male perché ignora che sia male), ma nel senso che il bene è lo stare nel
dialogo come confronto e ricerca, questo è l’unico contesto per il sapere e per il sapere come virtù
(non vanto o ostentazione retorica di competenze).
«MENONE Socrate, anche prima d’incontrarmi con te, sapevo per sentito dire che tu non fai altro
che mettere in dubbio te e gli altri; ora poi, come mi sembra, mi affascini, mi dài beveraggi,
m’incanti, tanto da non avere più alcuna via di uscita. E, se mi è lecito scherzare, mi somigli
davvero, nella figura e nel resto, alla piatta torpedine di mare: perché anche questa, se qualcuno le
si avvicini e la tocchi, sùbito lo fa intorpidire. Ora mi sembra che tu abbia avuto su di me lo stesso
effetto, poiché sono veramente intorpidito nell’anima e nella bocca, e non so più cosa risponderti.
E sì che ho fatto tante orazioni sulla virtù e dinanzi a un gran pubblico, e molto bene, come mi
pareva. E ora, invece, non so neppure dire che cosa essa sia. Mi sembra, poi. che tu abbia fatto
benissimo a non volerti mai mettere in mare, a non voler viaggiare fuori di qui, ché se da straniero,
in straniera città, ti comportassi in questo modo, sùbito ti arresterebbero come un ammaliatore.
SOCR. Sei capace di tutto, Menone, e per poco non mi hai messo nel sacco! MEN. Ma che dici,
Socrate? SOCR. So bene perché mi hai paragonato a una torpedine. MEN. Per quale ragione,
secondo te? SOCR. Perché a mia volta ti paragoni a qualcosa. So bene che tutte le persone belle
godono ad esser paragonate: da simili immagini traggono vantaggio, poiché, credo, belle sono le
immagini delle persone belle. Io, invece, non ti paragonerò a nulla. Quanto a me, se la torpedine fa
intorpidire gli altri perché torpida essa stessa, io allora le somiglio; se no, no, perché non è che io
sia certo e faccia dubitare gli altri, ma io più di chiunque altro dubbioso, fo sì che anche gli altri
siano dubbiosi. E così, tornando alla virtù, io non so che cosa essa sia; tu, forse, lo sapevi prima di
toccare me: ora, invece, sei divenuto simile a uno che non sa. Comunque voglio cercare e indagare
con te cosa essa sia.» (Platone, Menone 79e-80d)
2. la memoria: la reminiscenza come scoperta di sé e conoscenza
2.1. L’intoppo “logico” del dialogo e il suo rilancio in un nuovo contesto.
La filosofia etica del dialogo, impersonificata da Socrate, va incontro a un doppio fallimento, uno
esterno, uno interno alla filosofia, coraggiosamente ricostruiti e rappresentati da Platone nei suoi
dialoghi. Prende evidenza la logica del procedere del testo (delle opere e della filosofia di Platone:
gli intoppi che si evidenziano nelle posizioni dichiarate e sostenute, lo smacco che ne segue
diventano l’occasione di una ripartenza radicale per altre direzioni.
2.1.1. Un fallimento esterno: la condanna a morte di Socrate, da parte della polis, delle sue leggi e
della sua giustizia, rappresenta il fallimento del dialogo, almeno in contesto politico: un giusto
condannato a morte dalle leggi della polis e, drammaticamente, una morte che rappresenta un atto
ultimo di fedeltà alle leggi. (tema ripreso in “politica”)
3
2.1.2. Un fallimento interno: Platone, servendosi dell’abilità dei Sofisti, ravvisa e mette in mostra
un grave e compromettente difetto logico presente nel metodo etico del dialogo praticato da
Socrate.
La rappresentazione (drammatizzata) del doppio fallimento è contemporaneamente l’avvio di un
nuovo modello filosofico, etico e politico; il dramma / fallimento è aprirsi di un nuovo percorso.
2.1.2.1. L’argomento eristico presentato nel dialogo “Menone”
«MENONE. Ma in quale modo, Socrate, andrai cercando quello che assolutamente ignori? E quale
delle cose che ignori farai oggetto di ricerca? E se per un caso l’imbrocchi, come farai ad
accorgerti che è proprio quella che cercavi, se non la conoscevi? SOCRATE Capisco quel che vuoi
dire, Menone! Vedi un po’ che bell’argomento eristico proponi! L’argomento secondo cui non è
possibile all’uomo cercare né quello che sa nè quello che non sa: quel che sa perché conoscendolo
non ha bisogno di cercarlo; quel che non sa perché neppure sa cosa cerca. MEN. E non ti sembra,
Socrate, che sia questo un ragionamento assai ben condotto? SOCR. A me no! MEN. Dimmi
perché! SOCR. Certo!» (Platone, Menone 80d-81a)
L’argomento eristico evidenzia l’impraticabilità del dialogo impostato secondo la tecnica espressa
finora da Socrate. Se la base necessaria per stare nel dialogo è la consapevolezza della propria
ignoranza, la ricerca non decolla per mancanza di scopo e la somma dei “non-sapere” è ancora un
non sapere, destinato a non produrre.
2.2. Per uscire da questo vicolo cieco bisogna pensare che l’incalzante domanda di Socrate a
Menone sull’idea di virtù, si traduca nella scoperta e segnalazione di una nuova sede del sapere e
del dialogo: occorre portare alla attenzione filosofica il tema della mente umana come sede naturale
delle idee. Pensiero, nel dialogo, nella relazione e nella comunicazione, come una liana che pesca
nella stratificazione collettiva e individuale della mente e trae dalla memoria a parziale
rigenerazione forme di orientamento, prospettive di sguardi, progetti di cammino.
Si tratta di un discorso sulle origini, si impone perciò, anche nel testo di Platone, testo filosofico, la
forma mitica, la poesia e il racconto come forma per la presentazione dei principi - postulati.
« SOCR. Certo! Perché ho sentito dire da uomini e donne assai addottrinati nelle cose divine...
MEN. Cosa dicevano? SOCR. Cose vere, mi sembra, e belle. MEN. Quali? E chi sono coloro che le
dissero? SOCR. Sacerdoti e sacerdotesse, quelli a cui stava a cuore saper rendere ragione del
proprio ministero. E quelle stesse cose dice anche Pindaro e molti altri poeti, i poeti divini, E
questo dicono — ma vedi se ti sembra che dicano il vero —; dicono, dunque, che l’anima umana è
immortale, e che ora essa ha un suo compimento — il che si dice morire —, ora rinasce, ma che
mai essa va distrutta; ecco perché, dicono, bisogna trascorrere la vita il più santamente possibile,
“poiché Persefone, a quelli che hanno già pagato il debito / dei loro antichi peccati, giunto il nono
anno, di nuovo / l’anima loro rimanda su in alto verso il sole; / da tali anime i re illustri rinascono
/ e gli uomini potenti per forza o grandi o per sapienza, / che per tutto il tempo futuro sono, tra i
mortali, chiamati eroi senza macchia”.
L’anima, dunque, poiché immortale e più volte rinata, avendo veduto il mondo di qua e quello
dell’Ade, in una parola tutte quante le cose, non c’è nulla che non abbia appreso. Non v’è, dunque,
da stupirsi se può fare riemergere alla mente ciò che prima conosceva della virtù e di tutto il resto.
Poiché, d’altra parte, la natura tutta è imparentata con se stessa e l’anima ha tutto appreso, nulla
impedisce che l’anima, ricordando (ricordo che gli uomini chiamano apprendimento) una sola
cosa, trovi da sé tutte le altre, quando uno sia coraggioso e infaticabile nella ricerca. Sì, cercare ed
apprendere sono, nel loro complesso, reminiscenza [anamnesi].» (Platone, Menone 81a-d)
2.2.1. La tecnica socratica del dialogo conserva la propria struttura ma cambia la propria sede
operativa. La professione di ignoranza è invito a ritirarsi dai «soliti modi di ragionare del volgo»,
dal «cosa dirà la gente», dal «pensa ai tuoi figli» (citazioni da Critone) per camminare «dove la
ragione ci porta» secondo un percorso convenuto e condiviso («insieme si è convenuto … vediamo
insieme… con la persuasione tra…»). Il “so di non sapere” è dunque ritirarsi dalle opinioni
dominanti perché mai esaminate ed è scoperta della mente come sede di strumenti per definire e
4
comprendere. Il dialogo è allora terapia e strategia filosofica per risvegliare la mente al “proprio
logos” (come afferma Eraclito, autore di cui Platone resta la principale fonte documentaria).
2.2.2. Non è più allora semplice confronto tra interlocutori che non sanno; il dialogo trova sede
nella mente di ciascuno ed ha lo scopo di portare alla memoria e mettere a disposizione i concetti e
le idee, patrimonio specifico della mente umana, lì depositato come risultato di molte generazioni,
strumento e principio per cogliere la realtà leggendola appunto secondo concetti e rispondendo al
“che cos’è” incalzante di Socrate. Conoscere è ricordare, portare alla memoria, ricostruire e mettere
in azione la memoria interiore. Il dialogo, che porta ciascuno a far affiorare alla mente, in modo
assolutamente personale, il patrimonio di forme mentali di orientamento, è l’arte della conoscenza.
La memoria, l’anamnesi, la raccolta, il richiamo e il riaccadere, in forma nuova di quando
profondamente e quotidianamente interessa l’uomo, forma il suo naturale costituirsi in persona e in
singolarità; la memoria è la traccia della natura umana in dimensione personale.
Si tratta di un apprendimento che è sollecitato dall’esperienza sensibile, quale motore per alcuni
aspetti esterno, ma che si attiva in un procedimento interno, nella memoria interiore e non nasce per
indottrinamento o convinzione dall’esterno; è la definizione e lo scopo della filosofia e rende la
filosofia, e in generale la cultura, etica.
Il modo corretto di intendere l’apprendimento e, in generale, l’educazione: «… l’educazione non è
proprio come la definiscono taluni che ne fanno professione. Essi dicono che, essendo l’anima
priva di scienza, sono loro che la istruiscono, come se in occhi ciechi ponessero la vista. — Lo
dicono, sì, rispose. — Invece, continuai, il presente discorso vuole significare che questa facoltà
insita nell’anima di ciascuno e l’organo con cui ciascuno apprende, si devono staccare dal mondo
della generazione e far girare attorno insieme con l’anima intera, allo stesso modo che non è
possibile volgere l’occhio dalla tenebra allo splendore se non insieme con il corpo tutto; e questo si
deve fare finché l’anima divenga capace di resistere alla contemplazione di ciò che è e della parte
sua più splendida.» (Platone, Repubblica 518 c-d)
2.2.2.1. La ripresa e il rilancio del tema in Agostino, dalle Confessioni: «Anche nel caso di quelle
nozioni Agostino ricorre a una metafora spaziale: "miris tamquam cellis reponuntur", "vengono
messe via come in meravigliosi ripostigli" e da lì all'occorrenza "proferuntur", "vengono tirate
fuori" (X, 9, 16). Ma le nozioni astratte non sono entrate per le porte della carne ("ianuas [...]
carnis", X, 10, 17): ciò significa che si trovavano già nella memoria, sparse e nascoste in luoghi
molto reconditi; possederle, dunque, è un atto di estrazione e raccolta, insieme. Per questo, secondo
Agostino, pensare si dice "cogito", che è il frequentativo del verbo cogo, "raccolgo" (X, 11, 18).»
(Gardini Nicola, 2016, Viva il latino. Storie e bellezza di una lingua inutile, Garzanti, Milano, 169)
2.2.3. La tesi della reminiscenza ricorre nei testi di Platone e si ripresenta in più contesti tematici e
dialogici (Menone 80d-86c, Fedone 72e-77d, Fedro 249e-250c). Poiché è sia molto nota che molto
discussa e spesso banalizzata in quanto ridotta alla mitica concezione della reincarnazione, è bene
ricordare l’oggetto del riportare alla memoria nel vivere; non si tratta di un sapere qualsiasi, banale
e quotidiano, relativo alle circostanze sensibili che si stanno vivendo, ma di un sapere concettuale di
tipo modulare, strutturale che permette comportamenti formali di carattere conoscitivo logico
connettivo secondo svariate tipologie ; si tratta di episteme (cfr. Fedone73c,d, 74b,c); una
conoscenza che si distingue dalla sensazione, dall’orientarsi secondo opinioni e per convinzioni
diffuse, credenze (pìstis) accettate per adattamento e adeguamento esterno. Conoscenza definita
“scienza”, che pone al centro della propria attenzione e come oggetti ciò che Platone indica con i
termini éidos, idéa, schéma, ousìa, paradéigma, ti estin, tode ti… cioè schemi idee, paradigmi,
modelli, che entrano in azione al momento della percezione sensibile come principi attivi sapendo
cogliere e definire secondo essenze costanti e permanenti, porre in relazioni coordinando in
sequenze, gestire secondo progetti in vista di scopi ecc. Non dunque un semplice portare alla
memoria ricordi non meglio specificati, ma attivare processi che permettono una personale e
condivisibile conoscenza. L’umanità si ritrova dialogicamente nell’esercizio che ciascuno mette in
atto delle proprie capacità mentali e non nel loro compiacente e supino silenziamento.
2.2.3.1. Vi è uno stretto legame, in termini di coerenza e efficacia del metodo, tra la tecnica
dialogica condotta per brevi domande e risposte e la natura della memoria dell’uomo e dei suoi
5
processi di apprendimento. Se conoscere non è ricevere dall’esterno passivamente dottrine e
racconti, ma è reagire e partecipare risvegliando la mente al mondo delle proprie capacità, allora è
necessario che venga adottata un’arte adatta a provocare il risveglio. Non lunghi discorsi che
provocano torpore, assopimento, dipendenza e dolce abbandono e, sempre, dimenticanza di sé, ma
brevi domande e risposte che possano richiamare alla memoria e riportare alla mente ciò che essa
possiede senza esserne consapevole. Se conoscere è ricordare, quindi, è necessaria l’arte del porre
domande e del chiedere, esigere risposte.
2.2.3.2. La tesi socratica o platonica secondo cui conoscere è ricordare, portare alla memoria,
risponde, in qualche modo, alla ricerca avviata dalla consapevolezza fondamentale di Socrate “so di
non sapere”. Essa inaugura l’avvio della ricerca di una fondazione in termini di “soggetto supposto
sapere”. La risposta è nella tesi (in termini quasi psicanalitici) secondo cui ogni soggetto nasce alla
propria soggettività in forza dell’Altro che c’è in lui; del lascito linguistico storico costruito dalle
molte vite e il cui l’umanità continuamente rinasce in cui ognuno diventa soggetto; in cui avviene
(direbbe Foucault) un assoggettamento: un ingresso in sintonia educativa con quanto già prodotto
(cioè un entrare in comunicazione e condivisione), ma non passiva perché tale apparente (e a volte
reale) sottomissione (assoggettamento come sottomissione) diventa il luogo del proprio diventare
soggetti (un assoggettamento come assoggettarsi).
2.3. Le radici lontane (prime) dell’oblio, della memoria, della scelta di sé.
2.3.01. Il racconto / mito delle origini dell’anima, e del suo cammino di conoscenza e di
riconoscimento. Platone fa ricorso al mito e ne scrive di propri tutte le volte che il tema che si deve
affrontare riguarda i principi, le origini. Anche in filosofia il discorso delle origini è
necessariamente un discorso mitico, non può non essere introdotto se non in forma mitica. Questi
racconti hanno la forma e la funzione di miti fondativi(si tratta di mitologia fondativa).
Una nota come cautela e di metodo sui miti / narrazioni propri della filosofia, prsenti in particolare
dove ricorrono snodi centrali, fondanti, di un percorso filosofico: si tratta di ipotesi e di basi di
partenza che tendono a configurarsi come funzioni-principio ma, in realtà, nel corso della
costruzione, visto il loro ruolo, rimandano a inattingibili principi. «le ipotesi in filosofia hanno
necessariamente un carattere mitico, sono, cioè, sempre narrazioni e il rigore del pensiero consiste
appunto nel riconoscerle come tali, nel non scambiarle per principi» (Agamben Giorgio, 2016, Che
cos’è la filosofia?, Quodlibet, Macerata, 26-27)
I principi fondanti della filosofia platonica sono presentati attraverso un mito e sul mito si fonda poi
di conseguenza l’intero impianto filosofico di Platone e dell’intera tradizione culturale che ne
deriva: la nascita del mondo (Timeo), il formarsi delle idee nella mente, nell’anima in quanto sede
delle idee (Menone, Fedone), la natura dell’anima (Fedro), la natura e le forme dell’amore
(Simposio), la nascita dello Stato (Repubblica), la formazione educativa della conoscenza
(Repubblica), la natura del Bene (Repubblica), la capacità dell’uomo di scegliere il proprio destino
e non esserne scelto da un demone esterno (Repubblica), la fascino del canto e della musica (Fedro
259 b-c il mito delle cicale)… «Platone, che sembra così spesso respingere il mýthos come quando,
nel Filebo (14a), parla di un ragionamento, lógos, che minato dalle sue contraddizioni interne si
distrugge da solo come un mýthos, o quando osserva, nel Fedone (61 b), per bocca di Socrate, che il
mýthos non è cosa che riguarda lui ma i poeti — quei poeti che la Repubblica caccerà dalla città
come mentitori —, lo stesso Platone darà nei suoi scritti un posto eminente al mito come mezzo per
esprimere a un tempo ciò che è al di là e ciò che è al di qua del linguaggio propriamente filosofico.
Come esprimere filosoficamente, con un intreccio ordinato di parole, il Bene, valore supremo che
non è un'essenza ma si colloca, in quanto fonte dell'Essere e del Conoscere, al di là dell'essenza in
dignità e in potenza (Repubblica 509 b sgg.)? Come parlare anche filosoficamente del divenire,
sottoposto nel suo cambiamento incessante alla causalità cieca della necessità? Questo divenire
partecipa troppo dell'irrazionale perché vi si applichi un ragionamento rigoroso. Non può essere
l'oggetto di un sapere vero, ma solo di una credenza, pìstis, di un'opinione, dóxa. Ancora, per quel
che riguarda gli dèi e la nascita del mondo, è impossibile fornire lógoi homologoùmenoi,
ragionamenti del tutto coerenti. Bisogna contentarsi di una favola verosimile, eikóta mýthon (Timeo
6
29 b-c). A proposito dell'anima, del suo destino e della sua immortalità, Platone riprende i vecchi
miti di reincarnazione, come nella teoria della reminiscenza (anàmnesis) traspone i più antichi miti
di memoria dove Mnemosýne rappresenta, nell'al di là, la fonte di vita eterna riservata a quelli che
hanno saputo conservare, su questa terra, l'anima pura da ogni macchia. La Repubblica finisce con
queste parole: «E così, Glaucone, si è salvato il mito e non è andato perduto. E potrà salvare anche
noi, se gli crediamo».» (Vernant 1974, 210-211)
A concludere: «Ci sarebbe dunque a un tempo una continuità e una serie di rotture fra il racconto
orale, il mito, o piuttosto i diversi piani del mito, e la filosofia.» (Vernant 1974, 249).
2.3.1. Il viaggio mitico di Er (Platone, Repubblica X, le parole della divinità, le sentenze in
frammenti/aforismi).
Er, il guerriero morto apparentemente in battaglia, si risveglia dalla morte presunta e racconta di
aver compiuto un viaggio nell’aldilà e di aver assistito all’atto in cui le anime, sotto comando, invito
e sorveglianza delle divinità, scelgono la propria natura prima di tornare a vivere, prima di un
viaggio di ripartenza nel vivere: «Appena giunte, le anime dovevano presentarsi a Lachesi. Per
prima cosa, un araldo [prophetes] le mise in fila, poi, prendendo dalle ginocchia di Lachesi le sorti
[klerous — la tavoletta o il pezzo di coccio che ciascun cittadino contrassegnava e poi poneva in un
recipiente per il sorteggio] e gli esempi dei modi di vita [bion paradeigmata], salì su un'alta tribuna
e disse: «Proclama della vergine Lachesi, figlia di Ananke. Anime effimere, comincia per voi un
nuovo ciclo di vita mortale, portatore di morte [periodou thnetou genous thanatephorou]. Non sarà
un demone a scegliervi, ma voi sceglierete [airesesthe] il vostro demone. Chi è stato sorteggiato per
primo, scelga la forma di vita a cui sarà unito per necessità [aireistho bion oi synestai ex anankes].
La virtù invece è libera [adespoton, senza padrone, inassegnata] e ognuno ne avrà in misura
maggiore o minore a seconda che la onori o la disprezzi. La colpa [aitia] è di chi ha scelto, dio è
innocente.» Dopo aver pronunciato queste parole, gettò su tutti le sorti e ognuno prese [anairesthai,
lo stesso verbo che nel libro VII della Repubblica, Platone riferisce alle ipotesi] quella che le era
caduta vicino, tranne Er, al quale non fu permesso; e ciascuno conobbe così il numero d'ordine che
gli era toccato.» (Platone, Repubblica 617de)
2.3.1.1. Effetto di fondazione prima del mito di Er. Natura ed educazione (physis e paideia)
concorrono a definire la realtà o, se si vuole, l’identità personale di ciascuno, ma le due componenti
devono incontrarsi; l’assenza dell’una o dell’altra (natura senza educazione, educazione senza
natura, senza disponibilità naturali) rappresenta il fallimento di entrambe e del progetto di vita
personale; il loro incontro costituisce il tempo personale, non il tempo astratto di eventi fisici, ma il
tempo individuale e personale delle scelte del vivere. Questo tempo dell’incontro è indicato con un
termine specifico nel mondo greco, si tratta del “kairòs”, il tempo opportuno, il momento
conveniente, la circostanza propizia, l’occasione giusta; tempo che spesso si caratterizza per la sua
unicità e che richiede la saggezza e la prontezza dello scegliere. Ora, nel mito, lo stesso momento di
nascita, e di nascita secondo una particolare natura destinata a definire l’esistenza, ha un suo kairòs.
Il kairòs ontologico della propria esistenza, intesa in termini di forma di vita, è quello che si
presenta come circostanza particolare in cui ognuno è posto nelle condizioni di poter scegliere la
propria natura, la propria forma di vita e la propria conseguente sorte (il proprio demone); un
momento che Platone, servendosi di un racconto, colloca poco prima della nascita, del ritorno delle
anime ad una nuova vita. Un mito che toglie ogni peso deterministico al destino (e assimilati: fato,
fortuna, divinità, demone buono o cattivo…) per mettere al centro della vita di ciascuno la scelta: la
stessa natura è conseguenza di una scelta, che deve essere condotta senza precipitazione e con
ponderazione. L’affermazione «la responsabilità è di chi sceglie, il dio è irresponsabile» (Rep.
617e) toglie ogni senso al termine destino, come alle suppliche e ai rimproveri rivolti a un dio, pone
al centro l’etica della scelta.
2.3.1.2. Effetto di fondazione seconda del mito di Er.La scelta ontologica di sé in un kairòs
collocato prima della nascita è consegnata tuttavia a un destino di dimenticanza:
«Quando tutte ebbero scelto la loro forma di vita, si presentarono a Lachesi secondo l’ordine del
sorteggio ed essa assegnava a ciascuna come custode della vita ed esecutore della scelta il demone
che si era preso. Questi per prima cosa la conduceva da Cloto, ponendola sotto la sua mano e sotto
7
il fuso che essa faceva girare, sancendo in questo modo il destino [moiran] che aveva scelto dopo il
sorteggio. Dopo che aveva toccato il fuso, il demone conduceva l'anima al filo di Atropo, rendendo
irrevocabile [ametastropha] la trama filata. Di qui, l'anima andava senza voltarsi al trono di Ananke
e passava dall'altro lato e, quando tutte erano passate, si avviavano verso la pianura di Lete sotto
una calura soffocante e terribile, perché questa pianura era spoglia di alberi e di tutto ciò che nasce
dalla terra. Discesa la sera, esse si accamparono sulle rive del fiume Ameles, la cui acqua non può
essere contenuta da nessun vaso. Tutte dovevano bere una certa quantità di quest'acqua, ma quelle
prive di prudenza ne bevevano più del giusto e via via che bevevano dimenticavano ogni cosa.
Quando si furono addormentate, nel mezzo della notte si produssero un tuono e un terremoto, e
all'improvviso le anime si slanciarono da ogni parte verso l'alto, filando come stelle.» (Repubblica
620d-621b)
Il passaggio attraverso il fiume dell’oblio (il Lete) determina la dimenticanza di ciascuno nei
confronti della propria scelta, della propria natura e del proprio destino; quella natura, perché possa
venir portata a conoscenza e realizzazione, viene consegnata a un processo educativo, a un percorso
di paideia. Torna alla mente l’affermazione di Democrito, contemporaneo più giovane di Platone,
«La natura e l’educazione sono assai simili: perché l’educazione trasforma l’uomo e trasformandolo
ne costituisce la natura.» (Democrito, fr. 33)
Commenta Giorgio Agamben: «…il problema di cui Platone vuol dare ragione attraverso il mito è il
fatto che, con la nascita, ogni anima sembra trovarsi necessariamente e irrevocabilmente unita a una
certa forma di vita (bios), che abbandona con la morte. La vita (zoè) dei mortali (l'anima è il
principio della vita) si dà sempre in un certo bios, in un certo modo di vita (noi diremmo che è
gettata in esso) e, tuttavia, non coincide con questo né è unita ad esso da un qualche nesso
sostanziale. Il mito spiega questa unione fattizia — che contiene una non-coincidenza e uno scarto
e, insieme, un vincolo necessario — attraverso l'idea di una scelta: ciascuna anima, entrando nella
nascita, sceglie il suo bios e poi dimentica di averlo fatto. A partire da quel momento, essa si trova
unita alla forma di vita che ha scelto da un vincolo necessario (oi synesthai ex anankes). Per questo
Lachesi può dire che la colpa è di colui che ha scelto, dio è innocente.» (Agamben Giorgio 2014,
L’uso dei corpi, Neri Pozza editore, Vicenza, 318, 321-322)
Il mito, pur riprendendo il tema della necessità e inesorabilità del destino, del vincolo con cui
ognuno è legato alla propria natura, tende tuttavia ad allentarne il più possibile i tratti della necessità
e ad introdurre spazi e momenti di scelta. Prima della nascita, nelle origini e nel corso del vivere si
infittiscono i momenti o le occasioni opportuna per scegliere; anzi il tempo per l’uomo è questa
scelta, il kairòs è la forma del tempo che si impone antropologicamente, visto che l’identità
specifica di un essere consegnato alla propria mortalità e, con essa, al desiderio della immortalità, è
una identità in continuo mutamento, identità alla quale quindi è possibile accedere, che è possibile
definire e in cui si può stare secondo scelte operate nelle occasioni che vengono fornite nella
sequenza continua degli eventi e quindi del kairòs, del tempo opportuno.
2.3.1.3. Effetto di fondazione terza del mito di Er: conoscere è ricordare, portare alla memoria in
occasione dell’esperienza, il patrimonio di idee che definiscono la mente. La tesi compare nel passo
già citato: Menone 81a-d; in particolare: «L’anima, dunque, poiché immortale e più volte rinata,
avendo veduto il mondo di qua e quello dell’Ade, in una parola tutte quante le cose, non c’è nulla
che non abbia appreso. Non v’è, dunque, da stupirsi se può fare riemergere alla mente ciò che prima
conosceva della virtù e di tutto il resto. Poiché, d’altra parte, la natura tutta è imparentata con se
stessa e l’anima ha tutto appreso, nulla impedisce che l’anima, ricordando (ricordo che gli uomini
chiamano apprendimento) una sola cosa, trovi da sé tutte le altre, quando uno sia coraggioso e
infaticabile nella ricerca. Sì, cercare ed apprendere sono, nel loro complesso, reminiscenza
[anamnesi].»
Riprendendo. L’attività filosofica, in particolare il dialogo in cui Socrate è maestro, trova sede nella
mente di ciascuno ed ha lo scopo di portare alla memoria e mettere a disposizione i concetti e le
idee, patrimonio specifico della mente umana, lì depositato come risultato di molte generazioni.
Conoscere è ricordare, portare alla memoria, ricostruire e mettere in azione la memoria interiore. Il
dialogo, che porta ciascuno a far affiorare alla mente, in modo assolutamente personale, il
8
patrimonio di forme mentali di orientamento, è l’arte della conoscenza. Si tratta di un
apprendimento che non nasce per indottrinamento o convinzione dall’esterno; (cfr Platone,
Repubblica 518 c-d)
2.3.2.Un bilancio sulla dinamica della memoria e dell’oblio (come nota).
(le citazioni sono da: Roberta Bartoletti, La memoria (culturale) delle cose: oggetti di consumo e
contronarrazioni identitarie, in Doni Martino, Migliorati Lorenzo (a cura di) 2010 La forza sociale
della memoria. Esperienza, cultura, conflitti, Carocci, Roma, 112-114).
«Partiamo da una concezione di memoria come struttura selettiva che opera attraverso una duplice
operazione, il ricordo da un lato e l’oblio dall’altro. Entrambe queste operazioni, per quanto
apparentemente contrapposte, costituiscono in realtà i due lati ineliminabili di un unico processo
attraverso il quale vengono costruite la realtà del presente, ma anche l’immagine del passato e le
possibilità del futuro. Ci riferiamo quindi a una concezione costruttivista della memoria, che emerge
dalla convergenza degli studi più avanzati che la riguardano, nel campo delle neuroscienze, della
psicologia e delle stesse discipline sociali e umane che dal radicamento della memoria nei corpi e
nelle menti non possono più prescindere.»
2.3.2.1. Il passato cambia in continuazione nella ripresa presente. «Assumono così autorevolezza
scientifica intuizioni già rintracciabili negli studi classici sulla memoria, in particolare l’idea che il
passato non abbia un’esistenza oggettiva ma sia il frutto di una continua ricostruzione che avviene
nel presente e risponde a bisogni del presente, che i processi del ricordare e del dimenticare non
possano essere disgiunti dal problema del significato e che processi cognitivi ed emotivi siano
indissolubilmente intrecciati nel funzionamento della mente umana, e quindi anche della memoria
(Damasio, 1994)». [rileggi, da queste tesi, la teoria platonica delle reminiscenza: conoscenza come
reminiscenza cioè teoria costruttivista della memoria a partire dalle sollecitazioni del presente, e
quest’ultima è la definizione di conoscenza]
2.3.2.2. L’oblio è necessario per ricordare. «Cosa significa ricordare, cosa significa dimenticare in
relazione al lavoro della memoria? L’oblio non può essere liquidato superficialmente come
“problema” della memoria, come difetto o perdita (Connerton, 2008), ma deve essere colto nel suo
contributo specifico al lavoro della memoria, in quanto operazione che libera spazio per aprire alla
novità e quindi al cambiamento connaturato alla vita umana e all’esistenza delle società; l’oblio
opera inoltre una continua verifica di coerenza e consente di armonizzare presente vissuto, passato
“ricordato” e futuro immaginato.»
2.3.2.3. Oblio e costruzione di una memoria e di un apprendere personale. «Il ricordo si configura
invece come ridondanza finalizzata al mantenimento di un senso di continuità con il passato,
fondamentale sia per la costruzione del senso di sé sia per la costruzione delle identità collettive. La
memoria svolge quindi un lavoro essenziale di equilibrio costante e continuamente ricostruito tra
stabilità e mutamento, che è caratteristico sia della vita umana che dell’esistenza sociale.» (le
citazioni sono da: Roberta Bartoletti, La memoria (culturale) delle cose: oggetti di consumo e
contronarrazioni identitarie, in Doni Martino, Migliorati Lorenzo (a cura di) 2010 La forza sociale
della memoria. Esperienza, cultura, conflitti, Carocci, Roma, 112-114).
3. la polis: l’armonia sociale e individuale (polis, luogo della giustizia)
Il contesto del dialogo o declinazione “politica” del dialogo: la società organizzata, la polis e le sue
leggi, luogo di paideia; è il contesto del tempo opportuno (kairòs) per dimenticare, riportare alla
memoria, gestire la propria realtà secondo possibilità e secondo scelta.
3.1. il ruolo delle leggi: è il presupposto che permette di affrontare con correttezza il tema etico
della giustizia come fedeltà alle leggi. Nel dialogo “Critone” le leggi personificate si presentano
come coloro che permettono al cittadino di essere generato, allevato, educato.
«Di’, dunque, che cosa hai da reclamare tu contro noi e contro la città che stai tentando di darci la
morte? E anzi tutto, non fummo noi che ti demmo la vita, e per mezzo nostro tuo padre prese in
moglie tua madre e ti generò? Parla dunque: credi forse non siano buone leggi quelle di noi che
regolano i matrimoni, e hai da rimproverare loro qualche cosa?», — «Non ho nulla da
rimproverare», risponderei io. «E allora, a quelle di noi che regolano l’allevamento e la
9
educazione dei figli, onde fosti anche tu allevato e educato hai rimproveri da fare? che forse non
facevano bene, quelle di noi che sono ordinate a questo fine prescrivendo a tuo padre che ti
educasse nella musica e nella ginnastica?» «Bene», direi io. «E sia. Ma ora che sei nato, che sei
stato allevato, che sei stato educato, potresti tu dire che non sei figliolo nostro e un nostro servo e
tu e tutti quanti i progenitori tuoi?» (Platone, Critone 50d,e)
3.1.1. il tema della fedeltà alle leggi per definire un comportamento giusto o ingiusto.
La natura “estrema” del quesito: occorre obbedire alle leggi anche quando queste ti condannano a
morte o ti impongono il delitto massimo? L’ingiustizia nei confronti delle leggi va intesa in più
modi: si ha quando 1. non se ne accetta la sentenza perché sfavorevole all’utile privato; 2.
trasgredendole non si rispetta il patto presente nelle leggi stesse, il patto di convivenza civile; 3. non
si rispetta la natura dialogica del patto che le costituisce se non si concorre a modificarle.
L’ingiustizia non consiste solo nel non rispettare le leggi, ma anche e soprattutto nel non concorrere
a formarle e poi a modificarle quando si considerano ingiuste, adempiendo all’etica del dialogo. Ne
deriva, di conseguenza, che l’obbedienza alle leggi se talvolta viene usata come mezzo di
giustificazione giuridica per scagionare da gravi crimini (vedi nei sistemi totalitari e nei crimini
contro l’umanità ordinati da chi al momento si è insediato nelle strutture di gestione dello stato) non
può diventare il contesto di una giustificazione morale.
«…bisogna fare ciò che la patria e la città comandano, o almeno persuaderla da che parte è il
giusto; ma far violenza non è cosa santa, né contro la madre né contro il padre, e molto meno
ancora contro la patria…Ma chi di voi rimane qui, e vede in che modo noi amministriamo la
giustizia e come ci comportiamo nel resto della pubblica amministrazione, allora diciamo che
costui si è di fatto obbligato rispetto a noi a fare ciò che noi gli ordiniamo; e se egli non obbedisce,
diciamo che commette ingiustizia contro noi in tre modi: primo, perché non obbedisce a noi che lo
abbiamo generato; secondo, perché non obbedisce a noi che lo abbiamo allevato; terzo, perché
essendosi egli obbligato a obbedirci, né ci obbedisce né si adopra, caso che facciamo alcuna cosa
non bene, di persuaderci altrimenti, nonostante che noi, quello che gli diciamo di fare, gli si
proponga benevolmente, e non già duramente gli s’imponga; che anzi, mentre noi gli lasciamo
libertà di scegliere delle due cose l’una, o di persuaderci o di fare quello che gli diciamo, egli non
fa né l’una cosa né l’altra.» (Critone 51c, 51e-52a) La città e le leggi, nuova sede del dialogo, luogo
di una maieutica sociale.
3.2. Uno stato, una società, una situazione ideale, un progetto – modello ideale. Nella
Repubblica (Politèia), opera redatta nella forma di un dialogo raccontato, Platone presenta il
proprio ideale di società e di Stato. Lo costruisce su di una ricorrente simmetria tra le componenti
dell’uomo (l’anima e le sue funzioni) e le componenti della società (le classi e le loro funzioni). La
corrispondenza tra le tre funzioni (modi di essere) dell’anima: mente, volontà, desiderio, e le classi
dello stato: reggitori, custodi, lavoratori (governi, difesa, produzione). La sfida è coniugare la
complessità (dell’anima e sociale) con l’armonia (delle parti, funzioni e classi, indicate).
«Ebbene, in un àmbito maggiore ci sarà forse più giustizia e la si noterà più facilmente. Perciò, se
volete, cerchiamo prima negli stati che cosa essa sia. Esaminiamola poi con questo metodo anche
in ogni individuo e cerchiamo di cogliere nelle caratteristiche del minore la somiglianza con il
maggiore. — Così va bene, mi sembra, rispose. — Ora, ripresi io, se non di fatto, ma a parole
assistessimo al processo di nascita di uno stato non vedremmo nascere pure la giustizia e
l’ingiustizia? — Forse sì, ammise. — E se ciò avviene, non possiamo sperare di scorgere più
agevolmente il nostro obiettivo? — Molto di più, certo. — Ora, secondo voi, dobbiamo tentar di
andare sino in fondo? Non la credo una impresa da poco, e quindi pensateci su! — Ci abbiamo già
pensato, disse Adimanto. Via! Fa come hai detto.» (Platone, Repubblica 368e-369a)
3.2.1. Lo stato ideale sarà governato da filosofi in quanto competenti nella gestione delle idee o dei
modelli di definizione della realtà. Un piano di studi graduale e completo li porta a plasmare la
propria naturale inclinazione all’arte del governo; la disciplina più alta in questo piano formativo è
la dialettica, l’arte di gestire le idee secondo corrette relazioni e muoversi perciò con competenza
nella realtà naturale e sociale.
10
3.2.2. Il modello di Stato è dominato da una doppia armonia: la prima è quella tra le abilità della
persona e la classe sociale di appartenenza (ognuno svolgerà quella funzione, e di conseguenza
apparterrà alla classe sociale che la realizza, sulla base della propria natura, educazione e delle
opportunità che sa cogliere – kairòs), la seconda è quella delle classi sociali tra di loro (ognuno
adempie al proprio ruolo, non prevarica e non invade campi a sé non propri e lo stato si compone in
ordinata armonia). È come se l’accordo cui mirava Socrate con la propria arte maieutica dialogica
venisse a trasferirsi e operare nello Stato, nelle relazioni tra individui e città e tra le classi,
rendendolo perciò giusto.
3.2.3. Prende forma una triplice accezione di giustizia. Lo Stato è giusto se le funzioni sono
essenziali e non complicate (lo stato giusto è cioè lo stato sobrio perciò sano, e non di lusso, così
sarebbe corrotto e malato), lo stato è giusto se ognuno attende alle funzione cui è adatto (secondo
natura / secondo educazione / secondo "kairòs"), lo stato giusto è l'armonia (omologhìa) delle
funzioni che lo compongono ognuna ferma al ruolo di competenza.
3.2.4. Le forme storiche dello stato, la loro reciproca generazione e degenerazione.
Le forme politiche: 1. stato timocratico, 2. stato oligarchico, 3. stato democratico, 4. stato tirannico
(Repubblica 544 bc); il corrispettivo antropologico: «uomo regale, timocratico, oligarchico,
democratico, tirannico» (Repubblica 580b); analisi e previsione dei blocchi e delle cicliche
degenerazioni, a dinamica interna, delle forme dello stato. Platone costruisce le linee di uno Stato
ideale sede di giustizia, ma prende anche in analisi le forme (le costituzioni) storiche che
caratterizzano gli stati esistenti; ne individua quattro, ne studia la natura e coglie la dinamica del
loro divenire interno, per studiare anche la loro degenerazione e alternanza quasi in fatale deriva
ciclica. Il coraggio filosofico di Platone consiste nel dar corpo e nel rappresentare anche in forma
più generale, nello stesso dialogo che vede il sorgere dello Stato ideale e giusto, i passaggi e i
momenti che lo portano ad una inevitabile e quasi inesorabile dissoluzione, sempre non per
aggressione esterna ma per corruzione interna. Sembrano tre i punti principali di intoppo.
3.2.4.1. L’idea di Bene, principio reggente che resta privo di ogni possibile definizione. Questa
mancata definizione diventa un elemento centrale e fondamentale nel pensiero etico di Platone. In
sede politica può apparire come assenza di fondamento del piano, mancando un fine visibile. In
realtà, in coerenza con l’impostazione di Socrate questa indefinibilità si rivela essere non blocco o
freno, ma essenza e anima dell’agire politico delle componenti dello stato: la tendenza verso il bene
nella consapevolezza che nessuno ne possiede già la definizione.
3.2.4.2. I pericoli che il reggitore – filosofo corre in uno stato governato da una moltitudine guidata
dalla demagogia di retori, falsi politici, imbroglioni…
3.2.4.2.1. È il rischio generato dall’uso del discorso in forma retorica per persuadere e ottenere il
consenso da una folla riunita. È il tema che Platone affronta nella sua lunga lotta contro i Sofisti:
Gorgia, Protagora, Menone … Platone, Gorgia: l’arte retorica «GORGIA. E se tu sapessi tutto,
Socrate, [ti meraviglieresti] che la retorica in sé comprenda, per così dire, tutte le potenze e tutte le
abbia in suo dominio. Te ne darò una notevole prova: più di una volta, insieme a mio fratello e ad
altri medici, andato a casa di qualche ammalato, che non voleva bere la medicina o si rifiutava di
farsi tagliare o cauterizzare dal medico, mentre il medico non riusciva a persuaderlo ci riuscii io,
con nessun’altra arte se non con la retorica. Ecco perché posso dire che in qualsivoglia città vadano
un rètore e un medico, se una discussione si aprisse nell’assemblea popolare o in un’altra riunione
qualsiasi, per decidere quale dei due debba essere scelto in qualità di medico, il medico non
comparirebbe affatto, mentre il rètore, se lo volesse, verrebbe eletto. E così, se il rètore si trovasse a
concorrere con qualsiasi altro tecnico, più di ogni altro riuscirebbe a farsi scegliere, poiché non v’è
materia su cui non riesca più persuasivo di qualsiasi competente di fronte a una massa di persone
tale e tanto grande è la potenza dell’arte. Certo, Socrate, bisogna usare la retorica come si usa una
qualsiasi altra tecnica agonistica.» (Gorgia 456abc )
3.2.4.2.2. Premi e blandizie per gli istinti primari del popolo riunito (Platone, Repubblica) « — Che
ciascuno di quei privati che si fanno pagare, e che costoro chiaman sofisti e considerano rivali
nell’arte, niun’altra educazione impartiscono che non siano appunto queste opinioni del volgo, da
esso espresse quando si raduna, e questa chiamano sapienza: come sarebbe di uno che apprendesse
11
gli umori e gli appetiti di una bestia cresciuta grande e gagliarda, come bisogni accostarlesi e come
toccarla, e quando sia più intrattabile o più mansa e perché, e le singole voci che via via ha
l’abitudine di emettere, e quali sian quelle, in bocca a un altro, per cui essa si ammansisce o si
infuria; e avendo appreso tutto ciò col viverci insieme e col passar del tempo, lo chiamasse
sapienza, e sistematolo come in una arte si volgesse a insegnarla, senza nulla sapere in verità cosa
sia bello o brutto, buono o cattivo, giusto o ingiusto di tali opinioni e desideri, ma solo applicando
tutti questi nomi alle opinioni della grande bestia, chiamando buone le cose di cui quella si diletta,
cattive quelle per cui si arrabbia, né avendo altra ragione alcuna da dare su di esse, ma chiamando
giuste e belle le cose necessarie, senza aver mai egli veduto né essendo in grado di mostrare ad altri
di quanto in realtà le nature del necessario e del buono differiscan tra loro. Un tipo simile, per Zeus,
non ti par egli sia un ben curioso educatore? — A me certo!, disse.» (Platone, Repubblica 493 abc)
Una riflessione più ampia: con la prassi dei retori – sofisti, come ricostruita da Platone, «…la sfera
pubblica [si] popola dunque non più di attori rappresentativi, che sostengono con i loro speech acts
il peso di una responsabilità loro accordata per mandato e per delega da un’assemblea particolare,
ma la affolla di uno “sciame” di singole figure che affermano se stesse o dialogano tra loro come se
lo spazio del pubblico non fosse più contrassegnato e distinto in nulla rispetto allo spazio del
privato.» (Andrea Beretta, La sfera pubblica e la democrazia. Coimplicazioni processuali, Tesi
Scuola Superiore IUSS, 2011).
3.2.4.3. il caso Socrate, la condanna a morte di un giusto da parte dello Stato, segna la crisi interna
della democrazia. Il mito della caverna è una storia di schiavitù e di liberazione, ma anche del
tragico fallimento del progetto di liberare la moltitudine dalle ombre e dalle catene delle proprie
opinioni e illusioni, considerate, per assuefazione, abitudine ed attaccamento, difese come l’unica
indiscutibile realtà e verità.
3.2.5. La tripartizione dell’anima, alla radice dello Stato ideale, opera come modello per un
orientamento antropologico individuale e sociale e un programma di educazione, partecipazione,
realizzazione dell’uomo nella relazione civile. Essa coglie ed esprime la complessità del sentire
umano. « La ragione principale alla base di tale distinzione sta nel fatto che a volte ci troviamo a
provare nello stesso tempo, o apparentemente nello stesso tempo, desideri a favore o contro la
stessa cosa. Così potremmo fare l'esperienza di un forte impulso a soddisfare un appetito
riconoscendo allo stesso tempo che sulla lunga distanza questo obiettivo non è nel nostro interesse e
sarebbe dunque da evitare visto che non è un desiderio della ragione. Oltre a rendere conto di un sé
diviso fra il desiderio di una gratificazione immediata e quello di un prudente controllo, la divisione
platonica dell'anima serve anche per tenere insieme gli scontri tra la ragione ed emozioni quali la
vergogna o l'ira, o scontri fra queste emozioni e impulsi per gratificazioni che riguardano soltanto il
corpo o i sensi. L'assunto di fondo circa le tre parti distinte, calcolativa, appetitiva e animosa, a
volte semplificato in una divisione binaria tra impulsi razionali e non razionali, non solo rende
conto del conflitto psicologico, ma sottolinea anche i vantaggi che un ragionamento accorto ha
rispetto alla passione.» (Long A. Anthony, 2015, La mente, l’anima, il corpo. Modelli greci,
Einaudi, Torino 2016, 29)
3.3. Il mito della formazione alla ricerca del vero: la “caverna”
[un dramma in tre atti e due cesure]
[atto primo]
«In seguito, continuai, paragona la nostra natura, per ciò che riguarda educazione e mancanza di
educazione, a un’immagine come questa. Dentro una dimora sotterranea a forma di caverna, con
l’entrata aperta alla luce e ampia quanto tutta la larghezza della caverna, pensa di vedere degli
uomini che vi stiano dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover restare fermi e da
poter vedere soltanto in avanti, incapaci, a causa della catena, di volgere attorno il capo. Alta e
lontana brilli alle loro spalle la luce d’un fuoco e tra il fuoco e i prigionieri corra rialzata una
strada. Lungo questa pensa di vedere costruito un muricciolo, come quegli schermi che i burattinai
pongono davanti alle persone per mostrare al di sopra di essi i burattini. — Vedo, rispose. —
Immagina di vedere uomini che portano lungo il muricciolo oggetti di ogni sorta sporgenti dal
12
margine, e statue e altre figure di pietra e di legno, in qualunque modo lavorate; e, come è
naturale, alcuni portatori parlano, altri tacciono. — Strana immagine è la tua, disse, e strani sono
quei prigionieri. — Somigliano a noi, risposi; credi che tali persone possano vedere, anzitutto di sé
e dei compagni, altro se non le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta loro di
fronte? — E come possono, replicò, se sono costretti a tenere immobile il capo per tutta la vita? —
E per gli oggetti trasportati non è lo stesso? — Sicuramente. — Se quei prigionieri potessero
conversare tra loro, non credi che penserebbero di chiamare oggetti reali le loro visioni? — Per
forza. — E se la prigione avesse pure un’eco dalla parete di fronte? Ogni volta che uno dei
passanti facesse sentire la sua voce, credi che la giudicherebbero diversa da quella dell’ombra che
passa? Io no, per Zeus!, rispose. Per tali persone insomma, feci io, la verità non può essere altro
che le ombre degli oggetti artificiali. — Per forza, ammise. —»
[atto secondo e la prima cesura]
«Esamina ora, ripresi, come potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire dall’incoscienza.
Ammetti che capitasse loro naturalmente un caso come questo: che uno fosse sciolto, costretto
improvvisamente ad alzarsi, a girare attorno il capo, a camminare e levare lo sguardo alla luce; e
che così facendo provasse dolore e il barbaglio lo rendesse incapace di scorgere quegli oggetti di
cui prima vedeva le ombre. Che cosa credi che risponderebbe, se gli si dicesse che prima vedeva
vacuità prive di senso, ma che ora, essendo più vicino a ciò che è ed essendo rivolto verso oggetti
aventi più essere, può vedere meglio? e se, mostrandogli anche ciascuno degli oggetti che passano,
gli si domandasse e lo si costringesse a rispondere che cosa è? Non credi che rimarrebbe dubbioso
e giudicherebbe più vere le cose che vedeva prima di quelle che gli fossero mostrate adesso? —
Certo, rispose. — E se lo si costringesse a guardare la luce stessa, non sentirebbe male agli occhi e
non fuggirebbe volgendosi verso gli oggetti di cui può sostenere la vista? e non li giudicherebbe
realmente più chiari di quelli che gli fossero mostrati? — E così, rispose. — Se poi, continuai, lo si
trascinasse via di lì a forza, su per l’ascesa scabra ed erta, e non lo si lasciasse prima di averlo
tratto alla luce del sole, non ne soffrirebbe e non s’irriterebbe di essere trascinato? E, giunto alla
luce, essendo i suoi occhi abbagliati, non potrebbe vedere nemmeno una delle cose che ora sono
dette vere. Non potrebbe, certo, rispose, almeno all’improvviso. — Dovrebbe, credo, abituarvisi, se
vuole vedere il mondo superiore. E prima osserverà, molto facilmente, le ombre e poi le immagini
degli esseri umani e degli altri oggetti nei loro riflessi nell’acqua, e infine gli oggetti stessi; da
questi poi, volgendo lo sguardo alla luce delle stelle e della luna, potrà contemplare di notte i corpi
celesti e il cielo stesso più facilmente che durante il giorno il sole e la luce del sole. — Come no? —
Alla fine, credo, potrà osservare e contemplare quale è veramente il sole, non le sue immagini nelle
acque o su altra superficie, ma il sole in se stesso, nella regione che gli è propria. — Per forza,
disse. — Dopo di che, parlando del sole, potrebbe già concludere che è esso a produrre le stagioni
e gli anni e a governare tutte le cose del mondo visibile, e ad essere causa, in certo modo, di tutto
quello che egli e i suoi compagni vedevano. — È chiaro, rispose, che con simili esperienze
concluderà così. — E ricordandosi della sua prima dimora e della sapienza che aveva colà e di
quei suoi compagni di prigionia, non credi che si sentirebbe felice del mutamento e proverebbe
pietà per loro? Certo. Quanto agli onori ed elogi che eventualmente si scambiavano allora, e ai
premi riservati a chi fosse più acuto nell’osservare gli oggetti che passavano e più rammentasse
quanti ne solevano sfilare prima e poi e insieme, indovinandone perciò il successivo, credi che li
ambirebbe e che invidierebbe quelli che tra i prigionieri avessero onori e potenza? o che si
troverebbe nella condizione detta da Omero e preferirebbe «altrui per salario servir da contadino,
uomo sia pur senza sostanza», e patire di tutto piuttosto che avere quelle opinioni e vivere in quel
modo? — Così penso anch’io, rispose; accetterebbe il patire di tutto piuttosto che vivere in quel
modo. — »
[atto terzo e la seconda cesura]
«Rifletti ora anche su quest’altro punto, feci io. Se il nostro uomo ridiscendesse e si rimettesse a
sedere sul medesimo sedile, non avrebbe gli occhi pieni di tenebra, venendo all’improvviso dal
sole? Sì, certo, rispose. — E se dovesse discernere nuovamente quelle ombre e contendere con
coloro che sono rimasti sempre prigionieri, nel periodo in cui ha la vista offuscata, prima che gli
13
occhi tornino allo stato normale? e se questo periodo in cui rifà l’abitudine fosse piuttosto lungo?
Non sarebbe egli allora oggetto di riso? e non si direbbe di lui che dalla sua ascesa torna con gli
occhi rovinati e che non vale neppure la pena di tentare di andar su? E chi prendesse a sciogliere e
a condurre su quei prigionieri, forse che non l’ucciderebbero, se potessero averlo tra le mani e
ammazzarlo? — Certamente, rispose. — Tutta quest’immagine, caro Glaucone, continuai, si deve
applicarla al nostro discorso di prima: dobbiamo paragonare il mondo conoscibile con la vista alla
dimora della prigione, e la luce del fuoco che vi è dentro al potere del sole. Se poi tu consideri che
l’ascesa e la contemplazione del mondo superiore equivalgono all’elevazione dell’anima al mondo
intellegibile, non concluderai molto diversamente da me, dal momento che vuoi conoscere il mio
parere. Il dio sa se corrisponde al vero. Ora, ecco il mio parere: nel mondo conoscibile, punto
estremo e difficile a vedersi è l’idea del bene; ma quando la si è veduta, la ragione ci porta a
ritenerla per chiunque la causa di tutto ciò che è retto e bello; e nel mondo visibile essa genera la
luce e il sovrano della luce, nell’intellegibile largisce essa stessa, da sovrana, verità e intelletto. E
chi vuole condursi saggiamente in privato o in pubblico deve vederla. — Sono d’accordo anch’io,
rispose, come posso. — Su, ripresi, sii d’accordo con me anche su quest’altro punto e non stupirti
che chi è giunto fino a quest’altezza non voglia occuparsi delle cose umane, ma che la sua anima
sia continuamente stimolata a vivere in alto. È naturale che sia così, se anche per questo vale
l’immagine di prima. — È naturale, rispose. — E credi che ci si possa stupire, ripresi, se uno,
passando da visioni divine alle cose umane, fa cattiva figura e appare ben ridicolo, perché la sua
vista è ancora offuscata? e se, prima ancora di avere rifatto l’abitudine a quella tenebra recente,
viene costretto a contendere nei tribunali o in qualunque altra sede discutendo sulle ombre della
giustizia o sulle copie che danno luogo a queste ombre, e a battersi sull’interpretazione che di
questi problemi dà chi non ha mai veduto la giustizia in sé? — Non ci si può stupire affatto, rispose.
— Ma una persona assennata, feci io, si ricorderebbe che gli occhi sono soggetti a due specie di
perturbazioni, e per due motivi, quando passano dalla luce alla tenebra e dalla tenebra alla luce. E
se pensasse che questi medesimi fatti si producono pure per l’anima, quando ne vedesse una
turbata e incapace di visione alcuna, non si metterebbe a ridere scioccamente, ma cercherebbe di
sapere se, venendo da una vita più splendida, sia ottenebrata perché disabituata; o se, procedendo
dall’ignoranza a una condizione di maggiore splendore, si trovi ad essere troppo abbagliata. E così
direbbe l’una felice della sua condizione e della sua vita, e avrebbe pietà dell’altra. E se volesse
riderci sopra, il suo riso sarebbe meno ridicolo di quello che colpirebbe l’anima che viene
dall’alto, dalla luce. — Sì, rispose, parli a modo.
[epilogo]
[prima conclusione]
— Ora, ripresi, se questa è la verità, dobbiamo trarne la seguente conclusione: l’educazione non è
proprio come la definiscono taluni che ne fanno professione. Essi dicono che, essendo l’anima
priva di scienza, sono loro che la istruiscono, come se in occhi ciechi ponessero la vista. — Lo
dicono, sì, rispose. — Invece, continuai, il presente discorso vuole significare che questa facoltà
insita nell’anima di ciascuno e l’organo con cui ciascuno apprende, si devono staccare dal mondo
della generazione e far girare attorno insieme con l’anima intera, allo stesso modo che non è
possibile volgere l’occhio dalla tenebra allo splendore se non insieme con il corpo tutto; e questo si
deve fare finché l’anima divenga capace di resistere alla contemplazione di ciò che è e della parte
sua più splendida. In questo consiste, secondo noi, il bene. No? — Sì. — C’è dunque, feci io,
un’arte apposita di volgere attorno quell’organo, e nel modo più facile ed efficace. Non è l’arte di
infondervi la vista: quell’organo già la possiede, ma non è rivolto dalla parte giusta e non guarda
dove dovrebbe; e a quell’arte spetta appunto di occuparsi di questa sua conversione. — Sembra di
sì, rispose. — Ebbene, le altre che si dicono virtù dell’anima forse si avvicinano in certo modo a
quelle del corpo. Ché realmente, anche se non vi sono dentro prima, forse vi vengono infuse più
tardi dalle abitudini e dagli esercizi. Ma la virtù dell’intelligenza è propria più di ogni altra, come
pare, di un elemento più divino, che non perde mai il suo potere e che, secondo come lo si rivolge, è
utile e vantaggioso o inutile e dannoso. Non hai mai pensato quanto sia penetrante lo sguardo
dell’animuccia propria dei cosiddetti malvagi sapienti? e quanto acutamente discerna gli oggetti
14
cui è rivolta, appunto perché è dotata di vista non mediocre, ma è costretta a servire alla loro
cattiveria sì che i mali da essa prodotti sono tanto più numerosi quanto più acuto è il suo sguardo?
— Senza dubbio, rispose. — Supponiamo dunque, continuai, che, con un’operazione eseguita fin
dall’infanzia, questa natura così formata fosse amputata tutto intorno di quella sorta di masse
plumbee che appartengono al mondo della generazione e che le stanno attaccate addosso con gli
alimenti, i piaceri e simili golosità, tutte cose che fanno volgere in giù lo sguardo dell’anima. Se ne
fosse stata liberata e fosse stata volta alle cose vere, questa medesima natura, di questi medesimi
uomini, avrebbe potuto vedere anche quelle, così come vede gli oggetti ai quali è rivolta ora, assai
acutamente. — È ben naturale, rispose. — E non è naturale, ripresi, anzi non è conseguenza
necessaria delle nostre parole che né le persone non educate e inesperte del vero né quelle cui si è
permesso di consacrare tutta la vita all’educazione potranno mai amministrare bene uno stato?
quelle perché nella loro vita mancano di una mèta cui mirare compiendo tutte le loro azioni private
e pubbliche, queste perché non le compiranno spontaneamente, convinte di abitare ancora da vive
nelle isole dei beati? — È vero, rispose. — È dunque compito nostro, dissi, compito proprio dei
fondatori, quello di costringere le migliori nature ad accostarsi a quella disciplina che prima
abbiamo definita la massima, vedere il bene e fare quell’ascesa.
[seconda conclusione]
E quando sono salite e l’hanno visto pienamente, non dobbiamo permettere loro ciò che si permette
ora. — Che cosa? — Rimanere colà, feci io, senza voler ridiscendere presso quei prigionieri e
partecipare delle fatiche e degli onori del loro mondo, a prescindere dalla minore o maggiore loro
importanza. — Ma, rispose, dovremo veramente fare ingiustizia a queste nature e farle vivere
peggio, quando possono vivere meglio? — Ti sei dimenticato di nuovo, mio caro, replicai, che alla
legge non interessa che una sola classe dello stato si trovi in una condizione particolarmente
favorevole. Essa cerca di realizzare questo risultato nello stato tutto: armonizza tra loro i cittadini
persuadendoli e costringendoli, fa che si scambino i vantaggi che i singoli sappiano procurare alla
comunità; e creando nello stato simili individui, la legge stessa non lo fa per lasciarli volgere dove
ciascuno voglia, ma per valersene essa stessa a cementare la compattezza dello stato. —— È vero,
rispose; me ne sono dimenticato. — Considera poi, Glaucone, continuai, che non faremo torto
nemmeno a quelli che nel nostro stato nascono filosofi; ma che saranno giuste le cose che loro
diremo costringendoli a curare e custodire gli altri.» (Platone, Repubblica 514a- 520a.)
Appendici interpretative recenti intorno al mito della caverna:
3.3.1. Bruno Latour. (Il riferimento va, in particolare all’opera: Latour Bruno 1999 Politiques de la
nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, ed. La Découverte, Paris 2004 ; in
traduzione italiana : Latour Bruno 1999 Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze,
Raffaello Cortina editore, Milano 2000.)
Il problema. In Platone è in atto una separazione che assume le forme della lacerazione e
dell’opposizione politica. Nel mito della caverna (nell’“inganno della caverna”, Latour) il parlare,
sempre forse in forma di parresia, si divide, si colloca in due sedi separate (scarsamente collegate,
di difficile collegamento) e assume natura ben diversa; la conseguenza è che tra le due forme la
distanza è pressoché, disperatamente, incolmabile e di tragica opposizione. La vicenda di Socrate
(la sua condanna a morte da parte di quella polis che intendeva curare, salvare) e dello stesso
Platone (il fallimento drammatico dei tentativi di Platone, minacciato di morte e quindi in
precipitosa fuga, e dei platonici di condurre lo stato o i suoi reggitori alla filosofia) ne sono
(sarebbero) una drammatica e eloquente conferma.
Parole e linguaggi separati e la questione politica.
Il parlare (la parresia) di coloro (la massa, i più, il demos) che stanno nella caverna, prigionieri
senza saperlo, senza esserne consapevoli (quindi doppiamente prigionieri), legati e abituati (legati
dall’abitudine) a guardare scorrere sullo schermo del fondo della caverna immagini e ombre, è
chiacchiericcio infinito e senza senso (“bavardage” Latour) intorno a ombre, immagini, apparenze e
simili amenità… Di esse ignorano sia ciò di cui sono copia, sia gli artefici di quelle oculate
proiezioni: burattinai alle loro spalle, non visti e non sospettati di esistere che astutamente
15
proiettano per la massa dei prigionieri ombre accorte, accompagnate da parole adeguate
trasmettendole come la realtà; ciò che essi vedono è considerato realtà in quanto unica visione
avvertita, e realtà ritenuta senza alternativa… Difficile, per i legacci e legami, girare il capo,
cogliere e smascherare l’inganno senza incorrere nell’ingiuria collettiva della follia, dell’uscita di
senno, senza essere derisi, accusati, cacciati, uccisi; comunque se la liberazione (conversione) capita
si tratta di un caso fortuito, accade a pochi, la sorte di costoro è l’irrisione e, come nel caso di
Socrate, la cacciata e la morte.
Il parlare di coloro (i pochi, gli aristoi) che per fortuna e coraggio, per condizioni naturali favorevoli
(per natura) e per pazienza di adattamento educativo (per educazione e studio; uno studio che si
unisce alla natura risvegliandola secondo opportunità: il kairòs) si sono liberati dalla catene e,
uscendo dalla caverna, hanno compiuto il cammino in salita dalle ombre verso gli oggetti, di cui
quelle ombre erano proiezioni, dagli oggetti verso le forme ideali geometriche che di ogni oggetto
visibile sono forme, dagli enti ideali delle geometrie verso i principi logici ideali, cioè verso le
forme e essenze ideali a partire dalle quali ogni realtà trova spiegazione e fondamento e si compone
in un ordine razionale comprensibile e gestibile. Il loro parlare costituisce scienza. È la repubblica
dei pari quanto all’aristocrazia del sapere e della parresia della scienza, del costruire secondo
sapienza di cui l’Accademia platonica è realizzazione storica concreta, esterna alla polis, ma
rivendicante un progetto di gestione, conduzione razionale (pitagorica, nostalgica del modello
pitagorico) della polis.
Il problema politico come problema del doppio e la sua gestione.
È necessario riconoscere e stabilire la natura e le competenze dei due luoghi che il mito della
caverna di Platone nettamente distingue e oppone, almeno in prima relazione. Distruttivo è pensare
di conservarli in opposizione, in guerra, in disprezzo reciproco (stile “radical chic” contro “gente
comune/normale”) o pensare di eliminare uno di loro, eliminando così una espressione competenza
sociale insopprimibile. Il problema che si impone è come legarli tra loro in un progetto o in una
relazione di tipo politico.
3.3.2. La proposta: «Giacché i Lumi possono abbagliarci soltanto se l’epistemologia (politica) ci fa
innanzitutto scendere nella Caverna, per uscirne vi è un mezzo molto più semplice di quello di
Platone: non entrarvi!» (Latour 1999, 9,10). Osserva William Kentridge (cfr. Sei lezioni di disegno,
Johan and Levi Editore, 2016) come nella dialettica tormentata del mito della caverna, in cui
vengono sconfitti gli estremi, i prigionieri incatenati e mangiatori di ombre, il filosofo liberato e di
ritorno, portatore di luce, l’area che viene posta in risalto come sede abitabile è, probabilmente, una
“terra di mezzo”. Così Kentridge, rileggendo il mito della caverna di Platone: «Concediamoci di
non essere né i prigionieri nella caverna, incapaci di comprendere quello che vediamo, né
l'onnisciente filosofo che ritorna alla caverna con tutte le sue certezze. Concediamo ci di abitare la
terra di mezzo, lo spazio tra ciò che vediamo sul muro e la forma che inventiamo dietro la retina».
Terra di mezzo che, consapevole della sua condizione di medietà, sa guardare gli estremi senza la
tentazione di volerli abitare.
4. l’altro: il problema del confronto (la contraddizione del confronto)
Le radici “metafisiche” o strutturali (antropologiche e sociali) del dialogo, della dimenticanza, della
reminiscenza e quindi della costruzione della memoria di sé nel tempo delle opportunità (kairòs) si
collocano nel principio, nella realtà e nella nozione di “altro” (tò éteron).
4.01. Il problema nel contesto nella ricerca di Platone. Conoscere è gestire la realtà secondo
modelli, indicati nella loro insieme da Platone con i molti termini già richiamati: schemi, concetti,
idee, paradigmi, essenze… Il tema della gestione dei modelli diventa l’argomento principale della
scuola fondata da Platone, l’Accademia, e permette la definizione della scienza filosofica
considerata somma nel piano degli studi, la Dialettica: la scienza dei modelli, dei paradigmi o delle
idee. Scienza che finisce per costituire un mondo ideale, logico e metafisico, di studio e di
esercitazioni su cui si concentrano le “dottrine non scritte” di Platone, quelle che, all’interno
dell’Accademia (le dottrine esoteriche, per gli “interni”), programmano, definiscono e guidano i
piani di lavoro della scuola platonica, e che sono presentati e discussi anche (per gli esterni,
16
essotericamente) nei dialoghi platonici definiti “dialettici” (Sofista, Filebo, Parmenide…); trovano
inoltre richiami nelle opere giovanili di Aristotele (dialoghi scritti da Aristotele quando lavorava
nell’Accademia di Platone) e in alcune sue opere “maggiori” (come nel primo libro della
Metafisica). Le proposte di Platone su come gestire la “dialettica”, la scienza dei modelli, dei
paradigmi o delle idee, si articolano in tre procedimenti principali: il metodo della divisione e
sintesi (diairesis e synagoghé), degli elementi (uno e diade, e i numeri ideali), dei generi sommi.
In quest’ultima dottrina di metodo, il vasto mondo delle idee viene gestito dialetticamente in quanto
ricondotto a cinque generi sommi che presiedono alle articolazioni possibili dei modelli; i cinque
generi sono: quiete, moto, identico, essere, non essere (diverso, altro). La sorpresa, e il paradosso, è
data principalmente dalla affermazione che il non-essere (indicato con l’espressione “non-essere,
“l’altro”) è un genere… come dire, paradossalmente, “il non-essere è”, anzi rientra tra i generi
sommi della realtà e delle idee. Nel Sofista in particolare, Platone discute e dichiara, sfidando
esplicitamente la tradizione filosofica e la contraddizione: «Abbiamo dimostrato che il non-essere
è».
4.02. Il passaggio in gioco risulta fondamentale: con l’affermazione del genere del non-essere,
dell’altro, (tò éteron), è posta la base ontologica del dialogo; solo la presenza e il rispetto del nonessere, dell’altro, rende possibile un reale rapporto; il non essere, l’alterità, si colloca a fondamento
dell’arte delle relazioni e qui si ripropone, e trova fondamento, il tema primo e ricorrente di Platone,
impostato da Socrate: il dialogo, cosa sia e come si possa realizzare; quali ne sia la natura e quali le
implicazioni. Platone è alla ricerca delle basi di una logica (una dialettica) in grado di definire,
distinguere e salvare le differenze, in grado di gestire il linguaggio, condizione prima di dialogo e
confronto, di scelta e di conoscenza.
4.1. La radice metafisica del quesito è fornita si impone dal richiamo inevitabile delle tesi di
Parmenide: l’affermazione filosofica dell’esistenza del non-essere contraddice infatti le sue tesi e
rappresenta la morte (filosofica) di Parmenide: «Abbiamo dimostrato che il non-essere è». L’idea è
introdotta con ripetuta titubanza, nel dialogo Sofista: «Forestiero. E non s’ha a dire con fiducia che
il non essere ha sicuramente una sua propria natura; e, come il grande era grande, il bello bello, e
il non grande non grande e il non bello non bello: così anche allo stesso titolo il non essere era ed è
non essere, annoverabile, come una forma tra le molte che sono? O rispetto a ciò, Teeteto, abbiamo
tuttora qualche diffidenza? Teeteto. Oh! nessuna. FOR. Ma sai dunque che abbiamo disobbedito a
Parmenide al di là del suo divieto? TEE. E perché? FOR. Perché, proceduti con la nostra indagine
anche oltre, noi gli abbiamo dimostrato più di quello che egli ci aveva interdetto di esaminare.
TEE. E come? FOR. Difatti egli, se non erro, dice: «Perché questo non può venire mai imposto:
che le cose che non sono siano: ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero». TEE. Così
difatti egli dice. FOR. E noi invece non solo abbiamo dimostrato che il non essere è, ma del non
essere abbiamo chiarito anche la forma che lo costituisce, perché dopo di aver dimostrato che la
natura del diverso è, e si trova sminuzzata per tutti quanti gli esseri nei rapporti reciproci; di
ciascuna particella di essa, che si contrapponga all’essere abbiamo avuto l’audacia di dire che
questa per l’appunto è realmente il non essere.» (Platone, Sofista 258 b-d)
4.2. La logica deve ammettere il non-essere tra i generi sommi e affermare, con coraggio e
impudenza, ma per necessità e coerenza (quasi contraddittoria), che il non-essere è. Una qualsiasi
idea, infatti, possiede una propria e specifica identità ed è se stessa in quanto si distingue e non è
un’altra idea; così è per ogni realtà che si voglia determinare, definire, delineare, individuare. È
necessario dunque disporre non solo del genere sommo dell’essere, per poterne affermare
l’esistenza, ma, per lo stesso motivo, del genere del non-essere, della diversità, dell’alterità.
La forma è sempre una negazione determinata. Proprio in forza e in relazione all’altro, al non
essere, la forma si determina; acquista la forza di una negazione determinata (non di una negazione
assoluta, né di una pretesa all’assoluto e alla totalità che, con il togliersi delle determinazioni,
coincide con il nulla). L’altro, il non-essere, è dunque un problema di tipo logico: distinguere,
accettare la differenza e la molteplicità significa usare una nozione, quella del non-essere. Si tratta
di una contraddizione perché si usa un termine e una realtà mentre se ne nega l’esistenza. Eppure se
17
tutto è essere non abbiamo uno strumento per distinguere una cosa concreta da un’altra (“questo
non è quello”), una persona da un’altra, un valore da un altro (il bene dal male, il giusto
dall’ingiusto, il bello dal brutto, il vero dal falso… e la tesi di Parmenide finisce per diventare,
osserva Platone, un abile rifugio per la retorica dei Sofisti quando destinata all’inganno). Nulla si
definisce e la nostra conoscenza della totalità dell’essere (uno e unico) è conoscenza di nulla: non vi
è nulla di determinato, definito, delimitato; perché ciò che è definito lo è in forza di un fine, un
confine, un termine, di ciò che esso non è, del genere del non-essere. Per poter continuare a vedere,
pensare, scegliere dobbiamo servirci della nozione del non-essere, di ciò che è diverso, di ciò che è
altro, di cui dunque occorre affermare l’esistenza se la differenza è reale.
4.2.1. Il trauma deriva dall’affermazione che il non-essere si presenta come un genere e non come
una semplice caratteristica di qualcosa; è un principio originario e non dipendente da un’altra realtà
di cui è qualità; anzi è la condizione di esistenza di ogni realtà determinata, sia essa ideale o visibile.
L’alterità non è un tratto particolare dell’essere, né il suo assoluto contrario, ma una sua condizione
di esistenza e di identità; l’essere deve fare i conti con il non-essere, può definirsi solo in forza del
non-essere. Qui la base metafisica della relazione e del dialogo, della natura aperta della conoscenza
e della scelta, della scoperta continua e del portare alla memoria e all’azione la nostra storia, nella
relazione.
4.2.2. La nostra definizione è possibile in forza dell’altro, del rapporto con l’altro (l’alterità). Stare
nel rapporto con l’altro è stare nel rapporto con il nostro non-essere, con la nostra definizione. Il
nostro esser-altro da noi (il nostro divenire), dagli altri (la nostra singolarità) è luogo di dialogo,
confronto, scoperta. La filosofia è dunque dialogo; per portare alla conoscenza si muove infatti
nell’alterità, nella relazione all’altro. Compaiono i noti paradossi del divenire, propri della scuola
eleatica, attribuiti a Zenone, discepolo di Parmenide: il movimento, il divenire, implica lo stare e il
non stare nello stesso punto; l’assenza di una delle due situazioni annulla il divenire. L’indicibile al
di là del dicibile nel dicibile, il vuoto al di là del simbolico nel simbolico.
4.2.3. La relazione con l’altro non rimanda ad un altro determinato, particolare e come tale
provvisorio e infinito come numero e come esemplari, non rimanda all’altro come un oggetto
qualsiasi posto all’esterno del soggetto che guarda e considera, ma si tratta di una relazione che
colloca il soggetto nella dimensione dell’alterità allo scopo di costruirlo. L’altro, in Platone, è uno
dei “generi sommi” non una cosa qualsiasi; in quanto genere costituisce le condizioni strutturali
della relazione e in essa della conoscenza teorica e pratica della soggettività. Solo la capacità di
restare nell’alterità, di conservare l’altro come altro rispettando di ogni determinazione
l’appartenenza al genere dell’alterità come essenza che lo rende proprio e singolare rende possibile
la relazione, altrimenti si è alla presa di possesso, alla assimilazione, alla definizione di oggetti in
vista di una appropriazione e assimilazione definitiva ed esclusiva e quindi alla negazione dell’altro.
La conseguenza inesorabile che si profila nell’assimilazione è l’assenza di ogni possibile reale
relazione. Ritorna qui ancora, al centro della filosofia platonica, e della filosofia in generale, il
metodo del dialogo socratico che, attraverso l’affermazione del non-sapere da parte di colui che
esprime il desiderio di ricerca e attraverso l’esercizio di una sospensione (epoché) ironica per tutto
ciò che ostacola il cammino presentandosi come dogma certo e finale, scopre e conserva l’alterità e
rende possibile il riconoscimento. Dialogo è riconoscere ed essere riconosciuti nella relazione che
non ha come obiettivo il possesso di un oggetto, la negazione della differenza, ma la travagliata e
mai risolta apertura all’Altro. Il desiderio strutturale e profondo è il desiderio dell’Altro (come
alterità), non il desiderio dell’altro (come oggetto da possedere); o meglio, nel desiderio dell’altro,
di ogni altro, è sempre in azione il desiderio dell’Altro (di una trascendente alterità); il desiderio
umano come desiderio di essere riconosciuto dall’Altro, collocato nel genere dell’Altro. L’Altro, il
non-essere è l’oggetto stesso del desiderio in quanto consente il riconoscimento. Nella posizione
dialogica, costruita attraverso la messa in sospensione di ogni definizione precostituita, viene posta
in atto una intersoggettività fondante, nel senso che l’essere di ogni soggettività dipende
costitutivamente dall’essere dell’Altro, dal rispetto del genere Altro. Domina il “sapere di non
sapere di Socrate”: «Non c’è vero atto creativo se l’Altro sa, se la produzione procede da un sapere
18
o una tecnica noti. Senza aver fatto «tabula rasa» l’azione rimane esecuzione». (Galimberti Fabio,
2015, Il corpo e l’opera. Volontà di godimento e sublimazione, Quodlibet, Macerata, 113)
[Una precisazione sulle lettere in scrittura: altro, con la a minuscola, indica ogni determinazione
considerata oggetto e moltiplicabile in numero senza fine; Altro, con la A maiuscola, indica la
condizione o il genere dell’alterità come possibilità di conservare l’irriducibilità di ogni realtà alle
definizioni oggettuali.]
4.3. Alcune riprese, ritorni e riflessioni, sul tema dell’alterità, formulate nel tempo a partire da
altre prospettive.
4.3.1. un contributo di carattere ontologico-intenzionale: «Quando parlo di filosofia prima, mi
riferisco ad una filosofia del dialogo che non può non essere un’etica. Anche la filosofia che
interroga il senso dell’essere lo fa a partire dall’incontro di altri. Sarebbe questa una maniera di
subordinare la conoscenza, l’oggettivazione all’incontro d’altri presupposto in ogni linguaggio. […]
L’incontro avviene tra stranieri, altrimenti sarebbe parentela. Ogni pensiero è subordinato alla
relazione etica, all’infinitamente altro in altri, e all’infinitamente altro di cui ho nostalgia. Pensare
altri dipende dall’irriducibile inquietudine per l’altro. […] In questa relazione all’altro, non c’è
fusione, la relazione all’altro è pensata come relazione all’alterità.» Emmanuel Levinas, Alterità e
trascendenza, ed. il melangolo, Genova 2006, 87, 91)
4.3.2. un contributo di carattere psicanalitico e sociologico: i rischi di un’empatia in cui la presa
emotiva finisce per azzerare ogni relazione, ogni dialogo, nella parvenza della relazione, in quanto
annulla l’alterità (la dimensione ontologica e storica dell’alterità) e l’analisi dei rischi di un
altruismo non razionale. Bisogna disporre di strumenti (concetti, principi e scelte) a difesa di un
altruismo razionale, così come emerge nel dialogo platonico, nella dottrina dei generi sommi ove
l’Altro, in quanto genere sommo, non diventa una appropriazione possibile, ma un anelito senza
fine. Gli elementi che strutturalmente agiscono nella relazione intersoggettiva sono: il concetto
(genere) dell’Altro, la soggettività come intersoggettività, il riconoscimento. Il formarsi del
soggetto, il suo “assoggettarsi”, accade nella relazione dell’intersoggettività che è dominata dal
concetto di Altro operante qui come richiesta e desiderio di riconoscimento. Si torna alle radici
socratiche della filosofia platonica (e della filosofia in generale): «il desiderio di riconoscimento
[diventa] il motore della ristrutturazione soggettiva realizzabile nel dialogo. La parola [diventa] così
l'atto con cui nella relazione dialogica con l'altro il soggetto domanda di essere riconosciuto. Il
riconoscimento [diventa] la soddisfazione specifica raggiungibile nel rapporto con l'Altro,
quell'altra soddisfazione, appunto, diversa da quella istintuale …» (Galimberti Fabio, 2015, Il corpo
e l’opera. Volontà di godimento e sublimazione, Quodlibet, Macerata, 42)
4.3.2.1. i rischi di un’empatia (magari istintuale) con l’altro che annulla la relazione (e l’altro). «In
gradazioni diverse l’esigenza di preservare la differenza da un'empatia eccessiva ispira tutti i legami
autenticamente generativi. Non si tratta evidentemente della freddezza necessaria del chirurgo —
che sarebbe altamente patologica nella vita comune — ma di quella quota necessaria di solitudine
che accompagna inevitabilmente ogni gesto di responsabilità. Per questa ragione Heidegger diceva
che si muore sempre da soli, il che non significa affatto che si debba morire abbandonati dall’altro o
senza partecipazione emotiva.
Pensiamo alla relazione tra genitori e figli. Sappiamo bene come un eccesso di prossimità rischi di
assorbire quel margine di libertà da cui scaturisce la dimensione singolare della vita. È quello che ci
insegnano le bugie dei bambini. La loro importanza nello sviluppo psichico non va sottovalutata.
Mentire è una prima prova necessaria di libertà: il bambino deve poter custodire i propri segreti
senza che nessun altro possa spiarli, deve poter verificare che nessuno possa leggere i suoi pensieri.
Un eccesso di empatia nella relazione tra genitori e figli può alimentare invece l'illusione dannosa
dell’indifferenziazione come segnala in modo drammatico la morte del padre di Flaubert. Per questo
è sempre bene non capire sino in fondo i propri figli, non venire mai a capo del mistero della loro
esistenza. I bambini hanno bisogno di non essere mai capiti del tutto, di essere almeno un po'
incompresi. Non sono forse i genitori che presumono di conoscere i propri figli sino all’ultimo
capello i più sorpresi di fronte a certe loro scelte o gesti estremi?
19
Questa esigenza di oscurità, come si sarebbe espresso Nietzsche, non è al fondo di ogni rispetto
autenticamente altruistico? L’elogio sperticato dell’empatia come capacità di immedesimazione
all’altro, vorrebbe invece attenuare la solitudine della nostra singolarità rendendoci tutti più simili.
La psicoanalisi insegna sempre a sospettare della spinta a renderci uguali, a cancellare le differenze
soggettive. Non a caso Lacan ha fatto della critica all’empatia un motivo costante del suo
insegnamento. Abbiamo non a caso conosciuto l'attitudine empatica di tutti i grandi leader totalitari
e populisti nel sentirsi all’unisono con la pancia del loro popolo. Anche il genitore che pensa di
sapere tutto di suo figlio perché è come lui, perché risuona in lui empaticamente, non sa lasciare
spazio alla differenza. L'empatia rischia di trasformare la relazione tra due soggetti differenti in una
relazione speculare tra simili. Ma è proprio con chi riteniamo più simile a noi e non con l’altro
diverso che diamo il peggio di noi stessi. È il caso dell’invidia che già Aristotele faceva notare
essere un sentimento che non proviamo per chi appartiene ad un mondo troppo diverso dal nostro,
ma solo verso chi ci è più prossimo. Anche l'ostilità verso l’accoglienza dei disperati che sbarcano
sulle nostre coste scaturisce da un processo di identificazione proiettiva: sono poveri, affamati come
ciascuno di noi è o teme di diventare.
Possiamo chiederci: quali sono i legami che sanno durare creativamente nel tempo? Quelli che
sanno preservare la differenza come dato inassimilabile, quelli nei quali l’altro resta l’altro, ad una
distanza sufficiente per impedire quella “intimità alienata” che Adorno vedeva riflettersi
impietosamente nella canottiera bianca del padre-marito sdraiato sul divano. Saper stare
generativamente in un legame significa anche saperne stare sempre parzialmente fuori, permanere
oscuro a se stesso. Lo sappiamo: i legami più fecondi e duraturi sono quelli che si fondano sulla
capacità di stare da soli. È questa l'essenza non-empatica dell’altruismo. Altrimenti la comunità
stessa rischia di scivolare verso l’identificazione totalitaria alla massa. La violenza può essere letta
come il sintomo estremo dell’illusione empatica: se capisco tutto dell'altro, se mi identifico a lui, se
condivido tutto con lui, se nessuno dei suoi processi psichici mi è oscuro, cade quella differenza e
quel rispetto per la sua lingua straniera che solo rende possibile un legame nutrito di rispetto. Sapere
tutto dell’altro, dissolvere il suo mistero in una trasparenza senza resti, finisce per cancellare la
bellezza del mistero dell’alterità. Un incontro non avviene mai allo specchio. Ogni volta che accade
davvero noi facciamo esperienza di ciò che ci sfugge, di ciò che non arriviamo mai del tutto a
comprendere.» (Recalcati Massimo, Critica della ragion empatica, la Repubblica 5 ottobre 2014)
4.3.2.2. I rischi politici di un altruismo non razionale. «Empatia e simpatia, due parole in questo
equivalenti, spingono di per sé ad avvicinarsi emotivamente ai simili, a preferire persone di
bell’aspetto, a sviluppare forme di altruismo che si rivolgono superficialmente a quello che di più
colpisce attraverso i media: un singolo bambino le cui sofferenze vediamo sul video pesa molto di
più di milioni danneggiati da una scelta di governo che taglia i fondi alle scuole pubbliche. La
violenza su un singolo gattino, la morte di una singola orsa — recenti casi che hanno dominato il
web — hanno un impatto gigantesco che oscura realtà spesso più rilevanti, ma più astratte nella
comune percezione, come per esempio dati sull'aumento di siccità, in Medio Oriente e altrove, che
devasta la vita di milioni di esseri umani. Non so quanto i terroristi dell’Is conoscano l’«effetto
della vittima identificabile», ma certo ne fanno uso quando mostrano a tutto il mondo il video della
decapitazione di una singola persona e nascondono quelli (trovati sugli smartphone di qualche
jihadista morto) dei massacri di massa e della deportazione di donne schiavizzate. […] gli appelli
al puro ragionamento devono fare i conti con l'enorme incidenza dei fattori non razionali in politica,
delle emozioni che influenzano le simpatie, le valutazioni e i voti.» (Bosetti Giancarlo, I rischi
politici dell’altruismo non razionale, la Repubblica 5 ottobre 2014)
[cita Martha Nussbaum , Emozioni politiche. Perché 1’amore conta per la giustizia, (Il Mulino
2014)]
4.3.3. un contributi di carattere socio-politico (note espresse da Rosanvallon Pierre, 2011, La
società dell’uguaglianza, Castelvecchi, Roma 2013)
4.3.3.1. tra definizioni “storiche” di individualità abbinata a tre diversi termini: universale,
particolare, singolare.
20
«La metamorfosi dell’individualismo: 1. L'individualismo dell'universalità. […] Rinviava alla
costituzione dell'uomo in quanto soggetto giuridico, portatore di diritti che garantiscono la sua
libertà di pensiero e d'azione, la sua proprietà e la sua autonomia, e in quanto soggetto politico,
membro sovrano che esercita il proprio diritto di voto. Definiva dunque un modo di fare società,
una modalità inedita di composizione dell'ordine politico e sociale che prendeva il posto del vecchio
ordine corporativo e assolutista. L'individualismo rivoluzionario era perciò inseparabile dall'idea di
uguaglianza e dal riconoscimento di una similarità tra gli uomini. […] Con quest'espressione ha
voluto sottolineare che allora l'aspirazione all'autonomia e alla libertà era ritenuta inseparabile da un
ethos egualitario e universalista. 2. L'individualismo della distinzione. [… ad esempio] L'artista si è
allora definito come colui che esprimeva la propria identità con la forma di una dissidenza rispetto
al senso comune. […] L'individualismo della distinzione è stato il precursore del contemporaneo
individualismo della singolarità. 3. L'individualismo della singolarità. L'individualismo della
singolarità consiste nella generalizzazione dell'individualismo della distinzione. Lo banalizza, gli
toglie il suo lato elitario, lo democratizza. Con esso si apre una nuova tappa dell'emancipazione
umana, quella del desiderio di accedere a un'esistenza pienamente personale. […] La responsabilità
diventa inestricabilmente un obbligo e un valore positivo, in una società che in tal modo si reindividualizza. L'individualismo della singolarità corrisponde anche a nuove aspettative
democratiche. Nella democrazia come regime politico legato all'individualismo universalistico, il
suffragio universale significava per ciascuno una porzione di sovranità uguale a quella degli altri.
Nella democrazia come forma sociale dell'individualismo della singolarità, c'è l'aspirazione a essere
importante agli occhi degli altri, a essere unico. C'è la formulazione implicita di un uguale diritto
per ciascuno di essere considerato come una star, un esperto o un artista; di vedere le proprie idee e
i propri giudizi presi in considerazione, riconosciuti come aventi un valore. D'altronde, la pubblicità
e i concorsi organizzati dai media non smettono di affermarlo, anche se per orientare verso i loro
scopi la modalità dell'individualismo della singolarità. […]… desiderio di essere visto dall'altro
nella propria particolarità, con una storia e delle caratteristiche proprie, di non essere «considerato
come un numero». Si identifica con la volontà di essere qualcuno». (Rosanvallon Pierre, 2011, La
società dell’uguaglianza, 224-229)
4.3.3.2. singolarità e alterità: «L'aspirazione alla singolarità può prendere forma solo nella relazione
con l'altro. Trovare il senso della propria esistenza nella diversità rispetto agli altri implica infatti il
vivere con loro. Per questo la nozione di singolarità non può essere confusa con quelle di autonomia
o di identità. L'autonomia è determinata da una variabile di posizione, statica nella sua essenza.
L'identità invece lo è da variabili di costituzione; necessariamente composita, è essenzialmente data,
anche se può evolvere nel tempo. La singolarità è definita da una variabile di relazione; non è uno
stato. In questo caso, la diversità è ciò che unisce e non ciò che divide. Essa suscita la curiosità, la
voglia della scoperta, il desiderio di comprendere l'altro. L'uguaglianza delle singolarità, lungi dal
fondarsi sul progetto di una identificazione con l'altro, implica al contrario che ogni individuo si
manifesti attraverso ciò che gli è proprio. Il fenomeno della diversità in questa accezione è il
campione dell'uguaglianza. Ciò significa che ciascuno può trovare la propria strada e diventare
padrone della propria storia, ognuno è parimenti unico.
Questa forma di uguaglianza definisce un tipo di società il cui modo di composizione non è né
quello dell'universalismo astratto né quello del comunitarismo identitario, ma quello di una
costruzione continua e di un riconoscimento dinamico delle particolarità. Quest'oscillazione ha
notevoli implicazioni. Indica che ormai gli individui vogliono fare società a partire da quello che
hanno di specifico in sé. La valorizzazione della singolarità dunque ha una dimensione
immediatamente sociale. Essa non indica una tendenza al distanziamento dell'individuo rispetto alla
società (nel senso di un individualismo del ripiegamento, che divide), ma fonda piuttosto
l'aspettativa di una reciprocità, di un mutuo riconoscimento. Questo porta alla soglia di un'epoca
pienamente democratica del sociale, e corrisponde alla constatazione che il sociale stesso non è più
definitivamente fondato in natura e che verte unicamente su una filosofia condivisa
dell'uguaglianza. E corrisponde anche al fatto che la democrazia come regime non è più slegata
21
dalla democrazia come forma di società». (Rosanvallon Pierre, 2011, La società dell’uguaglianza,
262-263)
4.3.3.3. Singolarità, alterità, riconoscimento. «Il rivelatore della discriminazione. Ogni singolarità
si afferma in relazione a quelle che la circondano. Vive e prende forma in una democrazia del
riconoscimento. Perciò quello che mina la sua costituzione è la mancanza di riconoscimento. La
discriminazione ne è una delle espressioni più evidenti. Essa si definisce come un trattamento
disuguale delle persone in base alla loro origine, alla loro religione o alle loro convinzioni, al loro
orientamento sessuale, al loro genere, o anche ai loro handicap. La causa del trattamento disuguale,
ciò che lo rende illegittimo, sta nell'identificazione negativa di una persona con uno dei suoi
caratteri. Il soggetto della discriminazione è l'individuo-categoria, la donna, la persona di colore,
l'omosessuale. In tal modo la discriminazione può essere definita come un rifiuto incrociato di
similarità (o di generalità) e di singolarità; mischia le due dimensioni. Questo gli conferisce una
centralità come forma di negazione dell'uguaglianza nel mondo contemporaneo. È innanzitutto una
patologia della singolarità che relega un individuo in una classe di singolarità giudicata spregiativa,
diminutiva. La persona, ad esempio, viene ridotta alla sua origine etnica o al suo sesso e tutte le sue
caratteristiche personali vengono cancellate o occultate. Non lo si riconosce nella sua personalità
autentica, nella sua vera e piena singolarità. Dunque non è considerato come qualcuno.
Parallelamente però gli viene rifiutata la qualità di individuo qualunque, poiché è socialmente
chiuso in una categoria. La persona discriminata in tal modo è doppiamente esclusa: dalla società
dei simili tanto quanto dalla società delle singolarità». (Rosanvallon Pierre, 2011, La società
dell’uguaglianza, 263)
4.3.3.3. come rideclinare l’uguaglianza in rapporto alla singolarità. «Dall’uguaglianza-distribuzione
all’uguaglianza relazione» (Rosanvallon Pierre, 2011, La società dell’uguaglianza, 244-257)
4.3.3.4. come pensare e costruire il “comune” la “comunalità” la dimensione comune (non
comunitaria) oggi: qui il progetto che ruota attorno alle tre parole: singolarità, reciprocità e
comunalità. In passaggi di sintesi: 1. la sociologia antropologica presenta l’uomo come un misto di
interesse, altruismo, reciprocità … e non sulla sola ipotesi che a determinare un comportamento sia
la scelta razionale. (Rosanvallon, 271ss); 2. in questa variata tipologia di relazioni trovano sede,
definizione e ruolo i beni comuni: all’interno di questa visione si colloca il tema della varietà dei
beni e in particolare la nozione di bene comune, la cui natura è illustrata attraverso una sua nuova
definizione / presentazione: «bene relazionale». «La nozione di bene relazionale è recente in
sociologia. Nata negli anni Ottanta del Novecento negli scritti di Martha Nussbaum e Carole
Uhlaner, è stata elaborata per designare dei beni che possono essere posseduti solo se condivisi non possono dunque essere consumati individualmente - e la cui produzione e consumo sono
simultanei. L'amicizia o l'amore sono di questa natura. Ma sono dei beni elettivi, non
universalizzabili: non si può essere amico o amante di tutti. In compenso il rispetto e il
riconoscimento lo sono, anche se necessariamente la loro espressione si declina in molti modi. Essi
sono dunque dei beni propriamente sociali, fondati sul principio di una relazione di reciprocità.
Questi ultimi beni vengono valorizzati in modo particolare in un mondo della singolarità. Infatti,
consentono a una moltitudine di esseri singolari di fare società pur restando pienamente se stessi. Di
più, fanno di un'attenzione alla singolarità il principio di un rapporto di uguaglianza. Dunque è
essenziale promuoverli e proteggerli». (Rosanvallon, 273); 3. è la nozione di reciprocità e di bene
relazionale ( utilizzando la categorie come coinvolgimento e riconoscimento) che permette
operativamente di definire (o di declinare e specificare) al suo interno i concetti di diritti e doveri e
la loro individuazione (come rinvenimento e come configurazione mirata alle singolarità
individuali). «Ci sono due modi per progettare la cittadinanza: come un insieme di diritti o come
una forma sociale. [a.] La dimensione giuridica è la più comune. […] la cittadinanza civile ha
continuato a imporre una crescente centralità, essendo basata sulla costituzione dell'individuo
attraverso i diritti umani. […] [b.] Ma la cittadinanza non si riduce a questo. È anche una forma
sociale. Il cittadino, in questo contesto, non è più solo l'individuo dotato di diritti personali, viene
definito anche attraverso la propria relazione con gli altri: per questo viene definito come
concittadino. Su questo punto è particolarmente illuminante l'etimologia della nozione di civis […]
22
Questa dimensione della cittadinanza come forma sociale si può denominare comunalità, per
distinguerla dall'altra dimensione giuridica che le è propria» (Rosanvallon, 279-386); contro la
tentazione dell'omogeneità e le forme in cui si manifesta, proclama e esalta. «La produzione del
comune [comunalità].
La nozione di comune, quando viene assimilata all'idea di un'identità, si riduce generalmente a un
catalogo di nostalgie e di cliché. […] bisogna rendere complessa questa nozione di comune,
declinarla nelle sue diverse dimensioni possibili. Possiamo ricordare le tre principali: la
partecipazione, l'intercomprensione e la circolazione. [a.] Il comune-partecipazione è il più
evidente. Si esprime con il fenomeno del vivere insieme degli eventi. [b.] A fianco di questo
comune festivo o dimostrativo, esiste anche un comune riflessivo. Deriva dalla sottomissione a uno
stesso flusso di informazioni, strutturato dal confronto obbligato con le urgenze del mondo o le
domande della società. È decisivo per fortificare la vitalità di una comunità. È organizzato
sull'implicazione e sulla curiosità dei cittadini, sulla qualità dell'universo mediatico così come su
quella della vita delle idee. In questo è attiguo al comune-intercomprensione, fondato sul fenomeno
della conoscenza reciproca. [c.] Il comune-circolazione si può definire come una divisione dello
spazio. Rientra nell'ordine di una civiltà la maggior parte delle volte silenziosa, ma al contempo
produttrice di conoscenza diffusa, di scambi furtivi, di un sentimento di vicinanza, e da qui anche di
un ethos egualitario. Lo si ritrova nei trasporti, sulle piazze e sui marciapiedi. È la rappresentazione
vivente di un popolo-flusso in costante rinnovamento, prodotto dalla città e dalla qualità
dell'urbanismo. Viceversa, è minato dai recinti, dall'esistenza di quartieri enclave e separati, dalle
intimidazioni sociali, dalle molteplici forme di indotta privatizzazione dello spazio. Il comunecircolazione è un bene pubblico fragile. Deperisce quando i servizi pubblici d'accesso sono lasciati
in abbandono. Questo significa che la politica della città è, per esso, centrale e che questa dovrebbe
dunque essere il motore essenziale di una politica di rivitalizzazione dello spirito di uguaglianza.
Queste diverse forme di produzione del comune contribuiscono di concerto all'arricchimento della
comunalità.» (Rosanvallon, 287-288).
23