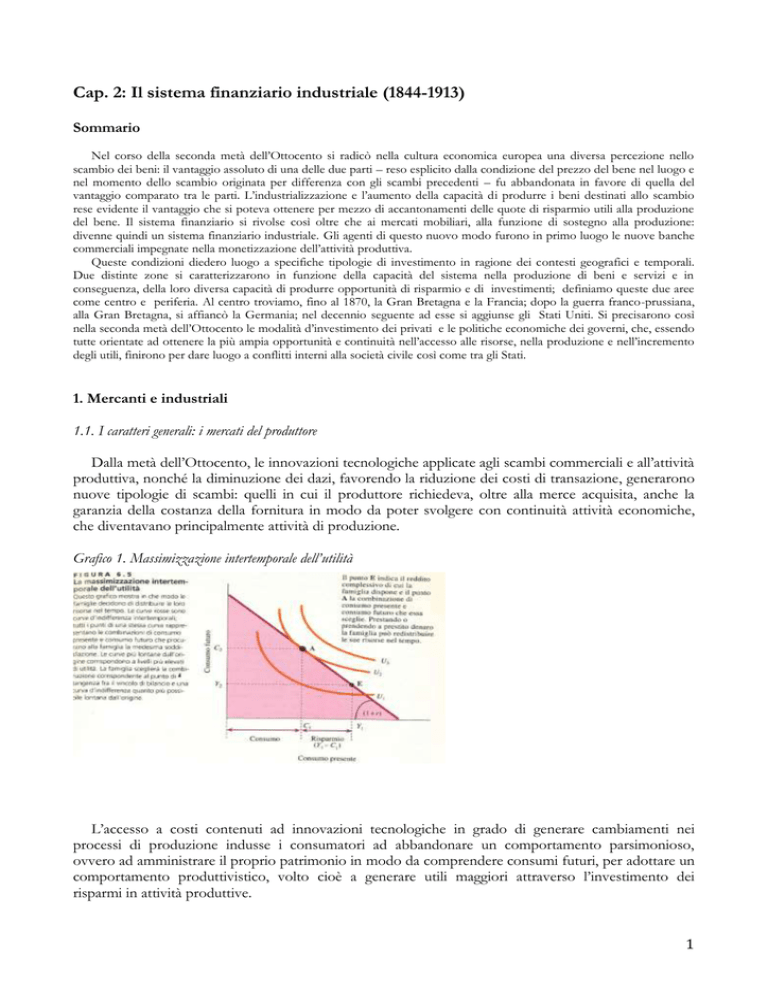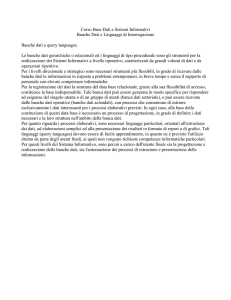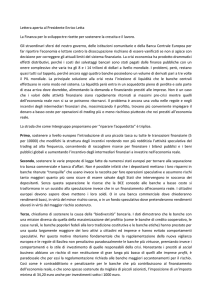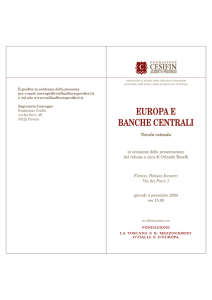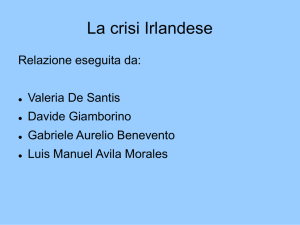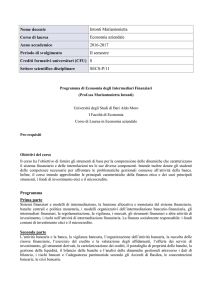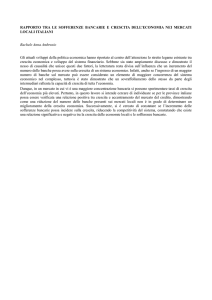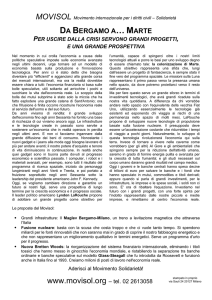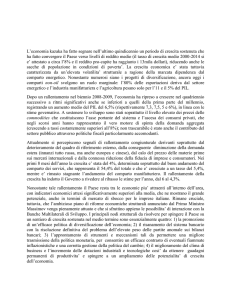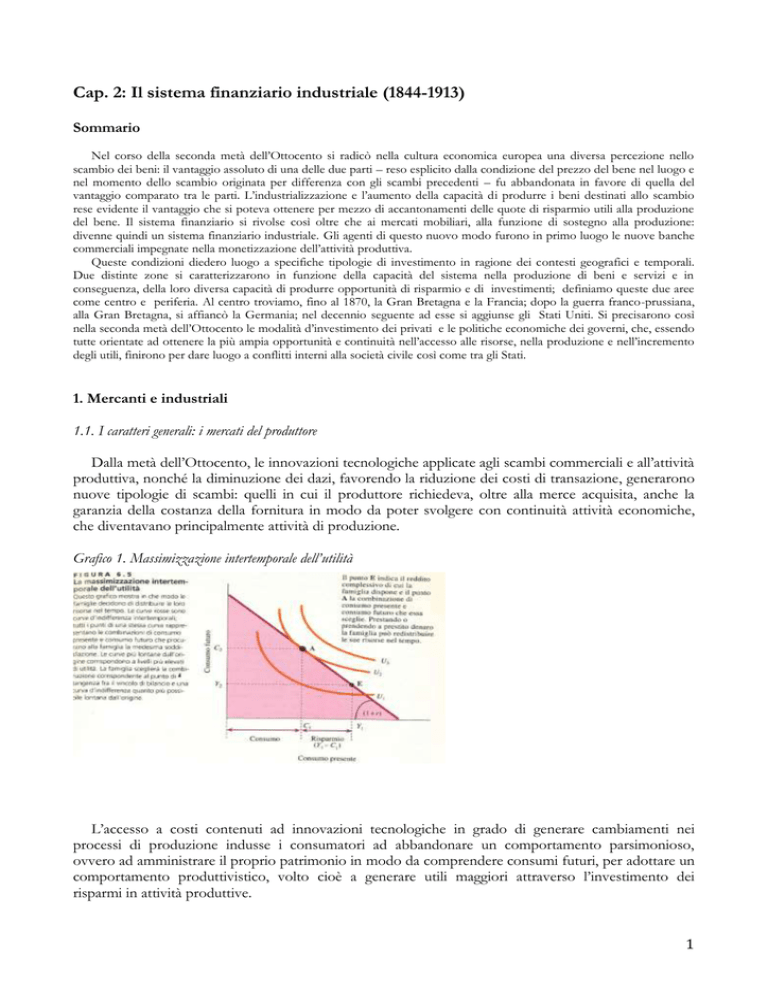
Cap. 2: Il sistema finanziario industriale (1844-1913)
Sommario
Nel corso della seconda metà dell’Ottocento si radicò nella cultura economica europea una diversa percezione nello
scambio dei beni: il vantaggio assoluto di una delle due parti – reso esplicito dalla condizione del prezzo del bene nel luogo e
nel momento dello scambio originata per differenza con gli scambi precedenti – fu abbandonata in favore di quella del
vantaggio comparato tra le parti. L’industrializzazione e l’aumento della capacità di produrre i beni destinati allo scambio
rese evidente il vantaggio che si poteva ottenere per mezzo di accantonamenti delle quote di risparmio utili alla produzione
del bene. Il sistema finanziario si rivolse così oltre che ai mercati mobiliari, alla funzione di sostegno alla produzione:
divenne quindi un sistema finanziario industriale. Gli agenti di questo nuovo modo furono in primo luogo le nuove banche
commerciali impegnate nella monetizzazione dell’attività produttiva.
Queste condizioni diedero luogo a specifiche tipologie di investimento in ragione dei contesti geografici e temporali.
Due distinte zone si caratterizzarono in funzione della capacità del sistema nella produzione di beni e servizi e in
conseguenza, della loro diversa capacità di produrre opportunità di risparmio e di investimenti; definiamo queste due aree
come centro e periferia. Al centro troviamo, fino al 1870, la Gran Bretagna e la Francia; dopo la guerra franco-prussiana,
alla Gran Bretagna, si affiancò la Germania; nel decennio seguente ad esse si aggiunse gli Stati Uniti. Si precisarono così
nella seconda metà dell’Ottocento le modalità d’investimento dei privati e le politiche economiche dei governi, che, essendo
tutte orientate ad ottenere la più ampia opportunità e continuità nell’accesso alle risorse, nella produzione e nell’incremento
degli utili, finirono per dare luogo a conflitti interni alla società civile così come tra gli Stati.
1. Mercanti e industriali
1.1. I caratteri generali: i mercati del produttore
Dalla metà dell’Ottocento, le innovazioni tecnologiche applicate agli scambi commerciali e all’attività
produttiva, nonché la diminuzione dei dazi, favorendo la riduzione dei costi di transazione, generarono
nuove tipologie di scambi: quelli in cui il produttore richiedeva, oltre alla merce acquisita, anche la
garanzia della costanza della fornitura in modo da poter svolgere con continuità attività economiche,
che diventavano principalmente attività di produzione.
Grafico 1. Massimizzazione intertemporale dell’utilità
L’accesso a costi contenuti ad innovazioni tecnologiche in grado di generare cambiamenti nei
processi di produzione indusse i consumatori ad abbandonare un comportamento parsimonioso,
ovvero ad amministrare il proprio patrimonio in modo da comprendere consumi futuri, per adottare un
comportamento produttivistico, volto cioè a generare utili maggiori attraverso l’investimento dei
risparmi in attività produttive.
1
Grafico 2. Curva di offerta di risparmio
Grafico 3. Risparmio e investimento in economia aperta
Osservati dall’esterno, i mercati preindustriali e industriali appaiono quindi diversi da quelli
precedenti per tre elementi fondamentali: in primo luogo, gli agenti dello scambio che prima erano
principalmente dei mercanti divennero dei produttori di beni; in secondo luogo, gli oggetti dello
scambio furono rivolti non più a garantire un tenore di vita, bensì ad incontrare il numero maggiore
possibile delle preferenze dei consumatori; in terzo luogo, le modalità dello scambio passarono da
essere caratterizzate da un tempo spezzato, caratteristico dell’epoca preindustriale ed esemplificato dalle
fiere che, con cadenza annuale, erano principalmente rivolte al ripristino delle scorte consumate, a
quello continuo della fornitura industriale, rivolto a generare beni da poter vendere continuamente a
nuovi e crescenti consumatori.
2
Queste condizioni portarono a far si che i beni prodotti non valessero più per il loro valore
intrinseco, ma venissero prezzati per il valore che qualcuno era in grado di ricavare da essi. Nella teoria
economica questo processo di cambiamento è semplificato nell’evoluzione delle categorie dello
scambio commerciale, che passano dalla forma di vantaggio relativo a quella di costo opportunità.
In questo modo, la modalità di scambio del sistema industriale, modificando i prezzi relativi di tutte
le merci, generava una sequenza di transazioni fondate sul costo opportunità degli agenti di possedere,
in ogni specifico momento, quelle merci che avrebbero potuto consentire un incremento di valore
indipendentemente dal fatto che esse fossero disponibili sul mercato domestico o acquistabili sui
mercati internazionali. Il tasso di cambio reale tra due mercati, quindi, determinava la domanda
aggregata di produzione dei beni in un paese, sia nel breve che nel lungo periodo.
In questi mercati del consumatore, il mezzo di pagamento utilizzato negli scambi non poteva più
essere solamente definito sul mercato monetario, ma andava definito anche sul mercato delle attività,
cioè sui titoli di risparmio e di investimento. La differenza tra il valore nominale e il valore reale della
moneta e dei titoli non poteva, quindi, più essere rappresentata unicamente da un prezzo nel tempo
presente, ma doveva anche essere rappresentata da un prezzo nel tempo futuro. Tale prezzo non
poteva che essere pari alla media dei suoi rendimenti, ovvero del tasso di interesse applicato nel
mercato di riferimento.
La differenza fra i due periodi è evidente considerando come le variazioni nel valore del mercato
monetario presenti nel sistema finanziario mercantile potevano unicamente dare luogo a fenomeni di
deflazione o di alterazione del valore della moneta stessa, ma non di una sua svalutazione in quanto la
sua natura di merce ne costituiva un limite naturale: essa non poteva valere, a fronte di scorte attive, né
più, né meno, del metallo in essa coniato. Come tale la moneta-merce, coniata dallo Stato, veniva
quotata in borsa così come qualunque altro bene reale e finanziario: questa pratica consentiva di
mantenere il suo valore reale identico alla quantità di metallo contenuto.
Nei nuovi mercati del consumatore e nel sistema finanziario industriale, questa tipologia di moneta
non era più in grado di misurare il valore generato dalle attese della produzione a tempo continuo. C’era
la necessità, quindi, di uno strumento più flessibile per la misura del valore dei beni, capace di esprimere
in ogni momento l’aspettativa che il consumatore attribuiva al bene scambiato, ovvero il suo prezzo, il
quale diventava così pari alla moda delle preferenze. Si trattava, dunque, di una moneta generata dal
mercato, in grado di rappresentare il reciproco dei prezzi.
Grafico 4. Derivazione della curva AA
3
Questo fece si che, nella seconda metà dell’Ottocento, l’offerta di moneta venisse gestita da enti
capaci sia di dare tutela assicurativa alla stabilità tra valore nominale e valore reale, sia di acquisire ed
elaborare le informazioni utili a stimare il merito di credito nell’impiego del risparmio disponibile per
finanziare la spesa pubblica, il credito agli impianti e le spese di esercizio delle imprese, e i consumi
delle famiglie.
La letteratura istituzionalista ha sottolineato come affinché un processo di cambiamento economico
possa consolidarsi nel tempo, non basta che esso sia più funzionale del precedente. Esso deve essere
anche sostenuto da una parte della popolazione in grado di attuare sanzioni verso coloro che svolgono
azioni di free riding: solo in questo modo le nuove pratiche potranno entrare nella vita civile ed
economica come norme. Queste considerazioni rendono evidente come l’opportunità nuova di
produrre e investire poteva divenire regola solo dopo che la prassi mercantile fosse stata abbandonata.
L’attenzione politica dell’epoca si concentrò, quindi, proprio sul ceto mercantile, sia perché esso
aveva la maggiore possibilità di ottenere risparmi in forma finanziaria, sia perché risultava essenziale,
per la stabilità dell’intero sistema, convincere i mercanti a investire il proprio capitale in modo nuovo.
Risulta fondamentale, quindi, comprendere cosa abbia consentito al ceto mercantile di abbandonare
la propria condizione di rendita, basata sulla rete di scambi in essere, per rivolgersi a finanziare e avviare
attività manifatturiere, i cui profitti non potevano essere, almeno in un primo momento, altrettanto
sicuri.
Di norma, il costo di produrre un nuovo strumento di pagamento è tanto più basso quanto più alta
sarà la sua capacità di soddisfare una rete tanto più estesa di agenti economici. La divisione del lavoro
nelle comunità ha riservato alle banche questa funzione: gli agenti che, nel periodo che va dalla metà
dell’Ottocento alla Prima guerra mondiale, assunsero quel ruolo furono definiti nel lessico coevo, in
modo trasparente, mercanti-banchieri.
Il cambiamento fu consentito, in questo periodo, dalle nuove procedure nell’accumulazione di
capitale e dalle regole dei pagamenti, ovvero dall’uso di contratti che prevedevano il pagamento in
moneta bancaria. L’efficacia di tali contratti fu, infatti, la condizione che portò a impedire
l’espropriazione della utilità presente a seguito di scelte rivolte ad utilità futura. Essa si ottenne con tre
modalità: la riduzione delle quasi-rendite espropriabili; la richiesta di un pegno a garanzia del contratto;
l’integrazione verticale di tutte le parti in un'unica struttura di governo.
Il rischio di esproprio degli investimenti fu contrastato, in ogni paese, mediante la diffusione delle
forme societarie attraverso le quali furono organizzate le attività imprenditoriali. Tra di esse risultarono
importanti sia quelle accomandita semplice, maggiormente diffuse in Francia, sia quelle di società
anonime per azioni a responsabilità limitata, che nacquero e si svilupparono, a partire dall’Inghilterra,
negli Stati in cui vi fu un maggiore livello di diffusione della moneta bancaria e del credito.
È comunque verosimile che la parte della “vecchia” comunità mercantile che non era disposta ad
assumersi rischi di produzione – la comunità che dava, cioè, maggiore utilità marginale al risparmio
presente rispetto al valore che sarebbe stato possibile ricavare in futuro a seguito dell’investimento –
non era incline a far parte del “nuovo” sistema, quello industriale. In tal modo i mercanti finivano per
frenare la diffusione del nuovo sistema, alzando i costi e i rischi per chi, invece, era più naturalmente
incline ad assumersi rischi di produzione. Tuttavia, anche gli agenti economici avversi al rischio sono
sempre disposti a pagare un premio assicurativo ritenuto equo al fine di annullare l’incertezza del
fallimento e, quindi, poter procedere con l’investimento. Questa consapevolezza rese possibile definire
forme di contratto assicurativo che, essendo accettate da un ampio numero di operatori, ridussero i
costi medi dell’incertezza del sistema.
4
Grafico 5. Equilibrio nel mercato interno e Esportazioni (XX)
Grafico 6. Variazioni dei vincoli di portafoglio e delle preferenze
E’ il processo di cambiamento nelle preferenze attivato da cambiamenti nel reddito e/o nelle
aspettative di reddito degli agenti che determina in ultimo la diversa inclinazione della curva XX e fa si
che la composizione della produzione destinata alla esportazione sia in un primo momento meno
inclinata della DD poiché mano a mano che Y aumenta la domanda dei beni domestici aumenta meno
della produzione stessa in quanto parte è risparmiata e parte è rivolta ai beni esteri. Posto però che la
domanda aggregata debba essere uguale all’offerta, e che le partite correnti coincidenti con il punto di
equilibrio debbano restare tali, cioè CA = X, per prevenire un eccesso di offerta dei beni domestici E
deve aumentare in misura sufficientemente rapida lungo la DD da far si che la domanda di
esportazioni cresca più rapidamente di quella di importazioni.
Ne segue che ogni cambiamenti di politica fiscale o di politica monetaria attuato dal potere centrale
debba essere necessariamente coordinato con variazioni delle partite correnti del cambio e della
produzione. Fu la consapevolezza di questa condizione che portò alla definizione dell’Atto di Peel, poi
replicato in modo più o meno simile in tutte le economie industriali, con cui il potere sovrano
imponeva per norma la condizione di equilibrio tra le esigenze dello Stato e quelle del Commercio. In
5
termini moderni, quindi, lo Stato cercava il consenso sociale favorendo sia la tutela del valore della
“vecchia” utilità, quella del sistema mercantile che preferiva i saldi positivi sul valore patrimoniale, cioè
sulle rendite, realizzato mediante il controllo della rete degli scambi; sia quella degli industriali, dei
capitalisti, orientati ad una “nuova” utilità, che preferiva ottenere saldi positivi per mezzo del controllo
sul valore aggiunto nel processo di produzione.
In tutta la seconda metà dell’Ottocento il finanziamento fiduciario degli investimenti industriali,
quindi, si fondò in primo luogo su una cultura del capitale di rischio ma, in secondo luogo, anche sulla
possibilità di ridurre il costo delle transazioni in moneta grazie alla circolazione fiduciaria di una quota
di biglietti. Riducendo, in tal modo, i costi di rischio di investimento, e creando contestualmente un
mercato del consumatore, fu possibile incentivare all’impiego produttivo dei capitali anche quella parte
dei risparmiatori che richiedevano di avere un’assicurazione sulle loro scelte. La pratica di offerta di
moneta e credito si incrociò in modo diretto anche con la richiesta di un pegno, a cui si fece riferimento
sia nel momento in cui si richiedeva la convertibilità dei biglietti, sia nel momento in cui si richiedeva
che vi fosse, in ogni conio, una specifica quota di metallo fine così da poter utilizzare quella moneta
come merce nel mercato internazionale.
È noto che per tutto l’Ottocento il mercato internazionale fu organizzato in un regime di gold
standard e di libera circolazione dei capitali. Tuttavia, ciò non significa che non vi fossero, da un lato,
modalità operative diverse, ovvero delle barriere non tariffarie tra mercati nazionali, che furono di fatto
superate solo negli anni Ottanta del secolo; né, dall’altro, che la pratica con cui si era definita la
circolazione dei mezzi di pagamento e dei capitali nel sistema finanziario mercantile fosse adeguata a
consentire la continuità dei mercati dell’età industriale.
Affinché questo fosse possibile, un mercato interno doveva possedere due condizioni fondamentali:
la prima era disporre di una quota congrua di mezzi di pagamento, tale da non portare a tensioni
deflattive; la seconda era possedere un centro di raccordo tra la circolazione delle attività finanziare
domestiche e quelle internazionali in grado di assicurare non solo la parità di cambio, ma anche le
aspettative di rendimento legate al rischio di risparmio e di credito attuate in quella valuta nei confronti
di quelle attuate nella valuta dei mercati in cui si scambiavano, con continuità, merci non perfettamente
sostituibili.
In terzo luogo, si può ritenere che, al fine di garantire la diffusione di nuovi comportamenti
economici da parte del vecchio ceto mercantile, le banche di emissione, a partire da quelle delle
economie del centro del sistema, ovvero le economie inglese e francese, vennero indotte a unirsi,
attraverso atti normativi e non con azioni di mercato, ad altri istituti finanziari, al fine di poter fare in
modo che le tensioni che si realizzavano nel breve periodo sarebbero poi state risolte nel lungo periodo.
Grazie alla combinazione dei tre fattori appena descritti la fiducia nel sistema aumentò: di riflesso si
ridussero i rischi e molti operatori accettarono così il rischio di investire i propri risparmi. L’utilità che
ne derivava era il frutto di un mercato organizzato non più secondo la logica dei vantaggi comparati
della cultura mercantile, ma con quella dei costi-opportunità della cultura industriale.
Il perno di tali modalità è individuabile nella legge che definì la moneta bancaria utilizzata di fatto nei
pagamenti e, di riflesso, l’attività operativa degli intermediari finanziari. Il Bank Charter Act del 1844,
varato dal governo del Primo ministro Robert Peel, si pose due obiettivi. Il primo fu quello di
contrastare l’inflazione, dando un valore certo alla moneta e permettendo al ceto mercantile di avere la
certezza che un comportamento opportunistico di abbattimento del valore della moneta sarebbe stato
punito dall’autorità. Il secondo, invece, fu quello di garantire la comunità industriale dal pericolo di
deflazione: la carenza di moneta, infatti, avrebbe impedito ai consumatori l’accesso ai beni, dando luogo
a una crisi economica. La legge di Peel regolava però la moneta attraverso l’introduzione di un limite
certo, ovvero una rigida quota frazionaria riservata alla circolazione mercantile. La possibilità di esubero
6
da tale quota era prevista, ma con la condizione che essa fosse attuata con un rapporto tra biglietti e
riserve auree di 1:1.
I rischi di deflazione e inflazione, quindi, che si concretizzeranno in rapidissima sequenza nella crisi
del 1847-1848, vennero necessariamente risolti attraverso un atto politico con cui il Ministro del Tesoro
assunse su di sé la tutela del valore della moneta. Attraverso una lettera, il governo inglese affermava
che se il limite coperto dalle riserve auree avesse superato la proporzione delle riserve stesse, la Banca
avrebbe automaticamente potuto avvalersi del privilegio d’inconvertibilità senza incorrere nelle sanzioni
penali previste dalla legge del 1844. Quello che è importante sottolineare è che, in quel contesto, bastò
l’annuncio di tale condizione per interrompere la corsa agli sportelli e consentire il normale
funzionamento dei mercati che, da quel momento, possiamo logicamente immaginare organizzati in
modo industriale: la disponibilità del mezzo di pagamento, necessario ad attivare l’azione del consumo,
diventava più importante della stabilità del suo stesso valore.
La rigidità con cui la norma definiva il valore stabile delle rendite, ovvero definiva la loro misura, ha
indotto, in seguito, a ritenere non efficace la norma stessa, ma non per questo a dettarne la fine: l’atto di
Peel, così come il sistema che inaugurava, rimase infatti in vita fino alla Grande Guerra.
All’interno di questa cornice normativa si attuarono tre diverse tipologie di intermediazione
finanziaria, che conobbero diverse modalità di funzionamento a seconda dell’area geografica di
appartenenza. La prima è quella dei crediti mobiliari, simile alla finanza privata propria del periodo
mercantile e per questo spesso indicata come vecchia banca, attiva fino agli anni Sessanta e Settanta
dell’Ottocento. La seconda è, invece, quella della nuova banca commerciale, organizzata in società per
azioni e vicina al mondo della produzione e del consumo. La terza, infine, è quella costituita dalle
banche di deposito, dalle casse di risparmio e dalle casse popolari, le quali, rivolte alla tutela dei risparmi
e all’educazione e alla promozione di un’idea di risparmio finanziario diversa da quella della
tesaurizzazione, svolsero un ruolo fondamentale per la coesione dell’intero sistema. Esse, infatti,
contribuirono alla formazione di quote di risparmio a basso rischio utilissime a comporre la quota di
capitale necessaria a stabilizzare i corsi dei titoli finanziari che gli intermediari finanziari emettevano
spesso più sulla base di aspettative di realizzazione che su un risparmio precedentemente accumulato.
1.2 Le modalità di funzionamento
In correlazione con il mutamento dei comportamenti degli agenti economici nei mercati
preindustriale e industriale, che da mercanti operanti in un tempo spezzato divennero industriali che
lavoravano in un tempo continuo, cambiarono anche le forme, i modi e gli obiettivi
dell’intermediazione finanziaria.
La componente finanziaria nei sistemi industriali si specificò nella funzione di garantire,
principalmente, la continuità della produzione. Questa comportò due modalità specifiche: in primo
luogo era necessario avviare, ed in seguito mantenere in attività, il sistema di produzione ad un livello
ottimale; in secondo luogo, era necessario garantire che la sua attività generasse in modo continuativo i
beni a cui era rivolta.
Le strutture finanziarie del sistema industriale furono fondamentali nel realizzare, da una parte, la
concentrazione del capitale, che per questo assunse natura di rischio e, dall’altra, nel raccogliere il
capitale necessario per l’esercizio della produzione. Il livello del rischio insito nella concentrazione fu
reso accettabile alle collettività attraverso l’introduzione del titolo azionario, che permetteva di
frazionare il rischio tra più investitori. Inoltre, l’esigenza e l’opportunità di produrre quel numero di
beni che consentiva i costi medi più bassi, quindi quello che dava gli utili maggiori all’impresa, portò
l’impresa stessa ad generare i titoli obbligazionari con cui finanziare la sua attività corrente. Possiamo
7
quindi definire i primi come investimenti, che prendevano la forma di titoli azionari, mentre i secondi
come prestiti, che assumevano invece la forma di titoli obbligazionari.
Il sistema finanziario industriale si fonda, quindi, sul concetto di risparmio e sul suo utilizzo
produttivo, che inevitabilmente genera incertezza. Questa incertezza, attraverso la sua monetizzazione,
diventa rischio. In questo modo il livello di rischio viene quantificato in un prezzo e organizzato in una
regola di comportamento economico. Tale comportamento economico era una manifestazione della
cultura di una determinata comunità. Conseguentemente, ogni società che partecipava allo scambio
economico nei decenni in cui si andava formando il sistema finanziario industriale, contribuì in maniera
specifica e originale alla definizione della sue regole di comportamento, le quali mantenevano
comunque come fondamento l’azione del risparmio e del suo investimento: azione che richiedeva un
comportamento di fiducia verso sé stessi o verso gli altri.
Per assumere la forza e l’efficacia di regola, un comportamento economico deve per forza di cose
essere quello maggiormente diffuso. Ciò comporta necessariamente il coinvolgimento di agenti
economici già in attività, rappresentati in questo periodo storico dai mercanti, i quali diventano
mercanti-banchieri disposti anche a finanziare l’attività industriale.
Tale disponibilità al finanziamento si incrocia con la preferenza al rischio specifica di ogni società ed
è coerente con l’attività economica più diffusa in quella società, nonché con gli obiettivi politici che si
vogliono raggiungere. È importante sottolineare che nell’Ottocento la dimensione economica delle
società rese possibile l’utilizzo dei vantaggi economici per raggiungere, di volta in volta, obiettivi di
natura politica e/o civile.
Il consolidamento della regola nazionale di comportamenti economici e finanziari, lo scambio
internazionale dei beni e la consapevolezza del vantaggio nella divisione del lavoro, favorì
l’organizzazione di diverse tipologie di intermediari finanziari, che si strutturarono in maniera simile
all’interno delle diverse comunità nazionali.
Si è detto che l’origine del sistema finanziario industriale ha il suo fondamento sui costi-opportunità,
che portano logicamente a pensare il sistema in una dimensione internazionale, organizzato secondo un
comportamento liberale. Tuttavia, questo non è ciò che è storicamente accaduto. La ragione di ciò è da
ricercare nel fatto che la componente di incertezza e di conseguente di rischio è insopprimibile
nell’azione di risparmio e investimento, la quale, quindi, può avvenire solo all’interno di specifici
contesti culturali e di produzione normativa. Questo fa si che i sistemi finanziari industriale, che si
qualificano come capitalistici, abbiano assunto forme nazionali specifiche in ragione dell’avvicinarsi
della cultura politica ed economica nazionale con le necessità del mercato internazionale. Tale relazione
prende forma nei rapporti tra mercati domestici e mercato internazionale.
La dimensione economica del costo opportunità del capitale non deve portarci a ritenere che il
sistema si regoli in funzione dei limiti delle risorse. Un’osservazione più attenta mostra che il sistema
non può escludere, insieme al conflitto sulle risorse, anche il conflitto sulla posizione per ottenere
quelle risorse. Questo duplice conflitto determina un valore posizionale del bene scambiato, che genera
un costo/prezzo di produzione e di vendita, i quali, però, non sono necessariamente coincidenti. Si
determina, infatti, un evidente vantaggio nel produrre a un costo minimo e vendere a un costo medio.
Le due realtà sociali in questa condizione sono qui definite come centro del sistema, quella che ha il
costo minimo, e periferia del sistema, quella che ha costo medio.
I mercati domestici saranno qui indicati, dunque, per la loro natura nazionale, ma vanno pensati
come realtà produttive e finanziarie. Questa dimensione posizionale ha una sua natura nello spazio e nel
tempo.
8
Nello spazio, essa diventa centro e periferia, in cui il centro era quella realtà capace di darsi delle
regole che consentiva di produrre al costo minimo e vendere al costo medio, laddove i costi di
produzione erano costituiti dal valore relativo con cui i fattori produttivi partecipavano al processo
produttivo. Questa consapevolezza rende manifesto come, nel corso del tempo, il contributo ottimale
di ogni singolo fattore si sarebbe potuto esprimere solo secondo una funzione logistica. La scelta di
ottimizzare la relazione tra queste funzioni per ottenere il costo minimo porta a essere consapevoli della
possibilità di scomporre il tempo, che si è detto essere in origine continuo, in due componenti: quella
breve e quella lunga, dove si intende per lungo periodo quello in cui si ottiene il cambiamento di
almeno uno dei fattori della produzione.
Dalla seconda metà dell’Ottocento, il contesto economico-giuridico cui ciò venne ricondotto fu di
due tipi. Il primo fu l’ordinamento liberale, a cui si associò una struttura del credito di tipo piramidale,
che ebbe come sua principale fonte normativa il Parlamento e previde la responsabilità diretta delle
aziende di credito e la loro piena libertà nelle procedure di gestione e contabilizzazione delle operazioni.
Il secondo tipo fu l’ordinamento prescrittivo, a cui si associò una struttura finanziaria di tipo radiale,
che assunse come principale fonte normativa il governo e previde che le modalità di esercizio delle
aziende di credito fossero definite con atti amministrativi e verificate con procedure di controllo da
parte di magistrature pubbliche.
Nell’ordinamento che abbiamo definito come liberale a forma piramidale, il cui caso più
esemplificativo è quello inglese, le relazioni tra gli istituti di credito si costruivano in ragione del capitale
versato, dell’area di esercizio e del fatturato. Le ditte bancarie interessate all’azione di emissione di
moneta cartacea risultavano essere in questo modo legate tra loro in modo che le cambiali, o più
generalmente le obbligazioni, accettate come pegno dell’emissione di biglietti venivano scontate ad un
tasso progressivamente più alto via via che ci si allontanava dalla base della piramide, i mercati di
scambio, fino al vertice costituito dalla Banca d’Inghilterra.
Quest’ultima era l’unica società privata a godere del privilegio di essere costituita in forma di società
per azioni, condizione che le consentiva di disporre di congrue quote di riserva. Secondo questo
sistema, i flussi furono indirizzati dalle aziende minori verso quelle maggiori, attuando un’implicita
procedura di tipo assicurativo: l’azienda maggiore, più capitalizzata, assumendo titoli dalla minore, ne
garantiva la liquidità e faceva sì che restassero sul mercato i titoli più solvibili. Ma così il sistema
generava per estensione, mezzi di credito e di pagamento – banconote convertibili – più costosi del
minimo possibile – per cui era soggetto sia ad azioni di free riding, sia alla sperimentazione di
innovazioni.
Nell’ordinamento che abbiamo definito come prescrittivo a forma radiale, ad esempio quello
strutturato in Francia, la fonte normativa principale fu il governo, che definì le modalità di esercizio
delle aziende di credito attraverso atti normativi e verifiche di controllo operate da magistrature
pubbliche.
Questo sistema accomunò sia agenti di cultura liberale, che vedevano nella piena responsabilità di
mercato la principale via di modernizzazione del sistema economico nazionale, sia operatori più
pragmatici, che ritenevano la scelta inflattiva inevitabile in quanto l’unica in grado di ricomprendere, nel
tempo medio, l’eterogeneità degli usi e dei soggetti economici confluiti, conservando le loro condizioni
di partenza, in una nuova e maggiore comunità nazionale.
2. La moneta legale e convertibile (1844-1870)
Nel corso della seconda metà dell’Ottocento si realizzò, come visto nel paragrafo precedente, il
passaggio da un sistema finanziario mercantile ad un sistema finanziario di tipo industriale. Tale
9
passaggio risulta essere sfumato e graduale, con uno sviluppo cronologico e di intensità che varia a
seconda del paese preso in esame. La pietra angolare che permette di registrare e riportare il movimento
tra i due sistemi è la tipologia di intermediario finanziario che si sviluppa e diviene predominante,
nonché la trasformazione dei mezzi di pagamenti privilegiati per gli scambi commerciali e per il credito
industriale.
In questo senso, è possibile riscontrare una netta discontinuità con l’età precedente in quanto, fin
dagli anni Venti dell’Ottocento ma con maggior intensità durante la seconda metà del secolo, si assiste
alla nascita di banche costituite in società per azioni, che rappresentano la vera novità dei sistemi
bancari e finanziari mondiali tardo-ottocenteschi. Durante questo periodo, numerosi paesi
cominciarono a porsi sul percorso di industrializzazione precedentemente tracciato dalla Gran
Bretagna. La crescita economica che si realizzò su questa spinta, portò ad un precedentemente
sconosciuto sviluppo della produttività industriale e ad aumento dei volumi, dei valori e dell’estensione
geografica delle transazioni commerciali. Tale processo economico, per potersi esprimere con le
potenzialità che divennero uno dei tratti distintivi della seconda metà dell’Ottocento, doveva essere
accompagnato e sostenuto da un aumento della disponibilità dei mezzi monetari e creditizi, e da una
più generale espansione del credito.
Le modalità attraverso le quali tali mezzi furono forniti rappresentano l’innovazione monetaria
dell’Ottocento che ha portato, con tempi e modi diversi a seconda dei paesi in questione, ad una più
diffusa concentrazione dei capitali, ad un maggiore drenaggio del risparmio verso l’investimento e, in
generale, ad uno sviluppo senza precedenti del credito industriale attraverso la nascita e l’espansione del
sistema finanziario di tipo industriale. Particolarmente importanti per comprendere i percorsi della
crescita industriale ottocentesca, appaiono i legami che si instaurano tra le diverse imprese industriali, i
sistemi monetari e l’intermediazione finanziaria.
Tuttavia, anche se un determinato livello di sviluppo economico necessita di un certo tipo di
interazioni tra banche e industrie, lo sviluppo di questi rapporti non si ripete mai esattamente nelle
stesse forme all’interno dei vari paesi. La natura, le caratteristiche e le funzioni dei sistemi bancari dei
diversi paesi europei seguirono percorsi eterogenei e originali, plasmandosi sui diversi contesti
istituzionali all’interno dei quali si svilupparono; risentendo, quindi, delle specifiche condizioni storiche,
geografiche e politiche delle varie nazioni. Un paese sulla via dell’industrializzazione, infatti, ha
certamente bisogno di intermediari finanziari, i quali tuttavia acquisiranno caratteristiche adatte alla
diversa maturità e tipologia dell’economia di un dato paese, seguendone ritmi e percorsi. Alcune
caratteristiche sembrano in ogni caso comuni a tutti i sistemi bancari che nel corso della seconda metà
dell’Ottocento costruiscono sistemi finanziari di tipo industriale. In primo luogo, in tutti i paesi il
governo centrale svolge un’azione essenziale nell’indirizzare lo sviluppo del sistema bancario, avendo il
potere legislativo necessario a garantire la qualità e la validità dell’unità monetaria.
Connesso a questo elemento si assiste, sull’onda del Bank Charter Act emanato nel 1844 dal governo
inglese del Primo ministro Robert Peel, alla nascita di una banca di emissione forte, più o meno
strettamente legata al governo e più o meno in posizione di monopolio nell’attività di emissione di
moneta. Nel caso inglese, ad esempio, venne fissato un limite nel rapporto tra banconote e oro oltre il
quale non era possibile andare. Tale limite era in realtà superabile, come mostra già il caso della crisi di
liquidità del 1847 e delle lettere del Tesoro, con le quali il governo sollevava la Banca d’Inghilterra da
ogni conseguente responsabilità giudiziaria. In ogni caso, il principio che era alla base del Bank Charter
Act inglese venne tradotto e adottato nel corso della seconda metà dell’Ottocento dalle legislazioni
bancarie di numerosi altri paesi: esso apparve, infatti, in Francia nel 1848; negli Stati Uniti nel 1860; in
Italia nel 1874; in Germania nel 1875 e in Svezia nel 1897.
Un’ulteriore importante convergenza trans-nazionale si realizzò grazie alla nascita di una nuova
tipologia di intermediario finanziario, destinato a rimpiazzare gradualmente le grandi banche private del
10
passato: le banche costituite in società per azioni a responsabilità limitata. Eliminata, tra il 1858 e il
1868 in Gran Bretagna, Francia e Prussia, la richiesta d’approvazione preventiva da parte delle autorità
per la costituzione di società di capitali a responsabilità limitata, esse cominciarono a imporsi
soprattutto per via del vantaggio che avevano sulle banche private nella possibilità di raccogliere un
capitale nettamente maggiore, potendo contare sui risparmi di un più alto numero di azionisti.
Se importanti furono i fattori comuni tra i diversi paesi, non è comunque possibile fare a meno di
riscontrare anche delle difformità rilevanti. È, infatti, possibile rilevare nel panorama dei sistemi
finanziari della seconda metà dell’Ottocento l’esistenza di due grandi insiemi, mutevoli nel tempo ma
continuativamente comunicanti tra loro: questi due insiemi costituirono il centro e la periferia del
sistema finanziario industriale. Il centro del sistema è caratterizzato dall’esistenza di una struttura
economica dotata di una maggiore capacità finanziaria e di un assetto istituzionale coerente con questa
capacità. La capacità finanziaria è rappresentata dalla disponibilità di un agente di aumentare la propria
spesa senza ridurre i consumi. Si può prendere come esempio di tale comportamento la capacità di
esportare capitali, così come la capacità di mantenere stabile il proprio sistema monetario.
Questo permette agli intermediari finanziari di avere un quadro economico e istituzionale fisso
all’interno del quale poter operare le proprie scelte, che saranno diverse a seconda della tipologia
industriale, economica, sociale, culturale e politica del paese in questione. Conseguentemente, gli
intermediari finanziari si strutturarono in relazione, da un lato, alla capacità di esportare capitali e,
dall’altro, alla stabilità monetaria dell’intero sistema finanziario.
La periferia del sistema è costituita da quei paesi che hanno una bilancia dei pagamenti non
stabilmente in pareggio. Ciò avviene a seguito dei flussi di capitale in ingresso e della non continua
capacità di acquisire saldi positivi sulle bilance commerciali. Le due condizioni determinano una
tensione sulle riserve tale che la stabilità del cambio non poteva essere garantita. L’oscillazione del
cambio determinava così spazi speculativi, che dando luogo a rapidi guadagni o perdite, logorarono la
capacità esecutiva dell’assetto istituzionale. Quindi, gli intermediari finanziari dei paesi della periferia si
strutturarono, da un lato, in relazione alla loro capacità di catturare flussi di capitale in entrata e
individuare i settori produttivi in cui è possibile una continuità di profitto; dall’altro, in rapporto alla
debolezza complessiva dell’assetto istituzionale.
Le condizioni indicate, e i due insieme di paesi che ne scaturiscono, si articolano in due scansioni
cronologiche. La prima, che va dagli anni Quaranta agli anni Settanta, comprende un centro composto
da Gran Bretagna e Francia; e una periferia, composta dall’Europa meridionale, gli Stati Uniti, Russia e
Africa settentrionale. La seconda, invece, che va dagli anni Settanta fino alla Prima guerra mondiale,
comprende un centro, costituito da Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti; e una periferia, dove si
collocano Francia, Russia, Europa meridionale, Asia e Africa settentrionale. In queste due fasi i processi
di cambiamento nella composizione delle attività finanziarie attraversano quattro momenti, non
necessariamente in successione tra loro: in primo luogo quello della monetizzazione, ovvero l’aumento
dei mezzi di pagamento disponibili; in secondo luogo, quello della differenza tra le varie forme dei
mezzi di pagamento; in terzo luogo, quello della determinazione del livello del loro prezzo, cioè il loro
valore nominale; infine, il momento del rapporto tra il loro valore nominale e il loro valore reale nel
tempo e nello spazio.
2.1 – Il centro: Gran Bretagna e Francia
La Gran Bretagna
I fallimenti bancari rimasero un elemento costante nella storia finanziaria ottocentesca, inglese come
europea, e l’intervento governativo mirava in particolar modo a prevenire, attraverso apposite riforme
11
monetarie, il fenomeno che i contemporanei definivano sovraemissione. Dopo aver sperimentato, per
un breve periodo nel corso degli anni Trenta, la cosiddetta regola di Palmer, che prendeva il suo nome
da John Horsley Palmer, governatore della Banca d’Inghilterra tra il 1830 e il 1833, il governo Peel
emanò il Bank Charter Act nel 1844, che costituisce un vero e proprio pilastro nella legislazione
bancaria delle società occidentali. La legge fu pensata soprattutto per regolamentare un sistema bancario
intrinsecamente debole, come dimostrano i numerosi fallimenti bancari avvenuti durante la crisi del
1836.
Per quanto riguardava la costituzione di nuove banche in società per azioni, la legislazione del 1844,
estesa a Scozia e Irlanda tra il 1845 e il 1846, aveva come obiettivo quello di permettere la formazione
esclusivamente di quegli istituti bancari che potessero garantire un capitale sufficiente, prevedendo un
percorso in due livelli, quindi non immediato, per ottenere la registrazione ufficiale da parte delle
autorità. L’effetto reale del Bank Charter Act del 1844 fu quello di porre un freno alla nascita di nuove
banche anonime – solamente 12 furono create tra il 1844 e il 1857 –, concedendo quindi una sorta di
monopolio del settore alle banche già esistenti prima del 1844.
La crescita di questi istituti bancari si unì, tra gli anni Quaranta e Sessanta del secolo, alla nascita e
allo sviluppo di un’altra tipologia di banche: le cosiddette overseas banks. Si trattava di istituti bancari con
una dirigenza inglese e con la sede sociale solitamente ubicata a Londra, le quali tuttavia operavano
esclusivamente nei territori dell’Impero britannico e all’estero, da cui il nome di Colonial and Foreign
Banks, con il quale erano all’epoca conosciute. Le prime overseas banks furono fondate per svolgere
attività finanziaria nelle colonie britanniche, ma a partire dagli anni ’60 esse cominciarono ad ampliare il
proprio giro di affari anche all’America Latina e al Vicino Oriente. Nel 1860 esistevano 15 banche di
questo tipo, con 132 filiali all’estero; mentre nel 1890 erano operative 30 overseas banks, per un totale di
739 filiali estere attive. I fondatori di queste banche anonime attive sui mercati esteri erano mercanti
della City londinese con interessi economici nei medesimi mercati in cui andavano ad operare i nuovi
istituti bancari, i quali offrivano servizi finanziari in aree geografiche spesso carenti di infrastrutture
creditizie. In questo modo, oltre a favorire il commercio nelle zone coloniali, le overseas banks riuscirono
anche a costruirsi una clientela formata dalle classi sociali più ricche delle comunità locali.
L’avvento delle nuove tipologie bancarie – le overseas banks e, in particolar modo, le banche anonime
– non scalfì tuttavia il prestigio e il predominio delle grandi banche private almeno fino agli anni ’60
dell’Ottocento. Il credito internazionale, infatti, era ancora appannaggio esclusivo dei mercantibanchieri come i Rothschild e i Baring, che continuarono a dominare il mercato almeno sino alla fine
della Guerra di secessione americana nel 1865, sperimentando comunque nelle decadi successive un
declino lento e certamente solo relativo alla crescita degli altri istituti creditizi.
Il Bank Charter Act fu seguito da una serie di leggi, varate negli anni tra il 1857 e 1862, che
portarono ad una riformulazione del diritto societario inglese, introducendo la possibilità di costituire
società per azioni a responsabilità limitata anche nel settore bancario. Il rischio insito in una stretta
regolamentazione dell’emissione di carta moneta, legata al valore delle riserve auree bancarie, venne
tuttavia alla luce già negli anni immediatamente successivi al 1844, in particolar modo con la crisi di
liquidità del 1847. Questa, però, venne superata grazie alle cosiddette lettere del Tesoro, che
sollevavano la Banca d’Inghilterra da qualsiasi conseguenza giuridica qualora essa avesse, in caso di
necessità, come in effetti accadde proprio nel 1847, superato il limite che la legislazione imponeva alle
sue emissioni di banconote. Si faceva, in questo modo, un ulteriore passo in avanti verso la
regolamentazione governativa degli istituti bancari, in particolar modo per quanto riguardava
l’emissione di cartamoneta e, in generale, le questioni monetarie.
L’evoluzione legislativa inglese tra il 1844 e il 1862, sia per quanto riguarda la materia strettamente
monetaria sia da un punto di vista strettamente giuridico, unita ad una favorevole congiuntura
economica che iniziò negli anni ’60 dell’Ottocento per concludersi alla metà degli anni ’70, portò alla
12
crescita del numero di istituti bancari costituiti in società per azioni a responsabilità limitata, il cui picco
venne raggiunto nel 1880 quando si contavano 128 banche di questo tipo. Tuttavia, per il periodo qui
considerato, le banche in società per azioni non avevano un’estesa rete di filiali, con un giro di affari
che, nelle province, rimanere geograficamente limitato. Il sistema bancario inglese, quindi, ancora fino
al 1880, era caratterizzato dall’esistenza di numerose unit bank: solamente due istituti bancari – la
London & County Bank e la National Provincial Bank of England – avevano cominciato a costruire
una rete di filiali attive sul territorio.
La Francia
Il quadro dello sviluppo del sistema creditizio e finanziario francese è certamente uno dei più
complessi e variegati della storia finanziaria mondiale perché i processi di monetizzazione e di tutela del
valore dei mezzi di pagamento avvennero in maniera sfasata. Tali caratteristiche vanno probabilmente
ricercate nelle condizioni istituzionali all’interno delle quali gli operatori finanziari si trovarono a dover
operare dalla fine delle guerre napoleoniche in poi. In particolar modo, appare ricoprire un’importanza
particolare la scarsa diffusione di mezzi di pagamento alternativi alla moneta metallica e alle cambiali,
che fece della Francia un paese a bassissima diffusione di cartamoneta.
Ciononostante, se si osserva il rapporto tra crescita economica e ampiezza dell’uso delle banconote
in Francia, ci si rende conto come la diffusione queste ultime aumenti nel periodo tra il 1845 e il 1910 –
passando da 700 milioni a 16 miliardi di franchi – , periodo nel quale vi fu un rallentamento del tasso
medio di crescita del reddito pro capite. Osservare solamente la diffusione dei moderni mezzi di
pagamento non è un dato sufficiente per valutare la modernità di un sistema finanziario. Occorre,
piuttosto, porre l’attenzione sul rapporto che si crea tra i mezzi di pagamento disponibili in un sistema
economico; la presenza di vari e diversi tipi di intermediari; e le esigenze delle diverse economie, di cui
gli intermediari sono una funzione.
Su queste basi si è costruita quella che molti studiosi considerano l’originalità del sistema creditizio
francese, sorto come modello specifico nella seconda metà dell’Ottocento in concomitanza con la presa
del potere di Napoleone III e la conseguente nascita del Secondo impero nel 1852. A partire da questo
periodo, e almeno fino al 1880, lo scenario del credito francese fu dominato, con la chiara spinta
istituzionale del governo di Napoleone III, dalla nascita e dallo sviluppo di grandi istituti di credito sorti
sotto forma di società per azioni che, sul modello del più famoso di questi, il Crédit Mobilier, si
comportarono, per quasi un trentennio, come grandi banche universali. Queste operavano attivamente
nel settore del finanziamento industriale, anche mediante la creazione di nuove società industriali, e nel
settore dell’investimento dei titoli, sia industriali che ferroviari, acquisendo in tal modo il controllo di
imprese sia in Francia che all’estero.
Il momento di svolta, quindi, è da identificare con la metà dell’Ottocento. Al rivolgimento politico e
alla rinascita imperiale sotto Napoleone III, vi fu una crescente, costante, sovrapposizione delle nuove
istituzioni bancarie, le banche anonime, alle vecchie banche private dei mercanti-banchieri. Per un certo
periodo di tempo, almeno fino alla fine del secolo, queste due tipologie di istituti finanziari convissero e
si assistette, parallelamente, alla graduale crescita dell’una, della banca anonima, e, inversamente, al
declino dell’altra, della banca privata.
Dopo la presa del potere da parte di Napoleone III nel dicembre del 1851, nel dicembre del 1852 vi
fu la fondazione del Crédit Mobilier, che con un capitale di 60 milioni di franchi diveniva la seconda
banca del paese dopo la Banca di Francia. L’istituto venne creato dai fratelli Emile e Isaac Pereire, di
origine ebreo-portoghese, provenienti da Bordeaux. Durante gli anni ’40 dell’Ottocento, Emile Pereire
aveva lavorato per Rothschild alla Chemin de Fer du Nord, per poi mettersi in proprio insieme al
fratello Isaac dopo la rivoluzione del 1848. L’istituto dei fratelli Pereire si poneva l’ambizioso obiettivo
13
di allocare le risorse disponibili concedendo finanziamenti alle imprese industriali, di trasporto e di
utilità pubblica, come ad esempio quelle per la costruzione di dighe e canali. Per fare questo, venivano
emesse delle obbligazioni con lo scopo di raccogliere capitali da investire nelle imprese. In questo
modo, l’istituto dei Pereire cominciò ad acquistare i titoli delle più importanti industrie manifatturiere e
ferroviarie, creando contemporaneamente diverse imprese, sia in Francia che all’estero. Uno dei settori
in cui il Crédit Mobiliere fu più attivo fu certamente quello ferroviario, in particolar modo in Austria e
Spagna.
L’esperimento, però, cominciò ad entrare in crisi giù durante gli anni ’60 dell’Ottocento. In questo
periodo il Crédit Mobilier venne investito da una grave crisi di illiquidità, che emerse come conseguenza
di una vasta e rapida estensione delle attività finanziarie nel settore industriale. La crisi definitiva arrivò
nel biennio 1866-1867, quando una controllata della banca dei Pereire, la società di costruzioni
marsigliese Compagnie Immobiliére, andò incontro al fallimento, trascinando con sé l’intero sistema
finanziario costruito intorno al Crédit Mobilier, che crollò definitivamente nel 1870.
Le altre grandi banche che sorsero in questo periodo si dimostrarono più stabili e, soprattutto, più
vicine al modello delle banche in società per azioni inglesi. Si ricordano, tra queste, la Société Générale
de Crédit Industriel et Commercial (Cic), fondata per iniziativa di Armand Donon nel 1859 con un
capitale di 60 milioni di franchi; e il Crédit Lyonnais, costituito nel luglio del 1863 da Henri Germain
con l’appoggio dei più importanti imprenditori lionesi, in maggioranza mercanti di sete, e con una
importante partecipazione di finanzieri ginevrini. Infine, è d’obbligo citare il caso delle nuove banche
d’affari, come la Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas), fondata nel 1863, che si posizionò tra le più
importanti banche del paese specializzandosi nell’investimento d’impresa e che avrà un ruolo di non
secondaria importanza nell’ultimo trentennio del secolo.
Queste nuove banche non riuscirono ad ottenere il predominio del mercato finanziario almeno fino
agli anni Settanta dell’Ottocento, in quanto le grandi banche private, come ad esempio quella di James
de Rothschild, continuarono ad essere assolutamente predominanti nella gestione di un campo chiave
del settore, ovvero il controllo dei grandi prestiti pubblici esteri. La svolta si ebbe solamente con il
1872, con il lancio del prestito per poter ripagare l’indennizzo alla Germania dopo la sconfitta del 1871
nella guerra franco-prussiana.
2.2 La periferia: Germania, Italia, Stati Uniti
La Germania
Fino al 1871 la Germania è caratterizzata, politicamente, dalla presenza di un grande numero di
piccoli stati, che intrapresero una prima unificazione economica attraverso gli accordi tariffari dello
Zollverein, avviato nel 1818 e perfezionato progressivamente fino al 1833. Alcune città tedesche con
una storica tradizione commerciale internazionale, tra le quali occorre ricordare Amburgo, Colonia,
Francoforte e Berlino, videro la nascita di forti centri bancari fin dall’inizio dell’Ottocento, per lo più
improntati sulla figura di banchieri-mercanti, tra cui i più famosi e ricchi furono gli appartenenti alla
famiglia Rothschild, che si sparse poi in tutta Europa.
Con la rivoluzione del 1848 cominciò ad attuarsi un primo, piccolo cambiamento. In seguito ai moti
rivoluzionari, la A. Schaaffhausen, una casa privata mercantile-bancaria di vecchio tipo, entrò in grande
crisi. Impossibilitata a trovare un’istituzione disponibile a concederle un prestito per risollevare i propri
affari, la banca chiese al governo prussiano di concedergli l’autorizzazione per riorganizzarsi in forma
societaria. Sull’onda del breve periodo liberale dovuto al clima che si era creato dopo la rivoluzione del
1848, tale autorizzazione venne concessa, portando così alla nascita della Schaaffhausen’scher
Bankverein.
14
Nel periodo successivo, tuttavia, la burocrazia prussiana tornò ad opporsi fermamente alla nascita
delle nuove banche, rifiutando l’autorizzazione a formare banche in società anonima, come nel caso
della Sal. Oppenheim & Co., che si rivolse poi ai Pereire a Parigi, e nel caso di Gustav Mevissen, che
vide rifiutato il suo progetto di costituire a Colonia un istituto creditizio sul modello del Crédit Mobilier
francese. Mevissen, comunque, non si arrese e, dopo essersi visto rifiutare l’autorizzazione anche a
Francoforte, la ottenne invece a Darmstadt, nell’Assia, dove fondò nel 1853 la Bank fur Handel und
Industrie, solitamente chiamata Darmstadter Bank, con uno statuto modellato in una certa misura su
quelli del Crédit Mobilier parigino e della Scaaffhausen’scher Bankverein, per la quale lo stesso
Mevissen aveva lavorato negli anni precedenti.
La Darmstadter aveva uno statuo che le consentiva un’attività da vera e propria banca
d’investimenti. Essa aveva quindi la possibilità di acquisire la proprietà di azioni di imprese commerciali,
di sottoscrivere azioni e di organizzare fusioni tra imprese. Similmente alla Darmstadter, altre banche
trovarono la loro sede in città al di fuori della Prussia, dove gli Junker , che continuavano ad essere
politicamente influenti, non ne consentivano la formazione. La Diskontogesellschaft, ad esempio,
venne fondata da David Hansemann, il quale era stato in precedenza Ministro delle finanze prussiano e
presidente della Banca di Prussia, nel piccolo principato di Dessau nel 1851, mentre il Middeldeutsche
Creditbank nacque a Meiningen in Sassonia, nel 1856.
Lo Stato prussiano, e così molti altri stati tedeschi tra cui la Bavaria, avevano impedito la nascita di
nuove banche sotto forma di società per azioni, ma non vietavano la formazione di società in
accomandita a responsabilità limitata. Questo portò alla immediata nascita di nuove banche e alla
riorganizzazione di quelle più vecchie: nacquero, così, nel 1856, la Berliner Handels-Gesellschaft a
Berlino; il Schlesische Bankverein a Breslavia, in Slesia; l’Allgemeiner Deutscher Credit-Anstalt a Lipsia,
in Sassonia; e la Vereinsbank e la Norddeutsche Bank, entrambe sorte ad Amburgo.
Le nuove banche cominciarono quasi immediatamente a stringere forti rapporti con l’industria, in
particolare con quella mineraria e manifatturiera, senza tuttavia tralasciare gli investimenti in ferrovie e
in imprese di pubblica utilità. La Darmstadter in particolare partecipò direttamente, sempre nel 1856, in
forme diverse, a ben sette imprese industriali, che fondò o ristrutturò in società per azioni,
conservandone la proprietà per circa un terzo del capitale. Sempre nello stesso periodo, lo
Schaaffhausen’scher Bankverein aveva contribuito alla formazione dello Hoerder Bergwerk &
Huttenverein nel 1851, una società di miniere e fonderie, e di altre imprese, tra cui filatoi, assicurazioni
e ferrovie.
La crisi finanziaria del 1857 bloccò la nascita di nuove banche. Ad un intervallo di circa quindici
anni, però, vi fu una nuova ondata di fondazioni, innescata principalmente dalla grande crescita
economica, dalla vittoria nella guerra franco-prussiana e dalla conseguente nascita del Reich.
L’Italia
Durante la prima metà del XIX secolo, l’Italia era una paese politicamente frammentato. Ad una
molteplicità di piccoli stati, come quello di Genova o di Venezia, si affiancavano ampi territori dominati
da potenze straniere, come il Lombardo-Veneto, sotto il dominio austriaco, e Napoli, sotto quello
spagnolo, mentre il Papa conservava il suo potere temporale sullo Stato Pontificio nell’Italia centrale.
L’unificazione politica del paese, come successe anche in Germania, iniziò dalle tariffe. In reazione
all’adozione tedesca dello Zollverein, nel 1847, il Regno di Sardegna adottò un’unica unità tariffaria con
la Toscana e con gli Stati Pontifici. Le varie dominazioni straniere però, presenti nel nord-est e nel sud
del paese, avversarono tale piano. In questo modo rimasero fuori dall’unificazione tariffaria il
15
Lombardo-Veneto, già allora la parte industrialmente più progredita del paese, e il Regno delle Due
Sicilie.
Al momento dell’unificazione politica, nel 1861, vi erano in circolazione centinaia di vecchie monete,
in quanto non soltanto gli Stati, ma anche le singole città, possedevano un proprio sistema di
coniazione con pesi, metalli e sistemi divisionali diversi. Per fare un esempio, nella sola Toscana si
contavano, nel 1861, ben ventiquattro unità monetarie diverse. Di fronte ad una situazione così
frammentaria, l’uniformità del cambio progredì, così come quella politica, per passaggi intermedi.
Fino alla nascita del Regno d’Italia era in vigore il Codice albertino del 1837, attraverso il quale
l’esercizio del credito veniva riservato a società di negozianti e banchieri, i quali erano incaricati della
diffusione del credito commerciale e bancario attraverso l’uso di biglietti e depositi convertibili in
moneta metallica coniata dallo Stato e dai privati.
Dopo l’Unità, la legge Pepoli, emanata il 24 agosto del 1862, definì la lira italiana moneta legale per i
pagamenti, nonché unità di conto del risparmio e del credito, estendendo a tutto il paese la normativa
già in vigore nel Regno di Sardegna. Quest’ultima prevedeva un conio bimetallico, che doveva andare
incontro a due elementi considerati fondamentali per lo sviluppo economico del paese: l’importanza
attribuita agli scambi con la Francia, che costituiva il principale mercato di sbocco dei prodotti italiani; e
la possibilità di uniformarsi ai pagamenti in oro, come era in uso nel principale paese di importazione,
ovvero l’Inghilterra. Quello che venne poi definito «bimetallismo zoppo» divenne una forte fonte di
instabilità per il sistema monetario italiano, favorendo lo sviluppo della diffusione di moneta abusiva, di
aggio, e, in generale, contribuendo a generare una sostanziale incertezza sul reale valore dei mezzi di
pagamento in circolazione.
L’impatto di tale incertezza sul sistema creditizio fu di notevole importanza, causando profonde
conseguenze sul piano giuridico e amministrativo. Le norme che regolavano l’emissione e l’accesso al
credito furono comunque sensibili ai mutamenti politici del paese. Tuttavia, le condizioni generali in cui
si realizzò il Regno d’Italia, processo segnato dall’assoluta centralità del governo e dall’estensione delle
regole istituzionali del Regno di Sardegna a tutta la penisola, portarono ad affermare un ordinamento
prescrittivo di tipo piramidale.
Con l’unificazione si intensificò il fenomeno di adesione azionaria delle banche locali alla Banca
nazionale sarda, rinominata nel 1861 Banca Nazionale del Regno d’Italia. Al netto delle fusioni,
rimanevano, all’indomani dell’unità e dopo la presa di Roma nel 1870, cinque banche di emissione: la
Banca nazionale, la Banca nazionale toscana, la Banca romana – l’ex Banca degli Stati Pontifici – , e i
due più importanti istituti meridionali, il Banco di Napoli e il più piccolo Banco di Sicilia. Conclusa
comunque la fase delle annessioni regionali, e morto Cavour, il progetto di creazione di un sistema del
credito di tipo piramidale venne portato avanti dalla Destra piemontese per mezzo del ministro
Giovanni Manna. Il progetto Manna, presentato nel 1863, prevedeva la creazione di una Banca d’Italia
attraverso la fusione, favorita dal governo, delle due banche nazionali esistenti al momento dell’Unità,
ovvero la Banca nazionale degli Stati sardi e la Banca nazionale toscana. Quella proposta era una
rivisitazione del sistema francese, dove ad un istituto centrale di tipo statalista veniva affiancata una
serie di istituti di sconto commerciale: chiaro era infatti il ruolo gerarchico dell’ordinamento, che
avrebbe avuto al vertice una Banca d’Italia incaricata di scontare solo cambiali a tre firme, ovvero già
scontate da altre banche.
Il disegno di legge, però, si scontrò contro le élites commerciali, che si opponevano ad un progetto
che avrebbe creato, secondo la loro opinione, un sistema del credito troppo centralista e prescrittivo,
lesivo delle libertà d’impresa privata. L’avvenuta unificazione italiana diede un forte impulso all’arrivo di
una nuova ondata di capitali esteri, che arrivarono nel paese sia attraverso prestiti contratti all’estero
dallo Stato, sia direttamente per mezzo delle banche straniere. Nel 1862 esistevano sul territorio tre
16
banche di credito costituite in società per azioni. Tra il 1863 e il 1866 ne furono fondate altre 13, tra cui
la Banca anglo-italiana, fondata dalla famiglia Ricasoli e dall’ambasciatore inglese Henry G. Elliot, la
Società generale di credito mobiliare, nata per iniziativa del Crédit Mobilier francese, e la Banca di
Credito Italiano, creata dal Crédit Industriel et Commercial attraverso fondi di proprietà dei Rothschild.
Negli anni successivi all’Unità e alla nascita di nuove banche grazie al capitale straniero, vi fu in Italia
un breve boom dovuto alla costruzione di linee ferroviarie. Per questo progetto, essenziale
all’ammodernamento del paese, il governo piemontese si era pesantemente indebitato giù durante gli
anni ’50, continuando questo trend anche durante il decennio successivo. Se al momento
dell’unificazione il debito pubblico ammontava a 2,4 miliardi di lire, di cui solamente uno apparteneva
al Regno di Sardegna, durante il primo anno del nuovo Regno d’Italia vi fu un deficit di 500 milioni.
Nel 1866, infine, il debito pubblico nazionale era salito a ben 6 miliardi di lire. Con l’esplosione delle
crisi finanziarie a Parigi nel 1864 e nel 1866, il flusso di credito estero venne improvvisamente
interrotto e l’Italia non fu più in grado di assicurare la convertibilità delle banconote in monete
metalliche. Il corso forzoso venne così imposto nel 1866, in un paese di recente unificazione e che
ancora aveva poca dimestichezza con l’uso della cartamoneta.
Gli Stati Uniti
I problemi di finanziamento dello sviluppo economico presentarono negli Stati Uniti delle
problematiche per un verso analoghe a quelle europee e, per un altro verso, diverse. Le strutture su cui
poggiava la crescita erano infatti le medesime, ma profondamente diverse erano invece le condizioni
specifiche, da un punto di vista politico, sociale e culturale. L’architettura federale, unita ad una forte
gelosia d’autonomia dei diversi Stati, che caratterizzò il paese almeno per tutto l’Ottocento, dettarono il
peculiare sviluppo del sistema finanziario statunitense, un paese che, libero dal peso dell’eredità storica
presente in Europa, poté sviluppare tratti originali – il più vistoso dei quali era certamente l’assenza,
fino al 1913, di un sistema bancario centrale –, al fianco di caratteristiche vicine al sistema britannico ed
altre più vicine a quello dell’Europa continentale.
La crescita del tasso del risparmio nazionale, che comincia negli anni ’50 e aumenta sensibilmente
negli ultimi trent’anni del secolo, è spiegabile in parte con lo sviluppo degli intermediari finanziari e
delle innovazioni che essi mettono in campo, svolgendo un ruolo di stimolo al risparmio e di
agevolazione all’accesso di prestiti di capitali.
Uno dei tratti più originali del sistema bancario statunitense ottocentesco è l’eccezionale
proliferazione di banche, unita all’assenza di una banca centrale tra il 1836 e il 1913. Vi erano stati, tra la
fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, alcuni esperimenti in questo senso, con l’istituzione di una
banca denominata Banca degli Stati Uniti: la cosiddetta Prima Banca fu operativa tra il 1791 e il 1811,
mentre la Seconda Banca riprese l’attività tra il 1816 e il 1836, quando il dinamismo del suo presidente
Nicholas Biddle lo fece entrare in conflitto con diversi ambienti finanziari e politici, in particolare con il
presidente Andew Jackson che, a conclusione della cosiddetta «guerra della Banca», pose il suo veto al
rinnovo dell’istituto nel 1836.
Il sistema bancario che domina negli Stati Uniti fino alla Guerra civile e oltre era quindi costituito da
un altissimo numero di banche commerciali, spesso senza filiali e a sportello unico, che stabilivano al
massimo alcune filiali all’interno della propria contea e comunque mai al di fuori del proprio Stato. Esse
erano investite di un duplice ruolo. Da una parte esse fornivano i crediti necessari alla crescita
economica del territorio; dall’altra, la moneta che esse emettevano, doveva essere convertibile a vista.
Quest’ultimo punto diventava, nei periodo di recessione, il più difficile da mantenere, facendo sì che i
casi di sospensione furono molto frequenti.
17
Dall’inizio dell’Ottocento fino allo scoppio della Guerra civile, le banche commerciali conobbero un
rapidissimo sviluppo: nel 1800, ad esempio se ne contavano 29; esse divennero 260 nel 1816, per
raggiungere poi la cifra di 634 nel 1837 e di 2000 nel 1860. Questa grande crescita è spiegabile anche
grazie al fatto che la legislazione in vigore in numerosi stati americani concedevano facilmente le
autorizzazioni necessarie. Soprattutto nelle regioni di frontiera ad Ovest, dove i capitali scarseggiano, le
banche commerciali ricoprono principalmente il ruolo di istituti di emissione, con attività costituite in
gran parte da titoli del debito pubblico e una incertezza nella convertibilità dei biglietti.
Al fine di combattere la minaccia inflazionistica insita in tali attività bancarie, molti esperimenti locali
vengono posti in essere in questi anni. In Indiana viene fondata una banca centrale di stato, nel 1834; in
Iowa, stato agricolo con una forte tradizione anti-bancaria, viene vietata l’emissione a tutte le banche
nel periodo 1846-1857; nella Nuova Inghilterra viene istituito il controllo delle emissioni delle country
bank rurali da parte delle banche urbane; infine, in Louisiana, nel 1842, una legge bancaria impone
l’obbligo alle banche di avere una riserva metallica pari ad un terzo dei biglietti e dei depositi.
In questo scenario molteplice, le banche commerciali, non assumendo tutte le funzioni finanziarie di
base, permettono la nascita di altri intermediari finanziari specializzati.
Uno di questi è costituito dalle banche di mutuo risparmio, sorte agli inizi del secolo con intenti
filantropici per promuovere la mentalità economica nelle classi popolari. La prima di queste, la Bank for
Savings in the City of New York, venne fondata nel 1819. Alla metà dell’Ottocento, queste banche
cominciano a svilupparsi rapidamente, raccogliendo depositi e investendo in numerosi campi. Con la
crisi del 1857 – e maggiormente con quella del 1873 – questa tipologia di banche ritorna ad un originale
spirito di prudenza e specializzazione, iniziando tuttavia un rapido declino.
3. La concentrazione del capitale (1870-1913)
A partire dagli anni ’70 dell’Ottocento si realizzò quella che viene definita come la prima ondata di
globalizzazione della storia, che si accompagnò, e fu al tempo stessa favorita, dalla nascita degli imperi
coloniali delle grandi potenze. L’ambiente istituzionale ed economico tra il 1870 e il 1914 era, quindi,
particolarmente favorevole allo sviluppo di centri finanziari internazionali. Il ruolo dominante spettava
ancora alla City di Londra, capitale dell’economia dominante all’interno del contesto globalizzato,
seguita al secondo posto per importanza da Parigi ed in seguito da Berlino e New York. La Francia,
tuttavia, cominciava a declinare rapidamente in quanto ad importanza internazionale, e veniva sempre
più relegata a ruolo regionale, come erano regionali le zone di influenza degli altri centri minori, come
Francoforte, Ginevra, Zurigo e Milano.
Tre cambiamenti fondamentali si realizzarono in questo periodo in connessione con la rapida
globalizzazione del sistema economico e finanziario. Il primo è di tipo strettamente quantitativo: i flussi
di capitale esportato raggiunsero, infatti, somme mai viste in precedenza. Il secondo fu, invece, la
maggiore integrazione fra i diversi centri finanziari mondiali, resa possibile dall’avanzamento
tecnologico nel sistema dei trasporti, quindi delle informazioni, e dalla libera circolazione di capitali. Il
terzo ed ultimo mutamento fu l’aumento del numero dei centri finanziari mondiali, all’interno dei quali,
come detto, Londra rimase tuttavia il più importante fino alla Prima guerra mondiale.
In particolar modo il flusso di capitali a livello internazionale era il centro della crescita delle attività
economiche e finanziarie. La quantità di capitale inglese investito all’estero, ad esempio, quadruplicò tra
il 1875 e il 1914, mentre quello francese triplicò. Le attività all’estero erano per la maggior parte, circa il
65%, investimenti che prendevano la forma di attività di portafoglio in titoli di governi stranieri,
obbligazioni di ferrovie, in particolar modo negli Stati Uniti, e titoli di imprese di forniture pubbliche.
18
Il flusso di capitali raggiunse tutto il mondo, anche se l’Europa rimase l’area maggioritaria, seguita
dall’America del Nord, dall’America centro-meridionale, dall’Asia e dall’Africa. Tuttavia, i diversi centri
finanziari si specializzarono rapidamente anche per aree geografiche: se, infatti, i capitali inglesi erano
indirizzati per il 40% nei territori dell’Impero britannico, gli investitori francesi privilegiarono
investimenti in Europa, Medio Oriente, Impero ottomano ed Egitto, che insieme costituivano il 60%
del totale investito.
3.1 Il centro: Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti
La Gran Bretagna
Fino al 1914 la Gran Bretagna rimase l’economia egemone nel sistema economico e finanziario
mondiale. Anche se altre economie nazionali, come la statunitense e la tedesca, cominciavano in quel
periodo a crescere a tal punto da mettere in discussione la supremazia industriale inglese, Londra rimase
in posizione dominante nei settori del commercio estero, che rappresentava ancora il 14% del totale nel
1913, con la marina commerciale più grande al mondo, e nei settori dei servizi e della finanza, che
vedevano ancora la Gran Bretagna al centro dei sistemi dei pagamenti internazionali grazie al ruolo
delle sterlina, cardine del sistema monetario mondiale in uso all’epoca.
Nell’ultimo quarto dell’Ottocento e fino al 1914, la supremazia finanziaria della City di Londra
faceva perno sul suo sistema bancario che, insieme ad altre tipologie di intermediari finanziari come le
compagnie di assicurazione e le società finanziarie, creavano un sistema specializzato e fortemente
orientato alle attività internazionali. Le parti di cui il sistema finanziario inglese si componeva tra il 1870
e il 1914, erano tra loro complementari, creando così una forte omogeneità che garantiva il buon
funzionamento dell’intera struttura del credito. Ognuna delle principali istituzioni finanziarie della City
rappresentava un ingranaggio essenziale. Uno di questi ingranaggi era rappresentato dalle mercahnt bank,
che finanziavano la maggior parte degli scambi internazionali.
Il volume delle accettazioni sul mercato londinese crebbe, tra il 1875 e il 1913, di circa il 120%,
passando da circa 50-60 milioni di sterline a 140. Le merchant bank mantennero anche il predominio
dell’altra maggiore attività finanziaria londinese, cioè l’emissione dei prestiti esteri. Tra il 1870 e il 1914,
infatti, esse furono incaricate del 37% delle emissioni collocate sul mercato, superando la quota di
qualsiasi altra tipologia di banca.
Nonostante il mercato bancario londinese divenisse, per via della sua forza di polo di attrazione
mondiale, più competitivo con il passare del tempo, le grandi banche mercantili inglesi riuscirono a
mantenere il predominio almeno fino alla Prima guerra mondiale. È questo il caso, ad esempio, delle
note «Big Five»: Rothschild, Baring, Morgan, Schroder e Kleinwort. La maggiore di esse era certamente
la N.M. Rothschild & Sons, che nel 1873 aveva un capitale triplo della sua più vicina rivale, la Baring
Brothers. Alla fine dell’Ottocento, tuttavia, la Rothschild subì un declino, che in realtà fu solo relativo,
in quanto essa crebbe ma non con la rapidità delle sue concorrenti.
Tra gli anni ’80 e ’90, i Rothschild di Londra, in cooperazione con il ramo parigino della famiglia,
cominciarono a costruire il proprio impero minerario, investendo in oro, diamanti, metalli non ferrosi e
petrolio, e mantennero comunque saldamente il controllo sulle emissioni del debito pubblico estero.
Nel periodo che va dal 1865 al 1914, infatti, si calcola che i Rothschild si fecero carico di emettere quasi
il 75% dei prestiti di Stati lanciati sul mercato inglese.
La grande rivale dei Rothschild, la Baring Brothers, ebbe vicende altalenanti in questo periodo.
Dopo una grande crescita negli anni ’70 e ’80, subentrò una forte crisi, dovuta in particolar ad alcuni
19
investimenti non andati a buon fine in Argentina, che ne causarono la caduta nel 1890. Troppo grande
per poter fallire, in quanto le conseguenze sarebbero state disastrose per tutto il mercato finanziario
inglese e mondiale, la Baring Brothers venne salvata dalla comunità finanziaria, guidata dalla Banca
d’Inghilterra, e riorganizzata sotto forma di società a responsabilità limitata.
Proprio la costituzione di banche in società per azioni a responsabilità limitata fu una delle novità del
periodo preso in considerazione. Il mondo bancario inglese subì infatti un violento scossone nel 1878,
quando il fallimento della City of Glasgow Bank ebbe numerose ripercussioni sull’intero sistema. La
City of Glasgow Bank era una banca costituita in società per azioni senza responsabilità limitata. I suoi
azionisti, quindi, vennero chiamati a farsi carico dei debiti della banca dopo la sua bancarotta per ben
due volte. Questi eventi, che portarono a conclusione un dibattito avviato sin dagli anni ’30,
dimostrando tutti gli svantaggi derivati dalla non introduzione della responsabilità limitata nella
formazione delle banche in società per azioni.
Con i Companies Acts del 1879 venne inserita la possibilità di mutare i regolamenti societari per
inserire la responsabilità limitata nelle già esistenti banche costituite in società per azioni. Lo shock
provocato dal fallimento della banca scozzese, e i danni che i debiti e la bancarotta di quest’ultima
causarono agli azionisti, fecero si che durante gli anni ’80 ben 27 istituti bancari inserirono nei loro
statuti la responsabilità limitata. I vantaggi di quest’ultima erano, infatti, ormai divenuti così evidenti che
negli anni ’90 del secolo era davvero raro trovare una banca che non ne facesse uso.
La crisi della Baring nel 1890 diede il colpo finale alle maggiori banche di deposito private, che, già
in crisi nel periodo precedente per l’avanzare delle grandi banche anonime, cominciarono a scomparire
una dopo l’altra nel periodo fino al 1914. In questo periodo le banche costituite in società per azioni
con responsabilità limitata cominciarono a crescere, costruendo le proprie reti di filiali nelle province.
Le prime a muoversi in questa direzione furono la National Provincial Bank e la London and County
Bank che, insieme alla Westminster Bank, presente solo a Londra, divennero le tre più grandi banche
del paese sino alla fine degli anni ’80.
Tra il 1870 e il 1914 vi fu anche un mutamento nelle dimensioni delle maggiori banche, che crebbero
in maniera esponenziale. Se, ad esempio, nel 1891 i depositi della National Provincial Bank
ammontavano a 41 milioni di sterline, quelli della Midland Bank, nel 1913, toccavano la cifra di 216
milioni. Parallelamente, si assistette alla crescita del numero delle filiali che queste grandi banche
aprivano nelle province inglesi. Tuttavia, per quanto riguardava la tipologia di attività bancaria svolta,
queste nuove banche non erano molto diverse da quelle che le avevano precedute nel corso
dell’Ottocento. L’attività principale, infatti, rimaneva il credito a breve termine, che andava quindi a
sostenere gran parte delle attività finanziarie del mercato della City di Londra.
L’altro grande settore all’interno del quale il mondo finanziario londinese dominava erano le
assicurazioni. Soprattutto dagli anni ’70 in poi, l’attività assicurativa aumentò notevolmente:
l’ammontare dei premi per rischio d’incendio, ad esempio, crebbe da 4 a 29 milioni di sterline nel
periodo compreso tra il 1870 e il 1914, mentre i premi per le assicurazioni sulla vita aumentò da 10 a 29
milioni. Tale crescita dei volumi fu accompagnata da una maggior concentrazione. Le dieci più grandi
compagnie di assicurazioni, tra cui spiccavano la Royal, la Commercial Union raccoglievano il 70% dei
premi in incendi; per quanto concerneva le assicurazioni marittime, i Lloyd’s controllavano
praticamente l’intero mercato; infine, per quanto riguardava le assicurazioni sulla vita, la Prudential
controllava, da sola, più della metà del mercato.
Contestualmente, stava mutando anche la tipologia degli investimenti operati dalle compagnie
assicurative, che tendevano, nell’ultimo quarto di secolo, a diversificare il collocamento dei propri
guadagni. Si assistette, innanzi tutto, ad un allargamento degli investimenti all’estero, che passò dal 7%
del 1870 al 40% nel 1914; inoltre, aumentò la quota detenuta di azioni di imprese private, che nel
20
medesimo lasso di tempo salì dal 13% al 40% del totale dei fondi investiti. Tale diversificazione
avvenne per la maggior parte a scapito dei tradizionali investimenti delle compagnie di assicurazione,
che consisteva in titoli di Stato, prestiti a enti locali e obbligazioni ferroviarie britanniche, il cui
rendimento era in costante calo.
Ultimo, fondamentale tassello del sistema finanziario inglese della tarda età vittoriana era ovviamente
la Banca d’Inghilterra. Con la medesima struttura organizzativa prevista dal Bank Charter Act del 1844,
la Banca d’Inghilterra, a causa dell’enorme crescita del mercato e dello sviluppo delle banche di
deposito che, come visto, stavano diventando in questi anni dei veri e propri colossi, aveva sempre più
difficoltà a gestire il mercato monetario attraverso solamente lo strumento del tasso di sconto. Si
cominciò, quindi, a far ricorso ad altri mezzi al fine di rendere efficace la propria politica monetaria, in
particolar modo prendendo in prestito sul mercato con lo scopo di far salire il costo del denaro,
attraendo così oro a Londra. In questi anni, comunque, la Banca d’Inghilterra controllava saldamente la
comunità finanziaria della City di Londra, come dimostra la guida che essa, attraverso principalmente il
suo governatore William Lidderdale, acquisì nell’operazione di salvataggio della Baring Brothers nel
1890-1891.
La Germania
Dopo la vittoria sulla Francia del 1871, in Germania si realizzò contemporaneamente l’unificazione
politica, l’unificazione monetaria, e la costruzione di una banca centrale che avesse il compito di
regolare il nuovo sistema finanziario nazionale.
La nuova istituzione venne creata per iniziativa del Reichstag. La Reichsbank nacque nel 1876
attraverso la trasformazione della principale banca prussiana con sede a Berline, la Preussische Bank,
che rifletteva la posizione dominante della Prussia e di Berlino all’interno del nuovo stato. Pur avendo
la supremazia come organo di vigilanza e di emissione, la legge consentiva la sopravvivenza di altri
trentadue banche con diritto di emissione, limitando tuttavia questo privilegio con vincoli territoriali
particolarmente stringenti.
L’unificazione monetaria, che giunse a conclusione con l’adozione di un’unica moneta tedesca
convertibile in oro, il marco, era comunque già in moto dagli anni Sessanta in quanto il tallero prussiano
si era diffuso in tutti gli Stati tedeschi, diventando la moneta di uso comune. Modellata seguendo il
modello inglese del Bank Charter Act del 1844, la Reichsbank doveva mantenere, per legge, una riserva
pari a un terzo delle proprie passività in cartamoneta. Era tuttavia prevista l’elusione di questo limite
attraverso una multa pari al 5% delle eccedenze.
L’adozione del gold standard e il rapido sviluppo economico tedesco, resero il marco una delle valute
di riserva più pregiate a livello internazionale al fianco della sterlina e del franco, rafforzando la
posizione della Germania nei campi del finanziamento del commercio estero e nelle emissioni di prestiti
stranieri. Sulla piazza berlinese gli affari erano dominati dalle grandi banche. Al vertice del sistema vi
erano le cosiddette «quattro D»: Deutsche Bank, Dresdner Bank, Disconto Gesellschaft e Darmstadter
Bank. Nel 1914, esse comparivano tra le venti maggiori banche del mondo e secondo alcune classifiche
la Deutsche Bank sarebbe stata al primo posto.
La struttura del sistema bancario tedesco era tuttavia vasta e andava al di là di questi grandi istituti,
che tuttavia, come vedremo, giocarono un ruolo essenziale in particolar modo dagli anni Ottanta in poi.
Le nove maggiori banche berlinesi raccoglievano, secondo una stima del 1913, solamente il 12% delle
risorse bancarie nazionali. Il grosso dei depositi era raccolto da centinaia di banche anonime territoriali
e da altre tipologie di istituti, come casse di risparmio, istituti di credito ipotecario e banche popolari.
21
Ciononostante, tre fattori determinavano l’importanza capitale delle grandi banche tedesche. In
primo luogo, fondamentali si rivelarono le loro dimensioni e i grandi capitali a disposizione, acquisiti
grazie ad un peculiare processo di concentrazione del settore bancario, attraverso il quale presero forma
delle comunità di interessi, realizzate tramite compartecipazione ai profitti e partecipazioni incrociate,
più che mediante fusioni e acquisizioni. La Deutsche Bank, ad esempio, nel 1904 si trovava alla guida di
un gruppo di quattordici banche, il cui capitale ammontava a 700 milioni di marchi.
In secondo luogo, le grandi banche tedesche erano quelle che vengono tradizionalmente definite
come banche universali, che univano quindi l’attività di investimento a quella di deposito. In questo
modo, questi istituti di credito partecipavano sia al finanziamento dell’industria nazionale, sia a grandi
operazioni bancarie e finanziarie internazionali, con particolare riferimento all’emissione di prestiti
esteri. Queste attività erano esclusivo appannaggio delle grandi banche, che escludevano totalmente le
altre banche locali e i diversi istituti di credito presenti nel paese da questo genere di affari.
Fino ancora agli anni Settanta dell’Ottocento, i prestiti internazionali vennero emessi soprattutto
dalle banche private. Tuttavia la loro importanza era in fase discendente e dagli anni Ottanta in poi le
grandi banche conquistarono il predominio di tali operazioni finanziarie. Da quel momento in poi, in
particolare la Deutsche Bank e la Disconto Gesellschaft dominarono i sindacati di emissione,
soprattutto verso i paesi dell’America latina, oltre che verso la Cina e l’Impero ottomano.
In Germania, fortissimi erano i legami tra le grandi banche e l’industria, come ad esempio nei casi
della Siemens & Halske e la Deutsche Bank; dell’Aeg e della Berliner Handels-Gesellschaft; infine della
Gelsenkirchen Bergwerkgelleschaft e la Disconto Gesellschaft. I rapporti tra grandi industrie e grandi
banche era stretto e reciproco: gli industriali erano rappresentati all’interno dei consigli delle banche e,
viceversa, le grandi banche sedevano nei consigli delle imprese.
Gustav Mevissen rappresenta un tipico esempio di queste strette relazioni tra finanza e
imprenditoria tedesca nell’ultimo quarto dell’Ottocento. Egli partecipava, ad esempio, ai consigli di sei
imprese minerarie – e di due di esse era nel comitato esecutivo – e di due società industriali, di cui era
anche presidente; era, inoltre, presidente della Darmstadter Bank e della Luxemburger Internationale
Bank; membro del consiglio di amministrazione dello Schaaffhausenscher Bankverein, della Bank fur
Suddetuschland, della Kolner Privatbank e della Berliner HAndels-Gesellschaft, nonché, infine, della
società ferroviara Rheinische Eisenbahngesellschaft.
Nacquero in questi anni, a Berlino, anche alcune overseas bank, anche se in numero decisamente
minore rispetto a quelle sorte a Londra e Parigi. Nate con l’obiettivo di finanziare il commercio e gli
investimenti esteri tedeschi, esse furono tutte fondate dalle grandi banche. La Deutsche Bank, ad
esempio, fondò con propri capitali nel 1886 la Deutsche Uberseeische Bank per gestire gli affari in
America del sud, e la Deutsch-Asiatische Bank nel 1889, in collaborazione con la Disconto Gesellschaft
e con Beichroder, uno degli ultimi esponenti del settore bancario privato.
Gli Stati Uniti
Negli anni tra il 1870 e il 1914 si assistette al sorpasso degli Stati Uniti sull’Inghilterra come
principale potenza economica del mondo. Se già nel 1870 il Pil statunitense superava di poco quello
inglese, che rimaneva comunque al primo posto nel settore manifatturiero con quasi un terzo dell’intera
produzione globale, nel 1914 il Pil degli Stati Uniti eguagliava la somma dei Pil di Inghilterra, Francia e
Germania, ovvero le altre tre nazioni più industrializzate del mondo.
In relazione a questa crescita, e al peculiare sistema bancario statunitense, New York divenne uno
dei centri finanziari internazionali attraverso un percorso in parte diverso da quello di Londra, Parigi o
Berlino. Fino ancora alla fine dell’Ottocento, infatti, gli Stati Uniti erano un paese importatori di
22
capitali, legando quindi inversamente New York ai grandi centri europei che finanziavano il commercio
estero statunitense. Quest’ultimo continuò quindi a dipendere in larga parte dai capitali della City di
Londra, ponendo la piazza di New York in una posizione ambigua, risolta solamente dopo la Prima
guerra mondiale.
La rilevanza del mercato finanziario statunitense, tuttavia, divenne sempre più chiara con il passare
dei decenni in particolar modo in relazione a tre tratti: l’ammontare degli investimenti esteri negli Stati
Uniti, la grande crescita economica del paese e la centralità di New York come polo finanziario
nazionale. Il mercato dei capitali di New York, che crebbe enormemente di importanza soprattutto tra
il 1870 e il 1914, andò a finanziare le imprese di enormi dimensioni che caratterizzarono l’ambiente
microeconomico statunitense, come ad esempio le ferrovie e, alla fine dell’Ottocento e come
conseguenza di un’ondata di fusioni e acquisizioni aziendali, i grandi giganti industriali che ne
scaturirono.
Il fulcro del centro finanziario newyorkese era costituito dalle banche d’investimento. Le più
importanti di queste ultime erano quelle che avevano i legami più stretti con i centri finanziari europei
ed in particolar modo con la piazza di Londra. Anche se quasi tutte le banche d’investimento
statunitense vennero fondate nel corso della prima metà dell’Ottocento, fu solo con la conclusione della
Guerra civile che esse conobbero un massiccio sviluppo. Esistevano due grandi gruppi di case bancarie,
caratterizzati dalle origini sociali e dall’appartenenza etnico-religiosa.
Il primo gruppo era costituito da banchieri di religione protestante e di origine anglo-sassone, come
ad esempio la J.P. Morgan, che agli inizi del Novecento era indubbiamente la più grande e importante
del paese, la Kidder Peabody & Co. e la Lee Higginson & Co. La J.P. Morgan affondava le sue origini
nell’attività di una delle maggiori merchant bank inglesi di Londra, la J.S. Morgan & Co., che portava il
nome del padre di John Pierpont Morgan. Quest’ultimo, dopo un apprendistato a Londra e, dal 1858 in
poi, a New York, divenne socio nel 1871 della Drexel & Co., della quale assunse il controllo sei anni
dopo, alla morte di Anhony J. Drexel, cambiandone il nome in J.P. Morgan & Co. nel 1895. La Kidder
Peabody & Co. era invece originaria di Boston, dove aveva iniziato, già dagli anni ’20 del secolo,
un’attività di brokeraggio sotto la guida della famiglia Thayer. Alla morte dell’ultimo discendente, tre
impiegati dell’azienda rilevarono l’attività, costituendo una nuova società con il nome di Peabody & Co.
La casa Lee Higginson & Co., anch’essa di Boston, fondata nel 1845, cominciò ad espandere le proprie
attività soprattutto dopo la conclusione della Guerra civile, in particolar modo offrendo i propri servizi
di investimento alla ricca clientela degli stati della Nuova Inghilterra, nel nord-est del paese.
Il secondo gruppo di banche d’investimento era invece costituito da banchieri di origine tedesca ed
ebraica, tra cui si ritrovano Kuhn, Loeb & Co. e J. & W. Seligman & Co. Al contrario della maggioranza
dei banchieri di origine anglosassone, che provenivano dal mondo mercantile e della finanza con forti
legami con la City di Londra, questi banchieri di origine ebraico-tedesca, emigrati negli Stati Uniti tra gli
anni ’40 e gli anni ’50 dell’Ottocento, avevano origini più umili. Non era infatti raro che questi banchieri
avessero iniziato la propria carriera come venditori ambulanti, per poi passare al commercio,
all’ingrosso o al dettaglio, per spostarsi poi sulle attività bancarie e finanziarie sulla piazza di New York.
Joseph Seligman rappresenta in questo caso un esempio paradigmatico. Emigrato dalla Baviera nel
1837 con appena 100 dollari in tasca, fu inizialmente impiegato in un negozio in Pennsylvania,
dedicandosi poi alle attività di venditore ambulante. Dopo che nel 1839 due fratelli lo raggiunsero negli
Stati Uniti, essi divennero proprietari di alcuni negozi in Alabama e, nel 1846, di una società di
importazione di capi d’abbigliamento e di merceria a New York. Dopo che due dei fratelli si
trasferirono, nel 1850, a San Francisco per commerciare in oro, spedito prima a New York e poi a
Londra per pagare le importazioni di lana e seta, nel 1862 essi aprirono la banca J. & W. Seligman &
Co. con un capitale sociale di un milione di dollari. Una delle principali attività bancarie a cui la casa
23
bancaria si dedicò negli anni successivi fu il collocamento dei titoli del debito pubblico durante la guerra
civile.
Un percorso simile fu anche quello seguito da Abraham Kuhn, che partì, nuovamente dalla Baviera,
insieme a suo cognato Salomon Loeb, aprendo insieme un negozio di abiti da uomo nell’Indiana
all’incirca nel 1850. Nel 1867, dopo un breve soggiorno a Cincinnati, i due si trasferirono a New York,
dove aprirono la propria casa bancaria, la Kuhn Loeb & Co., dedicandosi alla vendita di obbligazioni
ferroviarie e del debito pubblico. Quando nel 1875 Jacob Schiff, originario di Francoforte, la banca
divenne la prima banca d’investimento del paese a finanziare la costruzione delle grandi ferrovie transamericane.
Proprio gli investimenti nella costruzione dell’enorme rete ferroviaria statunitense, durante gli anni
Settanta e Ottanta dell’Ottocento, rafforzarono largamente la posizione delle banche d’investimento
che, durante gli anni Novanta, cominciarono a investire anche le grandi imprese manifatturiere del
paese, cominciando a svolgere un ruolo di crescente importanza a sostegno della tendenza alle fusioni
societarie d’inizio Novecento. Il punto più alto di tale percorso di fusioni fu, forse, la creazione della
United States Steel Corporation per mezzo della J.P. Morgan nel 1901. La U.S. Steel Corporation era la
più grande impresa mai creata nella storia, con un capitale sociale che, per la prima volta, superava il
miliardo di dollari.
Le banche d’investimento statunitensi erano operative in ambito internazionale, anche perché esse
erano legate ai capitali che provenivano dall’Europa ed in particolare da Londra. In questo contesto, la
J.P. Morgan & Co. era certamente in un posizione avvantaggiata grazie agli stretti legami, d’affari e
familiari, che la legavano con la J.S. Morgan & Co. di Londra e con la Morgan, Harjes & Cie di Parigi,
delle quali John Perpont Morgan era socio per diritto ereditario. Anche le altre case bancarie erano
comunque fortemente legate all’ambiente finanziario europeo: i Seligman avevano infatti vincoli
familiari con le case di Londra, Parigi e Francoforte, mentre la casa Kidder Peabody era in stretti
rapporti con la Baring Brothers, della quale divenne l’agente esclusivo sul mercato statunitense nel
1886.
Centro vitale del sistema bancario e del mercato finanziario statunitense era il New York Stock
Exchange, la cui supremazia sulle altre borse del paese risale alla metà del secolo, in contemporanea con
quella rivoluzione delle telecomunicazioni che portò all’introduzione del telegrafo nella metà degli anni
Quaranta, della telescrivente nel 1867 e del telefono nel 1878. Ad inizio Novecento, la supremazia della
borsa di New York all’interno del mercato finanziario nazionale era netta, con il 45% del valore
nominale di tutti i titoli quotati nel 1912 e il 69% del numero complessivo dei titoli trattati nel paese nel
1910, percentuale che raggiungeva il 91% in valore nominale se si osservano le sole obbligazioni.
L’ascesa della borsa di New York è testimoniata anche dal fatto che, tra il 1879 e il 1909, il valore
nominale dei titoli quotati crebbe da 4,2 a 19 miliardi di dollari.
La borsa di New York era organizzata in modo diverso rispetto alle tre maggiori borse europee.
Come quella di Londra, la borsa newyorkese era un’organizzazione autonoma che non aveva alcun
monopolio sul mercato; diversamente da Londra, però, gli operatori della borsa erano anche i
proprietari, con un numero fisso – stabilito in 1060 individui nel 1869 e che salì a 1100 nel 1879 –, che
si riunivano in un consiglio di amministrazione che controllava la gestione dell’intera struttura.
L’aumento del valore dei titoli, che come detto quasi quintuplicò in un trentennio, e il numero degli
operatori di borsa che si mantenne invece stabile, fece si la borsa di New York fu spinta ad una
specializzazione funzionale, trattando in particolar modo i titoli delle grandi imprese con una salda
reputazione. L’ammissione di titoli alla quotazione borsistica era quindi attentamente vagliata da un
apposito comitato, che ignorò per lungo tempo i titoli delle compagnie di assicurazione e delle imprese
minerarie, mentre vennero favoriti quelli delle ferrovie e delle grandi imprese manifatturiere.
24
Con questi mezzi, bancari e azionari, si continuava ad organizzare un mercato dei capitali rivolto agli
investimenti di aziende statunitensi con il decisivo concorso dei capitali esteri. Fu l’emissione dei primi
debiti esteri sula piazza di New York che cominciò a far accrescere l’importanza internazionale di Wall
Street. Uno dei maggiori da un punto di vista quantitativo, nonché dei più importanti da un punto di
vista simbolico, fu il prestito britannico emesso nell’agosto del 1900 al fine di finanziare la guerra angloboera, collocato da John Pierpont Morgan. L’emissione, che riscosse un largo successo pressi il
pubblico americano, aprì la strada a successivi quattro prestiti di guerra britannici, che cominciarono a
insinuare una breccia nell’assoluta supremazia londinese prefigurando la futura ascesa della piazza di
New York al vertice della finanza mondiale.
Nonostante i cambiamenti che cominciavano a verificarsi agli inizi del Novecento, New York
dipendeva ancora dalla City londinese in quanto rimanevano consistenti le esportazioni del capitale
britannico negli Stati Uniti e, ancor più importante, il commercio estero americano rimaneva finanziato
in buona parte tramite Londra.
Ancora fino alla prima decade del nuovo secolo, gli Stati Uniti, anche se erano diventati la maggior
potenza economica mondiale, rimanevano un paese in larga parte esportatore di prodotti agricoli,
dipendente da Londra per la liquidità e, quindi, per l’oro, con una domanda di credito stagionale nelle
aree rurali e un sistema bancario estremamente frammentato. Quest’ultimo era infatti ancora
caratterizzato dal divieto di costituire una rete di filiali in diversi Stati e, soprattutto, dall’assenza di una
banca centrale.
Queste mancanze vennero alla luce con la crisi dell’ottobre del 1907. Dopo un fallito tentativo da
parte di banche e trust company di prendere il controllo del mercato del rame, la Knickerbocker Trust
Company fu costretta a chiudere gli sportelli, rischiando di scatenare una reazione di panico a catena.
L’intervento congiunto del segretario del Tesoro, George Cortelyou, e della comunità bancaria guidata
da John Pierpont Morgan, riuscì a calmare la situazione.
Il ruolo di J.P. Morgan, che si era ritirato dagli affari ed era tornato solamente per fronteggiare la
crisi bancaria, comportandosi quasi come un banchiere centrale, fu fondamentale nel superare il panico
del 1907. Parallelamente, però, l’intera crisi, nonché le sue modalità di risoluzione, fecero emergere
chiaramente i limiti di un sistema bancario di cui si chiedeva ormai una riforma generale.
Il panico del 1907, nonché alcuni sospetti circa l’esistenza di un «trust del denaro» portarono alla
formazione della Commissione Pujo nel 1912, che aveva appunto il compito di indagare sull’esistenza
di un ristretto circolo di pochi, potenti e ricchi banchiere che controllavano tutto il mondo degli affari.
Sebbene il rapporto della commissione non arrivò a nessuna conclusione definitiva, dal periodo 19071912 scaturirono due importanti provvedimenti legislativi, entrambi varati e attuati nel biennio 19131914. La legge Clayton, del 1914, proibiva il cumulo di qualsiasi direzione di istituti bancari le cui
attività avessero superato, nella somma dei depositi, del capitale, degli utili e dei profitti, i cinque milioni
di dollari. Il secondo provvedimento, il Federal Reserve Act approvato il 23 dicembre del 1913 e
applicato a partire dal novembre del 1914, istituiva la Federal Reserve Bank, modellata su una struttura
decentrata. Il paese venne infatti suddiviso in dodici distretti, ognuno dei quali dotato di una banca
federale distrettuale con sede nella più importante città del distretto medesimo, il cui capitale doveva
essere sottoscritto dalle banche che intendevano usufruire del nuovo sistema di finanziamento.
L’obiettivo principale dell’istituzione delle banche federali era quello di risolvere il problema della
rigidità monetaria in particolar modo in relazione alle fluttuazioni stagionali della domanda e in
mancanza di un creditore di ultima istanza. Con le banche federali, quindi, si immaginava un sistema
per fornire moneta elastica e per offrire mezzi per il risconto dei crediti commerciali, funzionando
come stanze di compensazione per le banche del territorio. Infine, il sistema bancario federale era
25
anche costruito con compiti di monitoraggio sull’intero sistema bancario, la cui supervisione nazionale
era affidata ad un Federal Reserve Board, formato da otto membri e con sede a Washington.
3.2. La periferia: Italia, Francia
L’Italia
Con il regio decreto del 1 maggio 1866, il governo italiano decretò la non convertibilità delle
banconote emesse in relazione al ricorso ad un prestito di 200 milioni in previsione della guerra contro
l’Austria. Questo prestito, concesso dalla Banca Nazionale alle finanze governative, pose la Nazionale
in una posizione di forte vantaggio rispetto agli altri istituti di emissione, in quanto il decreto attribuiva
alle sole banconote emesse dalla Banca nazionale la condizione di corso legale in tutto il paese, mentre
le banconote messe dalle altre banche erano sottoposti alla convertibilità in metallo o in titoli di
pagamento della Banca nazionale.
Tali provvedimenti normativi conferirono, come detto, una posizione privilegiata alla Banca
nazionale, ma, più che per una sua effettiva egemonia, per il radicarsi della vocazione territoriale e
geograficamente limitata degli altri istituti, in ragione dell’accresciuto uso della cartamoneta e della
comparsa della circolazione abusiva di banconote di piccolo taglio, necessarie dopo la scomparsa di
circolante metallico.
Negli anni Settanta in Italia vi erano due insiemi di aziende di credito. Il primo insieme era costituito
dalle società di credito ordinario e dalle società familiari dedite ad attività finanziarie di vario tipo.
Queste vengono solitamente indicate come «alta banca», al fine di distinguerle dalla «nuova banca»
organizzata in società per azioni, ovvero gli istituti di credito mobiliari organizzati sul modello del
Crédit Mobilier francese dei fratelli Pereire. Un secondo insieme era invece costituito dalle banche di
costo e circolazione indicate come istituti di emissioni, che si trovavano in una posizione di
interlocutori privilegiati con il mondo politico in ragione del loro privilegio di emettere moneta.
Elemento comune a tutti gli istituti bancari, comunque, era in questo periodo l’eterogeneità della
gestione e dell’esercizio del credito.
Per superare la disomogeneità nei mezzi di pagamento e nelle forme del credito, il Ministero del
Tesoro istituì nel 1866 il Sindacato di controllo delle società anonime presso il ministero de Tesoro.
Guidato da Carlo De Cesare, il Sindacato veniva chiamato a dare parere sulla conformità dei criteri
organizzativi delle nuove banche, svolgendo anche ulteriori compiti di vigilanza. Attraverso questa
nuova magistratura, De Cesare riuscì a orientare la struttura del sistema bancario in tre settori non
comunicanti tra loro: gli istituti di credito mobiliare, ai quali si riservava la funzione di credito a medio e
lungo termine finanziato con raccolta di capitale di rischio; le casse di risparmio, che dovevano
raccogliere il piccolo risparmio; infine, le società ordinarie di credito, di cui facevano parte anche gli
istituti di emissione, che potevano erogare solamente credito a breve termine.
Tuttavia, l’instabilità del sistema permase in quanto divenne manifesta l’incapacità della classe
dirigente di attuare una riforma credile del sistema bancario. Negli anni tra il 1870 e il 1872 si registrò
un aumento triplo degli istituti di credito rispetto a quello del periodo precedente. Le ragioni sono
principalmente riconducibili ad una svolta liberale nella regolazione dell’attività bancaria, attuata dal
1870 in poi da Quintino Sella, ministro delle Finanze, e Stefano Castagnola, ministro dell’Agricoltura,
industria e commercio. Tuttavia, non è di secondaria importanza la crescita commerciale che si
cominciava a registrare nel paese in quegli anni.
L’inversione del ciclo economico successiva al 1873 pose, infatti, un freno alle attività commerciali
che comportò la crisi di molte aziende bancarie. Alla caduta del governo Lanza e di Sella, raggiunsero
posizioni di comando dello Stato esponenti della corrente «statalista». La legge Minghetti, emanata
26
nell’aprile del 1874, si poneva come obiettivo principale la regolamentazione dell’emissione di moneta.
Il vigente regime di duplice circolazione –una a carattere nazionale e inconvertibile rappresentata dai
biglietti della Banca nazionale e una locale e convertibile degli altri istituti di emissione – veniva
sostituito da un regime ad unica circolazione, costruito su una banconota inconvertibile emessa da un
Consorzio formato da tutti gli istituti di emissione esistenti.
Con la legge Minghetti il Parlamento delegò istituzionalmente la sua funzione monetaria ad un ente
privato, il Consorzio delle banche di emissione, i quali si impegnavano così alla produzione congiunta
di un bene pubblico, la banconota, al fine di realizzare un sistema dei pagamenti più stabile ed
efficiente. Tra il 1874 e il 1883, quindi, il Parlamento costruì un sistema di gestione bancaria di tipo
verticale, agendo però non attraverso norme che andassero a regolare gli statuti delle società e le
tipologie delle operazioni loro consentite, bensì regolamentando il totale di moneta di cui gli operatori
potevano disporre.
In questo periodo emersero così tre livelli all’interno della struttura piramidale del credito in Italia:
quello di base, costituito da tutti gli operatori; quello intermedio, che comprendeva l’insieme degli
istituti di credito; infine, quello di vertice, costituito dagli istituti di emissione. In questo modo il vertice
regolava l’intero sistema attraverso la decisione del prezzo e della quantità di offerta di moneta bancaria.
In quanto depositaria della maggior quota di riserve, la Banca nazionale venne di fatto investita, senza
però esplicite indicazioni giuridiche, dell’azione di vigilanza sull’intero sistema finanziario.
La formazione del consorzio degli istituti di emissione, insieme all’equilibrio del bilancio dello Stato
e ad un prestito di 644 milioni di lire emesso sulla piazza di Londra al fine di stabilizzare la
convertibilità delle banconote, rese possibile il ritorno alla convertibilità, decretata nel 1881 e attuata nel
1883. Conseguentemente, vi fu una rinnovata disponibilità di capitali esteri, che portò alla formazione
di società industriali e prestiti verso società siderurgiche, elettriche e chimiche; vi fu, inoltre, una grande
espansione edilizia, che si realizzò in particolare a Roma e Napoli dove la speculazione edilizia
coinvolse in particolar modo il Banco di Roma, fondato nel 1880.
La crisi finanziaria prodotta dalle speculazioni edilizie venne portata al suo stato terminale da due
eventi: il primo fu la guerra tariffaria scoppiata tra l’Italia e la Francia nel 1887, che condusse ad un calo
degli investimenti francesi in Italia; il secondo fu la notizia del fatto che la Banca Romana aveva, con
l’aiuto di alcuni alti funzionari corrotti, oltrepassato i limiti imposti alle sue emissioni di cartamoneta. In
conseguenza a questo scandalo, nel 1893 venne fondata la Banca d’Italia, sorta in conseguenza della
fusione forzosa tra la Banca Romana, sull’orlo della bancarotta, le due banche di emissione toscane – la
Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito per le Industrie e il Commercio – e la Banca
nazionale del Regno.
Dopo gli attriti con Parigi, il governo italiano, guidato da Crispi, si rivolse a Bismarck e alla
Germania in cerca di aiuti e di nuovi capitali. Ai primi contatti, occorsi nell’aprile del 1889, seguì la
formazione di nuove banche con capitali tedeschi, che iniziò nel 1893. Venne così formata la Banca
Commerciale Italiana, con fondi che provenivano dalla Creditansalt austriaca, oltre che da un consorzio
di banche tedesche e svizzere. Si assistette, inoltre, alla riorganizzazione della Banca Generale del
Credito Italiano, avvenuta grazie a investitori milanesi, tedeschi, belgi e svizzeri.
La Creditansalt, insieme ad altre cinque banche tedesche – la Darmstadter, la Berliner HandelsGesellschaft, la Detusche Bank, la Diskontogesellschaft e la Bleichroder – , possedevano tra il 10,3 e il
12,3% del capitale azionario ciascuna. La partecipazione italiana, molto bassa all’inizio, crebbe tuttavia
al 17% già nel 1894, aumentando ancora nel 1897 quando la Banca acquisì il Credito Industriale di
Torino. Nel 1899, a seguito del trattato commerciale del 1898 che poneva fine alla guerra tariffaria italofrancese, la Paribas acquisì il 28,3% del capitale.
27
Durante il primo decennio del Novecento, il Banco di Roma, la Banca Commerciale e il Credito
Italiano – i tre maggiori istituti di credito del paese – cominciarono ad investire nel settore immobiliare,
nei prestiti all’estero, in particolare nei paesi dell’Africa settentrionale, iniziando contestualmente a
finanziare l’industria del paese, con particolare attenzione ai settori dell’industria elettrica e chimica. Dal
1896 al 1907, la crescita dell’industria italiana fu rapida e consistente. Tuttavia, la speculazione a cui
molte società industriali rivolsero i proprio investimenti tra il 1901 e il 1905 fece salire i prezzi delle
azioni di impresi che, nella maggior parte dei casi, erano del tutto fittizie. Il mercato azionario, già
instabile tra il 1905 e il 1906, crollò definitivamente nella primavera del 1907.
La Francia
Il declino con cui si è soliti indicare la situazione di Parigi e della Francia come centro finanziario
internazionale, per quanto corretta, è sostanzialmente relativa alla parallela crescita di altri paesi, come
Germania e Stati Uniti, che conquistarono nell’ultimo quarto dell’Ottocento i primi posti tra i paesi più
industrializzati all’inseguimento della Gran Bretagna.
Parigi, tuttavia, rimaneva ancora un centro finanziario di grande importanza nell’Europa
continentale. Una delle caratteristiche principali del sistema bancario francese era la presenza di grandi
banche, sorte all’inizio del Secondo impero come banche universali con una grande presenza nelle
industrie, sia in Francia che all’estero. Tale predisposizione, tuttavia, cominciò ad attenuarsi già dagli
anni Sessanta e Settanta dell’Ottocento, quando banche come il Crédit Lyonnais cominciarono a
dedicarsi ai prestiti commerciali a breve termine e alla speculazione in obbligazioni estere. Quest’ultimo
punto è strettamente legato alle rentes emesse dal governo di Adolphe Thiers tra il 1871 e il 1872 per
pagare gli indennizzi contrattati con la Germania in seguito alla sconfitta nella guerra franco-prussiana.
Perseguendo grandi profitti, molte banche passarono dagli investimenti industriali alla speculazione sui
titoli e, successivamente, a quella sui titoli del debito pubblico estero.
Dagli anni Ottanta fino al 1914, le grandi banche francesi divennero molto attive nelle operazioni
internazionali, partecipando regolarmente ai sindacati di emissione e cominciando ad erodere il potere
che le grandi banche private, e i Rothschild in particolare, avevano in questo settore. La capacità di
collocamento dei prestiti di queste banche erano eccezionali, in quanto potevano contare su una
capillare rete di sportelli in tutto il paese.
Per quanto le grandi banche cominciassero, come detto, ad erodere il predominio della cosiddetta
haute banque francese, quest’ultima rimase importante per tutto il periodo fino alla Prima guerra
mondiale. Alla fine dell’Ottocento si ritiene facessero parte di questa categoria otto case bancarie, di cui
quella dei Rothschild era, per tradizione, importanza e capitale, certamente la più importante. Quando
nel 1905 essa fu ristrutturata in seguito alla morte di Alphonse de Rothschild e allo scioglimento, datato
1904, dell’associazione tra i diversi rami europei della famiglia, il suo capital fu fissato in 50 milioni di
franchi. Tuttavia, la contabilità interna suggerisce che la casa parigina avesse avuto, tra il 1874 e il 194,
attività finanziarie per un totale di 500 o 600 milioni di franchi.
La concorrenza delle nuove banche anonime aveva fatto adottare ai Rothschild francesi un
atteggiamento cauto e difensivo. Tuttavia, nel settore dei prestiti agli Stati, i Rothschild rimasero ai
vertici del sistema fino al 1914, grazie alla loro capillare rete di relazioni e conoscenze. Nonostante ciò,
essi furono costretti a scendere a patti con le grandi banche emergenti, concedendo loro una parte
sempre più consistente del settore. Un chiaro esempio di ciò furono le operazioni finanziari per i
prestiti russi, i quali dal 1888 furono condivisi con la Paribas (Banque de Paris et des Pays-Bas), che ne
assunse il controllo totale nel 1901. La posizione dei Rothschild sulla piazza di Parigi non deve essere
sottovalutata anche per via delle partecipazioni che, tra gli anni Ottanta e Novanta, essi acquisirono in
giacimenti di metalli non ferrosi e in petrolio. La somma stimata di questi investimenti è, al 1900, di 100
milioni di franchi.
28
La sopracitata Paribas, fondata nel 1872, era tra le nuove banche d’affari che si svilupparono in
Francia nell’ultimo trentennio dell’Ottocento e che arrivarono a ricoprire un ruolo di primaria
importanza all’interno del sistema. La prima generazione di queste banche sorse a partire dal 1870, con
ulteriori ondate di fondazione nel 1878 e nel 1882. Dopo un periodo iniziale di rodaggio, caratterizzato
dall’acquisto di titoli nel settore della siderurgia, dei trasporti, del gas e dell’elettricità, proprio la Paribas
fu protagonista di un’eccezionale crescita durante la Belle époque, con un aumento dell’attivo da 277 a
716 milioni di franchi tra il 1902 e il 1912. Questa crescita si legò in particolar modo al ruolo di
protagonista che la banca assunse nel settore dei prestiti ai governi stranieri, del quale rappresentò il
vertice insieme al Crédit Lyonnais in particolar modo dal 1901 al 1914. Parallelamente, proseguiva
l’attività di emissione di titoli di imprese private, generalmente connesse con l’acquisizione di
partecipazioni al capitale di queste società e del collocamento di propri rappresentanti nei consigli di
amministrazione,
Le banche francesi erano anche molto attive all’estero, anche se non quanto le proprie omologhe
britanniche, in special modo in conseguenza alla minore presenza francese nel mondo. Nel 1914, si
contavano 555 filiali estere complessive per tutte le banche francesi, ovvero circa un terzo di quelle
inglesi. Tuttavia, vi erano alcune banche estremamente importanti in questo numero, come ad esempio
la Imperial Ottoman Bank e la Banque de l’Indochine, entrambe con privilegio di emissione della
moneta locale.
Ancora a fine Ottocento e fino alla Prima guerra mondiale, il prestigio francese e parigino era
connesso all’importanza della Borsa di Parigi. Ancora nel 1913, per dimensioni calcolate sul valore
nominale dei titoli quotati, Parigi contava un totale di 6,2 miliardi di sterline, a grande distanza dalla
Borsa di Londra, sempre prima con 11,3 miliardi di sterline, e poco sopra le emergenti piazze di New
York e Berlino, entrambi con 5,3 miliardi di sterline. La Borsa di Parigi era comunque una delle più
internazionalizzate del mondo, tanto quanto quella di Londra, in quanto più della metà dei titoli
ufficialmente quotati erano titoli esteri. Per quanto riguarda le transazioni, invece, il volume era
decisamente inferiore non solo a Londra, ma anche alla Borsa di New York.
Fino alla Prima guerra mondiale la Borsa di Parigi conservò la sua peculiare organizzazione duale.
Da una parte vi era il parquet, ovvero il mercato ufficiale dove gli operatori erano nominati dal governo
ed erano istituzionalmente limitati – essi erano, ad esempio, ottanta dopo la riforma del 1898 –.
Parallelamente vi era un mercato libero, la cosiddetta coulisse, aperto a chiunque e decisamente più
dinamica del parquet, che rimaneva tuttavia il mercato più importante, con chiare garanzie vista la sua
natura pubblica.
I due mercati si trovarono numerose volte in contrasto tra loro, in particolar modo questo avvenne
durante gli anni Settanta in relazione al collocamento dei prestiti nazionali per pagare le indennità di
guerra alla Germania. Il parquet chiese a più riprese l’abolizione di quello che definiva come un mercato
illegale, mentre la coulisse chiedeva al governo l’abolizione del monopolio degli agenti di cambio. Nel
1892 si arrivò ad un primo, precario accordo, che prevedeva che le obbligazione russe venissero trattate
al parquet mentre quelle dei titoli spagnoli, portoghesi, ungheresi, turchi e egiziani dalla coulisse. La
soluzione definitiva arrivò nel 1898, quando alla coulisse fu permesso di trattare solamente i titoli non
ammessi alla quotazione ufficiale, limitando notevolmente il giro di affari.
Infine, la Banca di Francia continuò a ricoprire un ruolo essenziale nel mantenere comunque alto il
prestigio di Parigi sul mercato internazionale. Diversamente dalla Banca d’Inghilterra, la Banca di
Francia disponeva di immense riserve auree, le maggiori d’Europa dopo quelle russe.
29
4. La mobilità dei capitali (1870-1913)
L’allargamento del mercato mondiale creò enormi possibilità di investimento per i capitali del
centro del sistema, le cui esportazioni verso tutte le periferie del globo, nell’ultimo quarto
dell’Ottocento, assunsero dimensioni mai conosciute in precedenza. Questa mobilità internazionale dei
capitali ruppe la stretta connessione tra risparmio e investimenti nazionali, portando la domanda di
investimenti a ricoprire una funzione chiave per lo sviluppo economico.
Storicamente, la domanda di capitali reali e di investimenti è stata determinata principalmente da
tre elementi: il primo è costituito dalla ricerca del progresso tecnico al fine di aumentare la produttività
attraverso un miglioramento tecnologico delle attrezzature e degli strumenti utilizzati nella produzione;
il secondo è relativo alla crescita della produzione, la quale esigeva maggiori capitali pur lasciando
invariate le tecniche produttive; infine, il terzo elemento è rappresentato dalla crescita, o dalla
redistribuzione, della forza lavoro, la quale generava la necessità di una maggiore e più efficiente rete di
infrastrutture, in particolar modo ferrovie, porti, ponti e strade. Posto che la crescita della produttività e
della produzione non sono elementi che influiscono fortemente sulla necessità di capitali esteri, in
quanto molti dei paesi che per molto tempo sono stati esportatori di capitali hanno conseguito tassi di
crescita della produttività maggiori a quelli dei paesi importatori, la causa più probabile per l’aumento
della domanda di investimenti tra il 1875 e il 1913 può essere ragionevolmente indicata nella crescita
della popolazione, alla quale si associava tutta una serie di necessità e attività economiche e
imprenditoriali.
Un’attendibile spiegazione per l’ammontare delle esportazioni europee di capitale verso paesi extraeuropei, come quelli dell’America latina e dell’Australia, è quindi connessa alle necessità legate alla
generale espansione delle frontiere, nonché ai bisogni che le potenze europee avevano che i nuovi paesi
producessero le materie prime e i beni alimentari che esse dovevano importare per i consumatori
europei. A tal proposito, quindi, risultava essenziale costruire reti di trasporti, migliorare il rendimento
delle terre ed edificare case per le nuove comunità. Le fluttuazioni rilevate nel periodo in questione nei
livelli delle esportazioni di capitale possono essere, conseguentemente, connesse anche con le
fluttuazioni relative ai flussi migratori a livello globale. È stato rilevato, infatti, che negli anni in cui
questi ultimi erano elevati, cresceva anche il volume degli investimenti di capitali europei, che si
muovevano inseguendo in qualche modo le migrazioni.
Alla base dei movimenti che hanno permesso la grande estensione del mercato dei capitali e gli
investimenti in ogni angolo del globo vi è certamente la rivoluzione nei settori dei trasporti e delle
comunicazioni che cominciò a realizzarsi fin dalla metà dell’Ottocento. Il telegrafo, in particolare, rese
più rapida la trasmissione delle informazioni tra i vari centri finanziari, permettendo quindi una più
facile e veloce integrazione dei mercati dei capitali. L’informazione sui differenziali dei prezzi sono,
infatti, centrali nel determinare l’azione di investimento da parte degli agenti economici. Il primo cavo
sottomarino venne installato, fra Dover e Calais, nel 1851, mentre New York e San Francisco vennero
collegate nel 1864 ed infine, nel 1866, venne messo in funzione il primo cavo che collegava le due
sponde dell’oceano Atlantico.
In precedenza, gli investitori londinesi venivano in possesso delle informazioni circa i prezzi degli
altri centri dall’altra parte dell’oceano in tre settimane. Essi dovevano, quindi, prevedere con in mano
informazioni già vecchie, quale sarebbe stato il prezzo sul mercato straniero di destinazione tre
settimane dopo la loro decisione di inviare capitali. La lentezza del processo faceva quindi calare
inevitabilmente la precisione nelle stime: l’alta incertezza, quindi, portava questi investitori a
intraprendere solamente quelle operazioni che garantivano un’altissima percentuale di successo.
Successivamente al collegamento telegrafico tra l’Europa e le Americhe, invece, il prezzo sui mercati
esteri veniva conosciuto sulle piazze finanziare del vecchio continente in giornata, dando così la
possibilità di decidere dell’investimento con un solo giorno di ritardo sull’ultima informazione nota,
30
aumentando notevolmente la precisione dell’informazione e moltiplicando così le possibilità
d’investimento.
Un altro elemento che è stato ritenuto centrale nello stimolare un’ampia mobilità internazionale dei
capitali è stato il regime di gold standard a cui, nell’ultimo quarto dell’Ottocento, aderirono tutti i
maggiori paesi industriali. Se il Regno Unito tornò alla convertibilità della sterlina nel 1821, dopo il
corso forzoso dichiarato nel 1797 in correlazione con le guerre napoleoniche, il Portogallo vi aderì già
nel 1865. Dopo la sua adozione da parte della Germania dopo il 1871, molti paesi europei seguirono la
stessa scelta e, infine, gli Stati Uniti ripristinarono la convertibilità anche del dollaro nel 1879.
L’adesione ad uno standard monetario mondiale, garantito dalla predominanza dell’economia inglese e
dalla forza e dalla fiducia che essa donava alla sua valuta, la sterlina, divenuta il mezzo di pagamento
degli scambi internazionali, fu certamente un elemento di non secondo piano nel facilitare i movimenti
internazionali di capitale. Tuttavia esso può essere considerato più come una conseguenza, che come
una causa, dell’ampiezza mondiale del mercato. Inoltre esso non basta certamente a spiegare la mobilità
dei capitali e dei commerci, come ben dimostra il caso degli anni tra le due guerre mondiali. Aiutò
certamente il fatto che il periodo che va dal 1871 al 1914 fu un periodo generalmente molto stabile da
un punto di vista politico, nonché sostanzialmente privo di conflitti.
Molteplici ragioni avevano quindi determinato l’unificazione di un grande numero di mercato
nazionale in un unico mercato dei capitali mondiale. I paesi creditori a livello mondiali erano guidati da
due nazioni, il Regno Unito e la Francia, dove i saggi di risparmio si mantennero per tutto il periodo
elevati e costanti, permettendo la disponibilità di capitali necessaria alla loro esportazione.
Contemporaneamente, anche Stati Uniti e Germania, che stavano diventando le maggiori potenze
industriali, cominciavano ad investire all’estero. Tra i paesi in cui la domanda di capitali era più alta
figurano, invece, l’Argentina, per tutto il periodo che va dal 1875 alla Prima guerra mondiale, l’Australia,
in particolar modo tra gli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento, ed infine il Canada, con riferimento
agli anni tra il 1900 e il 1914.
La City di Londra era il cuore del mercato globale dei capitali. Nel 1870, la percentuale di ricchezza
britannica investita all’estero era già del 17%, crescendo fino ad arrivare al 33% nel 1913. Anche la
quota di investimenti all’estero calcolata sul totale dei risparmi nazionali era in forte ascesa: essa
ammontava a circa il 35% fra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta, salendo poi al 47% alla fine degli
anni Ottanta e finendo a pesare per il 53% negli anni che precedettero la Prima guerra mondiale. Per
quanto riguarda la specializzazione geografica, prendendo come campione gli anni che vanno dal 1907
al 1913 che rappresentano l’apice del processo di internazionalizzazione del mercato dei capitali, si nota
che quasi il 70% degli investimenti inglesi erano indirizzati ai territori dell’America del nord,
dell’America latina e dell’Australia, mentre il restante 30% era diviso tra Cina, Giappone, Europa
orientale e Russia. In generale, i territori dell’Impero britannico assorbivano circa il 40% del totale degli
investimenti, di cui la parte maggioritaria era collocata in India e in altre colonie di insediamento di
popolazione bianca, come il Canada, il Sudafrica, l’Australia e la Nuova Zelanda.
L’esportazione del capitale non fu tuttavia un processo continuo e subì anche forti fluttuazioni,
seguendo i cicli economici che si susseguirono in quel periodo. Osservando alcune cifre, ad esempio, si
nota come i flussi di capitale britannico indirizzati verso l’estero ammontavano a 100 milioni di sterline
nel 1872, crollando fino a 8 milioni nel 1878, per poi ricrescere fin ad un nuovo picco di 95 milioni di
sterline nel 1888. Nel decennio successivo gli investimenti calarono nuovamente drasticamente,
arrivando a toccare appena gli 11 milioni di sterline nel 1902, per vivere poi un’ultima vertiginoso
impennata raggiungendo i 218 milioni nel 1913.
Se il Regno Unito faceva la parte del leone, la Francia era saldamente al secondo posto tra i paesi
esportatori di capitali. Fino al 1875 l’obiettivo degli investimenti francesi era stato essenzialmente
limitato all’Europa occidentale e centrale, ma nell’ultimo quarto del secolo essi si diressero sempre più
31
verso l’Europa orientale, l’America latina, l’Asia e le colonie. Il paese che beneficiò maggiormente degli
investimenti provenienti da Parigi fu, in questo periodo, la Russia, che assorbiva da sola il 25% dei
capitali francesi investiti all’estero: quando, tra il 1891 e il 1894, la Russia e la Francia firmarono una
serie di accordi e convenzioni militari che consolidarono un’alleanza costruita essenzialmente in
funzione anti-tedesca, la somma dei prestiti francesi verso San Pietroburgo ammontava, infatti, già a 6
milioni di franchi. Altri paesi privilegiati per i capitali francesi erano, poi, i Balcani, la Scandinavia, ma
anche l’Impero ottomano, dove vennero finanziate le ferrovie di Baghdad e dell’Anatolia, e l’Egitto, che
rappresentavano la destinazione del 60% del totale degli investimenti francesi all’estero. In generale,
infine, la Francia investiva meno della Gran Bretagna nelle proprie colonie, le quali erano per altro
economicamente molto meno rilevanti, raggiungendo tuttavia una quota, tutt’altro che irrilevante, del
13% degli investimenti totali all’estero.
Come accennato in precedenza, anche la Germania e gli Stati Uniti, i paesi in quel periodo
emergenti dal punto di vista industriale, cominciavano ad avere importanti quote del proprio capitale
investite all’estero. Per quanto riguarda la Germania, i capitali venivano investiti sia in Europa che nel
resto del mondo, in particolare nei territori dell’Impero ottomano e dei paesi balcanici da una parte, e
dell’Impero austro-ungarico dall’altra: queste due aree assorbivano rispettivamente il 15% e il 13% dei
capitali tedeschi complessivamente sportati. Gli Stati Uniti, invece, destinavano i propri investimenti
maggiormente ai paesi a loro vicini. I capitali andavano quindi principalmente verso il Canada, a cui
veniva destinato il 24,7% del totale, e verso il Messico, per un 24,3%; seguivano, poi, i paesi
dell’America latina, con una quota del 10,4%, ed infine Cuba e i Caraibi, che assorbivano il 9,6% del
totale esportato.
In Francia gli investimenti esteri erano legati, molto più che in Gran Bretagna, alle necessità di
Stato e di sicurezza nazionale, cosicché i rapporti tra la comunità degli investitori e il governo centrale
erano molto più stretti e costanti. Ad esempio, quando nel 1887 venne rinnovata l’alleanza che legava
l’Impero austro-ungarico, la Germania e l’Italia, le banche francesi vendettero i titoli di Stato italiani per
dirigersi verso l’acquisto dei titoli russi. Quando, alcuni anni dopo, l’Italia si rivolse nuovamente verso la
piazza parigina per ottenere nuovi crediti, i Rothschild, d’accordo con il governo, rifiutarono di
cooperare con il governo italiano. In particolar modo, quindi, dopo il 1870, la Germania fu un luogo
proibito per i capitali francesi, così come l’Impero austro-ungarico che entrò nella Triplice alleanza,
insieme all’Italia, nel 1882.
Anche se non con i livelli francesi, anche nel Regno Unito a volte la politica governativa si
appoggiava o supportava gli interessi degli investitori britannici, con un tetraedro di relazioni che
coinvolgeva il Ministero degli affari esteri, il Tesoro, la Borsa di Londra e la Banca d’Inghilterra, la cui
dirigenza tentava la mediazione tra gli interessi governativi e quelli finanziari. In generale, comunque,
sulla piazza londinese venivano piazzati titoli di Stato coloniali, titoli di Stato stranieri, ferrovie coloniali,
statunitensi e straniere, ed infine azioni di società estere.
32
Flussi internazionali di capitale in percentuale sulla produzione nazionale lorda per un campione di paesi, 1870-1910
Percentuale di investimenti all’estero rispetto al totale del risparmio, (Fonte: O’Rourke, Williamson, 2005)
33
Di converso, le necessità delle industrie nazionali sembravano essere sufficientemente soddisfatte
dai capitali raccolto nei territori di provincia. La preferenza per i finanziamenti di iniziative
imprenditoriale all’estero da parte degli investitori londinesi derivava anche dal fatto che prima del 1914
i dati pubblici relativi alle ditte inglesi erano scarsi e gli azionisti basavano le proprie scelte quasi
esclusivamente sulle proprie conoscenze personali. Sulla piazza di Londra, invece, venivano quotati i
titoli esteri venivano quotati con una grande dovizia di informazioni, paradossalmente più facili da
reperire rispetto a quelle inerenti le aziende che operavano sui territori provinciali del paese,
indirizzando così più risorse in questo settore.
Esportazione di capitale britanniche e investimenti domestici (Fonte: O’Rourke, Williamson, 2005).
Complessivamente, nel periodo considerato, gli investimenti erano costituiti per la maggior parte,
poco meno del 70%, da investimenti di portafoglio, che prendevano la forma di azioni e obbligazioni
emesse sulla piazza londinese da imprese straniere. Per quanto riguarda i capitali britannici, ad esempio,
nel 1913 questo tipo di investimenti rappresentava il 79% del totale, mentre la percentuale saliva
all’85% se si prendono in considerazione esclusivamente i territori dell’Australia e dell’America del
nord. Per quanto riguarda le destinazioni produttive, la grande maggioranza dei capitali andava a
finanziare le infrastrutture: circa il 70%, infatti, fu utilizzato per costruire ferrovie, le quali da sole
assorbivano circa il 41% del totale dei capitali investiti, oltre a porti, fognature, reti telefoniche, miniere
e altri investimenti di pubblica utilità.
Esistevano, tuttavia, anche investimenti di tipo diretto. In questo caso è interessante osservare
come la distribuzione dei due tipi di investimento risulti molto diversa da paese a paese. Ad esempio gli
Stati Uniti costituiscono un caso del tutto particolare, in quanto gli investimenti diretti all’estero
costituivano ben il 75% del totale, una percentuale che, se consideriamo alcuni paesi dell’America latina,
poteva superare anche l’80%. La maggior parte di questi investimenti diretti, che non passavano per il
mercato secondario dei titoli, era costituito da gare d’appalto per l’assegnazione di contratti per
determinate opere che raramente sfociavano in comportamenti di sfruttamento da parte delle società
estere. Un paio di eccezioni a questa norma sono costituite dal monopolio conferito a due società
inglesi in Africa, la British South Africa Company e la Royal Niger Company. LA BSA & Co, ad
esempio, effettivamente operò uno sfruttamento delle risorse in favore dei coloni europei,
espropriando a loro beneficio tutti i territori della Rhodesia meridionale.
34
Altre forme di sfruttamento coloniale si realizzarono anche quando non vi era l’esclusiva
nell’utilizzo di determinate risorse o imprese da parte delle aziende europee. Una prassi comune era
costituita, ad esempio, dal vincolare gli investimenti in un determinato territorio alle esportazioni,
determinando così un ulteriore profitto per il paese esportatore di capitali. Questa pratica era già in uno
nell’Europa continentale. I francesi, ad esempio, erano soliti assicurarsi commesse in cambio della
concessione dei prestiti soprattutto in relazione ai territori dei Balcani e dell’Impero ottomano.
Solitamente un rappresentante della Schneider-Creusot, la più grande azienda francese produttrice di
materiale bellico e di acciaio della regione della Borgogna, o di una qualche banca all’interno del cui
consiglio di amministrazione l’impresa era ben rappresentata, era presente ai negoziati tra la Francia e i
paesi importatori di capitale da Parigi.
Tuttavia, il legame tra prestiti concessi e importazione di materiale non deve essere sopravvalutato.
Numerosi sono, infatti, gli esempi in cui non sussiste questa correlazione. Nel caso di 17 prestiti
accordati da investitori americani ed europei al governo cinese per la costruzione della rete ferroviaria
tra il 1898 e il 1914, la nazionalità del prestatore si dimostrò del tutto irrilevante nella decisione della
concessione degli appalti di costruzione. A riprova di questo, gli Stati Uniti, che detenevano la minor
quota dei prestiti ferroviari cinesi, appena 3 milioni su un totale di 123, erano però il secondo maggior
esportatore di rotaie e materiale rotabile; viceversa la Gran Bretagna, il maggior investitore che deteneva
quasi il 50% del totale del prestito, era penultimo nella classifica delle commesse ricevute.
Una situazione simile si verificò anche nell’America latina. Ad esempio in Argentina, il 75% delle
ferrovie erano di proprietà di investitori inglesi, ma le società britanniche riuscirono ad assicurarsi meno
del 50% delle importazione di attrezzature ferroviarie. Anche i francesi, che detenevano in Brasile quasi
la metà dell’intero sistema ferroviario, esportavano in quel paese una quota di materiale ferroviario più
esigua di quella indirizzata in Argentina.
L’investimento di capitali all’estero, soprattutto quelli indirizzati a finanziare il debito degli Stati,
potevano avere anche notevoli ripercussioni dal punto di vista politico. Se, infatti, un’impresa non
riusciva a far fronte ai pagamenti veniva dichiarato il fallimento, aprendo una procedura legale che
prevedeva anche il carcere per i debitori, se a dichiarare l’impossibilità a pagare il debito era un intero
Stato la faccenda era certamente più problematica per i creditori privati.
Dal 1873 in poi, in conseguenza della depressione economica internazionale, molti Stati in tutto il
mondo dovettero dichiarare l’insolvenza delle proprie obbligazioni. Honduras e Santo Domingo nel
1873; Costa Rica, Liberia e Paraguay nel 1874; Bolivia e Guatemala nel 1875; infine, Perù e Impero
ottomano nel 1876. Nell’ultimo quarto dell’Ottocento si verificarono una molteplicità di casi simili e gli
Stati insolventi vennero sottoposti ad un procedimento affine a quello utilizzato per le aziende. Una
serie di curatori stranieri, nominati in qualità di rappresentanti delle potenze economicamente e
politicamente più importanti, venivano incaricati di gestire una parte degli introiti fiscali, spesso quelli
derivanti dai dazi doganali, al fine di trattenere le entrate necessarie a ripagare i debiti pendenti.
Solitamente le grandi potenze tendevano ad evitare, in questi casi, l’intervento diretto armato. Sono
esistite, tuttavia, eccezioni a questo comportamento, come ad esempio nel caso dell’Egitto, dove era in
ballo anche una questione politicamente e strategicamente rilevante come quella dell’accesso al Canale
di Suez. A partire dalla salita al trono di Ismail Pasha, avvenuta nell’ottobre del 1863, il debito pubblico
egiziano aveva raggiunto dimensioni preoccupanti. I finanziamenti ottenuti in particolar modo da
Londra e Parigi vennero utilizzati soprattutto per la ricostruzione del Cairo, che prendeva come
modello proprio la capitale francese, per aumentare i possedimenti del Khedivè, che raggiunsero la
quota del 20% di tutte le terre coltivabili egiziane, ed infine per costruire ferrovie, una rete telegrafica,
un sistema stradale e numerosi canali d’irrigazione.
35
Con la depressione del 1873 la situazione si fece più problematica. Nel 1876 venne nominata una
commissione internazionale incaricata di mettere sotto controllo alcune entrate tributarie, come quelle
sul tabacco e sul sale, al fine di garantire i prestiti. La curatela era composta da quattro rappresentanti
dei creditori, nominati da Ismail Pasha ma praticamente imposti dalle nazioni che rappresentavano la
fetta maggiore del debito egiziano, ovvero Francia, Gran Bretagna, Italia e Austria-Ungheria. Lo stato
delle finanze egiziane rimase comunque critico ed una Commissione d’inchiesta internazionale,
nominata nel 1878, raccomandò nuove, più drastiche, soluzioni, come il licenziamento degli ufficiali
dell’esercito, la tassazione delle classi elevate e ulteriori limitazione al potere del Khedivè. Ismail Pashà
venne destituito nel 1879, ma il contenzioso tra la commissione internazionale e il Parlamento egiziano
continuò anche negli anni successivi, scatenando, nel 1881, dei sommovimenti popolari nazionalisti che
portarono al governo il colonnello Ahmed Arabi.
A questo punto, dopo le violenze anti-europee di Alessandria d’Egitto del giugno del 1882, gli
inglesi intervennero militarmente, in quanto temevano che i sentimenti nazionalisti che dilagavano in
tutto il paese potessero minacciare il loro accesso al Canale di Suez. Dal 1883, quindi, la nuova
costituzione dava il potere effettivo al Console generale britannico, la cui amministrazione rimase in
carica fino al 1913 con i compiti di regolarizzare il prelievo fiscale, riformare il sistema dei conti
pubblici e controllare la spesa dello Stato. Solo nel 1923 l’Egitto riconquistò, infine, la sua indipendenza
politica.
Una situazione simile si realizzò anche in Grecia, quando il paese ellenico nel 1893 decise
unilateralmente di ridurre il pagamento sugli interesse del debito. Cinque anni dopo, nel 1898, alla
sconfitta della Grecia nella guerra contro l’Impero ottomano, il governo ebbe bisogno di nuovi aiuti
finanziari internazionali, i quali vennero concessi solamente dopo la nomina di una commissione
internazionale, con rappresentanti nominati dalle sei potenze detentrici del debito pubblico greco.
Vennero, per tramite dei commissari, adottate misure per migliorare le finanze della nazione, ponendo
dei limiti ai prestiti che lo Stato poteva contrarre e controllando l’offerta di moneta. Lo scopo di questo
organismo internazionale, quindi, era in pratica quello di garantire alle nazioni creditrici che il bilancio
dello Stato debitore fosse in pareggio, per soddisfare le esigenze degli investitori privati.
La crescita demografica che ebbe luogo a seguito dei flussi migratori nei paesi ricchi di terre
determinò una vistosa crescita nella domanda di capitale di portafoglio mobile a livello internazionale.
L’offerta provenne in particolar modo dalla Gran Bretagna e dalla Francia, nonché, seppur in quantità
minori, dalla Germania e dagli Stati Uniti. Il centro pulsante del flusso dei capitali internazionali era la
piazza finanziaria londinese, la quale aveva accumulato nel corso del secolo precedente le maggiori
connessioni e le più alte competenze in materia, completate dall’essere anche la capitale dell’economia
guida a livello mondiale. Nei paesi riceventi, i capitali venivano investiti, in modo diretto oppure
attraverso il collocamento di azioni e obbligazione sulle piazze finanziare europee con Londra e Parigi
in testa, per la costruzione di ferrovie, ponti, porti, strade e tutte quelle infrastrutture necessarie a dei
paesi con una grande crescita demografica e di recente insediamento europeo. Parallelamente, la
tradizionale attività dei banchieri europei di prestare denaro a governi stranieri andò intensificandosi,
portando con sé tutta una serie di nuove problematiche politico-economiche internazionali.
La mobilità internazionale dei capitali e gli accresciuti volumi dello scambio determinarono
crescenti tensioni e squilibri nei rapporti politico-diplomatici. L’ampio utilizzo di politiche tariffarie
volte alla regolamentazione dello scambio mercantile determinò diverse capacità di risparmio nelle varie
nazioni, le quali furono determinarono le condizioni di base di diverse capacità di investimento in
ragione delle opportunità tecnologiche disponibili. La generazione di nuove tipologie di beni trovava
necessariamente un numero ancora relativamente esiguo di consumatori. La necessità di proteggere gli
investimenti fu ottenuta attraverso tutele definite dai trattati commerciali, i quali, data la cultura coeva,
erano comunque soggetti ad un rischio di cambio sul volume di pagamento. Ad esempio, si pensi al
rapido rovesciamento di fronte avvenuto dall’Italia nei confronti di Francia e Germania. La diversa
36
preferenza costituitasi nei mercati italiani tra beni agricoli e beni industriali portò a far sì che si passasse
dallo scambio con un grande paese agricolo, come la Francia, a scambiare con un grande paese
industriale, come la Germania.
Le tensioni generate sui mercati finanziari, coinvolgendo anche i governi nazionali, assunsero
rapidamente connotazioni politiche, la quale, finendo per determinare condizioni sulla capacità
produttiva delle economie nazionali, a sua volta generava forti sentimenti nell’opinione pubblica. Tutte
queste condizioni finirono per delineare un’atmosfera di conflitto sociale e produttivo tra nazioni, sia
per avere libertà decisionale sulle politiche fiscali, cioè sui beni posseduti, sia per ottenere l’accesso alle
risorse necessarie per la produzione di nuovi beni. L’esito ultimo di tutto ciò sarà la Prima guerra
mondiale.
4. Quadri di approfondimento
4.1. Il Bank Charter Act del 1844 e le lettere del Tesoro
Tra la fine degli anni Trenta e l’inizio degli anni Quaranta dell’Ottocento, vi fu un vivace dibattito
circa il ruolo, le funzioni e i meccanismi della Banca d’Inghilterra e, più in generale, circa il generale
assetto che il sistema bancario avrebbe dovuto possedere per evitare le crisi finanziarie che si erano
ripetute, nel corso degli anni, fin dal ritorno alla convertibilità aurea della sterlina, del 1819.
L’inefficacia dei meccanismi con cui era regolato il sistema venne messa in luce dall’inchiesta
condotta dal Committee on the Bank Issue, tra il 1840 e il 1841, davanti al quale lo stesso John H.
Palmer, governatore della Banca d’Inghilterra tra il 1830 e il 1833, che aveva dato nome alle cosiddette
Palmer Rules nella gestione monetaria, testimoniò in favore di una maggiore regolamentazione del
rapporto tra oro e titoli.
Da questo contesto, caratterizzato dalla disputa tra la Banking School e la Currency School, si arrivò al
Bank Charter Act, che venne presentato al Parlamento inglese attraverso due discorsi del Primo
ministro Robert Peel nel maggio del 1844. Con la legge del 1844, il potere di controllare l’emissione di
moneta veniva demandato interamente allo Stato, lasciando però libera l’attività bancaria. La a tesi che
veniva quindi sostenuta e ricompresa nella nuova legislazione bancaria si opponeva ad una completa
liberalizzazione per le banche private di emettere banconote, per evitare quindi i rischi di
sovraemissione che avevano caratterizzato le crisi finanziarie dal 1825 in poi.
La Banca d’Inghilterra poteva, quindi, emettere banconote basandosi sia sulle proprie riserve auree
che su una quantità fissa di titoli, che ammontavano a 14 milioni di sterline. Il limite alle emissioni era
quindi molto rigido, in quanto la legge stabiliva che esso poteva essere superato solo se le nuove
banconote sarebbero state garantite da una riserva di metallo prezioso pari al 100% del circolante.
Il numero delle banconote, inoltre, poteva essere aumentato nel caso in cui una banca di provincia
con privilegio di emissione fosse fallita o avesse spontaneamente rinunciato all’emissione: in questo
caso i due terzi delle sue banconote potevano essere aggiunti al massimale della Banca d’Inghilterra. Si
favoriva, così, un riassorbimento progressivo delle emissioni delle varie banche provinciali da parte
della Banca d’ Inghilterra. Infine, il Bank Charter Act suddivideva le attività della Banca in due
dipartimenti distinti, per evitare commistioni tra due funzioni che si pensavano diverse: un primo
dipartimento si sarebbe occupato delle emissioni e della gestione delle riserve auree; un secondo,
invece, avrebbe invece gestito le ordinarie funzioni bancarie.
Il punto centrale della normativa stava nella chiarezza dei meccanismi che andava ad istituire. La
Banca d’Inghilterra si vedeva mutilata della discrezionalità nell’emissione di banconote, la quale era ora
37
invece determinata dal flusso di oro che entrava nelle sue casse, aumentando l’emissione all’aumento
delle riserve auree e diminuendo la cartamoneta al calo delle medesime.
Nonostante la nuova normativa venne salutata da molti come una vittoria definitiva, bastarono
pochi anni e nuove tensioni economiche e finanziarie a farne emergere i limiti. Essi erano dovuti
essenzialmente alla rigidità con la quale veniva regolata l’emissione di cartamoneta, che come abbiamo
appena vista era strettamente legata alla quantità di riserve auree. Le banconote era, infatti, divenute
così dei semplici sostituti della moneta metallica, senza una propria identità e senza, quindi,
quell’elasticità necessaria nei momenti di crisi finanziaria.
All’approssimarsi della prima di esse, nel 1847, ovvero solamente tre anni dopo l’approvazione dei
decreti di Peel, la finanza londinese fu attraversata da una grave crisi di liquidità in conseguenza alla
caduta del prezzo del granturco che aveva causato il fallimento di alcune banche di provincia. La grande
richiesta di liquidità che ne seguì cominciò velocemente a prosciugare le riserve della Banca
d’Inghilterra, che nell’estate del 1847 raggiunsero il minimo storico di un milione di sterline.
I dirigenti dell’istituto, quindi, si trovarono di fronte ad un problema che si sarebbe periodicamente
riproposto sullo scenario finanziario inglese: da un lato essi dovevano rendere conto ai propri azionisti,
preoccupati per il drastico calo delle riserve auree e interessati all’adozione di misure funzionali al
mantenimento della solidità patrimoniale della banca; dall’altro lato, però, la Banca subiva anche enormi
pressioni da un mercato bisognoso di liquidità.
La soluzione, in realtà, avrebbe dovuto essere molto semplice, in quanto la legislazione del 1844
regolava precisamente quale dovesse essere il comportamento dei dirigenti della Banca d’Inghilterra,
anche in casi di estrema tensione finanziaria come quello che si stava verificando nell’estate del 1847.
Se, tuttavia, la Banca avesse seguito alla lettera le istruzione della normativa di Peel, la stabilità della City
e della sterlina sarebbe stata messa seriamente in pericolo, con danni per tutto il sistema finanziario,
economico e commerciale dell’intero paese.
Invece di modificare la legge, però, il potere esecutivo, nella persona di Lord Halifax, Cancelliere
dello Scacchiere, decise di agire in modo informale, assumendo sulle proprie spalle la responsabilità di
sospendere le restrizioni imposte dal Bank Charter Act all’emissione. Con una lettera del 25 ottobre del
1847, quindi, la Banca d’Inghilterra veniva invitata a scontare lettere di credito e altri titoli ad un tasso di
sconto minimo dell’8% senza preoccuparsi delle conseguenze. L’istituto londinese, quindi, veniva
praticamente invitato a prestare liberamente denaro per andare incontro alle necessità degli operatori
finanziari garantendo che, qualora la legge fosse stata infranta, il governo avrebbe provveduto a far
approvare una sanatoria dal Parlamento, sollevando quindi i dirigenti della Banca da ogni conseguenza
penale.
Il successo dell’iniziativa andò al di là delle più rosee prospettive. Il solo annuncio del contenuto di
questa lettera bastò, nel giro di poche ore, a calmare le tensioni. Di conseguenza, la circolazione di
banconote della Banca d’Inghilterra rimase, in ultima istanza, al di sotto dei limiti imposti dalla legge e
la sanatoria parlamentare promessa dal governo in caso di necessità divenne assolutamente superflua.
La medesima politica venne messa in campo sia nel 1857 che nel 1866, conseguendo, in entrambi i casi,
risultati soddisfacenti, anche se nel 1857 l’annuncio della lettera non scongiurò del tutto un eccesso di
circolazione, la quale si mantenne tuttavia in livelli accettabili ancorché oltre il limite imposto. Il
governo, tuttavia, prestò fede alle proprie parole facendo approvare dal Parlamento una sanatoria per i
dirigenti della Banca d’Inghilterra.
4.2. La clausola della nazione favorita: il trattato Cobdein-Chevalier e la liberalizzazione dei commerci
38
Nel periodo precedente al 1860, nell’Europa continentale solamente alcuni piccoli paesi, come Paesi
Bassi, Danimarca, Portogallo e Svizzera, che rappresentavano non più del 5% dell’intera popolazione
europa, avevano adottato una politica liberista. Il punto di svolta del periodo è certamente il trattato di
libero scambio anglo-francese di Cobden-Chevalier che prende il nome dai nomi dei due maggiori
promotori.
Richard Cobden, nato nel 1804 e capo della delegazione inglese nelle trattative che iniziarono
ufficialmente nell’ottobre del 1859, si era già distinto per le sue idee libero-scambiste fin dal 1838,
quando fondò la Anti-Corn Laws League, che si poneva il preciso obiettivo di abolire i dazi doganali sul
grano risalenti alle guerre napoleoniche. Michel Chevalier, invece, nato nel 1806, era un ingegnere
seguace delle idee di Saint-Simon: nel 1841 divenne professore di politica economica al Collége de
France, mentre fu eletto deputato per il dipartimento di Aveyron quattro anni dopo, diventando infine
senatore nel 1860.
Il 5 gennaio del 1860, Napoleone III, in una lettera inviata al Ministre d’Etat e pubblicata poi il 15
dello stesso mese sul «Moniteur», espose un vasto programma di riforme liberali, all’interno del quale
trova largo spazio l’idea dell’imperatore francese di sottoscrivere una serie di trattati commerciali. Fu
proprio quella lettera che, in qualche modo, rese pubbliche le trattative con gli inglesi. Queste aveva
raggiunto un punto di svolta, come detto, nell’ottobre del 1859, quando Cobden venne ricevuto da
Napoleone III in persona, ma le cui origini possono essere fatte risalire indietro nel tempo fino al 1856,
quando vi fu il primo incontro a Parigi tra Cobden e Chevalier.
Il trattato, firmato il 23 gennaio del 1860, doveva avere una durata decennale. Tuttavia la sua entrata
in vigore fu diluita su un lungo periodo di tempo, con ritmi diversi a seconda dei diversi settori
economici e industriali. Ad esempio l’entrata in vigore del trattato venne stabilita, per il carbone e il
coke, il 1 luglio del 1860 e per l’acciaio e il ferro il 1 ottobre dello stesso anno. Per i manufatti in ferro,
invece, l’accordo entrò in vigore il 31 dicembre 1860; il 1 giugno 1861, per i filati in canapa e lino e,
infine, il 1 ottobre 1861 per tutte le altre tipologie di manufatti.
In conseguenza al trattato, il Regno Unito abolì, o diminuì fortemente, le barriere doganali su molti
prodotti francesi, sopprimendo contestualmente il dazio sul carbone. La Francia abolì tutti i divieti di
importazione, sostituendoli con dazi doganali che non dovevano superare il 30% ad valorem, che
divenne il 25% dopo il 1 ottobre 1864. Anche i dazi sull’esportazione dei vini francesi vennero ridotti
notevolmente, calando di oltre l’80%.
L’aspetto più interessante dell’accordo anglo-francese, che avrebbe comportato i maggiori effetti
commerciali ed economici sul continente europeo negli anni successivi al 1860, è l’inserimento della
clausola della nazione più favorita. La formula, introdotta mediante un accordo complementare tra
Francia e Inghilterra siglato il 16 novembre del 1860, obbligava ciascuno dei due paesi firmatari ad
accordare all’altro ogni privilegio, favore o vantaggio commerciale, o relativo alla navigazione, che esso
aveva già accordato al momento della stipula del trattato, o che avrebbe accordato in futuro, ad un’altra
nazione.
Questa formula non era una novità assoluta nel panorama commerciale europeo: alcuni rari casi si
trovano già nel Trecento, ma essa venne affinata nella sua formulazione contrattuale solamente nei
secoli successivi, cominciando a venire applicata con maggiore frequenza nel corso del Cinquecento e
del Seicento. Tuttavia, in questo periodo sussisteva ancora una forte limitazione: i paesi favoriti
dovevano, infatti, essere nominati esplicitamente, riducendo, così, la portata degli effetti commerciali di
una clausola della nazione più favorita pura.
Quest’ultima venne introdotta a partire dagli inizi del Settecento. Un esempio di ciò è rappresentato
dal trattato stipulato fra l’Inghilterra e la città di Danzica nel 1706, che recitava come segue: «Qualsiasi
39
privilegio riguardante le persone, le navi o le merci straniere nella città di Danzica, che sarà d’ora
innanzi accordato a qualsiasi nazione straniere, sarà pienamente goduto nella stessa maniera dai cittadini
britannici dalle loro navi e dalle loro attività commerciali».
Nel corso della seconda metà del Settecento, molte nazioni ricorsero all’uso della clausola della
nazione più favorita. Tuttavia, alla fine del secolo, gli Stati Uniti cominceranno a invertire questa
tendenza, introducendo la nozione di reciprocità, secondo la quale la clausola della nazione più favorita
viene attivata solamente nel caso in cui il nuovo vantaggio da estendere all’altro paese è stato ottenuto
senza una contropartita. Se, invece, il paese, al fine di acquisire un beneficio commerciale, ha dovuto
concedere qualcosa in cambio, esso dovrà ottenere le medesime concessioni anche dal paese
beneficiario della clausola della nazione più favorita, che viene così ad essere nuovamente limitata.
Ad esempio, nel trattato commerciale tra Francia e Stati Uniti siglato il 6 febbraio del 1778, si legge
che «il Re Cristianissimo e gli Stati Uniti si impegnano ad accordarsi reciprocamente qualsiasi
particolare favore relativo al commercio e alla navigazione concesso ad altre nazioni, senza compenso,
se quella concessione fu fatta gratuitamente, o in cambio dello stesso compenso, se essa fu onerosa».
Questa clausola, che limita fortemente l’azione liberalizzatrice dei commerci della nazione più
favorita, appare in Europa intorno agli anni Trenta dell’Ottocento, per venire poi applicata
sistematicamente in tutti i trattati degli anni che vanno dal 1840 al 1860. Reintroducendo, quindi, la
clausola della nazione più favorita in forma pura, il trattato anglo-francese del 1860 portò ad un
processo di generale abbassamento delle tariffe doganali su scala continentale, in quanto esso fu seguito
da altri trattati, tutti stipulati con la medesima formula, che legarono la Francia agli altri paesi europei.
Il primo fu quello con il Belgio, firmato nel maggio del 1861, al quale seguì, l’agosto dell’anno
successivo, la stipula di un accordo con la Prussia, la quale agiva però in nome dello Zollverein che, dal 1
gennaio del 1834, legava tutti i paesi tedeschi in un’unione doganale di libero scambio. L’accordo
franco-tedesco stabilì una riduzione delle tariffe del 40-80% per gli articoli in cotone, del 25% per il
ferro grezzo, dell’80% per i manufatti in ferro e del 60-80% per i capi in lana.
Negli anni successivi altri paesi europei si legarono alla Francia da trattati di libero scambio,
entrando così nella vasta rete commerciale aperta dai trattati Cobden-Chevalier: l’Italia firmò un
accordo con la Francia nel gennaio del 1863, la Svizzera nel giugno del 1864, la Svezia e la Norvegia nel
febbraio del 1865, le città anseatiche nel marzo dello stesso anno; la Spagna entrò nel giugno del 1865, i
Paesi Bassi nel luglio di quell’anno e l’Austria nel dicembre del 1866; infine, Portogallo e Danimarca
entrarono nell’area di libero-scambio europea per effetto dei trattati che avevano già stipulato negli anni
precedenti con l’Inghilterra. L’unico paese che rimase fuori da questa rete ancora fino all’aprile del 1874
fu la Russia, anche se anche il paese degli Zar promosse, nel 1868, alcune riforme in senso liberista al
suo sistema doganale.
Nello stesso periodo, tra il 1860 e il 1877, si assistette ad una modificazione generale delle politiche
commerciali all’interno dei maggiori paesi europei. I nuovi sistemi tariffari nazionali, che andavano a
regolare le tariffe con i paesi che non facevano parte dei trattati commerciali appena ricordati andarono
a delineare, insieme a questi ultimi, un periodo di generale liberalizzazione dei commerci.
Con la legge del 5 maggio del 1860, implementata da ulteriori decreti nel 1861 e nel 1862, la Francia
soppresse la maggior parte delle tariffe doganali sulle materie prime, mentre, con la legge del 15 giugno
del 1861, i dazi di importazione sui cereali vennero fissati al 3% del valore. La nuova tariffa doganale
del 1869 andò anche oltre, esentando da qualsiasi tipo di barriera doganale quasi tutte le materie prime e
i prodotti agricoli. In Germania, dopo la vittoria nella guerra austro-prussiana del 1866, la Prussia
impose una nuova organizzazione degli stati tedeschi, dalla quale l’Austria venne esclusa, che portò ad
una riorganizzazione del Congresso generale dello Zollverein.
40
Dal 1867 spariva così il diritto di veto degli stati, che portava quindi a prendere le decisioni secondo
un principio di maggioranza assoluta: su 58 voti disponibili in totale, la Prussia ne possedeva ben 17, la
Baviera 6, mentre gli altri 23 stati da 1 a 4 ognuno. Proprio questa nuova tipologia di governo dello
Zollverein approvò, tra il 1868 e il 1870, alcune misure liberiste nelle politiche commerciali, che vennero
però implementate e rese effettive solo con la creazione dell’Impero, avvenuta il 18 gennaio del 1871 in
seguito alla vittoria nella guerra franco-prussiana. Queste nuove politiche portarono alla riduzione, o in
alcuni casi alla totale abolizione, di una molteplicità di dazi tra il 1873 e il 1875, mentre con la legge del
1 gennaio del 1877, la Germania aboliva le tariffe doganali sulla quasi totalità dei manufatti in ferro.
Dopo l’unificazione dell’Italia del 1861, il regime doganale del Regno di Sardegna, che aveva
conosciuto un processo di progressiva liberalizzazione ad opera di Cavour tra il 1851 e il 1859, venne
esteso a tutta la penisola italiana. Questo comportò, soprattutto nel meridione, casi di abbassamento dei
dazi doganali che arrivavano anche all’80%. Il processo continuò con maggior velocità dopo la sigla del
trattato commerciale italo-francese nel gennaio del 1863, che pose l’Italia sulla strada per diventare, alla
metà degli anni Settanta dell’Ottocento, il secondo paese dell’Europa continentale più liberista sotto il
profilo dei dazi doganali.
I casi del Belgio e della Svizzera, infine, ci raccontano di come due piccoli paesi industrializzati
raggiunsero, in questo periodo, una situazione molto vicina al libero scambio integrale. A causa del gran
numero di trattati in cui era coinvolto, le tariffe generali erano diventate in Belgio un’eccezione, dato
che la gran parte del commercio era regolato da dazi speciali derivati da accordi internazionali. La
Svizzera viveva una situazione molto simile: senza alterare la sua tariffa doganale generale, il paese
alpino entrò nell’area di libero commercio attraverso il grande numero di trattati stipulati che
includevano la clausola della nazione più favorita: nel periodo che va dal novembre del 1860 all’agosto
del 1875 furono, infatti, stipulati accordi commerciali con ben 16 paesi europei.
Per concludere, occorre notare che il Regno Unito, che aveva già dazi doganali molto bassi, fin
dall’abolizione delle Corn Laws del 1846, li ridusse ancor di più negli anni successivi al 1860. Le tariffe
sul grano, che erano del 2%, vennero completamente abolite nel 1869, mentre i dazi sull’importazione
dello zucchero vennero dimezzati una prima volta nel 1870 ed una seconda volta nel 1873, per poi
venire infine aboliti del tutto nel 1874.
4.3. La crisi della Baring Brothers
Negli anni Ottanta dell’Ottocento, l’impero dei capitali inglesi impiegati in ogni luogo del mondo
stava trovando un nuovo mercato nel quale cominciarono a concentrarsi sempre più investimenti
provenienti dalla City di Londra: l’Argentina. Un ruolo di primo piano in questo contesto fu giocato
dalla Baring Brothers, una delle merchant bank inglesi più importanti, ricche e prestigiosi che, fin dal
1824, aveva iniziato la sua penetrazione finanziaria nel paese dell’America latina con un prestito di un
milione di sterline a favore delle Province Unite del Rio della Plata, denominazione dei territori che nel
1810 avevano conquistato l’indipendenza dalla Spagna, conservata fino al 1830.
Tuttavia, il prestito del 1824 fu un fallimento quasi totale e occorre attendere il 1866 per avere il
primo sindacato di emissione per conto del governo centrale argentino. Anche questo prestito fu di
dimensione assai modeste, appena 550.000 sterline, e non ebbe certamente un grande successo. La
stessa Baring Brothers dovette infatti sottoscrivere 200.000 sterline per mostrare sicurezza nella stabilità
dell’Argentina e incoraggiare così altri investitori ad entrare in quel mercato. Un nuovo prestito venne
emesse poi nel 1870 per un ammontare complessivo di 2 milioni e 500 mila sterline, mentre nel 1873 vi
fu un’emissione di 2 milioni di sterline, non per il governo centrale, ma per il governo della provincia di
Buenos Aires.
41
Nei decenni che vanno dagli anni Sessanta agli anni Ottanta del secolo, quindi, il Baring ricoprirono
un ruolo fondamentale nel finanziare il debito del governo argentino, ma anche di diverse province e
municipalità. Sempre in quel periodo, però, la banca inglese iniziò anche la sua penetrazione finanziaria
del Banco Provincial de Buenos Aires e della Great Western Railway, entrambe di proprietà dello Stato.
Il vero punto di svolta nel coinvolgimento finanziario della Baring Brothers in Argentina si ebbe
però negli anni tra il 1881 e il 1884. In quel periodo la casa bancaria inglese era forse all’apice della
proprio ricchezza e, come altre case della haute finance londinese, la sua attività principale era quella del
collocamento di prestiti per governi e imprese straniere. Nella prima metà degli anni Ottanta, ad
esempio, i Baring gestirono prestiti a governi e imprese ferroviarie fuori dall’Europa per un ammontare
di 54,500,000 sterline. Di questa enorme cifra, ben 2,049,200 sterline erano state collocate per conto
della provincia di Buenos Aires e altre 1,683,100, in collaborazione con il Comptoir d’Escompte
parigino e con la Paribas francese, verso il governo nazionale argentino.
Nel periodo successivo gli investimenti diretti della Baring Brothers in Argentina, però,
aumentarono ancora di più. Questo avvenne essenzialmente in seguito alla grande espansione
economica che si verificò nel paese Sudamericano dagli anni Ottanta in poi, quando l’Argentina smise
di essere un paese importatore di cereale e le sue esportazioni invece crebbero enormemente, come ad
esempio nel caso della lana, il cui commercio estero aumentò del 500%, o del pellame, che raddoppiò il
volume delle esportazioni.
I capitali per tale crescita vennero, ovviamente, importati dall’estero e in particolar modo dalla Gran
Bretagna, che in quegli anni era il vero banchiere del mondo. Si calcola che, tra il 1885 e il 1890, anno
della crisi dei Baring, essi investirono oltre 20 milioni di sterline in varie attività sul territorio argentino.
Una somma, questa, che rappresentava una percentuale enorme, soprattutto rispetto al passato, sul
totale degli investimenti esteri della casa londinese, il che la esponeva rischiosamente agli eventi politici
ed economici argentini.
L’Argentina quindi divenne una grande importatrice di capitali esteri e la bilancia dei pagamenti non
riusciva ad essere in pareggio. Soprattutto, cominciava, agli inizi degli anni Ottanta, a risultare
difficoltoso per il governo ripagare gli interessi che andavano maturando sul debito contratto nei
decenni precedenti. Agli inizi del 1885, il vice-presidente del governo argentino, Carlos Pellegrini, venne
in Europa a capo di una delegazione incaricata di negoziare nuove linee di credito sulle principali piazze
finanziare europee, per dare all’Argentina la possibilità di ripagare gli interessi sul proprio debito che era
passato dai 25 ai 40 milioni di sterline tra il 1880 e il 1885.
Alla fine Pellegrini tornò in Argentina dopo aver negoziato un prestito di 8,400,000 sterline, raccolto
tra la Baring Brothers, la Paribas, il Comptoir d’Escompte e J.P. Morgan, mettendo come garanzia
un’ipoteca sui dazi doganali. In conseguenza di questa nuova linea di credito al governo, che ora
sembrava aver recuperato la credibilità di far fronte ai propri impegni finanziari internazionali anche in
a fronte del cambio di governo che vi fu nel 1886, quando Miguel Juarez Celman succedette a Julio
Roca, vi fu una crescita esponenziale degli investimenti privati in Argentina, che crebbero dai 45 milioni
di sterline della fine del 1885 a oltre 150 milioni nel 1890.
In questo clima la Baring Brothers abbandonò la sua tradizionale politica di cautela e iniziò a
promuovere e investire in imprese private di pubblica utilità, come la Buenos Ayres Water Supply and
Drainage Company Limited. Questi massicci acquisti di obbligazioni a lungo termine portati avanti da
Lord Ravelstoke, in quel periodo a capo dei Baring, attraverso denaro ottenuto in presto a breve
termine, costituirono il fulcro della crisi della casa bancaria londinese.
Proprio alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento, però, la situazione economica, sociale e politica
interna all’Argentina stava repentinamente cambiando. L’inflazione cresceva infatti a ritmo elevato,
42
andando ad incidere in particolar modo sulla capacità d’acquisto dei lavoratori stipendiati. I sindacati, a
quel punto, cominciarono ad assumere un atteggiamento ostile nei confronti del governo di Juarez
Celman, che tentò una riorganizzazione del proprio esecutivo nell’aprile del 1890, in seguito a tre giorni
di sciopero generale, mettendo a capo del Ministero delle Finanze José E. Uriburu, le cui proposte
politiche vennero però rifiutate.
Nell’ultima settimana di luglio, violente sommosse scoppiarono a Buenos Aires, che costrinsero il
presidente a dimettersi. Il nuovo Ministro delle Finanze, Vincente Lopez, decise di imporre nuovi dazi
doganali, ammettendo contestualmente che le finanze argentine erano in una situazione drammatica e
che il pagamento degli interessi del debito verso i creditori stranieri era a forte rischio.
La rivoluzione argentina determina un crollo del valore delle obbligazioni in mano ai Baring, i quali,
come detto, si trovavano nella particolare situazione di aver concesso crediti a lungo termini e contratto
prestiti a breve cadenza. La crisi di liquidità andava a colpire, così, una delle più antiche, prestigiose e
ricche case bancarie inglesi, che aveva fornito nel corso del tempo innumerevoli direttori e governatori
alla Banca d’Inghilterra e che rischiava, per le sue dimensioni e per i suoi contatti finanziari, di
trascinare tutta la finanza inglese con sé nel baratro della bancarotta.
La prima eco delle difficoltà delle banche inglesi impegnate in Argentina comincia a circolare a
Londra già nel giugno-luglio del 1890. La notizia del coinvolgimento dei Baring, tuttavia, arriva non
prima dell’ottobre dello stesso anno. Bertram Currie, banchiere della Glyn, Mills, Currie & Co., afferma
che la prima notizia delle difficoltà finanziare dei Baring arrivò nella City il 13 ottobre 1890 attraverso
un broker, S. Brunton, che recava un messaggio di Lord Revelstoke in persona, il quale chiedeva grosse
somme di denaro.
In quel momento George Goschen era Cancelliere dello Scacchiere, mentre William Lidderdale era
governatore della Banca d’Inghilterra. In novembre la situazione era ormai disperata e i principali attori
della scena finanziaria londinese cominciavano ad esserne pienamente consapevoli, tanto che lo stesso
Lidderdale affermava che la Banca d’Inghilterra, insieme alle altre grandi case e banche di Londra
avrebbero dovuto unirsi per concedere ai Baring le liquidità necessarie a coprire i propri passivi.
Tra il 14 e il 15 novembre del 1890, il governo e la Banca d’Inghilterra riuscirono a creare un
sindacato di garanzia formato da tutte le grandi case bancarie dell’epoca: Rothschild, Glyn & Co.,
Rapahel, Gibbs, Morgan, Brown, Shiply & Co. e altri aggiunsero liquidità a garanzia e il fondo
raggiunse, in questo modo, la cifra di 18 milioni di sterline, grazie anche ai prestiti in oro che, grazie alla
mediazione di Rothschild, vennero ottenuti dalla Banca di Francia e dalla Banca di Russia coperti dalla
garanzia di nuove emissioni di buoni del Tesoro, i tresaury bills.
Nell’autunno del 1890, quindi, l’intera oligarchia finanziaria della City, formata dai mercantibanchiere e dalla Banca d’Inghilterra, insieme ad un governo che ne era, in larga parte, espressione,
comprese di poter contare solamente sulle proprie risorse per risolvere una crisi che minacciava di far
crollare l’intero sistema del credito e tutti i profitti che erano ad esso collegati.
Conclusioni
1. La competitività nelle modalità mercantili e in quelle di produzione, determinarono nei decenni
centrali dell’Ottocento, differenze nella attuazione di valore aggiunto. A queste scelte si
associarono le modifiche in quelle della regolamentazione e tutela degli investimenti: questi due
insiemi definirono il contesto di un nuovo sistema finanziario, quello industriale.
2. Nel sistema industriale fu la diversa concentrazione di capitale nei settori produttivi e la
43
3.
4.
5.
6.
produttività marginale derivata dagli investimenti a definire i confini tra economie e paesi del
centro e economie e paesi della periferia.
Questi elementi indussero, a partire dal centro, sia la necessità di una tutela del capitale
accumulato, condizione che si traduce prima nelle lettere del Tesoro e poi nel credito di ultima
istanza; sia l’uniformazione delle regole dei mercati, prima attraverso il trattato di CobdeinChevalier, poi con scelte di tipo coloniale.
La sequenza degli investimenti e l’aumento dei volumi della produzione determinarono possibili
vantaggi nella regolamentazione: esse ebbe, nel caso dei cartelli tedeschi, la sua più evidente
rappresentazione.
La corsa verso la prima globalizzazione avvenne così a fronte di crisi degli accordi commerciali
e dell’inasprirsi del nazionalismo.
Il peso della regolamentazione finì col tempo per risultare più determinante della capacità
produttiva medesima. Questa condizione aprì un conflitto istituzionale che sfociò nella Prima
guerra mondiale e nella organizzazione di un nuovo sistema finanziario: quello nazionale.
Letture
-
MOKYR J., La leva della ricchezza. Creatività tecnologica e progresso economico, Bologna, Il Mulino, 1995
MOKYR J., I doni di Atena. Le origini storiche dell’economia della conoscenza, Bologna, Il Mulino, 2004
O’ROURKE, WILLIAMSON, Globalization and History
DE VRIES, J. The Industrious Revolution
44