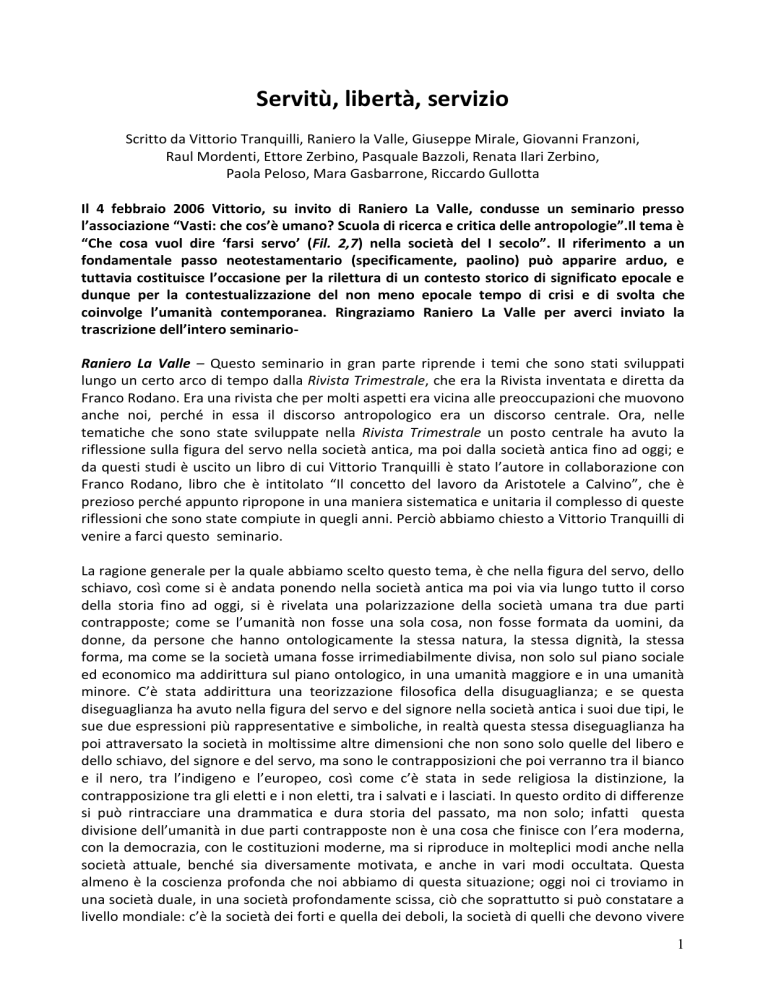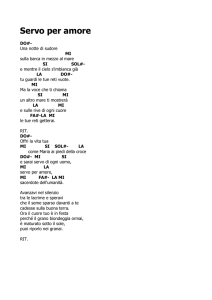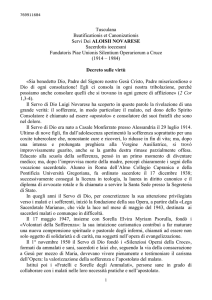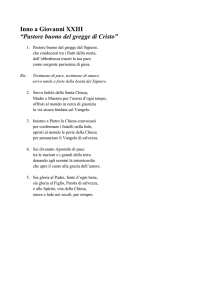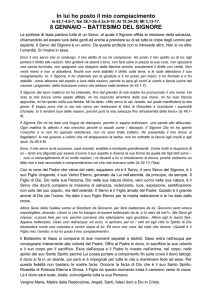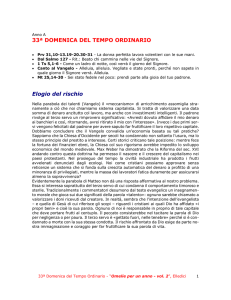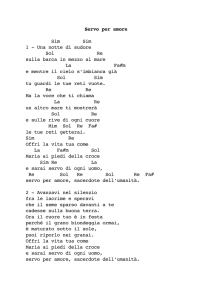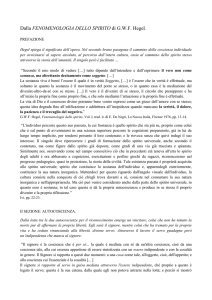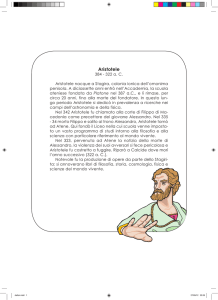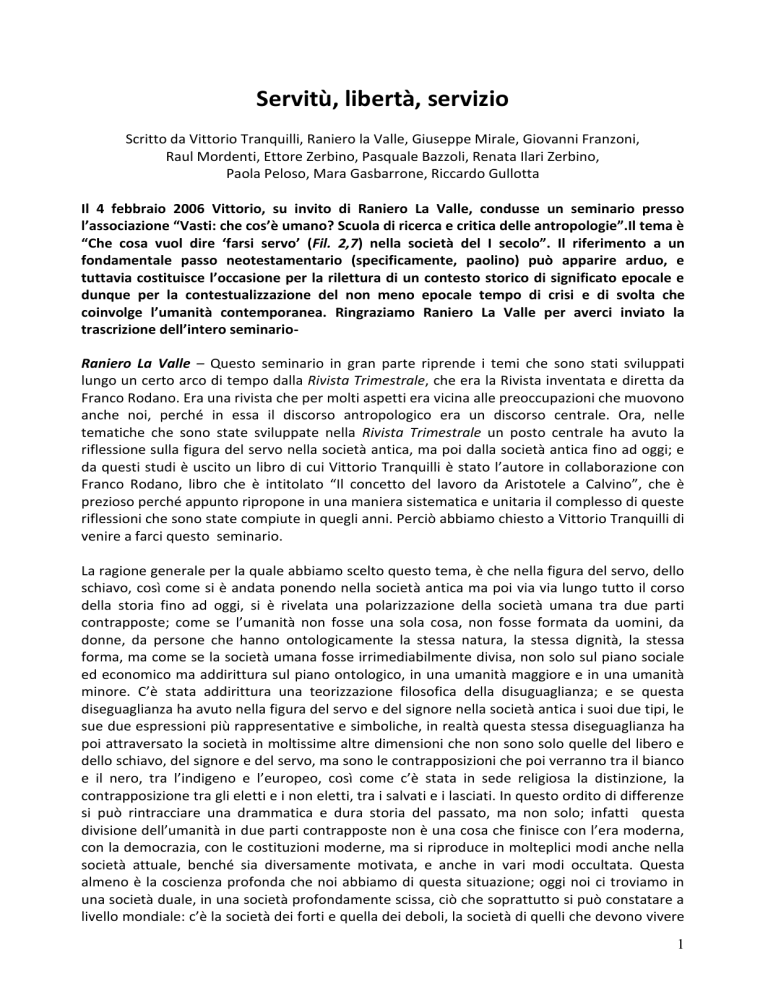
Servitù, libertà, servizio
Scritto da Vittorio Tranquilli, Raniero la Valle, Giuseppe Mirale, Giovanni Franzoni,
Raul Mordenti, Ettore Zerbino, Pasquale Bazzoli, Renata Ilari Zerbino,
Paola Peloso, Mara Gasbarrone, Riccardo Gullotta
Il 4 febbraio 2006 Vittorio, su invito di Raniero La Valle, condusse un seminario presso
l’associazione “Vasti: che cos’è umano? Scuola di ricerca e critica delle antropologie”.Il tema è
“Che cosa vuol dire ‘farsi servo’ (Fil. 2,7) nella società del I secolo”. Il riferimento a un
fondamentale passo neotestamentario (specificamente, paolino) può apparire arduo, e
tuttavia costituisce l’occasione per la rilettura di un contesto storico di significato epocale e
dunque per la contestualizzazione del non meno epocale tempo di crisi e di svolta che
coinvolge l’umanità contemporanea. Ringraziamo Raniero La Valle per averci inviato la
trascrizione dell’intero seminarioRaniero La Valle – Questo seminario in gran parte riprende i temi che sono stati sviluppati
lungo un certo arco di tempo dalla Rivista Trimestrale, che era la Rivista inventata e diretta da
Franco Rodano. Era una rivista che per molti aspetti era vicina alle preoccupazioni che muovono
anche noi, perché in essa il discorso antropologico era un discorso centrale. Ora, nelle
tematiche che sono state sviluppate nella Rivista Trimestrale un posto centrale ha avuto la
riflessione sulla figura del servo nella società antica, ma poi dalla società antica fino ad oggi; e
da questi studi è uscito un libro di cui Vittorio Tranquilli è stato l’autore in collaborazione con
Franco Rodano, libro che è intitolato “Il concetto del lavoro da Aristotele a Calvino”, che è
prezioso perché appunto ripropone in una maniera sistematica e unitaria il complesso di queste
riflessioni che sono state compiute in quegli anni. Perciò abbiamo chiesto a Vittorio Tranquilli di
venire a farci questo seminario.
La ragione generale per la quale abbiamo scelto questo tema, è che nella figura del servo, dello
schiavo, così come si è andata ponendo nella società antica ma poi via via lungo tutto il corso
della storia fino ad oggi, si è rivelata una polarizzazione della società umana tra due parti
contrapposte; come se l’umanità non fosse una sola cosa, non fosse formata da uomini, da
donne, da persone che hanno ontologicamente la stessa natura, la stessa dignità, la stessa
forma, ma come se la società umana fosse irrimediabilmente divisa, non solo sul piano sociale
ed economico ma addirittura sul piano ontologico, in una umanità maggiore e in una umanità
minore. C’è stata addirittura una teorizzazione filosofica della disuguaglianza; e se questa
diseguaglianza ha avuto nella figura del servo e del signore nella società antica i suoi due tipi, le
sue due espressioni più rappresentative e simboliche, in realtà questa stessa diseguaglianza ha
poi attraversato la società in moltissime altre dimensioni che non sono solo quelle del libero e
dello schiavo, del signore e del servo, ma sono le contrapposizioni che poi verranno tra il bianco
e il nero, tra l’indigeno e l’europeo, così come c’è stata in sede religiosa la distinzione, la
contrapposizione tra gli eletti e i non eletti, tra i salvati e i lasciati. In questo ordito di differenze
si può rintracciare una drammatica e dura storia del passato, ma non solo; infatti questa
divisione dell’umanità in due parti contrapposte non è una cosa che finisce con l’era moderna,
con la democrazia, con le costituzioni moderne, ma si riproduce in molteplici modi anche nella
società attuale, benché sia diversamente motivata, e anche in vari modi occultata. Questa
almeno è la coscienza profonda che noi abbiamo di questa situazione; oggi noi ci troviamo in
una società duale, in una società profondamente scissa, ciò che soprattutto si può constatare a
livello mondiale: c’è la società dei forti e quella dei deboli, la società di quelli che devono vivere
1
e di quelli che invece devono morire. Ora questa dicotomia profonda ha il suo modello appunto
nella contrapposizione tra servo e signore; è una dicotomia che ci troviamo di fronte anche oggi
e questo è uno dei grandi temi, anzi io penso il maggiore tema della politica moderna.
Questa è la ragione generale di questo seminario. La ragione particolare è quella a cui
accennavo nella lettera di convocazione di questo incontro, ed è questa: c’è stato un momento
nella storia in cui proprio questa figura del servo, dello schiavo è stata assunta come il peccato
da superare, da risarcire; è il momento in cui è emersa la figura del servo come il non uomo da
rivendicare, da trasformare e da restituire ad una dimensione pienamente umana; questo
momento della storia si ha con la venuta di Gesù, il quale come tutti sanno è professato come il
Verbo incarnato; è noto il discorso dell’incarnazione, il Verbo che si fa uomo e così via; però
dentro questa nozione che è di cognizione comune, c’è un aspetto che è quasi sempre
dimenticato o trascurato o occultato, e cioè che questa incarnazione, questo farsi uomo del
Verbo non avviene in un uomo generico, avviene in un uomo storico, che non è solo, come
volentieri oggi si ricorda, un palestinese del I° secolo: in modo specifico questa incarnazione
avviene nella forma del servo; essa, così come ci viene trasmessa dai testi della fede rivelata, è
una incarnazione nella figura del servo. Questa è una cosa che viene espressa in molti modi
nella Scrittura, nel modo più forte nella lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 2, laddove appunto
si dice che il Cristo pur essendo nella forma di Dio, “en morphē Theoū”, non tenne per sé come
se fosse una rapina l’essere uguale a Dio ma facendosi simile all’uomo prese la forma del servo,
“morphèn doùlou”; quindi esattamente nello stesso modo in cui il Cristo è nella forma di Dio,
cioè è divino, esattamente in questa stessa forma, detto con le stesse parole, assume “morphèn
doùlou”, cioè la forma del servo; il che non può essere una ridondanza retorica, non può essere
una ridondanza puramente spirituale. Questa cosa però è stata ignorata per secoli nelle grandi
controversie dei concili cristologici; a Nicea, a Efeso, a Costantinopoli primo, la reminescenza di
questo testo di Paolo, di questo essere entrato il Verbo nella figura del servo non viene mai
citata, tanto è vero che nel simbolo niceno-costantinopolitano che i credenti recitano nella
liturgia, questo accenno al servo assolutamente non c’è; ed è invece proprio nel grande concilio
cristologico per così dire ricapitolativo, che è il concilio di Calcedonia (451), che attraverso una
lettera del Papa Leone Magno ai Padri Conciliari lì riuniti, viene riproposta con forza questa
realtà dell’incarnazione del Verbo nella figura del servo. Ci sono poi altri riscontri biblici: per
esempio l’episodio che viene narrato da Giovanni della lavanda dei piedi, che sostituisce in
Giovanni il racconto dell’istituzione dell’eucarestia che c’è negli altri evangelisti, nei Vangeli
sinottici. In questo episodio della lavanda dei piedi Gesù fa quel gesto che si può considerare un
gesto di umiltà, un gesto di amore e certamente lo è, ma in modo specifico nel gesto della
lavanda dei piedi Gesù compie una cosa che neanche lo schiavo faceva, cioè che neanche lo
schiavo ebreo faceva: lo schiavo ebreo non lavava i piedi al signore, i piedi venivano lavati dagli
schiavi stranieri perché solo a loro era conforme questa forma estrema di umiliazione; ciò è
come dire che in Gesù non c’è solamente il prendere la figura del servo, ma il prendere la figura
del servo e la figura dello straniero. Certamente questo discorso del servo si potrebbe
intendere, come spesso è stato inteso, come un semplice riferimento a una figura classica della
Bibbia: nell’Antico Testamento c’è la figura del servo del Signore; e allora si dice che Gesù è
servo ma non nel senso storico, sociale, concreto in cui il servo è servo nella società palestinese
del I° secolo, ma nel senso che prende la forma del servo per attuare le antiche scritture, le
antiche profezie che parlavano del salvatore di Israele come del servo del Signore; quindi si
tratterebbe di una trasposizione spiritualistica della figura del servo nella figura di Gesù, sicché
essa non avrebbe una sua concretezza, una sua realtà effettiva. Ora contro questa
interpretazione, si deve dire che quando nella Bibbia ebraica, nelle profezie di Isaia, compare
2
questa espressione, “il servo del Signore”, nella traduzione greca dei 70 non si usa mai la parola
“doùlos” che è la parola greca che indica lo schiavo, ma si traduce sempre con la parola “pais”
che significa figlio; quindi il servo del Signore nella Bibbia ebraica è il figlio, il figlio di Dio; e
perciò quando Paolo, che sapeva bene il greco usa la parola “doùlos” e non la parola “pais”
significa che vuol proprio dire il servo, lo schiavo; e allora questa è certamente una cosa da
indagare. Naturalmente questa è una cosa che ha un grande interesse per quelli che hanno
fede, ma credo che abbia interesse anche molto al di là di quelli che hanno fede perché se c’è
questa tradizione nella quale il figlio di Dio prende la forma dello schiavo, è molto importante
sapere se quando si parla dello schiavo se ne parla in un senso generico, allegorico, oppure si
parla dello schiavo nel senso preciso in cui i lettori del greco di Paolo del I° secolo d.C.
intendevano quando leggevano la parola “doùlos”, e non potevano che intendere lo schiavo.
Queste sono le due ragioni, quella generale e quella particolare per cui ci è sembrato
interessante, proprio per procedere nella nostra ricerca sulla giustizia, di capire bene che cosa
voleva dire allora essere servo, essere schiavo; e questa è la ragione per cui abbiamo chiesto a
Vittorio Tranquilli di essere qui con noi. Tali motivazioni precedono l’esposizione di Vittorio
Tranquilli; non gli chiediamo un discorso sulla fede, non gli chiediamo un discorso sulla
cristologia, certamente non è questo il tema del seminario; il tema del seminario è capire cos’è
il servo nella filosofia della Grecia classica, in Aristotele, quindi che cosa era il servo, come
poteva essere inteso il servo nella società del I° secolo; le motivazioni che vi ho detto
precedono la ricerca e ne danno ragione.
Vittorio Tranquilli – Vorrei fare una premessa. Effettivamente Franco Rodano si è occupato
molto di questi temi. In particolare per quanto riguarda questo capitolo 2 versetti dal 5 all’11
dell’epistola ai Filippesi, l’interpretazione di Rodano mi sembra in sostanza collimante con
quella di La Valle. Comunque chi fosse interessato la può andare a leggere quale Franco Rodano
la espose non sulla Rivista Trimestrale ma in un corso di storia del pensiero politico tenuto nel
1968-1969 a un gruppo di giovani del movimento studentesco dell’epoca. Queste lezioni furono
poi riprese e continuate in anni successivi sempre ai giovani del movimento studentesco, e
furono da me sbobinate, trascritte da nastro, e pubblicate in due volumi. Uno di questi volumi si
intitola “Lezioni di storia possibile”: a pag. 82 e seguenti di questo libro potete trovare
l’interpretazione di Rodano a questo passo di San Paolo. Mi pare che sia collimante anche
perché lui insiste poi molto su quell’autem: “fu obbediente fino alla morte, mortem autem
crucis”: dunque non soltanto la morte, ma la morte di croce, che era il supplizio riservato agli
schiavi.
Questo seminario si basa su uno studio di Aristotele, essendo egli il massimo o uno dei massimi
esponenti del pensiero greco; questo studio appunto risale al 1962, primo numero della Rivista
Trimestrale e poi fu continuato in altri numeri. Io qui ora riprendo quello studio, anche se nella
prospettiva indicata da Raniero.
Non credo che in questa sede interessi un’analisi in termini storico-sociali, e magari economici,
dei tratti caratterizzanti il ceto servile nell’ambito specifico della società ebraica del primo
secolo. Quello che interessa qui, credo sia piuttosto cercar di vedere come era inteso e che cosa
era il servo generalmente nell’insieme della società antica, o meglio pre-capitalistica, alla quale
viene dato anche, non a caso, il nome di società signorile: rifacendosi cioè alla figura del
3
signore, dialetticamente antitetica a quella del servo e che quindi immediatamente la implica e
la richiama.
Su un tema di questo genere (che potremmo allora enunciare così: “L’uomo, il signore e il servo
nell’era pre-capitalistica”, e che è un tema di carattere filosofico-antropologico), prendiamo
quindi come paradigma l’antropologia di Aristotele, quale risulta nella “Politica” e nell’”Etica
nicomachea”, utilizzando talvolta, all’occorrenza, i rispettivi commenti di S. Tommaso d’Aquino
(“In libros Politicorum Aristotelis expositio” e “In libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum
expositio”).
La vera “opera dell’uomo”
In questa prospettiva la prima cosa che si deve vedere è come Aristotele definisce l’operazione
tipica; peculiare e distintiva dell’uomo in quanto uomo, in quanto tale; poi dovremo vedere
qual è l’operazione dello schiavo, se è vicina o lontana da questa.
Nel libro I dell’ “Etica Nicomachea” (“Etica a Nicomaco”), Aristotele si domanda che cosa sia il
bene. Ogni determinata operazione o attività umana – osserva – è ordinata a un bene specifico:
ad esempio la medicina alla salute, l’arte militare alla vittoria, l’architettura all’edificazione di
una casa. Questi beni particolari, però, sono desiderati in vista di beni ulteriori. Al di là e al di
sopra di essi, deve esservi un bene fine a se stesso, e sarà questo il bene perfetto.
Vediamo, attraverso alcune brevi citazioni, il percorso logico seguito da Aristotele per definire
questo bene perfetto (mi servo di una traduzione di Laterza del 1957, che non è molto bella
nella forma perché ha voluto essere molto letterale).
«Noi diciamo che è più perfetto il fine che si persegue di per se stesso che non quello che si
persegue per altro motivo; (diciamo inoltre) che ciò che non è mai scelto in vista di altro è più
perfetto dei beni scelti contemporaneamente per se stessi e per altre cose; insomma il bene
perfetto è ciò che deve essere scelto sempre di per sé e mai per altro. Tali caratteristiche sembra
presentare soprattutto la felicità: infatti noi la desideriamo sempre di per se stessa e mai per
qualche altro fine; invece l’onore e il piacere e la ragione e ogni altra virtù li perseguiamo bensì
di per se stessi (infatti, se anche essi dovessero essere privi di ulteriori effetti, noi
desidereremmo ugualmente ciascuno di essi), tuttavia li scegliamo anche in vista della felicità,
immaginando di poter essere felici attraverso questi mezzi. Invece la felicità nessuno la sceglie in
vista di questi altri beni, né, in generale, in vista di qualcosa d’altro. Ma anche
dall’autosufficienza sembrano provenire gli stessi risultati. Il bene perfetto sembra infatti essere
autosufficiente […]. Insomma la felicità appare essere qualcosa di perfetto e di autosufficiente,
essendo il fine delle azioni».
Bisogna dire però – sostiene Aristotele – qualcosa di più preciso sulla natura della felicità, per
identificare il bene supremo con la felicità. A tal fine si deve esaminare quale sia – così
Aristotele testualmente si esprime – l’opera dell’uomo. Proseguo allora nella citazione,
riprendendo però, adesso, la traduzione fatta per San Tommaso, che non sapeva il greco, da
Guglielmo di Moerbeke, che era un suo amico, era il “poenitentiarius” o confessore di vari papi
dell’epoca, il quale appunto si dedicò a tradurre in latino per Tommaso le opere di Aristotele, in
modo che lui poté conoscerle con una certa sicurezza.
4
«Forse che, mentre esistono opere e attività distinte del tessitore e del conciatore, non ve ne
sarà alcuna propria dell’uomo, cosicché quest’ultimo sarà da ritenere ozioso per natura? O al
contrario, come risultano esservi operazioni specifiche dell’occhio, della mano, del piede e di
ogni singolo membro, così dovrà individuarsene una che sia al di sopra di tutte queste e vi
presieda? E quale sarà essa dunque? Il vivere, in verità, è comune anche alle piante, mentre qui
si ricerca l’operazione peculiare dell’uomo. E’ quindi da scartare il processo della nutrizione e
della crescita. Vi è poi la sensibilità, ma anche questa appare comune sia al cavallo, sia al bue, sia
ad ogni altro animale. Non rimane perciò se non l’operazione propria di un essere razionale».
E qui cominciamo a delimitare il campo. Dal parlare dell’ opera dell’uomo, come dell’
operazione essenziale, vera dell’uomo, al parlare, tout court, dell’essenza dell’uomo stesso, il
passo è breve, o meglio non c’è alcun passo da fare: le due cose si identificano. Infatti quanto
riferito sin qui può essere espresso anche, senza difficoltà, in termini di struttura essenziale,
costitutiva, attribuita da Aristotele all’uomo. Di preciso egli configura – così si esprime – un
composto umano formato da tre parti, ovvero – così le chiama – da tre anime: l’anima
vegetativa, l’anima sensitiva, e l’anima razionale, che però non sono anime nel senso di entità
metafisiche, sono dei principi vitali.
Ora, essendo l’anima razionale – essa ed essa sola – quella distintiva ed esclusiva dell’uomo, è
lecito dire che l’uomo è razionalità. Per Aristotele ogni essere è il principio superiore che è in
lui, è quest’essere giunto alla pienezza di se stesso. C’è tutta la questione della potenza all’atto,
etc. Dunque l’uomo è pienamente se stesso solo in quanto razionalità in atto; è su questo
terreno che egli raggiunge la felicità. C’è però da fare un’ulteriore distinzione; razionalità è
usata da Aristotele a due livelli, in due sensi: c’è la razionalità “in senso essenziale, in quanto
cioè trattasi della stessa attività dell’intendere e del ragionare – per usare le parole di San
Tommaso in Libros Eticorum Aristotelis expositio - e questa attività è razionale in via principale
poiché ciò che è in virtù di se medesimo ha sempre preminenza su ciò che è in virtù di altro”;
questa è la razionalità contemplativa, o speculativa (i due termini sono pressoché equivalenti),
tesa unicamente a ricercare il vero, a riflettere sull’ordine del cosmo, per adeguarvisi, riposare
in esso, godere di esso. A questo tipo di razionalità si addice propriamente il termine di
intelletto. E poi c’è la razionalità che presiede alle altre attività del composto umano, presiede
ad una retta vita delle passioni, dell’anima sensibile e presiede alle attività del corpo, dell’anima
corporea, e questa è la razionalità pratica tesa a regolare i comportamenti dell’uomo
nell’insieme della sua composita struttura. La virtù che corrisponde alla prima delle due
razionalità, quella che rimane in se stessa ed è rivolta alle operazioni puramente intellettuali, è
la virtù della sapienza, mentre quella che corrisponde alle operazioni dell’anima razionale, in
quanto rivolta al di sotto di sé, al resto del composto umano, è la virtù della prudenza.
Ora, fra il primo e il secondo tipo di razionalità, quale sarà “più alto” – stante il modo
aristotelico di argomentare - se non il primo? Si tratta della razionalità tesa alla ricerca del vero,
tesa a riflettere, come ho detto, sull’ordine del cosmo, a riflettere – dice testualmente il filosofo
– a riflettere sulle cose come esse sono e come non possono non essere, non possono essere
diverse da come esse sono. L’operazione del sapiente, l’operazione secondo l’intelletto, è
adeguarsi all’ordine del cosmo, è riconoscere queste cose che non possono essere diverse da
come sono. Ed è questa operazione quella veramente tipica dell’uomo, l’operazione
contemplativa, speculativa, è il riconoscimento di ciò che è veramente umano ed anche al di
sopra dell’uomo stesso. E’ dunque nell’esercizio della ragione al suo livello supremo, cioè
appunto in quanto “intelletto”, che viene finalmente a identificarsi l’essenza vera dell’uomo, la
sua compiutezza, dunque la sua felicità.
5
Qui mi dovete consentire una citazione di una certa lunghezza, che credo molto utile per capire
meglio questo punto, come è necessario per proseguire il discorso sul tema che ci interessa
(cito l’ “Etica a Nicomaco” sempre sulla base della traduzione latina di Guglielmo di Moerbeke).
«L’attività più eccellente e fonte di felicità più vera, è certo quella della parte migliore che è in
noi […]. Se la felicità risiede in un’operazione conforme a virtù, è logico che si tratti della virtù
superiore, propria di ciò che nell’uomo vi è di più alto […], tale cioè da possedere l’intelligenza
delle cose buone e divine, essendo o divino esso stesso, o comunque il principio più divino che è
in noi: precisamente nell’operazione di questo principio, nell’operazione conforme alla virtù che
ad esso presiede [individuata da Aristotele nella sapienza], sta dunque la felicità perfetta.
Si tratta precisamente dell’attività speculativa. Questa infatti è l’attività più alta, poiché
l’intelletto è in noi il principio superiore e riguarda le cose più eccelse fra quelle passibili di
conoscenza. Ed è anche l’attività più continua: possiamo infatti contemplare con una continuità
maggiore di quella consentita da qualunque altra attività. D’altra parte, stimiamo che il diletto
sia carattere essenziale della felicità; ora, fra tutte le attività conformi a virtù, quella secondo
sapienza è certo la più dilettevole: ineriscono infatti alla filosofia piaceri mirabili nella loro
purezza e solidità […]. L’autosufficienza, poi, è propria soprattutto dell’attività speculativa. Se
infatti tanto il sapiente quanto il giusto e ogni altro hanno bisogno delle cose necessarie per
vivere, tuttavia, assicurate queste ultime, il giusto avrà ancora bisogno di coloro verso i quali
dimostrarsi tale, e analogamente può dirsi del temperato, del forte e di chi viva secondo le altre
varie virtù; il sapiente, invece, può contemplare rimanendo solo con se stesso, e quanto più è
sapiente, tanto più lo può. Gli gioverà forse avere dei collaboratori, nondimeno è del tutto
autosufficiente.
Sola, poi, fra tutte le attività umane, la sapienza è amata per se stessa. Null’altro infatti ne
deriva all’infuori dello speculare, mentre dalle attività pratiche ci attendiamo qualcosa, più o
meno grande, al di là di esse. Altro carattere della felicità è inoltre quello della libertà da scopi o
preoccupazioni estrinseci. Ora, le altre attività non possiedono tale carattere, ma tendono a
qualche fine estrinseco e quindi non sono volute per se stesse. L’operazione dell’intelletto,
invece, essendo puramente speculativa, non ricerca alcun fine fuori di sé, ma è fonte essa stessa
di una felicità che, rimanendo in essa, la intensifica. Perciò sia l’autosufficienza, sia la libertà da
tutto il resto, sia l’assenza di ogni preoccupazione, sia l’umana compiutezza, sia qualunque altro
carattere proprio della beatitudine, sono tutti inerenti a questa operazione […].
Certo, una vita dedita a tale operazione sarà superiore alla normale misura umana, poiché sarà
conforme, più che all’uomo nell’insieme della sua composita struttura, a quella scintilla divina di
cui lo rende partecipe. Infatti, quanto il superiore principio intellettuale si eleva al di sopra del
composto umano, tanto l’operazione speculativa si distingue dalle attività conformi a ogni altra
virtù. Come, cioè, l’intelletto è principio divino rispetto al complesso dell’uomo, così la vita
conforme a tale principio è divina rispetto alla comune esistenza umana. Ma non bisogna vivere
come consigliano coloro che vogliono gli uomini dediti a cose umane e i mortali a cose mortali;
bisogna invece, per quanto possibile, farsi immortali, cercando in ogni modo di vivere secondo la
nostra parte migliore. Questa invero, pur se di minime dimensioni, sopravvanza di gran lunga
tutte le altre per potenza e pregio; e l’uomo in quanto tale risulta consistere in essa, dal
momento che la parte superiore è quella principale.
Ora, conviene scegliere un modo di vivere conforme alla propria vera essenza, e non ad altre
cose […]. Ogni essere si distingue, per natura, in base a ciò che vi è in lui di migliore e di più alto:
per l’uomo, dunque, tale aspetto distintivo sarà la vita secondo intelletto, dato che soprattutto
in questo egli consiste. Perciò chi vivrà in tal modo sarà veramente felice».
6
Individuo e società
“Chi vivrà in tal modo”, dice Aristotele. Ma, appunto, chi vivrà in tal modo? Chi vorrà e potrà
vivere “secondo intelletto”? Bisogna aggiungere un punto interrogativo. Questo pronome chi
già da solo ci fa capire che per Aristotele non è necessario che la “vita secondo intelletto” sia di
tutti. Al contrario, dalle citazioni fatte sopra e dagli stessi caratteri che abbiamo visto attribuiti
alla “operazione speculativa” (l’essere conforme a ciò che nell’uomo “vi è di più alto”, al
“principio divino che è in noi”, l’essere autosufficiente), nonché dai caratteri di chi esercita tale
operazione (questo “sapiente” solitario contemplatore del vero, questo “filosofo” libero da ogni
altro scopo o preoccupazione), da tutto ciò emerge chiaramente che la “vita secondo intelletto”
può essere attinta solo da pochi.
Ma questo non pone, in Aristotele, alcuna difficoltà. Affinché l’ uomo sia realizzato, è sufficiente
che si realizzino, che si “compiano”, che giungano all’operazione umana di vertice, alcuni
individui, anche pochi, anche – al limite – uno solo. Ciò non contraddice affatto – come a prima
vista potrebbe sembrare - il noto assioma aristotelico che l’uomo è animale sociale (o più
precisamente, per attenerci al termine aristotelico, politico). Questa definizione, infatti, va
presa “secondum quid”. Si è già accennato all’uomo aristotelico come “composto” da tre
principi, da tre “anime”: vegetativa, sensitiva, razionale. Ebbene, l’uomo è “sociale” secondo i
primi due principi e secondo quella “parte” del terzo, quell’aspetto o momento della
razionalità, il cui compito è di disciplinare e regolare gli altri due in maniera “prudente”. E’
proprio la virtù della “prudenza” quella che presiede all’esplicarsi di questo momento inferiore,
“pratico” della razionalità, così come a quello superiore, “intellettivo”, presiede la “sapienza”.
E allora su questo terreno - vita vegetativa, vita sensitiva e vita razionale rivolta alla pratica
(cioè su tutto ciò che non è intellettuale, su tutto ciò che sta al di sotto dell’operazione del
sapiente) - le cose si rovesciano. Qui, a questo livello inferiore, occorre veramente che tutti
abbiano il necessario per la vita del corpo (la salute e i beni di sussistenza), che in tutti la vita
affettiva, e insomma le passioni, siano regolate secondo le virtù etiche (giustizia, equità,
temperanza, fortezza, coraggio, altruismo ecc.). In effetti, dopo aver trattato – come abbiamo
visto nelle citazioni precedenti – della vita “secondo intelletto”, conforme alla virtù suprema
della “sapienza”, Aristotele, proseguendo, parla degli altri piani di vita e delle rispettive “virtù”:
«Al secondo posto sono da annoverare le attività conformi a ogni altra virtù […]. Tali sono le
opere secondo giustizia, secondo coraggio, secondo equità negli scambi, il sovvenire alle altrui
necessità, e così via […]. A sua volta, la prudenza [cioè, ricordiamo, la virtù propria dell’ “anima
razionale” in quanto regolatrice della vita sensitiva e vegetativa] è congiunta alle virtù etiche, e
queste a quella, dal momento che i principi della prudenza si manifestano, sul piano etico, come
virtù e la rettitudine etica è tale perché conforme a quei principi. L’una e gli altri sono dunque in
immediato rapporto con le passioni, e perciò con gli elementi del composto umano. Siffatte
virtù, quindi, sono umane […] e del pari umana sarà una vita conforme ad esse, insieme a quel
tanto di felicità che le è inerente. L’operazione speculativa, invece, è separata».
Ed ecco come San Tommaso commenta queste asserzioni di Aristotele:
«Ne discende chiaramente che sia la prudenza, sia le virtù etiche, riguardano gli elementi del
composto umano. Propriamente parlando, dunque, tali virtù sono umane in quanto l’uomo è
costituito anche dal corpo, e in tal senso sarà perciò umana la vita conforme alla prudenza e alle
7
virtù etiche, cioè la vita attiva, con il tipo e grado di felicità che ne conseguono, laddove la vita
contemplativa, specificamente propria dell’intelletto, e la felicità che essa comporta, sono cose a
se stanti e divine».
A questo punto ci domandiamo quale sia, in Aristotele, il rapporto tra l’operazione solitaria o
almeno strettamente elitaria del “filosofo” e la vita sociale, tra la razionalità “contemplativa”“speculativa” e la ragione “pratica”, tra la “sapienza” e la “prudenza” con la sua subordinata
costellazione di virtù “etiche”.
C’è nel cosmo una condizione in cui è presente solo la sfera suprema, di quelle che Aristotele ha
prima enunciato, è presente soltanto la vita intellettuale, del tutto autonoma, a se stante,
sganciata da ogni aspetto pratico sotto qualunque profilo e per qualunque esigenza, quindi
slegata da ogni altra virtù al di là della sola “sapienza”. Però non è una condizione degli uomini,
è degli dei. Aristotele ne parla in questi termini:
«Quali azioni – si legge nell’Etica a Nicomaco - dovremmo attribuire agli dei? Forse quelle
ispirate alla giustizia [nei rapporti economici]? Ma certo gli dei apparirebbero ridicoli se si
dedicassero agli scambi, se dessero pegni, e così via. Ovvero le azioni coraggiose, che li
porterebbero ad affrontare tremendi pericoli per il proprio onore? E se li diremo liberali, a chi
dunque faranno elargizioni? Non si addice loro possedere denaro e altri beni. Se infine li
supporremo temperati, in che senso lo saranno? E non apparirà goffo lodarli perché non cedono
a disordinate concupiscenze?1 In verità, passati in rassegna questi vari aspetti riguardanti le
azioni, essi risultano tutti meschini e indegni degli dei».
Per l’uomo, però, le cose sono diverse. Certo – lo abbiamo visto – gli individui umani dediti alla
contemplazione, alla speculazione, tendono a “farsi immortali”; ma – aggiunge Aristotele – “per
quanto è possibile”. La domanda che poco fa ci siamo posti (quale rapporto tra operazione
speculativa e vita sociale) viene allora a specificarsi così: qual è la condizione e la misura di
questo farsi immortali “per quanto possibile; a quale condizione cioè la suprema operazione
umana – quell’operazione “contemplativa” o “speculativa” in cui l’uomo realizza
compiutamente se stesso – può svolgersi con sufficiente regolarità, continuità, sicurezza?
La risposta è: a condizione che le operazioni degli altri elementi del “composto umano” –
l’elemento “vegetativo” e quello “sensitivo” – si esplichino in modo adeguato e bene ordinato,
sotto la guida della “razionalità” nel suo momento “pratico”. E ciò può avvenire soltanto,
precisamente, nel quadro della società e delle sue istituzioni. La vita sociale è dunque finalizzata
all’operazione solitaria o estremamente elitaria del “sapiente”. In tanto la società assicura a
tutti il nutrimento e la salute del corpo e in tanto essa realizza il corretto comportamento etico
di tutti, in quanto ciò è necessario per mettere i “felici pochi” nelle condizioni migliori per
effettuare la loro specifica e suprema operazione secondo “sapienza”, e quindi perché l’uomo
sia realizzato in quanto uomo.
E’ tuttavia da aggiungere che questa finalizzazione delle operazioni dei due elementi inferiori
del “composto” alla “vera opera dell’uomo”, non ha carattere positivo, ma solo negativo. Voglio
dire che una vita “vegetativa” accettabile e una bene ordinata vita dei sensi, delle emozioni,
delle passioni, non danno all’operazione suprema dell’uomo un contributo diretto, che le porti
a parteciparvi, a incidervi in qualche modo e misura. Abbiamo visto infatti che l’operazione
1
Qui lasciamo stare Omero e l’Iliade perché lì gli dei facevano proprio queste cose.
8
suprema, l’operazione della ragione in quanto “intelletto”, è del tutto “separata”. Una buona
vita “vegetativa” e una vita “sensitiva” ordinata, invece, sono condizioni esterne: sono
necessarie unicamente per tutelare, per garantire, per difendere l’operazione suprema
dell’uomo da qualunque ostacolo, fattore di disturbo, di distrazione, di interruzione, di
dispersività, e insomma – come Aristotele si esprime – da qualunque “impedimento”.
Per svolgere con tutta serenità, continuità e congruenza la sua suprema operazione, il
“sapiente”, non essendo comunque un dio ma un uomo, deve vedersi garantito dalla fame,
dalla miseria, dalla malattia, dall’impeto disordinato delle passioni, da litigiosità fra individui, da
scontri tra gruppi. Fornire ai “felici pochi” questa garanzia è appunto il compito della vita
regolare e bene ordinata di tutti, che si realizza o comunque deve tendere a realizzarsi sul piano
della società.
La famiglia e l’ “opera del servo”
Che cosa c’entra il servo in tutto questo? Il discorso di Aristotele sulla dimensione sociale si
articola secondo le due grandi istituzioni di essa: la famiglia e la polis, ovvero, come oggi
diremmo, lo Stato. La famiglia deve assicurare ciò di cui ha bisogno il corpo; lo Stato, oltre a
sancire definitivamente questa sicurezza, deve disciplinare i cittadini, con l’educazione (in
Grecia, soprattutto ad Atene, a Sparta, l’educazione era soprattutto a livello della polis, dello
Stato) con le leggi e le sanzioni, affinché vivano secondo le varie virtù etiche. Siamo arrivati così
a poter vedere, adesso, quali siano la collocazione e la funzione della figura umana del servo;
umana però – come risulterà – solo in un senso molto riduttivo. Da ora in poi, l’opera di
Aristotele da tenere più presente non sarà più la “Etica a Nicomaco”, ma la “Politica”, ed
essenzialmente il suo libro I. (è lì che è svolta la tematica del servo e della famiglia di cui il servo
è una componente subordinata).
In quale delle due grandi dimensioni e istituzioni sociali - la polis e la famiglia – si colloca il
servo, lo schiavo? Evidentemente, egli, o meglio esso, non partecipa in alcun modo alla vita
della polis, non è e non può essere un soggetto di vita politica, per il semplice motivo che non è
un cittadino ma, appunto, uno schiavo. In effetti – passando per un momento a osservazioni di
carattere descrittivo – il grosso degli schiavi veniva reclutato in occasione di guerre contro
popoli non greci, e dunque barbari: venivano ridotti in servitù i prigionieri catturati in queste
guerre. Scrive Aristotele nella “Politica”:
«E’ giusto che i barbari siano sotto il dominio dei greci, in quanto il barbaro e il servo sono, per
natura, la stessa cosa».
E ancora:
«Si deve utilizzare la guerra per catturare quegli uomini che, sebbene conformati, predisposti
dalla natura per servire, non vogliono essere assoggettati».
(Su questo concetto del servo “per natura” torneremo fra poco).
Esclusa dunque la polis, la figura e la funzione del servo vengono invece a rientrare nella
dimensione e nell’istituzione della famiglia. Evidentemente, però, la famiglia di cui parla
Aristotele non è quella delle nostre società, ma quella esistente ai suoi tempi, e comunque
9
quella che è per lui paradigmatica e da cui, ai suoi occhi, non ci si dovrebbe troppo allontanare.
Faccio questa aggiunta perché già al tempo di Aristotele la famiglia non è solo quella
aristocratico-patriarcale; Atene era già una città mercantile; ma il discorso aristotelico assume
le realtà che più si prestano a un paradigma filosofico, e giunge fino a dire che ciò che non si
presta a questo paradigma sono aggiunte spurie che andrebbero rifiutate. Per esempio lui ce
l’ha moltissimo con i mercanti; i mercanti sono peggio dei servi, ce l’ha con gli artigiani, perché
non sono inquadrabili in uno schema filosofico. Vediamo come questa famiglia aristotelica si
configura nel libro I della “Politica”:
«I primi, fondamentali rapporti che costituiscono la famiglia sono quelli tra il padrone e il servo,
tra il marito e la moglie, tra il padre e i figli, ossia il rapporto dispotico, il rapporto coniugale, il
rapporto procreativo».
Si noti che il rapporto dispotico, il rapporto tra padrone e servo, è messo al primo posto. Infatti
l’ opera del servo – l’insieme delle attività che il servo deve svolgere secondo gli ordini del
“despota” – è basilare affinché la famiglia possa adempiere il suo ruolo subordinatamente
umano, che sta all’infimo gradino del “composto umano”, e cioè quello di dare il nutrimento.
In precedenza abbiamo visto quale è, per Aristotele, la vera opera dell’uomo, identificata con la
suprema attività “intellettuale” del “sapiente”. Ebbene, siamo adesso venuti a parlare dell’
opera del servo. E quale sarà essa mai, se non quell’operazione, antitetica ma dialetticamente
necessaria, che con una parola di uso generale, valida per tutte le epoche e a tutte le latitudini,
si chiama il lavoro?
Su questo termine, lavoro, occorrono però delle precisazioni, perché non è molto aristotelico.
Ai nostri occhi, il lavoro è ordinato alla produzione; il servo aristotelico, invece, è ordinato
essenzialmente all’uso, al consumo. I rispettivi termini greci sono poiésis e krêsis. Poiésis, cui in
latino corrisponde factio, è l’operazione del fare nel senso di trasformare, fabbricare. Krêsis è
invece l’operazione dell’usare, e in latino è in relazione con actio. “Crematistica” è chiamato
infatti, nella “Politica”, il ruolo del capo-famiglia in quanto economo, cioè in quanto
amministratore della famiglia stessa (come si sa, il significato originario di economia era
appunto: l’arte, l’attività di amministrare la famiglia, era la legge della famiglia). Non è detto
che il capo della famiglia debba per forza fare anche l’economo. Se il capo-famiglia poteva
scaricare questo ruolo su altri a lui sottoposti, tanto meglio. Mi sono venute in mente,
preparando questo seminario, le pagine di “Giuseppe in Egitto” dedicate da Thomas Mann alla
figura di Mont-kav: quando Giuseppe si trova nella grande casa, nella grande famiglia di
Peteprê, il “flabellifero alla destra” del faraone, Peteprê non amministrava certo da sé le sue
grandi proprietà, delegava il tutto al suo amministratore che si chiamava Mont-kav; e qui ci
sono delle pagine bellissime di Thomas Mann sul rapporto tra Giuseppe e questo Mont-kav. È
da notare anche un’altra cosa. Finché è rimasta in piedi la società signorile, nell’antichità e fino
a un certo punto del Medio Evo, la borghesia era quella che amministrava; l’opera di economo,
di amministratore, era adempiuta dalla borghesia; quando poi la borghesia ha ucciso il signore,
si è autonomizzata, allora siamo nel capitalismo.
Come ci spiega S. Tommaso nel suo Commento alla “Politica”,
«fattiva è l’operazione attraverso cui viene modificata la materia esteriore, come nel tagliare o
nel bruciare; attiva è invece l’operazione che rimane nel soggetto, in quanto attiene
immediatamente alla sua vita».
10
Ora, si legge nella “Politica” che
«la vita domestica consiste nell’usare, non nel fare».
Che ne è allora della poiésis, della factio, del fare? In realtà questo tipo di operazione non è
escluso dall’ambito familiare; semplicemente è nascosto nelle pieghe della krêsis, è compreso e
implicito nelle operazioni dell’usare, come loro momento interno, subordinato, preparatorio.
Nella famiglia si usano le cose (siano esse oggetti, alimenti ecc.) che o sono state acquistate
fuori, sul mercato, o sono state prodotte entro la famiglia stessa; e in questo secondo caso sarà
stato ovviamente il servo a produrle (lavorando i campi, facendo le cose artigianali ecc.), ma
poiché tale produzione in tanto avviene in quanto è ordinata all’uso familiare, il servo rimane
ascritto essenzialmente alla categoria appunto dell’usare, mentre a quella del fare, del
produrre, è riferito in maniera coperta e sottintesa.
Scrive inequivocabilmente Aristotele nella “Politica”:
«Il servo è ministro di ciò che riguarda l’uso».
In termini moderni, noi diremmo il consumo. E l’organo dell’uso, del consumo, è precisamente
la famiglia. Si legge ancora nella “Politica” questa definizione della famiglia:
«La famiglia è la comunità istituita dalla natura per gli atti di tutti i giorni, quelli che Caronda dice
propri di chi condivide la stessa mensa, ed Epimenide cretese di chi siede alla stessa tavola».
In definitiva, allora, l’ “opera del servo” viene a consistere nell’insieme di quelle azioni che
mediano tra le risorse familiari come sono date in natura o come sono state acquistate, e il
consumo di esse da parte dei membri della famiglia. Tale mediazione si svolge secondo un
processo comprendente varie fasi o momenti: la trasformazione “fattiva” delle risorse naturali
grezze in prodotti consumabili dall’uomo e i vari “servizi” di supporto al consumo vero e
proprio.
Per chiarire ulteriormente attraverso un esempio molto pratico ed elementare, prendiamo il
consumo del pane. Le risorse naturali originarie sono la terra e il seme; occorrerà quindi arare,
seminare, poi mietere, trebbiare, macinare, lievitare, cuocere, insomma produrre il pane. Ma
poi bisognerà ancora servirlo, cioè apparecchiare la tavola, portarvi il pane, affettarlo ecc. Tutte
queste operazioni partono dalla factio e arrivano all’uso, ma sono comprese nel concetto di
uso, di consumo, come il meno nel più, come i momenti della preparazione in quello del
compimento, e mi azzarderei quasi a dire, aristotelicamente, come la “potenza” nell’ ”atto”.
E’ dunque in questo senso ampio, secondo questa successione articolata e complessa di fasi
operative – noi diremmo lavorative – che l’ “opera del servo” s’inquadra nella vita della
famiglia, cioè nel consumo delle “cose necessarie per vivere”, di cui essa è l’organo
istituzionale.
Nella complessiva scala delle operazioni umane, così, l’ “opera del servo” viene a collocarsi
all’infimo posto, esattamente agli antipodi dell’ “opera dell’uomo”. Questa, l’“opera
dell’uomo”, sta al vertice, è l’operazione dell’ “intelletto”, in cui l’uomo realizza compiutamente
se stesso e fa anche un passo più avanti, protendendosi verso il divino. Quella, l’ “opera del
servo”, si colloca nel sottostante “composto umano” e nel gradino inferiore di esso, avendo a
che fare soltanto con i bisogni “vegetativi”.
11
Dunque ora il discorso deve vertere direttamente sulla figura e sulla condizione del servo,
sempre come sono configurate da Aristotele, quindi dall’antichità..
Figura e condizione del servo
In che senso e in che misura, così stando le cose, la figura del servo rientra in quella dell’uomo?
Nel commento di S. Tommaso alla “Politica” c’è del servo questa breve e lapidaria definizione:
«Il servo è strumento animato, attivo, individuo, proprietà altrui, uomo».
È impressionante. Vedete come in questa espressione predicativa il sostantivo sia “strumento”.
Gli altri sono aggettivi. Il servo, cioè, è uno dei vari strumenti della vita familiare, della vita
“vegetativa” dell’uomo. Differisce però dagli altri strumenti per alcune caratteristiche, essendo
uno strumento
1)
animato: a differenza di una zappa, o del forno, o di un piatto, il servo si muove da sé;
2)
attivo: per i motivi già visti la sua operazione, pur avendo aspetti di “fattività”, di poiésis,
rientra essenzialmente nella categoria della “attività”, della krêsis, dell’ uso, del consumo;
3)
individuo: un servo non è in tutto e per tutto uguale a un altro, come un piatto è uguale
a un altro dello stesso servizio;
4)
proprietà altrui: è chiaro che, essendo un mero strumento, il servo è proprietà di chi lo
utilizza, cioè della famiglia. E’ parte del patrimonio familiare ed è specificamente proprietà del
capo-famiglia nella sua figura “dispotica”. Giovano qui alcune citazioni dalla “Politica”:
«La proprietà è l’insieme degli strumenti, e il servo è oggetto animato di proprietà […]. Il servo
non soltanto è sottoposto al padrone, ma gli appartiene completamente […]. Il servo è un uomo
appartenente non a se stesso, ma a un altro, è uomo di un altro».
5)
Infine il servo è anche uomo: il servo è un uomo, ma entro limiti molto ristretti, che sono
posti dalla stessa natura. Scrive Aristotele:
«La natura tende a fare i liberi diversi dai servi anche nel corpo, e lo fornisce a questi robusto,
per i compiti attinenti all’uso delle cose necessarie, a quelli nobile e non idoneo a simili
compiti».
Sono allora servi, e lo sono per natura,
«quanti differiscono dagli altri come il corpo dall’anima, e l’animale dall’uomo».
Così stando le cose, l’operazione del servo consiste
«nell’usare il proprio corpo», eseguendo, «in virtù della propria forza fisica, gli ordini del
padrone». E questa è «la miglior cosa che i servi possano fare», dato che «non possiedono
realmente la ragione, ma solo ne partecipano per quel tanto che essa comunica con la vita
sensibile».
L’ultima frase citata merita qualche precisazione. Tenendo presente la complessiva struttura
del “composto umano”, questa frase di Aristotele è da intendere nel senso che il servo,
ovviamente, è del tutto escluso dall’operazione del principio superiore della razionalità, quello
che è conforme alla virtù della “sapienza” e che presiede all’operazione “intellettuale”, cioè alla
12
“vera opera dell’uomo”. Il servo partecipa invece della razionalità nel suo principio inferiore,
quello che, secondo “prudenza”, presiede alla vita sensibile (e a quella vegetativa); ma vi
partecipa solo limitatamente a ciò che interessa il suo ruolo specifico di “strumento animato”
ecc. Ancora si legge infatti nella “Politica”:
«Intorno ai servi si potrebbe dubitare se, oltre alle virtù inerenti alla loro qualità di organi e
strumenti, giungano a possedere qualche virtù più onorevole, come la temperanza, il coraggio,
la giustizia e simili, ovvero non ne possiedano alcuna al di sopra di quanto attiene alle opere
corporali». Ora, posto che delle varie virtù «ciascuno partecipa nella misura che si richiede
affinché possa adempiere alla propria funzione», e posto che «il servo è strumento per le cose
necessarie», ne deriva con tutta evidenza che «gli occorre poca virtù, tanta quanto basta
affinché non venga meno al suo compito, per incontinenza o per ignavia».
Non deve essere pigro, non si deve ubriacare, ecc.
Radici antropologiche
Questo dunque l’ambito assai ristretto, la misura assai limitata, il senso assai ridotto secondo
cui anche il servo può essere considerato uomo. Ma quali sono le radici antropologiche di tutto
questo discorso?
Il concetto aristotelico di uomo, in definitiva, si divide, si dicotomizza in due operazioni, in due
realtà, in due vere e proprie figure umane molto diverse, il cui rapporto reciproco è dato
soltanto dalla funzionalità strumentale, e bassamente strumentale, dell’una all’altra. Da una
parte la figura dell’uomo realmente tale, dell’uomo che si compie, che si realizza come tale, e
dall’altra la figura del servo, la cui ridottissima umanità è strumentale a questo compimento, a
questa realizzazione dell’uomo, limitatamente alle “cose necessarie”, ai bisogni corporei
dell’uomo stesso.
Per spiegare questa spaccatura Aristotele sostiene – come abbiamo visto – che essa è voluta
dalla natura. In effetti è molto frequente che le posizioni conservatrici invocano la “natura”. Ad
esempio, il capitalismo viene identificato con l’economia in quanto tale, e perciò sarebbe
secondo “natura”. Talvolta si arriva addirittura a invocare l’autorità divina: il monarca assoluto
sarebbe tale per decreto divino; poi, con la rivoluzione borghese, è stato aggiunto: “e per
volontà della Nazione”.
Ci si domanda cosa sia sotteso e coperto da questa dicotomizzazione dell’uomo, che sarebbe
posta dalla natura. Penso sia da ritenere che, in realtà, la spaccatura cominci prima, che
provenga dalla stessa autocoscienza umana propria non solo di Aristotele, ma dell’intera
società antica e pre-borghese, insomma “signorile”; né è facile dire se poi, con l’affermarsi della
società borghese, tale autocoscienza antropologica sia stata davvero superata; Raniero prima
diceva di no, e io sono d’accordo con lui.
Da che cosa è determinato e caratterizzato questo tipo di autocoscienza umana, di
antropologia? Ritengo lecito pensare che alla sua base vi sia una concezione negativa del
lavoro: il lavoro inteso come ponos, come fatica, come penosità, come labor nell’accezione
latina della parola. Lo si vede nella stessa “Genesi”, dove il lavoro - “sudore del volto”, afflitto
13
da “spine e tribolazioni” - è pena del peccato, è parte della condanna divina dei primi
progenitori dopo commesso il peccato originale.
A sua volta, penso che un simile concetto negativo del lavoro discenda dal rifiuto indebito, da
parte dell’uomo, della propria figura di essere limitato, soggetto al limite e a dei limiti. Quella
che non è stata riconosciuta né accettata, più precisamente, è la figura dell’uomo come essere
limitato (alla stregua di tutti gli esseri naturali) e però anche, al tempo medesimo, storico, nel
senso che per lui non è sufficiente accettare il limite, ma deve viverlo in un suo modo peculiare,
e cioè tendendo a spostarlo man mano in avanti, producendo così sviluppo storico. Ora, qual è
l’operazione umana essenziale a questo progressivo spostamento in avanti del limite,
promotore di sviluppo, se non appunto il lavoro?
Se questa è – come ritengo – un’impostazione antropologica corretta, è dato allora capire
meglio da dove derivi quella spaccatura dell’uomo in due figure dai caratteri opposti – in
definitiva, l’uomo vero e l’uomo alienato – accennata poco sopra. Infatti, rifiutata la limitatezza
dell’uomo, considerato il limite in quanto tale come negazione dell’uomo, da una parte si viene
a identificare la vera operazione umana come del tutto sganciata e liberata, appunto, dal limite,
e perciò propria dell’uomo che aspira a quel farsi “simile agli dei”, che si protende verso quella
“beatitudine” meta-umana, di cui abbiamo parlato in precedenza. Dall’altra parte si viene a
ridurre il lavoro al minimo indispensabile, a ciò di cui fisicamente non si può fare a meno, a
quanto è necessario per il sostentamento della parte “vegetativa” del “composto umano”
(anche se lo deve essere, per dirla con S. Tommaso, “secondo la condizione della persona”) e al
tempo stesso si tende a scaricare questo lavoro, il lavoro così ridotto, su una determinata
categoria sociale, quella rappresentata precisamente dalla figura del servo. L’alienazione umana
del servo dunque come condizione basilare dell’autorealizzazione del “sapiente”, del
raggiungimento della sua pienezza da parte dell’uomo.
Questi temi sono stati approfonditi da Franco Rodano nel corso di Storia del pensiero politico
cui accennavo prima, ma nella prima parte del corso di Storia del pensiero politico. Si è data la
buffa circostanza che qualcuno ha tirato fuori dai suoi cassetti, dalle cantine, prima i nastri
riguardanti la seconda parte di quel corso e dopo, quando è stata pubblicata, qualcuno si è
ricordato di darmi pure la prima parte, e allora questa prima parte è stata pubblicata in un
secondo momento dagli Editori Riuniti. In questa prima parte - il volume è intitolato “Lezioni su
servo e signore”, Franco Rodano parla con questi ragazzi, dialoga, e dice:
“Libertà – diceva Madame Roland – quanti delitti si commettono in tuo nome! Abbiamo alle
spalle una storia culturale che assume la libertà come fine a se stessa e ne fa la meta suprema
ed esclusiva; ma servitù e libertà nascono a un parto, anzi, non vi sarebbe mai stata servitù (non
vi sarebbe stata mai cioè proprietà assoluta del lavoro di un uomo da parte di un altro uomo, per
sottrarsi ad una condizione comune, quella del lavorare) se l’uomo non avesse voluto essere
“libero”. È in funzione della libertà intesa come uscita dal limite “naturale” - dunque innanzitutto
dal lavoro - che si ha la fondazione di questa forma sociale di base, della forma signorile
dominante il mondo antico. Il signore è l’essere libero e la sua sussistenza (il suo consumo per
sussistere fisicamente) fuori dal lavoro diviene il fine immediato dell’attività produttiva, affidata
al servo. L’uomo ha evidentemente un bisogno di sussistenza corporea: può questo bisogno
venir definito come naturale? Che valore ha questa parola (la sussistenza corporea)? In realtà
qualunque bisogno dell’uomo non è mai puramente naturale, ossia non può essere riferito
all’uomo stesso in maniera immediata. Se così fosse si avrebbe veramente per l’uomo un livello
di bisogno indistinguibile da quello animale. Ma a veder bene, anche al suo primo gradino, al
14
livello cioè della sussistenza corporea, il bisogno umano è già a carattere storico, ossia mediato
dal lavoro. In altri termini è bisogno di un essere che non si limita a sussistere, ma che, per
sussistere, deve svilupparsi, deve trasformare l’immediatezza del dato naturale (cosa poi, che è
molto marxiana). Ora ammettiamo invece (…) che si concepisca il bisogno primario come
meramente naturale: che se ne abbia cioè un’idea del tipo di quella che è comune a tutta la
cultura accumulatasi fino ad oggi. Se dunque si ha questo concetto naturalistico-animalesco del
bisogno primario, e se quindi (…) si considera il lavoro che serve a soddisfarlo come un’attività
ordinata a un bisogno non veramente umano, allora questa medesima attività non può non
venir configurata dall’uomo come cosa che gli è estranea, che gli è imposta come un limite
iniziale di non-umanità e perciò un iniziale costo che per essere uomini non si deve più pagare”.
E per non pagare questo costo, questo lavoro inteso - dicevamo - come ponos, come labor,
come fatica penosa, essenzialmente perché posto in contraddizione con la libertà, lo si addossa
appunto a quel non-uomo, a quella parvenza di uomo che risulta così chiara dalle formulazioni
aristoteliche sulla condizione e funzione del servo.
Ma allora il servo, questa figura non realmente umana, solo riduttivamente e strumentalmente
umana, sub-umana, questa figura di umanità totalmente alienata, no n è affatto un portato
della natura; è invece il prodotto di una radicale distorsione antropologica, di una travalicante e
“rapinosa” autocoscienza umana e di una conseguente, millenaria prevaricazione sociale.
Raniero La Valle – Ringraziamo Vittorio Tranquilli. Naturalmente i problemi per la discussione
sono molti.
Il primo problema è che ci stiamo occupando qui di una sistemazione filosofica, altamente
drammatica, che risale ad Aristotele e potrebbe sembrare ormai troppo lontana da noi. La
questione è che Aristotele è stato riscoperto nel Medioevo come sommo filosofo, le sue tesi
sono state condivise e proseguite. Ad esempio la tesi di una differenza per natura tra l’uomo e il
servo, sicché addirittura anche il corpo del servo sarebbe dalla natura configurato in modo tale
da potere sobbarcarsi al lavoro, alle fatiche fisiche, mentre invece il corpo del signore, in quanto
esente dal lavoro, sarebbe conformato per degli scopi più nobili, tesi che a noi pare assurda,
arriva fino ad Hegel: infatti era esattamente questo il modo in cui Hegel definiva la differenza
tra gli europei e gli indigeni scoperti in America, proprio su questo piano anche di natura. C’è
una pagina tremenda di Hegel in cui si dice che tutto ciò che appartiene all’America, perfino la
flora, perfino la fauna, è inferiore a quella europea e quindi tanto più sono inferiori gli indigeni
agli europei. E’ un pensiero della disuguaglianza che arriva fino all’apice della cultura
occidentale, quale è appunto l’opera di Hegel, e che non è per nulla trasceso e che poi si
ritroverà anche nell’opera di Croce.
Il secondo problema da sottolineare è come la stessa concezione della società, in queste fonti
della cultura occidentale, è una concezione funzionale alla diseguaglianza, vale a dire tutta la
società è fatta perché una minoranza, una parte di uomini, quelli appunto che sono votati alla
contemplazione, alla speculazione, alla attività intellettiva, possano esercitare questa loro
funzione. La società è fatta perché ai sapienti, a quelli che devono farsi divini, che devono
raggiungere la comunicazione con il divino, si garantiscano la sussistenza, la sicurezza, l’ordine
pubblico, il bene comune per cui possano realizzare questa loro attività. Questi a me sembrano
i motivi dell’attualità di questa ricerca.
15
L’altra cosa da riprendere è naturalmente la definizione del lavoro come opera del servo. Il
lavoro è qualche cosa di disdicevole, si porta addosso una maledizione e per questa ragione non
può essere addossata a chi invece deve dedicarsi all’attività razionale, all’attività intellettiva
superiore; il lavoro deve essere addossato a quella particolare categoria di uomini che sono gli
schiavi, che sono i servi, i quali appunto servono a liberare il signore dalle necessità della vita
fisica e perciò a liberarli dal lavoro. E ne vale la pena, perché appunto l’umanità si possa
realizzare.
E l’ultima cosa è che in questa schematizzazione, non solo c’è l’identificazione dell’uomo
essenzialmente come ragione, come razionalità - che poi appunto è la tradizione del
perfettismo umano di derivazione aristotelica dove l’uomo perfetto è precisamente quello che
esercita la ragione - ma c’è che questa ragione è la più alta operazione dell’uomo che serve in
qualche modo come via di fuga dalla stessa umanità per raggiungere l’identificazione con il
divino, con gli dei, con il cosmo. Quindi, questo vertice dell’uomo che è l’attività razionale, serve
poi per uscire dalla stessa condizione umana e per partecipare della condizione divina. Ebbene,
da ciò invece per definizione i servi sono esclusi. Proprio perché i servi sono coloro a cui è
addossato il lavoro, sono quelli a cui non è destinata l’attività razionale, sono quelli che non
sono votati o adeguati all’attività razionale, essi non sono neanche attesi ad un rapporto con il
divino. Il rapporto con il divino è pregiudizialmente precluso a questi sotto-uomini che sono
strumento di altri uomini, che sono uomini di altri. Ed è esattamente a questo punto che arriva
lo scandalo, che arriva la indicibilità di questo divino che invece entra nella figura del servo. Qui
mi pare che siamo al massimo della contraddizione, rispetto a questa concezione della società
antica e rispetto a questa concezione antropologica che continua ancora oggi. Il massimo del
rovesciamento è che questo servo che pregiudizialmente non è fatto per il divino, viene invece
assunto dal divino come luogo della propria inabitazione nell’umanità e nella terra.
Giuseppe Mirale – Faccio una premessa. Mia madre era greca e io parlavo il greco moderno, il
greco però del popolo, perché in Grecia ci sono state due lingue per molti secoli: il greco puro, e
il greco del popolo. Io parlavo il greco del popolo e non ho mai studiato il greco puro, non sono
mai andato in una scuola greca. Bene, quando arrivo al liceo classico scopro che mi era più
facile capire i vangeli scritti in greco di quanto non capissi il greco classico di Aristotele. Allora a
questo punto mi sono chiesto se si tratta soltanto di una evoluzione, cioè se il greco dei vangeli
mi era più facile rispetto a quello classico perché successivo di 4-5 secoli rispetto al greco di
Aristotele, oppure se i vangeli sono stati scritti per un tipo di “intelletto” e il greco di Aristotele
per un altro “intelletto”; cioè mi sono chiesto se nel greco antico c’era questa differenza di
carattere linguistico a seconda dell’intelletto al quale ci si rivolgeva, e quindi se è avvenuta una
rivoluzione anche linguistica attraverso il cristianesimo oppure no. In ogni caso io, partendo dal
greco popolare, notavo la differenza di queste due forme del greco antico. Mi domandavo
insomma se il vangelo era indirizzato al popolo, non agli intellettuali
Giovanni Franzoni – I Vangeli prima di essere scritti corrispondevano a una tradizione orale non
scritta, che noi supponiamo in aramaico. I Vangeli scritti, i quattro canonici, sono scritti in greco
e anche in altre lingue.
Riguardo al rapporto con il divino, per cui per raggiungere Dio c’è bisogno della carne del servo,
bisogna dire che però c’è di mezzo l’ebraismo. Adam nasce dalla terra. Adesso c’è una notevole
16
consonanza nel pensare che le narrazioni circa l’Eden scritte in tempo post-esilico, descrivono
una condizione esilica. Adam nasce in un rapporto di esilio, quindi espulso dalla condizione
edenica, questo è l’unico suo limite, limite che tocca però tutti. Adam è terra e fin dal II° e III°
secolo, l’interpretazione che viene data è che questa corporeità è segnata dal fatto che è
animata dallo spirito divino, e non è mutila. Su questo poi la catechesi, la predicazione cristiana
ha un po’ slittato come se l’essere umano lo fosse diventato mutilo dopo la trasgressione.
Invece l’esule non è mutilo nell’ebraismo. Ecco perché a un certo punto dicono che questo
pugno di fango che siamo non è un furto di cui siamo solo ricettatori. Questo dice il primo dei
trattati sulla Genesi del Talmud.
L’uomo di fango è l’uomo, è se stesso, non può essere servo, la nozione di servo non c’è
nell’ebraismo; si diventa servi per debiti, per un incidente, ma poi c’era la famosa mitologia del
giubileo per cui non si poteva diventare servi per sempre perché essere servi è contraddittorio
con la vita stessa. Quindi noi siamo debitori anche come cristiani, come discepoli di Gesù, di
questo concetto: questo pugno di fango che siamo, comunque ci è stato dato. “Polvere sei e
polvere tornerai”, questo è l’altro limite fondamentale e non c’è una traccia notevole di
immortalità. Questo fatto che noi non siamo mutili, secondo me, strada facendo un poco ce lo
siamo persi, per esempio con l’introduzione del concetto che i progenitori sarebbero stati creati
immortali e la mortalità sarebbe stata una punizione per aver trasgredito, aver mangiato
l’albero della conoscenza. Di questo non c’è traccia né nell’ebraismo talmudico, né nel pensiero
moderno; l’uomo esce dalla condizione edenica, esce per così dire in una condizione faticosa in
cui lavorerà con il sudore della fronte, ma questo è per tutti, qualsiasi persona dotta, qualsiasi
maestro in Israele, qualsiasi profeta deve lavorare con le mani e sudare con il sudore della
fronte perché questa è condizione di tutti; quindi a Gesù è stato consentito e anche a Paolo è
stato consentito di pronunciarsi in quel modo perché aveva tutt’altro senso, il lavoro è
intrinseco alla condizione umana, chi non lavora con le mani si è automutilato, ma qualsiasi
fariseo si sarebbe guadagnato da mangiare con il lavoro delle mani e con il sudore della fronte.
Secondo me è affascinante questo tema; io l’ho scoperto da poco tempo e sono molto preso da
questo senso profondo della corporeità e anche del lavoro manuale, per così dire, proprio del
lavoro “servile”; perfino nei catechismi noi chiamavamo servile il lavoro, se ne era esonerati di
sabato e si introduceva la distinzione tra lavoro servile e lavoro non servile, per cui di domenica,
conformemente ai catechismi, ci si asteneva dal lavoro servile; perciò è stato reintrodotto il
concetto di servilità che di per sé non c’è, il lavoro manuale non è servile, il lavoro manuale è
adamico, cioè è lavoro terragno, è la nostra condizione di esiliati.
I rabbini dicevano che Dio, terminato il lavoro, pur cessando di modificare la natura si tenne tre
chiavi, perché Dio qualche cosa fa anche di sabato: la chiave della nascita dei bambini, la chiave
della pioggia e la chiave della guarigione, per cui quando nel Vangelo di Giovanni Gesù si difese
per aver lavorato di sabato, disse io faccio le opere del Padre, non sto piallando il legno, sto
guarendo; in questo senso rivendica una figliolanza che poi doveva diventare di tutti, però non
era l’astensione dalle opere servili, questa è un invenzione nostra, avendo noi reintrodotto
questi concetti aristotelici nell’etica cristiana.
Raul Mordenti – Vorrei tornare alla relazione di Vittorio Tranquilli che mi sembra bellissima e
importantissima, ringraziarlo non solo per avercela esposta oggi ma per averla pensata insieme
ad altri partecipi di questa elaborazione tanti anni fa. Mi sembra che sia anche una direzione di
ragionamento molto attuale e molto feconda, molto urgente e necessaria. Come punto di
17
approccio vorrei liberare il povero Aristotele; Vittorio Tranquilli usa Aristotele, perché Aristotele
ha, fra le tante altre, la grande virtù di parlare chiaro e di descrivere la situazione che vede, ma
io credo che si possa dire che questa antropologia in realtà non è fondata da lui, è descritta da
lui, ma viene prima; per esempio e più platonica che aristotelica e questo ci dice anche quanto
era forte questa antropologia se lo stesso Aristotele si deve piegare, a me pare, a qualche
contraddizione con il resto del suo pensiero. Perciò si può io credo far risalire ancora indietro,
perché questa identificazione terribile, questo triangolo tra essere, logos e parola è veramente
qualcosa di più antico, più fondativo, che poi spiega il concetto di barbaro, la non umanità del
barbaro, la non razionalità del servo, la non razionalità di chi non parla e in fondo non è.
La cosa per cui vorrei stimolare Vittorio Tranquilli è di proiettare questo discorso in avanti.
Ognuno di noi, che è abbastanza agghiacciato dalle descrizioni che Aristotele fa con tanta
chiarezza, con tanta limpida spudoratezza, riconosce in questa antropologia l’antropologia
vigente. Questa è la provocazione, la domanda che vorrei farti. Penso solo a quella frase che hai
letto sulla guerra, la guerra è necessaria perché chi per sua natura essendo servo si rifiuta di
fare il servo, deve essere sottoposto a guerra e questa è esattamente la fondazione diciamo
“filosofica” della guerra contemporanea, anzi della guerra ultimissima, della prova anche
catastrofica e apocalittica in cui il capitalismo contemporaneo ci getta, così come è vigente
questa antropologia perché è l’antropologia del rapporto del Nord con il Sud, ma è anche direi
l’antropologia del lavoro e del consumo. Non vorrei che “signorile” noi lo intendessimo come
un qualcosa che si è chiuso con l’avvento della società capitalistica, perché - e qui di nuovo è
uno spunto di elaborazione della Rivista Trimestrale - la società dei consumi, quella che un
tempo si diceva la società opulenta, ha molti tratti signorili, nella misura almeno in cui il
consumo prevale sulla produzione e la società sembra tutta orientata al consumo; così come si
potrebbe declinare tutta una serie di contingenze: se volete, c’è un estetica signorile, c’è una
visione della donna signorile e animalesca al tempo stesso, c’è la riduzione dell’altro a non
essere e così via. Sono spunti che volevo solo dare per dire quanto mi sembra urgente
riprendere questa vostra direzione di ricerca.
Ettore Zerbino
Vorrei dire a Vittorio Tranquilli la mia riconoscenza perché ci ha dato un materiale difficilissimo,
indigesto, in una forma che non si poteva pensare più didattica. La domanda che mi rimane
riguarda la parola che c’è nel testo di Paolo: morphē Theoū; credo che sia molto importante
chiedersi se lì Paolo usi un linguaggio della filosofia antica, usi morphē nel senso aristotelico,
forma, o se non la usi smontandola. Infatti lì morphē suona come condizione, perché non si può
dire morphē Theoū e morphē doūlou alla stessa stregua, no? Quella del servo è una condizione,
quella di Dio sarebbe una essenza, sarebbe la forma aristotelica e forse Paolo lo fa a ragion
veduta e per questo lo chiedo, perché appunto queste questioni filologiche sono molto
importanti..
Vittorio Tranquilli – Per quanto diceva Raul Mordenti io, dopo aver dato una descrittiva di
quello che dice Aristotele, ho cercato di vedere cosa sta poi al fondo, quale concezione
antropologica e quale coscienza che l’uomo ha di se stesso sta al fondo di quella situazione che
lui descrive; e allora se andiamo su questo terreno io penso che al fondo certe categorie
antropologiche distorte non siano ancora state superate, ci stiamo ancora dentro e quindi c’è
18
ancora parecchio da fare sia sul piano teorico che sul piano politico. Per quanto riguarda quello
che diceva Ettore, come interpretare quella parola che usa Paolo, io ho detto che se ne è
occupato Franco Rodano, ho cercato di dire in che modo se ne è occupato; io personalmente
non l’ho fatto, quindi non saprei rispondere. Certamente questo è stato un passaggio chiave di
tutto il suo corso di “Storia del pensiero politico”; attraverso questo passaggio, con un
riferimento anche alla Lettera agli Efesini, è stata sviluppata buona parte del Corso; Rodano
tendeva a enucleare l’antropologia dominante, l’antropologia che c’è sempre stata e che
prosegue ancora oggi e che non è stata ancora oggi superata, una antropologia che interpreta il
fatto che l’uomo sia limitato come alienazione dell’uomo; cioè l’uomo patisce la propria
limitatezza come estraniazione, dunque rappresenta se stesso come libertà assoluta; e allora
non c’è più nessuna mediazione nell’indiamento, l’uomo tende a divinizzarsi in modo
immediato; e allora una volta identificato il limite come negatività si tende a scaricare su altri
ciò in cui questa limitatezza si concretizza socialmente, e che è il lavoro; e da qui viene
l’alienazione, lo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo e l’alienazione di una parte degli
uomini
C’era un’altra cosa: se questa antropologia sia proseguita nei secoli indisturbata, oppure se
abbia trovato degli ostacoli, se abbia avuto dei sussulti; sì, ne ha avuti e grandissimi, c’è stato
Martin Lutero, c’è stata la Riforma che ha tentato di risolvere la contraddizione uomo uguale
signore, servo uguale non uomo uccidendo il signore, negando il signore ed esaltando il servo
come uomo, dicendo: l’uomo è colui che è in condizione di servo; ma poi questo è stato ripreso
da Calvino e da un grande fondatore della sociologia moderna come Max Weber che ha voluto
vedere nel passaggio della Riforma attraverso Calvino e quindi nel suo mutamento profondo,
calvinista appunto, l’accompagnamento e la espressione in termini religiosi del capitalismo.
Pasquale Bazzoli – Si è parlato tanto di Aristotele e poi anche di Platone, con un rimando
dell’antropologia aristotelica all’antropologia platonica. In parte sono d’accordo su questo, ma
penso che in Platone; discepolo di Socrate, c’erano forse le premesse per un altro tipo di
antropologia; ci si può riferire soprattutto al V° Libro della Repubblica, dove Platone per
rifondare la società del tempo con le sue guerre e i suoi conflitti, prospetta il superamento delle
proprietà, delle proprietà affettive - il “mio” - e quindi all’interno della famiglia la proprietà
affettiva e la proprietà dei beni. Se focalizziamo l’attenzione qui penso che ci sia già un
superamento di quell’antropologia, forse perché Platone aveva ricevuto questo input da
Socrate che tutto sommato contestava la gestione del potere del suo tempo e voleva un
effettivo cambiamento, e quando scendeva nell’agorà per discutere con i suoi interlocutori si
poneva in ascolto; ma era un ascolto che comportava poi un cambiamento effettivo;
nell’ascoltare e nel fare intervenire i suoi interlocutori, li metteva in crisi e tentava di fare
emergere un uomo diverso; infatti il “conosci te stesso” non è quello di un uomo che ripercorre
il passato e che vuole conservare l’esistente: è un conoscere che va in profondità e che vuol far
nascere qualcosa di nuovo; penso che in Platone ci sia questo. Poi dobbiamo tenere presente la
differenza essenziale tra un Aristotele e un Socrate; Aristotele viene dall’ambiente di corte, il
padre è medico alla corte macedone e diventa il maestro, il pedagogo di Alessandro Magno,
quindi non può che riflettere una gestione del potere come esisteva allora, un potere che era il
potere politico, culturale e di corte. In Platone il discorso è diverso perché vuole il
cambiamento; lo vediamo quando va a Siracusa dove è il tiranno e per ben tre volte si rende
disponibile a costo di lasciarci la vita; quindi ci crede. Probabilmente Platone, pur venendo da
famiglie che potrebbero gestire il potere, sente - probabilmente ispirato da Socrate - che la sua
19
missione non è quella; il suo mandato, la sua vocazione, il suo servizio, possiamo dire, non è
quello di gestire il potere ma di essere critico nei confronti di coloro che gestiscono il potere per
vedere se è possibile cambiare la gestione del potere. Poi con il passare dei secoli durante
l’umanesimo e il rinascimento personaggi come Ficino, Pico della Mirandola, si rifanno a
Platone perché sentono che lì ci sono gli elementi del cambiamento, di un salto qualitativo.
Questo lo vedrei collegato o collegabile a questa antropologia di Paolo, a questa rivoluzionaria
antropologia di Gesù e poi di Paolo. Certo Paolo è stato grande, grandissimo perché è riuscito a
cogliere l’essenza del messaggio di Gesù, che era un messaggio rivoluzionario, perché
certamente Gesù aveva capito come si stava gestendo il potere nel suo tempo, il potere
religioso e culturale, il potere politico ed economico, e si era posto in posizione critica nei suoi
confronti, per cui c’è questa critica continua nei confronti degli Scribi, dei Farisei, dei Dottori
della Legge; e nello stesso tempo avendo questa chiarezza si moveva in mezzo alla gente per
farle capire come stavano effettivamente le cose. Paolo riesce a cogliere questo messaggio di
rivoluzione morale di Gesù, e anche lui si mette su questa linea teoretica, la approfondisce; ma
poi Paolo, forse a causa della sua formazione intellettuale rabbinica, forse anche per i limiti del
contesto storico in cui le prime comunità cristiane vivevano, non riesce a portare avanti con
coerenza questa rivoluzione all’interno delle comunità a cui si rivolge; e quindi nel trasmettere
alle comunità questo messaggio rivoluzionario di Gesù, c’è una ricaduta di Paolo, riemerge
ancora l’Antico Testamento, riemerge nella pratica quello che c’era prima; se nella teoria alcune
Lettere, alcuni passaggi di Paolo sono chiarissimi, poi io penso che nella pratica non riesca a
trarne le conseguenze ed è per quello che poi Paolo viene ricuperato da Agostino, dal
pessimismo di Agostino e poi da Lutero con il pessimismo caratteristico di Lutero.
Vittorio Tranquilli – Per quanto riguarda Platone: se noi vogliamo una codificazione, una
formulazione codificatrice di quello che nella coscienza, nell’autoconsapevolezza degli uomini
del mondo antico (ma non solo), era il servo, proprio per quello che ha detto adesso Bazzoli
bisogna andare ad Aristotele e non a Platone: perché Aristotele descrive in maniera potremmo
dire anche spietata, con una freddezza assolutamente notarile la situazione esistente, come se
per natura fosse così e non potesse che essere così; se invece Platone lo vogliamo vedere (non
so se sia giusto) come un uomo tendente al nuovo, tendente a modificare la situazione sociale
esistente, allora non è in lui che dobbiamo andare a cercare ma è appunto in Aristotele. Per
quanto riguarda il famoso comunismo platonico penso che esista, ma rimane ristretto al ceto
dei filosofi e dei guerrieri, non al ceto degli addetti al lavoro; Platone individua tre figure: i
governanti, i guerrieri e gli addetti alle opere della vita quotidiana; secondo me questo
comunismo rimane limitato alle prime due categorie e quindi non è universale, è un modo per
raggiungere maggiore coerenza di vita all’interno del mondo signorile; ciò detto in modo molto
approssimativo.
Raniero La Valle – Io penso che dal complesso delle cose che ci siamo dette oggi restano aperti
due filoni di ricerca: uno è questo della figura del servo e quindi della divisione della società tra
figure contrapposte umane e subumane, uomini e no, il servo e il signore, il libero e lo schiavo e
così via; e l’altro grande tema è proprio quello del lavoro che si apre ad una riconsiderazione:
perché come ci ha detto Vittorio Tranquilli il lavoro viene essenzialmente considerato - e perciò
anche spregiato - come opera del servo; dunque il lavoro è in qualche modo sottoposto ad una
precomprensione negativa come qualche cosa in cui l’uomo non si realizza. Allora nel momento
in cui si assume invece il servo non come il “non uomo” ma come l’uomo per eccellenza, si
20
assume anche il lavoro e si rivaluta il lavoro non più come opera del servo ma come opera
interamente umana dell’uomo. Qui, anche secondo quello che ci diceva Vittorio della riflessione
di Rodano, c’è il rovesciamento della concezione dell’ imperfezione dell’uomo in quanto
limitato; c’è invece una rivalutazione del limite, che non va assunto solo naturalisticamente; il
limite va assunto come qualcosa che vive nella storicità, e quindi anche il superamento del
limite, è un superamento storico e perciò rappresenta l’avanzamento dell’uomo stesso. Ora
questo superamento del limite si ha mediante il lavoro, e quindi il lavoro diventa pienamente
non più l’opera servile del servo, ma come dice Tommaso, l’opera della mente e delle mani
dell’uomo. Quindi Tommaso cerca di ricondurre a unità questi due elementi contrapposti del
composto umano, cioè la mente che è quella dedita anche alla contemplazione, e le mani che
sono quelle fattive, attive; quindi il lavoro come opera dell’uomo, quindi la rivalutazione del
lavoro e quindi allora il diritto di ogni uomo al lavoro, il diritto di ogni uomo a un lavoro che non
lo alieni, il diritto a un lavoro che non lo punisca, che non lo reprima e così via.
A questo proposito vorrei fare una domanda a Giovanni Franzoni; a me pare che questo
deprezzamento del lavoro c’era nella concezione di Israele, non fosse altro per il fatto che il
lavoro viene considerato come introdotto a seguito della trasgressione, come pena della
trasgressione; quindi c’era questa svalutazione del lavoro, questa negatività del lavoro; ma
soprattutto il grande paradigma è quello del Sabato; il Sabato è il Sabato perché è libero dal
lavoro, il Sabato è essenzialmente non lavoro. Poi assume il suo pieno significato sacramentale,
però c’è questo significato del Sabato come libero dal lavoro, quindi il lavoro come negatività.
D’accordo, c’è questa dignità del fango dell’uomo, ma c’è anche questa ulteriore specificazione
che riguarda il lavoro come negatività; nella società di Israele come nelle altre società antiche
esisteva la schiavitù, anche se poi riscattata con il giubileo; però la condizione del servo era la
condizione del servo anche nella società di Israele.
Giovanni Franzoni – Come Aristotele partiva dalla descrizione di una società dispotica,
aristocratica, così anche il pensiero ebraico sulla fatica umana nasce da una condizione di esilio;
è vero che sono immagini un poco fantasiose, ma Dio per formare il corpo di Adamo raccoglie
terra un po’ dappertutto e lo colloca in Eden; la disobbedienza provoca una reazione; però
Rabbi Eliazer commenta che quando Dio punisce, quando Dio maledice benedice ancora, cioè
nasconde nella maledizione una benedizione; perciò dice: lavorerai con il sudore della fronte
perché il sudore è segno di buona salute; chi non suda sta male, anche lo starnuto è segno di
buona salute, il sonno: chi non dorme bene sta male; il sogno, chi non sogna non apre un varco;
anche la polluzione notturna, la defecazione e infine il pane sono cose buone, sono le sette
tavole di salvezza dell’uomo in esilio che esprimono questa dinamica interna; nonostante la
punizione Dio non ci ha mutilati, ci ha buttato fuori dall’Eden perché lo abbiamo voluto,
abbiamo voluto conoscere, ed era insostenibile l’antinomia tra bene e male dentro la situazione
edenica; ma non ci ha mutilati. Quindi gli ebrei descrivono dalla loro ottica sè come esuli e non
come servi o come schiavi: noi come esuli siamo qui a spaccare la terra, però sudiamo, quindi
stiamo bene; l’errore sta nella linea di immortalità che è un’uscita da questo segmento: polvere
sei e polvere ritornerai; non la resurrezione - perché quel Dio che ti ha tratto una volta dalla
polvere ti può trarre ancora dalla polvere - ma l’avere in mano l’immortalità è profanazione nei
confronti della eternità divina. In quanto al Sabato: in tutti i giorni della creazione si afferma: è
buono, è buono, Dio vide che era buono quindi il lavoro, tutta la produzione dei sei giorni è
buona. Per esempio io nelle Tentazioni di Cristo avevo avanzato l’idea che l’istituzione del
Sabato fosse un provvedimento, come dire, di benevolenza, per dare riposo ai lavoratori; ma mi
21
ha corretto Riccardo Di Segni: no, no è anzitutto dedicazione, momento in cui si riflette su noi
stessi; perciò si domandano: e voi cosa fate di sabato? A parte le tre chiavi per cui seguitano a
far nascere bambini, la risposta è: si rilegge la Torah. Però la Torah è legge per tutti e Levinas
commenta: perché qualsiasi popolo che non è Israele al momento che si da una legge è Israele.
Renata Ilari Zerbino – Riguardo alle indicazioni per il futuro, di che lavoro parliamo? Io non ho
mai spaccato la terra, e perciò non avrei lavorato? Parliamo di lavoro genericamente o ci
mettiamo l’aggettivo accanto e diciamo “lavoro servile” e quindi riprendiamo il discorso dello
schiavo, del servo, che chiaramente compie un certo tipo di lavoro che ancora oggi c’è: ci sono
ancora oggi gli schiavi, basti pensare ai bambini ridotti in schiavitù che lavorano o agli africani
ridotti in schiavitù che in Africa lavorano e sono proprietà altrui; noi non sempre ne siamo
consapevoli ma questo esiste ancora oggi, la schiavitù non è stata eliminata, anzi c’è un ritorno
verso la schiavitù. Tuttavia c’è anche un lavoro che non è così alienante: perché quando si va in
pensione si soffre tanto? Il lavoro può essere anche una dimensione creativa; e allora.forse
dobbiamo fare una distinzione fra lavoro servile, la schiavitù, e un lavoro invece umano,
creativo. Un’altra cosa vorrei dire: spesso sento questo discorso su Lutero: perché non facciamo
venire un protestante a parlarci di questo? Facciamoci dire da qualcuno che è intriso di quella
cultura in che termini sta la questione dell’influenza del protestantesimo sul capitalismo.
Vittorio Tranquilli – Per quanto riguarda il lavoro, procedendo in termini moderni da quello che
si può trovare in Aristotele o in altri sul lavoro servile, la traduzione moderna di questo
aggettivo servile è alienato; allora i giovani co.co.co., questi poveretti che dopo aver preso la
laurea vanno a pulire le scale, quelli che fanno lavori a progetto ecc.: questo lo chiamiamo
lavoro alienato. A ciò è stato ridotto in un contesto capitalistico in cui è venuto meno quel
contrappeso di movimenti sociali, che nell’epoca che ha preceduto la nostra attuale avveniva
per impulso principale del movimento operaio e che adesso non c’è più; oggi c’è una situazione
in cui il rapporto capitale-lavoro vede l’assoluto vantaggio del primo mentre il lavoro è ridotto
alle corde; quindi, ferma restando la figura di principio del lavoro alienato, nella situazione in
cui ci troviamo adesso questa alienazione è massima; perciò la parola lavoro “servile” io la
tradurrei in lavoro alienato, e oggi massimamente alienato. È una cosa che suscita indignazione;
è da qui che nella politica bisognerebbe ripartire.
Lutero è tante cose, naturalmente è un grossissimo personaggio e anche simpatico, molto più
simpatico di Calvino, tanto che lo stesso Calvino diceva: mi hanno temuto ma non mi hanno
amato; invece Lutero si poteva anche amare. Di Max Weber noi sulla Rivista Trimestrale
abbiamo molto parlato, ma ci siamo anche distinti da lui dicendo che secondo noi non era
quello il rapporto tra capitalismo e pensiero protestante nella sua accezione calvinista.
Raniero La Valle – Nel libro di Vittorio c’è tutta una seconda parte che è dedicata all’esame del
pensiero di Lutero e di Calvino. Se ricordo bene, a proposito di Calvino si dice come il
superamento della contrapposizione tra servo e signore si ha non nel rendere tutti signori ma
nel rendere tutti servi, sia pure di Dio; era comunque una condizione negativa di servitù anche
se rapportata a Dio e non ad un signore terreno
Riguardo al lavoro vorrei dire che la cosa da negare è precisamente la differenziazione tra
lavoro nobile e lavoro servile perché tutti i lavori sono lavori dell’uomo, tutti sono lavori
22
necessari, tutto il lavoro deve essere riscattato. In Aristotele la contemplazione non è
considerata un lavoro, e tutto il lavoro, in quanto spregevole e attribuito all’opera dei servi, è
un lavoro servile. Dunque non si tratta di riscattare una parte del lavoro, quello cosiddetto
servile, ma è proprio tutto il lavoro che va riscattato come non servile, come lavoro pienamente
umano, anche i lavori materiali, i lavori più umili; il problema dell’alienazione del lavoro non
deriva dal tipo di attività che si compie, l’alienazione del lavoro dipende dalla condizione
sociale, storica e produttiva in cui si è inseriti, per cui tutto il lavoro anche il lavoro intellettuale
diventa alienato, viene espropriato a colui che lo fa; quindi io penso che il discorso è proprio
questo, di ricostruire il lavoro, tutto il lavoro, come opera dell’uomo, come opera attraverso cui
l’uomo realizza se stesso nel limite, nella storicità, portando avanti l’intera società umana; tutto
il lavoro deve essere non servile ma pienamente lavoro umano, questa mi pare che sia la sfida .
[Dibattito Zerbino - La Valle fuori registrazione]
Paola Peloso – Io sono stata molto contenta nell’ascoltare tutta questa ricerca così bella, così
profonda, però mi è venuto anche il dubbio che non possiamo fermarci a questo, perché qui
non c’è solo un procedimento del pensiero, viviamo in un momento in cui il processo della
storia ha fatto tanti e tali cambiamenti e ha avuto tali e tanti slanci che noi siamo travolti da una
grande forza vitale ed è con questa che adesso ci misuriamo. Non possiamo dimenticare che
abbiamo avuto il Concilio che ci ha lasciato una eredità enorme. I lavoratori hanno
riconquistato una loro dignità ma da dove è venuta questa, al di là degli studi su Aristotele e
Platone, c’è una forza vitale che noi chiamiamo la forza dello spirito, che ci fa andare avanti
lungo un’altra strada; e allora questo ci chiede in questo momento un atteggiamento di
ripensamento, non per la sicurezza di avere in mano più adeguate categorie di pensiero di
carattere ideologico, ma per il riconoscere una categoria di vita, di forza vitale, antropologica
che è così importante in questo momento. Sono d’accordo con Renata Ilari, che venga qualche
protestante, e io direi anche qualche ebreo, qualche ortodosso, cioè apriamoci alle forze che
stanno in questo senso lavorando, non siamo solo noi perché se no rischiamo di rinunciare a
una grande ricchezza che oggi ci viene offerta.
Mara Gasbarrone – È la prima volta che vengo e vi ringrazio della partecipazione e degli
stimoli; premetto che non ho una formazione filosofica al contrario di mio marito che insegna
filosofia all’università; però in compenso mi occupo un po’ di economia e mi sono occupata di
demografia, quindi oggi pomeriggio mi si sono un po’ confuse le idee perché ho l’impressione
che abbiamo un po’ sovrapposto il concetto di schiavitù, di servitù, di lavoro alienato, di lavoro
salariato; tutti i lavori salariati, lavori dipendenti di qualsiasi genere secondo me sono alienati,
perché anche quelli più intellettuali nella sostanza vengono determinati nei contenuti, nelle
modalità, nei tempi, e il risultato viene espropriato. Allora schiavitù che cosa significa, significa
anzitutto che a uno gli viene negato il diritto di riprodursi, di fare figli, perché generalmente lo
schiavo non ha diritto di avere la sua famiglia, non solo è comprato e venduto il suo tempo, ma
proprio la sua vita, tutta la sua vita; in genere le schiave abortiscono, a meno che non diventino
le amanti del padrone. Ricordiamo che la schiavitù in Brasile è stata abolita alla fine dell’800,
nel 1880 c’è stata la legge del ventre libero per cui il figlio di una schiava nasceva libero, e che la
schiavitù sia in America del Sud che in America del Nord l’hanno praticata i cristiani; di fatto
nella cristianità c’è stata un’ampia pratica della schiavitù, per lo meno nel nuovo continente, sia
nell’America del Nord dove l’hanno praticata i protestanti, e pare leggermente meglio, sia
23
nell’America del Sud, dove l’hanno praticata i cattolici con risultati ancora peggiori. Servitù,
servo, lavoro servile nei miei studi demografici era soprattutto quello che veniva prestato
presso le famiglie, cioè di fatto c’era spesso una specie di contratto educativo, diciamo così, in
cui le famiglie più numerose davano i figli ad altri per praticare un apprendistato e poi però di
fatto a ciò si univa un lavoro servile presso le famiglie; poi c’è appunto il lavoro dipendente,
alienato, però mi sembra che forse ci converrebbe distinguere meglio queste varie categorie
che in effetti hanno dei tratti in comune e tuttavia sono molto diverse.
Riccardo Gullotta – Mi sembra che i fattori di alienazione sono oggi spostati dalla produzione al
consumo; oggi il vero problema è quello del consumo, si è passati da quello che era una
reificazione, una mercificazione marxiana una volta identificata classicamente nel capitalismo
della produzione, alla alienazione del consumo. Una seconda osservazione è che il problema
grosso è una spaccatura antropologica tra occidente, o nord del mondo e sud del mondo.
Infine, ho sentito qui parlare di Hegel, di Calvino, di Aristotele, come è giusto; però mi sembra
che quelli più inquietanti tutto sommato siano i risvolti di tipo positivistico: insomma l’800. Ci
sono dei fattori di spaccatura che vengono da Darwin forse maggiori di quelli che derivano da
Aristotele, da Tommaso quando ancora l’alienazione di tipo capitalista non c’era. C’è stato un
salto di qualità; mi sembra che con Darwin, con certe correnti positivistiche e anche con certi
filoni marxisti, come quelli dell’austromarxismo, si siano introdotti fattori di discriminazione;
potrebbe essere importante approfondire l’800, il dissidio che c’è stato tra scienza della natura
e scienza dello spirito; probabilmente troveremmo degli spunti che ci farebbero capire meglio
la situazione di oggi.
Vittorio Tranquilli – Certamente come c’è un’alienazione della produzione, del momento
produttivo c’è un’alienazione del consumo. Consumo indotto che cosa è se non un consumo
alienato? La radice di questa alienazione del consumo secondo me è simile a quella della
alienazione del momento produttivo dell’uomo in quanto lavora; essa sta nell’individualismo
del consumo; ridotti gli uomini a consumatori atomizzati è chiaro che stanno sotto il dominio
del produttore cioè dell’impresa che produce o del monopolio. Allora un problema che si pone,
ma con questo passiamo su un piano politico e di politica economica, sarebbe quello di
organizzare socialmente, per quanto è possibile, il consumo, come già per determinate cose c‘è;
e non a caso stanno cercando di demolirlo: la sanità che cosa è se non consumo collettivo, la
scuola che cos’è se non consumo collettivo? Per questo oggi sono sotto attacco.
24