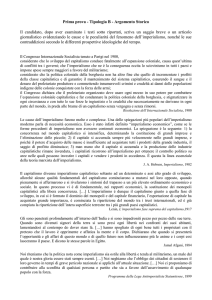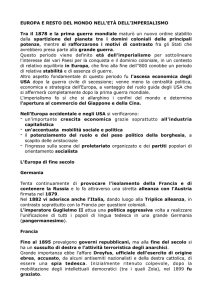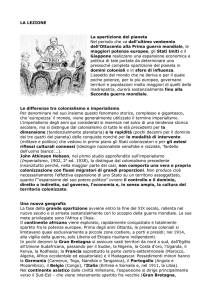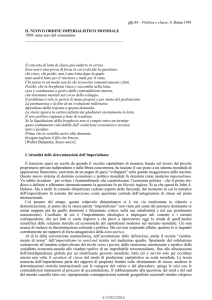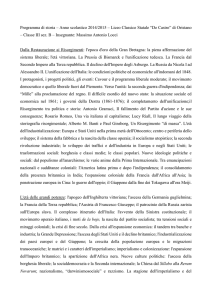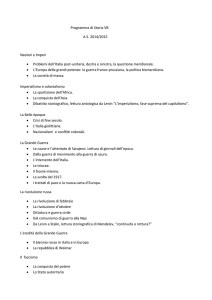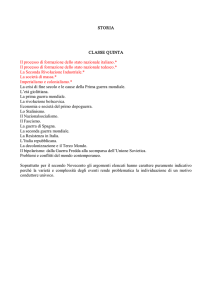gfp.70 - la Contraddizione, 20, Roma 1990
A PROPOSITO DI IMPERIALISMO
___________________________________________
“... troviamo dei giovani paesi capitalisti
in rapidissimo progresso, come
l’America, la Germania e il Giappone ...
... concreta peculiarità storica
del moderno imperialismo è
la concorrenza di diversi imperialismi...”
[V.I.Lenin, L’imperialismo]
Le riflessioni e i discorsi a proposito di imperialismo (e dei suoi tre poli principali, indicati già da Lenin
con precisione) - in un’analisi che stiamo portando avanti sulla rivista, e in genere nel dibattito entro la
sinistra - meritano qualche considerazione, anche in margine alla forma culturale del dibattito medesimo.
Ormai solo nella sinistra di classe, e finanche qui non senza difficoltà sul piano teorico e scientifico, si riesce
a parlare di imperialismo. La sinistra democratico-borghese, più o meno diffusa, ha infatti abbandonato del
tutto questa importantissima determinazione economico-politica del capitalismo contemporaneo, docilmente
accodandosi alle post-mode dell’ideologia dominante.
È trascorso quasi un secolo da quando il vecchio capitalismo, di maniera, si considerava basato sul lavoro
del piccolo proprietario privato indipendente e sulla libera concorrenza: queste, per l’appunto, insieme alla
democrazia, sono tuttavia le parole d’ordine del passato che la borghesia con i suoi mezzi di comunicazione
di massa - come già osservato da Lenin - usa ancora per ingannare i lavoratori e la popolazione in generale.
Fin da allora quella forma di capitalismo ha lasciato il suo posto a un sistema mondiale di oppressione
finanziaria (produttiva, monetaria e speculativa) esercitata da un pugno di paesi “sviluppati” sulla grande
maggioranza delle nazioni e dei popoli. Fu proprio codesto nuovo sistema di dominio economico e politico
mondiale che venne denotato come moderno imperialismo. Va subito ricordato - per evitare i fraintendimenti
che caratterizzano l’economia politica, tra mistificazioni dei suoi apologeti e tremori dei critici-critici - che il
primo studioso a definire e affrontare sistematicamente la questione fu un liberale inglese. Tutti sanno che
questi fu John A. Hobson, economista autodidatta (per sua fortuna) dell’ambiente marshalliano, ma critico
verso quella scuola e perciò definito “eretico” (a es., da Schumpeter, il quale, pur dedicandogli un certo
spazio e riconoscimento nella storia del pensiero economico, cita parecchi se non quasi tutti i suoi scritti, ma
ignora proprio il volume sull’Imperialismo del 1902).
A molti fa comodo dimenticare codesto aspetto originario della faccenda, dal momento in cui la critica
dell’imperialismo fu assunta dal marxismo come questione centrale dell’antagonismo di classe sul piano
internazionale. Certamente, l’impulso maggiore allo studio e alla critica dell’imperialismo fu merito del
movimento comunista, superandone l’origine capitalistica. Ciò spiega a sufficienza perché i borghesi,
padroni e benpensanti insinuati nelle file del proletariato, si siano dati tanto da fare per obliterare l’analisi
dell’imperialismo e farne dimenticare la terminologia stessa - insieme a ogni concezione di antagonismo e
forma di lotta di classe, e alla realtà e al nome del comunismo.
Col passare del tempo, questa colpevole dimenticanza si è così trasformata in mortale silenzio e
demonizzazione. È dunque la stessa parola “imperialismo” che - pur concepita e nata da grembo liberale,
così come le categorie dell’antitesi, della contraddizione e della lotta che hanno subito il disconoscimento
della loro matrice hegeliana, a seguito della pericolosa appropriazione marxiana - non viene più usata dal
pensiero dominante (e dunque ormai neppure più da quello dominato e falsamente critico, nella sua
subalternità e nel suo pentitismo teorico e ideologico).
Corollario di ciò è l’impedimento censorio a impiegare tali concetti e termini, imposto nei fatti a chi provi
a ripercorrere oggi la strada di quell’analisi scientifica delle relazioni storiche ed economiche del capitalismo
moderno nel mercato mondiale. Chiunque abbia qualche dimestichezza con la suprema segnatura
accademica o con i comitati “scientifici” della ricerca nazionale - ossia, università e Cnr, in stretta connessione con tutto l’apparato multimediale della cultura ideologica borghese - sa perfettamente quanto queste
considerazioni rispondano al vero. E sa pure come esse si traducano in discriminazione culturale, sia da parte
degli organi preposti, commissioni e comitati, che per opera del sistema delle comunicazioni di massa,
1
editoria, pubblicistica, didattica, ecc. - il tutto guidato da precisi orientamenti ideologici, partitici e
burocratici. I finanziamenti “pubblici” (si fa per dire!) per ricerca, pubblicazioni, ecc., sono vietati a chi
anche soltanto parli di crisi del capitalismo, o dell’imperialismo e delle sue contraddizioni. Ciò tuttavia non
sorprende affatto, qualora si inquadri correttamente questa faccenda nei rapporti di forza antagonistici della
lotta teorica.
Al fine di ristabilire, comunque, un minimo di riferimento storico culturale, è giusto rammentare soprattutto a sicofanti e scribacchini al servizio della borghesia che se ne fossero dimenticati - alcune delle
determinazioni teoriche dell’imperialismo. Per evidenziare meglio la polemica culturale qui sollevata, utile
anche ai compagni più giovani, è opportuno prendere le mosse proprio dalla lezione del liberale Hobson - a
cominciare dalla sua segnalazione esplicita, anche, delle “contraddizioni dell’imperialismo” e delle
“ricorrenti crisi del capitalismo, allorché la sovraproduzione si manifesta nelle principali industrie”.
Naturalmente i limiti dell’analisi di Hobson sono stati messi in chiara luce da tutto il dibattito marxista
di inizio secolo, anche e soprattutto nella lotta contro il revisionismo della seconda internazionale. Va da sé
che rimane ancora oggi centrale la critica verso il pacifismo, l’intento di conciliazione degli interessi
antagonistici di classe, la giustificazione di una pretesa superiore unitarietà dell’imperialismo, e così via, dei
vari Hilferding, Kautsky, ecc. Si tratta dei noti errori delle teorie del capitale finanziario inteso come
determinato e dominato dal sitema monetario delle banche, anziché dalla produzione di plusvalore, delle
mistificazioni di un governo mondiale unitario del super-imperialismo, armonioso e auspicabile per
revisionisti e riformisti, o monolitico avversario per estremisti infantili, e così via. Tali concezioni distorte e
pericolose, inevitabilmente, hanno origine proprio nell’ottica liberalborghese di Hobson. Il quale, tuttavia,
ancorché inglese ma proprio perché inglese, ebbe alcuni vantaggi rispetto ai revisionisti.
Innanzitutto, mostrò materialisticamente le basi storico-pratiche del moderno imperialismo britannico,
indagandone empiricamente i caratteri fondamentali (cosa che oggi nessun economista illuminato si sogna di
fare rispetto alle punte più avanzate del capitalismo contemporaneo). Poi, appunto in quanto suddito di sua
maestà, seppe vedere per tempo le rischiose tendenze verso cui precipitava l’impero britannico, soprattutto in
funzione della lotta di “concorrenza da tagliagole” sul mercato mondiale tra i diversi imperialismi, in
particolare tra quelli allora giovani - Stati uniti, Europa occidentale e Giappone - e la troppo matura
Inghilterra (ossia, mise in luce quelle contraddizioni interimperialistiche su cui Lenin seppe insistere, ma che
molti comunisti, dopo, fino a oggi, mostrano di sottovalutare). Infine comprese, proprio grazie alla esatta
percezione scientifica dell’origine di tali contraddizioni, che il problema dell’accumulazione capitalistica
stava nella tendenza ricorrente alla sovraproduzione generalizzata e non accidentale di capitale (e pur confidando nel ruolo salvifico di un aumento del consumo delle masse, non cadde nella banalità keynesiana di
un sottoconsumo eliminabile con buone previsioni e adeguati interventi statali: lo stesso lord Keynes, pur
apprezzando Hobson in quanto “eterodosso”, ritenne invece di criticarlo proprio per la giusta intuizione
della sovraccumulazione connessa alla pletora di liquidità monetaria, sotto forma di eccesso di risparmio, e
alla caduta del profitto!).
In linea generale, dunque, Hobson - che ha dedicato un intero capitolo ai “parassiti economici dell’imperialismo” - non nasconde che il nuovo imperialismo capitalistico, sebbene sia “un cattivo affare per la
nazione”, sia “un buon affare per certe classi”; se è “irrazionale” per la prima, “esso è sufficientemente
razionale dal punto di vista di certe classi”, i cui “ben organizzati interessi d’affari sono capaci di sopraffare
il debole diffuso interesse della comunità”, e di “usare le risorse nazionali per i loro guadagni privati”.
D’altronde, già sulla questione del debito internazionale, Hobson osservava che “i termini creditore e
debitore, applicati ai paesi, oscurano la più significativa caratteristica di questo imperialismo. Giacché, se i
debiti sono pubblici, il credito è quasi sempre privato”. Egli vedeva dietro codeste classi il grande “capitale
cosmopolita”, a cominciare dall’industria pesante (e relativi “servizi” - “ingegneri, speculatori, missionari”,
ecc.), direttamente e indirettamente interessato alle spese per gli armamenti.
“L’imperialismo aggressivo, che costa caro al contribuente, è fonte di grandi guadagni per l’investitore
che non trova all’interno un impiego profittevole per il suo capitale” - aggiungendo che “è inutile ciurlare
con la politica se non si riconosce chiaramente questo fatto centrale”. Ciò conduce pure i “furbi affaristi
politici” a “controllare la stampa, le scuole e se necessario le chiese, per imporre l’imperialismo alle masse”.
Insomma, il liberale Hobson sapeva benissimo che le “radici profonde dell’imperialismo” - “la cui essenza
consiste nello sviluppo dei mercati per l’investimento, e non per il commercio”, e tanto meno in quelle
“missioni di civilizzazione” e “manifestazioni del destino” con le quali si sciacquava la bocca il primo dei
Roosevelt e su cui Hobson stesso riversava il proprio sarcasmo - stanno nell’”eccesso di capitale in cerca di
investimento” e nelle “ricorrenti strozzature del mercato”, che non si spiegano con accidentali “errori di
direzione”, ma, appunto, con una “concorrenza da tagliagole”.
In particolare, merita ricordare alcune considerazioni di Hobson sulle tendenze dell’imperialismo
europeo, capace di trasformare l’Europa in un’area dominata da “un piccolo gruppo di ricchi aristocratici,
2
che traggono le loro rendite e i loro dividendi dal lontano (o vicino?!, ndr) oriente, accanto a un gruppo
alquanto più numeroso di impiegati e commercianti e a un gruppo ancora maggiore di domestici, lavoratori
dei trasporti e operai delle industrie manifatturiere. Allora scomparirebbero i più importanti rami industriali,
e gli alimenti e i semilavorati affluirebbero come tributo dall’Asia e dall’Africa”. Hobson riteneva che una
simile prospettiva di “federazione europea”, allora, “non solo non spingerebbe avanti l’opera della
civilizzazione mondiale, ma presenterebbe il rischio gravissimo di un parassitismo occidentale, sotto il
controllo della nuova aristocrazia finanziaria”. La speculazione e il parassitismo appaiono dunque in Hobson
giustamente come intrinseci e immanenti alla forma imperialistica del modo capitalistico di produzione, e
non già come storture e deviazioni eliminabili - circostanza che non tutti, anzi pochi marxisti, e tra questi
pochi Grossmann, seppero mettere in luce.
Lo stesso liberale Hobson invitava “coloro per i quali queste teorie sono da ritenersi indegne” a “meditare
di più sulle condizioni economiche e sociali” conseguenti all’assoggettamento del mondo da parte di “gruppi
di finanzieri, speculatori e loro impiegati politici, industriali e commerciali, intenti a pompare profitti dal più
grande serbatoio potenziale che mai il mondo abbia conosciuto, per consumarli in Europa”. Pur rifuggendo
da difficili previsioni, data la complessità della situazione e la contraddittorietà interimperialistica, non
esitava a ritenere che fossero proprio quelle “le tendenze che dominano l’imperialismo dell’Europa” - e, oggi
sappiamo bene, anche dell’America. Nonostante la giustezza di quell’analisi, le schiere di coloro che
considerano indegne le teorie dell’imperialismo sono aumentate a dismisura tra gli intellettuali della
borghesia, impegnati a nascondere anche la verità dei fatti denunciati da un loro precursore liberale: anche un
marziano potrebbe indovinare il trattamento riservato oggi a un marxista o a un leninista!
Abbiamo recentemente dedicato alcune pagine alla descrizione del nuovo imperialismo giapponese.
L’ultimo dei paesi imperialistici emergenti all’epoca di Lenin era appunto il Giappone. Già prima, quasi un
secolo fa, si affacciava alla conquista del mercato mondiale, quella forza che oggi, per certi versi, è la prima
e più dinamica potenza mondiale. Non sembra, d’altronde, che oggi si profili all’orizzonte qualche nuova
forza imperialistica. Chi credette di vedere, da destra e da “sinistra”, nell’Urss post-staliniana una
superpotenza, addirittura seconda solo agli Usa, capace di dominare la scena mondiale dell’imperialismo del
ventesimo secolo e oltre, ha dimostrato tutta la superficialità e la faziosità della propria analisi: smentita
prima da chi, con gli strumenti teorici marxisti, provava a dimostrarne la palese assoluta infondatezza, poi finalmente dai fatti concreti dello sfacelo attuale.
Come unica prospettiva consolidata, dunque, rimane proprio l’avvicendamento nipponico: o il prossimo
secolo, e millennio, si apre con il passaggio di mano dagli Usa al Giappone, analogamente (seppure in maniera parziale e molto più complicata a causa della transanzionalità del capitale finanziario monopolistico
contemporaneo) a quanto avvenne agli inizi di questo secolo tra Inghilterra e Usa; oppure le contraddizioni
interimperialistiche accelerano sensibilmente il loro grado di maturazione, approssimando il mondo intero con maggiore rapidità, e quindi instabilità, che nell’ipotesi precedente - alle condizioni di quell’atteso,
desiderato o temuto, salto epocale, dall’esito imprevedibile ma considerato comunque di grandissimo
interesse sociale da chiunque.
“Fino a che punto il raggiungimento da parte del Giappone di posizioni di potere politico e industriale di
prim’ordine influenzerà il problema dell’imperialismo in Asia, è una questione che riceve una sempre più
pressante considerazione da parte delle nazioni occidentali”. Questa osservazione non esce oggi dagli uffici
dell’addetto commerciale di Washington o di Bruxelles, ma dalla precoce osservazione di Hobson sul nuovo
imperialismo giapponese. All’inizio di questo secolo, per chi sapeva e voleva coglierla, era già chiara la
percezione del fatto che la crescita della potenza imperialistica del Giappone avrebbe inciso profondamente
sul corso della storia, con sue proprie caratteristiche e ben al di là delle più convenzionali considerazioni
militaristiche o ideologiche, come rammentammo in occasione dell’analisi specifica.
“Riflettendo su questo nuovo capitolo della storia mondiale - aggiungeva Hobson - molto dipende dalla
capacità giapponese di mantenere la propria indipendenza finanziaria”. Superata una prima fase di dipendenza, “la grande potenza industriale dell’estremo oriente può rapidamente gettarsi sul mercato mondiale come
il più grande e più valido concorrente nella grande industria meccanica, conquistando prima il mercato
asiatico e del Pacifico, e poi invadendo i mercati occidentali - spingendo così queste nazioni a un più rigido
protezionismo, come corollario di una diminuita produzione”. La precisione di questa diagnosi mostra come
sia possibile, anche per un borghese, non farsi sorprendere da fenomeni che i preti e i filistei dell’ideologia
economica, sociologica e politica oggi presentano invece con sorpresa e stupore: dalla deindustrializzazione
dei vecchi centri del potere produttivo mondiale, gabellata con la soda fesseria del post-industriale
presuntivamente diffuso a livello planetario, alla ricomposizione di classe del proletariato mondiale,
annunciata come terziarizzazione internazionale e fine della classe operaia, del proletariato e delle classi in
genere.
3
Il marxismo del ventesimo secolo ha saputo raccogliere le verità della teoria liberale dell’imperialismo,
criticandola nei suoi gravi limiti, così come Marx fece il secolo prima con le teorie classiche dell’economia
(ignorate o fraintese anch’esse, insieme alla loro critica, dall’accademia dominante). Perciò abbiamo
riproposto quella semplice lettura dimenticata, misconosciuta, di fatto proibita. Anche questo, sulla cultura, è
un segno dei “tempi bui” di dominio contraddittorio dell’imperialismo.
4